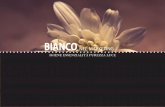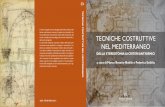Velletri nel Medioevo
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Velletri nel Medioevo
Volume pubblicato con il personale contributo del Dott. Luigi Sellaroli al quale vanno i sentiti ringraziamenti del «Centro Studi» I volumi che vanno sotto la denominazione «Centro Studi Antonio Mancinelli» sono espressione dell’attività e della responsabilità scientifica del Centro medesimo. © Copyright 2011 - 2015 Prima edizione 2011 Seconda edizione 2015 ISBN 978-88-88617-….-.. Edizione e distribuzione:
TORED s.r.l. - 00019 Tivoli (RM) Vicolo Prassede, 29 - tel. 0774.313923 fax 0774.312333 www.edizionitored.it E-mail: [email protected] - [email protected] In copertina:
La Casa della Ragione (da un disegno di L. Cardinali, 1824)
I N D I C E
Premessa ................................................................... pag. 11
Introduzione ............................................................ » 13
Gli avvenimenti – L’alto Medioevo: dai casalia all’incastellamento ......... » 19 – Il Duecento: nascita del libero Comune ...................... » 69 – Il Trecento: l’annosa lotta con il Comune di Roma ..... » 92 – Il Quattrocento: massimo splendore e fine del periodo
comunale .................................................................. » 111 Governo e istituzioni – Le istituzioni comunali ............................................ » 119 – L’origine dello stemma comunale ............................... » 125 – La chiesa di S. Clemente: ruolo politico e amministra-
tivo ......................................................................... » 130 Economia e Territorio – Coltivazione e agricoltura ......................................... » 137 – La moneta ............................................................... » 143 – Fuori e dentro le mura: le porte d’accesso alla città .... » 145 – Le decarcie e l’assetto urbano della città .................... » 154 – La popolazione ........................................................ » 159 Alcuni cenni di topografia medievale – I confini del territorio veliterno ................................... » 164 – I fondi del territorio ................................................... » 167
INDICE 8
– I confini dell’insula di pertinenza della chiesa di S. Cle-mente ..................................................................... pag. 179
– La carta enfiteutica del 946 tra il vescovo Leone e De-metrio di Melioso .................................................... » 181
Gli Ebrei ................................................................... » 191
Il problema delle fonti storiografiche....................... » 207
Fonti di Archivio e Bibliografia ............................... » 223
Indice dei nomi e di luogo ...................................... » 239
Il buon senso, sale necessario ad ogni ceto di persone, vieta di pubblicare come storia ciò che neppure merita il titolo di conghiettura
(Clemente Cardinali, 1823)
PREMESSA Sulla effettiva necessità ed utilità di questa seconda edi-
zione si potrebbe discutere inutilmente, ma la semplice ra-gione che mi ha spinto a rimettere mano al mio lavoro ri-mane confinata nel fatto che le duecento copie stampate quattro anni orsono sono andate esaurite in brevissimo tempo. Segno tangibile che il volume ha trovato una buona accoglienza, a riprova che le persone hanno interesse per la conoscenza di fatti che sono alla base della memoria del lo-ro passato. Vorrei sottolineare come la base delle conoscen-ze, allo stato attuale delle ricerche, non permetta ancora di delineare un quadro organico della storia di Velletri, in special modo per il suo periodo altomediovale. Ho cercato quindi di identificare alcune problematiche che hanno condizionato finora le indagini storiche, confinandole in schemi oramai vecchi e superati. Per questo motivo ho an-che cercato di rendere più evidenti gli obiettivi di questa ri-cerca chiarendone i punti nella nota introduttiva.
Rispetto alla precedente edizione, oltre che colmare qualche lacuna e arricchire per quanto possibile i contenu-ti, ho approfittato dell’occasione per ampliare il tema relati-vo sia allo stemma comunale che alla minoranza ebraica, e per chiarire il problema delle fonti storiografiche.
INTRODUZIONE Diffuse leggende e una certa esaltazione campanilistica
hanno portato nel tempo gli storici veliterni ad unire i fasti dell’antica Roma – legata in chiave locale alla famiglia Ot-tavia – alle glorie del libero Comune. Una consuetudine volta a considerare il tempo intercorso tra i due periodi come un ponte sotto il quale non sono passati avvenimenti caratterizzanti la storia cittadina. Così nella storiografia lo-cale possono ora notarsi gravi lacune per un periodo che pure ha segnato una netta soluzione di continuità con l’antico e si mostra al contrario ricco di un’adeguata vita po-litica alimentata da energie locali ed ecclesiastiche e da no-bili famiglie.
Prima dell’anno Mille anche Velletri riprese vigore sot-to la guida di una famiglia aristocratica, seppure su incarico del Vescovo, che qui costruì il suo castello. La storia è rac-contata in un documento risalente all’anno 946, una cui copia è ancora oggi conservata presso l’archivio vescovile di Velletri. Alessandro Borgia pubblicò quel documento eli-minando però alcune parti che ne alterarono l’essenza. Ciò non stupisce se si considera che nel XVIII secolo gli storici mancavano degli strumenti di indagine necessari. Egli inol-tre mancò talvolta di obiettività arrivando, in nome della continuità veliterna con la Roma antica, sulla scia del Theu-
INTRODUZIONE
14
li, a fornire a S. Clemente patrono di Velletri discendenze dirette dalla famiglia Ottavia.
Strano destino quello della città di Velletri, che per se-coli ha mantenuto un posto di assoluto rilievo nella storia del Lazio meridionale e nel divenire dello Stato pontificio, ma che non è mai stata, e che non risulta tuttora, adegua-tamente studiata. Oltre agli storici veliterni, l’unico saggio, seppur validissimo, rimane quello che Giorgio Falco ha de-dicato ai documenti dell’archivio storico veliterno, il quale però copre solamente gli ultimi secoli dell'età di mezzo. Consideriamo inoltre che le città, specialmente nel periodo altomedievale, risultano come i “rametti” dell'albero darwi-niano che, avendo fruttato in tempi remoti, sono oramai estinti; segmenti di un percorso evolutivo che a stento riu-sciamo ad immaginare nel centro e nelle campagne dell'o-dierna Velletri. Occorrerà allora reinterpretare e decodifica-re questo passato senza imbrigliarlo nei valori di una ora-mai datata tradizione, tenendo anche conto che il passaggio tra età tardoantica e altomedievale e la sua evoluzione sono ancora poco noti e studiati. È risultata infatti evidente la necessità di una revisione dell’edito, su alcuni argomenti alquanto lacunoso e reticente. Ne abbiamo un esempio pa-radigmatico con il documento del pieno secolo XI nel quale è riportato un contratto di vendita operato da alcuni abi-tanti del castello di Velletri. Un'affermazione che già di per sé avrebbe dovuto suscitare una certa curiosità. Il documen-to è invece completamente ignorato dai due Borgia (Ales-sandro e Stefano) e da tutta la letteratura veliterna. Steven-son, sempre attento e preciso, in questo caso sembra quasi non voler entrare nel merito. Egli riporta il testo originale avitatoris Velliternensis kastello, ma poi trascrive semplice-mente “abitanti di Velletri”. Singolare anche il racconto sul motto che campeggia nello stemma veliterno: “Est mihi liber-tas papalis et imperialis”, derivato dal sigillo già conservato
INTRODUZIONE
15
presso il palazzo Ginnetti. Landi non ne parla, mentre Theuli afferma: “Donde habbia havuto principio scritto tanto honorevole, io non l’hò potuto trovare; si tiene però comunemente, c’habbia havuto origine dall’haver de Velletri una Femeglia havu-to i suoi natali, la quale è stata seminario de’ Pontefici, e d’Impe-ratori, come se dirà à suo luogo”. È solamente Alessandro Bor-gia a spiegarne l’origine, come riconoscimento da parte di Giustiniano e Narsete, citando però come unica fonte l’Opera imperfetta scritta da suo padre Clemente Erminio Borgia! In verita Ascanio Landi non parla affatto della sto-ria medievale di Velletri fino al 1200, eccetto due paginette per i secc. XI e XII, tacendo in seguito anche fatti significa-tivi come i patti con Roma del 1312, perché ritenuti non gloriosi per la sua città (che al contrario dimostrano la forza di Velletri in questo periodo). “Per la mutazione della religio-ne, - scrive il Landi - e per la inondazione di tante barbare genti, in Italia si mutò il vivere, et il governo, e si spense la memoria de notabili fatti: e siccome Roma, e le altre città d’Italia rovinate af-fatto per le discordie, e parzialità civili, sono mancate di certo lu-me di storia, così parimente a Velletri esser’accaduto dovemo.” Sulla storia medievale di Velletri non si dilunga neanche Theuli, il quale incentra le sue ricerche, con qualche strava-gante fantasia, sulla storia più antica. La storia veliterna di città sempre libera e autonoma ci viene così solamente dalla lettura di Alessandro Borgia, al quale va comunque dato il merito di aver trascritto nel suo libro molti dei documenti conservati presso l’archivio capitolare. Il primo di questi pe-rò solamente in modo parziale e con una forzatura nella di-rezione univoca di allontanare da Velletri l’ombra che essa potesse essere stata sede del castello costruito nel 946 da Demetrio di Melioso. Il documento, un atto di enfiteusi tra il vescovo Leone e il consul e dux Demetrio, descrive chiara-mente, ma il passo non è riportato dal Borgia, l’isola che il vescovo si era riservato per sé intorno alla chiesa di S. Cle-
INTRODUZIONE
16
mente, i cui confini sono inequivocabili essendo citate, tra le altre, le zone di Acquavivola e S. Pietro ancora oggi esi-stenti. Queste le parole del Borgia: “L’isola del nostro Territo-rio in cui si dice, che fosse situata una Chiesa di s. Clemente Mar-tire non possiamo ben comprendere in qual luogo fosse ma certa-mente era diversa dalla Catedrale dedicata pur a’ s. Clemente, perche questa è dentro la Città, la dove quella era nel Territorio [questa è una forzatura del Borgia poiché nel documento questa distinzione non viene evidenziata]. Qualcuno crede che quest’isola fosse in un luogo oggi detto Cona di s. Clemente tra le Corti, e Papazzano ove si veggono ruine di antichi edificj forse dell’antica Chiesa di s. Clemente, e il Capitolo della Catedrale qui possiede molte vigne”. Di queste antiche rovine non vi era traccia neanche allora. Il Theuli, che scriveva ottanta anni prima del Borgia, non ricordava alcuna chiesa con questo nome tra quelle di cui rimanevano rovine al suo tempo, né tanto meno risultava una chiesa così denominata tra quelle in possesso della cattedrale nel XIII secolo (l’elenco inclu-deva le chiese di S. Antonino in strada, S. Dionisio, S. Pie-tro “in querceto”, S. Nicola, S. Benedetto e S. Blasio). In ogni modo il materiale rinvenuto in questa zona testimo-nierebbe una frequentazione protrattasi solamente fino alla fine del II secolo d. C. La famiglia di Demetrio di Melioso è ben insediata a Velletri ancora nel corso del secolo XI. Suo figlio, il Duca Giovanni, è menzionato in un altro docu-mento, quello relativo alla donazione di un terreno alla chiesa di S. Lucia nel 1026 o 1032. Ancora una volta però il Borgia tende a sminuire questa presenza: “Giovanni Duca, e Franco Conte, il quale interposero il lor consenso in questa do-nazione, stimiamo, che avessero in Velletri publica autorità di Duca, e Conte, i quali nomi in quel tempo non significavano do-minio, e Signoria, come significano oggi dì, ma solamente officio, e autorità di Governatore” [è un’altra evidente arbitraria consi-derazione del Borgia poiché in quel periodo Duces e Comites
INTRODUZIONE
17
erano i personaggi effettivamente al potere nei vari centri della regione]. Esiste in ogni modo una traccia che testimo-nia l’esistenza del castello di Velletri oltre ogni ragionevole dubbio. È contenuta nel documento su ricordato dell’Ar-chivio Capitolare del 1042, relativo alla vendita di un ter-reno sito nel territorio veliterno nel fondo Bussetulu da par-te di Boniza, Sasso e Costanza avitatoris Velliternensis kastello, dunque abitanti del castello di Velletri. Le pagine che se-guono vogliono quindi rappresentare un percorso in un territorio in parte ancora inesplorato, illuminato però da argomentazioni che meriterebbero indagini supplementari per completare la mappa dello sviluppo storico, sociale e culturale della nostra città e del territorio circostante lungo una strada non tracciata da solidi e consolidati binari. Na-turalmente eventuali imprecisioni e omissioni contenute in queste pagine potranno essere imputabili solamente all’au-tore. Vorrei infine sottolineare le potenzialità che la città di Velletri potrebbe fornire agli studi medievali su Roma, pro-ponendosi come un laboratorio di ricerca nell’ambito della grande narrazione del papato di quei secoli. Velletri rappre-senta infatti, di gran lunga, l’esempio più nitido di incastel-lamento da parte dell’aristocrazia romana legata ad Alberi-co, un chiaro tentativo di espansione nella provincia da parte dei papi tuscolani e da ultimo, ma non certo meno importante, un centro di contesa, forse determinante per il successivo evolversi degli eventi in ambito laziale, tra il pa-pato “riformatore” e il potere imperiale.
GLI AVVENIMENTI L’alto Medioevo: dai casalia all’incastellamento
Nel corso del Medioevo, lentamente ma senza incertez-
ze i papi guidarono il movimento che portò all’emanci-pazione del Patrimonium Sancti Petri dall’impero d’Oriente. Fra il 730 e il 750 il Pontefice diventò definitivamente l’erede dei bizantini, anche se restavano dubbi sulla capacità del papa di resistere ai longobardi e sull’estensione dei con-fini del suo territorio. Saranno i sovrani franchi a dare ri-sposta a entrambi gli interrogativi, difendendo la nuova en-tità territoriale e contribuendo a definirne i limiti territoria-li. La Chiesa aveva in ogni modo già costituito una grande e complessa struttura, con vaste proprietà e un’ampia serie di competenze, ben prima di assumere la responsabilità del governo temporale. Quando, nel corso del secolo VIII, si pose alla guida dello sforzo di emancipazione dell’Italia da Bisanzio, le riuscì facile adattare le proprie istituzioni alle necessità di un governo su scala maggiore. A partire da que-sto momento il Patrimonio stava diventando non solo uno stato ma anche, e soprattutto, una entità politica autonoma, dotata di proprie strutture di governo, di un popolo pecu-liare e di un territorio che sarebbe servito, anche nelle mu-tate circostanze dei secoli successivi, come garanzia della li-bertà della Chiesa nello svolgimento della sua missione
VELLETRI NEL MEDIOEVO
20
evangelizzatrice, indipendentemente dall’estensione del ter-ritorio sotto la sua giurisdizione.
Durante il dominio bizantino su Roma i possedimenti pontifici furono detenuti dai vescovi a titolo ‘privato’ ed erano il risultato delle donazioni ricevute a vario titolo fin dai tempi costantiniani. Rimane in ogni modo impenetrabi-le l’ampiezza dell’effettivo controllo del vescovo sul suo ter-ritorio. È vero che Velletri rappresentava una delle più anti-che diocesi, ma è altrettanto evidente come fosse rimasta radicata sul territorio una forte componente legata alla tra-dizione romana. Negli stessi anni in cui Teodosio si accin-geva a dichiarare il cristianesimo religione ufficiale del-l’impero e a bandire i culti pagani, a Velletri veniva infatti restaurato il vecchio anfiteatro1; forse, con tutte le cautele che una ipotesi del genere comporterebbe, proprio in con-trasto alla diffusione del cristianesimo che andava caratte-rizzandosi nel territorio veliterno. Un’ipotesi questa che aprirebbe nuove prospettive circa il ruolo svolto dal vescovo in seguito all’edificazione della chiesa di San Clemente, che secondo le conclusioni finora accettate avrebbe come ter-mine post quem gli anni tra il 364 e il 375 d. C., periodo del rifacimento dell’anfiteatro curato dal principalis curiae Lollius Cyrius2. La prima menzione della chiesa di S. Clemente è ef-fettivamente del V secolo e si riferisce ad una lettera inviata da papa Gelasio I nel 496 al vescovo Bonifacio di Velletri, nella quale si chiedeva la restituzione del servo di un certo Pietro ivi rifugiatosi3. Un analogo episodio è legato alle vi-
1 O. NARDINI, L’anfiteatro di Velletri, in «Bollettino dell’associazio-
ne veliterna di archeologia, storia e arte», 1930, pp. 29-36. 2 M. COGOTTI, Storia e vicende costruttive della cattedrale di S. Clemen-
te, in EADEM, La cattedrale di S. Clemente a Velletri, Roma 2006, p. 47. 3 P.F. KEHR, Regesta Pontificum Romanorum, Italia Pontificia, II, La-
tium, Roma 1907, p. 102.
GLI AVVENIMENTI
21
cende della basilica di S. Clemente in Roma, la cui costru-zione è databile tra la fine del IV e l’inizio del V secolo. Una lamina inserita in un collare, già conservata nel museo privato di Lelio Pasqualini4, incisa su entrambi i lati, rac-conta infatti di un servo fuggiasco che doveva essere ricon-dotto al chierico Vittore della chiesa di S. Clemente: tene me quia fugi et reboca me Victori acolito a Dominicu Clementis / fu-gi Euplogio ex praefecto Urbis. L’asilo per tutti coloro che si fossero rifugiati in una chiesa, nelle sue dipendenze o nella casa di un vescovo, inclusi gli schiavi fuggitivi, i quali non sarebbero stati riconsegnati al proprietario se questi non avesse giurato sulla Bibbia di non essere crudele, fu poi san-cito nel 511 durante il Primo Concilio di Orléans5.
Sia l’intitolazione a Clemente che la sua posizione vici-na al foro sembrerebbero dunque confermare la collocazio-ne cronologica della chiesa veliterna nell’ambito del V seco-lo, anche se la presenza cristiana a Velletri doveva risalire almeno al secolo precedente, come testimoniato dal cimite-ro paleocristiano rinvenuto poco fuori Porta Napoletana. In esso fu trovata una lapide che per i caratteri grafici poteva effettivamente datarsi nell’arco del IV secolo6. La multifor-me realtà di culto in questo periodo sembrerebbe peraltro evidenziata dai toponimi di alcuni fondi veliterni di chiara
4 G.B. DE ROSSI, Bullettino Archeologia Cristiana, 4, Roma 1863, p. 26. 5 M. ASPRONE, Il diritto d’asilo e lo status di rifugiato, Roma 2012, p.
16 n. 12. 6 V. FIOCCHI NICOLAI, Topografia cristiana di Velitrae e territorio in
età Tardoantica: una messa a punto, in Augusto a Velletri, «Atti del conve-gno di studio» (Velletri 16 dicembre 2000), Velletri 2001, pp. 140-149; G. SCHNEIDER GRAZIOSI, L’antico cimitero cristiano di Velletri, in «Bullet-tino della Commissione Archeologica Comunale di Roma», XLI (1913), pp. 225-255; B. BELARDINI, Nuove acquisizioni sul cimitero paleocristiano di Velletri fuori Porta Napoletana, in «Rivista di Archeologia Cristiana», LXVIII (1992), pp. 183-200.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
22
derivazione pagana: Soleluna, Ancarano, Paganico ai quali si opponevano quelli di S. Pietro, S. Tommaso e S. Stefa-no7. In ogni modo, a partire dal secolo VIII, dopo la fine del dominio bizantino, la Chiesa rivendicò la totale giuri-sdizione sui territori ed è questo il periodo in cui si dovrà ricercare il definitivo controllo politico del vescovo veliter-no sulla sua diocesi. Testimonianza indiretta di questo pas-saggio può essere fornita da una epigrafe databile agli inizi del secolo VIII, in cui sono elencati quattro fondi apparte-nenti alla basilica dei SS. Giovanni e Paolo8 di cui uno, il fondo Cosconis – evidentemente dopo la riorganizzazione territoriale – entrò, o tornò, a far parte dei possedimenti del vescovo veliterno9.
Sul finire del secolo IX, in ogni modo, il sistema legato alle domus cultae, entità residenziali e produttive autosuffi-cienti e fortificate intorno a Roma10, su cui i papi avevano
7 Il rinvenimento in queste zone di iscrizioni sia pagane che cri-stiane testimonierebbe il radicato decentramento di autonomi insedia-menti nel territorio veliterno (O. NARDINI, Iscrizioni rinvenute in Solluna, in «Notizie degli scavi di antichità», 1922, pp. 250-251; G. MANCINI, Scoperta di un antico sepolcreto cristiano nel territorio veliterno, in Notizie de-gli scavi, cit., 1924, pp. 138-142. Lungo la via Appia le rovine di una vil-la erano così grandiose da farle considerare quelle di una città (L. QUI-
LICI, La via Appia antica attraverso il territorio di Velletri, in Augusto a Vel-letri, «Atti del convegno di studio, Velletri 16 dicembre 2000», p. 99).
8 D. DE FRANCESCO, Partizioni fondiarie e proprietà ecclesiastiche nel territorio romano tra VII e VIII secolo. Prospettive di ricerca alla luce dei dati epigrafici, in «Mélanges de l’École française de Rome. Moyen-Age» 110 (1998), p. 73.
9 Vedi infra, pp. 168-169. 10 Le domus cultae erano colonie fortificate organizzate militarmen-
te ma abitate da agricoltori, istituite nel territorio intorno a Roma dai papi Zaccaria e Adriano I nel corso del secolo VIII. Toubert ha inter-pretato questo sistema insediativo quale centro di gestione signorile di-retta in contrapposizione alle coloniciae a conduzione indiretta (P. TOU-
GLI AVVENIMENTI
23
cominciato ad esercitare i diritti concreti legati alla sovrani-tà, era andato smarrito nel momento in cui su questi fundi si erano organizzati i laici ad agrorum curam continuam depu-tati11, conseguenza della minacciosa presenza dei saraceni che dall’inizio del secolo compivano sanguinose incursioni in tutto il Ducato romano, arrivando nel 846 ad infliggere una dolorosa ferita nel cuore stesso di Roma12. Le domus cultae erano derivate dalla mutata configurazione economi-ca della Chiesa nel momento in cui, perduti i territori sici-liani, i possedimenti papali si rafforzarono intorno a Ro-ma13. Risulta in ogni modo assente la documentazione di queste strutture nel territorio veliterno che rimaneva inclu-so nel patrimonium Appiae. Una carenza che rende ancora di più difficile inquadramento la riorganizzazione economica avvenuta in questo periodo nei fondi velletrani, dove non sembrerebbe essersi dunque sviluppato il sistema legato alle domus cultae – con la conseguente aggregazione di vari fondi amministrati direttamente dalla Chiesa attraverso l’impiego di funzionari e coltivatori – ma, al contrario, alcuni di que-sti fundi del territorio sembrerebbero essere rimasti auto-nomamente orbitanti intorno ad un casale che ne caratte-rizzò l’economia sotto la guida del vescovo, come suggeri-rebbero alcuni topoi presenti nel documento del decimo se- BERT, Les structures du Latium Medieval, Le Latium méridional et la Sabine du IX siècle à la fin du XII siècle, École Française de Rome, «Bibliothèque des écoles françaises d’Athènes et de Rome, 221», 1973, pp. 456-458).
11 G. ARNALDI, Le origini dello Stato della Chiesa, Torino 1987, p. 93. 12 Liber Pontificalis, a cura di L. DUCHESNE, (2 voll.), Parigi 1886-
1892, II, pp. 98-101 (da qui in avanti Lib. Pont.) 13 Le Massae di Norma e Ninfa erano state concesse al papa Zacca-
ria nel 743 da Costantino V in cambio della restituzione delle terre ro-magnole (Lib. Pont., I, 220, p. 433.) Evidente la volontà papale nel voler privilegiare il rafforzamento del potere temporale intorno alla città di Roma.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
24
colo14. Condizione da ricondurre probabilmente sia alla esclusiva giurisdizione vescovile sia ad una precedente e già costituita riorganizzazione territoriale avanti la metà dell’VIII secolo15. Resta in ogni modo di difficile inqua-dramento, in mancanza di attestazioni certe, l’organizza-zione, la vita quotidiana e la gestione all’interno di questi casalia. Nel territorio veliterno la presenza di queste struttu-re sembrerebbe essere capillare e dovevano risultare altresì stabilmente abitate, prosecuzione naturale, seppur trasfor-mata, della vocazione insediativa caratteristica dell’età im-periale. Sembrerebbe infatti accertata l’esistenza tra V e VI secolo di un numero minore, ma di assai più grandi dimen-sioni rispetto all’età precedente, di complessi rustico-residenziali di alto livello contrassegnati da un continuum in-sediativo, segno della presenza di una forte aristocrazia ter-riera, un fenomeno già evidenziato in altre aree del Lazio meridionale16. Il territorio veliterno apparirebbe così con-trassegnato da una suggestiva sovrapposizione riscontrabile tra alcuni fondi altomedievali e gli insediamenti abitativi di
14 ACV, perg. 946. 15 F. MARAZZI, Roma, il Lazio, il Mediterraneo: relazioni fra economia e
politica dal VII al IX secolo, in La storia economica di Roma nell’alto Medioe-vo alla luce dei recenti scavi archeologici, «Biblioteca di Archeologia Medie-vale», Firenze 1993, pp. 274-277; D. DE FRANCESCO, La proprietà fondia-ria nel Lazio, secoli IV-VIII, storia e topografia, Roma 2004, pp. 188-190.
16 “Benché molte ville appaiano defunzionalizzate, o per meglio di-re rifunzionalizzate in favore delle nuove comunità di villaggio tra V e VI secolo, solo tra VII e IX secolo alcuni di questi centri demici origina-ti dalle ville, che non hanno avuto un insediamento di tipo monastico, tendono a scomparire e i loro territori vengono assorbiti dai nuovi ca-stra” (F.R. STASOLLA, Per una ricerca sul medioevo rurale nel Lazio meridio-nale, in Lazio e Sabina, 7, «Atti del convegno Roma 9-11 marzo 2010».
GLI AVVENIMENTI
25
età imperiale17. Residenze che potrebbero anche essere state abbandonate avanti al VII secolo e rifrequentate successi-vamente. La città di Velletri in età tardo repubblicana ed imperiale non ebbe particolare importanza, tanto che non ne troviamo specifica menzione nelle fonti se non come luogo di diffusa edilizia residenziale, avendo la zona goduto sempre di molta considerazione quanto ad amenità climati-ca18. Il Lilli, nel sostenere una fase importante per il centro veliterno fino almeno al I secolo d. C. in base al corpus epi-grafico, deve registrare che il materiale riferibile alle diverse attestazioni è di esclusiva provenienza extra-urbana19. Infine non sembra rilevante la presenza di curatores nella seconda metà del II secolo d. C. poiché questi soprintendevano ai lavori di edilizia da realizzarsi sia nei centri urbani che nel territorio. Quanto fin qui esposto non preclude ovviamente una frequentazione del centro urbano durante e dopo l’età imperiale, ma evidentemente esso subì una progressiva ri-duzione restringendosi nella zona della cattedrale. Di con-seguenza sarebbe anche possibile ipotizzare, con le dovute cautele, una sua funzione politico-amministrativa nei ri-guardi degli insediamenti del territorio, un ruolo che, se ac-certato, avrebbe potuto mantenere anche durante il periodo altomedievale in ambito vescovile20. Sotto il profilo istitu-
17 G. GHINI, La villa degli Ottavi a Velletri, in Augusto a Velletri, cit.,
pp. 36-43. 18 T. CECCARINI, L. CRESCENZI, Il materiale marmoreo, p. 127, in
Museo Civico di Velletri, Cataloghi dei Musei e delle collezioni del Lazio, 6, Roma 1989.
19 M. LILLI, Velletri, Carta archeologica, Roma 2008, p. 566. 20 Cfr. G. VOLPE, Il ruolo dei vescovi nei processi di trasformazione del
paesaggio urbano e rurale, pp. 95-100, in Archeologia e società tra Tardo An-tico e Alto Medioevo (a cura di G.P. BROGIOLO, A. CHAVARRÌA ARNAU), SAP Società Archeologica, 2007.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
26
zionale si può infatti riconoscere una continuità fra l’ordi-namento di tipo romano e quello cittadino perpetuato dal vescovo. Pur in considerazione della “variabilità” che con-traddistingue il panorama altomedievale regionale italiano, sono evidenti i casi di sostanziale differenza tra il carattere istituzionale e l’aspetto fisico di insediamento urbano: esemplare il caso di Herdonia, documentata come civitas an-cora in età costantiniana e sottoposta ad un processo, co-mune a molte città italiane, di progressiva destrutturazione e ruralizzazione nel corso della tarda antichità nonostante il mantenimento della sede vescovile21. Lo stesso Stefano Bor-gia fu costretto a registrare, con sua grande meraviglia, co-me Velletri e Albano non fossero state indicate fra le città del Ducato romano nei diplomi di Ludovico il Pio (778-840), Ottone I e Arrigo II che sancivano il dominio tempo-rale del Pontefice22. Già Gregorovius aveva avanzato l’ipote-si che l’assenza dei rapporti politici di queste città, in con-trasto alla menzione dei loro vescovati, fosse dovuta alla “niuna importanza di quei luoghi, per il decadimento in cui erano precipitati”23. La condizione di diocesi rurale per Al-bano è d’altra parte sicuramente acclarata, riflesso di un fe-nomeno molto comune in area centrale tra il V e il VII se-colo24. La situazione tipica delle diocesi altomedievali si pa-lesava d’altronde come un aggregato di pievi, chiese, fondi, casali e curtes25. Bisogna infine sottolineare che i vescovi
21 Ivi, p. 87. 22 S. BORGIA, Breve Istoria del dominio temporale della Sede Apostolica
nelle Due Sicilie, Roma 1788, p. 288. 23 F. GREGOROVIUS, Storia della Città di Roma nel Medioevo, II, Ve-
nezia 1872, p. 517. 24 VOLPE, Il ruolo dei vescovi, cit. pp. 95-97. 25 E. PETRUCCI, Pievi e Parrocchie nel Lazio nel basso Medioevo, in Pievi
e parrocchie in Italia nel basso Medioevo, sec. XIII-XV, Roma 1984, p. 908.
GLI AVVENIMENTI
27
non dimoravano stabilmente presso le loro diocesi. Il ve-scovo di Velletri Gauderico, nella seconda metà del secolo nono, è attivamente impegnato a partecipare alla vita curia-le, ai vari concilii,26 e come legato pontificio a frequentare la corte dei re Franchi27. La sua residenza sembrerebbe esse-re fissata presso la basilica Lateranense. Secondo quanto narrato da Giovanni Diacono, infatti, Gauderico ritrovò all’interno di un antico altare della Beata Vergine al Late-rano due vasetti contenenti particelle della tunica di S. Giovanni28, attestazione questa di una frequentazione cer-tamente non sporadica della Curia romana.
Dall’atto di enfiteusi del 946 [pp. 181-189] – di cui si parlerà più oltre – e dai dati topografici ivi inseriti (vedi mappa), possiamo desumere con buona certezza che il mons nel territorio veliterno su cui fu costruito il castello può es-sere identificato con l’attuale centro cittadino di Velletri, il quale doveva presentarsi conseguentemente disabitato poi-ché il consul e dux Demetrio si impegnò ad aggregare la popolazione intorno al castello, oltre a consolidare fondi e casali del territorio circostante anche attraverso il restauro degli antichi edifici e delle nuove adiacenze, segno evidente questo di una continua frequentazione o rifrequentazione degli antichi insediamenti romani. L’uso del legno e di ma-teriali deperibili o di murature meno accurate nel periodo
26 Gauderico nel Concilio romano dell’869 svolse un ruolo de-
terminante nella condanna di Fozio. Un’ampia documentazione relati-va al concilio antifoziano e agli interventi dei vari personaggi, tra cui Gauderico, è contenuta in K.J. von HEFELE, H. LECLERCQ, Histoire des Conciles d’après les documents originaux, IV, I, Parigi 1911, pp. 326-342.
27 A. BORGIA, Istoria della chiesa e città di Velletri, Nocera 1723, pp. 151-156
28 M.A. BOLDETTI, Osservazioni Sopra I Cimiteri De’ Santi Martiri, Ed Antichi Christiani di Roma, Roma 1720, p. 689.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
28
altomedievale non fu necessariamente un segno di abban-dono e di uso solo provvisorio, anche se è possibile co-gliere in esso un carattere marginale, che vide un declino inesorabile di quei nuovi agglomerati che si inserirono su
Mappa – I fondi del territorio sicuramente identificabili nella concessione enfiteutica del 946.
ville romane a partire dalla seconda metà del VII secolo29. Che il luogo ove venne costruito il castello e la zona ad esso circostante siano stati progressivamente abbandonati a par-
29 A. CASTRORAO BARBA, Ville romane e riusi tra Tardantichità e Al-
tomedioevo: per un bilancio nazionale, in F. REDI, A. FORGIONE (a cura di), «Atti del VI Congresso Nazionale di Archeologia Medievale», Firenze 2012, pp. 175-180.
N
GLI AVVENIMENTI
29
tire dall’età imperiale sembrerebbe altresì confermato dalle indagini archeologiche che ne testimoniano una frequenta-zione solamente fino alla tarda età repubblicana.30 Ulteriore indiretta identificazione di un insediamento sparso sul ter-ritorio veliterno è data dalla linea difensiva e fortificata, contro gli attacchi saraceni, realizzata ai confini meridionali del territorio (fundus paritorum); è evidente che se la popola-zione fosse stata raccolta nell’attuale centro cittadino la suddetta linea semaforica non avrebbe avuto alcuna valen-za31, nonché la presenza di un castellum in uno spazio extra-urbano a poche centinaia di metri dalla cattedrale32.
I due termini “fondo” e “casale”, pur se tra loro assimi-labili, descrivevano due entità con funzioni differenti. Il ca-sale rappresentò una nuova tipologia di proprietà terriera con caratteri simili al fondo, con il quale arrivò spesso ad identificarsi. È presumibile che i casali veliterni del periodo altomediovale abbiano assimilato l’accezione di abitazione rustica e siano stati utilizzati per le necessità dei lavori agri-coli e per l’alloggio dei coltivatori. Nei primi secoli del Me-dioevo, sotto la qualificazione di casale poteva essere identi-ficata una qualsiasi delle portiones del fundus, compresi i ter-
30 LILLI, Velletri, cit., pp. 556-596. Cfr. G.L. GREGORI, Velletri tar-
dorepubblicana e imperiale. Materiali e appunti per un profilo di storia istituzio-nale e sociale, in L. DRAGO TROCCOLI (a cura di), Il Lazio dai Colli Albani ai monti Lepini tra preistoria ed età moderna, Roma 2009, pp. 495-529).
31 L’alternativa alla successione lineare delle torri era costituita dal sistema centrico impostato attorno alle civitates maggiori. Il sistema se-maforico tra Anzio e Velletri era costituito dalle torri di Capo d’Anzio e del Monumento, dalla torre del Padiglione, dalla torre di Spaccasassi, dalla torre di Lazzaria e, presso i Colli Albani, dalla torre di Presciano e dalla torre dei Monaci (D. FIORANI, Architettura e cantiere delle strutture fortificate, in G. GIAMMARIA (a cura di), Castelli del Lazio meridionale, Roma-Bari 1998, p. 58 e p. 102 n. 7).
32 Vedi infra p. 180.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
30
reni posti nelle immediate vicinanze della villa, ossia appun-to della casa33. L’assenza di fonti documentarie non ci per-mette di conoscere il numero dei residenti all’interno di questi insediamenti, che doveva in ogni modo rimanere modesto, nel numero di alcune decine; tuttavia la valuta-zione complessiva del quadro fin qui delineatosi suggerisce una consistente e piuttosto omogenea distribuzione della popolazione per tutta l’estensione della campagna veliterna. In alcuni casi il fondo finì per essere identificato dalla pre-senza stessa di un casale – fundus casale piscatorum, fundus ca-sale cesarea, fundus casale cerqua revolosa, segno evidente della loro caratterizzante attività o peculiarità – oppure dalla pre-senza di chiese rurali che si ponevano in relazione diretta con i fondi su cui sorgevano: S. Stefano, S. Pietro e S. Tom-maso. Purtroppo questi insediamenti risultano invisibili alla ricerca archeologica soprattutto in un territorio altamente urbanizzato come quello veliterno; quel mondo rurale, che affidava le sue costruzioni al legno piuttosto che alla pietra, ha lasciato tracce troppo labili per essere colte da una sem-plice ricognizione di superficie.
I numerosi fondi in cui era suddiviso il territorio di Velletri non risultavano molto estesi, definiti da naturali confini che rimarranno quasi immutati nel corso dei secoli e riscontrabili ancora oggi nei limiti delle attuali contrade. Essi mantennero evidentemente un’unità economico-ammi-nistrativa prima ancora che un’entità fisica, una condizione probabilmente derivata da tradizioni antiche dovute alla con-tinuata e diretta gestione del territorio veliterno da parte del
33 Cfr. M. LENZI, Per una storia dei casalia del territorio romano nel-l’Alto Medioevo, note di lavoro, in S. CAROCCI, M. VENDITTELLI, L’origi-ne della campagna romana. Casali, castelli e villaggi nel XII e XIII secolo , Roma, “Miscellanea della Società Romana di Storia Patria”, 47 (2004), pp. 315-317.
GLI AVVENIMENTI
31
vescovo fin dalla originaria istituzione dei patrimonia34. Re-stano in ogni modo ignoti i rapporti tra gli eventuali nu-clei abitativi del territorio e tra questi e il vescovo, che sa-rebbe rimasto l'ente proprietario esclusivo dei fondi dell'intera diocesi. Le origini di questi casalia nel territorio veliterno, pur nel probabile contesto di un continuum con l’età imperiale, dovrebbero essere ricercate con il processo di ridefinizione dell'assetto della proprietà fondiaria che trasfigurò l’ordine ereditato dall’età tardo antica, relativa-mente sia alla composizione sociale del ceto proprietario che all’organizzazione degli spazi agrari. Un processo che avrebbe avuto la sua caratterizzazione e codificazione nel corso della seconda metà del secolo ottavo. Certo è che i coloni fino ad allora insediati nei vari casali nel corso del X secolo dovettero rispondere positivamente all’invito del Duca ottenendo in cambio una casa, un orto ad essa ad-dossato, terreno da coltivare e condizioni giuridiche favo-revoli, come la piccola quantità di servizi da prestare sul fondo del signore.
Alla fine del IX secolo un ristretto numero di famiglie nobili si erano intanto insediate a capo della politica roma-na i cui membri, nelle fonti coeve, troviamo qualificati co-me nobiles viri, duces, consules, secondo una reinterpretazione della tradizione bizantina35. Queste famiglie erano legate tra
34 La creazione dei patrimonia dovrebbe risalire alla fine del V seco-
lo, quando si attuò una riorganizzazione delle rendite, in gran parte sot-toposte al controllo vescovile, basata su una ripartizione geografica delle proprietà fondiarie delle varie diocesi (F. MARAZZI, Il patrimonium Ap-piae: beni fondiari della Chiesa Romana nel territorio suburbano della via Ap-pia tra il IV e IX secolo, in «Archeologia laziale», 10 (1990), p. 118.
35 I titoli adottati a Roma in questo periodo possono essere inter-pretati come imitazione dei reggitori dei potentati meridionali che ave-
VELLETRI NEL MEDIOEVO
32
loro da relazioni di parentela e da interessi economici e controllavano le principali cariche del governo pontificio. In questo particolare momento storico si andò verificando un progressivo mutamento della gestione politica di Roma e del suburbio, nella direzione di una volontà di effettiva dominazione territoriale. Causa ed effetto di questa nuova situazione fu l’ascesa politica di Teofilatto, che riuscì a ga-rantire una grande stabilità di governo. Nel 915, all’apice della sua potenza, negoziò per conto di papa Giovanni X, probabilmente in qualità di senator Romanorum, l’alleanza con i principi dell'Italia meridionale che portò alla vittorio-sa azione contro i saraceni nella battaglia del Garigliano. Teofilatto al momento della sua morte era riuscito a tra-sformare il governo su Roma e a garantire alla sua famiglia una sorta di principato dinastico. Una volta realizzata la pa-cificazione ebbe inizio quindi l'incastellamento della regio-ne, un fenomeno che mirava a garantire un mezzo più con-sono all’esercizio del potere. Il ruolo decisivo di questo pro-cesso fu giocato dal princeps Alberico, nipote di Teofilatto e figlio di Marozia, la quale alla morte del padre aveva preso saldamente in mano, anche grazie a convenienti matrimoni, il potere politico romano tanto da ricevere l’appellativo di senatrix e patricia. Alberico prese il potere nel 932, ribellan-dosi alla madre nel giorno delle sue terze nozze con Ugo di Provenza, in un moto di evidente insofferenza da parte dell’aristocrazia romana che vedeva messa in pericolo la propria autonomia, e lo mantenne per oltre venti anni, du-rante i quali consolidò l'incastellamento nel Patrimonium vano riaffermato la loro autonomia all’interno della sfera d’influenza bizantina. Nei primi diplomi il duca di Napoli s’intitolava consul et dux, successivamente e costantemente consul, dux et magister militum; i primi due titoli assunti Dei nomine, il terzo Domini gratia (M. AMELOTTI, Per una storia del notariato meridionale, Roma 1982, p. 340).
GLI AVVENIMENTI
33
Sacti Petri e favorì il progetto di riforma monastica. In que-sto periodo fu evidente la sinergia tra la società civile e quel-la ecclesiastica – papa Marino II fu descritto come una crea-tura nelle mani di Alberico – che portò il nuovo gruppo di-rigente a realizzare un reale esercizio politico nella regione. I membri della corte di Alberico parteciparono attivamente a questo processo. Tra essi si distinse Demetrio di Melioso, il quale nel 946 ricevette l’incarico di aggregare la popolazio-ne di Velletri attorno al castello appositamente costruito36. Suo padre non aveva un nome molto comune e non è pre-cedentemente attestato nelle fonti; il nonno potrebbe essere stato il Demetrio che risulta aver ricoperto la carica di arca-rius nel 92637. Demetrio de Umiliosum era dunque uno dei personaggi più in vista della corte di Alberico – già presente al placito del 17 agosto 942, convocato dal princeps per di-rimere la questione tra l’abbazia di Subiaco e alcuni cittadi-ni di Tivoli che avevano occupato un terreno del monaste-ro38 – e potrebbe essere stato in realtà figlio del Iohannes eminentissimus consul et dux che nel 913 acquistava terreni a nord di Roma39. Consul romanorum, Demetrio nel 963 è pre-
36 ACV, Perg. 946. 37 Nel privilegio di Giovanni X all’abate del monastero di Subiaco
sottoscritto per manum Demetrii Dei providentia arcarius s. Sedis apostolicae (Il Regesto sublacense dell’undicesimo secolo, a cura di L. ALLODI, G. LEVI, Roma, «R.SRSP», 1885, n. 9, pp. 18-19 (da qui in avanti Reg. Subl.).
38 Reg. Subl., n. 155, pp. 202-204. Oltre a Demetrio erano presenti Benedetto Campanino, Caloleo, Giorgio de Cannapara dux, Teofilatto vestarario, Giovanni superista, Balduino, Franco, Gregorio dell’Aventino, Benedetto Mitcino, Crescenzio, Benedetto da flumen, Benedetto di Leone di Aza, Adriano dux e Benedetto di Sergio.
39 Il personaggio è passato alla storia come figlio di Melioso, ma la sua genealogia non è certa. Melioso (da Umile) è un nome quasi del tutto sconosciuto nel X secolo e soprattutto poco consono ad una fami-glia di alto lignaggio che poteva rivendicare il titolo di eminentissimus del
VELLETRI NEL MEDIOEVO
34
sente, tra i nobili romani, al sinodo convocato in San Pietro per giudicare Giovanni XII40 e nel 968 lo troviamo in Ger-mania – Liutprando lo definì l'illustrior degli optimates ro-mani – dove si era recato per chiedere l’aiuto dell’impera-tore Ottone per conto della nobiltà romana41. Una più at-tenta lettura del documento di enfiteusi del 946, già edito in parte da Alessandro Borgia42 e integralmente da Enrico
quale si fregiarono sia lo stesso Demetrio che suo figlio Giovanni. Que-sto titolo è in verità appannaggio di non più di dieci persone tra tutti i soggetti presenti nei documenti romani di quel periodo. Giovanni di Demetrio non era un personaggio così autorevole da poter ritenere che egli se ne sia investito autonomamente; dobbiamo quindi presumere che il titolo poteva essergli stato trasmesso per via ereditaria. Ipotizzan-do che Umile fosse in realtà un aggettivo caratterizzante il personaggio in questione, resterebbe in ogni modo da accertare il vero nome del ge-nitore di Demetrio e soprattutto rispondere al perché i contemporanei sentirono il bisogno di identificarlo come tale. Facendo riferimento al titolo di eminentissimus, la risposta potrebbe essere fornita dal documen-to del 913 (Reg. Subl., n. 115, pp. 162-163), che vide protagonista un Giovanni eminentissimus consul et dux. La ragione che avrebbe portato questo personaggio a dover essere idenficato poi come humilis è insita nello stesso documento, sottoscritto da un altro differente Giovanni consul et dux. Demetrio sottoscrivendosi semplicemente come figlio di Giovanni consul et dux avrebbe potuto dare origine ad una sicura confu-sione anche tra i suoi contemporanei. Restando in ogni modo incerta l’attendibilità di questo legame, anche se ampiamente plausibile attra-verso la linearità del titolo di eminentissimus, mi limito a proporre questa tesi per ampliare la scelta degli scenari possibili.
40 Nel “conciliabolo” che sancì la deposizione del papa, tra le nu-merose personalità era presente anche il vescovo veliterno Leone, pre-sumibilmente lo stesso che aveva concesso nel 946 il contratto enfiteu-tico a favore di Demetrio.
41 C. G. MOR, L’età feudale, II, Milano 1953, p. 116. 42 BORGIA, Istoria, cit., pp. 158-159.
GLI AVVENIMENTI
35
Stevenson43, evidenzierà come la concessione del mons ad castellum faciendum con molti fondi e pertinenze non fosse relativo a un non meglio precisato luogo del territorio veli-terno, ma coincideva con la zona che avrebbe in seguito co-stituito il centro della stessa città, dove aveva pulsato la vita dell’antico municipium romano, però a quel tempo oramai disabitato44. Se si avrà la pazienza di seguire i territori citati nel documento, infatti, ci si renderà facilmente conto che questi non erano alcune pertinenze date in concessione, ma rappresentavano quasi l’intero territorio veliterno all’inter-no di quei confini, confermati dai pontefici nei secoli suc-cessivi, che racchiudevano in cerchio la collina dove sarebbe sorto l’attuale centro abitato45. Il quadro emergente fornisce altresì lo spunto per indagare ulteriormente il ruolo e l’effettivo potere esercitato dai vescovi nelle loro diocesi, che sembrerebbe risultare esclusivo. L’atto di enfiteusi ven-ne sottoscritto non dal papa ma dal vescovo Leone, segno evidente che questi deteneva lo ius disponendi sul territorio, ma anche che l’antica civitas veliterna non conservava più lo status di città, essendo ridotta evidentemente ad un piccolo
43 E. STEVENSON, Documenti dell’archivio della cattedrale di Velletri,
in Archivio della R. Società di Storia Patria (ASRSP), 12 (1889), pp. 73-80. Tutti gli storici che in seguito si sono richiamati a questo documen-to hanno accettato la lettura secondo la quale essa identificava la co-struzione del castello in un non meglio precisato luogo sito nel territo-rio di Velletri, secondo quanto proposto dal Borgia.
44 Pur se elaborata in modo del tutto autonomo, questa tesi risulta essere stata sommariamente presentata già nel 2005 (C. LAMPE, Contri-buti alla storia di Velletri medioevale, in «Castelli Romani», 6 (2005), pp. 166-173). L’autore non sembra però interessato a supportare con ri-scontri oggettivi la sua intuizione.
45 Per l’individuazione di questi fundi rispetto all’odierno territorio di Velletri vedi infra, pp. 167-178.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
36
insediamento prossimo alla cattedrale46. Il vescovo veliterno concesse al consul e dux Demetrio fino alla terza generazione, forma consueta dei contratti di locazione da parte degli enti ecclesiastici, un mons con molti fondi e territori, al fine di co-struirvi un castello ad eccezione di una insula intorno alla chiesa di S. Clemente, circoscrivibile grosso modo a sud della chiesa stessa fino alla zona di Acquavivola – i cui confini sono dettagliatamente descritti nello stesso documento –, all’interno della quale è testimoniato un insediamento fino all’età medio imperiale47 con una probabile frequentazione del sito anche nel periodo altomedievale, dal momento che nel contratto enfiteutico del 946 il vescovo si riservò questa porzione di territorio che includeva campi, vigne e terre (cum campis et vineis et terris). È risultata infatti evidente la coincidenza topografica tra l’isola e il sito di Colle Palazzo
46 Questo potere traspare anche nella concessione, operata nel 959
da parte del vescovo verolano Giovanni a favore di Roffredo Consul et Dux Campaniae, di un vasto fondo munito di lago, terre, selve da rende-re coltivabili e pescherie (C. SCACCIA SCARAFONI (a cura di), Le carte dell’archivio capitolare della cattedrale di Veroli, ISALM, Roma 1960, n. 176, 9 giugno 959), anno corretto da Toubert come 960 (TOUBERT, Les structures, cit., p. 628). La totalità delle pertinenze del tenimento, che si dicono nel testo già definite indeterminatamente in antico, pre-suppongono certamente l’esistenza di una numerosa manodopera im-piegata nei lavori agricoli e nell’attività della pesca e in generale una presenza demica ivi stabilmente residente. Il fondo di Manilano si configurava quindi come un vero e proprio centro agglutinante di popolamento (S. DEL FERRO, Il ruolo delle signorie monastiche nell’arti-colazione del popolamento del Lazio medievale. La Diocesi di Veroli , in G. MACCHI JANICA (a cura di), Geografie del popolamento: casi di studio, metodi, ricerche, «Atti della giornata di studi 24-26 settembre 2008», Siena, 2009, pp. 337-338).
47 C. MENGARELLI, Le indagini archeologiche nel sito di Colle Palazzo: il contesto tardo-antico, in Museo e Territorio, IV, Roma 2005, pp. 187-189.
GLI AVVENIMENTI
37
intorno alla chiesa di S. Clemente48. Nel contratto venne espressamente stabilito che esso sarebbe risultato nullo se il Duca e i suoi eredi legittimi non ne avessero rispettato i termini: costruzione del castello, aggregazione del popolo intorno ad esso49, messa a coltivazione dei terreni con viti ed alberi da frutto e favorito l'allevamento del bestiame. Da questo quadro si evince come la collina che oggi rappresen-ta il nucleo dell’abitato di Velletri, sulla quale erano rimasti abbandonati i ruderi dell'antica Velitrae, fosse allora com-pletamente disabitata; del resto già Toubert aveva evidenzia-to che alcuni castelli potevano essere stati realizzati su pree-sistenze d’età romana50, anche se effettivamente lo storico francese non ipotizzò alcun nesso sostanziale tra siti antichi e popolamento51.
Il contratto di enfiteusi tra il vescovo Leone e il consul et dux venne evidentemente concluso e Demetrio costruì il castello sulla sommità del colle, un luogo ancora oggi cono-
48 Vedi infra, pp. 179-181. 49 A causa di un guasto nella pergamena il passo si legge debet … ga-
re popolum, che Borgia integrò con debet ac agregare popolum, ma è proba-bile che la dizione originale fosse congregare popolum formula usata in molti documenti coevi al pari di amasare homines.
50 TOUBERT, Les structures, cit., p. 794 n. 3. Egli, citava gli esempi di Fogliano e di Affile.
51 Alcuni dei centri che acquistarono nuova importanza nel Me-dioevo non furono mai del tutto abbandonati mentre altri come Cora, Norba e Circei appaiono spopolati fin dall’età imperiale. L’insediamento di pianura sopravvisse fino al periodo dell’incastellamento anche nelle zone di Priverno, Sonnino, Roccasecca dei Volsci e Maenza (M. CAN-
CELLIERI, Privernum: i mosaici della domus dell’Emblema figurato. Dati vecchi e nuovi, Atti III Coll. AISCOM, 1996, pp. 619-642). Per un ulte-riore contributo sul rapporto tra popolamento e incastellamento ri-mando al mio saggio: F. LAZZARI, Il ripopolamento delle antiche civitates romane del Lazio meridionale nell’ottica del primo incastellamento (X-XI seco-lo), in «Annali del Lazio meridionale», XIV/1, 27 (2014), pp. 7-19.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
38
sciuto con questo toponimo e che tre secoli dopo avrebbe fornito il nome ad una delle decarcie cittadine, oltre che il simbolo principale dello stemma municipale che rimarrà immutato nei secoli, nonostante il castello non esistesse più probabilmente già dal XIII secolo. L’esistenza del castello è peraltro confermata, oltre ogni ragionevole dubbio, in un atto del 1042 relativo alla vendita di un terreno sito nel ter-ritorio veliterno nel fondo Bussetulu da parte di Boniza, Sas-so e Costanza avitatoris Velliternensis kastello52. In un altro at-to del 1136 al contrario un certo Benone di Benone “Ferra-rii” è citato come habitator Velletrensis civitatis53. Evidente-mente nell’arco di tempo intercorso tra queste due date av-venne la trasformazione politica del centro veliterno da ca-stello a civitas, verosimilmente intorno al 1089 anno in cui Urbano II confermò a Velletri gli antiqua privilegia vestre civi-tatis nobis cognita54. La riforma istituzionale avvenne in ogni modo non prima del 1082, come termine post quem, poiché il privilegio di Pasquale II del 110255 faceva riferimento alle precedenti concessioni di Gregorio VII, evidentemente suc-
52 ACV, Perg. 1042. Pur tenendo conto della limitazione fornita
da una singola documentazione, i nomi dei protagonisti di questo atto evidenziano un aspetto non secondario circa l’influsso dei ceti domi-nanti sul sistema onomastico locale. Mentre i personaggi maschili risul-tano portatori di nomi in qualche modo legati alla continuità onoma-stica familiare (Pietro di Pietro) oppure d’influenza germanica (Sasso), i nomi femminili si richiamano espressamente a quelli della famiglia du-cale. Nel documento in questione Costanza e Boniza, suocera e nuora, dovevano avere rispettivamente intorno ai 50 e 25 anni e conseguente-mente nate avanti l’anno Mille la prima e intorno al 1015 la seconda. I rispettivi genitori erano stati indubbiamente testimoni del matrimonio del dux Giovanni con Costanza nobilissima femina. Boniza era il nome della sorella del duca Giovanni.
53 ACV, Perg. 11 agosto 1136. 54 Il privilegio è edito in BORGIA, Istoria, cit., pp. 204-205. 55 BORGIA, Istoria, cit., pp. 208-210.
GLI AVVENIMENTI
39
cessive al privilegio del 1081 dove Velletri era ancora no-minata come castrum56. Una condizione in ogni modo non definitiva, poiché successivamente la città si trovò di nuovo in mano alle forze antipapali.
Nel documento del 946, dove peraltro erano anche de-finiti i termini contrattuali relativi ai beni prodotti nel terri-torio, non viene fatto cenno alcuno alla costruzione di ope-re di difesa. Questo farebbe supporre che le mura della città vennero costruite solo successivamente, quando sarebbero mutate le condizioni politiche internazionali, e conferme-rebbe che il primo periodo di incastellamento, più che co-me atto di difesa contro invasioni esterne, fu il risultato di una volontà politica che tese a garantire e rafforzare l’esercizio del potere sulle popolazioni di un suburbio ora-mai pacificato. Il vescovo di Velletri fu quindi sin dalle ori-gini espressione dei ceti dominanti locali e raccolse attorno a sé le istanze della cittadinanza, provvedendo ad adottare le decisioni di merito per la risoluzione dei problemi comuni. Il potere vescovile si era indubbiamente rafforzato durante il periodo carolingio, quando i Franchi contribuirono a strutturare una società – la cui formazione era in ogni mo-do già cominciata nei decenni centrali del secolo ottavo – che modificò anche gli assetti delle campagne, dove il nu-mero dei liberi proprietari si assottigliò a favore di grandi possidenti fondiari. Studi recenti suggerirebbero infatti che le risorse prodotte durante questo chiaro processo di cresci-ta siano state indirizzate, durante l’età carolingia, verso un sistema che non ridistribuiva le ricchezze, ma le convogliava verso l’univoca direzione del potere ecclesiastico57. Sulla ba-
56 B. TRIFONE, Le carte del monastero di San Paolo di Roma dal secolo XI al XV, in «ASRSP», 31 (1908), pp. 278-279.
57 C. CITTER, L’Italia centrale tirrennica in età carolingia. Spunti di rifles-sione alla luce del dibattito attuale, in G. VOLPE, P. FAVIA (a cura di), «Atti
VELLETRI NEL MEDIOEVO
40
se di una ampia casistica è stato inoltre rilevato che durante questo periodo avrebbero convissuto insediamenti sia di ti-po sparso che di altura, un momento che rappresentò una forte discontinuità per via della rilevante presenza di siti “nuovi” o della rioccupazione di siti abbandonati da lungo tempo58. Dopo la dissoluzione dell’impero carolingio, in ogni modo, i vescovi mantennero e rinsaldarono ancor di più il ruolo guida in ambito politico-amministrativo, quan-do contadini piccoli proprietari e coltivatori liberi, coloro cioè che lavoravano dietro contratto nel massaricio di un'a-zienda, trasferirono la loro residenza in un’area più sicura e organizzata, gettando le basi per la costituzione dei centri comunali del periodo successivo. La possibilità da parte del-le élites laiche ed ecclesiastiche di controllare più efficace-mente la popolazione rurale determinò il rafforzamento del centro del potere locale e la terra, la proprietà, i contadini, l’aristocrazia fondiaria ne uscirono trasformati e la grande proprietà vide potentemente rafforzate certe tendenze, che le erano già connaturate da secoli. La profonda sinergia fra clero e laicato si esplicitò così in una compartecipazione nell’azione sociale e in quella comune gestione politica me-glio conosciuta come papato aristocratico, che portò all'as-segnazione di territori e a investiture di tipo feudale – an-che se tecnicamente non si può parlare ancora di conces-sione beneficiario-vassallatica –, il cui inizio, nella zona a sud di Roma, può essere designato dal contratto di enfiteusi veliterno. Tra le altre concessioni in favore di privati dotate di una chiara sostanza negoziale si possono ricordare: quella operata nel 966 da parte del monastero benedettino di Su- del V Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, Foggia-Manfredo-nia 30 settembre – 3 ottobre 2009», Firenze 2009, pp. 302-305.
58 H. PATTERSON, Rural settlements and economy in the middle Tiber valley: AD 300-1000, in «Archeologia Medievale», 37 (2010), pp. 143-161.
GLI AVVENIMENTI
41
biaco a favore del nobile Milone e sua moglie Anastasia per il fondo Semisano nel territorio di Tivoli, con il fine di co-struire un castello e amasare homines59; quella del 970, dove papa Giovanni XIII concesse alla senatrix Stefania la città di Palestrina per la consueta durata di tre generazioni60, e quel-la della città di Terracina operata nell’anno Mille da papa Silvestro II a favore del conte Daiferio61. Probabilmente an-che Tuscolo era stata ceduta in enfiteusi ai Tuscolani62, e al-trettanto verosimilmente possiamo ipotizzare che questo sia potuto accadere per Setia, dove le fonti ricordano una Platea de Incastellatura nel punto più alto del colle culminante nell’attuale via del Castello63. Le vicende di Tusculum – dove risulterebbero assenti le fasi sia tardo-antiche che altome-dievali – sembrerebbero essere assimilabili a quelle di Velle-tri, cioè espressione di un incastellamento “riuscito” su siti antichi, connotato da uno sviluppo decisamente urbano. I due centri si configurarono quindi sin dall’inizio come qua-si-città piuttosto che come semplici castra: una progressiva condizione che per il centro tuscolano è supportata anche
59 Reg. Subl., n. 200, pp. 241-242. 60 P. FABRE, L. DUCHESNE, Le Liber Censuum de l’Eglise romaine, I,
Paris 1902-1910, pp. 406-407. 61 Sugli strumenti negoziali di cui si servirono i proprietari per la ge-
stione dei loro patrimoni vedi: M. LENZI, Forme e funzioni dei trasferimenti patrimoniali dei beni della Chiesa in area romana, in «Mélange de l’École fra-nçaise de Rome». Moyen Age, 111 (1999), pp. 771-859; IDEM, La terra e il potere. Gestione delle proprietà e rapporti economico-sociali a Roma tra alto e basso medioevo (secc. X-XII), «Miscellanea della Società romana di storia patria» 40, Roma 2000.
62 C. WICKHAM, Roma medievale, Crisi e stabilità di una città, 900-1150, Roma 2013, p. 74.
63 M.T. CACIORGNA, Marittima medievale. Territori società, poteri, Roma 1996, p. 186.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
42
dai dati archeologici64. Al momento delle su citate conces-sioni i centri di Palestrina e Terracina – così come anche quelli di Tivoli, unico centro veramente urbano del perio-do, e Veroli – erano chiaramente individuati come civitates, segno che avevano mantenuto una maggiore continuità abi-tativa rispetto alla situazione veliterna, anche se risulta evi-dente che essi dovettero subire in periodo altomedievale una decisa contrazione65. In questo periodo tutte le città del districtus urbis sembrano apparire prive di una propria iden-tità e di un’economia veramente urbana66. La situazione ve-literna risulta singolare anche riguardo al rapporto tra città e notariato: a differenza degli altri centri del territorio, nei secoli a cavallo dell’anno Mille non trova riscontro la pre-senza di alcun tabellio civitatis. I redattori veliterni dei do-cumenti si identificano regolarmente con il titolo di scrina-rio sancte Vellitrensis ecclesie, a imitazione precoce del model-lo romano dove i tabelliones urbis Romae vennero prima af-
64 V. BEOLCHINI, P. DELOGU, La nobiltà altomedievale in città e fuo-ri: il caso di Tusculum, in S. CAROCCI (a cura di), La nobiltà romana nel Medioevo, «École française de Rome», 359, Roma 2006, pp. 149-161.
65 Sulle vicende di Terracina si vedano: S, COCCIA, Le fortificazioni nel Lazio meridionale. Il quadro storico-archeologico dalla tarda antichità all’incastellamento, in GIAMMARIA, Castelli, cit., pp. 23-24 e M.T. CA-
CIORGNA, Una città di frontiera. Terracina nei secoli XI-XIV, Roma 2008. La contrazione urbana è ben rappresentata dalla città di Veroli, dove, “a partire dalla fine del X secolo, le fonti scritte attestano due importanti realtà possessorie: il vescovo e il monastero di S. Erasmo, posto nella città vescovile, in una posizione topograficamente urbana, ma ritenuta dalle fonti come esterna, dato molto interessante nella valutazione della percezione dello spazio urbano” (F.R. STASOLLA, Il ruolo delle signorie monastiche nell’articolazione del popolamento del Lazio medievale, in MAC-
CHI JANICA, Geografie del popolamento, cit., p. 332). 66 C. WICKHAM, Nobiltà romana e nobiltà italiana prima del Mille:
parallelismi e contrasti, in S. CAROCCI (a cura di), La nobiltà romana nel Medioevo, “École française de Rome” 359, 2006, p. 10.
GLI AVVENIMENTI
43
fiancati e poi soppiantati dagli scrinari di Curia67. Nel pri-mo documento sottoscritto tra privati (1042) relativo alla compravendita di un terreno sito nel territorio veliterno tra alcuni abitanti di Velletri, il rogatario è romano e si sotto-scrive come Guittimanno scrinarius sancte romane ecclesie nel-la rogatio e come scrinarius urbis Rome nella completio, così come fecero Guido nel 1037, in un atto a terza generazione operato dal monastero di S. Benedetto di Velletri in favore di Domenico prete e suoi eredi, e Giovanni l’anno successivo in un atto in cui Guittimanno68 appare come locatario a ter-za generazione di una terra “spettante all’episcopio”. A Tivo-li, invece, i sottoscrittori si definiscono tabelliones civitatis Ty-burtine, ma sono attestati anche scrinari civitatis Tyburtine; a Veroli i rogatari di X-XI secolo si dicono sempre tabelliones ci-vitatis Berulani e solo a partire dal 1069 cominciano a sotto-scriversi anche come scrinari sancte Berulanensis ecclesie69.
La più marcata destrutturazione della civitas veliterna ebbe probabilmente come concausa il completo abbandono del centro, avvenuto alla fine del VI secolo a causa delle in-vasioni longobarde e fu legata verosimilmente, come il resto del Ducato romano, alla presenza nel territorio di ampie proprietà imperiali, le quali furono spesso trasferite al pa-
67 Sul rapporto tra tabellioni e scrinari resta basilare il saggio: C.
CARBONETTI, Tabellioni e scriniari a Roma nei secoli IX-XI, in «ASRSP», 102 (1979), pp. 77-156.
68 Il personaggio potrebbe essere lo stesso Guimannus che nel 1059 risulta essere scrinario sancte Vellitrensis ecclesie.
69 Tra X e XI secolo troviamo tabelliones civitatis anche ad Anagni, Alatri, Nepi, Otricoli, Sutri, Gallese e Orte (F. SANTONI, Notarius civi-tatis. Rileggendo le fonti tra VI e XI secolo (pp. 220-222), in Civis/Civitas. Cittadinanza politico-istituzionale e identità socio-culturale da Roma alla prima età moderna, «Atti del Seminario internazionale (Siena-Montepulciano 10-13 luglio 2008)» a cura di C. TRISTANO e S. ALLEGRIA, Montepul-ciano 2009.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
44
trimonio ecclesiastico e a volte organizzate nella forma di massa fundorum70, una situazione che doveva caratterizzare anche il territorio veliterno71.
Tra le altre concessioni enfiteutiche di questo periodo, non sembrerebbe invece essere sostenibile l’identificazione del Castrum Vetus con il castello edificato nel 946 da Deme-trio di Melioso72. Il Castrum vetus fu infatti concesso a Cre-
70 M. DE FINO, Proprietà imperiali e diocesi rurali paleocristiane
nell’Italia Tardo Antica, in G. VOLPE, M. TURCHIANO (a cura di), Paesaggi e insediamenti rurali in Italia meridionale fra Tardoantico e Altomedioevo, «Atti del 1º seminario sul Tardoantico e Altomedioevo in Italia meri-dionale», (STAM 1), (Foggia 2004), Bari 2005; cfr. D. VERA, Forme della grande proprietà e poteri della città in Italia tra Costantino e Gregorio Magno, in «Mélange de l’École française de Rome, Antiquité» T. 111, 2 (1999), pp. 991-1025.
71 Con il termine “in territorio veliterno” venivano indicati tutti i luoghi all’interno della diocesi, che potevano però essere situati anche al di là dei confini altomedievali di Velletri. Tra i fondi citati nei vari documenti epigrafici possiamo ricordare infatti Presciano nella Massa Caesariana e Julianus nella Massa Trabatiana.
72 L’assimilazione tra i due castra (CACIORGNA, Una città di frontie-ra, cit., p. 173 e p. 175) ha generato incertezze sia per l’individuazione che per l’origine onomastica del sito. Sulla base del documento del 1380 che sancì la pace tra Velletri e Onorato Caetani (G. FALCO, Il Comune di Velletri nel Medio Evo (sec. XI-XIV), in «ASRSP», 39 (1916), p. 123), Castrum Vetus dovrebbe essere invece ricercato tra Cisterna e Tor-recchia vecchia. Nel citato documento fu stabilito infatti che gli abitanti di Velletri avrebbero potuto continuare a seminare nei territori situati al di fuori dei confini di Velletri. Questi erano elencati con un moto di evidente contiguità. Dapprima nella parte meridionale in direzione ovest-est: S. Pietro in formis, Conca, Le Castella (Castellarum), Cisterna e Castrum Vetus e poi nella direzione opposta procedendo verso nord: Presciano, Lazzaria, Casale della Mandria (Mandra), Lanuvio, S. Genna-ro, Nemi. Castrum Vetus non poteva essere quindi individuato con Vel-letri, né situato nel luogo ancora oggi conosciuto come Le Castella, ma evidentemente oltre Cisterna in un territorio, confinante con Velletri,
GLI AVVENIMENTI
45
scenzio di Teodora nel 978 dall’abate di S. Andrea in silice, il quale non aveva giurisdizione sul territorio veliterno, all’interno del quale Demetrio aveva ricevuto dal vescovo di Velletri la concessione a terza generazione. Nel 978 Deme-trio era ancora in vita, così come lo era suo figlio Giovanni, con tutti i diritti di esercitare il potere derivatogli dal con-tratto di enfiteusi. I confini indicati nel contratto del 946 poi, entro i quali il castello costruito da Demetrio doveva essere ubicato, sono inequivocabilmente quelli del territo-rio veliterno73, di cui S. Andrea in silice rappresentava il confine più meridionale prima di sterzare in direzione nord fino al ponte Minello, che ancora oggi delimita il confine veliterno con il comune di Genzano lungo la via Appia vec-chia.
Demetrio contribuì direttamente allo sviluppo urbano, sociale e politico di Velletri per circa quarant’anni fino al 987 (come termine ante quem), anno della sua morte74. Gli successe il figlio Giovanni, il quale continuò l’opera paterna almeno fino al 1026 quando è citato in un atto per aver da-to il suo consenso – iubente et consentiente dominus Iohannes dux [sic] – alla donazione di un terreno alla chiesa di Santa Lucia in Velletri nel giorno della sua consacrazione75. Gio-vanni di Demetrio, che rivestì tra l’altro la carica di vestara- che una “logica geografica” tenderebbe ad identificare nell’attuale terri-torio di Torrecchia Nuova.
73 Vedi infra, pp. 164-167. 74 Quell’anno, Giovanni eminentissimus consul et dux Demetrii quon-
dam bone memorie, con le sorelle Boniza e Teodora, donò l’insula Licao-nia, l’attuale isola Tiberina, al monastero dei SS. Bonifacio e Alessio all’Aventino (F.M. NERINI, De templo et coenobio sanctorum Bonifacii et Alexii historica monumenta, Roma 1752, pp. 378-381).
75 ACV, Perg. 1032. Stevenson rilevava che la datazione del do-cumento era in qualche parte errata poiché questa poteva essere letta sia come 1026 che come 1032 (STEVENSON, Documenti, cit., p. 81).
VELLETRI NEL MEDIOEVO
46
rius Urbis Romae76, aveva già ricevuto in concessione nel 977 dall’abate di Subiaco un altro territorio, il fundus Foliano et castre77, segno dell’interesse della politica romana di valoriz-zazione del territorio. Obiezioni potrebbero esse mosse ri-guardo l'identificazione nella stessa persona dei Giovanni su citati, sulla base del lungo arco temporale intercorso tra i due avvenimenti. Osservazioni superabili in considerazione della vita evidentemente ottuagenaria del padre Demetrio e, soprattutto, perché Giovanni è attivo ancora nel 1015 nel seguito di Benedetto VIII78. Nel 1007 è attestato come illu-strissimo viro figlio di “Melioso” consulus et dux e di Marozza nobilissima femina79. I “Meliosi” pur non arrivando ai vertici del potere politico romano – appoggiarono in questo i Tu-
76 Il titolo è riportato in una lettera di Innocenzo III del 1206, do-
ve si ricordava che la chiesa di S. Maria di Fossanova aveva ricevuto da lunghissimo tempo beni e terre da parte di Joanne Demetrii urbis Romae vestarario (M.T. CACIORGNA, L’abbazia di Fossanova, vicende e problemi di un’abbazia tra stato della Chiesa e Regno (secoli XII-XIII) pp. 93-94, in Il monachesimo cistercense nella Marittima medievale. Storia e Arte. «Atti del Convegno (Abbazia di Fossanova-Valvisciolo, 24-25 settembre 1999)», Casamari 2002.
77 Reg. Subl., n. 51 28 aprile 977, pp. 89-91. Il fondo era situato nel Patrimonium Appiae: “Benedetto, abate sublacence, concede a Giovanni, figlio di Demetrio Duca, il fondo di Foliano (Fogliano), il villaggio dove si vede edificata una Torre, con fiumi e laghi, ivi compresa la chiesa di San Donato e con altre cripte e chiese in rovina. Patrimonio compreso fra il miglio 53 della città di Roma e dal terzo lato di confine in linea retta tra Caprolace e la Sorresca”.
78 Il 4 dicembre di quell’anno risulta tra i sottoscrittori, come Jo-hannes Emeliosus, in un placito tenuto da Benedetto VIII per la restitu-zione di alcuni possedimenti all’abate di Farfa (Il regesto di Farfa compila-to da Gregorio da Catino, a cura di I. GIORGI, U. BALZANI, III, Roma 1883, p. 211, n. 502).
79 L. HARTMANN, Ecclesiae S. Mariae in via Lata tabularium, I, Vienna 1895, XXVII, p. 35.
GLI AVVENIMENTI
47
scolani – sembrano in grado di poter esercitare una grande influenza politica dal momento che controllavano un vastis-simo territorio che si estendeva da Velletri fin sotto il Cir-ceo. L’ufficio di vestarario ricoperto da Giovanni era in ogni modo uno dei più elevati a cui gli aristocratici romani potevano ambire. Accanto al duca Giovanni troviamo a Velletri un Francus comes, forse lo stesso “Franco nobili viro”, che qualche anno prima aveva presenziato alla donazione dell’isola Tiberina80 e a quella del fondo di Zizinni nel terri-torio di Albano, operata nel 979 da Demetrio di Melosio in favore di Benedetto, monaco di Subiaco, in ossequio alla volontà di sua nipote Marozia81; l’affermazione della figura del comes era forse coincisa con la presenza imperiale a Ro-ma, frutto della politica di avvicinamento all’impero iniziata da Giovanni XII, figlio del princeps Alberico, e proseguita sotto i pontificati dei Crescenzi e dei conti di Tuscolo. Con tutte le cautele del caso si può evidenziare come, tra la se-conda metà del X e la prima metà del secolo XI, nei territo-ri della provincia, dai titoli con cui risultano designati i de-tentori dell’autorità cittadina sembrerebbe emergere che le figure di consul et dux e quella di comes convivessero in una sorta di governo bicefalo. Queste cariche di nomina ponti-ficia non erano certamente in contrasto o competizione tra di loro e dovevano riflettere una separazione tra poteri; i comites sembrerebbero esercitare un incarico in ambito amministrativo e patrimoniale, mentre i duces quello politi-co e di governo. A Roma, già dai primi decenni del X seco-lo, i titoli di consul e dux avevano evidentemente espresso una appartenenza ad una classe che prefigurava una mani-festa superiorità sociale, dalla quale erano tratti i funzionari
80 NERINI, De templo, cit., p. 379. 81 Reg. Subl., n. 125, pp. 175-176.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
48
per contingenti incarichi di governo, mentre il rafforzarsi della presenza del comes, relativamente alla zona pontificia, sembrerebbe essere collegato all’influenza imperiale proprio nel momento in cui a Roma risiedette, anche per periodi relativamente lunghi, la corte di personaggi d’oltralpe legati all'imperatore. Paradigmatico il caso di Daiferio, che nella concessione dell’anno Mille era indicato solamente con il titolo di comes – conte di Traetto, un titolo quindi non lega-to ai domini pontifici –, ma già l’anno successivo risultava designato come consul et dux et comes civitatis Terracine. La stessa persona poteva evidentemente accumulare le cariche su scelta comune del papa e dell’imperatore. Anche nel ca-so forse più articolato, sempre relativo a Terracina, accanto al comes Crescenzio, il quale aveva ottenuto la carica per pre-ceptum pontificalis [sic] et imperatorum, troviamo un Leo dux che sembrerebbe ricoprire compiti di governo82. Al tempo e per opera di Ottone III comparve invece per la prima volta il titolo di comes sacrosancti palatii Lateranensis, di cui si fre-giò anche Alberico III, fratello e padre di papi ricordato come illustrissimus et clarissimus vir, eminentissimus consul et dux nonché comes sacri Lateranensis palatii83.
Nei cento anni a cavallo dell’anno Mille, le famiglie dei Tuscolani, dei de Imiza e dei “Meliosi”, sempre vicine all’im-pero, risultano al vertice dell’aristocrazia romana, legate tra loro da possibili relazioni di parentela o convenienti ma-trimoni e, alla fine del secolo X, in apparente contrasto con quella dei Crescenzi. Tuscolani e Crescenzi, in ogni modo, sembrerebbero discendere entrambi, in linea diretta, dalla
82 CACIORGNA, Una città di frontiera, cit., p. 191; P. BREZZI, Roma e l’impero medievale (774-1252), in Storia di Roma (Istituto di studi romani), X, Bologna 1947, p. 161.
83 C. CARBONETTI VENDITTELLI, Documentazione scritta e preminen-za sociale, in CAROCCI, La nobiltà romana, cit., p. 332.
GLI AVVENIMENTI
49
famiglia dei Teofilatti. Crescenzio di Teodora risulterebbe essere figlio proprio della Teodora madre di Marozia sena-trix, a sua volta genitrice di Gregorio di Tuscolo. L’ipotesi risulterebbe confermata da una più attenta lettura del ne-crologio di S. Ciriaco a via Lata, che sembrerebbe rendere evidente una continuità sostanziale tra i due gruppi fino alla seconda metà del secolo XI84. Il papato tuscolano fu invece effettivamente in contrasto con l’altro ramo della famiglia, quello passato alla storia come i “Crescenzi Ste-faniani”. Ciò che divise i due schieramenti dei “Teofilatti” Crescenzi e Tuscolani, fu soprattutto il loro relazionarsi con la politica imperiale che culminò nel 998 con l’uccisione di Crescenzio II da parte di Ottone III. Forse anche a seguito di questo evento, nel 1001 Gregorio di Tuscolo abbandonò definitivamente la posizione filo-imperiale mantenuta fino a quel momento e si pose a capo dell’insurrezione cittadina che causò l’allontanamento di Ottone III da Roma.
I Crescenzi avevano legato le loro fortune alle relazioni con i papi Giovanni XIII (965-972), Benedetto VII (974-983) e Giovanni XV (984-996) attraverso i quali operarono una politica di insediamento territoriale. Il contrasto tra i due gruppi sembrerebbe apparire in alcune concessioni en-fiteutiche. Quando nel 977 Giovanni di Demetrio divenne concessionario del fondo Foliano per conto del monastero sublacense, i Crescenzi reagirono ottenendo l’anno succes-sivo, ma forse sarebbe meglio dire “pretendendo”, il Ca-strum vetus dal monastero di S. Andrea in silice con il pre-sumibile intento di impedire alla famiglia “Meliosi” il ricon-
84 F. LAZZARI, I Teofilatti nel necrologio del sec. XI del monastero dei SS.
Ciriaco e Nicola in via Lata, in «Annali del Lazio meridionale», XIV/2, 28 (2014), pp. 7-19.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
50
giungimento di quel fondo con il territorio veliterno85; un intento che potrebbe anche essere stato perseguito con grande efficacia – che portò al risultato di un incastellamen-to “fallito” – dal momento che il monastero sembra essere rientrato in possesso dei terreni, o almeno del lago di Fo-gliano, già nel 100586. La moderna storiografia tende dun-que a identificare la presa di potere nel 1012 da parte dei Tuscolani in contrapposizione al gruppo rivale dei Crescen-zi. In realtà, come sembrerebbe palesarsi evidente da una più attenta lettura del necrologio di S. Ciriaco, i Tuscolani appoggiarono Giovanni patricius durante il suo governo su Roma, riconoscendo di fatto la supremazia dei Crescenzi come ramo dominante della famiglia. Solo dopo che questi restarono senza eredi diretti, essi operarono una scalata al potere che li vide contrapporsi all’altro ramo della famiglia, quello dei “Crescenzi Stefaniani”87.
I conti di Tuscolo riuscirono quindi a imporsi a Roma come forza politica di primo piano e a conquistare il con-trollo del soglio pontificio attraverso i papi Benedetto VIII (1012-1024), Giovanni XIX (1024-1032) e Benedetto IX (1032-1044) e, dopo questa data, ad estendere la loro pre-senza nella regione di Marittima a cominciare proprio da Velletri. L’elemento che lascerebbe arguire la circostanza di una politica di effettiva detenzione del potere da parte della famiglia tuscolana nella città veliterna si palesa negli atti del 1043, attraverso il quale Gregorio II consul, figlio di Alberi-
85 Queste problematiche non risultano ancora del tutto sviluppate.
Per un primo spunto di riflessione rimando al mio saggio: F. LAZZARI, Castra e proprietà medievali del monastero di S. Andrea in Silice (Le Castel-la), in «Annali del Lazio meridionale», 2 (2011).
86 Reg. Subl., n. 10, p. 25: Lacis duobus, unum qui dicitur Foliano et alium quod Caprolaci nuncupatur.
87 LAZZARI, I Teofilatti, cit., pp. 7-19.
GLI AVVENIMENTI
51
co III e fratello di papa Benedetto IX, fece dono al prete Guido Frassia della chiesa ormai diruta dedicata a S. Maria e ai SS. Giovanni e Paolo iuxta silice al fine di riedificarla88, e in quello del 1059, relativo alla donazione operata dal consul romanorum Gregorio, figlio di Alberico, a favore del capitolo veliterno89. Dopo la morte del padre, Gregorio aveva affiancato decisamente il fratello papa nell’azione po-litica della regione. Benedetto IX, proseguendo nella dire-zione dei suoi predecessori, rafforzò il legame con l’impero, un fenomeno riscontrabile anche negli atti formalmente sottoscritti90. A metà del secolo XI dunque la famiglia Tu-scolana controllava effettivamente anche Velletri e nel 1058 riuscì a far eleggere papa il vescovo di questa città Benedet-to X/Giovanni detto Mincio, che salì al soglio pontificio grazie alla sortita dell’esercito capitanato da Gregorio fratel-lo del papa Benedetto IX. Benedetto X venne però deposto nel dicembre dello stesso anno durante il concilio di Sutri, convocato da Pier Damiani, al quale nel frattempo era stata assegnata la reggenza della diocesi di Velletri, e Ildebrando di Soana, futuro papa Gregorio VII, con l’appoggio di Gof-fredo di Toscana e Lorena. Risulterebbe comunque che Pier Damiani abbia solo temporaneamente retto la diocesi,
88 BORGIA, Istoria, cit., pp. 167-168. 89 ACV, Perg. 1059. I Tuscolani appaiono al potere ancora in
quell’anno quando presumibilmente lo stesso Gregorio donò alla chiesa di S. Clemente un pezzo di terra seminativo vicino al Rivo di Scazi (S. BORGIA, De cruce veliterna, Roma 1780, ed. Lozzi, Velletri 2005, pp. 286-288). Il documento riporta in realtà Gregorius filio [sic] domini Alverti, una denominazione (Gregorii Alberti f.) riscontrata anche nel necrologio dei SS. Ciriaco e Nicola a via Lata (P. EGIDI, Necrologio dei SS. Ciriaco e Ni-cola nella via Lata, in Necrologi e libri affini, della città di Roma, I, Roma 1908, p. 14). Comunque un componente della famiglia tuscolana.
90 ACV, Perg. 1038. Nell’incipit del documento, a papa Benedetto IX venne affiancato l’imperatore, il piissimo Corrado Romanorum Imprii.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
52
resasi vacante dopo l’elezione del Mincio al soglio pontifi-cio91. Il capostipite dei Tuscolani può essere identificato con il Gregorio discendente del princeps Alberico, ma forse difficilmente collegabile alla stessa famiglia “Meliosi”, rima-nendo dubbia la sua identificabile con il Gregorio già pre-sente nell’atto di donazione del 979 come marito (o figlio) di Marozia nipote di Demetrio92. Sarebbe quindi possibile
91 Sul rapporto tra il vescovo e Velletri si veda: F. CIPOLLINI (a cu-
ra di), Pier Damiani, figura, aspetti dottrinali e memoria nella diocesi di Velle-tri. Giornate di studio. Velletri, 9-10 novembre 2000, Venafro 2003, pp. 133-150.
92 L’unica attestazione certa riguardo al nome della moglie di Gre-gorio risale al 1013 (Il Chronicon Farfense di Gregorio da Catino: prece-dono la Constructio Farfensis e gli scritti di Ugo di Farfa, a cura di U. BALZANI, II, in Fonti per la storia d’Italia, XXXIV, Roma 1903, p. 96) e riporta in verità il nome di Maria, a quel tempo già defunta. Marozia era in ogni modo una forma ipocoristica allora molto in uso per Maria (T. DI CARPEGNA FALCONIERI, Le trasformazioni onomastiche e antroponi-miche dei ceti dominanti a Roma nei secoli X-XII, in «Mélanges de l’École française de Rome. Moyen-Age», 106 (1994), p. 607 e nota) e d’altronde Demetrio la ricorda come Maroza karissima netta mea. Il rapporto tra Tuscolani e “Meliosi” è basato sulla tesi di Valeria Beolchini che ipotiz-za che il Gregorio [di Tuscolo] citato nel documento del 979 [Reg. Subl., n. 125, pp. 175-176] come “olim suo viro” [di Marozia senatrix] fosse in realtà suo figlio – attribuendo l’errore ad una trascrizione del copista – in base ad un altro documento del 949 [Reg. Subl., n. 126, pp. 176-177] che indicava Marozia “nobilissima femina conius [sic] Theophilactus eminen-tissimus bestarario”, proprietaria di beni nel fondo Zizinni in territorio Albano, e che questi fosse lo stesso Gregorio consul et dux che sottoscris-se il documento (V. BEOLCHINI, Tuscolum II: una roccaforte dinastica a controllo della valle Latina, Roma 2006, p. 48 n. 203 e p. 55). Una inter-pretazione, che peraltro rafforzerebbe il rapporto di consanguineità tra la famiglia tuscolana e quella dei “Meliosi”, avvalorata dalla citazione che vede Gregorio, questo sì illustrissimo viro filius Maroze senatrix, otte-nere nel 980 concessioni a est di Roma (WICKHAM, Roma medievale, cit. p. 237, n. 44). Si tratta in ogni modo di una identificazione con il Gre-
GLI AVVENIMENTI
53
supporre, con le dovute cautele, che nel corso del quarto decennio del secolo XI i Tuscolani abbiano potuto rivendi-care la titolarità sul castrum veliterno, che effettivamente de-tenevano, in nome di una affinità – da ricercare probabil-mente in una discendenza matrilineare che potrebbe essere stabilita dal documento del 979 – con la famiglia “Meliosi” estintasi, almeno nella sua linea maschile, con Demetrio di Giovanni, nel continuum di un potere già da loro esercitato; anche se, effettivamente, l’estendersi della presenza dei con-ti di Tuscolo nella regione di Marittima coincise con la po-litica espansionistica di questa famiglia93. Bisogna anche te-nere conto che il monastero dei SS. Ciriaco e Nicola a via Lata, a cui erano legati i componenti della famiglia “Melio-si”, era stato fondato da Marozia senatrix e dalle sue sorelle, circostanza che tenderebbe a confermare una qualche affi-nità tra “Meliosi” e Tuscolani oltre che la consanguineità tra questi ultimi e i Crescenzi. I componenti delle due fa-miglie, Tuscolani e Crescenzi, si trovano, infatti, tutti ricor-dati nel necrologio del monastero.
In questo periodo alcune famiglie aristocratiche pote-rono pensare, e talvolta forse ci riuscirono, di trasformare le concessioni enfiteutiche in piene proprietà. A Velletri però gorio capostipite dei Tuscolani che il citato documento del 979 non rende esplicita. I nomi di Gregorio e Marozia e alcuni dei titoli usati erano d’altra parte molto comuni e generici e non sempre possono esse-re usati per costruire genealogie. Un altro e diverso Gregorio consul et dux, marito di Teodora, figlia di Demetrio di Melioso, risulta peraltro presente nell’atto relativo all’isola Tiberina del 987 (v. supra n. 74), che potrebbe anche essere lo stesso che aveva già sottoscritto la carta del 979; una identificazione che potrebbe essere avvalorata dalla contempo-ranea presenza, in entrambi i documenti, di Franco vir nobilis.
93 P. DELOGU, Territorio e domini della regione Pontina, in Ninfa, una città, un giardino, «Atti del Colloquio della Fondazione Camillo Caetani. Roma, Sermoneta, Ninfa 7-9 ottobre 1988», Roma 1990, pp. 21-22.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
54
il vescovo riuscì a riguadagnare alla Chiesa il dominio sulla città, come tenderebbero a suggerire la datazione al 1065 del privilegio in cui il pontefice Alessandro II, su richiesta di Pier Damiani, confermava al clero di Velletri l’esenzione perpetua da qualsiasi servizio o obbligo militare, che doveva essere tenuto soltanto verso il loro vescovo94, e la possibile datazione proprio all’XI secolo della copia autentica del contratto di enfiteusi del 946, esibito evidentemente per ri-vendicare i diritti del vescovo su Velletri dopo la cessazione dei privilegi concessi a Demetrio di Melioso, avvenuta pro-babilmente per mancanza di legittimi eredi dopo la morte di Giovanni. Ancora nel 1038 il vescovo di Velletri sembra poter esercitare diritti solamente sui terreni posti all’interno dell’insula, parte dei quali concessi quell’anno in enfiteusi a terza generazione ai nobili viri Guittimanno, Pietro de Senio-recto e Gregorio del presbitero Franco95. L’isola è menziona-ta ancora nel 1059 nell’atto di donazione da parte del consul romanorum Gregorio prima ricordato. Demetrio di Giovan-ni doveva essere probabilmente morto prima del termine ante quem 1043, anno della su citata concessione.
Nonostante la rarità del nome Melioso nel panorama dell’aristocrazia romana del periodo, è comunque difficile documentare una continuità familiare diretta da Demetrio
94 ACV, Perg. 1065. Il privilegio in questione non è in realtà un
documento originale e la sua compilazione è indubbiamente da postici-pare di qualche anno – Stevenson ne aveva in ogni modo già difeso la sostanziale autenticità (STEVENSON, Documenti, cit, pp. 94-95) – ma questo non cambia la sostanza di uno scontro in atto tra due distinti poteri che nella seconda metà del secolo XI si contesero il dominio del-la città di Velletri.
95 ACV, Perg. 1038. Da questo documento Gregorio del presbite-ro Franco risultava già proprietario di alcuni terreni confinanti con quelli ricevuti in enfiteusi.
GLI AVVENIMENTI
55
ai figli di Crescenzio di Melioso attestati a Roma negli anni Sessanta dell’XI secolo96. Nel caso vi fosse questa linearità dovremmo comunque ipotizzare che i “Meliosi” vennero al-lontanati o rinunciarono ad ogni pretesa su Velletri sempre in seguito alla morte di Demetrio di Giovanni, ultimo componente della famiglia a poter vantare i diritti della concessione enfiteutica del 946. Il nome Melioso è d’altra parte già testimoniato a Roma intorno all’anno Mille, e l’attività di pescatore esercitata da questo individuo esclude ogni possibile legame con il lignaggio degli eminentissimi “Meliosi”97. È possibile che il nome, che non sembra atte-stato in precedenza, possa aver avuto origine proprio in questo periodo come imitazione onomastica del ceto nobi-liare romano (cfr. supra n. 49). Melioso piscator doveva esse-re nato intorno agli anni Ottanta del X secolo e il padre, che gli aveva imposto il nome, fu evidentemente un con-temporaneo di Demetrio di Melioso.
Giovanni di Demetrio, come già evidenziato da Mar-chetti-Longhi, aveva avuto tre figli: Demetrio, Berta e Bo-na98 da Costanza nobilissima femina. Un dato che risultereb-be in ogni modo evidente dai documenti già conservati nel monastero di S. Ciriaco, incorporati poi nell’archivio di S. Maria in via Lata. Nel 1012, infatti, la religiosa Berta acqui-stò per due lire d’argento le quote patrimoniali del casale Cocumelli sito nel territorio di Albano dalle sorelle Bona e
96 WICKHAM, Roma medievale, cit., p. 254. 97 In un atto del 29 settembre 1037 è citato Stefanus qui vocatur de
Meliosus piscator (HARTMANN, Ecclesiae S. Mariae, cit., LXVI, p. 88). 98 Il riferimento ai figli è molto preciso, ma l’autore si riserva di
parlarne altrove e le fonti citate nel suo presente lavoro in realtà non ne parlano. (Cfr. G. MARCHETTI-LONGHI, S. Maria “de Secundicerio”. Topo-grafia medievale di Roma, in «Bullettino Archeologico comunale di Ro-ma», 54 (1926), pp. 121-122).
VELLETRI NEL MEDIOEVO
56
Berta, nobilissime femine, con il consenso di Costanza nobilis-sima femina loro madre e di Giovanni nobilis vir, marito di Bona99. Il nome di Costanza ricorre in un altro documento del 1023, quando Berta nobilissima femina donò ad Aisaida, ossia Berta religiosa ancilla Dei de monasterio martyris Ciriaci, una porzione di terreno nel territorio di Albano già ricevuta da suo fratello Demetrio, tra i cui confini erano citati i ter-reni di sua madre Costanza. Questo legame sembrerebbe essere ulteriormente confermato dal necrologio del mona-stero di S. Ciriaco in via Lata, risalente agli inizi del secolo XI, che ricorda domna Costantia uxor Iohannis de Demetrio100. Giovanni e Costanza, così come i titoli illustris101 e nobilissi-ma erano molto comuni tra l’aristocrazia romana dell’epoca e, purtroppo, la scarsità di documentazione disponibile non rende evidente alcuna combinazione onomastica coniugale “Giovanni illustris/Costanza nobilissima”, ad eccezione della Costanza nobilissima femina figlia del consul e dux Stefano de Imiza102, ricordata insieme al marito Johannes vir illustris, dux in una donazione che la donna operò, per la sua parte del Casale Moreni, in favore del monastero di S. Andrea e S.
99 HARTMANN, Ecclesiae S. Mariae, cit., XXXII, pp. 40-41. L’atto fu rogato dalla stessa Bona.
100 P. EGIDI, Necrologio, cit, p. 12. 101 “Illustris era tuttavia il titolo che indicava forse più chiaramente
le famiglie dominanti della ‘vecchia aristocrazia’. Prima del Mille è usa-to una quarantina di volte. In oltre metà di questi casi si tratta di per-sonaggi delle famiglie di Teofilatto e Alberico, dei de Imiza, dei de Primi-cerio, dei ‘Crescenzi’; potremmo ipotizzare che anche molti altri dei suoi utilizzatori appartenessero allo stesso livello sociale” (WICKHAM, Roma Medievale, cit. pag. 237).
102 Le vicende della famiglia de Imiza sono state ricostruite da K. GÖRICH nel saggio Die de Imiza. Versuch über einer römische Adelsfamilie zur Zeit Ottos III, «Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken», 74 (1994), pp. 1-41, dove è tra l’altro evidenziato il legame instaurato con Ottone III.
GLI AVVENIMENTI
57
Gregorio il 26 aprile del 992. Personaggi che però non pos-sono essere identificati con i nostri, poiché nel luglio dello stesso anno la donna risulta già morta, ricordata infatti co-me Constantia bone memorie olim filia Stephani, qui cognomina-batur de Imiza103.
Di seguito si riporta la tabella di una possibile linea ge-nealogica dei “Meliosi”, un nome di famiglia che, eviden-temente, così come quello dei “Crescenzi”, “Stefaniani”, “Ottaviani” e altri, è frutto solamente delle successive rico-struzioni storiche.
Giovanni eminentissimus consul et dux Demetrio di Melioso = Marozza nob.ima femina
Boniza = Franco Giovanni = Costanza Teodora = Gregorio vir nobilis nobilissima femina consul et dux
Bona = Giovanni Demetrio = Marozza Berta = Gregorio vir nobilis Ill.ima femina
I “Meliosi” risultano quindi in stretto rapporto con il
monastero di S. Ciriaco in via Lata, nei pressi del quale do-veva ubicarsi la residenza della loro famiglia: una regione nella quale era evidentemente concentrata l’aristocrazia
103 G.B. MITTARELLI, A. COSTADONI, Annales camaldulenses ordinis
Sancti Benedicti, I, Venezia 1755, appendice, coll. 112-117.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
58
romana dell’epoca. Demetrio di Giovanni illustris vir risulta ancora in vita nel 1017, anno in cui vendette alla sorella Berta, col consenso di sua moglie Marozza, una vigna nel territorio di Albano nel fondo Sabello104, e probabilmente ancora nel 1024, quando Berta, nel frattempo andata in sposa ad un Gregorio, donò lo stesso terreno alla monaca Aisaida105. Il sistema onomastico, allora in uso tra il ceto aristocratico, rende in ogni modo di difficile individuazione la Marozza e il Gregorio citati, poiché non è difficile incon-trare in questo periodo personaggi aventi lo stesso nome, appartenenti anche alla stessa famiglia106. Berta potrebbe es-sere comunque ancora in vita nel 1053, quando una donna con questo nome è citata in un documento dell’abbazia di Farfa: “Berta uxor Domni Gregorii … refutavit totam suam sor-tem de terra et vinea, sicut ei pervenit per cartam donationis a viro suo”107. In verità il documento non è datato, ma è inserito in un gruppo di documenti di quell’anno. Potrebbe anche riferirsi alla donazione effettuata prima del 1024 dalla stessa Berta in favore del monastero.
Dopo la metà del secolo XI era dunque iniziato quel lento processo da parte di papi più riformatori i quali, ve-nendo in contrasto sia con i signori del Tuscolo che con gli altri baroni, riuscirono a recuperare i loro possedimenti. Nell’archivio capitolare di Velletri una serie di documenti di questo periodo registra donazioni o restituzioni, che pos-sono essere ricondotte a quel processo di ricomposizione del capitolo cattedrale secondo i dettami della riforma, che
104 Cfr. HARTMANN, Ecclesiae S. Mariae, cit., XXXIX, p. 48. 105 Cfr. P.L. GALLETTI, Del Primicerio della Santa Sede, Roma 1776,
pp. 257-258; HARTMANN, Ecclesiae S. Mariae, cit., XLVII, pp. 58-59. 106 Cfr. DI CARPEGNA FALCONIERI, Le trasformazioni onomastiche,
cit., pp. 595-640. 107 SAVIO, Monumenta, cit., I, p. 813 n. 20568 e p. 811, n. 20521.
GLI AVVENIMENTI
59
si riproponeva il recupero delle proprietà in vario modo alienate108. Attraverso una politica fatta anche di larghe concessioni, Pasquale II confermò quindi ai velletrani i pri-vilegi elargiti da Gregorio VII. Quest’ultimo documento è andato purtroppo perduto, ma esso è citato nella bolla di Pasquale II. Qualcuno ne ha messo anche in dubbio l’esistenza109 poiché in contrasto con un’altra bolla di Gre-gorio VII, che confermava, nel 1081, al monastero di S. Paolo il possedimento del castrum Velletrum, cum omnibus suis pertinentiis, sicut a sanctis pontificibus concessum est. Senza voler entrare in un dibattito sterile poiché privo di attesta-zioni certe, potremmo ritenere che, nel convulso passaggio tra la signoria ducale e il ritorno al pieno potere politico della Chiesa, avvenuto comunque non prima del 1089 e soprattutto nel momento più alto del cruento scontro con l’impero, Velletri sia stata temporaneamente affidata alla potestà del monastero, della cui comunità era stato abate lo stesso Gregorio VII. La Chiesa “riformatrice” sembrerebbe operare qui un effettivo recupero dei beni ecclesiastici, pro-babilmente già concessi in enfiteusi, che sarebbero poi ser-viti come contropartita per ottenere il supporto delle fami-glie aristocratiche romane in funzione anti-imperiale110. Del resto quella di Gregorio VII fu anche una bulla confirmatio-nis di antichi privilegi concessi al monastero da re, impera-tori e pontefici tra i quali è ricordato Marino II (942-946), ma di questa antica appartenenza di Velletri al monastero non vi è traccia nel ricordato documento del 946. D’al-
108 ACV, Perg. 1090, 1099, 1100. 109 LAMPE, Contributi, cit., p. 170. 110 Su questo documento e la sua possibile interpretazione riman-
do al mio saggio: F. LAZZARI, Il privilegio di Gregorio VII del 14 marzo 1081 ovvero il recupero delle proprietà ecclesiastiche in vario modo alienate, in «Annali del Lazio meridionale», 2 (2013), pp. 7-17.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
60
tronde, quando nel 1203 Innocenzo III confermò al mona-stero di S. Paolo tutti i suoi beni, per quanto concerneva Velletri era citata la sola chiesa di S. Maria, identificata dal Borgia con quella di S. Maria dell’Orto111. Era inoltre svani-to ogni riferimento al castrum veliterno, sostituito da un più attuale possessiones in civitatem Velletri. È indubbio quindi che Velletri risulti essere effettivamente autonoma sotto la guida del suo vescovo già alla fine dell’XI secolo, quando quest’ultimo tornò ad esercitare quello ius disponendi che abbiamo visto appartenergli già dall'altomedioevo. Velletri vide confermati i suoi antichi privilegi in seguito al suppor-to fornito a Urbano II nella lotta contro Clemente III, que-st'ultimo a quel tempo saldamente insediato in Roma. Vel-letri, o almeno una sua fazione, doveva aver partecipato alla vittoriosa battaglia contro le truppe di Guiberto/Clemente III guidate dal nipote Ottone, in un frangente che aveva vi-sto penetrare, seppur per un breve periodo, le forze di Ur-bano in gran parte della città di Roma. Nella lettera del 1089 indirizzata ai Velletrani, definiti dilectissimi Fratres, ve-nivano ricordate le “immani crudeltà” di Guiberto, mentre Ottone era definito tirannus, membra diaboli112. Nella stessa lettera si faceva riferimento alle sofferenze che negli anni precedenti i Velletrani avevano dovuto subire ad opera del-la parte scismatica, che già negli anni successivi sembra es-sere tornata a detenere il potere nella città. In questo perio-do Clemente III esercitò un effettivo potere attraverso il ve-scovo Giovanni da lui assegnato alla chiesa veliterna, come dimostra il documento dell’archivio della cattedrale che si riferisce al settimo anno di pontificato dell’antipapa113. Un
111 BORGIA, Istoria, cit., pp. 256-257. 112 Ivi, p. 204. 113 BORGIA, De cruce, cit., pp. 289-291; STEVENSON, Documenti,
cit., pp. 98-100.
GLI AVVENIMENTI
61
potere che potrebbe aver mantenuto fino al 1094, così co-me avvenne a Roma, dove l’egemonia di Clemente fu pres-soché totale fino a quella data. È utile notare come il privi-legio su menzionato non solo sopravvisse alla damnatio me-moriae operata dalla parte vincitrice, che distrusse documen-ti, corpi, tombe e luoghi di culto legati a Clemente III, ma anche che esso fu gelosamente conservato al fine di rivendi-care i diritti territoriali in esso contenuti. L’atto indica chia-ramente che in quel frangente i Velletrani consideravano Clemente III semplicemente come un “altro” papa e non mettevano in discussione la legittimità dei suoi atti, che in quel caso favorivano il Capitolo veliterno riguardo il pos-sesso di alcuni terreni contesi al monastero di S. Andrea in silice114. Il solo modo per annullare le sue disposizioni era quello di far scomparire i documenti da lui emanati ed è per questo che fu attuata una sistematica deletio memoriae, ma questo evidentemente non poteva avvenire per gli atti relativi ai possessi dei vari istituti. Probabilmente le disposi-zioni contenute nel documento sopra citato rimasero parte integrante delle concessioni al popolo veliterno da parte dei papi, che uscirono vittoriosi dal conflitto; il che poteva so-lamente significare che i Velletrani non erano rimasti, in questo frangente, chiaramente e stabilmente favorevoli alla parte “riformatrice”.
I confini territoriali di Velletri risultavano definitiva-mente stabiliti alla fine dell’XI secolo, confermati nel 1102
114 Clemente III risultava, almeno per buona parte dei suoi con-
temporanei, come un pontefice legittimo. Come già evidenziato da di Carpegna Falconieri l’antipapa non è altro che un papa, che un altro papa ha dichiarato illegittimo, il quale solo a posteriori risulta essere perdente (T. DI CARPEGNA FALCONIERI, Popes through the Looking Glass, or «Ceci n’est pas un pape», in Framing Clement III, (Anti)Pope, 1080-1100, «Reti Medievali Rivista», 13, 1 (2012), p. 127.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
62
proprio da Pasquale II e ribaditi ancora nel 1235 da Grego-rio IX in un privilegio in cui essi venivano descritti in senso orario a partire dall’Artemisio, con il Monte del Vescovo e Acqua Palomba; da qui si estendevano fino a Torrecchia per poi ripiegare fino a Campomorto, ricordato con l’anti-co nome di S. Pietro in formis, poi risalivano attraverso il fosso di Carano fino a raggiungere la contrada di Acqua Lucia e da qui infine la cima del monte Artemisio115. Gli stessi confini già identificati nel documento del 946 e vero-similmente attribuiti alla diocesi di Velletri fin dalla riorga-nizzazione territoriale della seconda metà del secolo ottavo. Questi confini registreranno in seguito pochi essenziali cambiamenti, se si eccettuano le estensioni ai danni dei ca-stelli di Lariano e della Faiola. I privilegi concessi da Pa-squale II furono in quel momento più nominali che reali, poiché gli anni a cavallo tra l’XI e il XII secolo furono effet-tivamente un periodo tra i più turbolenti nella storia della Chiesa, venutasi a trovare in contrasto con le grandi fami-glie romane nel più ampio conflitto con l’impero. Essi ac-quisirono però un grande valore al momento del rafforza-mento del potere temporale dei papi e testimoniano come già dal XII secolo Velletri si trovassse a fianco del papa, in opposizione all’impero e all’aristocrazia romana, in una condizione di embrionale autonomia cittadina. Il territorio velletrano poté evidentemente rappresentare un potere ne-goziale del papato riformatore, che se ne servì per il suo tentativo di affermazione sulla città di Roma oltre che come base per riacquisire un più diretto e deciso controllo del ter-ritorium Sancti Pectri. Roma fu attraversata in quel periodo
115 A. LANDI, Compendio delle Cose della Città di Velletri, MDLXIV,
manoscritto pubblicato in “Quaderni della Biblioteca Comunale”, 4, in-troduzione e note di M.T. BONADONNA RUSSO, Velletri 1985, pp. 30-31.
GLI AVVENIMENTI
63
da una delle più gravi crisi della sua storia. La situazione nella Marittima era specularmente complicata e Velletri do-vette rivestire un ruolo non secondario in queste vicende. Nel 1108 Pasquale II, con le armi del normanno Riccardo, duca di Gaeta, conquistò Tivoli, roccaforte degli avversari, e assediò poi Subiaco e Velletri per restaurare la pace. Ninfa, Sermoneta e Tivera partecipavano alla rivolta contro la Chiesa; durante il pontificato di Gelasio II, l’esercito dell’imperatore Enrico V faceva scorribande nei confini del territorio di Velletri e assediava il castrum papae Turriculam, l’odierna Torrecchia Vecchia116.
Il corso degli avvenimenti sin qui descritti sembrerebbe delineare una ulteriore lettura, consona allo scenario del fenomeno di incastellamento proposto recentemente da Hubert sulla base della ancora valida ricostruzione di Pierre Toubert, almeno per il contesto romano117. La fondazione del castellum veliterno avvenne in relazione diretta con il popolamento e rispose alla necessità di controllo e di ge-stione da parte della grande proprietà fondiaria, in questo caso la Chiesa, senza però una diretta relazione con la sua fortificazione118. Essa si verificò quindi, soprattutto nelle aree strettamente legate alla politica romana, essenzialmente come mezzo per un più adeguato esercizio del potere piut-tosto che come atto di difesa verso ingerenze esterne. A par-
116 Pandulfus, Vita Gelasii, in Lib. Pont., II, cit., p. 315. 117 TOUBERT, Les structures, cit., 1973. 118 É. HUBERT, L’incastellamento dans le Latium, Remarques à propos
de fouille reécentes, «Annales. Histoire, sciences sociales», 3, Parigi 2000, pp. 583-599. Qui lo storico francese identifica tre forme di incastella-mento: 1) la fondazione del castello avviene senza relazione diretta con il popolamento; 2) la concentrazione della popolazione è precedente al-la costruzione del castello; 3) la concentrazione della popolazione e la fortificazione del castello vanno di pari passo.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
64
tire dalla fine del secolo decimo le due esigenze sarebbero invece divenute evidentemente convergenti. L’elemento che porterebbe ad escludere la fortificazione della città è la sua esplicita assenza nel pur dettagliato documento del 946. Avendo il vescovo Leone escluso dal contratto di enfiteusi la zona intorno alla chiesa di S. Clemente, una fortificazio-ne del territorio avrebbe dovuto essere autenticamente cir-costanziata, con l’eventuale inserimento nel contratto una clausola che definisse la costruzione della cinta muraria an-che nella zona di pertinenza della chiesa. Lo scenario che sembrerebbe delinearsi raffigura dunque un quadro in cui le invasioni saracene ebbero scarso rilievo nel fenomeno del primo incastellamento. Questo fu dovuto, almeno nella sua prima fase, essenzialmente alla necessità, in un momento di ripresa economica e demografica, di controllo politico e amministrativo su una popolazione sparsa nel territorio e intorno alla chiesa di S. Clemente, un sito quest'ultimo che sul finire del VI secolo era stata anche costretta ad abban-donare, nel momento in cui Gregorio Magno esortò il ve-scovo di Velletri a portare la sede veliterna in un luogo più sicuro, l’Arenata a Sant’Andrea apostolo119. Incombendo il pericolo di invasione da parte dei Longobardi, il papa scris-se nel febbraio del 593 a Giovanni vescovo di Velletri in questi termini: «La condizione dei tempi ci suggerisce di trasferire le sedi episcopali situate da tempo antico in de-terminate città in altri luoghi della stessa diocesi che repu-tiamo più sicuri dove si possano indirizzare ora gli abitanti
119 Il luogo viene identificato con S. Andrea in silice facendo rife-
rimento al documento del 978 con il quale l’abate del monastero di S. Andrea in silice et arenati concedeva in enfiteusi a Crescenzio di Teodora il Castrum vetus presso Velletri (R. MORGHEN, Carta di S. Andrea in Selci, in Statuti della Provincia Romana, «Fonti per la storia d’Italia», Roma 1930, pp. 1-9) .
GLI AVVENIMENTI
65
per sfuggire più facilmente ai pericoli dei barbari. Per que-sto ordiniamo che tu Giovanni fratello e coepiscopo nostro della città di Velletri ti trasferisca con la tua sede nel luogo che si chiama Arenata a Sant’Andrea apostolo, affinché possa essere al riparo dalle incursioni nemiche e ivi siano celebrate le funzioni liturgiche»120. Si trattò in ogni modo di una limitazione temporanea, poiché dopo breve tempo i Bi-zantini tornarono padroni della situazione. Il vescovo di Velletri risulta presente ai sinodi romani del 595 e del 601 con altri ventitré vescovi – venti dei quali provenienti dal suburbio di Roma –, in rappresentanza di quelle città il cui insieme può dare una chiara idea dell’estensione del terri-torio bizantino in quel momento121. Il vescovo Giovanni nel 595 si firmò con il titolo di episcopus civitatis veliterne, ma già nel 601 egli sottoscrisse la constitutio, con cui venne limi-tata l’autorità dei vescovi sui monasteri, come humilis episco-pus belitrensis122. Da quel momento scomparve ogni riferi-mento alla civitas, un termine che si ripresenterà solamente nel privilegio di Urbano II del 1089. Ancora nella seconda metà del secolo nono la chiesa di S. Clemente è individuata dal suo stesso vescovo in Veliterno oppido, un termine usato nel Medioevo per indicare insediamenti urbani meno rile-vanti rispetto alle civitates, a metà strada tra queste e i castra, nonostante la presenza della sede vescovile che avrebbe do-
120 GREGORIO MAGNO, Registrum Epistularium, in “Opere di Gre-
gorio Magno”, Roma 1992, vol. 1, p. 293, in A. NICOLA, Non disperi l’umana fragilità. Il dramma dell’uomo negli scritti di san Gregorio Magno, Torino 2005, pp. 27-28.
121 B. BAVANT, Le duché byzantin de Rome, in «Mélanges de l’Ecole française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes» 91 (1979), p. 58.
122 BORGIA, Istoria, cit., p. 135.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
66
vuto garantire a Velletri uno status più elevato123. Il passo è ricordato nella lettera di dedica di Gauderico, già vescovo di Velletri, a papa Giovanni VIII di una vita di S. Clemen-te. Una delle ragioni che indussero Gauderico a continuare l’opera iniziata da Giovanni Diacono fu quella di aver pre-sieduto la chiesa dedicata al santo, e nessuno più di lui po-teva conoscerne lo stato. Nessuno potrebbe altresì mettere in discussione la corrispondenza di questa chiesa di S. Cle-mente con l’attuale cattedrale di Velletri, nonostante gli storici veliterni non abbiano lesinato sforzi per dimostrare il contrario124.
Nel corso del XII secolo si registrò in ogni modo una
sensibile ripresa politica ed economica, nonostante lo sci-sma del 1130. Velletri sembra però rimanere ai margini del-la contesa tra Anacleto II e Innocenzo II: infatti, i docu-menti di quegli anni conservati presso l’archivio della chiesa cattedrale125 non riportano oppure evitano di riportare il nome di alcun papa – dalla qual cosa possiamo percepire una neutralità nei confronti delle due parti – contrariamen-
123 L’oppidum medievale era una forma di insediamento urbano,
che poteva rappresentare anche un centro di potere politico, ammini-strativo e religioso, la cui fortificazione era resa necessaria dall’assenza di sicurezza, in questo frangente rappresentata dalle incursioni saracene.
124 L. CARDINALI, Di un antico sigillo capitolare, in Accademia Roma-na di Archeologia, Roma 1825, p. 31 e n. 57. Curiosamente il Cardinali, nello smentire i due Borgia circa l’origine veliterna di S. Clemente, ne confermava allo stesso tempo la tesi secondo la quale alcune contrade del territorio veliterno riportavano il nome del santo già dal secolo IX, proprio con riferimento alla lettera di Gauderico. Abbiamo già avuto modo di notare come nel territorio di Velletri non vi siano attestazioni documentarie, epigrafiche, archeologiche o di altro tipo, che attestino la presenza di una chiesa dedicata a S. Clemente, oltre alla chiesa cattedrale.
125 ACV, a. 1136, 1137.
GLI AVVENIMENTI
67
te ad una consolidata prassi riscontrabile nei documenti del Capitolo veliterno, precedenti e successivi. Ed evita di farlo soprattutto un certo Giovanni, abitante di Velletri, che in due distinti atti si definisce solamente quondam Papae came-rarius, omettendo il nome del pontefice126. La città sembra rimanere estranea anche alla lotta tra il Papato – nel 1145 Eugenio III risulta sostenuto militarmente da Tivoli, Tusco-lo e Normanni, ma non da Velletri – e la Roma senatoria.
Intorno alla metà del secolo, in ogni modo, Velletri si era già dotata di una organizzazione amministrativa stabile e di un sistema elettivo delle cariche pubbliche quando, in-torno al 1150, la sede vescovile di Ostia fu congiunta da Eugenio III con quella di Velletri a causa dello spopola-mento della città ostiense127. In un documento del primo gennaio 1162 troviamo eletti quattro procuratores silvae, Amato Paribone, Davide di Pietro Jannelli, Pietro Dazani e Giovanni Rubeo i quali, a nome di tutto il popolo, acqui-starono per il prezzo di “tre libre di provisini”, un terreno confinante ad un altro da essi precedentemente acquista-to128. Siamo comunque lontani dalle forme istituzionali comunali del periodo successivo. Il rapporto che legava i
126 Ibidem. 127 Alessandro Borgia riporta la data del 1150, anno dell’istituzio-
ne del Decano del Sacro Collegio per opera di Eugenio III (BORGIA, Istoria, cit., p. 224), ma la più antica documentazione che menziona l’unione tra le due diocesi risale al 1154 anno in cui il cardinale Ugo, vescovo di Ostia e Velletri, donò al monastero di Mormosolio alcuni beni (PETRUCCI, Pievi e Parrocchie, cit., p. 898 n. 11). In verità Borgia as-serisce, con buone argomentazioni, che benché le due diocesi siano sta-te ufficialmente unite da Eugenio III, le stesse erano governate dal me-desimo vescovo fin dai tempi di Pier Damiani.
128 STEVENSON, Documenti, cit, , pp. 110-111; cfr. G. FALCO, Il Comune di Velletri nel Medio Evo (sec. XI-XIV), in «ASRSP», 36 (1913), pp. 374-375.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
68
cittadini velletrani alla Chiesa era, infatti, di tipo feudale e la loro dipendenza era sanzionata da un giuramento di fide-litas vassallatica, testimoniata già dal 1089; i veliterni erano tenuti ad effettuare hostem et parlamentum129 con la precisa-zione che il servizio militare poteva essere richiesto in tutto il Lazio meridionale130. Velletri aveva conservato in ogni modo numerosi privilegi e larga autonomia quando, spe-cialmente tra la fine del XII e l’inizio del XIII secolo, si an-dò dilatando il centro di potere del governo temporale as-sunto dalla Curia romana, nell’ambito dello scontro tra i papi e il Comune di Roma, una lotta aspra che sarebbe du-rata ancora a lungo poiché quest’ultimo non aveva alcuna intenzione di riconoscere i pontefici come capi della città. Lo spirito di autonomia era così forte che molti papi furono costretti a risiedere fuori della città eterna. Nel 1181 Ubal-do degli Allucingoli, nonostante la protezione di Federico Barbarossa, dovette essere eletto papa con il nome di Lucio III a Velletri, dove egli trasferì la propria corte e da dove governò la cristianità nei due successivi anni131. La regione di Marittima si estendeva a sud di Velletri ed era caratteriz-zata da estesi latifondi132, a differenza del terreno nel terri-
129 Bolla di Gregorio IX del 3 gennaio 1235: Unum comestionis
pabulum, parlamentum, et hostem per Maritimam et Campaniam. 130 S. CAROCCI, Feudo, vassallaggi e potere papale nello Stato della
Chiesa (metà XI sec.-inizio XIII sec.), in Fiefs et féodalité dans l’Europe méri-dionale (Italie, France du Midi, Péninsule ibérique) du Xe au XIIIe siècle (Col-loque international organisé par le Centre Européen d’Art et Civilisa-tion Médiévale de Conques et l’Université de Toulouse-Le Mirail, Conques, 6-8 juillet 1998), Toulouse 2002, pp. 43-73.
131 A. GABRIELLI, Un Conclave a Velletri, Elezione e Residenza di Lu-cio III, Velletri 1923, rist. anast., Velletri 1995.
132 Il territorio che si estendeva dai monti Lepini fino al mare era costituito da una serie di fondi coltivati, dove Ninfa era con ogni pro-babilità il centro organizzativo della Massa.
GLI AVVENIMENTI
69
torio veliterno che veniva affidato ai coloni con diritto di ri-scatto, e quindi frammentato in numerose piccole proprie-tà. Questo territorio della regione venne conteso tra le civi-tates e i castra sorti a seguito del secondo periodo di inca-stellamento, generando questioni di confine che nel secolo successivo furono alla base di continui scontri133.
Questo processo di trasformazione, in atto a Velletri nel XII secolo, ben si inserisce nella storiografia dell’«ori-gine dei Comuni», anche se la specifica linea lungo la quale si mosse non sembra riscontrabile altrove. La città rimase sotto la guida del suo Vescovo, che agiva in nome del papa, affiancato da una aristocrazia locale non troppo potente e dal popolo.
Il Duecento: nascita del libero Comune
Al sorgere del XIII secolo fu evidente la disputa tra al-
cuni comuni della Marittima, centrata nello scontro tra i si-gnori dei castelli di Ninfa e di Sermoneta. I primi, alleati con Sezze e il signore di Acquapuzza, fronteggiarono l’alleanza stretta dai secondi con Cori e Velletri. La succes-siva pace venne sancita, non senza difficoltà, grazie all’inter-vento del cardinale Ugolino, futuro papa Gregorio IX, con
133 Per un inquadramento del fenomeno dell’incastellamento nella regione vedi: TOUBERT, Les structures, cit., 1973; J. COSTE, La via Appia nel Medio Evo e l’incastellamento, ora in Scritti di Topografia medievale, a cura di C. CARBONETTI, S. CAROCCI, S. PASSIGLI, M. VENDITTELLI, Roma 1996 (Nuovi studi Storici, 30); S. CAROCCI, Baroni di Roma. Do-minazioni signorili e lignaggi aristocratici nel Duecento e nel primo Trecento, (Collection de l’École française de Rome) Roma 1993; G. GIAMMARIA (a cura di), Castelli del Lazio meridionale, Roma-Bari 1998; S. CAROCCI, M. VENDITTELLI, L’origine della campagna romana. Casali, castelli e villaggi nel XII e XIII secolo, con saggi di D. ESPOSITO, M. LENZI e S. PASSIGLI, Roma, «Miscellanea della Società Romana di Storia Patria», 47, 2004.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
70
un documento non datato fatto risalire dal Borgia134 al 1207, ma probabilmente posteriore di qualche anno135. I capitoli della sentenza, pur se rivolti alle varie comunità, fo-calizzavano i rapporti tra Velletri e Ninfa – i confini di quest’ultima al tempo non erano ancora stabilmente defini-ti – imponendo loro di mantenere la pace, stabilendo altre-sì che in caso di sconfinamento le due comunità avrebbero dovuto avvertirsi con un anticipo di tre giorni136.
Questi avvenimenti facevano da sfondo al più vasto piano di riorganizzazione del Patrimonio di S. Pietro e al progressivo divenire dello Stato della Chiesa. All’inizio del XIII secolo si rafforzò il diretto controllo pontificio, nel se-gno di quel consolidamento del territorio sostenuto da In-nocenzo III, sotto il quale si andava formando un forte cen-tro di potere economico e una eccezionale egemonia politi-ca concentrata nelle mani delle famiglie dei Conti e degli Annibaldi. Accanto alla oramai consolidata fedeltà di Velle-tri – reggeva la sede vescovile dal 1206 lo stesso Ugolino dei Conti di Anagni, succeduto a Ottaviano de’ Conti – pos-siamo osservare Cori sotto il rettorato di Pietro Annibaldi, al quale il papa aveva anche dato in sposa la sorella137. Già in questo periodo le due città sembrano essere legate da una fratellanza, che sarebbe stata lungamente ricordata nei successivi secoli dalle due comunità e sintetizzata nella tra-dizione popolare con il detto chi tocca Cora, tocca Velletri138.
134 BORGIA, Istoria, cit., pp. 258-260. 135 Caciorgna, Marittima medievale, cit., pp. 55-58. 136 G. LEVI (a cura di), I Registri dei cardinali Ugolino d’Ostia e Otta-
viano degli Ubaldini, Roma 1890, pp. 209-211. 137 CAROCCI, Baroni di Roma, cit., p. 311. 138 S. LAURENTI, Historiae coranae, ms., citato in A. GABRIELLI, Di
un’antica confederazione tra Velletri e Cori, in «Bollettino dell’Associazione veliterna di Archeologia e Arte», Velletri 1926, pp. 51-58.
GLI AVVENIMENTI
71
I rapporti tra le due città, apparentemente libere, erano in ogni modo sottoposti ad una evidente forma di dominatus pontificio che senza dubbio favorì la costituzione di organi-smi di autogoverno, proprio perché limitati nella loro por-tata, e soprattutto funzionali alla politica papale di afferma-zione in una regione come la Campagna e Marittima divisa fra molti poteri locali. Secondo il Marocco139, Cencio Ca-merario aveva riferito che Corani e Velletrani vivevano in amore quasi fraterno140. Egli citava un documento, allora conservato nell’archivio di S. Angelo in Pescheria in Ro-ma141, secondo il quale Velletrani e “Corani” combatterono fianco a fianco – in forza dell’antico patto che esse avevano sottoscritto – in risposta alle angherie subite da parte degli “Albani”, aggiungendo che nell’antico statuto veliterno si
139 G. MAROCCO, Monumenti dello Stato Pontificio, vol. V, Roma
1833, pp. 157-158. 140 Cencio Savelli, futuro papa Onorio III, fu l’autore del Liber cen-
suum, finito di compilare nel 1192, che rappresenta il più antico ed im-portante catalogo delle chiese di Roma. Il codice raccoglie il lavoro del precedente camerlengo, Boso o Bosone Breakspear nipote di Adriano IV. In esso sono riportate le rendite della Chiesa provenienti dai con-tributi di tutta la cristianità, le donazioni ed i privilegi accordati dai re Franchi e i trattati stipulati con i Normanni nonché l’Ordo romanus, cioè il rituale della chiesa romana contenente l’ordine delle cerimonie e dei riti usati in occasione delle solenni processioni papali, dei possessi pontifici, delle feste principali ecclesiastiche, di quelle per l’elezione e la consacrazione del papa o dei vescovi e le solenni cerimonie per la coro-nazione di re e imperatori.
141 Ora in BAV, S. Angelo in Pescheria, I, 6. Questo documento è forse riconducibile ad uno dei registri – il volume degli atti dell’anno 1370 – del notaio Antonio Scambi. Marocco, in ogni modo, nel ripor-tare la notizia, così come farà successivamente Gabrielli, non cita i fogli del registro e soprattutto non evidenzia la differenza temporale tra gli avvenimenti della seconda metà del XIV secolo e la citazione attribuita al Camerario risalente, almeno come termine ante quem, al 1216.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
72
trovava un capitolo, nel quale era stabilito che per la con-servazione delle pubbliche scritture si dovesse eleggere un corano con il titolo di cancelliere142. Gabrielli ipotizzava che il trattato tra le due città fosse stato sottoscritto agli inizi del XIII secolo, negli anni in cui Cencio Savelli rivestì la fun-zione di Camerario, fissando così al 1216, anno della sua elezione al soglio pontificio, il termine ante quem. Questo patto di fratellanza sarebbe dunque rimasto in vigore per ol-tre cinque secoli, tanto che ancora in età moderna, quando vennero riformati entrambi gli statuti di Velletri e Cori, fu-rono confermate le disposizioni secondo cui chiunque a Cori avesse offeso un cittadino di Velletri sarebbe stato pu-nito come se avesse offeso un cittadino di Cori, così come a Velletri nei riguardi dei cittadini corani. Il Podestà di Velle-tri poi, nel solenne giuramento di insediamento, promette-va di osservare e mantenere l’antica confederazione e la fra-tellanza tra la città di Velletri e il Comune di Cori143. Il rife-rimento di Cencio Camerario sembrerebbe trovare confer-ma in un documento del 24 luglio 1216, citato dal Conta-tore, relativo ad un trattato stretto dai Consoli di Terracina con il Conte di Fondi, che faceva riferimento anche a Cori e Velletri144.
142 Questa norma non compare invece negli statuti riformati del 1544.
143 A. GABRIELLI, Gli Statuti della città di Velletri, Velletri 1912, Lib. I, cap. VII “Item promitto observare et mantenere toto posse consocietatem, pa-cem, et fraternitatem antiquam inter Civitatem Velitrarum et Commune Co-ranum”; Statuta civitatis Corae, Roma 1549, p. 27, Lib I, cap. 73 “De of-fendentibus cives Velitrenses”.
144 D.A. CONTATORE, De Historia Terracinensi libri quinque, Roma 1706, p. 218: “Hec omnia jurabunt per Evangelia Dei servare sine fraude et malo ingenio usque ad decem annos salvo mandato et fidelitate Domini Papae ex parte Terracin. Et salva etiam fidelitate Dominorum Frajapanorum et salvis positis suis scilicet Velletrensibus et Coranis”.
GLI AVVENIMENTI
73
Il XIII secolo registrò evidentemente grandi difficoltà per quanto concerneva i rapporti tra il papato e il comune di Roma. Accanto alla riaffermazione della autorità papale sul territorio, il desiderio di dominio del papa dovette evi-dentemente riscontrare forti resistenze interne. Nel 1228 Gregorio IX, a seguito di una rivolta cittadina, fu costretto a rifugiarsi a Perugia, in un frangente in cui si andava intensi-ficando lo scontro con Federico II. Landi ricorda diversi documenti a questa data, inerenti a sentenze assolutorie e di riaffida nei confronti degli ufficiali e cittadini di Velletri che si erano opposti ai tributi richiesti dal comune di Ro-ma145. I romani, capeggiati dal senatore Luca Savelli, cerca-vano di esigere un giuramento di fedeltà da parte dei centri della Tuscia e della Campagna e Marittima. Lo scontro tra le parti culminò con la battaglia avvenuta presso il castello di Roccarespampani, che vide vittoriose le forze papali, an-che se non riuscirono ad espugnare il castello, composte anche da milizie di Segni, Velletri, Anagni e Terracina. In un alternarsi di situazioni che avevano visto il favore ora dell’una ora dell’altra fazione, il Papa e i Romani raggiunse-ro un accordo dove, per la prima volta, comparve la parola “Statuto”, segno del progresso tecnico e legislativo raggiun-to dalle amministrazioni comunali. Anche i velletrani che avevano preso parte al conflitto a fianco del papa furono inclusi negli accordi di pace146. Nei centri della provincia il
145 LANDI, Compendio, cit., pp. 27-28 e nota. Questa documenta-
zione è andata purtroppo perduta. Gregorio IX il 22 ottobre del 1227 era a Velletri, come si evince dalla lettera al Duca d’Austria dat. Velletri, XIII kalendas novembris, pontificatus nostri anno primo (LUCIEN AUVRAY (a cura di), Les registres de Grégoire IX, I, Paris 1896, n. 152, p. 84), dove tornò nel settembre del 1230, quando Gregorio di Santo Apostolo ri-sulta essere vicedomino di Velletri (Ivi, II, n. 2748, p. 152)
146 FALCO, Il Comune, cit, 36 (1913) pp. 382-383.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
74
potere politico, che fino ad allora era rimasto nelle mani del gruppo di origine aristocratica con un governo esercita-to da Consoli – nel 1237 papa Gregorio IX si rivolge ancora “dilectis filiis consulibus et populo Velletren.”147 –, fu progressi-vamente sostituito dal potere podestarile con una evoluzio-ne del quadro istituzionale più versato verso un regime po-polare148. Questo cambiamento rifletté l’esigenza dell’emer-gente ceto borghese di allargare i propri poteri nei confronti del ceto aristocratico, motivo alla base delle continue di-scordie tra le parti che a Velletri erano ufficialmente cono-sciute con i termini di Equites e Pedites149 e identificate poi nel secolo successivo nei maiores e nei minores150.
Verosimilmente, intorno alla metà del XIII secolo, pur attraverso un lento e disomogeneo processo, avvenne una ridefinizione delle competenze amministrative attraverso la composizione degli statuti comunali, la creazione o la ride-finizione delle cariche del podestà, del giudice, dei boni
147 A. DE SANTIS, Inventario delle pergamene, Velletri 1978, p. 39. 148 Cfr. S. CAROCCI, Barone e podestà. L’aristocrazia romana e gli uffi-
ci comunali nel Due-Trecento, in J.C. MARIE-VIGUER (a cura di), I podestà dell’Italia comunale. Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII-metà XIV sec., Roma 2000, (Nuovi Studi storici, 511), pp. 847-875.
149 ACV, Perg. 1237; edita in BORGIA, Istoria, cit., p. 276. A Sezze i componenti delle due fazioni nello stesso periodo erano ufficialmente registrati come Milites e Pedites. Le città si rifacevano evidentemente alla struttura delle colonie romane, organizzate in classi e dotate di un am-pio territorio circostante. I cittadini erano suddivisi in classi sulla base del censo, rispondente a finalità sociali, politiche e militari. La divisione in classi era indispensabile non solo al governo della città ma, anche, al-la formazione e all’organizzazione dell’esercito. Le assegnazioni della terra non avvenivano di conseguenza in misura uguale, ma erano mag-giori per il ceto dirigente (M.P. MUZZIOLI, Sui tempi di insediamento dei coloni nel territorio, in Urbanizzazione delle campagne nell’italia antica, Ro-ma 2001, p. 16, n. 40).
150 FALCO, Il Comune, cit., 36 (1913), p. 411.
GLI AVVENIMENTI
75
homines e del sindaco. Dei primi statuti comunali di Velletri si fa riferimento nel documento di nomina di Bonifacio VIII Caetani a podestà di Velletri del 1299151, in cui si spe-cificava che il vicario del podestà doveva osservare i singoli capitoli degli statuti, le deliberazioni dei boni homines e le sentenze del giudice152. Lo stesso Bonifacio ribadì al pode-stà, al giudice e agli ufficiali di Velletri l’esercizio della giu-stizia, relativamente alle cause in prima istanza, per i delit-ti commessi nel territorio della città; vietò al rettore di Campagna e Marittima ogni intromissione in dette cause, a meno che non avesse riscontrato negligenza nei giudici velletrani, e limitò la giurisdizione alle cause di appello; li-berò la città dall’obbligo di estradare, a richiesta del retto-re o di chiunque, i delinquenti che si trovavano nel suo territorio153.
Dalla documentazione disponibile non siamo in grado di chiarire quali siano state le funzioni originali dei boni homines154, ma esse vennero probabilmente modificate al tempo di Bonifacio VIII. Fu proprio il nuovo regime pode-starile, sostenuto dalla Chiesa, a far procedere ad una ri-conciliazione tra i ceti sociali in una direzione che assecon-dava le richieste del popolo. Il podestà infatti doveva essere straniero e senza vincoli di parentela con alcun cittadino; egli doveva amministrare la giustizia, far eseguire le sentenze
151 Oltre Velletri anche Sezze, Veroli e Terracina elessero il papa a
podestà. 152 FALCO, Il Comune, cit., 36 (1913), p. 379 n. 1. 153 DE SANTIS, Inventario, cit. pp. 40-41; FALCO, Il Comune, cit., 36
(1913), pp. 457-458. 154 Nell’ordinamento medievale, erano i cittadini chiamati ad assi-
stere i giudici, svolgendo mansioni di attività giurisdizionale volontaria e contenziosa. Con il passaggio al potere podestarile essi furono investi-ti di cariche amministrative e politiche nell’ambito del comune.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
76
e le deliberazioni del consiglio cittadino, nonché provvede-re alla difesa militare. Nella realtà dei fatti il podestà, quasi sempre espressione delle famiglie baronali romane, rappre-sentò il tentativo riuscito di queste ultime di estendere la loro influenza politica nel territorio della provincia. Il legi-slatore dovrebbe aver operato anche un riassetto urbanisti-co introducendo il termine “decarcia” – con riferimento ad entità amministrative territoriali – che apparve ab novo, a cominciare dall’inizio del Duecento, in diverse zone della regione di Campagna e Marittima155. Partendo dall’interpre-tazione che aveva dato Luigi Cardinali156 della parola “de-carcia” (dieci capi o dieci principi), lo storico veliterno Au-gusto Tersenghi diede eco all’ipotesi che Velletri fosse nei tempi antichi composta da dieci zone, denominate appunto decarcie, che nel periodo comunale erano ridotte solamente ad un numero di quattro157. La tesi, in verità molto debole, già messa in dubbio dai contemporanei158, è stata sostan-zialmente accettata da coloro che si sono finora interessati alla storia locale di Velletri o almeno costoro hanno conti-nuato a non porsi il problema. La persistenza del termine nel territorio dovrebbe in ogni modo essere esclusa, poiché
155 Per un approfondimento sull’argomento vedi: F. LAZZARI, La
decarchia medievale, innovazione o persistenza?, in «Annali del Lazio meri-dionale», 2 (2009), pp. 19-29.
156 L. CARDINALI, Risposta alla lettera del ch. Angiolo Uggeri sopra al-cuni edifizi veliterni del secolo XI, in Memorie romane di antichità e di belle arti, I, Roma 1824, pp. 69-70.
157 A. TERSENGHI, Velletri e le sue contrade, Velletri, Velletri 1975, rist. anast. dell’edizione del 1910, pp. 7-17.
158 FALCO, Il Comune, cit., 36 (1913), p. 395 dove ipotizzò una di-visione della città in decarcie già dall’XI secolo e IDEM, I Comuni della Campagna e della Marittima nel Medio Evo, in «ASRSP», 42 (1919), pp. 548-550, dove ribadì l’origine orientale del termine attraverso la sua persistenza nel territorio dai tempi dell’amministrazione bizantina.
GLI AVVENIMENTI
77
dal documento del 946159 e dall’indagine archeologica del territorio abbiamo visto che la città di Velletri, già nel pe-riodo bizantino, appariva quasi disabitata. Il termine decar-chia, che aveva già assunto nel linguaggio amministrativo della chiesa latina d’oriente il significato di una unità equi-valente ad una parrocchia160, si ritrova in documenti eccle-siastici latini, con riferimento a territori situati anche al di fuori della nostra regione – lontanissimi dalla zona di in-fluenza bizantina, come la Fiandra – proprio con questo si-gnificato161. All'inizio del XIII secolo ci fu un evidente le-game tra la regione franco-belga e Costantinopoli. Baldovi-no I di Fiandra, infatti, venne incoronato a Santa Sofia nel 1204 primo imperatore dell’impero latino, secondo l’antico cerimoniale di Costantino162. Il termine decarchia molto probabilmente fu quindi introdotto in occidente nel lin-guaggio amministrativo canonico – attraverso il neo costi-tuito impero latino d’oriente – al tempo di Giovanni Lota-
159 ACV, Perg. 946. 160 “Le terme decarchia désigne les divisions territoriales de la cam-
pagne. Le terme decarchia est employé également pour désigner une congrégation, celle exactement des 33 prêtres privilégiés de la cam-pagne” (H. AHRWEILER, M. BALARD, Eupsychia: mélanges offerts à Hélène Ahrweiler, La Sorbonne, Paris 1998, p. 17); cfr. P. IANNOY, -
, in Deltion t s Historik s kai. Ethnologik s Hetaireias t s Hel-lados, 2, Athenais 1885, 1889, pp. 587-608.
161 Il documento riportato in Patrologia latina, peraltro non databi-le con precisione, è in appendice alla vita di S. Arnoldo vescovo di Sois-son (1040-1087): Clarissimus presul Arnulphus, natione Flandrus, Fulberto ac Maiansiade ortus, eis scaldam in loca cui nomen Tydegem, in agro ac decharchia Aldernardensi, nobilissimo equite… (J.P. MIGNE, Patrologiae cursus completus, t. CLXXIV, Appendix ad Hariulfum, Lutetiae Parisiorum 1854, p. 1471).
162 La sua titolatura fu quella di Balduinus, Dei gratia fidelissimus in Christo imperator a Deo coronatus, Romanorum moderator et semper augustus, Flandrie et Hainonie comes (A. CARILE, Per una storia dell’impero latino di Costantinopoli (1204-1261), Bologna 1978, p. 186).
VELLETRI NEL MEDIOEVO
78
rio dei Conti di Segni, salito al soglio pontificio con il no-me di Innocenzo III; egli aveva eletto Anagni a luogo privi-legiato di residenza nell’ambito della sua azione politica iti-nerante nel Lazio meridionale, regione dove si muoveva con la disinvoltura di un padrone di casa163.
Il papa nel 1215 celebrò il quarto Concilio lateranense con un programma completo di riforma religiosa in campo teologico, disciplinare e organizzativo stabilendo regole ca-noniche e liturgiche in favore dei Greci dell’impero latino d’Oriente ritornati all’unità dopo l’occupazione di Costan-tinopoli da parte dei crociati nel 1204164. Il suo fu il tentati-vo, senza peraltro sensibili risultati, di riunire le due Chiese e di restaurare l’universalità del papato. Il nuovo impero la-tino d’Oriente, costituito sul modello feudale occidentale, registrò evidentemente una nuova struttura amministrativa basata sulla divisione territoriale cittadina in decharchie165. Non si vuole qui evidenziare una espressa volontà di rifor-
163 Sulla figura di Innocenzo III si veda la ricca e varia documenta-
zione contenuta negli atti del recente convegno tenuto in occasione dell’ottavo centenario della sua elezione al soglio pontificio (A. SOM-
MERLECHNER (a cura di), Innocenzo III Urbs et Orbis, Atti del Congresso Internazionale Roma, 9-15 settembre 1998, «Istituto storico italiano per il medio evo, Società romana di storia patria», Roma 2003).
164 La quarta Crociata, indetta con lo scopo di riconquistare Geru-salemme, deviò il suo tragitto originario contro il volere di Innocenzo III, e si concluse invece con la presa di Costantinopoli. Il papa in ogni modo legittimò successivamente la versione di Baldovino secondo cui il corso degli eventi era dovuto alla divina Provvidenza, che aveva voluto punire i peccati dei Greci costantinopolitani (Reg. Inn. VII, n. 154, p. 264). La lettera è edita in A.J. ANDREA, Contemporary sources of the fourth crusade, London-Boston-Köln 2000, pp. 115-126).
165 Nell’isola di Corfù, che proprio dal 1204 al 1212 cadde sotto la giurisdizione dell’impero latino d’Oriente, la suddivisione in decarcie risulta esistente a partire dal XIII secolo.
GLI AVVENIMENTI
79
ma amministrativa di Innocenzo III nella regione laziale, ef-fettivamente assente, ma allo stesso tempo non può essere negato l’indubbio scambio politico e culturale avvenuto in questo periodo tra la Curia romana e l’impero latino co-stantinopolitano, palesatosi evidentemente anche con l’in-troduzione del termine carchia nella città di Anagni166.
Nella provincia di Campagna e Marittima la nuova de-limitazione geografica, che fu sovrapposta ai confini ammi-nistrativi delle contrade, apparve a Sezze e Velletri intorno alla metà del XIII secolo mentre, come abbiamo visto, ad Anagni il termine carchia è documentato già dal 1212. Nelle due città di Marittima, così come ad Alatri, il termine trova una particolare coincidenza temporale. A Sezze il più antico documento riguarda un elenco di case e terreni sui quali la Chiesa di S. Maria esercitava diritti giurisdizionali seguiti dai nomi dei possessori e degli affittuari, individuati tramite i confini costituiti da vie pubbliche o vicinali, altre proprie-tà e possessi oppure da murum terre, distribuiti nelle sei de-carcie della città167. La grafia “catarcia” invece di decarcia –peraltro ribadita nel 1286 in un atto che può essere consi-derato un emendamento del precedente – riportata nel do-cumento porterebbe a far supporre che il termine fosse sta-to introdotto da pochissimo tempo e conseguentemente non ancora ratificato negli statuti della Comunità168, tanto
166 Ancora nel 1201 Anagni risulta suddivisa in regiones, mentre
nel 1212 i procuratori della Carchie Civitatis Anagnie que vocatur Celleri vendevano al vescovo alcune terre appartenenti alla stessa contrada (R. AMBROSI DE MAGISTRIS, Storia di Anagni, Roma 1889, Appendice, pp. 148-149 e 154-157).
167 CACIORGNA, Marittima medievale, cit., p. 185-215. 168 I primi “statuta” di Sezze, probabilmente non ancora distinti
per libri e per materia, sono documentati nel 1254 (G. FALCO, I Comu-ni della Campagna, cit., 48 (1925), p. 73.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
80
da non risultare familiare allo stesso notaio e alle locali au-torità ecclesiastiche169. Tra il 1272 e il 1273 una medesima operazione veniva ratificata a Velletri dal Capitolo di S. Clemente relativamente ad alcune case e possedimenti siti nella decarcia di Portella, per i quali i canonici della chiesa riscuotevano diversi fitti170.
Accanto alle nuove cariche di podestà e dei “boni homi-nes” apparve dunque ufficialmente il termine decarcia, in una medesima circostanza temporale, in diversi Comuni delle province di Marittima e Campagna, Sezze, Alatri e Velletri, che si trovavano allora sotto la diretta giurisdizione papale171. Potremmo quindi ragionevolmente ritenere che le nuove istituzioni di governo, in quei territori posti sotto un dominio più diretto del Papa, siano state il frutto di una riforma suggerita ed applicata da poteri esterni alle città172. La divisione decarciale non arrivò in ogni modo ad identifi-care e sostituire la “parrocchia”, rimanendo confinata in un ambito prettamente politico-amministrativo e urbano. Quan-
169 Nel documento comunale del 1279 in cui si registrò il nuovo
assetto urbanistico i rioni sono indicati con la grafia corretta di decarcia (AScSezze, Pergamene, 33).
170 TESTONE, I Regesti, cit., p. 19. 171 Nei comuni di Campagna e Marittima ci fu una evoluzione leg-
germente diversa rispetto a quella dei centri comunali dell’Italia centro-settentrionale, ben descritta nel recente studio di Milani (G. MILANI, I comuni italiani, Roma-Bari 2005). Qui ci fu una embrionale coincidenza tra potere politico e giurisdizionale nelle mani del Vescovo; una situa-zione che si riflettè in un più lento e meno traumatico processo di tra-sformazione delle istituzioni cittadine, che si inserirono quindi nell’ambito cittadino dopo che si erano ben radicate altrove.
172 Il termine decarcia fu introdotto ad Anagni tra il 1201 e il 1212, mentre negli altri centri della provincia, allora orbitanti nella diretta zona di influenza della politica papale, Alatri, Sezze, Velletri, Bassiano e Ser-moneta, esso non è testimoniato avanti la metà del XIII secolo.
GLI AVVENIMENTI
81
do nel 1276 Innocenzo V diede mandato di obbligare i par-rocchiani della chiesa di S. Clemente a corrispondere le de-cime al Capitolo per i beni situati nei confini della parroc-chia, questi includevano le terre, le vigne e i mulini situati evidentemente anche al di fuori della cinta muraria173. Grande influenza politica esercitò in quel periodo Riccardo della potente famiglia degli Annibaldi, nipote di Innocenzo III, il quale prestò i suoi servigi come rettore di Campagna e Marittima dal 1240 al 1249 ed ebbe grande peso politico fino agli ultimi giorni della sua vita174. Il rettorato consiste-va in una supervisione generale del territorio, nella riscos-sione delle tasse, nella mobilitazione delle truppe in caso di guerra e nel potere giudiziario di seconda istanza. Pochissi-mi documenti parlano di questo incarico, ragione proba-bilmente da ricercare nella distruzione degli archivi della famiglia Annibaldi175, ma possiamo supporre che egli go-vernò con ampia autonomia la provincia – soprattutto dal momento in cui Innocenzo IV, per preservare la sua libertà di azione e l'integrità personale, fuggì a Lione il 28 di giu-gno del 1244 e non fece ritorno a Roma sino al 6 ottobre del 1251 – e ancora di più sotto il pontificato di Alessandro IV Conti, suo parente, il quale lo nominò subito arciprete
173 ACV, Perg. 26 (BORGIA, De cruce, cit., p. 304; TESTONE, I Rege-sti, cit., p. 20).
174 Sulla figura di Riccardo Annibaldi si veda: F. ROTH, O.E.S.A., Cardinal Richard Annibaldi: First Protector of the Augustinian Order 1243-76, in Augustiniana, II (1952), pp. 26-60, 108-49, 230-47; III (1953), pp. 21-34, 283-313; IV (1954), pp. 5-24.
175 La conservazione e la trasmissione della memoria documentaria era considerata una componente essenziale e imprescindibile del patri-monio e dell’identità familiare (CARBONETTI VENDITTELLI, Documenta-zione scritta, cit., p. 323). Possibile quindi che non siano rimaste tracce evidenti dell’azione svolta da Riccardo Annibaldi nella regione di Ma-rittima.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
82
di S. Pietro e membro di quella Curia papale alla quale erano affidate le decisioni più importanti. Questo papa, già vescovo di Velletri dal 1231, fu molto legato a questa città, di cui mantenne il vescovato anche dopo la sua elezione al soglio pontificio. Durante questo periodo consacrò la Crux veliterna, fece traslare nella cattedrale di S. Clemente la sal-ma dei martiri Ponziano e Eleuterio dalla chiesa di Tibe-ria176 e visitò ogni tanto la città “predicando la parola di
176 Secondo il Liber Pontificalis, Ponziano fu sepolto nella cripta
papale delle Catacombe di S. Callisto. Secondo un’altra leggenda le re-liquie di Eleuterio, Anastasio e Ponziano furono portate a Troia in Pu-glia dal convento di Tivera o Tiberia sotto il vescovo Guglielmo II il 19 luglio 1105. La sepoltura di Ponziano ed Eleuterio in Velletri, di cui il primo a fornire i dettagli fu l’umanista veliterno Antonio Mancinelli (A. MANCINELLI, Sermonum decas, V, 3, Roma 1503), faceva fede sola-mente su una tradizione orale e fu accreditata dal veliterno Oreste Nar-dini, il quale agli inizi del secolo scorso ritrovò nella cattedrale di San Clemente i resti, da lui considerati tali, dei santi martiri Eleuterio e Ponziano, di cui si era persa ogni memoria, tanto che sia Cardinali (CARDINALI, Di un antico sigillo capitolare, cit.) che Bauco dubitavano che vi fossero mai stati (T. BAUCO, Storia della città di Velletri, II, Velletri 1851, pp. 186-200). Le reliquie di Eleuterio, già venerate a Costantino-poli, erano state portate a Tivera, dove i Monaci gli avevano dedicato il monastero. Le spoglie furono quindi traslate nella cattedrale di Velletri e poste nella cripta appositamente costruita per accoglierle. I primi sta-tuti comunali riferivano che la festa di S. Eleuterio si celebrava con grande solennità nel segno di grandi divertimenti e giochi popolari (BORGIA, Istoria, cit., p. 285). È probabile che le reliquie dei santi siano state conservate in diversi luoghi. I corpi dei martiri, infatti, furono considerati segni di elezione divina. Essi mantenevano la prodigiosa ca-pacità – così come l’ostia consacrata – di poter essere divisi senza perde-re la loro essenza ed efficacia di sorgente di vita e promessa di rigenera-zione.
GLI AVVENIMENTI
83
Dio oppure facendola predicare davanti a sé”177. Egli risie-dette nella città di Anagni a causa della situazione politica in Roma, retta allora con fermezza dal bolognese Branca-leone degli Andalò. Il rapporto tra la città di Velletri e l’Annibaldi è documentato già all’inizio del suo mandato quando Gregorio IX, dalla sua residenza in Laterano, il 19 giugno del 1240 diede mandato all’arciprete e al clero di Velletri di esortare il popolo ad inviare soldati a Ferentino, al servizio di Riccardo in difesa della Santa Sede178 e ancora nel 1270, quando ritroviamo il cardinale eletto a podestà della città179. I fatti e le circostanze lasciano arguire che, tra il 1258 e il 1260, durante il periodo anagnino del pontifica-to di Alessandro IV, avvenne a Velletri e in altri centri della provincia la riforma della divisione territoriale in decarcie, denominazione che si riscontra in documenti ufficiali del 1261 a Velletri180 e della metà del XIII secolo a Sezze181. L’anello di congiunzione tra la riforma e Riccardo Anni-baldi può essere ricondotto alle vicende di Sermoneta, che proprio in quel periodo (1264) fu assegnata, per i servigi re-si come rettore della provincia, proprio all’Annibaldi. Negli anni settanta del XIII secolo il vescovo della Molara, infatti, nonostante Sermoneta rimanesse una sua baronia, volle da-re alla Comunità una nuova veste giuridica dotandola di uno statuto e di nuove competenze amministrative e terri-
177 BORGIA, De Cruce, cit., p. XXVII. Il Borgia aveva ripreso la no-
tizia dalla Historia ecclesiastica nova di Tommaso di Lucca († 1326) inse-rita nella raccolta muratoriana.
178 TESTONE, I Regesti, cit., p. 17; BORGIA, Istoria, cit., p. 276. 179 FALCO, I comuni della Campagna, cit., 47 (1924), p. 180. 180 TESTONE, I Regesti, cit., p. 17. 181 CACIORGNA, Marittima medievale, cit., p. 190. Il documento è
ivi pubblicato alle pp. 216-221.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
84
toriali, basate sulla divisione del castrum in decarcie182. È in-teressante notare come questa riforma amministrativa non trovi spazio nei luoghi baronali e nemmeno in quegli inse-diamenti fuori dalla diretta giurisdizione della famiglia An-nibaldi, come Cori183 – dove il rettorato di Pietro Annibaldi
182 Ovviamente a Sermoneta non si verificò il passaggio al potere
podestarile, potere che continuò ad essere detenuto dal Dominus che veniva rappresentato localmente dal vicecomes. Il popolo era invece rap-presentato da dodici decancieri, uno per ogni decarcia (M. MOMBELLI
CASTRACANE, L’organizzazione del potere nel ducato di Sermoneta tra il 1501 e il 1586, in Sermoneta e i Caetani, dinamiche politiche, sociali e cultu-rali di un territorio tra Medioevo ed età moderna, «Atti del Convegno della Fondazione Camillo Caetani Roma-Sermoneta 1993, 16-19 giugno, Roma 1999», pp. 161-203). La suddivisione in decarcie fu mantenuta anche successivamente come testimoniato in un documento del 1570 dove sono descritte le decarcie di Travi, San Nicola, Valle Pagana, Sant’Angelo e Porta delle Noci (AsCSermoneta, Catasti, r. 37). In un al-tro documento sono riportate le decarcie di Borgo, Santa Maria, Torre Nova, Rione vecchio, Rocca, Santo Spirito, Portella, Travi, San Nicola, Valle Pagana, Sant’Angelo e Porta delle Noci (AsCSermoneta, Catasti, r. 38). A causa della perdita della prima parte dello statuto sermonetano non possiamo in ogni modo effettivamente stabilire se lo stesso fosse basato su un testo precedente oppure se l’Annibaldi abbia offerto ai sudditi statuti totalmente originali (M. VENDITTELLI, Signori, istituzioni comunitarie e statuti a Sermoneta tra il XII e il XIV secolo, in Sermoneta e i Caetani, cit., p. 43).
183 Da un inventario del 1401, uno dei pochi documenti medievali conservatisi, Cori, almeno dal secolo precedente, sembrerebbe essere suddivisa nelle tre parrocchie di S. Oliva, S. Pietro e S. Arcangelo, men-tre il territorio circostante era suddiviso in contrade (AsCC, PRE, Cata-sti, Reg. 2, cc. 143r-145r edito in P.L. DE ROSSI, E. DI MEO (a cura di), Il Catastum bonorum di Cori (1668-1696). Con un inventario dei beni comunali (1401), «Quaderni dell’Archivio Storico», 2, Cori 2009, pp. 197-200). A partire dal XVI secolo la distrettuazione cittadina venne quindi indicata con il nome delle tre porte cittadine: Porta Romana o Velletrana, Porta Signina o del Monte, Porta Ninfina.
GLI AVVENIMENTI
85
era terminato nel 1231 –, che Gregorio IX con la Bolla Rex excelsus aveva dichiarato assolutamente inalienabile184. La suddivisione in decarcie, inoltre, fu presente anche a Bas-siano185, altro possedimento degli Annibaldi dal 1240, quando fu assegnato da Gregorio IX a Trasmondo come ringraziamento per l’aiuto ricevuto contro i tentativi di in-vasione di Federico II.
L’influenza del Cardinale nella provincia risalta eviden-te nei patti stipulati nel 1257 tra Sezze e Terracina, che ri-sultavano favorevoli soprattutto agli Annibaldi, i quali ten-tavano di imporre il loro controllo su Terracina186 dove nel 1258 troviamo eletto a podestà il velletrano Pietro Guidoni. Nel medesimo periodo un messaggio del Papa ai Sezzesi esortava questi ultimi ad opporsi alle richieste dei boni homines che a quel tempo governavano Roma187.
184 Bull. Rom., Aug. Taur, 1868, III, pp. 481-482. Il documento del
16 gennaio 1234, Prohibitio alienandi terras, castra et alia loca Sedis Aposto-licae absque consensu sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium, faceva riferi-mento ai possedimenti pontifici di Campagna, Marittima, Tuscia, Spo-leto, Sabina e Marca Anconitana. Nella regione di Campagna troviamo Fumone, Paliano, Serrone e Lariano, mentre in Marittima sono citati i possedimenti di Acquapuzza, Ostia, Ariccia, Ninfa, Cori, Cisterna e Terracina.
185 Il castrum risultava suddiviso nelle decarcie di Vigilanza, S. An-gelo e Torre.
186 CACIORGNA, Marittima medievale, cit. p. 277. 187 Il diploma di Alessandro IV, con la data del 1259, andato pur-
troppo perduto, è riportato dal Moroni, ripreso da una pubblicazione del Marocco, il quale a sua volta asseriva di averlo tratto dall’archivio di Sezze: Alexander Episcopus servus servorum Dei, Dilectis filiis, rectori, consilio et comuni Setinae fidelibus nostris salutem et apostolicam beneditionem. Cum sit intelleximus [sic] illi qui dicuntur boni homines urbem ad praesens regentes, populusque romanus nobis injuxerint ut preparemini, et accingemini cum eorum exercita processuri, ac hujusmodi exercitus in nostram et apostolicae Sedis in-juriam congregetur volumus, et universitati vestrae sub debito fidelitatis, qua ec-
VELLETRI NEL MEDIOEVO
86
Prima dell’introduzione del termine decarcia, la topo-nomastica della città veliterna non evidenziava alcuna sud-divisione amministrativa. I vari documenti pervenutici ri-portano la generica formula “nel luogo detto”, come nel ci-tato documento del 1261 che descrive la donazione di due case site nella decarcia di Collicello in località detta Episco-pio, ribadendo un toponimo già citato in due precedenti at-ti dell’XI e del XII secolo, relativi rispettivamente alla con-cessione di una vigna e alla donazione di un orto situati in loco ubi dicitur Episcopium, luogo molto probabilmente da individuare presso la chiesa di S. Clemente. Questa zona “Episcopio” è nuovamente citata in un atto del 1300 senza alcun riferimento alla decarcia di appartenenza, segno que-sto della precedente e ancora ben radicata toponomastica cittadina. Ancora, in un atto del 1032 a favore della chiesa di S. Lucia erano state concesse omnia terra vel orta in isto lo-co posite qui nuncupatur lo prato.
Grazie alla ricca documentazione conservata nella città setina, è possibile un ulteriore confronto con le vicende le-gate al primo periodo comunale della città di Velletri. Qui come a Sezze venivano eletti due boni homines per ogni de-carcia cittadina. In quest’ultima, alla fine del XIII secolo, ne troviamo al governo dodici, in rappresentanza delle sei de-carcie che insieme raggruppavano le 996 case del Comune. Nel 1279, poiché a causa dell'aumento demografico le de-carcie avevano avuto uno sviluppo diseguale e pertanto comprendevano un numero diverso di case, si provvide a dare un nuovo assetto urbanistico attraverso lo scorporo di claesiae romanae tenemini, ac sub excommunicationis, et quingentarum marca-rum argenti poenis districta praecipiendo mandamus, quatenus ipsa super hoc nullatenus intendatis, ac aliquid eis in militibus, vel peditibus, aut alias impen-datis auxilium vel favorem (G. MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, LXV, Venezia 1854, p. 69).
GLI AVVENIMENTI
87
case da una decarcia e il riaccorpamento ad un'altra188. Alla fine del 1200 troviamo a Velletri la presenza di dieci boni homines, il che farebbe supporre una suddivisione originaria in cinque decarcie con una popolazione complessiva di cir-ca quattro, cinquemila abitanti. La diretta relazione tra il numero degli ufficiali e il numero delle decarcie sembre-rebbe confermata dalla situazione di Alatri, dove nove boni homines venivano eletti per rappresentare altrettante carcie cittadine189, Sermoneta, dove erano eletti dodici “decancie-ri” dalle altrettante decarcie in cui era suddiviso il castrum, e dai dodici boni homines sezzesi eletti dalle sei decarcie della città. Alatri era stata incamerata nei beni della Chiesa nel 1245 da Innocenzo IV e già l’anno successivo Riccardo An-nibaldi, in veste di rettore della regione, costrinse la città a mantenere la pace con Ferentino190. È dunque ipotizzabile che Alatri abbia attuato una riforma amministrativa nello stesso periodo di Sezze e Velletri e circoscrivibile intorno al 1260, anno in cui era podestà di Alatri Teobaldo Annibaldi nipote del Cardinale191.
La decarcia sezzese, in una realtà che contava pressap-poco gli stessi abitanti di Velletri, era suddivisa in otto vin-tane, cioè otto gruppi di venti case. Se ogni decarcia fosse stata legata al numero della sua popolazione, la riduzione a
188 CACIORGNA, Marittima medievale, cit. p. 180. 189 La prima notizia relativa alla Carcia in Alatri è del 1295: domum
… positam in carcia Collis (C. TOTI, Trascrizione di n. 284 pergamene dell’Archivio Cattedrale, ms. n. 10 citata in E. DE MINICIS, Alatri, in «La-zio Medievale», 33 abitati delle antiche diocesi di Alatri, Anagni, Ferentino, Veroli, Roma 1980, p. 19). Anche qui, similmente ad Anagni, la città ri-sulta precedentemente, già dal XII secolo, suddivisa in regiones.
190 A. THEINER, Codex diplomaticus dominii temporalis S. Sedis, I, Roma 1861, p. 116.
191 F. SAVIO, Gli Annibaldi di Roma nel secolo XIII, in Studi e docu-menti di storia e diritto, XVII (1896), pp. 355-363.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
88
nove boni homines nel corso del XIV secolo a Velletri poteva essere derivata dalla diminuzione degli abitanti dopo l’apice positivo raggiunto dallo sviluppo demografico intorno alla metà del secolo precedente, ma è probabilmente più plau-sibile che la magistratura dei Nove non sia stata una diretta emanazione di quella dei Dieci, dal momento che Nove bo-ni homines risultano affiancare il podestà nel castrum di Nin-fa alla fine del Duecento con funzioni assimilabili a quelle dei Nove veliterni192. In pieno XIV secolo risultano in ogni modo solamente le quattro decarcie di Collicello, Portella, S. Salvatore e Castello. A queste nel corso del secolo succes-sivo si aggiungeranno le decarcie di S. Maria e S. Lucia.
In questo periodo si insediarono in città i frati France-scani. Il convento, tra le cui mura si riunirà in seguito il Consiglio cittadino, fu costruito sul luogo dove, secondo la leggenda, avrebbe soggiornato Francesco di Assisi nel 1222, durante il suo viaggio verso Napoli. All’epoca era vescovo della città Ugolino dei Conti di Anagni, futuro papa Gre-gorio IX, amico del santo umbro. Francesco avrebbe opera-to il miracolo di disinfestare le vigne da un parassita chia-mato ‘magnacozze’. La prima testimonianza certa della co-struzione del convento è data dal Breve di Innocenzo IV del 30 marzo 1246, nella quale si concedeva una indulgenza di quaranta giorni per gli oblatori alla fabbrica193. Qui potrebbe aver studiato un giovanissimo Bonifacio VIII, affidato alle cure del frate suo zio Leonardo Patrasso194.
192 A. CORTONESI, Ninfa e i Caetani: affermazione della signoria e
assetto del territorio (secoli XIII-XIV), in Ninfa, una città, un giardino, cit., p. 65.
193 B. THEULI, Il Convento di S. Francesco in Velletri, in “Apparato Minoritico della provincia di Roma”, Roma 1648, p. 441.
194 B. THEULI, Teatro Historico di Velletri, Velletri 1644, (rist., Bolo-gna 1968), pp. 158-159. Le notizie fornite da Theuli, come spesso acca-
GLI AVVENIMENTI
89
Sotto il profilo politico, nella seconda metà del XIII se-colo i tempi erano già sensibilmente mutati rispetto a quelli che avevano portato alla sperata stabilità politica. Roma tornava ad essere terra di possibile conquista, anche perché i papi continuarono a soggiornare lontano dalla Santa sede. Quando Manfredi, figlio di Federico II, cercò di ottenere la massima carica comunale romana in chiave antipapale, Ur-bano IV ne anticipò le mosse maturando la decisione di of-frire la carica a Carlo D’Angiò, anch’egli francese come il papa. Le vicende di Velletri si delinearono sullo sfondo di questi eventi principali, come si evince dalle disposizioni di Martino IV, che da Orvieto nel 1282 esortava ad attenersi agli ordinamenti di Carlo, che stabilivano per Velletri la conservazione delle libertà di cui la città godeva sotto il
de nei suoi testi, a una più attenta verifica, non trovano poi riscontro. A proposito del convento di S. Francesco, l’attuale “casermaccia”, l’autore racconta che questo fu costruito su un sito precedentemente occupato dall’abbazia di S. Rufo, di cui era stato abate papa Anastasio IV. Questa notizia, ancora oggi avvalorata dagli storici locali, era già stata confu-tata da Alessandro Borgia che la definì una “pia credenza” del Theuli (BORGIA, Istoria, cit., p. 231). Quest’ultimo aveva ripreso la notizia dalla “vita dei Papi” del Platina il cui valore storico è molto limitato e in ogni caso variabilissimo. Anastasio IV è indicato dal Platina come abate dell’ordine di S. Rufo di Avignone, una notizia che studi recenti sul papato del XII secolo smentiscono, escludendo ogni collegamento tra Corrado di Suburra e il canone regolare di S. Rufo (I. STUART
ROBINSON, The Papacy, 1073-1198, Continuity and Innovation, Cam-bridge 1990, p. 73). Non è improbabile che l’erronea attribuzione di Bartolomeo Sacchi sia stata dovuta al fatto che il successore di Ana-stasio IV, papa Adriano IV, fu effettivamente abate di S. Rufo ad Avi-gnone. Il tenore dei brevi papali in favore del convento di S. France-sco, inoltre, tende altresì a confermare che si trattava di una nuova costruzione e non di un ampliamento o ristrutturazione di un sito già occupato precedentemente.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
90
pontificato di Niccolò III (1277-1280)195, cioè le disposizio-ni di cui la città si era dotata con l’introduzione del potere podestarile.
Intanto le vicende locali avevano registrato nel 1269 l’attacco dei Velletrani al castello di Lariano al seguito di Giacomo Cantelmi, vicario di Carlo D’Angiò come rettore di Roma. L’anno successivo, mentre era podestà Guglielmo di Novara196, Velletri fornì altri soldati a Gualtiero de Su-moroso, vicario per la Campagna e Marittima, per l’azione contro Rocca di Papa. Come ricompensa Pietro di Sumoro-so, vicario regio di Roma, diede mandato a Gualtiero di esentare Velletri per la fedeltà dimostrata alla Chiesa da ogni gabella e gravame che esigevano le città confinanti197. Urbano IV fu il primo pontefice a contrastare l’egemonia degli Annibaldi di fede ghibellina nella regione laziale, te-mendo che questi riuscissero a costituire un’area unitaria e organizzata fuori del controllo papale; l’azione in difesa del castello di Lariano da parte di Velletri e Cori nel 1268 av-venne infatti su esplicita richiesta di Clemente IV contro il tentativo di Riccardello di Mattia Annibaldi di impadronir-si del castrum198. Quest'ultimo aveva approfittato della va-canza papale per tentare di impossessarsi di Lariano, unifi-candolo così al territorio dell'Algido già in suo possesso. Velletri riusciva a portare temporaneamente a termine
195 DE SANTIS, Inventario, cit. p. 40. 196 Questi faceva parte di quella schiera di uomini, costituita da
famiglie di ‘pars ecclesiae’ al servizio della monarchia angioina, che aveva rinsaldato i rapporti con il re francese durante la sua discesa in Italia.
197 TESTONE, I Regesti, cit., p. 18. 198 Questo Riccardo, di fede ghibellina al contrario dell’omonimo
cardinale, era reduce dalla battaglia di Tagliacozzo a fianco del giovane Corradino (23 agosto 1268) quando attaccò il castello di Lariano (cfr. FALCO, Il Comune, cit., 36 (1913), p. 388 e p. 449).
GLI AVVENIMENTI
91
un’impresa che era già da qualche tempo nelle mire della cit-tà. Nel 1261 infatti il papa aveva già ammonito i Velletrani, vietando loro di occupare Lariano, azione che questi tenta-rono di reiterare ancora nel 1267 nell’ambito della contro-versia su alcune terre che Guglielmo de Braio, cardinale pre-te di S. Marco, aveva assegnato a fra’ Raimondo castellano della Rocca, ratificandone l’antico possesso. Il 2 febbraio 1263 Urbano IV aveva anche chiesto a Riccardo Annibaldi di difendere energicamente i diritti della Chiesa e di multare Velletri per 300 libbre, denaro che doveva essere usato per la ricostruzione di Lariano199, un castello fondamentale nel quadro del controllo dei traffici commerciali verso la regione della Marittima. Il feudo, proprietà inalienabile della Chiesa, era sotto il diretto controllo papale, anche se veniva concesso in locazione alle varie e potenti famiglie baronali.
Sul finire del XIII secolo assurgeva nel frattempo al so-glio pontificio Bonifacio VIII Caetani fautore di una politi-ca di acquisti patrimoniali per la sua famiglia nelle regioni di Campagna, di Marittima e della Tuscia. Una politica espansionistica che fece dei Caetani una delle famiglie più potenti del Lazio insieme ai Colonna, gli Orsini, i Savelli e gli Annibaldi. Questa politica papale non avvenne comun-que a danno delle sedi episcopali come Velletri o del de-manio ecclesiastico come Sezze, anzi essa ne ribadì gli anti-chi privilegi confermati nel 1298 al podestà, al giudice e agli ufficiali di Velletri. A loro veniva demandato il potere per l’esercizio della giustizia per le cause di prima istanza, vie-tando al contempo al rettore di Campagna e Marittima ogni intromissione in dette cause, favorendone anche la po-litica fiscale200. Il secolo si chiudeva lasciando dunque in
199 J. GUIRAUD, Reg. d’Urbain IV, cit., p. 189. 200 TESTONE, I Regesti, cit., pp. 40-41.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
92
eredità un effettivo rafforzamento delle istituzioni cittadine. Nel periodo intercorso tra Innocenzo III e Bonifacio VIII i papi avevano sollecitato e favorito, nell’ambito della loro ri-cerca di definitiva affermazione, la crescita politica e il raf-forzamento delle istituzioni delle civitates della provincia, parallelamente ad una politica nepotistica tendente a favo-rire l’accrescimento patrimoniale delle proprie famiglie. Abbiamo visto come Alessandro IV, già vescovo di Velletri dal 1231, mantenne la diocesi dopo la sua elezione al soglio pontificio e come Bonifacio VIII si fece eleggere podestà ol-tre che di Velletri anche di Sezze e Terracina; nel 1272 Gregorio X difese i comuni di Sezze, Priverno e Terracina dalle richieste di sudditanza di Roma201. Questo rafforza-mento istituzionale ed economico permetterà alla città di Velletri di tener testa ai tentativi di ingerenza di Roma, solo parzialmente riusciti, durante la imminente vacanza avi-gnonese e di sopravvivere adeguatamente alla crisi generale del secolo successivo.
Il Trecento: l’annosa lotta con Roma
Alla fine del Duecento era ormai un fatto acquisito per
Velletri rappresentare una tappa obbligata nella varietà dei percorsi utilizzati, tra Roma e la provincia, da coloro che muovevano sia lungo la Pedemontana che sulla Latina202, però già all’inizio del XIV secolo, mentre iniziava la cattività avignonese, buona parte della provincia di Campagna e di Marittima era caduta sotto il dominio di Carlo d’Angiò, al
201 CACIORGNA, Marittima medievale, cit., p. 28, n. 79. 202 J. COSTE, Strade da Roma per Sermoneta, in Sermoneta e i Caetani,
dinamiche politiche, sociali e culturali di un territorio tra Medioevo ed età mo-derna, Atti del Convegno della Fondazione Camillo Caetani. Roma-Sermoneta 1993, 16-19 giugno, Roma 1999, pp. 99-100).
GLI AVVENIMENTI
93
quale il territorio era stato affidato da Clemente V e Gio-vanni XXII. Già dopo la morte di Bonifacio VIII, avvenuta nell’ottobre del 1303, il nuovo papa Benedetto XI fu co-stretto a rifugiarsi a Perugia. Questi continuò la politica filo-angioina dei suoi precedessori e non poteva essere altrimen-ti, poiché egli fu proclamato in S. Pietro alla presenza del re Carlo II d’Angiò dopo un conclave nel quale erano stati esclusi i cardinali Colonna, principali esponenti della fa-zione filo-francese. Roma e l’intera provincia rimasero con-seguentemente in preda ad una lotta senza esclusione di colpi tra le varie fazioni. Agli inizi del 1304 i Velletrani si accanirono con efferata violenza contro il vicino castello di S. Gennaro203, all’epoca posseduto dagli Annibaldi, presumibil-mente su mandato dello stesso papa Benedetto XI, dal mo-mento che questi assolse in seguito il comune di Velletri – contro le rivendicazioni avanzate da Giovanni di Trasmondo Annibaldi e Riccardo di Giacomo Annibaldi de Urbe – ag-gressione, depopulatione, incendio et dirutione ipsius Castri et super ominbus et singuils violentiis, incisionibus et devastationibus arbo-rum, rapinis, homicidiis, dampnis, iniuriis et iniuriosis actibus et ex-cessibus quibuscunque eunque factis, datis illatis et commissis tam per vos, quam per singulares personas Civitatis vestre204.
203 Questa notizia è completamente ignorata sia da Landi che da
Alessandro Borgia e conseguentemente anche da Bauco, le cui fonti ri-mangono esclusivamente gli storici veliterni. Sulle vicende del castello di S. Gennaro si vedano anche: G. CRESSEDI, Il castello di S. Gennaro presso Lanuvio, in “Rendiconti lincei” (1952), VII, pp. 287-292; E. PAR-
ZIALE, Castrum Sancti Ianuarii: il castello degli Annibaldi presso Velletri, in «Arte medievale», n. s. III (2004), 1, pp. 59-70.
204 La Bolla Velletrenses a quibusdam bannis et condemnationibus absol-vuntur, data a Perugia l’11 maggio 1304 e indirizzata Dilectis filiis Com-muni Civitatis Velletrensis, è edita in A. THEINER, Codex diplomaticus do-minii temporalis S. Sedis, 1, Roma 1861, DLXXXIV, pp. 401-402.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
94
La situazione era potenzialmente e oggettivamente de-stabilizzante e ciò indusse il popolo di Velletri ad assogget-tarsi al Comune di Roma con un patto formalmente stipu-lato tra due pari, ma che di fatto pose fine al precedente pe-riodo di completa autonomia comunale. La partenza del Pontefice per Avignone aveva infatti lasciato i centri della provincia a lui direttamente dipendenti in balìa delle po-tenti famiglie baronali205. Velletri non rappresentò un caso isolato – nello stesso periodo anche Cori sottoscrisse un patto con Roma che a grandi linee ricalcava quello veliter-no206 – e c’è da ritenere che si arrivò al compromesso con il comune di Roma dopo aver considerato tutti i possibili scenari, forse favorito dalla contingente situazione che aveva visto i Romani destituire i nobili senatori e bandire dalla città gli esponenti delle famiglie più compromesse con Arrigo VII di Lussemburgo, disceso a Roma per rice-vere la corona imperiale.
Il governo cittadino veliterno fu in ogni modo sempre più improntato verso una matrice popolare che possiamo già scorgere nel trattato con Roma207, dove emerse la volon-tà del nuovo “ceto medio” di evitare la possibile ingerenza delle famiglie baronali romane nel proprio territorio. Nel patto fu stabilito infatti che nessun nobile avrebbe potuto
205 Agli inizi del Trecento, Anagni finì nelle mani di Bonifacio, fi-glio di Benedetto Caetani, mentre Sezze subiva la minacciosa influenza di Giovanni da Ceccano. Terracina aveva scelto invece la diretta prote-zione angioina.
206 Il patto, riportato negli statuti di Cori del 1549 e 1572, fu sot-toscritto il 29 novembre del 1312, sedici giorni dopo quello tra Velletri e Roma (cfr. FALCO, I Comuni della Campagna, cit., 49 (1926), p. 148).
207 Il documento ci è giunto da una copia del 1349 (DE SANTIS, Inventario, cit. p. 43) e già edito nel XIX secolo (L. CARDINALI, Dell’auto-nomia di Velletri nel sec. XIV, in «Atti della società letteraria volsca», Vel-letri 1839, pp. 243-250).
GLI AVVENIMENTI
95
abitare entro le mura cittadine o acquistare terre nel distret-to di Velletri. I capitoli sancirono in ogni modo la sottomis-sione giurisdizionale al comune di Roma, che provvedeva ad inviare il podestà ogni sei mesi mentre il giudice, sempre romano, continuava ad essere eletto dai velletrani previa conferma di Roma. L’Urbe si impegnava a concedere aiuto e difesa contro qualsiasi autorità esterna ricevendo in cam-bio il giuramento del sequimentum208, la partecipazione dei velletrani ai giochi di Testaccio e l’offerta annuale di cera per la processione dell’Assunta. Sono queste condizioni certo non gravissime, se consideriamo la grande instabilità politica della regione funestata da reiterate lotte e distruzioni, la lon-tananza del Papa ad Avignone, il fatto che il podestà doveva essere comunque un forestiero e la clausola inserita nei patti secondo la quale il podestà inviato da Roma era tenuto a ri-spettare gli statuti veliterni facta et facienda, a meno che que-sti non fossero in evidente contrasto con gli interessi di Ro-ma. La forza “contrattuale” di Velletri risalta evidente, se si considerano le condizioni già imposte dal comune di Roma ad altre città della provincia. Gli accordi del 1257 tra Tivoli e Roma, infatti, prevedevano non solo il diritto di Roma a nominare il potestas tiburtino, ma anche la facoltà di poter correggere ordinamenta e statuta Tiburis, nonché il diritto a ri-cevere un tributo annuale di mille libre209.
208 Era il giuramento solenne e formale di fedeltà e obbedienza
con il quale la città annualmente, in modo formale a Roma avanti al Senato, si impegnava a riconoscere l’autorità dell’Urbe. Cardinali ri-tenne di assimilare questo giuramento a quello dei Baroni, il cui obbli-go consisteva nel rifiutare asilo agli omicidi, ai falsari e ai banditi.
209 M. MARINO, Cenni sulle trasformazioni e sul funzionamento delle istituzioni politico-amministrative della città di Tivoli dai trattati del 1257 e 1259 alla restaurazione, in Archivio storico comunale di Tivoli, Inventario del-la sezione pre-unitaria (1257-1870), Roma 2003, p. 15: cfr. S. CAROCCI,
VELLETRI NEL MEDIOEVO
96
Il patto sottoscritto tra i comuni di Roma e Velletri –firmato in Campidoglio il 13 novembre 1312 da Branca di Giovanni per conto del popolo romano e da Jacopo Melati sindaco e ambasciatore del comune di Velletri – era dun-que un accordo tra due città “sovrane” e dimostra come Velletri conservasse ancora parte di quel potere economico e politico, derivatole dall’autorità papale, che l’aveva con-traddistinta nel secolo precedente. La scelta di sottomissio-ne fu senza dubbio il male minore per Velletri, che dovette considerare la concreta possibilità di poter cedere la propria autonomia, a vantaggio di una tra le numerose famiglie ba-ronali che stavano stringendo la loro influenza intorno al territorio veliterno, ora che era iniziata la cattività avignone-se. La stessa Roma si mostrava non troppo potente, divisa com’era nella contesa tra le famiglie baronali. Uno scontro che si inasprì dopo la discesa in Italia di Ludovico il Bavaro il quale, già scomunicato da Giovanni XXII dalla sua sede avignonese, in accordo con il popolo romano decretò deca-duti i papi che si fossero allontanati da Roma e fece elegge-re l’antipapa Pietro Rainalducci da Corvara, che prese il nome di Niccolò V. Nel giugno 1328 l'imperatore, accom-pagnato dai romani, mosse contro il castello della Molara e quello di Cisterna di parte angioina. Quest’ultimo venne distrutto e dato alle fiamme. In questo frangente non tro-viamo il popolo velletrano al fianco di Roma e dell’impera-tore, al contrario vediamo la stessa città di Velletri rifiutarsi di accogliere tra le sue mura l’esercito imperiale durante la sua risalita verso Roma210, dimostrando così la sua secolare fedeltà al Papa e la larga autonomia decisionale rispetto a quei patti che non la relegavano evidentemente in una po-
Tivoli nel basso medioevo, società cittadina ed economia agraria, in «Nuovi Studi Storici», 2, Roma 1988, pp. 31-32 e 92-93.
210 G. VILLANI, Cronica, Firenze 1832, X, cap. LXXVII, p. 114.
GLI AVVENIMENTI
97
sizione di mera subalternità. Velletri era rimasto indiscuti-bilmente un centro politicamente potente, come dimostra-no i numerosi podestà velletrani eletti in altre città, e ben difendibile; tra le sue mura trovarono asilo molti di quei cittadini sfuggiti alle distruzioni e alle guerre: da Cisterna entrarono in città numerosi abitanti211.
Risultato dell’accordo con Roma fu anche un diverso rapporto che Velletri intraprese con gli altri Comuni orbi-tanti nella sfera di influenza capitolina e di cui si hanno tracce nelle riformanze medievali di Amelia. Il comune di Velletri scriveva infatti nel 1327 ai nobiles et prudentes viri – podestà, consiglio e comune della città di Amelia – affinché inviassero unum bonum et expertum notarium disposto ad exer-cendum officium syndicatus per sex mensibus proxime secuturis, cum salario XII florenorum. Angelo Massarucoli, nella seduta consiliare del 26 maggio di quell’anno, propose quindi di eleggere un notaio da inviare a Velletri che risultò essere ser Leonardo Jacobutij, il quale, Christi nomine, accettò l’incari-co. Si trattava evidentemente di uno scambio alla pari di personaggi pubblici. Dalla stessa documentazione appren-diamo infatti che, quando tre giorni dopo la ricordata ele-zione il podestà Egidio Jannis (Marchi) di Roma ottenne li-cenza dal consiglio, affinché potesse recarsi nella sua città per il disbrigo di alcuni affari ed assentarsi da Amelia per un periodo di dodici giorni, malgrado quanto previsto dagli statuti cittadini, egli nominò suo vicario per sostituirlo nell’ufficio podestarile il giudice Simone di Velletri, conce-dendogli l’autorità di procedere nei processi civili e penali, con ogni facoltà et omnia et singula facienda que ipse potest, commictens eidem in omnibus et per omnia vices suas212. Un
211 FALCO, Il Comune, cit., 36 (1913), pp. 410-411. 212 G. SPAGNOLI, I. FREZZA FEDERICI, Almanacco, Amelia 1999, p. 22.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
98
Giacomo di Velletri risulta podestà a Sutri nel 1324213. Da Avignone il papa continuò in ogni modo a sostenere il po-polo veliterno: infatti nel luglio del 1328 Giovanni XXII concesse prima la remissione della scomunica nella quale erano incorsi, probabilmente per aver in qualche frangente vacillato a favore della parte imperiale, e esortò poi i velle-trani a proseguire nella lotta contro il Bavaro214.
Nel 1332 troviamo eletto alla carica di podestà Buccio di Giovanni Savelli. Questi, già vicario regio di Roma l’anno precedente, aveva cooperato alla restaurazione ponti-ficia e fu fedele sostenitore degli Orsini215. In questo fran-gente a Roma il disordine e l’anarchia continuavano a re-gnare sovrani; bande di malfattori infondevano terrore tra i cittadini, protetti dagli stessi ufficiali regi. Nella provincia lo scontro si inasprì di conseguenza tra le varie famiglie baro-nali. Le discordie furono temporaneamente sedate nel 1337. Nicola Caetani di Fondi, unitamente a Benedetto Caetani Palatino, firmava un atto di pace in Velletri con Francesco e Pandolfo Savelli, nonché con i loro nipoti Cola e Guglielmo, figli dell’ormai defunto Buccio Savelli. La pa-ce doveva considerarsi rotta ogniqualvolta si recasse ingiuria con più di 10 cavalli e 20 pedoni. Dalla qual cosa si do-vrebbe arguire che le piccole razzie e spedizioni punitive erano considerate inevitabili incidenti giornalieri e di poca importanza. Benedetto XII, nel tentativo di frenare la po-
213 G. FALCO, Studi sulla storia del Lazio nel Medioevo, I, “Miscella-
nea della Società Romana di Storia Patria”, Roma 1998, p. 40, n. 159. 214 FALCO, Il Comune, cit., 36 (1913), p. 406. 215 Velletri rimaneva nella sfera di influenza angioina attraverso gli
incarichi ricoperti da esponenti della nobiltà romana, sicuramente fede-li alla causa francese (M.T. CACIORGNA, L’influenza angioina in Italia: gli ufficiali nominati a Roma e nel Lazio, in «Mélanges de l’École française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes», T. 107, 1. 1995. p. 198).
GLI AVVENIMENTI
99
tenza dei baroni della provincia il 18 maggio 1338, notificò agli stessi il divieto di accedere alle cariche comunali nella Campagna e Marittima. Niccolò Caetani continuò in ogni modo a spadroneggiare nella regione di Marittima. Nel feb-braio del 1341 tentò di impadronirsi di Terracina; respinto ne devastò il territorio. Altre azioni ostili vennero orientate l’anno successivo verso Sezze e Ninfa. Nei territori di quest’ultima i velletrani tenevano a pascolo i loro armenti. Il comune di Velletri, in base al patto sottoscritto nel 1312, avanzò allora una richiesta di rappresaglia al comune di Roma contro il Caetani, il quale hostiliter et armata manu aveva fatto razzia di quantitatem non modicam vaccarum, buba-larum, porcorum et pecudum et aliorum animalium216. La violen-za e la strapotenza del Caetani divennero nel 1347 anche uno dei principali bersagli di Cola di Rienzo. Cola fece ci-tare il Caetani inutilmente in pubblico parlamento alla fine di luglio, poi lo dichiarò decaduto dalla dignità comitale, lo condannò a morte e alla confisca dei beni. La successiva spe-dizione, assai più modesta del previsto, diretta da Angelo Malabranca, a cui presumibilmente parteciparono i cittadini di Velletri, diede battaglia al Caetani ai piedi di Sermoneta e lo sconfisse. Il conte di Fondi giurò fedeltà a Cola i primi di settembre e fece pace anche con Terracina e Gaeta.
Nel 1346 tutta la città – il podestà, i contestabili dei ba-lestrieri e il popolo armato, accompagnati dai musici delle quattro decarcie con trombe, nacchere e cennamelle217 – aveva anche mosso contro Piglio, poiché un tale Niccolò di
216 DE SANTIS, Inventario, cit. p. 42. 217 La cennamella era un rudimentale strumento musicale a fiato
ricavato da una canna. Trombe, nacchere e cennamelle erano i consueti strumenti suonati dai banditori del Comune. Questi facevano parte del-la milizia comunale e dovevano seguire le insegne e i loro comandanti in ogni battaglia. È una parola che ricorre nell’Anonimo Romano.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
100
quel castello aveva rifiutato di sottostare alla condanna del-la curia veliterna218.
Lo scontro nella provincia andava facendosi sempre più serrato, mentre il comune di Roma si mostrava intenzionato a rivedere a suo favore i patti sottoscritti nel 1312219. La co-pia dei capitoli, uno dei pochi documenti pervenutici rela-tivamente alla prima metà del XIV secolo, dimostra che il trattato fu riproposto nell'evidente necessità di difendere quelli che venivano considerati propri diritti nel sempre più cruento scontro con Roma, che sfocerà nei decenni succes-sivi in una lotta senza esclusione di colpi. Nel 1351 il consi-glio generale e speciale della città diede infatti mandato ad Andrea di Nicola di Bartolomeo di rappresentare il Comu-ne, al fine di sostenerne le ragioni nella causa civile e penale intentata contro Giovanni di Pietro Mete, cittadino roma-no e già podestà di Velletri220.
La situazione era precipitata dopo la presa di potere in Roma da parte di Cola di Rienzo; questi nel maggio del 1346 aveva riunito presso Santa Sabina o Sant’Alessio, sull’Aventino, esponenti della borghesia mercantile ed arti-giana e aveva presentato il suo piano finanziario per il risa-namento di Roma221. Le rendite dovevano provenire dalla tassa del focatico, dal monopolio del sale, dal transito dai porti e dalle rocche, dal passaggio delle bestie e dalle con-danne a pene pecuniarie. Tali rendite facevano riferimento al districtus Urbis comprendente, oltre alla città di Roma ed i suoi immediati dintorni, la Tuscia fino al ponte sul fiume
218 FALCO, Il Comune, cit., 36 (1913), p. 409. 219 Iniziò allora una annosa lotta tra Velletri e il comune di Roma,
che si protrasse fino alla tregua firmata il 29 settembre 1389. 220 DE SANTIS, Inventario, cit. p. 43. 221 G. PORTA (a cura di), Anonimo Romano, Cronica, XVIII, Mi-
lano 1981.
GLI AVVENIMENTI
101
Paglia, all’altezza di Montalto di Castro, la Campagna fino al ponte di Ceprano e la Marittima, fino a Terracina. Velle-tri si vedeva dunque gravare di imposte che erano state al contrario del tutto escluse dagli accordi del 1312. La città in un primo momento aveva visto in ogni modo con favore la nascita del governo popolare di Cola, nell’ottica della sua secolare lotta contro le famiglie baronali. Le truppe velle-trane nel 1354 sono anche schierate al fianco del tribuno, durante la sua seconda breve avventura, nell’assedio peral-tro fallito contro Palestrina e i Colonna. Si noti come per Velletri la fedeltà al Papa non era una condizione subordi-nata, anzi rimaneva un tema centrale e sostanziale nei con-fronti di ogni altra singola vicenda. La città è con Cola poiché questi aveva ricevuto l’investitura papale, mentre abbiamo visto come Velletri avesse rifiutato l’appoggio al popolo romano che agiva in nome di Ludovico il bavaro. Dopo la morte di Cola di Rienzo, Innocenzo VI racco-mandò ad Egidio D'Albornoz, impegnato a ristabilire l’autorità pontificia, un velletrano come rettore della Cam-pagna e Marittima.
Non bisogna in ogni modo ritenere che la vita trascor-resse in uno stato di continua allerta. La città pullulava e vi-veva nelle sue azioni quotidiane: nel 1353 venne eretta la Torre del Trivio, forse in conseguenza dello scioglimento di un voto effettuato per richiedere la cessazione di quella “pe-sta nera” che aveva attraversato l’Europa intera, decimando gran parte della popolazione; nel 1355 il Comune si fece garante della divisione dei beni della famiglia dei Savelli, con la condizione di poter procedere contro coloro che non avessero rispettato i patti222; nel 1362, da Avignone, il car-
222 DE SANTIS, Inventario, cit. p. 43; FALCO, Il Comune, cit., 36
(1913), p. 410.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
102
dinale Niccolò Capocci stabiliva che due giovani veliterni, ogni sei anni, potevano essere ospitati presso l'università di Perugia per lo studio di diritto civile e canonico223. In que-sto periodo venne costruito anche il nuovo palazzo comu-nale, segno di una ritrovata seppur momentanea stabilità politica ed economica, frutto forse dell’azione come giudice del perugino Morandino di Boccobardi, che utilizzò per opere di pubblica utilità il denaro ricavato dai processi per corruzione224.
Gli equilibri erano però ormai saltati; Velletri vedeva in quel momento effettivamente a rischio la propria auto-nomia e non trovò altra soluzione se non quella di prose-guire la lotta contro il comune di Roma, che si faceva sem-pre più esoso ed ingerente. Alla fine in ogni modo Velletri capitolò, parte delle sue mura vennero abbattute e le porte della città trasportate a Roma. La notizia fu riferita da Laz-zaro de’ Cancellieri ai fiorentini attraverso una lettera che recava la data del 12 maggio 1362225. Il Consiglio generale di Velletri, radunato presso la chiesa di S. Francesco e nello stesso palazzo comunale, per provvedere alle spese di risar-cimento nei confronti di Roma e alla riaffida generale, eleg-geva quattro boni homines i quali, a causa del dissesto finan-ziario del Comune, presero a prestito denaro dagli Ebrei.
Nel settembre del 1363 però le ostilità ripresero vigore. In seguito ad una scorreria dei Romani nel territorio velle-trano, il Consiglio generale e speciale elesse di nuovo quat-tro boni homines, di indiscussa autorevolezza, con ampi pote-ri per condurre le trattative e reperire i fondi necessari per il
223 ACV, Perg. 63, Avignone 18 giugno 1362. Ancora nel 1466 ne poté beneficiare Antonio Mancinelli.
224 FALCO, I Comuni della Campagna, cit., 49 (1926), p. 197. 225 Le fonti sono riportate da Bonadonna Russo nel suo commen-
to al Compendio (LANDI, Compendio, cit., p. 46, n. 113).
GLI AVVENIMENTI
103
riscatto di uomini e animali. I primi quattro furono eletti per la durata di sei mesi, gli altri si sarebbero poi avvicenda-ti ogni tre mesi. I primi procedettero immediatamente all’elezione di dieci custodi dei campi tra coloro che presso il catasto comunale avevano almeno “dieci denari per cen-tenario”. Tra i quattro, Cecco Mancini e Giovanni di Ste-fano Palomba si mostrarono come i più tenaci e combattivi. Accanto alla reazione violenta contro ogni cittadino roma-no, Velletri continuò a confidare sull’antico appoggio del Papa, al quale inviò un’ambasciata tramite il velletrano Nic-colò Symarde. Urbano V, che aveva ovviamente interessi convergenti con la città, nel tentativo di riacquisire il pos-sesso delle sue terre, esortò Roma e Velletri alla concordia, rassicurando inoltre i velletrani di aver scritto al cardinale D’Albornoz, al Senatore e al popolo romano di togliere gra-vami e restrizioni alla città di Velletri. L’Albornoz diede a sua volta mandato a Tommaso, cardinale di S. Angelo, di riportare la pace, ma gli animi erano così esasperati che si potè addivenire solamente ad una tregua della durata di un anno tra Roma, Velletri e Sanzia Caetani, vedova di Stefa-no Colonna e alleata dei velletrani226. A rappresentare Vel-letri furono nominati il maiore Nardo di Gorio di Nardo227 e Niccolò Ventura. Con questo accordo veniva sospeso ogni diritto di Roma, compreso l’invio del podestà e quello della riscossione di ogni tipo di imposta. Velletri ottenne quindi
226 DE SANTIS, Inventario, cit. pp. 47-48. 227 Nardo o Leonardo di Gorio fu uno dei personaggi più eminen-
ti della politica veliterna di questo periodo. Urbano VI (1378-1389) gli affidò anche la temporanea castellania di Cisterna e del suo tenimento che il papa aveva ottenuto in pegno da Riccardo Frangipane a fronte di un prestito di 600 fiorini. (G. SILVESTRELLI, Città, castelli e terre della re-gione romana: ricerche di storia medioevale e moderna sino all’anno 1800, I, Roma 1993, p. 114. Ripr. facs. dell’ed. Roma 1940).
VELLETRI NEL MEDIOEVO
104
di potersi eleggere autonomamente il podestà, anche se questi doveva essere sottoposto all’approvazione della Curia capitolina. Questa situazione fu evidentemente favorita dal momentaneo rientro a Roma di Urbano V e dalla conver-genza tra gli interessi di Velletri con quelli del Papato, che guardava ora alla concreta possibilità di un ritorno stabile nella sua sede tradizionale.
La tregua fu in ogni modo di breve durata e già l’anno successivo la lotta riprese ancora più cruenta, per conclu-dersi qualche anno più tardi, nel 1367, quando il senatore di Roma, il fiorentino Bindo de’ Bardi, pronunciò la riaf-fida a favore del podestà, dei nove, del sindaco e degli uo-mini veliterni, un elenco di oltre quattrocento persone, ri-stabilendo di fatto le condizioni precedenti al conflitto. I disordini però continuarono. Unite le loro milizie, Corani e Velletrani assaltarono in seguito i monasteri di S. Paolo e S. Maria Rotonda nel territorio di Albano causando gra-vi danni che in seguito il Comune veliterno si impegnò a risarcire dopo l’arbitrato dell’abate Angelo di San Basilio de Cantusecuto di Roma e di Andrea “domini Iohannis” dell'archipresbiterio di Velletri228. In seguito le bande armate di Velletri e Cori operarono un nuovo assedio al castello di Lariano, che continuava a rimanere proprietà della San-ta sede, anche se concesso di volta in volta in enfiteusi a nobili famiglie. All’epoca se ne contendevano il controllo gli Orsini di Marino, ai quali Lariano fu concesso da Cle-mente VII antipapa nel 1378, e i Conti, che già l’anno successivo risultano averne preso il controllo. La presenza di queste famiglie era avvertita da Velletri come una mi-naccia, tanto da giustificare varie azioni di disturbo culmi-nate poi nel 1433 con la distruzione del castello. Nel 1377
228 BORGIA, Istoria, cit., p. 319.
GLI AVVENIMENTI
105
in ogni modo fu sancita una tregua tra le parti, che ratificò i confini tra Velletri e Lariano facendo riferimento alla Bol-la di Gregorio IX229.
Nel 1370 il pretesto di un ferimento di un ufficiale romano indusse la Curia capitolina a imprigionare sedici velletrani, che vennero rilasciati dopo che il comune di Vel-letri si obbligò a pagare un nuovo tributo annuo di mille libbre di provisini. La questione si protrasse per quasi trent’anni, tra pagamenti e rifiuti, fino a quando la città ne fu liberata definitivamente da Bonifacio IX nel 1398. In questo periodo avvenne un’ulteriore ed esasperata evolu-zione della già presente rappresentazione dicotomica della società, ma non maiores contro minores. La distinzione fon-damentale tra i due gruppi, consistente nella loro ricchezza patrimoniale e insita nella stessa origine nobiliare dei primi, che vietava loro di occuparsi direttamente degli affari rispet-to ai secondi che, al contrario, gestivano direttamente i loro beni, non sembra riflettersi nelle fazioni veliterne. La città appare invece divisa tra “Agnelli”, fautori di un Comune democratico, e “Lupi”, i quali dopo aver rivendicato l’auto-nomia da Roma si allearono con quest’ultima; ognuna delle due fazioni aveva in sé una componente sia nobile che po-polare230 e sono attestate per la prima volta in un documen-to del 1371231. Esse si fronteggiarono aspramente fino alla definitiva ricomposizione delle parti nel 1431232. Nel 1372 il tentativo di ristabilire la pace tra le fazioni sembrò andare in porto. Il podestà, i Nove e i rappresentanti delle quattro decarcie vennero incaricati della riaffida dei fuoriusciti, i quali ultimi si impegnarono a prestare giuramento di fedel-
229 LANDI, Compendio, cit., pp. 50-51 230 IVI, p. 51. 231 FALCO, Il Comune, cit., 36 (1913), p. 425. 232 DE SANTIS, Inventario, cit., p. 73, Perg. 106.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
106
tà al Comune. Già l’anno successivo però la situazione pre-cipitò di nuovo, poiché nei pressi della Faiola venne ucciso uno dei comestabili233 dei balestrieri. Nel 1374 il podestà Jacovello Pantaleoni e il giudice sezzese Pietro Parlatore im-pegnarono il Comune in un'azione più incisiva per pacifica-re la città, che sarebbe dovuta passare anche attraverso la ri-forma degli statuti. I risultati non dovettero essere sufficien-ti, se solamente il mese successivo il comune di Roma in-tervenne in prima persona, probabilmente su richiesta degli stessi velletrani, eleggendo due cittadini romani con l'inca-rico di mettere pace tra le fazioni veliterne234. La conseguen-za più pesante di questi avvenimenti fu che i romani ripre-sero ad inviare i loro podestà235, i quali ultimi ad ogni mo-do riuscirono a far cessare le ostilità tra i Lupi e gli Agnelli, interferendo pesantemente nella politica veliterna. Infatti quando nel giugno dello stesso anno il Consiglio generale deliberò la proposta di riforma degli statuti, tra i capitoli da emendare erano scomparsi quelli relativi all’elezione dei Nove, alla potestà loro concessa per la riaffida dei con-dannati236 e quelli relativi alla limitazione dei poteri del podestà e del giudice. Il motivo del contendere tra le due fazioni cittadine era degenerato a tal punto che per porre rimedio alla situazione venne deciso di sospendere gli sta-tuti e di procedere alla loro revisione affidandola ad alcuni
233 Il termine, dal tardo latino comes stabuli, letteralmente “conte di
stalla”, identificava gli ‘ufficiali’ delle corporazioni cittadine. 234 FALCO, Il Comune, cit., 38 (1915), appendice, pp. 79-89. 235 Ivi, pp. 95-99. 236 Questa disposizione con relativa riforma dei capitoli venne ri-
proposta e attuata solamente nel secolo successivo durante il periodo di occupazione durazziano (DE SANTIS, Inventario, cit. p. 65, Perg. 67, 24-25 aprile 1407).
GLI AVVENIMENTI
107
massari, tra i quali doveva esserci un giudice esperto e un notaio forense237.
La città si trovò però ad affrontare una minaccia ester-na ancora più grave, le truppe di Onorato I Caetani che fa-cevano scorrerie nella campagna veliterna devastando e raz-ziando. Dal 1377 sino ai primi decenni del ’400, la regione di Marittima, così come il resto d’Italia, fu lacerata dagli ef-fetti del grande scisma della Chiesa d’Occidente, cui pose fine l’elezione del cardinale Oddone Colonna, il quale nel 1417 salì al soglio pontificio con il nome di Martino V, causa ed effetto del ritorno all’unità ecclesiastica. La pro-vincia rimase indubbiamente in una situazione esplosiva, nell’ambito della lotta scismatica tra Urbano V e l’antipapa Clemente VII, quando vere e proprie orde di uomini im-perversarono al di fuori della cinta muraria veliterna facen-do razzia di ogni cosa e uccidendo uomini e animali238. Onorato I Caetani svolse un ruolo decisivo nell’attuazione dello scisma. L’incoronazione di Roberto da Ginevra, avve-nuta a Fondi il 31 ottobre 1378 nella Cattedrale di San Pie-tro apostolo, testimonia la potenza che aveva oramai rag-giunto il conte di Fondi. Durante la solenne cerimonia
237 I capitoli sottoposti a riforma includevano: libro I, rub.
XXXVIII Quod nullus habens officium in Velletro possit exercere aliquod aliud officium in dicta civitate; libro I, rub. LXXII Quod aliqua positio non fiat in consilio, que esset contra formam alicuius statuti; libro I, rub. LXXIIII Quod quicumque habuerit aliquod officium, videlicet: officium Novem, camerariatus, consilariatus, consulatus sylve et Scyindici, non possit habere aliquod aliud offi-cium hinc ad duos vel tres annos; libro I, rub. CLXXX De electione scyndica-toris et eius officio; libro III, rub. XXX Quod nullum parlamentum fieri possit in civitate Velletri nisi modo infrascripto; libro V, rub. CLXXX Quod aliud statutum non fiat in civitate Velletri hinc ad sex annos; libro I, rub. LXXX Quod nullus eligat aliquem officialem nisi de decarcia sua (FALCO, Il Comune, cit., 38 (1915), appendice, p. 101).
238 FALCO, Il Comune, cit., 36 (1913), p. 432.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
108
Onorato I pose con le sue mani di principe laico la tiara sulla testa del pontefice Clemente VII. In cambio Onorato riceveva il rettorato di Campagna e Marittima con il titolo di Conte. Tra i paesi della provincia Terracina aderì imme-diatamente alla causa scismatica, ricevendo in cambio nuo-vamente la concessione della dogana del sale così come Anagni, tradizionalmente vicina alla famiglia Caetani. Sezze già dal 1360 aveva perso la sua autonomia a favore del con-te di Fondi, ma nel 1367 si era ribellata e aveva restaurato gli ordinamenti popolari giurando fedeltà alla Chiesa. Suc-cessivamente la situazione era mutata di nuovo e le rela-zioni tra le parti erano decisamente migliorate; nel 1381 gli uomini di Sezze, scortati dai mercenari di Onorato I, parteciparono alla distruzione della città di Ninfa. Il meri-to di queste buone relazioni fu anche di Caterina del Bal-zo, moglie di Onorato Caetani, la quale, quando questi si recò nella Curia avignonese per sollecitare aiuti da parte di Clemente VII, cercò di assicurare al marito l’appoggio di Sezze e Velletri.
L’antipapa era tornato nella sede avignonese dopo la sconfitta del suo esercito, subita da parte delle forze di Ur-bano VI capitanate da Alberico da Barbiano, riconosciuto maestro di un’intera generazione di capitani di ventura, nel-la famosa battaglia di Marino avvenuta nell’aprile del 1379. Ascanio Landi ignorò completamente questo avvenimento, al contrario fortemente valorizzato in numerose cronache locali nelle quali fu esaltato come il primo successo di un esercito italiano su armi straniere239. Lo scontro, anche se aveva indubbiamente rafforzato la posizione di Urbano VI,
239 LANDI, Compendio, cit., p. 55 n. 142. Bonadonna Russo mette
qui in risalto la ristrettezza degli orizzonti del Landi, che continua ad at-tenersi alla sola fonte del Platina.
GLI AVVENIMENTI
109
non ebbe sensibili conseguenze sul potere dei Caetani e sui Bretoni che, reduci dalla disfatta di Marino, continuavano le loro razzie nel territorio veliterno. Dopo una serie di scontri – nel corso dei quali Cori aveva inviato 200 sagittari per combattere al fianco di Velletri – le parti in conflitto strinsero un accordo, attraverso il quale Onorato I tentò evidentemente di consolidare con Velletri un appoggio in funzione antipapale. La stessa città di Roma fu peraltro co-stretta a stipulare un accordo di pace (dicembre 1380). Vel-letri cedeva alle pressioni di Onorato Caetani per assicurar-si la pace, anche se vedeva così restringere ancora di più la propria autonomia. La città si impegnò a non dare ospitali-tà ai nemici di Onorato: Adinolfo Conti, suo fratello Gia-como Caetani conte palatino e Benedetto Caetani di Pofi. L'accordo, siglato a Fondi il 18 ottobre 1380 dal discretus vir Pucciarello Paolozzi sindaco veliterno, non pose in ogni modo fine agli scontri. I Bretoni al servizio di Onorato, dal castello di Ninfa dove si erano accampati, continuarono le loro razzie nel territorio veliterno, nonostante la città avesse nominato due deputati, Pietro del Bufalo e Antonio Del Vecchio, per fronteggiarne gli assalti. Il fallimento dei due incaricati indusse il popolo velletrano a ricorrere ai servigi di Annibale Strozzi, capitano fiorentino reduce da una posi-tiva campagna a Tivoli, al quale furono conferiti pieni pote-ri. Questa vicenda provocò forse la prima vera frizione con il papato, che temeva l’instaurarsi di una signoria in Velle-tri. Incurante delle proteste di Urbano VI, il Consiglio ge-nerale di Velletri confermò lo Strozzi per un periodo di due anni240. Questi dopo una serie di scaramucce con il nemico
240 Tra i testimoni dell’elezione dello Strozzi troviamo il nobile
Riccardo Frangipane a fianco del popolo veliterno, in un evidente ruolo anti Colonna.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
110
riuscì ad avere la meglio sui Bretoni nella famosa battaglia delle ghiande ricordata dal Landi 241, la cui vittoria, secondo Mancinelli, avvenne grazie all’intercessione di S. Geral-do242. Ma il pericolo non cessò; nel 1383 le forze al co-mando di Fabrizio Colonna invasero il territorio veliterno, catturando uomini ed animali che condussero nel castello di Genazzano. Per far fronte alla situazione il Consiglio ge-nerale, riunito presso la chiesa di S. Francesco, con 177 voti a favore e 26 contrari – sarebbe stato interessante conoscere il motivo per cui ventisei cittadini votarono contro questa risoluzione – deliberò la nomina di Paolo di Nuzio Paolozzo e Cecco Cimini in qualità di antepositi, con ampi poteri per contrastare le azioni del Colonna, del duca Luigi d’Angiò e di Fabrizio Spalvieri243. Questi avvenimenti riflet-tevano la più ampia ed incerta situazione politica generata dallo scisma. L’anno precedente infatti Luigi d’Angiò aveva approntato un esercito con l’intento dichiarato di liberare la regina Giovanna di Napoli che, essendo partigiana dell’antipapa Clemente VII, era tenuta prigioniera a Napo-li. Lo scontro tra i due eserciti però non avvenne mai. Carlo di Durazzo, che era stato riconosciuto re di Napoli il primo giugno 1381 da Urbano VI, decise di affermare ad ogni co-sto l’indiscutibilità della sua ascesa al trono e per sgombrare il campo da qualsiasi rivendicazione ordinò l'assassinio della
241 LANDI, Compendio, cit., pp. 58-59. 242 Questo episodio, riportato solamente dal Landi e ignorato dagli
storici successivi, era già stato raccontato da Antonio Mancinelli in uno dei suoi epigrammi, circostanza che ne confermerebbe la veridicità poi-ché la famiglia dell’umanista era da secoli inserita nel governo della cit-tà veliterna (A. MANCINELLI, Primus epigrammaton libellus, Roma, Silber, 1503, Ad Carolum regem Franciae Velitris hospitantem, v. 10); cfr. F. LAZZA-
RI, M. LOZZI, Gli Epigrammi di Antonio Mancinelli, Tivoli 2009, pp. 72-74. 243 FALCO, Il Comune, cit., 39 (1916), appendice, pp. 468-479.
GLI AVVENIMENTI
111
regina. Giovanna d’Angiò fu raggiunta dai sicari nel castello di Muro Lucano dove morì il 12 maggio del 1382.
Il contrasto tra Velletri e i Colonna, fautori dell’antipa-pa, si protrasse a lungo, poiché ancora nel 1400 il Consiglio generale di Velletri tornò a deliberare, in deroga agli statuti, più ampi poteri ai Nove per condurre la lotta contro Nicco-lò Colonna. Durante i turbinosi ultimi anni del XIV secolo Velletri cercò quindi nuovamente la protezione di Roma, con la quale nel 1381 era stata confermata la nomina del podestà e ribadito l’obbligo a partecipare ai giochi di Te-staccio. La situazione mutò radicalmente nel 1398, quando Bonifacio IX riuscì ad avere la meglio sul comune di Roma. La fortuna di Onorato era oramai al tramonto e quando morì nel 1400 aveva già ceduto gran parte del territorio alle forze del papa. Da questo momento i podestà di Velletri fu-rono nominati direttamente dal pontefice, prima per un periodo indeterminato e poi secondo consuetudine per la durata di sei mesi. Il 12 aprile del 1400 il papa nominò a questa carica Paolo de Malleotiis244. In cambio della rinno-vata fedeltà Bonifacio esonerò definitivamente Velletri dall’obbligo del pagamento annuo dei mille provisini pre-cedentemente stabiliti in favore del comune di Roma. Il Quattrocento: massimo splendore e fine del periodo comunale
La pace era comunque ancora lontana. Ladislao di Du-
razzo re di Napoli non nascondeva le sue ambizioni di con-quistare Roma. Durante questo tentativo di assoggettamen-to Velletri si vide costretta a cedere alle richieste di fedeltà del re, ottenendo come contropartita il godimento delle
244 BORGIA, Istoria, cit. pp. 334-335.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
112
proprie leggi e consuetudini245. Nel 1408 Ladislao, prima di prendere Roma, si accampò due giorni a Velletri, da dove sferrò l’attacco contro Ostia, e ne fece consolidare la cinta muraria246. L’anno successivo il podestà di nomina regia Sil-lano Pignatelli riuscì a pacificare le fazioni dei Lupi e degli Agnelli. Nel 1412 la città, in balìa evidentemente ora di una, ora dell’altra fazione, contribuì con 650 scudi d’oro al-la richiesta dell’antipapa Giovanni XXIII per riscattare la terra di Sezze in mano a Ladislao. In cambio il pontefice li-berò il comune dall’obbligo di inviare cento fanti e sei cava-lieri a richiesta del Rettore di Campagna e Marittima, di de-legare un sindaco ai parlamenti generali della Provincia e di riservare alla Sede apostolica le cause di appello civili e pe-nali della città247. Nel 1413 Ladislao riprese nuovamente Roma – dove era entrato già nella primavera del 1408 – e occupò Viterbo e gran parte della Tuscia. Il 6 agosto 1414 l’improvvisa morte di Ladislao, quando tutto sembrava pro-cedere secondo i suoi piani di conquista, mutò decisamente il corso degli avvenimenti, che portarono il sinodo di Co-stanza a porre fine allo scisma con l’elezione di Martino V e a nominare Alto Conti alla carica di rettore di Campa-gna e Marittima. Seguì in Velletri un periodo di relativa tranquillità, durante il quale vennero ribadite le limitazio-ni e le modalità di elezione dei magistrati cittadini – Si-gnori nove, Camerario, Consules sylvae, Sindaco, ufficiali dei
245 DE SANTIS, Inventario, cit. p. 65, Perg. 66 e 68. 246 “Re Lanzilao … prima stette a campo a Velletri doi dì, et pigliao
Hostia per forza … et poi fece edificare torri in Roma, et fece ordinare la roccatura in Velletri in Tivoli in Core ..” (F. ISOLDI (a cura di), Il Diario attribuito a Gentile Delfino, in RIS, II, Città di Castello 1912, pp. 78-79).
247 DE SANTIS, Inventario, cit. p. 67, Perg. 74.
GLI AVVENIMENTI
113
“danni dati”248 – già fissate nei capitoli dello statuto comu-nale, i quali non potevano essere rieletti alla stessa carica per un periodo di due anni. Il divieto era esteso anche ai lo-ro affines, ai nobili, ai vassalli domini, ovviamente ai diffidati, nonché agli avvocati e notai della stessa città249. Nel 1426 furono rinnovati i capitoli con Roma250 e definiti nuova-mente i confini con il castello di Lariano.
L’elezione di Eugenio IV nel 1431 fece ritrovare Velle-tri al centro della politica di questo papa contro i Colonna e i Savelli, dando origine per Velletri a quella che Mancinel-li definì, solo pochi anni più tardi, una nuova età dell’oro. Dopo aver dichiarate ribelli e nemiche della Chiesa le nobi-li famiglie romane, il papa iniziò una serie di azioni che portarono alla confisca dei loro castelli, terre e beni. Alla fine di queste azioni ai Colonnesi rimaneva solamente il ca-stello di Lariano che le truppe papali, forti di quattromila unità guidate da Micheletto Attendolo su ordine di Gio-vanni Vitelleschi, cinsero d’assedio per oltre quattro mesi, senza riuscire nell’intento di farlo capitolare251. Il comune di Velletri, a cui era delegato l’onere delle spese di mante-nimento per la truppa, decise allora di muovere con le pro-prie forze all’assalto del castello. Al comando del capitano Paolo Annibaldi della Molara circa 800 velletrani riusciro-no nell'impresa, costringendo i colonnesi a ritirarsi nella rocca. Nell’ottobre del 1433 i sindaci Nardo di Stefano e Cola di Nardo in rappresentanza dei larianesi si recarono al palazzo comunale di Velletri, dove alla presenza dei Nove
248 Erano i magistrati deputati a giudicare le cause per i danni pro-
vocati da uomini e animali nelle coltivazioni. 249 AsCV, Perg. 85, 21 novembre 1421; DE SANTIS, Inventario, cit.
p. 71. 250 DE SANTIS, Inventario, cit. p. 72, Perg. 89. 251 LANDI, Compendio, cit., p. 84.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
114
sottoscrissero le condizioni di resa252. Il castello di Lariano cadeva nelle mani dei velletrani e in cambio i larianesi rice-vevano il diritto di cittadinanza unitamente ad una serie di esenzioni fiscali e amministrative. Nel 1443 Eugenio IV ne confermava il possesso alla città253. Velletri coglieva il mo-mento favorevole per espandere i propri confini. Lo stesso anno distruggeva il castello di San Pietro in formis, occupava la rocca di Acquapuzza, ricevuta in custodia dal papa, e strappava il castello della Faiola ai Savelli. Eugenio IV aveva nel frattempo restituito a Velletri l’elezione del giudice e diminuita la quantità di cera dovuta ai romani in occasione della festa dell’Assunta in base ai patti del 1312254. La situa-zione mutò di nuovo nel 1447, quando il neo eletto papa Niccolò V – che tra le altre cose elesse alla carica di podestà Lorenzo di Giacomo Velli – si impegnò a restituire ai Co-lonna i castelli loro sottratti. In seguito alle proteste dei vel-letrani il castello della Faiola venne però di nuovo confer-mato alla città. I Colonna, rientrati nel possesso di Lariano, portarono avanti vari tentativi di ricostruzione della fortez-za, che però vennero definitivamente interrotti nel 1463 con il breve di Pio II, che ne decretò la definitiva distruzio-ne255, anche se questo non arrestò le rivendicazioni colon-nesi. Nel 1465 la sentenza arbitrale del cardinale rotoma-gense Guglielmo d’Estouteville divise il territorio lungo il crinale del monte e ne assegnò il territorio, già possesso del castello di Lariano, verso meridione a Velletri, mentre ai Colonna fu restituito quello a nord, ribadendo in ogni mo-do che la rocca non doveva essere più riedificata. Nel 1479
252 DE SANTIS, Inventario, cit. p. 74; Perg. 89, 26 ottobre 1433. 253 BORGIA, Istoria, cit. pp. 357-360. 254 LANDI, Compendio, cit., p. 87; DE SANTIS, Inventario, cit. p. 74. 255 LANDI, Compendio, cit., p. 96; DE SANTIS, Inventario, cit., p. 84,
Perg. 125.
GLI AVVENIMENTI
115
un’altra sentenza del cardinale stabilì i confini anche con il comune di Nemi. Gli ultimi anni del secolo rappresentaro-no il canto del cigno della secolare autonomia della città, che riuscì a recitare ancora un ruolo centrale nella politica pontificia. Dopo l’esenzione dall’obbligo di inviare giocatori alla festa annuale di Testaccio, Velletri otteneva da parte di Sisto IV della Rovere la conferma di tutti i privilegi accor-dati dai precedenti pontefici e il riconoscimento dei propri statuti cittadini256, Quando nel 1482 divampò la guerra tra il papa e Alfonso di Calabria, chiamato a Roma dalle fami-glie dei Della Valle, Santa Croce, Orsini, Savelli e Colonna, Velletri scese naturalmente a fianco del papa. Il 21 agosto di quell’anno nei pressi di Velletri, in località Campomor-to257, avvenne lo scontro tra i due eserciti e la vittoria arrise alle armi pontificie capitanate da Roberto Malatesta258 si-gnore di Rimini, tra le cui fila si distinsero cinquecento vel-letrani, tra cui almeno duecentocinquanta balestrieri. Nella battaglia si scontrarono da una parte 4500 cavalli e 6000 fanti e da quella aragonese 2500 cavalli e 1500 fanti. Rober-to Malatesta divise l’esercito in sette squadroni e si pose al comando della sesta schiera. Il duca di Calabria mise la ca-
256 DE SANTIS, Inventario, cit. p. 92, Perg. 145. 257 BORGIA, Istoria, cit., p. 378. 258 La presenza del condottiero riminese potrebbe aver dato origi-
ne al toponimo della contrada ancora esistente. I curatori del volume Strade e Contrade nella Storia (p. 154) non sembrano propendere per questa ipotesi, adducendo il fatto che il Malatesta morì a Roma proba-bilmente di malaria, ma corse voce che fosse stato avvelenato, pochi giorni dopo la battaglia. La lettura del racconto di Alessandro Borgia sembrerebbe al contrario avvalorarla: «Roberto doppo la Vittoria si condusse a Velletri per curare i Feriti, e riposar gli Stanchi, e il giorno seguente mandò la cavallaria Leggiera a metere a sacco le bagaglie del Duca» (BORGIA, Istoria, cit., p. 378). Episodio che potrebbe aver dato origine anche al toponi-mo “Ara di Stanga” (campo degli stanchi).
VELLETRI NEL MEDIOEVO
116
valleria al centro, la fanteria alle ali e l’artiglieria sui rialzi del terreno. La mattina furono respinti gli attacchi portati dalla fanteria pontificia prima e dalla cavalleria successiva-mente. Malatesta pensò quindi di sostituire le schiere stan-che del combattimento con altre fresche e piombò nuova-mente sul nemico. Gli aragonesi contrattaccarono, ma fu-rono costretti a ripararsi dietro un piccolo torrente. A que-sto punto si ebbe la fase decisiva della battaglia. Duecento cavalli leggeri e 1500 fanti, guidati da Jacopo Conti, signore di Montefortino e condottiero di ventura, riuscirono ad at-traversare la zona paludosa e boscosa ed a prendere di fian-co ed alle spalle i napoletani. Lo scontro, che durò sei ore, risultò uno dei più sanguinosi della seconda metà del Quat-trocento dal momento che rimasero sul terreno circa 1200 morti. Trecento soldati aragonesi furono inoltre catturati. Il duca di Calabria si salvò miracolosamente ripiegando a Ter-racina via Nettuno, mentre Roberto Malatesta si ritirava a Velletri, dove lasciò i feriti e fece riposare l’esercito. Dopo questa battaglia il toponimo Campomorto sostituì quello più antico di S. Pietro in formis. Effettivamente lo scontro tra il duca di Calabria e le armi pontificie lasciò sul terreno un numero ragguardevole di morti, in considerazione delle piccole armate che si combattevano in Italia in quel perio-do. Successivamente, come ricompensa per l’azione portata contro Ardea e Rocca di Papa, Velletri ricevette parte dei feudi dei Savelli259. Ancora nel 1493 il neo eletto papa Ales-sandro VI Borgia confermava ai velletrani il possesso dei ca-stelli di Lariano e della Faiola, nonché l'esenzione di pre-
259 LANDI, Compendio, cit., p. 106; DE SANTIS, Inventario, cit. pp. 95-96, Perg. 156. Velletri ottenne i casali di Torre Orlando, Campoleo-ne, ‘Lepontonne’, Santa Maria Palomba, la metà delle Torri dei Gan-dolfi e di Nemi, le case dei Savelli in Albano e gli orti e le terre a loro confiscati.
GLI AVVENIMENTI
117
senziare ai giochi di Testaccio, ma a partire da allora inevi-tabile fu la perdita di importanza della città, nel panorama politico che si andava ampliando in una prospettiva euro-pea. Di questa situazione si resero conto gli stessi cittadini veliterni, che lamentarono sempre più la scarsa considera-zione che andava assumendo la città in seno alla politica papale, nonostante il legame che almeno una parte della società veliterna poteva rivendicare nei confronti di Cesare Borgia, pupillo del papa.
Il rapporto tra il Valentino ed alcune famiglie veliterne si era rinsaldato al momento della discesa di Carlo VIII in Italia nel 1495. Questi, dopo essere entrato in Roma con il suo esercito, aveva proseguito verso Napoli, portando con sé il secondogenito di Rodrigo Borgia come garanzia della fedeltà del papa. A Castelgandolfo fece una prima sosta presso il cardinale Giovanni Battista Savelli, dove venne raggiunto dai cardinali Raimondo Peraudi e Giuliano della Rovere. Si fermò quindi a Velletri, dove incontrò gli inviati del re di Spagna, Juan de Albiòn e Antonio de Fonseca, che cercarono inutilmente di dissuaderlo dal proseguire la sua azione contro Napoli. A quanto afferma il Landi, durante la sosta a Velletri, Cesare Borgia riuscì a fuggire fuori città gra-zie all’aiuto di Pietro di Gorio Borgia, Ludovico Monticelli e Lercia260. A seguito dell’episodio il re francese ordinò di mettere a ferro e fuoco Velletri, fatto che fu scongiurato grazie all'intervento diretto del vescovo della città, Giuliano della Rovere, sostenitore dello stesso re di Francia.
Il venir meno dell’importanza di Velletri è chiaramente descritto in un epigramma di Mancinelli allo stesso duca
260 Secondo Bonadonna Russo questi nomi potrebbero non essere
esatti, dal momento che “quello del Lercia va quasi certamente corretto in Giovanni Lerici” (LANDI, Compendio, cit., p. 114 e 114n).
VELLETRI NEL MEDIOEVO
118
Valentino, nel quale egli sembra rifiutare il fatto di dover prendere coscienza di un’età dell’oro ormai perduta per sempre261. Agli albori dell’età moderna, evidentemente, con l’affermarsi degli Stati nazionali, i piccoli centri municipali andavano perdendo ogni importanza strategica. La fedeltà di Velletri al papato dei Borgia – che in quel momento sta-vano sviluppando una incisiva azione di controllo militare del territorio – era già stata ribadita con la partecipazione di contingenti di Velletri nell’esercito papale che mosse contro i Caetani e prese possesso del castello di Sermoneta nel 1499262. Successivamente, il 31 luglio 1501, Alessandro VI soggiornò a Velletri e da qui si recò a Sermoneta per ammi-rare la nuova fortezza263.
261 “Nessuna più di questa città è fedele al Papa / nessuna è più
angosciata e trascurata” (ed. Mario Lozzi in, LAZZARI, LOZZI, Gli Epi-grammi, cit., Ep. 20, vv. 11-12).
262 G. PESIRI, Sermoneta: 1499-1503, in Roma di fronte all’Europa al tempo di Alessandro VI. «Atti del Convegno. Città del Vaticano-Roma, 1-4 dicembre 1999», a cura di M. CHIABÒ - S. MADDALO - M. MIGLIO - A. M. OLIVA, Roma 2001, pp. 658-670.
263 BORGIA, Istoria, cit., pp. 394.
GOVERNO E ISTITUZIONI
Le istituzioni comunali La scarsità della documentazione anteriore alla metà
del XIV secolo non permette purtroppo di conoscere l’evo-luzione delle istituzioni comunali nel periodo in cui presu-mibilmente vennero stabilmente costituiti il Consiglio ge-nerale e quello speciale, nonché fissato a nove il numero dei boni homines. Sappiamo comunque che dopo il periodo signorile, risultato della concessione enfiteutica del 946, vi fu al governo un regime consolare che amministrò il potere a nome di tutto il popolo, fino alla nascita della forma di governo podestarile. La formazione del regime consolare non dovrebbe risalire in ogni modo anteriormente alla prima metà del secolo XII. Nel 1162 sono attestati quattro procuratores sylvae, che rappresentavano quanto meno la vo-lontà di tutta la comunità veliterna1. L’ultimo riferimento ai consoli in Velletri si ha in una lettera del 1237 di Grego-rio IX indirizzata dilectis Filiis consulibus et Populo Velletrensis. Non abbiamo documenti che rivelino in dettaglio le fun-zioni dell’ufficio consolare, ma questo non doveva disco-starsi da quello esercitato negli altri centri della provincia
1 FALCO, Il Comune di Velletri, 36 (1913), cit., pp. 374-375.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
120
dove venivano eletti a questa carica sia milites che massarii2. Nella forma di governo successiva, quella podestarile, a fianco del podestà, del giudice e dei Nove agivano i sindaci, i massari, il camerario (tesoriere) e tutta una serie di ufficiali minori. Al podestà, la cui prima attestazione dovrebbe risa-lire intorno al 12403 e che a partire dal 1312 venne eletto dal Senato romano, faceva capo il potere esecutivo e quello giudiziario, aveva mansioni di giudice ordinario per le ma-terie criminali, di appello per le cause civili; a lui era de-mandata la sicurezza pubblica e la difesa della città. Questi riceveva, per il periodo dei sei mesi in cui ricopriva l’incarico – il mandato del podestà inviato da Roma iniziò subito nel novembre del 1312 – la somma di trecento lib-bre di provesini e la metà delle multe riscosse per i danni dati, che dovevano servire a coprire le sue spese e quelle del-la sua “familia”, notaio, guardie e cavalli, ma non poteva agire contro gli interessi della città formalmente stabiliti ne-gli statuti comunali. Se riconosciuto di contravvenzione ai capitoli, sui quali era tenuto a fare atto di giuramento for-male all’inizio del suo mandato, veniva sanzionato con pene pecuniarie che venivano decurtate dal suo ultimo stipendio. Nei periodi di vacanza si procedeva ad eleggere a questo uf-ficio tre rettori e un notaio. Nell’ottobre del 1346 la nomi-na si rese necessaria in seguito all’improvvisa morte del po-destà Bonanni Boccabelli4. Il podestà era affiancato dal Consiglio Generale, formato da tutti i cittadini che godeva-no dei diritti politici e dal Consiglio Speciale, un consiglio più ristretto composto da venticinque membri. Al consiglio
2 Nel 1193 i consoli privernesi che raggiunsero un accordo con l’abbazia di Fossanova in merito ad alcuni beni erano rappresentati da quattro milites e tre massarii.
3 BORGIA, Istoria, cit., p. 276. 4 FALCO, Il Comune, cit., 37 (1914), appendice, p. 529.
GOVERNO E ISTITUZIONI
121
spettava l’approvazione di questioni generali e l'emenda-mento degli statuti. La carica più importante di pubblico ufficio comunale era quella dei boni homines ai quali era demandata anche la facoltà di convocare il Consiglio. Nell’atto di elezione di Bonifacio VIII a podestà del 1299 sono citati dieci boni homines, un numero che nella seconda metà del secolo successivo è ridotto generalmente a nove. Non sappiamo quando e perché questo numero sia stato cambiato, ma probabilmente i Nove non furono una diretta derivazione dei Dieci, se consideriamo che anche Terracina nel 1368, dopo il recupero della città al papato da parte dell’Albornoz, istituì una magistratura dei nove5. Inoltre Nove boni homines risultano affiancare il podestà nel castrum di Ninfa già alla fine del Duecento, con funzioni assimilabi-li a quelle dei Nove veliterni6. A questi era riservata l’intera macchina amministrativa comunale, compresa la riscossio-ne dei dazi e la cura degli usi civici, per i quali provvedeva-no ad eleggere i Consules sylvae. Era loro compito eleggere anche il medico per la cura dei poveri7, il maestro per l’istruzione dei fanciulli e, dalla seconda metà del Quattro-cento, gli ufficiali del Monte di pietà. In momenti di parti-colare crisi il loro numero fu ridotto dal Consiglio ad un gruppo di quattro. Questi ufficiali nel loro incarico ordina-rio duravano in carica sei mesi e venivano estratti a sorte le
5 CACIORGNA, Una città di frontiera, cit., p. 17. È d’altronde evi-
dente un intenso rapporto tra le due città in questo periodo quando, durante la dominazione genovese (1346-1367), i giudici di Terracina fu-rono di quasi esclusiva provenienza veliterna.
6 CORTONESI, Ninfa e i Caetani, cit., p. 65. 7 Il 7 luglio 1467 il Comune di Velletri nominò a questo incarico
Tradito da Cori con uno stipendio annuo di 25 ducati di 72 bolognini per ducato (ANV, Protocolli Notarili, Vol. 15 (olim 24), c. 46, notaio Franciscus Iacobi Galliani).
VELLETRI NEL MEDIOEVO
122
ultime domeniche di aprile e di ottobre tra i nomi posti ne-gli imbussolatori delle rispettive decarcie. Gli eletti non po-tevano rifiutare l’incarico che in pieno Quattrocento sem-brerebbe essere prestato a titolo gratuito; al massimo essi venivano compensati con un quantitativo di cera8. Di nor-ma gli ufficiali comunali erano regolarmente remunerati con un compenso mensile di almeno dieci soldi9. Solita-mente i Nove svolgevano le loro funzioni di domenica, giorno deputato alle funzioni pubbliche; in questo giorno veniva anche adunato il Consiglio che veniva convocato mo-re solito al suono delle campane indifferentemente nel chio-stro di S. Clemente, presso la chiesa di S. Francesco e pres-so il palazzo comunale. I Nove dovevano deliberare all’una-nimità e quando questo non avveniva avevano facoltà di convocare il consiglio e rimettere ad esso ogni decisione. Terminato il loro mandato, i Nove e i loro familiari non potevano essere rieletti alla carica per lo spazio di alcuni anni10, mentre il loro operato, così come quello di tutti gli altri ufficiali compresi il podestà e il giudice, veniva sotto-posto a sindacato. Non è chiara invece la funzione dei “Sei buoni uomini”, eletti pro maiori firmitate regiminis, che risul-tano in carica contemporaneamente ai Nove, presenti al consiglio speciale convocato il 30 agosto del 1346 per discu-tere della liceità della tassa del sale e del sequimentum impo-
8 “excepto che volemo siano recognosciuti de cera nelli tempi de-
biti et ciasche uno de issi como quilli che sonno et per lo tempo ser-rando in l’officio li signori nove et l’officio ad fare honore nello dicto tempo iuxta la consuetudine della communità predicta” (F. LAZZARI, Il Monte di pietà, Velletri 2005, p. 35).
9 FALCO, Il Comune, cit., 37 (1914), appendice, p. 538. 10 Cinque anni negli statuti del XIV secolo: Offitialis forensis Civita-
tis Velletri qui fuerit in officio dicte civitatis medio anno non possit resumere il-lud iddem offitium ad quinque annos, poi ridotti a due nel 1421.
GOVERNO E ISTITUZIONI
123
sto da Roma, che i velletrani non reputavano conforme ai patti del 1312. Consiglio al quale furono presenti anche i comestabili dei balestrieri e dei massari11. I sindaci, eletti dal comune, avevano compiti di sorveglianza interna e an-che di difesa degli interessi comunali presso le curie, roma-na e del rettore della provincia. Abbiamo visto, che era sta-to un sindaco a firmare il trattato sia con il popolo romano che quello con Onorato Caetani. Nel 1346 risultano con-temporaneamente in carica un syndicus forensis e un syndicus civis. A loro spettava il compito, durante le sedute del con-siglio, di giustificare la contabilità comunale12. Essi avevano anche facoltà di elevare contravvenzioni e di eseguire le sen-tenze giudiziarie. Ai consigli partecipavano regolarmente i comestabili dei balestrieri e i rappresentanti dei Massari. Questi ultimi, che nell’alto Medioevo avevano rappresenta-to i lavoratori di fondi agricoli con libertà personali abba-stanza limitate, in età comunale acquistarono una notevole rilevanza. La giurisdizione del Massaro era normalmente confinata entro i limiti della “ordinaria amministrazione” e di controllo. Essi erano scelti tra i cittadini più ricchi senza differenza di classe. Nel consiglio generale convocato nel 1374 per mettere pace tra le diverse fazioni cittadine ritro-viamo infatti, tra gli altri, il magister Angelo caldarario, il dominus Pietro Tozzi e il notaio Cola Guerci. Tra i massari venivano scelti anche gli incaricati alla revisione degli statu-ti, tra i quali dovevano figurare almeno un giudice e un no-taio. Essi proponevano i nuovi capitoli statutari nel pubbli-co arengo secondo la formula «Placent vobis, domini de popu-lo, dicta capitula per me vobis lecta?», alla quale il popolo, con-fermando, rispondeva all’unisono «Placent, placent». Le deci-
11 FALCO, Il Comune, cit., 37 (1914), appendice, pp. 495-496. 12 FALCO, Il Comune, cit., 36 (1913), p. 400.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
124
sioni ordinarie erano invece prese con il sistema delle “bus-sole”, una rossa e una nera.
Le cariche di questi uffici non erano cumulabili e colo-ro che erano stati eletti non potevano accedere ad altri uffi-ci per il tempo di due, tre o cinque anni. Venne quindi sta-bilito o confermato, che nessuno poteva eleggere ufficiali che non appartenessero alla propria decarcia. Nel 1374, pe-riodo sicuramente tra i più turbolenti nella storia medievale velletrana, vennero eletti nel tentativo di riportare la pace i massari Puccio Petrella di S. Salvatore, Bello di Giovanni di Castello, Cola Ciccaroni di Portella e Lello Tudini di Colli-cello. All’interno del Comune operava anche tutta una se-rie di notai: uno del podestà, un notaio dei Nove, uno dei sindaci, due destinati alla registrazione delle cause crimina-li13 e uno per il Monte di pietà denominato cancelliere. Sul finire del Quattrocento ci fu una naturale evoluzione delle cariche cittadine di cui ci ha lasciato una diretta seppur sbiadita testimonianza l’umanista veliterno14. Nei periodi di consolidato potere papale, il podestà venne designato diret-tamente dal papa e non più dal Senato romano. All’inizio del Cinquecento fu appellato da Mancinelli con il nome di Pretore così come i Nove furono chiamati governatori o ret-tori della città. Il pretore o podestà continuò a gestire l’amministrazione della giustizia, mentre al giudice seguitò ad essere affidata la competenza delle cause civili. Il giorno dell’entrata in carica del nuovo pretore questi riceveva lo scettro simbolo del potere. Il governo podestarile durò al-
13 Nel 1494 risulta eletto all’ufficio per le cause criminali (malefi-
ciorum) un notaio di Cori, tale Giovanni Palino (MANCINELLI, Sermo-num, cit., IV, 2, p. 33).
14 MANCINELLI, Sermonum, cit., III.
GOVERNO E ISTITUZIONI
125
meno fino al 1504, come termine post quem15, ma non oltre il 1512, anno in cui Giulio II diresse un Breve Dilectis Filijs Prioribus et Camerario Civitatis nostrae Vellitrarum16.
L’origine dello stemma comunale
I Comuni italiani cominciarono ad adottare i sigilli
nella seconda metà del secolo XII come espressione della propria autonomia. Le mu-ra fortificate e turrite sim-boleggiavano l’indipenden-za e la potenza delle città ed esprimevano, insieme al-le iscrizioni, orgoglio e sfi-da17. «La veduta dell’Urbe, scolpita in alcuni sigilli im-periali, costituì l’esempio cui si ispirarono molte città nel disegno dei propri sigil-
li. E tali vedute sono disegnate ora con intenzioni realisti-che, ora ridotte a schemi o ad un solo monumento od ele-mento: la cattedrale, una porta, una torre, un muro merla-to»18. La menzione del più antico stemma veliterno è ripor-tatata da Alessandro Borgia, che parla di un “antichissimo sigillo di metallo trovato frà alcune ruine di Velletri, e con-
15 In quell’anno risulta aver ricoperto la carica Giacomo Jacovacci
(F.M. RENAZZI, Storia dell'università degli studj di Roma, detta la Sapienza, I, Roma 1803, p. 209).
16 BORGIA, Istoria, cit., p. 395. 17 G.C. BASCAPÉ, Sigillografia. Il sigillo nella diplomatica, nel diritto,
nella storia, nell’arte, I, Milano 1969, p. 184. 18 Ivi, II, pp. 205-206.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
126
servato già nel museo di Giovanni Paolo Ginnetti”19. È que-sta la più antica rappresentazione, già pubblicata da Cardina-li20, dell’iconografia che raffigurerà poi lo stemma comunale: un castello con tre torri, non ancora definito come rocca, circondato da alberi da frutto. Sul margine di questo stem-ma si legge: Signum Communis Veletri, Sit vobis papalis libertas imperialis, motto che verrà poi trasformato in quel Est mihi libertas papalis et imperialis che comparirà nelle rappresenta-zioni dello stemma veliterno a partire dal 164321. È proprio la rappresentazione iconografica del castello, al tempo del ritrovamento oramai non più esistente da secoli, a deporre per una datazione antica del sigillo che, per il tipo di carat-teri usati, dovrebbe risalire al XIII-XIV secolo, anche se non ho potuto riscontrare in alcun documento la grafia Veletri, in un periodo in cui si fa sempre riferimento a communis Velletri. Del resto la lettura potrebbe anche essere attribuibi-le ad un errore da parte dell’incisore. La rocca turrita appa-rirà al contrario, in maniera sistematica, in tutti i sigilli e stemmi posteriori, a cominciare da quello inserito nei “Ca-pitula della dogana di Velletri”, stampati nel 1544 insieme con gli statuti comunali.
19 BORGIA, Istoria, cit., p. 71. Il Ginnetti, fratello del più famoso
cardinale Marzio, visse nel corso del XVII secolo. 20 Luigi Cardinali pubblicò l’immagine, che dice di aver tratto dal-
le schede della propaganda e dall’archetipo già nel Museo Ginnetti, prima a Napoli (L. CARDINALI, Di un antico sigillo comunale, “Estratto dal Giornale Enciclopedico di Napoli”, Anno XII, Num. XII, Dicembre 1818) e poi a Roma (L. CARDINALI, Di un antico sigillo capitolare, Osser-vazioni, in «Dissertazioni della Pontificia Accademia romana di archeo-logia», II, Roma 1825).
21 La scritta appare per la prima volta su un bando comunale del 1643 (R. ZACCAGNINI, Est mihi libertas …? Il punto sullo stemma di Velletri, Velletri 1991, p. 4).
GOVERNO E ISTITUZIONI
127
Del sigillo in metallo Ascanio Landi e Antonio Manci-nelli non fanno alcuna menzione, segno che esso doveva es-sere stato rinvenuto nella seconda metà del XVI secolo, al-meno come termine post quem, ma anche che era abbastanza antico, tanto che già nel Quattrocento non era rimasta al-cuna memoria dei privilegi che esso rivendicava. Ne fossero stati a conoscenza i due illustri personaggi veliterni, non avrebbero certo passato sotto silenzio le antiche libertà in esso declamate, tenendo conto dell'enfasi che entrambi diedero al ritrovamento della lapide, andata in breve tempo distrutta, sulla quale era riportata la scritta SPQ Veliternus22. Mancinelli ne parla nel suo commento ai Carmi di Orazio pubblicato a Venezia nel 1492, lamentandone la distruzio-ne ad opera di un “livore ductus quidam ex Aquapendente oriundus”, familiare del cardinale Rotomagense, del quale Mancinelli dice di tacere il nome per non consegnarlo alla storia come era successo a Erostrato, distruttore del tempio di Diana Efesina23. Il personaggio in questione dovrebbe es-sere comunque identificabile con Giacomo di Aquasparta, uno dei commissari del cardinale d’Estouteville che nel 1479 stabilirono, con sentenza arbritrale, i confini tra il ter-ritorio di Velletri “quod fuit Faiole” e il castello di Nemi24. Sembrerebbe comunque apparentemente inspiegabile una
22 La scritta SPQV in ogni modo apparirà nello stemma di Velletri
non prima del secolo XVIII. 23 Ho consultato l’edizione stampata nel 1495, sempre a Venezia,
da Benedetto Fontana dove il riferimento è alle pp. 118-119: “in marmo-re quodam arae cuiusdam basis in sacra aede sancti Stephani iam diruta le-gebatur S. P. Q. Veliternus, quod marmor livore ductus quidam ex Aquapen-dente oriundus cardinalis Rhotomagensis Veliternorum protectoris familiaris clam rupi fecit, ruptumque ego paulo post conspexi; illius impii nomen tacui ne sacrilegio perpetuum celebre foret”.
24 DE SANTIS, Inventario, cit., p. 93, Perg. 149.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
128
distruzione basata sull’invidia, da parte di un funzionario pubblico alle dirette dipendenze del cardinale25, di un re-perto archeologico così importante, a meno che l’opera non fosse stata frutto probabile di una volgare imitazione con-temporanea26. Iacobus de Acquasparta era un personaggio molto noto, forse residente nella stessa città di Velletri, già attivo nella regione almeno dal 1472, essendo stato collet-tore della vigesima dovuta dagli Ebrei, come testimoniato dalla descriptio da lui redatta dei fuochi ebraici della regio-ne27. C’è poi una coincidenza temporale quanto meno sin-golare del ritrovamento della lapide veliterna, avvenuta se-condo Mancinelli nella già diruta chiesa di Santo Stefano, con quella su cui era incisa la scritta SPQ Lanivinus28. Di quest'ultima Mancinelli era perfettamente a conoscenza, poiché era stata riportata da Martino Filetico nel suo com-
25 Guglielmo d’Estouteville, famosissimo al suo tempo per la sua
ricchezza e munificenza, fu cardinale di Velletri dal 1461 al 1483, pe-riodo in cui fece costruire il palazzo vescovile e restaurare le mura della città.
26 Clemente Cardinali dedicò una distinta sezione alle false iscri-zioni, evidentemente un esercizio non infrequente, rinvenute in Velletri (C. CARDINALI, Iscrizioni antiche veliterne, Roma 1823, pp. 218-223).
27 La descriptio è stata pubblicata da: A. ESPOSITO, Una ‘descriptio’ relativa alla presenza ebraica nel Lazio meridionale nel tardo Quattrocento, in «Latium», 2 (1985), pp. 151-158.
28 La lapide, databile tra gli anni 184-187, è ancora oggi visibile in Piazza Mattei a Lanuvio. Alberto Galieti aveva già avanzato dubbi per un altro possibile plagio avvenuto nello stesso periodo (1464) a proposi-to di un dipinto conservato nella chiesa di Lanuvio. “Le dimensioni e il motivo di decorazione ci richiama alla memoria l’altro consimile, ma in-tero, il quale trovasi nella chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo in Velletri e che offre la leggenda: m-iorio-f-fieri. Confrontato però con quel-lo di Civita Lavinia rivela una mano meno esperta nell’incidere: pure la loro contemporaneità si può sospettare” (A. GALIETI, La tomba di Pro-speretto Colonna in Civita Lavinia, in «ASRSP», XXXI (1908), p. 213).
GOVERNO E ISTITUZIONI
129
mento ad Orazio pubblicato solo pochi anni prima29. A quanto scrive il Cluverio l’iscrizione era stata pubblicata da Flavio Biondo (morto nel 1463) parlando a proposito dell'imperatore Marco Aurelio30. Proprio questa testimo-nianza epigrafica servì a Mancinelli per rilevare l’errore tra le due città di Lavinio e Lanuvio vulgato nelle stampe pre-cedenti al suo commento sulla Geographia di Strabone. Non è chiaro invece se Landi abbia effettivamente visto questo marmo che dice “trovato questi anni passati, mentre si fat-bricava [così] la Chiesa di S. Rocco”31, oppure se abbia fatto riferimento al suo illustre concittadino umanista, del quale in ogni modo tace il nome in ogni occasione, come quando riferisce della battaglia “delle ghiande” del 138132.
Menzione di un non meglio identificato sigillo comu-nale si ha in ogni modo già nel 1363 quando, con riferi-mento agli interessi da pagare per il mutuo ricevuto dagli ebrei, i boni homines “solvere teneantur anno quolibet florenos ... debeant fieri appodisse sigillate sigillo dicti communis Velletri”. Il sigillo in metallo, per i caratteri ivi incisi e per la sua icono-grafia, dovrebbe essere precedente a questa data e risalire ad
29 Tenendo conto che nella dedica ad Alessandro Sforza del com-
mento a Persio (1468-69) il Filetico annunciava la prossima composi-zione del commento a Giovenale e a Orazio e tenendo conto che il commento a Giovenale risale al 1469-70, si può indicare questa data co-me termine post quem per il commento ad Orazio (C. BIANCA, Martino Fi-letico, in «Dizionario Biografico degli Italiani», 47 (1997), pp. 636-640.
30 P. CLUVER, Italia Antiqua, 1619 citato in C. MENCACCI. Cenni storici della badia di S. Maria di Grottaferrata, Roma 1875, p. 45.
31 LANDI, Compendio, cit., p. 6 e n. 8. 32 Ivi, p. 60. “ Par mi conveniente avvertire in questo luogo la falza
oppinione di quelli, che han detto quella tempesta essere stata di gian-de di piombo, le quali si trovavano in varij e diversi luoghi, erano istrumenti bellici, de quali gli Antiqui si serviavano a tirare colle fionde, e colle balestre”.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
130
un periodo in cui il castello doveva ancora simboleggiare l’edificio più imponente della città. Il motto a margine del-lo stemma dovrebbe essere stato coniato in un secondo momento, forse nel corso del XIII secolo come termine post quem, sicuramente dopo che la città aveva ottenuto dal pa-pato l’affrancamento definitivo dal monastero di San Paolo, a cui era stata temporaneamente affidata da Gregorio VII, forse nel momento in cui papa Gregorio IX, in riconosci-mento alla secolare fedeltà della città, concesse a Velletri il diritto a consuetae libertatis insignijs decorare33. In ogni modo, procedendo su un terreno privo di attestazioni certe, ogni ipotesi sulla datazione del motto potrebbe rimanere valida e potrebbe coincidere con il periodo della vacanza avignone-se, poiché l’impiego di sigilli in metallo da parte dei Comu-ni fu un evento raro, essendo riservato tradizionalmente al-la Chiesa, e anche perché, ancora nel 1312, nell'accordo stipulato tra il comune di Velletri e quello di Roma, il sigil-lo utilizzato raffigurava i santi protettori di Velletri34.
La chiesa di S. Clemente: ruolo politico e religioso
L’indagine sulla chiesa cattedrale di S. Clemente si li-
mita in questo ambito ad una comprensione del ruolo poli-tico-religioso svolto dalla chiesa veliterna a partire dall’anno Mille e ad una verifica più puntuale della motivazione che portò la curia romana ad unire le diocesi di Ostia e di Vel-letri; una considerazione che sembrerebbe basata sulla effet-
33 BORGIA, Istoria, cit., p. 270. Diploma del 3 gennaio 1235 indi-
rizzato Dilectis filiis Civibus Velletrensis Apostolicae Sedis Fidelibus. “Hic est quod Nos libertates et immunitates vobis concessas, et consuetudines confirma-tas a bonae recordationis Paschali et Urbano predecessoribus nostris”.
34 CARDINALI, Di un antico sigillo capitolare, cit., p. 338. Il docu-mento è in ogni modo una copia della metà del XIV secolo.
GOVERNO E ISTITUZIONI
131
tiva volontà di preservare la diocesi ostiense attraverso il suo accorpamento con quella veliterna, altrettanto antica e pre-stigiosa, in un momento di spopolamento della prima in contrasto alla forte espansione economica e demografica della seconda. Velletri fin dall’alto Medioevo era stata una delle sedi cardinalizie delle diocesi suburbicarie insieme a Ostia, Albano, Palestrina, Porto, Gabii poi unita a Labicum, e Tuscolo dal 1073. Dopo l’accorpamento di Velletri con Ostia la diocesi di Sabina subentrò a quella veliterna35. In-torno all'anno Mille, in ogni modo, per quanto ridimen-sionata la diocesi di Ostia conservava ancora pienamente il suo status, essendone vescovo lo stesso Pier Damiani, il qua-le rifiutò di accettare quella di Velletri, resasi vacante dopo l’elezione del Mincio al soglio pontificio. Certo è che, per quanto spopolata, Ostia conservò effettivamente i suoi tito-li: la chiesa di S. Aurea lo status di ecclesia cathedralis36 e l’Arciprete della chiesa ostiense il privilegio, in assenza del vescovo, di partecipare alla consacrazione del Pontefice37. Dopo la loro aggregazione38, le due diocesi mantennero
35 G. GRECO, Lezioni di Storia della Chiesa, 1, “Appunti e materiali
di lavoro”, Università degli Studi di Siena, a.a. 2009-10, p. 21. 36 S. PANNUZI, Recenti indagini archeologiche presso la chiesa di S. Au-
rea nel borgo di Ostia antica, in «Atti del IV Congresso Nazionale di Ar-cheologia Medievale», 26-30 settembre 2006, p. 371; cfr. A. NIBBY, Ana-lisi Storico-topografica-antiquaria della carta de’ dintorni di Roma, II, Roma 1848, p. 441.
37 BORGIA, De cruce veliterna, cit. p.VI. 38 La più antica documentazione che menziona l’unione delle due
diocesi risale al 1154, anno in cui il cardinale Ugo, vescovo di Ostia e Velletri, donò al monastero di Mormosolio alcuni beni (E. PETRUCCI, Pievi e Parrocchie nel Lazio nel basso Medioevo, in Pievi e parrocchie in Italia nel basso Medioevo, sec. XIII-XV, Roma 1984, p. 898 n. 11). Il Borgia ri-porta la data del 1150, anno dell’istituzione del Decano del Sacro Col-legio ad opera di Eugenio III (BORGIA, Istoria, cit., p. 224).
VELLETRI NEL MEDIOEVO
132
probabilmente due cattedrali e due sedi vescovili aeque prin-cipaliter sotto un unico vescovo, però di fatto la diocesi veli-terna ne uscì ridimensionata rimanendo esclusa dal novero delle diocesi che componevano il Sacro Collegio. Nelle sue funzioni di decano, infatti, il vescovo di Ostia e Velletri sembrerebbe utilizzare solamente il titolo ostiense. Quando nel 1294, dopo ventisette mesi di sede vacante, il Sacro Col-legio al completo elesse a Perugia il futuro papa Celestino V, si palesò evidente l’assenza del titolo veliterno39. Il cardi-nale decano, Latino Malabranca, ratificò infatti la decisione di eleggere Pietro da Morrone solamente con il suo titolo di Ostiensis episcopus40. La firma potrebbe essere considerata non determinante, potendosi intendere che il cardinale Latino abbia rappresentato a tutti gli effetti la diocesi di Velletri, pe-rò nell’occasione il cardinale Matteo d’Acquasparta sotto-scrisse con entrambi i titoli di Porto e Santa Rufina, diocesi che erano state anch’esse riunite nel corso del XII secolo. La sottoscrizione era accompagnata dal sigillo, che al con-trario era munito sia del titolo ostiense che di quello veli-terno: S’. FRIS: LATINI: OSTIEN: et VELLETREN: EPI41. Il sigillo del vescovo in ceralacca rossa, importante anche per la storia del capitolo veliterno perché di sicura datazio-ne, si presenta in forma di edicola gotica con quattro nic-chie su due piani. Nella parte superiore sono effigiati una martire e un vescovo, forse S. Aurea e S. Clemente; in quel-
39 Il documento fu sottoscritto dai cardinali vescovi di Ostia, Sabi-
na, Tuscolo, Porto e Santa Rufina, Santa Sabina, S. Marco, Santa Maria in Portico, Sant’Adriano, Santa Maria in via Lata, Sant’Eustachio e SS. Sivestro e Martino ai Monti.
40 Ego frater Latinus Ostiensis episcopus, in eumdem fratrem Petrum licet absentem expresse consensi eumque nominavi et elegi ac recepi in Romane et universalis Ecclaesie episcopum et pastorem.
41 Archivio Segreto Vaticano, AA. Arm. I-XVIII, 2177, 2178.
GOVERNO E ISTITUZIONI
133
la inferiore probabilmente lo stesso Latino in posizione ge-nuflessa e quindi in atto di predicazione42.
Ostia comunque non rimase mai del tutto spopolata, se è vero che, ancora nel secolo successivo all’unione con Velletri, papa Alessandro IV (1254-1261) “andava ad Ostia e Velletri e lì predicava la parola di Dio”43. Il cardinale Bor-gia faceva risalire lo spopolamento della città ostiense all’anno 1335, quando il territorio contava appena trecento abitanti – un numero in ogni modo non trascurabile per il periodo in questione –, tra cui cinque o sei sacerdoti e tra questi l’arciprete della chiesa di Sant’Aurea in un ridimen-sionato ruolo di Cappellanus curatus S. Aureae civitatis Ostien-sis, vel cathedralis S. Aureae Ostiensis44. Secondo il Borgia, il vescovo “veliterno” avrebbe avocato a sé, in questo periodo, i titoli della Chiesa ostiense esercitando di fatto, da quel momento, il pieno potere sopra le sue reliquie consistenti nella consacrazione del Pontefice e nell’esercizio del ruolo di ministro dello stesso.
In realtà, la basilica di S. Aurea – edificata in età co-stantiniana45 e detentrice del titolo di cattedrale già nell’alto Medioevo al tempo di papa Sergio I46 – sembrerebbe con-servare il titolo almeno fino al pieno XVI secolo, quando la chiesa di S. Clemente appare associata formalmente alla se-
42 A. MERCATI, Il decreto e la lettera dei cardinali per l’elezione di Cele-stino V, in «Bollettino dell’Istituto Storico Italiano e Archivio Murato-riano», 48 (1932), pp. 1-16.
43 BORGIA, De cruce veliterna, cit. p. XXVI. 44 Ivi, p. XII. Ostia è in ogni modo indicata ancora come civitas e
la chiesa di S. Aurea come cathedralis. 45 P. PENSABENE, Ostiensium marmorum decus et decor, Studi architet-
tonici, Roma 2007, p. 458. 46 S. PANNUZI, Il borgo di “Gregoriopoli” dall’Altomedioevo all’età rina-
scimentale: analisi della cinta muraria, in EADEM, Il castello di Giulio II ad Ostia antica, 2008, p. 12.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
134
de vescovile. Questa ricostruzione sulle vicende di Ostia e sulla chiesa di S. Aurea sembrerebbe suffragata anche dalle fonti storiche:
Agli inizi del XIII secolo nel borgo di Ostia fu fatta edificare una nuova cinta muraria, munita di torri, da parte del vesco-vo Ugolino dei Conti di Segni, poi papa Gregorio IX (1227-1241). Ancora durante il XIII e la prima metà del XIV l’abitato subì occupazioni militari e saccheggi, ma dopo que-ste distruzioni le fortificazioni di Ostia furono comunque re-staurate, tanto che, quando papa Gregorio XI nel 1377 sbar-cò sul litorale ostiense, al definitivo ritorno da Avignone, si trovò ad ammirare un presidio ben munito, in contrasto con l’abbandono del territorio circostante47. Le mura dell’insediamento furono in seguito più volte
ristrutturate finché Martino V (1417-1431) fece edificare il torrione, restituendo ad Ostia il controllo militare alla foce del Tevere. I lavori proseguirono nella seconda metà del XV secolo, ad opera prima del cardinale D’Estouteville e poi di Giulio della Rovere (Giulio II) sotto il cui pontificato furo-no terminati i lavori della cattedrale di S. Aurea e quelli del Castello.
Il passaggio effettivo dei titoli dalla cattedrale di S. Au-rea a quella di S. Clemente dovrebbe essere avvenuto pre-sumibilmente nel corso del XVI secolo, poiché la chiesa Ostiense continuò in seguito a rivendicarne l’antica legitti-mità. Nel 1723, infatti, la Congregazione dei vescovi con-fermò che le due diocesi dovevano essere considerate come una e che esse dovevano mantenere solamente un vicario capitolare e che questo apparteneva al capitolo di S. Cle-
47 IVI, pp. 15-16.
GOVERNO E ISTITUZIONI
135
mente48. È ipotizzabile dunque che la Chiesa veliterna abbia avocato a sé i diritti di quella ostiense intorno al 1572, an-no in cui papa Gregorio XIII nominò Lorenzo Bernardino quale primo suffraganeo del cardinale Giovanni Girolamo Morone, residente presso la cattedrale di Velletri e investito delle funzioni episcopali49. Il Morone era stato uno dei pro-tagonisti del Concilio di Trento, dove era stato appunto stabilito che i vescovi dovevano effettivamente risiedere presso le loro diocesi50.
48 BORGIA, De cruce veliterna, cit. p. XIV. 49 BORGIA, Istoria, cit. p. 442. 50 Sessione VI, 13.6.1547: De residentia episcoporum et aliorum infe-
riorum.
ECONOMIA E TERRITORIO Coltivazione e agricoltura
Ancora all’inizio del secolo scorso l’agricoltura rappre-sentava l’attività economica predominante nel territorio e la grande massa degli abitanti erano lavoratori agricoli. La so-cietà medievale poggiava evidentemente su queste stesse ba-si rurali e, fra tutti i lavoratori, era in primo luogo il conta-dino a rendere possibili con la sua umile attività le più alte realizzazioni intellettuali e culturali. Nel corso dell’altome-dioevo il territorio di Velletri, come gran parte della cam-pagna romana, era caratterizzato da casali, terreni coltivati (fundi) e, in minor quantità, pascoli. I casali erano general-mente caratterizzati da un nucleo edilizio situato al centro del proprio terreno di pertinenza, destinato ad ospitare sia i nuclei familiari legati stabilmente al casale sia le attività connesse con la vita del casale stesso e la coltivazione delle sue terre. Tra i numerosi fondi altomedievali – probabil-mente in parte abitati – abbiamo riscontro toponomastico di almeno tre casali: Casale dei pescatori, Casale cesarea e Ca-sale quercia rigogliosa. Nella concessione enfiteutica a favore di Demetrio di Melioso il canone non monetario rilevava una quantità non certo irrisoria, considerando anche l’estensione del territorio, consistente in un quarto della produzione di vino, dei cereali e dei frutti; il patto prevede-
VELLETRI NEL MEDIOEVO
138
va che il castello fosse diviso a metà tra il vescovo e il duca e che per la loro parte i concessionari avrebbero pagato un canone annuale di trenta modia di grano e un bue ottimo. Con tutta evidenza i beni prodotti nel territorio di Velletri confluivano in gran parte nel mercato romano.
Sin dai tempi antichi dunque il territorio di Velletri era diffusamente coltivato, principalmente a vigneto (in special modo la qualità di grecheto), cereali e anche canapa1, ma è a partire dal X secolo che il territorio veliterno, sino ad allora lavorato autonomamente nei diversi fondi, diven-ne centro di coltivazione intensiva. Il più volte ricordato contratto di enfiteusi prevedeva, ove fosse stato possibile, la messa a coltura di vigneti e alberi da frutto su tutto il terre-no che il Duca si era impegnato a bonificare, consolidan-done fondi e casali. Da una delle più antiche pergamene del Capitolo di S. Clemente, datata 15 giugno 1037, si ha noti-zia di una vigna in località Episcopio che venne concessa ad un prete di nome Domenico da parte del monastero di S. Benedetto di Velletri2; di terreno seminativo si parla invece in altri due documenti del 1038 e 1042, dove peraltro non viene specificata la qualità del prodotto, ma possiamo sup-porre che venissero coltivati diversi tipi di cereali, princi-palmente frumento (il duca doveva al vescovo trenta moggi di grano ogni anno), ma probabilmente anche orzo e farro, fatto indiziato dai numerosi atti del periodo relativi ai mu-lini, il primo dei quali riporta la data del 1062 ed è inerente alla donazione, da parte di un certo Santi, di parte della
1 Ancora nel XVI secolo esisteva in Velletri una fiorente industria
del lino, come documentato negli statuti comunali. Theuli riporta inol-tre che nella sua epoca esistevano in città “cinquecento cinquanta telari di donne particolari” (THEULI, Teatro Historico, cit., p. 271).
2 T. TESTONE, I Regesti delle pergamene dell’Archivio Capitolare di Vel-letri, Velletri 1998, p. 4; Stevenson, Documenti, cit., p. 82.
ECONOMIA E TERRITORIO
139
mola della “Pentoma”3 a favore della chiesa di S. Clemente. I mulini del periodo avevano con ogni probabilità una struttura a ruota orizzontale che accomunava facilità di co-struzione e d’installazione, ma soprattutto la loro adattabili-tà a correnti poco consistenti come quelle che potevano es-sere sfruttate nel circondario veliterno. Questi mulini erano costituiti da un albero verticale collegato alla ruota orizzon-tale formata dall'insieme delle pale, piatte o a cucchiaio; il sistema, privo di meccanismi e di complicati ingranaggi, comportava una manutenzione minima, non dovendosi apportare notevoli mutazioni al terreno circostante. La do-cumentazione conservata presso il Capitolo di S. Clemente conferma la felice intuizione secondo cui queste strutture hanno visto una moltiplicazione del loro uso nel corso dell’XI secolo4. Il mulino lavorava ininterrottamente giorno e notte e chi doveva macinare era tenuto a pagare una quo-ta oraria che veniva divisa tra coloro che detenevano i diritti sul mulino. La circostanza è testimoniata in due atti del 1136 e 1137: un certo Giovanni, già camerario del papa, fe-ce prima una donazione a sua nipote Scotia della sua parte di mulino detto del Giudice, consistente in un giorno e rela-tiva notte di ogni mese, e poi, l’anno successivo, donò due quote del mulino del Pertuso, consistenti rispettivamente nella terza e nella quinta parte di un giorno ogni diciotto giorni al nipote Giovanni figlio di Maria Antedonia5. Non
3 Voce largamente in uso nel periodo altomedievale nel suo signi-
ficato di terreno in pendio. La prima menzione è attestata nel 952 ed è relativa alla donazione da parte di Benedetto consul et dux di un locum qui vocatur Pentoma, positum supascrito territorio campanino (Reg. Subl., n. 195, p. 236).
4 Cfr. M. BLOCH, Avvento e conquiste del Mulino, in Lavoro e tecnica nel Medioevo, Bari 1970.
5 BORGIA, De Cruce, cit., pp. 296-298.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
140
trascurabile la produzione ittica ricavata dai ruscelli della zona, al tempo molto più ricchi di acqua e conseguente-mente di pesce6. Paradigmatiche al riguardo le antiche de-nominazioni di Casale dei pescatori, zona da individuare con ogni probabilità nella zona a nord di Velletri, e Ponte della bolaga (ponte bolagai), l’attuale Ponte di Mèle. La bola-ga era infatti una grossa cesta di vimini intrecciati di forma sferica che veniva lasciata immersa nell’acqua per catturare i pesci, e essa era usata ancora pochi anni fa nelle valli di Comacchio per la pesca delle anguille. Il territorio di Velle-tri, a differenza di quelli confinanti, veniva concesso ai co-loni con diritto di riscatto, una consuetudine che porterà alla frammentazione della proprietà in piccole entità, un ri-sultato ancora visibile nell’odierna mappa catastale. La col-tivazione della vite, già menzionata nel contratto enfiteutico del X secolo, era particolarmente estesa intorno alla città, fatto che fece presto di Velletri il maggiore esportatore di vino verso Roma, una situazione che sarebbe durata per tut-ta l’età moderna. Nel XIV secolo i vigneti si estendevano ormai diffusamente intorno alle mura cittadine: fino alle falde dell'Artemisio a nord, Tevola, Cigliolo, Colle Petrone, con un raggio espansivo costante nelle altre direzioni, Colle Pipino, Papazzano, Acquavivola, Rioli. La specializzazione del vitigno indusse a privilegiare la qualità di grecheto, un nome che tenderà sempre più ad esaltare la qualità del pro-dotto nel mercato di esportazione romano7. È bene ricorda-
6 Nel documento del 946 si parla espressamente di rivis aque pe-
rhennis. 7 Mancinelli non esitò a paragonare il vino velletrano ai vini crete-
si dell’antichità (A. MANCINELLI, Vitae sylva, ed. Tiziana Testone in F. LAZZARI (a cura di), Antonio Mancinelli (1452-1505) pedagogo, grammatico e umanista, Contributi di C. MELLIDI e T. TESTONE. Prefazione di V. ROMANI, Velletri 2005, p. 35, v. 25).
ECONOMIA E TERRITORIO
141
re che ancora nel periodo medievale il vino, secondo l’uso romano, poteva essere servito con l'aggiunta di acqua. Negli stessi terreni destinati a vigneto venivano poi piantati alberi da frutto, principalmente meli e in seguito ulivi; una por-zione di essi era riservata al canneto da cui poter ricavare il sostegno per le singole viti, una pratica diffusa sul territorio fino al secolo scorso. L’unità di misura non è documentata per il Duecento, ma già dal secolo successivo il capezzo (ca-pitium) è sempre usato per indicare la superfici piantate a vigna. Se la dimensione del terreno non era tale da arrivare al capezzo si ricorreva alla conta del numero dei filari, de-nominati rasae8. Le vigne venivano delimitate con una siepe o fratta (redina), un toponimo ancora frequente nel territo-rio e già testimoniato in documenti del XII secolo9. Il pe-riodo di vendemmia non poteva avere inizio avanti al primo di settembre di ogni anno; fino a tale data i torchi e le va-sche dovevano rimanere ben coperti e per tale operazione si poteva ricorrere al legname della selva comunale10. Il mosto veniva quindi trasportato nelle cantine del centro abitato utilizzando animali, somari o cavalli, tenuti in soccida.
All’interno della cinta muraria potevano trovare spazio gli orti, dove venivano coltivati gli ortaggi tipici del periodo medievale: aglio, cipolle, cavoli, lattuga, cetrioli, zucche. Per ciò che concerneva l’allevamento, i cittadini di Velletri con-tinuarono a godere l’antico privilegio di libero pascolo ai confini del territorio di Ninfa, in base agli accordi vigenti tra le città che usavano ratificare gli usi e le porzioni di ter-ritorio da mantenere in comune. Sappiamo che nel 1342 il Comune di Velletri avanzò una richiesta di rappresaglia al
8 Rase, rasali e rasaletti specificavano la distanza e le misure della disposizione delle viti.
9 STEVENSON, Documenti, cit., pp. 102-104. 10 GABRIELLI, Gli Statuti, cit., l. V, XXV.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
142
Comune di Roma contro Niccolò Caetani, il quale hostiliter et armata manu aveva razziato quantitatem non modicam vacca-rum, bubalarum, porcorum et pecudum et aliorum animalium11. La fruizione del pascolo è confermata ancora trent’anni più tardi dalla vicenda relativa al furto di circa 600 capi di be-stiame appartenenti a cittadini velletrani di cui si era illegit-timamente appropriato Giovanni Caetani. I proprietari de-gli animali lasciati al pascolo erano tenuti a contribuire se-condo la loro parte nel caso di composizione delle cause contro il popolo romano o il rettore della Provincia12. Ve-niva allevato ogni tipo di animale: muli, asini, buoi, vacche e vitelli, maiali, caprini (montoni, pecore e capre)13 e galline queste ultime ovviamente all’interno delle mura. Partico-larmente potente fu la corporazione dei Boattieri, di cui fa-cevano parte coloro che possedevano buoi nel territorio di Velletri. I suoi componenti si adunavano presso la chiesa di S. Francesco, come antica consuetudine, la prima domenica di agosto ed eleggevano due boni homines alla carica di Con-soli. Gli agricoltori veliterni erano soliti seminare e macina-re anche nei territori circostanti. Nel trattato di pace del 1380 con Onorato I Caetani sono elencati i territori al di fuori dei confini della città dove i velletrani potevano con-tinuare a recarsi: S. Pietro in formis, Conca, Le Castella, Ci-
11 DE SANTIS, Inventario, cit. p. 42. 12 GABRIELLI, Gli Statuti, cit., l. V, LX. Il riferimento al popolo
romano e al Conte di Campagna negli statuti del 1544, in un momento in cui il Papa stava oramai esercitando sempre più il suo potere, testi-monia l’antichità di queste disposizioni.
13 “Andrea de Stesante canonico da Velletri e Ponziano di Cola di Terio da Velletri danno in soccida a Tenar Cola sessanta capre grosse maschi e femmine” (ANV, Protocolli Notarili, vol. 1 (olim 3), c. 71, no-taio Crispinus Guidonus).
ECONOMIA E TERRITORIO
143
sterna e Castrum vetus, Presciano14, Lazzaria, Mandra15, La-nuvio, S. Gennaro e, solo per la molitura, Nemi.
Velletri, oltre che centro di produzione agricola, fu na-turalmente un centro di scambi e commerci di ogni genere. La descrizione che ne fece l’umanista veliterno, forse un po’ enfatica, ci consegna comunque l’idea di quello che doveva essere la possibile condizione dei velletrani nel corso del pieno XV secolo: “Ovunque nel territorio vi sono fonti, campi coltivati e greggi / vigne, piante, pascoli, ville, boschi / da cui si ricava legna. Volatili di ogni tipo / cinghiali, ca-prioli, cervi e lepri / vini greci i quali nulla concedono a quelli della mitissima Gnosi / A stento bastano le biade come nella Gargara libica / Dal mar tirreno arrivano i pesci / una grande abbondanza per gli uomini / non mancano pesci di lago né di fiume”16.
La moneta
Nei numerosi atti del periodo medievale sono ricordati vari tipi di monete. Esse andarono a sostituire l’oro e l’ar-gento non coniati che venivano allora valutati in libbre17, mentre andava estendendosi l’uso comune di designare le
14 Il fundus Priscianus, faceva parte sin dall’VIII secolo della Massa Caesariana posta nel Patrimonium Appiae. Esso apparteneva alla Basilica Vaticana ed era situato tra i confini di Velletri, Lanuvio e Campomorto (NIBBY, Analisi Storico-topografica, II, cit., p. 662). Il toponimo è ancora oggi conservato nella via di Presciano in località Pedica nel territorio di Lanuvio.
15 Riconducibile al territorio tra Campoleone e Lanuvio dove è ancora esistente il casale della Mandria.
16 MANCINELLI, Vitae sylva, cit., vv. 22-29, ed. T. TESTONE in An-tonio Mancinelli (1452-1505), cit., p. 35.
17 Nel più volte ricordato documento del 946 era prevista una pe-nale di sei libbre di oro obrizo cioè puro.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
144
monete d’argento con il nome di denari18. Tra le monete circolanti troviamo il provesino, moneta coniata nella città di Provins dai Conti della Champagne, usata a Roma come valuta corrente già dal 1155, e il rotomagense, che prendeva il nome dall’antica città di Rouen dove essa veniva coniata. Nel corso del XIV secolo ebbero corso legale denari del Se-nato, provesini e soldi camerari19. Naturalmente la presenza di una particolare moneta fu legata alle vicende storiche e politiche del periodo contingente. La circolazione di una determinata valuta fu cioè collegata al flusso derivatole dalla influenza politica o commerciale della città di provenienza. Alle fine del Quattrocento, ad esempio, vari comuni laziali effettuavano i loro pagamenti in carlini in conseguenza del flusso di denaro arrivato a seguito della discesa in Italia del re francese Carlo VIII. Il carlino era una moneta che, a par-tire da Carlo d’Angiò nel 1278, fu coniata da vari re e prin-cipi di nome Carlo e rimase in uso fino al 1869. A partire dal XV secolo il ducato e il fiorino sostituirono progressi-vamente le altre valute. Il ducato risulta essere effettivamen-te la moneta ufficiale circolante a Velletri, mentre il fiorino fu utilizzato in atti che riguardarono i pagamenti del Co-mune ad altre città20. Il ducato era coniato dalla Camera Apostolica. Il valore di queste due monete, coniate dalle va-rie zecche italiane del periodo, fu esattamente equivalente, avendone i vari Stati codificato sia il peso sia la lega, mentre la situazione della monetazione argentea, denominata “bo-lognino”, risultava completamente differente. Le varie città italiane che battevano moneta avevano preso a coniare i bo-
18 BORGIA, De Cruce, cit., p. 274. 19 Il 23 agosto del 1346 il Comune di Velletri comprò una casa da
Nuzio Giovanni Nicolai per il prezzo 800 librarum denarorium Senatus (FALCO, Il Comune, cit., 37 (1914), appendice, pp. 492-495).
20 Cfr. DE SANTIS, Inventario, cit., pp. 61-91.
ECONOMIA E TERRITORIO
145
lognini con un proprio valore e la loro diffusione, pur con-sentendo di disporre di nuovo denaro circolante, determi-nò una costante incertezza nei cambi21. Nella seconda metà del Quattrocento la moneta aurea circolante a Velletri ave-va una valutazione di 72 bolognini per ducato, mentre a Pe-rugia servivano solamente 40 bolognini per ottenere un fio-rino, pur conservando, ducato e fiorino, lo stesso valore in-trinseco22.
Fuori e dentro le mura: le porte d’accesso alla città
Nel corso dell’altomedioevo Velletri si animò nella zo-na a sud dell’odierna città intorno al vescovado, centro del potere ecclesiastico, e nei fondi del circondario. Il periodo successivo al contrario, in seguito all’incastellamento, avreb-be visto la costruzione di mura di difesa e il conseguente progressivo sviluppo della città verso settentrione. La ragio-ne di questo processo è da ricercarsi, oltre che nell’ovvia necessità di difesa e sviluppo urbano intorno al castello, an-che nel cambiamento degli itinerari utilizzati per gli spo-stamenti lungo le principali vie di comunicazione tra Roma e Napoli. Fino al secolo VIII la via Appia era rimasta la principale arteria di comunicazione da Roma per coloro che si spostavano verso sud, ed era stato quindi naturale per la città di Velletri svilupparsi verso questa direttrice rag-giungibile attraverso l’antica via Mactorina, già restaurata
21 A. FINETTI, La zecca e le monete di Perugia, Perugia 1997, pp. 83-94. 22 Tra i molti atti dell’Archivio Notarile rogati tra il 1467 e il 1471
che restituiscono questo rapporto di 72 bolognini per ducato, ne segna-liamo uno relativo alla vendita di un appezzamento di terreno: ANV, Protocolli Notarili, vol. 24 (olim 38), c. 14, notaio Antonio Nicola Di Cicco. La stessa valutazione è riportata nei capitoli del Monte di pietà.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
146
nel I secolo d. C. da Octavius Onesimus23. Questo tracciato, identificato da Cressedi, come collegamento ufficiale tra Appia e Velletri, è stato invece declassato come secondario da Crescenzi che privilegiò il tragitto più breve in direzione di Lanuvio24. Nel più volte richiamato documento del 946 si fa comunque riferimento solo al primo tracciato nomina-to come “selce antica”.
A partire dal secolo VIII, però, la via Appia venne gra-dualmente sostituita a nord dal percorso interno ai Colli Albani, passante per Marino e a sud dalla Pedemontana, a causa del progressivo impaludamento della pianura ponti-na, attraverso i territori di Sermoneta e Sezze. Vi era anche un altro principale asse viario che correva più internamente e che corrispondeva grosso modo all’attuale via Casilina. Non è accertato il percorso che, lungo questa strada lam-bendo il territorio dell’Algido, veniva seguito fino a Monte-fortino, l’attuale Artena, per proseguire poi verso Anagni, ma possiamo ritenere che, a partire dal XIII secolo, molti itinerari verso sud avessero come punto d’incontro la città di Velletri in considerazione della crescita demografica, del-lo sviluppo economico e del potere politico che la città esercitò sul territorio. Nei secoli altomedievali, procedendo verso sud si arrivava a Capua percorrendo l’Appia antica oppure, soprattutto dopo l’impaludamento di quest’ultima, spostandosi lungo la Latina. Dopo il disfacimento del-l’impero carolingio, tutta la regione rimase indifesa non so-lo per via delle scorrerie saracene, ma anche per la presenza di numerosi malviventi lungo le principali vie di comunica-zione. Nell’870 alcuni monaci, di ritorno dalla Terra Santa,
23 G. CRESSEDI, Velitrae, in Italia romana: municipi e colonie, «Istitu-to di Studi Romani», Roma 1953, p. 92.
24 L. CRESCENZI, Archeologia, territorio, museo, «Quaderni della Bi-blioteca Comunale» 2, Velletri 1981, pp. 36-37.
ECONOMIA E TERRITORIO
147
partirono alla volta di Roma da Salerno attraverso la via La-tina, un percorso che, man mano che ci si allontanava dai territori longobardi, diveniva sempre più pericoloso: «sunt ibi homines mali, fures et latrones et ideo non possunt homines, ad Sanctum Petrum ire volentes, per eam transire, nisi sunt plurimi et armati»25.
Dopo la costruzione della cinta muraria, avvenuta pro-babilmente nella seconda metà del secolo XI, la pianta di Velletri si andò modellando nella forma dello scudo roton-do, su cui era situata, e si sviluppò verso la parte alta della città, che divenne il centro civile del Comune, mentre la parte bassa continuò a pulsare sotto la diretta influenza del-la sede vescovile. Il quadro più appariscente di questo svi-luppo urbano fu il probabile avanzamento verso nord della Porta Superiore, poi Porta Romana, evidenza della progres-siva espansione dell’intera cinta muraria. L’originale cinta doveva probabilmente correre ad est lungo la linea interna dell’attuale viale Regina Margherita, mentre ad ovest, dopo il convento di S. Francesco doveva risalire lungo l’attuale via dei Lauri, per ricongiungersi finalmente all’altezza di Porta Romana26. Molto si è discusso e talvolta fantasticato sul numero dei punti d’accesso alla città del periodo medie-
25 P. DALENA, Vie di pellegrinaggio nel Sud Italia verso Gerusalemme
nel Medioevo, in Roma – Gerusalemme, lungo le vie Francigene del Sud, I, Napoli 2008, p. 47.
26 La porta fu ricostruita nel 1576-77 sotto la direzione di Giaco-mo Della Porta, probabilmente su disegno del famoso Giacomo Ba-rozzi da Vignola, e rimase in piedi fino al 1839. Le vicende di Porta Romana di questo periodo furono descritte da un giovane ufficiale che licenziò le bozze nel 1916 mentre si trovava in trincea. Pochi giorni dopo sarebbe caduto in combattimento sul Veliki Kribach (G. SCHNEIDER-GRAZIOSI, L’antica «Porta Romana» di Velletri, in «Bollettino d’Arte», I-II, 1917, pp. 7-27).
VELLETRI NEL MEDIOEVO
148
vale, ma sulla base della testimonianza del Theuli27 e della diretta e spontanea asserzione di Mancinelli possiamo stabi-lire che intorno alla metà del XV secolo le porte urbiche28 fossero effettivamente due e già esistenti fin dal secolo un-dicesimo29. Le due porte, Romana o Superiore e Napoleta-na o Inferiore, erano situate sul principale asse viario lungo la direttrice nord-sud. I due profondi fossati, discendenti dalla montagna, circondavano e difendevano naturalmente la città non lasciando spazio ad altre facili vie d’accesso. Porta Napoletana fu ricostruita nel 1511 e modificata in se-guito nel 1727 e ancora nel 1769, quando acquisì la strut-tura ancora oggi visibile. L’originale Porta Romana fu sosti-tuita da una nuova nel 1577 su disegno del Vignola e poi demolita a metà del XIX secolo a causa dell’instabilità di uno dei palazzi su cui poggiava. Nel periodo medievale un’altra porta, quella di Portella, doveva avere svolto una sua specifica funzione. Il toponimo Portella, che diede il nome anche ad una delle decarcie cittadine, doveva la sua origine al termine militare Posterla o Pusterla, che antica-mente designava la porta di limitate dimensioni riservata per le comunicazioni con l’esterno a esclusivo uso militare. Queste porte, a volte opportunamente occultate, corrispon-
27 THEULI, Teatro Historico, cit., p. 270. Egli cita al suo tempo Porta Fura o Figura, vicino alla chiesa di S. Antonio, Porta del Pontone vici-no alla chiesa demolita di S. Rocco, Portella vicino al Matano, Porta S. Martina e Porta S. Lucia. Quest’ultima, insieme alle Porte Napoletana e Romana, è l’unica effettivamente esistente ancora nel XVII secolo. Nel-la quasi contemporanea (1631) e dettagliata pianta prospettica del Lau-ro, Portella e Porta del Pontone, così come Porta S. Martina e Porta Metabo non sono riportate.
28 Con questo termine vengono identificate le porte di una città dalle quale si dipartono le direttrici viarie.
29 “Colle sita est umili, clypei cui forma rotundi, / porta duplex, insunt bis templa decem” (MANCINELLI, Vitae sylva, cit., vv. 7-8).
ECONOMIA E TERRITORIO
149
devano a passaggi che servivano per movimenti isolati; in alcuni casi avevano la soglia alta sul fondo di un fosso, che veniva raggiunto con scale che poi erano ritratte all’interno. A Velletri essa era situata alla fine dell’omonima strada di Portella, tuttora esistente e ancora visibile nella pianta del Lauro30, benché non riportata in legenda. Il toponimo era presente in molti centri della provincia: Portella a Sermone-ta e Segni, Pusterula a Terracina, Priverno e Cori. In molti centri gli ebrei trovarono residenza in queste zone, tanto da originare in alcuni casi il patronimico familiare31, anche se non possiamo affermare che questo fu il frutto di una pre-cisa disposizione emanata delle autorità comunali. Testi-monianza iconografica della Portella veliterna è rimasta in una foto scattata all’indomani dei bombardamenti alleati del 1944 che avevano distrutto il palazzo antistante, edifi-cio che sfortunatamente fu riedificato subito dopo senza alcun apprezzamento per le antiche vestigia. Anche Porta Furia o Figura è rappresentata nella pianta del 1631 ed è descritta in legenda tra la chiesa di S. Antonio di Vienne e via Furio. Essa è documentata con entrambe le denomina-zioni nei libri consiliari almeno dal XVI secolo32 ed è ipotiz-zabile che sia stata aperta proprio in quel periodo con fun-zioni di passaggio pedonale. In un documento del 1790 ri-sulta esplicitamente attestato che Porta Figura non era più
30 La mappa incisa su rame (195x260) da L. Grignani a Roma nel
1631, è edita in R. MAMMUCARI, Velletri, viaggio dentro la città, Velletri 1995, pp. 140-141.
31 Ad Urbino gli ebrei vivevano nella Quadra di Pusterla (A. VE-
RONESE, Famiglie di banchieri ebrei attive nel Ducato di Urbino tra XIV e XV secolo, in Zakhor, Rivista di storia degli ebrei d’Italia, III, Roma 1999, p. 142).
32 A. REMIDDI, Velletri, memorie storiche, 2, Velletri 1982, pp. 218-219.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
150
unita alle mura cittadine33, mentre era sicuramente funzio-nante ancora nel 170934.
Il Theuli descrivendo le porte di Pontone35 e di Portel-la, ai suoi tempi in ogni modo già chiuse, pur senza fornir-ne l’esatta collocazione, le identifica, separatamente, in prossimità del medesimo luogo; vicino la chiesa di S. Rocco la prima, attigua alla chiesa di S. Maria la seconda. Anche il Tersenghi36 riporta la presenza delle due porte nella stessa sezione di mura nei pressi del fosso del Matano, dove suc-cessivamente sarebbe stata aperta anche la porta Metabo. Quest’ultima, conosciuta anche come Porta del Matano, fu progettata solamente nel 162337. Un ponte di tavole adia-cente alla Porta di Metabo esisteva ancora agli inizi del XX secolo38. In prossimità dello stesso luogo vengono inoltre ri-cordate la chiesa di S. Maria a Portella e quella di S. Maria del Pontone39. Quest’ultima, benché citata in legenda con il
33 A. ACCHIONI et al. (a cura di), Velletri, Strade e Contrade nella Sto-
ria, Velletri, 2005, p. 49; TERSENGHI, Velletri, cit., pp. 99-100). 34 In una anonima descrizione della città di Velletri di quell’anno
sono riportate come funzionanti quattro porte: Romana, Napoletana, S. Martina e Furia (AsCV, MS-IX-7).
35 Il nome derivò presumibilmente dall’adiacente ponte. Con il termine pontone, infatti, veniva designato ogni tipo di sostegno galleg-giante ad uso dei ponti. («L’Italia Militare», I, 2, Torino, 1864, Dell’uso dei pontoni, pp. 251-263). Nel caso specifico la costruzione servì a per-mettere il superamento dell’attiguo fosso del Matano.
36 TERSENGHI, Velletri, cit., p. 97. 37 REMIDDI, Velletri, cit., p. 220. 38 “Tutto il piazzale innanzi alla dogana Metabo era un profondo
burrone che veniva transitato, fino ai tempi nostri, con un malfermo ponte di tavole” (TERSENGHI, Velletri, cit., p. 95).
39 Di S. Maria a Portella si ha notizia nel 1429, mentre non si co-nosce la data della sua demolizione (THEULI, Teatro Historico, cit., p. 302); possiamo comunque indicare l’anno 1544 come termine post quem dal momento che essa viene menzionata negli statuti riformati
ECONOMIA E TERRITORIO
151
numero sette sia nella pianta del Lauro che in quella del Mortier del 172440, non risulta identificabile nelle stesse mappe. Essa fu aperta probabilmente nel corso della prima metà del XVI secolo e permise allora un accesso diretto in città lungo la via Retta41 ed ebbe, per oltre un secolo, lo sco-po di agevolare il transito verso la via Vecchia di Napoli, che in quel periodo stava diventando la principale arteria di col-legamento verso sud. All’alba dell’epoca moderna era appar-so, infatti, un nuovo itinerario, dominato da preoccupazioni di celerità e rendimento, identificabile con quello della via consolare o postale, già delineato nella mappa del catasto Alessandrino. Questo tragitto non aveva più come in pre-cedenza la funzione principale di collegare i vari centri abi-tati, ma le stazioni postali lungo il suo percorso: Tor di Mezza, via di Marino, Marino, Mezzaposta, Velletri, Casa-fondata, Osterie di Sermoneta, Case Nuove, Piperno, Maru-ti, Terracina. Dopo Marino il tragitto procedeva per il Ca-sale dei Corsi, che ospitava guarnigioni con l’intento di vigi-lare sulla sicurezza della macchia della Faiola infestata da briganti42. La strada scendeva poi verso Castel Ginnetti e
(GABRIELLI, Gli Statuti, cit., V, CXIV). Anche Porta del Pontone è citata negli statuti del 1544. Borgia ricorda la chiesa del Pontone come prima residenza della Confraternita del Gonfalone, consacrata nel 1348 dal vescovo di Nicodemia (BORGIA, Istoria, cit., p. 335; cfr. THEULI, Teatro Historico, cit., p. 301).
40 P. MORTIER, Velletri, pianta prospettica su rame, da «Novum Ita-lie Theatrum», Amsterdam 1724.
41 Questa via collegava Porta del Pontone alla Porta del Vescovo (GABRIELLI, Gli Statuti, cit., V, XIV), probabilmente lungo quel traccia-to che nel 1677 diede vita all’attuale via Metabo. Porta del Vescovo non coincideva dunque con porta Napoletana, ma corrispondeva all’entrata del palazzo vescovile costruito nel 1465 per volontà del vescovo d’Estouteville.
42 Cfr. COSTE, Strade da Roma per Sermoneta, cit., p. 102.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
152
proseguiva fino a Sermoneta. Questa impazienza di rag-giungere la meta nel più breve tempo possibile ebbe effetti anche all’interno della stessa Velletri. Per tutto il XV secolo, l'unico tragitto possibile era quello che, attraversando Velle-tri, toccava Piazza Superiore, San Martino, dove era situato il punto di posta, Piazza Dabballe (Piazza Mazzini) e infine Porta Napoletana. Dal 1612 questo tragitto ebbe una valida alternativa derivata dalla nuova via Borghesia, che collegava direttamente porta Romana alla parte sud della città43 lungo le attuali via Menotti Garibaldi e viale Regina Margherita, per rientrare poi nella cinta muraria attraverso la porta del Pontone fino alla cattedrale, lungo la via Retta.
La chiesa di S. Rocco fu abbandonata nel 1609 perché troppo vicina al traffico veicolare verso la via Vecchia di Napoli44 oppure per l’insalubrità del luogo45; La porta del Pontone, in ogni modo, dovette essere chiusa quasi subito poiché il Lauro solo pochi anni più tardi (1631) non la ri-portava nella sua mappa e lo stesso Theuli non ne fa men-zione nel suo Teatro.
43 Ancora oggi si può leggere la targa posta a ricordo dell’avveni-
mento incastonata in un palazzo sito nei pressi dell’antica porta Roma-na: Burghesia amplissima via in novam ornatus formam ex Romana princi-pium ducens ad Cathedralem recto se itinere confert anno D. MDCXII. Pauli Papae V Pont. Anno VIII.
44 THEULI, Teatro Historico, cit., p. 303. 45 Secondo altre testimonianze i frati Cappuccini abbandonarono
il sito appena un ventennio dopo il loro insediamento «per essere in luogo basso molto humido, e di cattiv’aria dov’era anco tanta quantità di serpi che spesso i Frati ne trovavano sino nelle celle, e sotto alli ca-pezzali delle lettiere, si risolsero finalmente a mutarlo, elegendo il sito fuor di porta Romana in un monticello di buonissima aria» (R. COR-
DOVANI, I luoghi abitati dai cappuccini nel Lazio dal 1528 al 1578, in «L’Italia Francescana», 53, 1978, p. 477, n. 26).
ECONOMIA E TERRITORIO
153
La lapide posta a ricordo della costruzione della via Borghesia (1612)
Porta S. Lucia fu costruita probabilmente tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo dagli abitanti provenienti da Lariano per rimarcare la loro autonomia, poiché essa non è ricordata da Mancinelli tra le porte della città46.
L’apertura di questa Porta, troppo vicina a quella Su-periore e senza una naturale espansione esterna, può essere spiegata plausibilmente con il forte sentimento della gente di Lariano che, pur costretta ad accettare il forzato trasferi-mento all’interno di Velletri, rivendicò per molto tempo un
46 Mancinelli scrive che la città era fornita di due porte (porta du-plex). Sempre nella sua opera autobiografica egli, nel descrivere il cir-condario di Velletri che poteva essere osservato dal punto più alto della città, volutamente aggiunse la città di Preneste, ab tergo montibus, per rimarcare l’assenza di qualsiasi abitato, appunto il castello di Lariano, verso quella direzione (MANCINELLI, Vitae sylva, cit., vv. 12-20). L’editio princeps della Vitae Sylva fu pubblicata a Venezia nel 1492, il che fa pre-sumere che a questa data la porta non fosse stata ancora costruita.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
154
orgoglioso, fiero e autonomo senso di appartenenza alla propria origine47. Il fatto è testimoniato dal colophon di un manoscritto, il De nuptiis Paulini, copiato presso la scuola di Mancinelli durante i primi anni di insegnamento a Velletri e conservato oggi presso la Biblioteca Laurenziana di Firen-ze: Excriptum per me Placentinum Sancti Lariani de Praeneste die martii 10, 1474 Velitris. Questo allievo rimarcava con la sua firma l’origine della sua famiglia ancora molti anni dopo il loro trasferimento.
Le decarcie e l’assetto urbano della città
Il primo assetto urbano della città avvenne a seguito
del più volte ricordato incastellamento, quando la maggior parte degli abitanti sparsi sul territorio si trasferì intorno al castello. La città assunse il suo primo aspetto formando tre distinti nuclei intorno alle chiese di S. Michele Arcangelo, S. Salvatore e S. Martino, zone che, insieme a quella preesi-stente di S. Clemente, diedero vita alle quattro decarcie del XIII secolo: Castello, S. Salvatore, Portella e Collicello. La chiesa di S. Michele costruita vicino al castello fu dedicata all’Arcangelo poiché quest’ultimo simboleggiava il naturale collegamento tra la terra e il cielo. I santuari e le chiese mi-caeliche, infatti, erano sempre situati nel punto più alto del-la città, poiché l’arcangelo era la creatura a cui Dio aveva af-fidato il compito di accompagnare gli uomini nei pericoli della vita terrena e di condurli nell’Empireo48.
47 LAZZARI, LOZZI, Gli Epigrammi, cit., p. 18. 48 F. FERRUTI, Note sul culto di San Michele Arcangelo, in «Quaderni
dell’Archivio Storico di Castel Madama», «Bollettino di Studi Storici», 1, 2007, p. 11.
ECONOMIA E TERRITORIO
155
Nel corso del Duecento la maggior parte degli edifici innalzati in precedenza subì lavori di trasformazione ed am-pliamento in conseguenza delle migliorate condizioni econo-
G. LAURO, Velletri, pianta prospettica, 1631.
miche e della forte crescita demografica e per il fatto, non secondario, che prima di quella data il legno era la materia prima largamente utilizzata nelle costruzioni. Già da un paio di secoli in ogni modo aveva avuto luogo la costruzio-ne di quella cinta muraria che dopo aver subito ristruttura-zioni ed ampliamenti è oggi quasi del tutto scomparsa.
Nel XIV secolo la città di Velletri risultava divisa in quattro decarcie. Purtroppo il salto cronologico di quasi un secolo, tra la prima testimonianza del termine e i documen-ti del pieno Trecento, non ci permette di conoscere la loro
VELLETRI NEL MEDIOEVO
156
primigenia evoluzione e di affermare se originariamente es-se fossero stabilite in numero di cinque49.
In ogni caso fino al 1346 sono documentate solamente le due decarcie di Portella e Collicello, zone di diretta perti-nenza della Curia vescovile che qui possedeva numerose abi-tazioni. Intorno alla metà di questo secolo la momentanea stabilità politica e una ancora buona situazione economica permisero un primo assetto urbanistico, evidenziato dalla co-struzione del nuovo palazzo comunale, dalla nuova sede po-destarile denominata “Casa della Ragione”, andata poi di-strutta a seguito dei terremoti del 1800 e del 180650, dalla chiesa di S. Antonio e dalla imponente Torre del Trivio. In precedenza la costruzione del convento di San Francesco aveva già ampliato verso ovest la crescita della città. Una se-conda espansione urbanistica si ebbe nel Quattrocento quan-do, dopo la distruzione di Lariano, gli abitanti del castello si trasferirono all’interno delle mura cittadine dando linfa allo sviluppo di due nuovi quartieri: le decarcie di S. Maria e S. Lucia. Quest’ultima venne probabilmente abitata dalla popo-lazione meno abbiente, mentre le famiglie nobili dovettero trovare spazio all’interno del centro urbano preesistente. La circostanza sembrerebbe confermata dal fatto che il nuovo abitato, ancora oggi conservato, risulta privo non solo di edi-fici pubblici, ma anche di palazzi nobiliari a cui le classi patri-zie provenienti dal castello non avrebbero certo rinunciato51.
49 Per una visione più approfondita sull’origine della decarcia nella
provincia romana vedi: F. LAZZARI, La decarchia medievale, innovazione o persistenza?, in «Annali del Lazio meridionale», 2 (2009), pp. 19-29.
50 CARDINALI, Risposta, cit., p. 65. 51 Dalla distruzione del castello di Lariano, secondo la tradizione
riportata da Tersenghi, si sarebbe salvato il portone di peperino poi si-stemato nel palazzo di fronte alla chiesa di S. Martino e andato distrut-to durante l’ultima guerra (TERSENGHI, Velletri, cit., p. 196). È presumi-
ECONOMIA E TERRITORIO
157
Anche se non raggiunsero certamente il fasto dei palazzi ba-rocchi di epoca posteriore, non mancarono nel Quattrocento abitazioni di un certo pregio come ricordato da Mancinelli nella descrizione della sua città52.
Il materiale usato nel Medioevo sia per la costruzione della cinta muraria che degli edifici era composto da selce nera (lava leucititica), di dimensioni medio piccole somma-riamente lavorata, proveniente dalle cave a cielo aperto del circondario, mentre risultano rari i grandi blocchi di tufo o materiale residuale di antichi edifici di origine romana. Per le opere di pregio, come la Torre del Trivio o la chiesa di S. Antonio, lo stesso materiale venne raffinato e tagliato in blocchetti regolari, seguendo i canoni della tradizionale lavo-razione che si riscontra negli esempi databili in prevalenza tra il secondo quarto del XIII secolo e i primi decenni del secolo seguente53. Il diverso grado di finitura potrebbe essere spiega-to con la capacità e le consuetudini esecutive delle maestran-ze ovvero dei cavatori e degli scalpellini impegnati nei lavori di estrazione e di taglio e finitura dei blocchetti. Maestranze che potrebbero essere state richiamate a Velletri in occasioni particolari, come la costruzione della torre del Trivio, e sicu-ramente durante il periodo di sindaco di Morandino Bocco-bardi da Perugia, il quale venne riconfermato in deroga agli statuti comunali poiché la sua carica fu ritenuta indispensa-bile bono et quieto statu dicte civitatis. La Torre del Trivio era in origine il campanile dell’antica chiesa di S. Maria, che fu poi riedificata nel XVIII secolo su disegno di Carlo Mader-
bile ritenere che il portone sia stato portato a Velletri dai proprietari originari, ora cittadini velletrani.
52 Sunt plateae pulchraeque domus, sunt strata viarum (MANCINELLI, Vitae sylva, cit., v. 11).
53 Cfr. D. ESPOSITO, Tecniche costruttive murarie medievali, murature ‘a tufelli’ in area romana, Roma 1997.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
158
no, architetto di S. Pietro, lasciando il campanile isolato54. Con la fine del XIV secolo la posa in opera diviene sempre meno regolare sfumando nella tecnica in pezzame, simile su tutto il territorio della campagna romana con l’utilizzo di blocchi configurati per favorire una migliore coesione con il nucleo interno, che può essere riscontrata nelle strutture dei sopravvissuti edifici medievali e nei resti delle mura, una tecnica che aveva comunque bisogno di continua ma-nutenzione e riparazione55. Le mura, alte e forti intorno alla città – costruite tra torri quadrate o circolari a distanza re-golare l’una dall’altra –, costituivano certamente una difesa efficace e scoraggiavano ogni velleitario tentativo da parte degli eserciti nemici. Velletri per tutto il periodo medievale, anche per la sua naturale posizione orografica, non subì as-salti riusciti ad eccezione della capitolazione inflitta da parte del popolo romano, che doveva essere costata grande sforzo e sacrificio considerando l’enfatico e liberatorio annuncio dell’avvenimento che i romani fecero ai fiorentini. Una si-tuazione che riuscì forse grazie all’aiuto che dovettero rice-vere dall’interno della città da parte di alcuni componenti della fazione dei Lupi. Le mura erano munite di torrioni di avvistamento ancora ben visibili in tutte le stampe rinasci-mentali e moderne. Durante la feroce lotta tra i Lupi e gli Agnelli, torri ben fortificate vennero costruite all'interno della città, di cui ancora possono scorgersi alcuni resti già ricordati da Tersenghi56. La dislocazione casuale di queste
54 G. TOMASSETTI, La campagna romana, antica, medievale, moderna,
II, nuova ed. aggiornata, a cura di L. CHIUDENTI e F. BILANCIA, Firenze 1979, pp. 436-438.
55 Ancora negli statuti del 1544 i Giudei erano tenuti ogni anno a costruire a loro spese “quattro passi” delle mura cittadine (GABRIELLI, Gli Statuti, cit., l. V, CIX)
56 TERSENGHI, Velletri, cit., pp. 170-171 e p. 282.
ECONOMIA E TERRITORIO
159
fortificazioni evidenzia come la loro costruzione fu il risulta-to del rafforzamento delle abitazioni preesistenti da parte delle famiglie aristocratiche. Così come avvenne a Roma nello stesso periodo, la costruzione di una torre fu un privi-legio consentito soltanto alle famiglie più importanti e la casatorre, che in pratica era la torre con funzioni abitative, divenne il modello d'abitazione più diffuso del patriziato locale. Tersenghi descrive la Torre de’ Foschi in via Furio e rammenta i resti di altre torri site in via S. Francesco, in via delle Morelle, al vicolo Gagliardi ed “altre ancora”. La Tor-re degli Annibaldi, situata in quella che ancora oggi è cono-sciuta come via della Torre, era probabilmente la stessa che fu poi tramandata dalla tradizione, già dal XV secolo, con il nome di Torre di Cacaritto57.
La popolazione
Risulta oltremodo difficile applicare criteri demografici
certi relativamente alla popolazione medievale. I documenti disponibili non rispondono alle nostre aspettative. Anche a Velletri dopo lo sconvolgimento della civiltà romana ab-biamo visto come la popolazione fosse diminuita in manie-ra inarrestabile per poi tornare a crescere fino al X secolo, quando secondo il noto accordo del 946 essa fu radunata intorno al castello appositamente costruito. Da questo momento iniziò una nuova fase di crescita che sarebbe du-rata fino al XIV secolo. Non possiamo evidentemente cono-scere il numero delle persone che diedero vita al nuovo centro urbano, ma in considerazione del fatto che vennero costituiti tre nuovi nuclei cittadini intorno alle chiese di S. Michele, S. Martino e S. Salvatore, oltre a quello già esi-
57 ACCHIONI et al., Strade, cit., p. 108.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
160
stente di S. Clemente, e tenuto conto dell'evoluzione de-mografica successiva, possiamo considerare un buon nume-ro di persone, forse addirittura un migliaio, anche se i vil-laggi da dove essi si mossero sembrano risultare invisibili al-la documentazione storica. Dalla contrazione altomedievale si passò quindi ad una fase espansiva, marcatamente nei se-coli XI-XIII, con una rinnovata organizzazione delle campa-gne, la rinascita della città, la circolazione monetaria, le corporazioni, il mercato e il commercio. Questa espansione fu accompagnata, a partire dall’XI secolo, da un fortissimo incremento demografico – causa ed effetto del perfeziona-mento delle tecniche agricole e dell’estensione dello spazio coltivato – a cui fece seguito un rapido decremento nel cor-so del XIV secolo, culminato con la peste nera del 1348 che può essere considerata a buon diritto il segno principale della crisi della società medievale e che falcidiò più o meno un terzo della popolazione europea58. La popolazione au-mentò alla fine del XII secolo, anche grazie al contributo di quelle famiglie che cercarono rifugio tra le mura cittadine dopo la distruzione della città di Tuscolo da parte dei Ro-mani nel 119159. Le avvisaglie di una crisi demografica ed economica del territorio della provincia di Marittima pos-sono essere rintracciabili già negli ultimi decenni del XIII secolo, anche se risulta enormemente difficile fornire dati certi sul numero della popolazione poiché le fonti coeve sono raramente ‘quantitative’. In ogni modo il calo netto della popolazione, riscontrabile già verso la fine del Due-cento, non pare arrestarsi fino agli albori del XV secolo, quando le difficili congiunture che avevano profondamente
58 Ovviamente il tasso di mortalità fu diverso da luogo a luogo oscillando tra un ottavo e i due terzi della popolazione.
59 CAROCCI, VENDITTELLI, L’origine della campagna romana, cit., p. 27 e nota.
ECONOMIA E TERRITORIO
161
segnato il cinquantennio precedente, carestie, guerre e pe-stilenze, pur se non possono dirsi terminate, proseguirono allora con minore intensità.
Se è vero che i dati in nostro possesso sono del tutto insufficienti, è indubbio che Velletri risultava essere una delle città più popolate della regione, anche in considera-zione del fatto che la popolazione della stessa Roma oscillò in questo periodo tra le venti e le quarantamila unità60. I primi dati sul numero degli abitanti veliterni, sempre par-ziali e indiziari, sono relativi al secolo XV: dai dati del pre-lievo di sale risulta che in questo periodo Velletri levava 207 libbre di sale, il che porterebbe ad ipotizzare una popo-lazione di circa 4.500 persone61. Tenuto conto che il Tre-cento ebbe una fase demografica altamente negativa, pos-siamo supporre che nel secolo precedente si potevano con-tare i veliterni in un numero oscillante tra le cinque-sei mila unità e che intorno all’anno Mille la popolazione doveva sommare almeno un quarto di questa cifra e cioè un nume-ro non inferiore alle mille anime. La curva demografica tornò quindi a crescere sensibilmente nel corso del Quat-trocento quando, oltre l’intenso sviluppo economico e de-mografico, la città si trovò ad accogliere tra le sue mura gli abitanti del castello di Lariano, un buon numero di ebrei e uomini di altre città ma qui domiciliati come attestano i numerosi atti dell’archivio notarile. In base alle liste di sale e focatico redatte negli statuti di Roma nel 1363, il castello di Lariano doveva contare circa 1500 abitanti, una cifra
60 Roma contava forse quarantamila abitanti prima dello spostamen-
to della sede papale ad Avignone. Nel corso del Trecento subì un vero tracollo demografico scendendo fino a diciassettemila abitanti (G. CHE-
RUBINI, Pellegrini, pellegrinaggi, giubileo nel Medioevo, Napoli 2005, p. 78) 61 C. BAUER, Studi per la storia delle finanze papali durante il pontifica-
to di Sisto IV, in «ASRSP», 50 (1927), p. 354.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
162
confermata ancora nel 1416, mentre per Velletri l’imposta per cento rubbia di sale, tenendo anche conto della percen-tuale di esenzione della tassa, confermerebbe una stima di quattro-cinquemila cittadini. Una tassazione che era il dop-pio di quella di Terracina e tre volte quella di Sezze62. Agli albori dell’età moderna Velletri poteva dunque stimare sei-ottomila individui, tenendo però conto che le ricorrenti pe-stilenze potevano incidere notevolmente sull'effettivo numero della popolazione.
62 G. TOMASSETTI, Del sale e del focatico del Comune di Roma nel Me-
dioevo, «ASRSP», 20 (1897), pp. 356-357. La possibile differente percen-tuale di esenzione nelle diverse città potrebbe in ogni modo falsare que-sto rapporto.
ALCUNI CENNI DI TOPOGRAFIA MEDIEVALE I topoi presenti in una determinata regione sono spesso
il risultato di grandi riorganizzazioni territoriali. Attenen-doci al caso specifico veliterno – speculare ovviamente al re-sto della campagna romana – possiamo registrare due gran-di fasi di questo fenomeno nel periodo medievale. La prima è rappresentata dalla riorganizzazione dell’VIII secolo, men-tre la seconda è individuabile con il secondo periodo di in-castellamento del XIII secolo, quest’ultimo accompagnato inoltre da un notevole incremento demico1. Ci limiteremo in queste pagine a mettere in evidenza i toponimi registrati nell’atto di enfiteusi del 946, la loro possibile localizzazione nel territorio e la loro eventuale persistenza. Elemento de-gno di nota riscontrato è l’evidente conservazione di alcuni toponimi antichi perpetuati nei secoli. Essi sono giunti fino ai nostri giorni mettendo in rilievo una suggestiva continui-tà onomastica, indice del forte attaccamento dell’uomo con la terra. In altre circostanze nuovi toponimi hanno invece sostituito quelli più antichi, talvolta però in modo solamen-te alterato o corrotto. I cambiamenti registrati risultano tal-volta derivati dalla modificazione geo-morfologica della re-gione, un tempo sicuramente più ricca di acqua e decisa-
1 M. SANFILIPPO, Agro Romano: storia di un nome e di tante realtà di-
verse, in Studi in onore di Giosuè Musca, Bari 2000, pp. 447-448.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
164
mente meno popolata, oppure da una storpiatura successiva del nome originario come rispettivamente nei casi di Casale dei Pescatori e Ponte della Bolaga.
I confini del territorio veliterno
Monte de Episcopo: ancora oggi denominato Colle del Vescovo. Nella zona è stato individuato un insediamento rupestre altomedievale con possibili finalità produttive.
Mensa latronis: questo toponimo risulta abbandonato già nel 1235, al tempo della bolla di Gregorio IX, sostituito dal termine Acqua Palomba, probabile derivazione da Ac-qua di Erbellone già presente nel documento del 946 e iden-tificativo delle rispettive proprietà. La famiglia Latroni è at-testata in Roma nel corso del secolo X ed era forse impa-rentata ai Tuscolani e ai Papareschi2.
Cesa di Raniero, Gizzi, Terra del fontanile: tutti questi to-ponimi, elencati da nord verso sud, sono situati sul confine orientale del territorio veliterno. Non sono più presenti nel documento del 1235 sostituiti da Bagno nuovo, Valle di Cento Gocce, Colle di Benione manioso, Prato di Canudel-lo, Turricchia3. I nomi originari dovrebbe corrispondere grosso modo a quelli attuali di via Redina Ricci, via Le Cor-ti (già via delle Quattro Vasche nella cartografia IGM del 1936), via Fossatello, Malatesta e Torrecchia;
Chiesa di S. Andrea apostolo (in silice): ancora fino a qualche anno fa si potevano scorgere i ruderi dell’antica chiesa nell’odierna località di Le Castella. Il tutto è stato adesso ricoperto da un cementificio!
2 C. CALISSE, I Prefetti di Vico, in «ASRSP», 10 (1887), p. 3. 3 BORGIA, Istoria, cit., p. 271.
ALCUNI CENNI DI TOPOGRAFIA MEDIEVALE
165
Campo Mosevo: era situato probabilmente nella zona dell’attuale Prato di Maggio. Il nome potrebbe derivare dal-la presenza di un’antica pavimentazione a mosaico geome-trico (musivo) in una zona dove sembrerebbe attestata una frequentazione fino all’età imperiale4;
Plagoro di Scazzi (Scazi): il termine era ancora in uso nel XVIII secolo5; dovrebbe corrispondere all’odierna zona si-tuata tra Capanna Murata e Monaci e la sua derivazione onomastica potrebbe originare da Scaptia, una delle antiche tribù rustiche romane, identificata da alcuni con il territo-rio di Velletri6, la cui funzione territoriale rimase attiva fino all’età imperiale; secondo una consolidata tradizione dopo che i Volsci, furono sottomessi, il loro territorio fu investito da un complesso progetto organizzativo-politico che com-portò la ridistribuzione delle terre e il controllo ammini-strativo-demografico degli abitanti. Per tale aspetto i territo-ri annessi fecero capo a cinque tribù rustiche: Pomptina, Pu-blilia, Maecia, Scaptia e Oufentina, il cui ruolo fu quello di organizzare i nuovi coloni aventi diritto al voto. La Scaptia fu delegata ad organizzare il territorio che si estendeva dai Colli Albani alla costa e questa individuazione ben si so-vrapporrebbe al toponimico del fondo veliterno.
Plagaro Carano: doveva essere situato probabilmente tra le odierne contrade di Muracce e Lazzaria, divise ancora og-gi da via di Carano. Era collegato al precedente fondo dal fossato Salginano.
Stuti: la zona potrebbe essere identificabile con l’odier-na contrada di Ponte di Mele;
4 LILLI, Velletri, cit., p. 1034. 5 BORGIA, Istoria, cit., p. 160 e p. 271. 6 GREGORI, Velletri tardorepubblicana, cit., p. 511, n. 34 con relativa
bibliografia.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
166
Ponte bolagai: Ponte della bolaga, che corrisponde all’at-tuale ponte di Mèle. È questo uno dei toponimi derivati da storpiamenti successivi. Nel privilegio di Pasquale II del 1102 è diventato ponte valagai mentre nel 1235 è denomi-nato ponte malagai. Nel XIV secolo è citato in alcuni atti notarili come ponte di Mèll e pontis di Mele. Il luogo doveva probabilmente la sua antica denominazione alla presenza di acqua e di pesce. La bolaga era infatti una grossa cesta di vimini intrecciati di forma sferica che veniva lasciata im-mersa nell’acqua per catturare i pesci; essa era usata ancora pochi anni addietro nelle valli di Comacchio per la pesca delle anguille. Originariamente il toponimo identificava so-lamente il ponte, mentre successivamente ha, con ogni evi-denza, indicato anche la zona circostante già conosciuta come Stuti.
Ponte Mainelli: l’odierno ponte Minello. Segna tuttora il confine con il territorio di Genzano lungo la via Appia vec-chia. Nella pergamene del 1102 e 1235 è individuato con il nome di ponte Magnello.
Via Caiana: la strada, che potrebbe coincidere con l’attuale via Ponte Minello, tracciava il confine con il terr i-torio che più tardi sarebbe appartenuto al castello di S. Gennaro. Il termine sembrerebbe confermare un’antica at-testazione del toponimo. La strada conduceva forse ad un fondo omonimo che si doveva estendere in direzione di Nemi. Attestazione che rimane ancora oggi nel sito Fon-tana di Caiano nel territorio nemese. L’ipotesi dell’esisten-za di un fundus Caianus è plausibile, ma non ci sono al momento attestazioni certe, epigrafiche o di altro tipo, che consentano di dimostrarlo a meno che non si possa identi-ficare con il fondo Caniano parte della massa Trabatiana nel Patrimonium Appiae, fondo ricordato in una iscrizione della Basilica vaticana che sanciva una donazione, a favore
ALCUNI CENNI DI TOPOGRAFIA MEDIEVALE
167
della stessa basilica di vari fondi ad opera di Gregorio II in-torno all’anno 7157.
Monte Celio: nome probabilmente riconducibile all’at-tuale monte Spina, termine quest’ultimo effettivamente ri-portato nella bolla di Pasquale II del 1102. Nello stesso do-cumento il monte Artemisio è ricordato con il nome di Ca-cumen.
I fondi del territorio:
La descrizione dei fondi pare seguire una linea immagi-
naria, che collegava ogni fondo a quello successivo partendo dal confine nord occidentale del territorio veliterno per arri-vare nei pressi della chiesa di San Clemente dal versante op-posto. La localizzazione di questi fondi dovrebbe quindi cor-rispondere, con una certa approssimazione, a quanto di se-guito riportato anche se, è bene ribadire, alcuni toponimi sono stati identificati solamente in base a quella che possia-mo definire una ‘logica geografica’. In ogni caso, anche rifiu-tando alcune delle identificazioni proposte, la cornice deli-neata dai soli siti sicuri rimarrebbe sostanzialmente valida.
Fondo (Monte) Calvello, fondo Bespoleto: questi fondi do-
vevano essere situati nella parte occidentale della città, pro-babilmente nella zona compresa tra le odierne contrade di Colle dei Marmi8 e Colle Ottone9. Dal momento però che
7 A. MAI, Scriptorum veterum nova collectio e Vaticanis codicibus edita,
Typis Vaticanis, Roma 1831, p. 210. 8 Il toponimo, adottato nel XVII secolo, rimanda ai numerosi
elementi decorativi marmorei rinvenuti sul posto (G. GHINI, La villa de-gli Ottavi a Velletri, in Augusto a Velletri, «Atti del convegno di studio, Velletri 16 dicembre 2000», p. 40).
9 La tradizione storica veliterna, a partire dal Theuli, ha sempre as-
VELLETRI NEL MEDIOEVO
168
non è stato possibile identificare con certezza il primo fun-dus indicato nel documento, potrebbe essere possibile una differente chiave di lettura facendo coincidere il fondo Cal-vello con il colle S. Giovanni, dove nel periodo della media età imperiale potrebbe essersi sviluppato un impianto rusti-co-residenziale10;
fondo Cosconi: il fondo era conosciuto con questo nome ancora nel XVIII secolo11, ma non sembrerebbe coincidere con il sito proposto agli inizi del secolo scorso12. Il fondo doveva essere ubicato invece nei pressi di Colle Ottone13, nel luogo in cui nel 1646 era ricordata una fonte sita in ‘quarto di Paganico detto di Casconi’ all’altezza dell’incro-
sociato il toponimo all’imperatore romano Otone Marco Salvio sulla testimonianza di Svetonio che raccontò della sua sepoltura in Velletri. In considerazione dell’assenza di questo nome nel documento del 946, ma soprattutto perché Demetrio di Melioso nel 968 fu ambascia-tore in Germania per richiedere l’aiuto dell’imperatore Ottone per conto della nobiltà romana, potrebbe essere altrettanto ipotizzabile che il toponimo sia derivato dalla possibile permanenza nella zona di uno degli imperatori sassoni presenti a Roma tra il 963 e il 1002. Qui si trovava uno dei probabili insediamenti altomedievali andato distrutto a seguito di un incendio nella prima metà del XIX secolo, ma già de-scritto agli inizi del secolo precedente da Volpi, che annotò la presenza di fabbricati medievali che avevano inglobato resti più antichi (G. R. VOLPI, Latium vetus sacrum et profanum, IV, De Veliternis et Coranis, Pa-dova 1727, p. 60).
10 LILLI, Velletri, cit., p. 600. 11 BORGIA, Istoria, cit., p. 160. 12 G. TOMASSETTI, La campagna romana nel Medioevo, in «ASRSP»,
2 (1879), p. 157. 13 THEULI, Teatro Historico di Velletri, Velletri 1644, (rist., Bologna
1968), p. 97. La testimonianza del francescano si rivela preziosa quando riferisce di avvenimenti a lui contemporanei. Qui egli ricorda che il convento di S. Francesco possedeva una proprietà detta di Coscone non distante da Colle Ottone.
ALCUNI CENNI DI TOPOGRAFIA MEDIEVALE
169
cio dove ancora oggi si diramano le strade per Velletri (via di Rioli), Lanuvio e verso sud per Ponte di Mele14. Questo era uno dei quattro fondi: Mucianus, Cosconis, Pretoriolus e Casa Catelli, che agli inizi del secolo VIII era di proprietà della basilica dei SS. Giovanni e Paolo. È evidente che nel X secolo il fondo Cosconi era rientrato nei possedimenti del vescovo veliterno, probabilmente in quanto l’unico dei quattro a trovarsi all’interno del territorio di Velletri15. Gli altri fondi dovevano essere probabilmente localizzati in di-rezione di Lanuvio al di là del confine di Ponte di Mele16;
fondo Cesa presbitero: Cesa, toponimo che ritroviamo anche per un altro fondo, Cesa Raineri, stava ad indicare una zona che aveva subito il taglio (caesa) di alberi per poi essere dissodata e messa a coltivazione;
fondo Due amanti: il sito potrebbe derivare il nome dalla presenza di un blocco marmoreo raffigurante le figure di Amore e Psiche. Anche a Roma nello stesso periodo esisteva un luogo così denominato, presso il quale era ubicato il Monastero di S. Salvatore poi unito a quello di S. Ciriaco. Il Crocioni ricordava di aver visto un atto comunale del XV secolo in cui era attestata la costa de’ domanti17. Anche que-
14 ACCHIONI et al., Strade, cit., p. 157. 15 In considerazione della originaria tendenza di porre i territori
sotto la diretta responsabilità del vescovo, possiamo ipotizzare che l’attribuzione dei fondi alla basilica sia stata il frutto di uno stornamen-to in suo favore di alcuni beni fondiari poi tornati nel patrimonio cen-trale della Chiesa.
16 D. DE FRANCESCO, Partizioni fondiarie e proprietà ecclesiastiche nel territorio romano tra VII e VIII secolo. Prospettive di ricerca alla luce dei dati epigrafici, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen-Age», 110 (1998), p. 73.
17 G. CROCIONI, La toponomastica di Velletri, in «Bollettino della Società Geografica Italiana», Roma 1901, p. 699.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
170
sto fondo era con ogni evidenza ubicato nella parte occi-dentale del territorio nei pressi della strada che conduceva al castello di S. Gennaro18;
fondo Forconi: seguendo il tracciato descritto nel docu-mento dovrebbe corrispondere ad un fondo confinante con la contrada di Soleluna;
fondo Soleluna: la contrada ha mantenuto la sua antica denominazione. Deve probabilmente la sua designazione al-la presenza di un antico tempio pagano. Il rinvenimento in questa zona di iscrizioni sia pagane che cristiane testimonie-rebbe il radicato decentramento di autonomi insediamenti nel territorio veliterno;
fondo Paganico: anche questa zona è ancora oggi cono-sciuta con il suo nome altomedievale. Oltre all’accezione comune di abitante di villaggio rurale, a partire dal IV seco-lo il termine aveva cominciato ad assumere il significato di privato cittadino in contrapposizione a militare. Di qui nell’uso cristiano avrebbe indicato chi era escluso dalla mi-lizia di Cristo19. D’altra parte l’editto di Teodosio del 391 – che decretò la chiusura dei culti e templi pagani e riconobbe il cristianesimo come religione ufficiale – non poteva aver re-ciso di colpo il culto delle antiche divinità. In entrambe le ipotesi, abitante rurale o non cristiano, questo toponimo tenderebbe a dimostrare l’antichità del sito abitativo;
fondo Casale dei Pescatori: zona forse identificabile nei pressi dell’attuale Colle Caldara e comunque sicuramente nella zona a nord della città. Nell’elenco dei beni dell’ab-
18 A. RUGGERI, Appendice topografica, in M.T. CACIORGNA (a cura
di), Santa Maria di Grottaferrata e il cardinale Bessarione. Fonti e studi sulla prima commenda, Roma 2005, p. 352.
19 TACITO, Storie 3, 24; TERTULLIANO, De corona 11.
ALCUNI CENNI DI TOPOGRAFIA MEDIEVALE
171
bazia di Grottaferrata è infatti elencato insieme con la contrada Cigliolo20. Il toponimo suggerisce la presenza di un’azienda con annessa piscaria per l’itticoltura;
fondo Gliõcni: probabilmente riconducibile per corru-zione onomastica all’attuale Colle Ionci. Nelle Platee sei-set-tecentesche è ancora denominato come ‘Gionchi’ e/o ‘Col-le de’ Gionchi’21;
fondo Ancarano: probabilmente l’odierno Colle Scara-no. Una città con questo nome esiste in provincia di Tera-mo e fa risalire la propria origine alla presenza nella zona di un tempio dedicato alla dea Ancaria. Nel nostro caso ve-rosimilmente un prediale dal nome della sua proprietaria. Senza azzardare collegamenti diretti, possiamo ricordare che una Ancaria fu la prima moglie di Gaio Ottavio padre di Cesare Ottaviano Augusto;
fondo Scazzi (Scazi): probabilmente nei pressi dell’odierna Capanna Murata. Ancora nel XVIII secolo manteneva l’antica denominazione22, mentre nel XIII veniva registrato come casale cum silva et pratis23. Potrebbe derivare il suo nome dalla tribù Scaptia, individuata da alcuni tra Velletri e Anzio (vedi p. 165 e n. 6).
fondo Paritorum (fondo delle Guardie): la contrada an-cora oggi conosciuta come La Parata rappresentava eviden-temente il baluardo difensivo contro le scorrerie dei sarace-ni provenienti dalla base che avevano costituito nei pressi del Garigliano;
20 RUGGERI, Appendice topografica, cit., p. 352. 21 Ibidem. 22 BORGIA, Istoria, cit., p. 160. 23 Ivi, p. 256.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
172
fondo Cripta …: nei pressi dell’attuale contrada Monaci. Una lacuna della pergamena non ci permette di conoscere il nome completo di questo fondo, però considerando che molti fondi veliterni confinanti con il monastero di S. An-drea in silice condivisero la stessa denominazione, possiamo ipotizzare che si tratti del fondo Cripta rubea. Il toponimo denotava evidentemente la presenza di un antico edificio con volte, in parte interrato. Durante alcuni lavori effettuati sul finire del XIX secolo per portare l’acqua a Cisterna fu-rono rinvenuti nella zona numerosi ex voto rappresentanti organi del corpo umano24;
fondo Formello: forse la zona comprendente le attuali contrade Colle Salvia e Le Mole. I mulini furono, come evidenziato da Marc Bloch, una ‘invenzione’ dell’XI secolo. La loro costruzione determinò evidentemente il cambio nel toponimo;
fondo di San Tommaso apostolo: l’attuale San Tomao. È probabile che come per S. Pietro e S. Stefano su questo fon-do ci fosse fin dall’altomedioevo una chiesa dedicata in onore del santo. Essa risulta citata infatti già nel secolo VIII a proposito dei lavori fatti eseguire da papa Adriano I (772-795) per la chiesa di S. Andrea in silice: Basilicam beati An-dreae apostoli sitam via Appia in Silicae ultra sancti Thoma apo-stolo non procul a trigesimo desolatione ruinis praeventa25. L’atti-vità della chiesa è documentata ancora alla fine del XII se-colo. Nel 1181 infatti un diacono sancti Thome risulta tra i testimoni della vendita di un terreno a favore del vescovo veliterno26. Per lunghissimo tempo la porzione di territorio a sud della via Appia dell’attuale contrada di S. Tomao è
24 ACCHIONI et al., Strade, cit., p. 149. 25 Lib. Pont. I, p. 508, II. 19-21. 26 TESTONE, I Regesti, cit., p. 16.
ALCUNI CENNI DI TOPOGRAFIA MEDIEVALE
173
stata proprietà dell’abbazia di Grottaferrata, a partire alme-no dal 1345, quando compare nell’elenco dei beni indebi-tamente venduti dall’abate Angelo Corradi27 e fino al 1660 quando la tenuta di S. Tomao fu venduta dall’abbazia al cardinale Marzio Ginnetti28;
fondo Cornarolo: non distante dal fondo di San Tomao. Dovrebbe coincidere con la località Tornarolus, fondo ap-partenente alla chiesa di S. Andrea in silice nel privilegio del 120129. Questo e il precedente fondo S. Thomae furono evi-dentemente comuni sia al territorio di Velletri che a quello del monastero di S. Andrea in silice o almeno i fondi in questione furono in tempi diversi rivendicati dalle due enti-tà giurisdizionali, la diocesi di Velletri e l’abbazia di S. An-drea30;
fondo Casale Cesarea: situato manifestamente nella zona compresa tra le odierne contrade di S. Tomao e S. Pietro, probabilmente nei pressi dell’odierna zona di Ulica. La dire-zione si arguisce dal fatto che partendo dal fondo Cornarolo e proseguendo verso est si incontrava il fundus de Hospitali31, luogo ancora oggi conosciuto come Colle Ospedale. È inol-tre evidente che il fondo Cesarea non ha nulla in comune con la località di S. Cesareo, dove si suppone vi fosse situata
27 RUGGERI, Appendice topografica, cit., p. 355 28 V. CICCOTTI, Inventario Archivio Notarile, II, Protocolli Notarili
(1651-1787), Velletri, Biblioteca Comunale, 2004, p. 9, prot 832, cc. 174-176, notaio Lelius Albritius; nel prot. 837 (not. Carolus Vergatus), cc. 214v-216 viene registrata la presa di possesso da parte del card. Marzio Ginnetti).
29 P. PRESSUTTI (a cura di), Regesta Honorii papae III, I, Roma 1888, pp. CXXI-CXXIII.
30 Su questi fondi e più in generale sulle vicende del monastero di S. Andrea in silice vedi: LAZZARI, Castra e proprietà medievali, cit., pp. 7-17.
31 TOMASSETTI, La campagna romana, in «ASRSP», cit., p. 156.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
174
la villa di Cesare Ottaviano Augusto. È probabile che il ca-sale altomedievale sia sorto su un antico impianto attivo almeno fino alla prima età imperiale32;
fondo S. Pietro: la zona ha mantenuto la sua antica de-nominazione. Qui doveva essere situata l’ecclesia Sancti Petri de Querqueti ricordata ancora nel 120333. È probabile che il sito sia stato contrassegnato da un continuum abitativo dal periodo tardo-antico a quello altomedievale34. Nella zona fu ritrovata un’urna di marmo bianco con bassorilievi, databi-le al III secolo, poi usata come fonte battesimale nella cat-tedrale di San Clemente35;
fondo Casale quercia revolosa: derivato evidentemente dal-la presenza di una quercia rigogliosa. Nei pressi dell’attuale contrada Carbonara36, come chiaramente riscontrabile in-crociando i dati di questa posizione con i confini dell’insula di pertinenza della chiesa di S. Clemente;
fondo Orselli e fondo Torano: questi fondi sono da indi-viduare tra Carbonara e Malatesta, una zona che compren-de oggi le contrade di Colle Perino37, Colle Formica, Colle Cicerchia e Colle d’Oro;
32 LILLI, Velletri, cit., pp. 894-895. 33 BORGIA, Istoria, cit., p. 256. 34 LILLI, Velletri, cit., p. 837. 35 ACCHIONI et al., Strade, cit., p. 167 e nota. 36 Un fundus Carbonaria è ricordato insieme a quello Canianus nel
corso del secolo VIII (vedi n. 7). L’antichità del toponimo è testimonia-ta ancora in un privilegio del 1428 (TESTONE, I Regesti, cit., p. 50).
37 Questo fondo è denominato come casale collis de Ilperino almeno dal XIII secolo. Un Teofilatto de Ilperino è citato come testimone in un atto del sec. XI (ACV, Perg. 1091), forse affine di quell’Alperino pre-sente come teste alla consacrazione della chiesa di S. Lucia nel 1026 o 1032 insieme al consul e dux Giovanni di Demetrio e al comes Franco. Quest’ultimo potrebbe forse coincidere con l’Elperino novili viro da via
ALCUNI CENNI DI TOPOGRAFIA MEDIEVALE
175
fondo Gizzi: stando alla linea di confine, relativa al terri-torio veliterno, tracciata nel documento del 946, doveva es-sere situato a sud delle attuali contrade di Colle d’Oro, Lu-pacchiotti e Malatesta38;
fondo Bassetti: Circoscrivibile tra le attuali contrade di Capitancelli e Le Corti. Non ritengo possa essere identifica-bile con il fondo che nel documento del 1042 è citato con il nome di Bussetuli, poi Bussitoli nel XIII39 e XIV secolo40. Nel privilegio di Innocenzo III del 1202, dove la descrizione dei fondi sembra muoversi da ovest verso est, esso è infatti situa-to tra il casale in Plano de formis e quello de Ilperino;
fondo Carcano: l’attuale Colle Carciano. Il toponimo è rimasto quindi quasi inalterato;
Lata testimone in un atto del 1027 per il monastero di S. Ciraco (HARTMANN, Ecclesiae S. Mariae, cit., I, LIII, p. 66). Gli Ilperini erano una famiglia molto ramificata, ma è ancora poco conosciuta e studiata. Tra essi si ricorda il ramo di S. Eustachio. Di origine franca, gli Ilperini vennero in Italia al seguito di Carlo Magno e si sarebbero stanziati in un primo momento in Sabina avendo ottenuto dall’imperatore la si-gnoria di Lariano, da Lefevre situato, ma non identificato, in quella re-gione (R. LEFEVRE, Sulla «signoria di Lariano», in «ASRSP», 101 (1978), pp. 375-383) in contrasto con il Tomassetti che aveva messo questo Il-perino o Alperino in relazione con l’omonimo castrum dell’Algido e con i Tuscolani (TOMASSETTI, La campagna romana, cit., IV, p. 549). Nella genealogia dell’Orano (D. ORANO, Appendice al diario di Marcello Alberi-ni, in «ASRSP», 19 (1896), p. 57) che fa discendere la famiglia Alberini da questo Ilperino signore di Lariano, vivente nel 1030, non è in ogni modo menzionato alcun Teofilatto. Ancora nel 1491 in ogni modo un Giacomo de Alperinis vendeva alla città di Velletri alcune terre site nel-la tenuta di Lariano (DE SANTIS, Inventario, cit., p. 178).
38 RUGGERI, Appendice topografica, cit., p. 354. Sulla possibile ori-gine del toponimo Malatesta si veda p. 115, n. 258.
39 BORGIA, Istoria, cit., p. 256. 40 STEVENSON, Documenti, cit., p. 87.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
176
fondo Sambuci: dovrebbe corrispondere alla zona oggi conosciuta con il nome di La Chiusa;
fondo Revoli: oggi Rioli. Evidente la derivazione onoma-topeica da rivolo, piccolo corso d’acqua. Sulla base delle di-verse strutture variamente documentate sembrerebbe possi-bile una frequentazione fino al V secolo d. C., estesa su un’area di circa 64.000 mq41.
fondo Vallescura: forse identificabile con l’odierna Ma-donna degli Angeli. Secondo quanto riportato da Lilli, esi-steva un tracciato viario che partendo dal lato settentrionale di Rioli arrivava fino alle pendici meridionali della dorsale di Madonna degli Angeli42;
fondo Lociolu: probabilmente l’attuale Cigliolo. Il nome potrebbe forse trarre origine da loculus, nome con cui i lati-ni definivano lo spazio di terreno che occupava una tomba o un monumento sepolcrale;
fondo Papazzano: Ancora oggi la contrada è conosciuta con questo toponimo. Il termine potrebbe derivare dal lati-no medievale papatium nel significato dispregiativo di papa (papazzo). Il Borgia ricorda nei pressi di questa contrada la presenza di «antiche ruine e antichi edifizi»43, di cui però non vi è traccia, probabilmente per sostenere la tesi secon-do cui esisteva qui un’altra chiesa nominata di S. Clemente e alla quale apparteneva l’insula descritta nel documento del 946. Tesi questa ripresa acriticamente dal Bauco e ancora avvalorata dagli studiosi contemporanei44. Il Theuli, che scriveva ottanta anni prima del Borgia, non ricordava alcu-
41 LILLI, Velletri, cit., p. 677. 42 Ivi, p. 246. 43 BORGIA, Istoria, cit., p. 157. 44 COGOTTI, La Cattedrale, cit. p. 53 e nota.
ALCUNI CENNI DI TOPOGRAFIA MEDIEVALE
177
na chiesa con questo nome tra quelle di cui rimanevano ro-vine al suo tempo45, né tanto meno risultava una chiesa così denominata tra quelle in possesso della cattedrale nel XIII secolo46. In ogni modo il materiale rinvenuto in questa zona testimonierebbe una frequentazione protrattasi solamente fino all’età arcaica47.
fondo Santo Stefano: doveva essere situato nei pressi di Troncavia a cui si accedeva dall’omonimo ponte, oggi ponte della Regina, citato tra i confini dell’insula. Il toponimo porterebbe ad ipotizzare la presenza di una chiesa con con-seguente nucleo abitativo durante il periodo altomedievale, forse prosecuzione o rifrequentazione di un insediamento rustico-residenziale attivo in età imperiale48. Nell’agiotopo-nomastica S. Stefano è generalmente associato ad un culto di origine orientale diffusosi durante il periodo bizantino49. Una chiesa con questo nome, poi denominata di S. Rocco, esisteva nei pressi della Portella, citata già nel XIV secolo, in una zona vicina alla mura cittadine che si affacciava davanti
45 THEULI, Teatro Historico, cit., p. 301. 46 BORGIA, Istoria, cit., p. 256. L’elenco includeva le chiese di: S.
Antonino in strada, S. Dionisio, S. Pietro in querceto, S. Nicola, S. Be-nedetto, S. Blasio, secondo un apparente tragitto che partendo dalla via Appia antica arrivava a nord della città, e S. Pantaleone. Di esse riman-gono oggi i toponimi di contrada San Pietro, via S. Nicola che collega via di Paganico a via di Rioli e via S. Biagio di fronte al cimitero. Nel documento del 1201 relativo alla concessione di S. Andrea in silice alla basilica lateranense, per quanto concerneva il territorio di Velletri era-no citate la chiesa di Sant’Agnese e quella di S. Giacomo “di Teto” (PRESSUTTI, Regesta, cit., p. CXXII).
47 LILLI, Velletri, cit., p. 554. 48 Ivi, pp. 555-556 e p. 645. 49 G. CLEMENTE, Toponomastica e agiotoponomastica: strumenti, meto-
di e casi di studio per la conoscenza archeologica del territorio, in REDI, FOR-
GIONE (a cura di), cit., pp. 28-31.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
178
a quello che doveva essere il fondo S. Stefano. Ancora oggi la toponomastica cittadina riporta qui una via con il nome di questo santo.
fondo Pullano: nelle vicinanze dell’attuale Colle S. An-tonio. Il toponimo potrebbe forse derivare dal latino me-dievale pullano ossia puledro, oppure, più probabilmente, dal prediale romano Pullianus. Il fondo era già appartenuto alla basilica di S. Maria in Trastevere, frutto di una dona-zione menzionata in un’epigrafe frammentaria conservata nel portico della suddetta chiesa, dalla discussa collocazione cronologica50. La datazione, con molte cautele assegnata tra la fine del VII e l’inizio del secolo VIII, dovrebbe essere in ogni modo sicuramente anteriore al X secolo poiché, come nel caso del fondo Cosconi, al momento della concessione enfiteutica del 946, anche questa porzione di territorio era rientrata nel dominio del vescovo veliterno. L’epigrafe menziona la donazione di omnem portionem fundi Pulliani ... cum v[ineis e]t terris erga seriem docum[ento]rum eius velliterno si-ti te[rrito]rio miliar[io] XXV domux haec sanctae [semper]que vir-ginis et Dei genetric[is] [Ma]riae quae Callisti vocatur. La posi-zione è peraltro confermata dalla bolla di Innocenzo III del 1202 dove il fondo, denominato come casale de Puliano, è situato tra il fondo Casale de Ilperino e quello delle Corti51. L’identificazione del fondo, molti chilometri all’interno del territorio rispetto alla via Appia, tenderebbe a dimostrare che il miglio non individuava necessariamente il fondo nel-le immediate vicinanze della via, ma che quello era il punto da cui procedere per il luogo di riferimento.
50 DE FRANCESCO, La proprietà fondiaria, cit., pp. 203-204. 51 BORGIA, Istoria, cit., p. 256.
ALCUNI CENNI DI TOPOGRAFIA MEDIEVALE
179
I confini dell’insula di pertinenza della chiesa di S. Cle-mente:
La linea di confine è descritta iniziando dal punto ter-
minale della strada selciata (silice antiqua) probabilmente an-tistante la chiesa di S. Clemente e da qui in direzione del ponte sancti Stephani;
Ponte di S. Stefano: corrisponde all’attuale ponte della Regina. L’individuazione si ricava procedendo a ritroso dal-la successiva indicazione, Acquavivola, lungo il fossato mag-giore. Secondo le coordinate contenute nel documento, in-fatti, dal ponte si proseguiva lungo il primo tratto del fossa-to verso Acquavivola (et ducit in fossatum maiorem et pergit in aquam vivam);
Aqua viva: il luogo ha conservato la sua antica denomi-nazione essendo oggi conosciuto come Acquavivola. Il to-ponimo è citato ancora in un atto del 1038 come aqua buia. Sul retro dello stesso documento una mano del XII secolo aggiunse: de terris de aque bibule52. Si trattava ancora di una concessione enfiteutica a terza generazione da parte del ve-scovo Leone di un fondo situato tra la Valle e Colle del-l’Orto e Valle di Aqua buia. Dalla descrizione dei confini il fondo dovrebbe corrispondere topograficamente alla parte meridionale dell’odierna zona di Colle Palazzo, toponimo quest’ultimo che potrebbe derivare dagli edificia testimonia-ti nello stesso documento. Il tracciato, ricordato nell’atto del X secolo, circondava da vicino la fonte omonima, lungo la parte terminale dell’attuale via di Acquavivola e quella iniziale di via della Caranella, e discendeva quindi verso la cerqua revaliosa;
52 STEVENSON, Documenti, cit., p. 84.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
180
Cerqua revaliosa: nello stesso documento del 946 il ter-mine è trascritto anche come Cerqua revolosa. Il nome fu de-rivato evidentemente dalla presenza di una quercia rigoglio-sa sita nei pressi dell’attuale contrada Carbonara. Da questo punto la linea di confine continuava dritta fino al fossato occidentale nel luogo situato davanti alla strada che ancora oggi conduce a San Pietro (vadit subtus in cerqua revaliosa et venit in via que pergit ad sanctum petrum e ducit se in fossatum maiorem ad castellum muzzum). La linea di confine dell’isola coincideva evidentemente con i confini settentrionali dei fondi di Cerqua revolosa e S. Pietro poiché questi rientrava-no tra i fondi concessi in enfiteusi al consul et dux Demetrio;
Castello mozzato: non sappiamo quando e da chi fu co-struito questo edificio, ma evidentemente erano i resti di una più antica costruzione. Nel decimo secolo era già diru-to, forse distrutto da un’incursione saracena. Stando alle coordinate riportate nel documento del 946 doveva essere ubicato nei pressi dell’attuale S. Maria dell’Orto. Questa ti-pologia di costruzioni, nonostante la denominazione di “ca-stella”, dovrebbero essere escluse dal quadro del fenomeno del primo incastellamento. Esse furono probabilmente co-struite a scopo difensivo. A questa varietà potrebbe essere associato il castellum di Mons Maiorinulus costruito nei pressi di Sutri e già abbandonato nel 954 in un periodo in cui il pericolo saraceno era ormai cessato, ma che era stato ben vivo solo pochi anni prima, poiché, ancora nel 914, Sutrini e Nepesini avevano contrastato e sconfitto un contingente di saraceni53;
L’ultimo tratto del confine dell’insula era tracciato dalla via pubblica (et sicut venit in predicta silice antiqua);
53 VENDITTELLI, Sutri nel Medioevo, cit., p. 7.
ALCUNI CENNI DI TOPOGRAFIA MEDIEVALE
181
Silice antiqua: Il segmento in oggetto dovrebbe essere identificabile con il primo tratto della via Mactorina che collegava la chiesa di S. Clemente alla via Appia, coinci-dente approssimativamente con gli attuali viale Guglielmo Oberdan, viale Salvo D’Acquisto e il primo tratto di via di Paganico.
Per un confronto più immediato con i luoghi citati, si
riporta qui di seguito la trascrizione della concessione enfi-teutica del 946 come edita da Enrico Stevenson.
Anno 946 (?), 9 genn. Leone vescovo di Velletri concede in enfiteusi, sino alla
terza generazione, a «Demetrio quondam (?) Meliosi», Con-sole e Duca, un monte «ad castellum facendum» con molti fondi, nel territorio di detta città.
(In nomine domini nostri)1 Iesu Christi. Anno deo
propitio, pontificatus domini Marini summi Pontificis, universalis Iunioris pape in sacratissima sede beati petri apostoli quarto, indictione VI Mense Ianuario Die nona.
Quisquis actionibus venerabilium locorum pre (esse dignoscitur in) cuntanter2 eorum utilitatibus ut proficiant cum summa diligentia procurare festinet. Placuit igitur cum Christi auxilio atque convenit in Leonem reverentissimum
STEVENSON, Documenti, cit., pp. 73-79. Quelle di seguito riporta-
te [1-37] sono le note originali al testo. 1 Borgia; queste parole oggi non si scorgono perché è consunta la
pergamena. 2 Ho supplito il lacero testo col confronto del documento n. III,
dove sono adoperate molte delle medesime formole. Il Borgia ha: «loco-rum … in cuntanter».
VELLETRI NEL MEDIOEVO
182
episcopum Velitrensis3 ecclesie consentientem in hoc sibi cuncta congregatione presbiterorum atque servorum dei eiusdemque venerabilis episcopi et e diverso Demetrius eminentissimus consul et dux Meliosi quondam4 filio et cum domini auxilio suscipere debeat a suprascripto leone reverendissimo episcopo vel a cuncta congregatione eius … congregazione presbiterorum (sic) atque servorum dei eiu-sdem venerabilis episcopi sibi consentientibus sicut et su-scepit suprascriptus demetrius5 eminentissimus consul con-ductionis venerabilis episcopi. Idest monte uno in Integro in quo suprascriptus demetrius cum omni suo dispendio construere et allevare debet … gare6 populum nec non et foris ipso castello terra vacante in circuitu eius ubi aptum fuerit vineas cum arboribus pomorum. Item cum tuo ex-pendio pastinandum et allevandum ac solidandum cum subter dictis omnibus fundis et casalibus videlicet fundum qui vocatur … calvelli7, fundum bespoleti, fundum cosco-ni, fundum cesapresbiterum, fundum duo amanti, fun-dum soleluna, fundum forconi, fundum paganicum, fun-dum casale piscatorum, fundum gliõcni, fundum ancara-num, fundum scazzi, fundum paritorum, fundum cripte …, fundum formellum, fundum sancti thome apostoli, fundum cornarolum, fundum casale qui dicitur cesarea (sic), fundum sancti petri, fundum qui vocatur casale cer-qua revolosa, fundum orselli, fundum toranum, fundum
3 «Velitrensis q.’ episcopum», le due ultime parole sono cancellate,
l’una perché errata, l’altra perché ripetuta. 4 «quondam», voce abbreviata che potrebbe significare anche «qui-
dem». 5 Fu scritto «dometrius» e si corresse l’errore ponendo una e sulla o. 6 La pergamena è guasta; il Borgia lesse «debet ac aggregare popu-
lum». 7 «Monte calvelli»; Borgia.
ALCUNI CENNI DI TOPOGRAFIA MEDIEVALE
183
gizzi, fundum bassetii8 fundum carcanum, fundum sambu-ci, fundum revoli, fundum (v)alle scura, fundum lociolu, fundum papazzano, fundum sancti stephani, fundum pul-lanum, vel si quibus aliis vocalibus nuncupantur cum terris sationalibus, campis, pratis9 [pascuis, silvis, saltis, arboribus pomiferis vel infructiferis diversi generis et fontibus, rivis aque perenni. Parietibus antiquis adtiguis adiuntis, adiacen-tibusque seu edificiis et montibus, vallibus, planitiis, atque scorpetis, cultum et incultum, vacuum et plenum, cum omnibus a suprascript … e cum fundis et vocaboli supra-scriptis sicut per terminos designantur generaliter et in in-tegro pertinentibus] positum in territorio vellet. Miliaro ab urbe roma plus minus XXXmo et inter affines cuius esse de-signant. Incipiente a monte qui vocatur de episcopo sicut discendi (mensa?) latronis et vadit in aquam q. de erbellonis et ducit in cesa rainerij et vadit in g(i)zzi et remeante in fos-sato maiore usque fontali terra et de ipsa fontana I .. erañ10 sicut vadit ad ecclesiam sancti andree apostoli que vocatur in silice (deinde) vadit in campo mosevo, recte in plagoro de scazzi et vadit in fossato salginano, qui aqua viva ducit et deinde vadit in plagaro carano et pergit in stuti (sic) et re-meante per silicem et venit in ponte qui dicitur bolagai et exinde per foss(atum et) vadit in pontem mainelli et deinde ducit in viam que dicitur caiano (sic) et inde veniente per celium montem usque in suprascripto monte de episcopo et
8 Forse «bassetii» piuttosto che «bassetu»; ad ogni modo non è «fos-
setum» come nel Borgia. 9 «pratis etc. positum»; Borgia. 10 Il copista ha letto nel documento originale in due modi diversi
il nome della stessa fontana; la prima volta si emendi «fonta(na) literra (?); la seconda volta pare fosse scritto literañ o laterañ».
VELLETRI NEL MEDIOEVO
184
pergit in suprascripta mensa?11 latronis, unde in primis fi-nibus incip. Excepto insula una in integro in qua si(ta ec-clesia) est que in honore sancti Christi martiris clementis edificate esse videtur [cum12 campis et vineis et terris, infra habentem cum finibus et terminis suis que ad me vel ad meos successores detinemus op? in perpetuum et cum om-nibus a suprascripta insula una in integro … nes13 et termi-nos designantur et concluduntur generaliter et in integro pertinentibus pos [sic] in territorio ipso velitren. et inter af-fines ad totam insulam. Incipientes a silice antiqua sicuti pergit ad pontem sancti Stephani et ducit in fossatum maiorem et pergit in aquam vivam et circumdat … me14 et vadit subtus in cerqua revaliosa et venit in via que pergit ad sanctum petrum et ducit se in fossatum maiorem ad castel-lum muzzum et sicuti venit in predicta silice antiqua omnia iuris suprascripto episcopo venerabili ita ut suo studio suo-que …15 suprascriptus demetrius eminentissimus consul iam dicto monte uno integro cum fundis et vocabulis suis cum omnibus eorum pertinentiis, vineis, arboribus, pomarum, pastinare et allevare sive16 in omni restaurare et solidare atque tali … o17 tenere et possidere debeant et in ominibus ut supra legitur erigentes laborantes et solidantes ad melio-rem faciendum deo iubante cultum perducas. Ipse supras-
11 Pare «mensa» piuttosto che «fossa»; ho perciò più sopra supplito così, ma col punto interrogativo perché la parola «fossa» si adatta meglio al senso.
12 «videtur etc. Quod»; Borgia. 13 «(fi)nes»? 14 «(proxi)me»? 15 Tracce evanide che paiono della parola «labore» piuttosto che
della voce «dispendio», che ha il Borgia, che già si è avuta in questo do-cumento e che sarebbe più esatta.
16 Nella pergamena: «Sñe». 17 «(mod)o».
ALCUNI CENNI DI TOPOGRAFIA MEDIEVALE
185
criptus heredesque sui per futurum usque in tertium gra-dum tertiam heredem tertiam generationem …18 hoc est ip-se suprascriptus, filii, nepotesque sui, ex filiis legitime pro-creatis]. Quod si autem in ipso predicto monte per quamli-bet occupationem castellum factum non fuerit et populus ibi non habitaverit vel vineas et arbores pastinantes et alle-vantes non fuerint, atque suprascriptis fundis omnibus19 cultis restaurati non fuerint, tunc carta ista quam a nomine tuo factam habeo, inanem et vacuam absque omni robore firmitatis existens, et tunc suprascriptis omnibus in integro sicut supra leguntur a suprascriptis episcopis modis omni-bus revertantur et si autem omnia solidata que re superius leguntur et restaurata fuerint sicut suprascriptus demetrius profitetur haveant ut supra dictum est ipso suprascripto minibus suis … ut20 inferius continetur, hoc est ut nullus extraneus ex eadem proprietate qui quolibet argumento alienare potestatem non habeant vel concedi absque con-sensu episcopi sed rem per ipsum suprascripto minibus suis detineant. Pro quibus namque suprascriptum castellum postquam constructum fuerit atque vinea, et arbores pomo-rum pastinantes et per omnia suprascripti loci restaurati et laborati fuerint, et in omnibus meliorati, tunc ipso castel-lum sive de placitu aut de stricto sive cum21 dominatu suo seu de vino qui de ea vinea exierit, vino mundo et aquato in quatuor dividantur partes, tres vero partes ad vos quate-nus laboratores tolli debeatis, una ad nos quatenus domina-tione tolli debeo, et de glandatico, de silvis, de ex omni porcos decem unum, et de ex omni pecora decem una, ut illa cum omnia quarta quam de terris rationali iure et legali-
18 È incerto se manca una parola. 19 «omnibus» aggiunto dalla medesima mano. 20 «(sic)ut». 21 «cum» aggiunto dalla medesima mano.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
186
ter exierit, vel ab eisdem populis de placitis acquirere po-tuerint, et que de fructibus dominus donaverit, omnia in-simul per medium dividamus et de ipsa tua medietate de eodem castello in suprascripto episcopo per singulos annos pensionem inferri debeã absque omni mora tritici modia XXX et bovem obtimum22 [ et si quid absit ipsi heredesque ipsorum aliquam calumpnia, vel minuationem ex eisdem partibus suprascripto episcopo suisque successoribus suique (sic) fecerint, aut qualiter tribuere noluerint, tunc de suis facultatibus in suprascripto episcopo componi debeat pe-nam ut inferius continetur, et ipsum namque dictum castel-lum licentiam habeas tu quidem demetrius per medium di-vidi, et qualem partem a me quatenus dominatore in om-nibus placuerit talem23 a te et omnibus recipiam (sic) tuis heredibus recipiam. Aliam vero medietatem de eodem cas-tello que ad te evenit, simul cum vineis et terris silvis fundis et casalibus, cum omnibus eorum pertinentiis tu laborationis habeas, teneas, possideas in tua tuisque heredibus et succes-soribus sit potestatem. In tam repromitto atque specialiter spopondeo, ut si in aliquo tempore ego quidem demetrius vel meos successores presumpserit vel heredes …24 leoni episcopus vel ad tuos successores de suprascripta medietate de suprascripto castellum postquam divisum fuerit, cum ominibus eorum pertinentiis, quam a te evenit aliquam mo-lestiam temptationem exinde facere presumpserit …25 tuos homines qui in eadem terra habitaturi sunt, et dominio vindicandi aut aliqua submittente persona magna vel parva quam ego conducam, et de tua medietate perdat de predic-
22 «obtimum etc de qua re»; Borgia. 23 «tales», corretto indi: «talem». 24 «(tibi)». 25 «(vel)».
ALCUNI CENNI DI TOPOGRAFIA MEDIEVALE
187
to castello, tunc suprascriptam meam medietatem …26 me-morato castello cum omnibus suis pertinentiis statim sine omni mora vel contentione revertatur in tua tuisque succes-soribus, veniat potestate, et in suprascripto episcopo per-maneat27 in perpetuum. Completa vero tertia generatio-nem, ut supra legitur, tunc suprascripto monte ad castellum faciendum cum fundis casalibus suis, cum omnibus perti-nentiis, sicut fuerit culto et meliorato ad ius28 suprascripti episcopi, cuius et est proprietas modis omnibus revertatur ], de qua re et de quibus omnibus suprascripta veroque partes iuratus dico per deum omnipotentem sancteque sedis apo-stolice seu salutem viri beatissimi et apostolici dñi Marini sanctissimi iunioris pape29 hec omnia que huius emphiteo-sin cartula series eius eloquitur inviolabiliter conservare et adimplere promitto. [Quod30 si quisquam eorum huius car-tule placiti conventionisque seriem in toto partemve eius quolibet modo venire temptaverit, tunc non solum periurii reatum incurram, verum etiam daturos se suprascriptore-sque suos promittunt, pars parti fidem reservante31, ante omne litis initium pene nomine auri librarum sex obrizi, et post penam absolutionis manentem, hanc emphiteosin car-tule seriem in sua nichilominus maneat firmitate. Has au-tem duas uniformes uno tenore conscriptis per manus ste-phani scriniarii et tabellionis urbis rome scribendam pariter dictaverant (sic)32 easque propriis roborantes, testibus a se
26 «(de)». 27 Qui fu ripetuto «potestate» e quindi cancellato. 28 Così interpreto una parola scorretta e male emendata nella per-
gamena. 29 «ppi» nella pergamena, lo scrittore essendosi confuso con «epi». 30 «promitto etc. Actum»; Borgia. 31 Qui è la parola «contra», cancellata. 32 Seguiva la parola «ab», indi cancellata.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
188
rogatis obtulerunt scribendam, et suprascripti in invicem tradiderunt sub stipulationem et sponsionem sollempniter interposita].
Actum Rome die anno pontificatus I.M.33 Indictione suprascripta VI. † Ego Leo indignus episcopus sancte vellit34 ecclesie huius cartule placiti conventionisque de suprascrip-to monte uno ad in integro35 castellum faciendum, cum fundis et casalibus suis cum omnibus suis pertinentiis facta a me leone episcopo in demetrius consul et dux sicut supra-scriptum legitur manu propria subscribsi, et teste (sic) qui subscripserunt rogavi36. † [Aluini pbr huic ecclesie placiti conventionisque de suprascripto castello monte uno ad in (sic) integro ad castellum faciendum cum fundis et casalibus suis cum omnibus suis pertinentiis facta a nobis in deme-trius consul et dux consensi et subscripsi † Sixtus indignus pbr venerabilis episcopi huic ecclesie placiti conventionisque de suprascripto monte uno in integro ad castellum facien-dum cum fundis et casalibus suis cum omnibus suis perti-nentiis facta a nobis (in) demetrius consul et dux sicut supra legitur, manu mea scripsi et consensi † Theophilattus pbr. venerabilis episcopi, huic ecclesie conventionis placitique de suprascripto monte uno ad (sic) in integro ad castellum fa-ciendum cum fundis et casalibus suis cum omnibus suis per-tinentiis facta a nobis in demetrius consul et dux sicut supra legitur manu mea scripsi et consensi. † Leone dõ37 amabil. secundicerius sancte sedis apostolice huic cartule placiti
33 «I(n) M(ense)». 34 Segue «episcopo», poi cancellato. 35 «ad in integro» per «i. i. ad», cancellata indi la prima parola. 36 «rogavi etc.»; Borgia. 37 Leggo «Leone deo amabilis» sull’esempio, per non citarne altri,
del «Gregorius Deo amabilis» di un documento in circa [così] contem-poraneo, D’Achery, Spicileg. II, 504.
ALCUNI CENNI DI TOPOGRAFIA MEDIEVALE
189
conventionisque de suprascripto monte uno in integro ad castellum faciendum cum fundis et casalibus suis et cum omnibus suis pertinentiis facta a leone episcopo in deme-trium consul et dux sicut supra legitur rogatus ab eo testis scripsi et istas cartulas sibi in invicem tradente vidi † Petrus in dei nomine consul et dux huic ecclesie placiti conven-tionisque de suprascripto monte uno in integro ad castel-lum faciendum cum fundis et casalibus suis et cum omni-bus suis pertinentiis facta a leone episcopo in demetrium consul et dux sicut supra legitur rogatus ab eo testis sub-scripsi et hac cartulas in invicem tradiderunt. † Romanus in dei nomine in hac cartula placiti conventionisque de supra-scripto monte uno in integro ad castellum faciendum cum fundis et casalibus suis et cum omnibus suis pertinentiis facta a leone episcopo sancte velit. (sic) in demetrius et con-sul et dux sicut superius legitur rogatus ab eo testis sub-scripsi et istas cartulas in invicem tradentes vidi.
Ego Stephanus scriniarius et tabellio urbis rome qui supra scriptor hanc cartulam emphiteosim post testium subscriptionis factam complevi et absolvi.]
I due sottoscrittori, Pietro e Romano, erano entrambi
consul et dux anche se il secondo non è espressamente no-minato come tale. I due personaggi, che risultano quasi anonimi nell’attività politica e sociale di Roma nella prima metà del secolo X, risultano già presenti come testimoni in una vendita del 936 a favore dell’abbazia sublacense insie-me con Nicola, Baduaro e Leone, tutti qualificati come con-sul et dux54. I due personaggi potevano forse essere legati in qualche modo a Demetrio, e probabilmente erano più an-
54 Reg. Subl., n. 43, pp. 83-85.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
190
ziani di lui55, ma come avverte Chris Wickham nel suo ul-timo lavoro su Roma, questi nomi accompagnati da titoli generici non possono essere usati in alcun modo per co-struire genealogie56.
55 Due personaggi identificati come Romanus e Leo consul et dux ri-
sultano già presenti come sottoscrittori in un documento del 913 (Reg. Subl., n. 115, pp. 162-163), lo stesso che vide protagonista Iohannes emi-nentissimus consul et dux, presunto padre di Demetrio di Melioso (v. supra pp. 33-34, n. 39).
56 WICKHAM, Roma medievale, cit., p. 236.
GLI EBREI Il quadro delle conoscenze sulla presenza ebraica nella
provincia di Marittima nel corso del Medioevo è oggi suffi-cientemente delineato, per merito delle numerose e pun-tuali indagini ad esse dedicate1. Il contributo sviluppato in queste pagine è quindi limitato a mettere in rilievo alcuni aspetti legati all’insediamento veliterno2.
Il primo stanziamento ebraico in Velletri dovrebbe risa-
lire almeno alla prima metà del XIV secolo, poiché nel 1363, quando il Consiglio generale di Velletri per fare fron-te al dissesto finanziario deputò quattro boni homines a prendere in prestito denaro dagli Ebrei, questa comunità era già qualificata come Iudaicha universitas Velletri ed era
1 Cito per tutti: R. PADOVANO (a cura di), La presenza ebraica a
Roma e nel Lazio. Dalle origini al ghetto, Padova 2009, con contributi di D. PACCHIANI, A. ESPOSITO, U. LONGO e S. DI NEPI con relativa bi-bliografia, e Gli Ebrei e il Lazio (secoli XV-XVII), Archivi e Cultura, XL (2007), Roma 2008 che raccoglie gli interventi presentati al seminario: La presenza ebraica nel Lazio: fonti e studi, organizzato dal Laboratorio di storia economica regionale dell’Università di Cassino e dall’Archivio della Comunità ebraica di Roma l’11 giugno 2008.
2 Ad oggi il più completo resoconto sugli ebrei veliterni si deve alle ricerche di M.T. CACIORGNA tra cui: Un’attiva minoranza: gli ebrei, in EADEM, Marittima Medievale, cit., pp. 115-153.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
192
rappresentata dai sacerdotes Sammato dello Schiavo e Bento-rello magistri Benedetto. In considerazione di questo fatto e della situazione politica papale nei confronti dei giudei3, è ipotizzabile che proprio in quel periodo abbia avuto inizio quello che sarebbe diventato un consistente insediamento ebraico nella decarcia di Portella, nella zona compresa tra via della Stamperia e della Trinità, dove Pavoncello ritenne impropriamente di aver individuato la sinagoga per via del rosone a forma di stella di David4, ma che in realtà appar-teneva alla piccola chiesa della Trinità5. D’altronde, non si hanno esempi di manifestazioni artistiche ebraiche che in-cludano la stella di David6. Il diritto degli ebrei ‘a fare sina-
3 Nel 1348 Clemente VI, nella sua Bolla Quamvis perfidiam, aveva
sollecitato la protezione degli ebrei contro le accuse di essere responsa-bili della peste nera mediante l’avvelenamento dei pozzi. Gli ebrei in-crementarono così il loro insediamento nelle terre del papato. Molti in quel periodo lasciarono l’Urbe e diedero luogo ad una più robusta cor-rente migratoria di prestatori di denaro su pegno che, attraverso tappe e stanziamenti in varie città e località minori del Lazio, dell’Umbria, della Toscana, delle Marche e dell’Emilia Romagna, raggiunse verso la fine del XIV secolo gli estremi lembi settentrionali della Penisola.
4 N. PAVONCELLO, Le Comunità ebraiche prima del bando di Pio V, in «Lunario Romano», IX, 1980, p. 77. Una tesi peraltro recentemen-te ribadita (L. GALIETI, La presenza ebraica a Civita Lavinia, Velletri 2004, p. 37).
5 La chiesa, antica e piccola e, come ricordato dal Theuli, giuspa-tronato della famiglia Landi per eredità dalla famiglia Gori (THEULI, Teatro Historico, Velletri, cit., p. 343), presentava già dalla visita pastora-le del 1595, compiuta dall’uditore Ludovico Boldo, la presenza di una finestra orbicolare que est super altari (Archivio Capitolare Velletri (ACV), Sez.I, tit. I, Visita Alfonso Gesualdo, c. 82r). L’appartenenza alla famiglia Gori potrebbe forse far risalire la sua costruzione al XIV secolo al tempo del maiore Nardo di Gorio.
6 D. PACCHIANI, Le origini della presenza ebraica a Roma e nel Lazio, in PADOVANO, La presenza ebraica, cit., pp. 72-84.
GLI EBREI
193
goga’ era inoltre limitato dal fatto che l’edificio scelto come casa di preghiera doveva avere un aspetto modesto e sem-plice, in tutto simile nella facciata esterna agli edifici circo-stanti7.
Nei centri della Marittima le abitazioni degli ebrei ri-sultano spesso concentrate nei quartieri della Portella, Pu-sterula: Velletri, Sermoneta, Terracina, Priverno. Situazione riscontrabile anche al di fuori dei confini della provincia. Ad Urbino ad esempio gli ebrei vivevano nella Quadra di Pusterla. A Cori la comunità ebraica risulta insediata nel XVI secolo nel terziere di Porta Ninfina nelle zone Colum-narum, Plagiarum e Ultima, ma ad oggi non conosciamo l’esatta ubicazione della Portella corese, sicuramente esisten-te nel Medioevo. Tra i possedimenti comunali8 del 1401 erano infatti elencati omnia montanaria9 que sunt extra muros ... in contrada Posterule et vadit ... ad Porta Montis in contrada Pistincole. Non sappiamo però se ciò fosse dovuto a precise disposizioni emanate dalle autorità comunali.
Un apparente patronimico ebraico è presente negli atti del comune di Velletri già nel 1346 in una sentenza che aveva visto la condanna alla mordacchia di Grasso macella-rius per aver presentato in giudizio, al fine di testimoniare il falso, un certo Iuvene Cole Salomonis contro magister Luca
7 A. TOAFF, Il vino e la carne. Una comunità ebraica nel Medioevo, Il
Mulino, Bologna 1989, p. 110. 8 P.L. DE ROSSI, E. DI MEO (a cura di), Il Catastum bonorum di Cori
(1668-1696). Con un inventario dei beni comunali (1401), «Quaderni del-l’Archivio Storico», 2, Cori 2009, p. 198.
9 Il termine sembrerebbe indicare grossi blocchi di pietra. Nome da cui deriverebbe il vocabolo montano inteso come frantoio, che all’epoca era appunto formato da due grandi blocchi di pietra usati co-me macine.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
194
Landolfi10. In ogni modo Iovine non è identificato come ebreo ed è effettivamente cittadino veliterno, essendo citato in un altro atto come “massaro de Velletro”11. Nel marzo del 1367 Salomone, Sagazzolo, Ventura domini dello Schiavo, suo fratello Sammato e Lenzo, chiaramente indicati come iudei, sono inclusi nell'elenco della riaffida generale pro-nunciata dal senatore di Roma Bindo de’ Bardi in una lista di oltre trenta persone, omnes de civitate Velletri, dove erano presenti, oltre lo stesso Iovine, cittadini di ogni estrazione sociale: giudici, notai, domini e allevatori di bestiame12. Il gruppo di persone era accusato in solido di aver derubato Lorenzo detto Grievolo, della regione Ripa della somma di trecento fiorini d’oro, che avevano poi diviso, tra loro, e di averlo tenuto carcerato. Una situazione che lascia trasparire l’alto grado di integrazione della comunità ebraica, pur con-siderando la contingente situazione storica che faceva regi-strare in quel momento il punto più aspro della lotta tra Roma e Velletri.
Il prestito ottenuto dalla Comunità veliterna nel 1363 era stato approvato in deroga agli statuti comunali che, prima di questa data, proibivano espressamente che i rap-porti tra cristiani e giudei potessero essere di natura usu-raia13. Le poche tracce a nostra disposizione tenderebbero quanto meno a confermare che prima di questo periodo gli ebrei non esercitavano l’usura nel Comune veliterno. Da
10 FALCO, Il Comune, cit., 37 (1914), appendice, pp. 531-533. La
sentenza fu in verità eseguita per restituire la “buona fama” agli imputa-ti, in deroga agli statuti comunali, poiché, secondo quanto in essi stabi-lito, quicumque fuerit condempnatus de falso vel de mordacha quod in perpe-tuum non possint habere offitium in civitate Velletri.
11 Ivi, p. 589. 12 Ivi, p. 625. 13 FALCO, Il Comune, cit., 37 (1914), appendice, pp. 585-587.
GLI EBREI
195
un documento già conservato presso l’archivio vescovile di Velletri, datato 7 marzo 1250, sappiamo infatti che Inno-cenzo IV, da Lione dove si trovava per il Concilio, avendo appreso che certi Giordano Leno e suo figlio Alessio di Roma cercavano di estorcere denaro al comune di Velletri, dava mandato al cardinale vicario di costringere i due a de-sistere dal richiedere interessi illeciti pena la scomunica ri-servata agli usurai stabilita nel Concilio lateranense del 113914. Il prestito ad interesse doveva essere dunque una pratica messa in atto dagli stessi cittadini se il pontefice, at-traverso la bolla inviata da Assisi il 16 ottobre 1253, favori-va la costruzione del convento di San Francesco destinando allo scopo le usure e le cose male acquistate15. In pieno Duecento in ogni caso gli Ebrei non dovevano ancora esser-si insediati nei centri della provincia. Sembrerebbe al con-trario evidente che il ricorso a prestiti da parte del Comune di Velletri fosse regolato da specifici capitoli dello statuto cittadino. Quello ottenuto dalla comunità ebraica infatti venne concluso secundum formam statuti dicti communis – et hoc non ostante quocumque statuto et specialiter statuto Commu-nis Velletri quo cavetur instrumenta concepta in christianos et iu-deos esse usuraria –, che delegava ai Nove boni homines la fa-coltà di accedere ai mutui per conto del Comune, preve-dendo allo stesso tempo che gli stessi ufficiali dovevano provvedere alla loro estinzione nel tempo del loro ufficio. Il
14 FALCO, Il Comune, cit., 36 (1913), p. 447; Gabrielli riporta la da-
ta del 1249 (A. GABRIELLI, Alcuni capitoli del 1547 per un banco di prestito a pegno tenuto dagli ebrei in Velletri, Velletri 1917, p. 8). La pergamena, già indicata da Falco come alquanto guasta e da Gabrielli come lacera in qualche parte, non risulta nell’attuale inventario dell’archivio capito-lare di Velletri.
15 B. THEULI, Il Convento di S. Francesco in Velletri, in «Apparato Minoritico della provincia di Roma», 1648, p. 441.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
196
fatto che il divieto di rivolgersi all’attività feneratizia ebraica fosse codificato presupporrebbe che in precedenza la co-munità poteva avervi fatto ricorso o che comunque si era posta il problema, proibendone l’esercizio tout court al con-trario di altri centri del Patrimonio, a nord di Roma, dove il prestito ebraico era invece regolato e documentato. In con-siderazione delle vicende storiche legate al comune di Velle-tri del XIII secolo, che portarono all’istituzione del governo podestarile, e dei rapporti all’interno della provincia, è an-che possibile ritenere che il riferimento a quocumque statu-tum può essere stato il riflesso una medesima situazione nei centri comunali della Marittima. Risulta così evidente l’assenza, all’interno della comunità veliterna, di prestatori ebrei che abbiano svolto l’attività feneratizia fino al 1363. Allora il comune, in un momento di evidente difficoltà economica, derivata dal conflitto con Roma che si pro-traeva oramai da oltre un decennio, ottenne il denaro non da banchieri ebrei preposti a tale attività, ma dalla comu-nità ebraica in quanto tale. La lunga lotta con il comune di Roma aveva indubbiamente svuotato le casse comunali. Se nel 1357 il comune di Velletri aveva potuto fare fronte alla riaffida generale pronunciata dal senatore Niccolò di Riccardo Annibaldi – che imponeva a Velletri il risarci-mento dovuto a seguito delle uccisioni, furti e razzie ai danni di cittadini romani16 – non così fu possibile per la riaffida del 1362 pronunciata dal senatore Lazzaro dei Cancellieri, per ottemperare alla quale fu preso in prestito il denaro dagli ebrei: quo ad dictam partem tantumodo, ut premittitur, liberare pro pecuniarum quantitatibus in quibus cum eis duxerint componendum ac etiam paciscendum et diffita-
16 FALCO, Il Comune, cit., 37 (1914), appendice, p. 550-561.
GLI EBREI
197
tos reaffidare et in pacem communis Velletri reducere17. La som-ma da restituire agli ebrei, comprensiva degli interessi, fu a sua volta recuperata tramite la riaffida operata dai quattro boni homines nei confronti dei colpevoli di omicidio, adulte-rio, deturpazione del viso, falso e di ogni altro reato, colpa, delitto e danno dato, in deroga agli statuti comunali che proibivano ai boni homines la riaffida dei colpevoli che non avessero scontato interamente la loro pena18.
Abbiamo visto che prima di questo periodo in caso di necessità, almeno dalla metà del XIII secolo, il Comune fa-ceva ricorso a mutui finanziati da privati cittadini ai quali veniva poi restituito il denaro senza corresponsione di alcun interesse (i Leno e altri cittadini romani avevano prestato inizialmente “pecunie summa a comuni Velletrensi pretextu mu-tui sine usuris”). Non è chiaro in ogni modo quali fossero i possibili benefici, fiscali o di altra natura, a vantaggio dei finanziatori. Ancora nel 1346 è documentata la parziale mancata restituzione di un mutuo da parte del Comune per la somma di nove fiorini nei confronti di altrettanti cittadi-ni19. Denaro che era stato raccolto e consegnato al cardinale di Velletri “pro revocatione interdicti positi in civitate Velletri”20.
Sul finire di questo secolo in ogni modo gli ebrei risul-tano essersi ben integrati nella società veliterna. Nel 1380 il trattato di pace tra il comune di Velletri e il conte Onorato Caetani, in quel periodo rettore di Campagna e Marittima, includeva una clausola che permetteva ai cittadini velletrani e agli ebrei ivi abitanti di passare e andare per tutte le terre, anche quelle nemiche. Sul finire del XIV secolo Bonifacio
17 Ivi, p. 587. 18 Ivi, p. 594. 19 Ivi, p. 501: “florenis mutuati dicto comuni per homines de Velletro,
quorum florenorum restitutio facta non fuit”. 20 Ivi, p. 281.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
198
IX esentò gli ebrei di Velletri e della provincia da dazi e col-lette. Agli inizi del Quattrocento gli ebrei erano così già da tempo identificati come “giudei di Velletri”, a conferma della loro integrazione nel tessuto sociale cittadino. Una si-tuazione probabilmente comune agli altri centri della pro-vincia. A Cori la presenza ebraica è documentata dal 1359, quando un certo Dattolo di Manuele è designato come iu-deus de Cora21. Sporadiche attestazioni – di ebrei mai identi-ficati con il toponimico della città di provenienza – sembre-rebbero non sufficienti a suffragare la presenza di comunità ebraiche nella provincia di Marittima nella prima metà del XIII secolo. A Terracina la prima attestazione è ancora della prima metà del Trecento, periodo in cui venne assunto co-me insegnante della comunità locale Mosè Remos di Maiorca22. Un ricorrente stanziamento temporale di fine XIII e inizio XVI secolo troverebbe conferma sia nella situa-zione di Sermoneta, dove esisteva una sinagoga di XIII-XIV secolo23, che in quella di Ninfa. Nel 1298, nel momento del passaggio del castrum ninfense dai Colonna ai Caetani, Agapito del fu Giovanni Colonna si recò a Ninfa per la sanzione in cui comune et homines dicte terre erano incorsi per non aver rispettato una sentenza da lui emanata a risolu-zione di una controversia insorta tra lo stesso comune e al-cuni ebrei de Urbe abitanti del castello24. L’ipotesi è indiret-
21 G. PESIRI, La presenza agostiniana a Cori nelle “Notitie” di padre
Tommaso Bonasoli, in «Annali del Lazio meridionale», 2 (2005), pp. 39-40. 22 PAVONCELLO, Le comunità ebraiche laziali, cit., pp. 59-60. Maria
Teresa Caciorgna ipotizza cautamente una presenza anteriore (CA-
CIORGNA, Gli ebrei di Campagna e Marittima tra Quattrocento e Cinquecen-to, in Gli Ebrei e il Lazio, cit. p. 37).
23 PACCHIANI, Le origini, cit., p. 57. 24 A. CORTONESI, Ninfa e i Caetani: affermazione della signoria e as-
setto del territorio (secoli XIII-XIV), in Ninfa, una città, un giardino, «Atti del
GLI EBREI
199
tamente confermata dalla situazione di Orte, dove ai giudei era peraltro consentito di svolgere l’attività del prestito ad usura. Nel 1312, Pietro di Gianni Grasso di Orte riceveva un mutuo da Musetto di Abramo de Urbe, habitator nunc ci-vitate ortana, mentre nel 1349 l’ebreo Manuele si definiva judeus de Orto, tam ut filius et heres Leoni Musecti. È evidente dunque che agli inizi del secolo Musetto de Urbe si era tra-sferito ad Orte per esercitare l’usura, attività continuata poi dal figlio Leone e dal nipote Manuele25. Ad Anagni all’ini-zio del Trecento gli ebrei risultano godere degli stessi diritti dei cittadini ernici. Nel 1332 l’ebreo Manuel è indicato come iudeus civis Anagninus, filius et haeres quondam Sabati26. Situazione essenzialmente confermata anche dall'insedia-mento ebraico di Tivoli, dove la presenza di una delle co-munità ebraiche più consistenti del Lazio è documentata a cavaliere dei secoli XIII e XIV27.
Parafrasando Ariel Toaff potremmo essere non troppo lontani dal vero nel fissare alla fine del Duecento l’arrivo degli ebrei in quasi tutte le località del Lazio, dove rimar-ranno attivi nei secoli successivi fino alla loro espulsione28. Questo quadro di insediamento degli ebrei nella provincia
Colloquio della Fondazione Camillo Caetani. Roma, Sermoneta, Ninfa 7-9 ottobre 1988», Roma 1990, p. 72 e p. 88 n. 64.
25 A. LUZZATTO, Note sulla presenza ebraica a Orte tra i secoli XIII e XIV, Quaderni dell’Accademia dei signori disuniti della città di Orte, 7, 1993, pp. 27-32; A. ESPOSITO, La presenza ebraica in una regione pontificia nel tardo Medioevo: il Patrimonio di S. Pietro in Tuscia e Viterbo, in «Italia Judaica», Gli ebrei nello Stato pontificio fino al Ghetto (1555), «Pubblicazio-ne degli Archivi di Stato» (47), Roma 1998, p. 188.
26 Archivio Capitolare di Anagni, Perg. 48, citato in A. ESPOSITO, Gli ebrei della regione di Campagna alla fine del Medioevo: prime indagini, in «Latium», 7 (1990), p. 58.
27 CAROCCI, Tivoli nel basso medioevo, cit., pp. 326-328. 28 TOAFF, Il vino e la carne, cit., p. 289.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
200
romana nel corso della seconda metà del secolo XIII sem-brerebbe legato dunque allo sviluppo del sistema podestari-le e al contingente periodo di espansione economica. Si mo-stra evidente, in questo processo, il ruolo della comunità ebraica romana – che già nella seconda metà del XII secolo contava duecento famiglie ed era trattata con grande rispet-to –, connesso ad una espansione verso l’esterno della città di Roma29. La comunità romana fu legata, durante questo periodo, alla curia pontificia e dunque l’emigrazione sem-brerebbe prendere forma nell’ottica di una politica papale tesa a rinsaldare i vincoli di dipendenza delle città subordi-nate al suo dominio. Nuclei di famiglie ebraiche romane si trasferirono così in diversi centri del Patrimonio allora sotto la diretta giurisdizione papale, in forte trasformazione socia-le ed economica, e in alcuni dei castra, dominio di nobili famiglie romane. Una migrazione che si sarebbe rafforzata nel corso della vacanza Avignonese, perdurando la scarsità di moneta circolante. Gli ebrei avrebbero potuto infatti an-ticipare ai vari Comuni e Signori il denaro necessario per le loro iniziative e al tempo stesso animare i loro traffici. Un fenomeno questo apparentemente assente nei centri della provincia di Marittima avanti la prima metà del Trecento.
Molto attivo a Velletri come prestatore banchiere risul-
ta essere nell’ultimo decennio del XIV secolo Angelo dello Schiavo, che acquista una casa in via Portella per il prezzo di 38 libbre da Amico di Biagio di Amico da Velletri, al quale tre giorni prima, il 28 ottobre 1393, aveva rimesso una quietanza per la somma di 44 fiorini30. Un’attività eser-
29 S. SIMONSOHN, The Jews in the Papal States to the Ghetto, in «Italia Judaica», cit., p. 13.
30 Archivio Notarile di Velletri (ANV), Protocolli Notarili, vol. 1 (olim 3), c. 66, notaio Crispinus Guidonus.
GLI EBREI
201
citata attivamente anche da Angelo di Ventura e proseguita poi dal figlio Ventura almeno fino al 1432. Oltre all’attività feneratizia – non mancarono attività di mutuo tra gli stessi giudei –, gli ebrei veliterni si inserirono ottimamente nel tessuto sociale cittadino svolgendo le varie attività loro con-cesse. Nel 1393 Sagazzolo di Manuele giudeo è presente in due atti dell’archivio notarile. Il primo si riferisce ad un contratto di soccida relativo ad un somaro dato a Giovanni di Giuratto di Meo, mentre il secondo registra la quietanza, relativa ad alcuni mutui, concessi dallo stesso ebreo ad An-drea di Giannettola31. Nel 1426 il consiglio concedeva Emanueli, magistri Menaguzoli, Iudeo, Phisico, di poter eserci-tare l’attività di medico anche con i cristiani32. Già all’inizio del secolo alcuni ebrei avevano cominciato a muoversi da Velletri, tanto da essere identificati con il nome della città come tale Dattero figlio di Manuello da Velletri che nel 1414 risulta sposato a Cortona con Flora figlia di Aleuccio da Montalto di Castro33. La famiglia di Boncore da Anagni, trasferitasi a Velletri probabilmente all’inizio del secolo, ri-sulta dedita a varie attività. Ventura di Boncore commercia in vino, mentre Manuele di Boncore lavora nel settore dei panni. Il primo nell’ottobre del 1429 chiese un mese di tempo per adempiere al pagamento di 24 libbre di provesi-ni del Senato quale prezzo di una partita di vino greco34, il
31 ANV, Protocolli Notarili, vol. 1 (olim 3), c. 49 e c. 71, notaio Cri-
spinus Guidonus. 32 S. SIMONSOHN, The Apostolic See and the Jews. Documents, Ponti-
fical Institute of Mediaeval Studies, Toronto 1990 , p. 742, n. 638. 33 M. BOTTICINI, New evidence on Jews in Tuscany, in Mercanti e
banchieri ebrei, Zakhor, in Rivista di storia degli ebrei d’Italia, I, Roma 1997, p. 89.
34 ANV, Protocolli Notarili, Vol. 8 (olim 11), c. 106, notaio Ludovi-cus Iacobi Seraphii.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
202
secondo nel 1433 si impegnò a fornire stoffe di ottima qua-lità a Biagio di Cola di Nardo, dal quale aveva ricevuto prima la somma di 30 ducati d’oro veneziani e poi una più cospicua somma di ottanta ducati35. Gli ebrei evidentemen-te erano ben accolti e accettati. La loro attività di prestito ri-sultava essenziale nell’ambito dell’economia cittadina e ri-mase preminente fino alla metà del secolo quando, miglio-rate sensibilmente le generali condizioni della popolazione, alcuni prestatori ebrei cominciarono a lasciare Velletri con-tinuando il flusso della loro espansione verso settentrione. Sotto il pontificato di Eugenio IV (1431-1447) Velletri rag-giunse la sua massima espansione politica ed economica36. Il flusso della numerosa popolazione proveniente dal castel-lo di Lariano (1433) portò evidentemente ad una fase eco-nomica espansiva dovuta all’afflusso in città di nuove risor-se, ma anche e soprattutto per il conseguente sviluppo ur-banistico che diede origine alle nuove decarcie di S. Maria in Trivio e di Santa Lucia. Questa nuova situazione costrin-se molti ebrei a convertire i propri esercizi, fatto che portò loro stessi, con una apparentemente sorprendente inversio-ne di tendenza, a chiedere prestiti ai cristiani per le loro at-tività commerciali. Intorno agli anni quaranta del XV sec. troviamo a Vicenza Josep e suo padre Abramo da Velletri che inizialmente svolgono un ruolo di fattori nel banco di Arzignano, gestendo al contempo il banco vicentino di Ja-cob di Mosè37. Mosè (o Musetto) di Abramo da Velletri si
35 ANV, Protocolli Notarili, Vol. 6 (olim 12), c. 47 e c. 53, notaio
Ludovicus Iacobi Seraphii. 36 Mancinelli definì questo periodo una nuova età dell’oro: Eugeni
tempora lumen (MANCINELLI, Vitae sylva, Venezia 1492, v. 166). 37 R. SCURO, La presenza ebraica a Vicenza e nel suo territorio nel
Quattrocento, in Ebrei nella Terraferma veneta del Quattrocento, «Atti del Convegno di studio (Verona, 14 novembre 2003)», a cura di G. M. VA-
GLI EBREI
203
dedica invece alla pezzaria con Simone di Dattilo da Terra-cina. Tra i motivi di questo cambiamento va sicuramente annoverata anche la predicazione antiebraica ed antiusura-ria che in quel periodo aumentò in tutta l’Italia centro-settentrionale e che portò anche all’istituzione del Monte di pietà di Velletri38. Antonio Mancinelli nella sua opera auto-biografica racconta con orgoglio di come il padre allontanò i giudei che opprimevano i cittadini veliterni con le loro usure e fissò per legge il valore del tasso d’interesse attraver-so l’istituzione del Monte39. Un’azione morale, giusta e do-vuta, nella visione dell’umanista veliterno, che quando l’ebreo si recò a Roma per ottenere soddisfazione contro questa decisione venne colpito da maledizione divina e mo-rì (fulmine tactus obit). Il ricorso alla Camera Apostolica por-terebbe a ritenere che l’ebreo abbia potuto tenere una con-dotta di prestito ad usura, regolata da capitoli sottoscritti con lo stesso Comune, o quanto meno l’esercizio era ora-mai una prassi consolidata. Nel suo ricorso l’ebreo fu evi-dentemente appoggiato da una parte della stessa popolazio-ne veliterna, se è vero che Giovanni Mancinelli, allora uno dei Nove boni homines, fu costretto a convocare il Consiglio e ribadire con forza le ragioni del nuovo istituto per i presti-ti su pegno.
L’attività feneratizia degli ebrei veliterni risultava oltre modo regolata negli statuti comunali riformati nel 1439,
RAINI e R.C. MUELLER, in Quaderni di Reti Medievali, 5, Firenze 2005, pp. 106-108. Nel marzo del 1437 Josep viene definito quale “habitator in Arzignano et tenens ibi banchum imprestedi”.
38 Sulle vicende del Monte vedi: F. LAZZARI, Il Monte di Pietà di Velletri (1470-1940), «Quaderni della Biblioteca Comunale», 9, Velletri 2005.
39 MANCINELLI, Vitae sylva, ed. T. Testone, in LAZZARI (a cura di), Antonio Mancinelli, cit., pp. 36-37, vv. 59-62.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
204
mentre essa è assente in quelli del 1544, poiché l’erezione del Monte di pietà, avvenuta sicuramente prima del 1472, dovette portare alla graduale cessazione dei prestiti. Un ul-teriore segnale della mutata condizione economica dei pre-statori ebrei in pieno Quattrocento ci viene dal dimezza-mento della vigesima loro richiesta. Nel 1473 venne infatti riconosciuto che gli ebrei velletrani non avevano più entrate dall’attività feneratizia40. Circa un secolo più tardi, quando il Comune decise di concedere nuovamente un banco a prestatori ebrei, questi dovettero arrivare dai centri vicini41. Infatti, per far fronte alla difficile situazione economica e finanziaria il consiglio comunale concesse, nella seduta del 12 giugno del 1547, ai banchieri ebrei Simone di Benedetto da Civita, Beniamino de Melone da Marino, Mastro Elia di Benedetto da Montopoli e Salomone Abramo da Cori, in-sieme a numerosi privilegi, di istituire banchi di prestito a pegno in Velletri, a condizione che l’esercizio del mutuo ad usura fosse regolato da appositi capitoli approvati dal Car-dinale governatore. Traccia dei capitoli riguardanti la rego-lamentazione del prestito ebraico dopo il 1439 è rimasta in alcuni protocolli notarili42, mentre prima di questa data le modalità di prestito – che riguardavano mutui a tre, sei o dodici mesi – non erano sempre espresse e rimandavano ad un generico cum refectione dampnorum oppure pro quadruplo more hebreorum. Di fatto nel 1363, a fronte dei cento fiorini
40 Archivio di Stato di Roma (ASR), Camerale, I, Collectorie, b.
1223, allegato E, citato in CACIORGNA, Un’attiva minoranza: gli Ebrei, in EADEM, Marittima Medievale, cit., p. 131.
41 GABRIELLI, Alcuni capitoli, cit., p. 11. 42 Il riferimento ai capitoli degli statuti riguardanti il prestito
ebraico (in Statutis Velletrensibus loquentibus de iudeis mutuantibus) si trova in atti notarili del sesto decennio del Quattrocento (CACIORGNA, Un’attiva minoranza, cit., p. 130).
GLI EBREI
205
ricevuti dalla comunità ebraica, il Comune si impegnò a re-stituirne 132. Un tasso di interesse molto alto, in questo ca-so superiore al 30% annuo, che diminuì quando fu codifi-cato negli statuti comunali e ancor di più dopo l’istituzione del Monte di pietà. Al contrario esso risulta rimanere eleva-to negli altri centri della provincia. A Terracina agli inizi del Cinquecento era ancora nell'ordine del 40%, quando al prestito accedevano indistintamente aristocratici, gente co-mune e religiosi43. Un saggio d’interesse probabilmente co-mune a molti centri della provincia. Esso era infatti codifi-cato nei Capitula moderata e tollerata per Cameram Apostoli-cam hebreis civitatis Terracene, Ferentini et magistro Sabato civi romano commoranti in Piperno, conservati nell’archivio storico di Velletri44 e già editi da Maria Teresa Caciorgna45.
43 P.L. DE ROSSI, La Comunità ebraica di Terracina (sec. XVI), Cori
2004, p. 40. 44 A. DE SANTIS, Inventario delle pergamene, «Quaderni della Biblio-
teca Comunale», 1, Velletri 1978, p. 101. 45 M.T. CACIORGNA, Ebrei in Campagna e Marittima tra XIV e XV
secolo. Osservazioni sui capitula concessi dalla Camera Apostolica, in Gli ebrei a Ferentino e nel Lazio meridionale fino alla seconda metà del XVI secolo, a cura di G. LUTZENKIRCHEN, Ferentino 2001, pp. 47-60.
IL PROBLEMA DELLE FONTI STORIOGRAFICHE
La prima difficoltà che lo storico incontra riguarda sen-
za dubbio la credibilità del suo lavoro nel ricostruire i fatti accaduti. Il problema delle fonti è quindi elemento fonda-mentale per ogni lavoro storico. L’accertamento dei fatti porta con sé il problema della qualità delle fonti e del loro utilizzo. La loro disposizione in una successione cronologica riconoscibile crea i presupposti indispensabili di una storio-grafia scientifica che precluda ogni parzialità e si mantenga equidistante dai fatti che vengono raccontati. In assenza di documenti scritti, non può esistere una “verità storica”, al più si può parlare di “attendibilità” dello storico che riporta le relative vicende.
Gli storici veliterni non sempre riescono a prescindere dalle proprie idee, dal proprio coinvolgimento personale, dal condizionamento del proprio ambiente, dalle proprie simpatie. Talvolta, o spesso, a seconda dei casi, si allonta-nano dalla scienza per avvicinarsi alla fabula annacquando con elementi affascinanti la ricostruzione effettuale.
Per quanto ci si possa sforzare a verificare l’attendibilità delle fonti non documentabili, ci si imbatterà sempre nella stessa domanda: ci possiamo fidare? Ovviamente dipenderà molto dalla autorevolezza della fonte che fornisce un’infor-mazione che ‘ragionevolmente’ permetta di affermare che le
VELLETRI NEL MEDIOEVO
208
cose stiano effettivamente come presentate. Alla luce di questa affermazione vale la pena considerare come una sem-plice congettura, una personale opinione possano essere tra-mandate come un dato certo solo perché trascritte da una persona considerata a tutti gli effetti autorevole. È questo il caso che più si adatta ad Alessandro Borgia e alla sua Istoria e, più marginalmente non essendosi egli dedicato alla sto-ria, ad Antonio Mancinelli.
Gli autori “classici” veliterni qui considerati danno per scontata l’attendibilità delle loro fonti. In questo modo, chi legge non è in grado né di controllare né di valutare se la scelta di presentare un fatto in una determinata maniera sia convincente oppure no. In una parola, il lettore è nella condizione di doversi fidare ciecamente della loro capacità di giudizio, della loro intelligenza e della loro buona fede. Se questo poteva essere ammissibile per i loro contempora-nei, non può essere oggi giustificabile, allo stato delle attuali conoscenze, replicare acriticamente i fatti raccontati che provengono da un passato ormai remoto. I maggiori storici veliterni, Landi, Theuli, Borgia, Bauco, rimangono in ogni modo esempi di uomini illuminati, esponenti della società politica e dell’autorità ecclesiastica, che si sono dedicati alla storia, lontani dal profilo di coloro che nei secoli successivi si dedicheranno ad essa in modo prevalente o esclusivo, modello cui non si avvicinò neanche Luigi Cardinali1 il quale non mancò di inciampare in favolistiche interpreta-zioni.
Ascanio Landi, amministratore della città di Velletri, era nel pieno dell’attività politica quando scrisse il suo
1 L’attività di studioso di antichità del Cardinali non rappresentò
mai un suo interesse prevalente (cfr. N. PARISE, Cardinali Luigi, in «Di-zionario Biografico degli Italiani», 19, 1976, pp. 786-787).
IL PROBLEMA DELLE FONTI STORIOGRAFICHE
209
“Compendio” attraverso il quale egli si propose di mettere in risalto le glorie, passate e presenti della sua città2. È una storia “civile”, dal momento che egli ignorò completamente le vicende della Chiesa e dei suoi vescovi. Non trovano spa-zio anche quegli episodi che per il Landi avrebbero potuto offuscare la grandezza di Velletri. Egli dimenticò di registra-re l’elezione di Bonifacio VIII a podestà e non diede grande importanza ai patti con Roma del 1312 di cui pure era a conoscenza. Esaltò la partecipazione dei velletrani nella conquista di Lariano e il ritrovamento della lapide su cui era scritto SPQ Veliternus, alludendo di averne visto i resti ma facendo poi confusione sulle date. Nell’evidente esalta-zione della città, Landi non esitò a mettere in relazione i re-sti di un mosaico, ai suoi tempi ancora visibile nella decar-cia di Castello, con l’altare sul quale, secondo la tradizione, la famiglia Ottavia faceva sacrifici a Marte e quella parte di città che secondo il racconto di Svetonio ne aveva preso il nome3. L’identificazione fu poi suggellata nella toponoma-stica cittadina con la intitolazione di una via Ottavia ancora oggi esistente, ma non ancora menzionata né da Theuli né da Alessandro Borgia.
Il “Teatro Historico” di Bonaventura Theuli, che Re-migio Sabbadini definì un vero teatro di fantasia4, non pre-
2 Sulla figura di Ascanio Landi si veda la validissima presentazione
di Bonadonna Russo alla sua opera. 3 Bonadona Russo nel suo commento al testo landiano riporta che
“i resti sono attualmente spariti” (p. 14, n. 27) non accorgendosi della relazione di questi con una sua osservazione precedente in merito al tempio di Sango (p. 11, n. 21), nella quale riferiva di “frammenti di un pavimento a mosaico e un vasto ambiente di epoca romana … cfr. la re-lazione di O. Nardini”, evidentemente situati nella medesima zona.
4 R. SABBADINI, Antonio Mancinelli, saggio storico-letterario, Velletri 1878, p. 9.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
210
senta alcun riferimento cronologico ed è diviso per materie. Il Minore conventuale tracciò una visione leggendaria di Velletri alla quale dedicò interi capitoli. Le notizie furono riportate con assolutà acriticità e quando intravvide la pos-sibilità di esaltare il ruolo della città si lasciò trasportare da autentici voli pindarici. Lo stesso Clemente Cardinali aveva già additato Theuli come un cantafavole “a scusar le quali val poco o nulla la protesta del non essere antiquario: dac-chè vuol rispondersi che il buon senso, sale necessario ad ogni ceto di persone, vieta di pubblicare come storia ciò che neppure merita il titolo di conghiettura”5. In generale la storiografia secentesca veliterna presenta, oltre al problema delle fonti, un intento apologetico e la difesa di tesi prefab-bricate, in qualche modo il trionfo della forma più che del contenuto6. Theuli introduce spesso le proprie affermazioni tramite un “si tiene che…” e tale forma dovrebbe già far ri-flettere sulla qualità dell’informazione. L’opera resta co-munque in qualche modo preziosa per la conoscenza di av-venimenti contemporanei all'autore.
L’Istoria del Borgia, incentrata preminentemente sulla storia ecclesiastica, è accompagnata da numerosi documen-ti, che il vescovo trovò disponibili presso l’archivio capitola-re, ed è questo che conferisce all’opera una grande autore-volezza. L’autore rimase in ogni modo ancorato, ad ogni co-sto, ad una visione leggendaria della grandezza della sua cit-tà e dimostrò eccessiva credibilità nei confronti degli autori veliterni da lui citati, dei quali acriticamente confermò tesi
5 C. CARDINALI, Iscrizioni Antiche Veliterne, Roma 1823, p. 5. 6 A questo periodo risale anche un sunto sulla storia di Velletri di
Clemente Erminio Borgia, padre di Alessandro. Il manoscritto, tuttora inedito, consta di 105 fogli e racconta la storia di Velletri dall’inizio del mondo biblico fino al XIV secolo. L’Opera imperfetta è conservata presso l’Archivio Storico Comunale di Velletri (AsCV, MS-IV-19).
IL PROBLEMA DELLE FONTI STORIOGRAFICHE
211
e riportò ampie sezioni. Non solo Landi, che saccheggia in-discriminatamente per raccontare la storia politica di Velle-tri, e Theuli, ma anche il manoscritto di suo padre, dal Borgia definito l’Opera imperfetta, al quale concesse pari di-gnità tra le fonti. Sulla scia del Theuli, che aveva tracciato una linea che legava, senza soluzione di continuità, la fami-glia Ottavia alla Velletri medievale, non esitò infine ad alte-rare documenti – come il contratto enfiteutico del 946 – e a passarne sotto silenzio altri con il solo fine di esaltare la grandezza della città di Velletri. Il Borgia è perfettamente consapevole che in alcuni casi la sua opera potrebbe pren-dere una china apologetica nei riguardi della sua città ed è per questo costretto a giustificare in qualche modo il suo operato. Nel parlare di Benedetto X come di un pontefice legittimo, cosa che nessuno aveva fatto prima e farà poi in seguito, così si esprime: «Molti forse … sospetteranno, che noi annoveriamo fra legitimi Pontefici Benedetto X più per amore della nostra Patria, di cui fu Vescovo e Cittadino, che della verità, mà pur sol questa è stata, che in tal senten-za, la quale à molti sembrerà forse nuova, e pellegrina»7. Borgia sa che con una simile affermazione potrebbe in-camminarsi su un terreno per lui particolarmente scivoloso. Annoverando un membro della famiglia dei Conti di Tu-scolo come cittadino veliterno, egli potrebbe essere costret-to ad ammettere che la città di Velletri possa essere rimasta in quel periodo sotto la signoria di quella casata. Ne esce sostenendo che i Tuscolani possedevano beni in Velletri so-lamente a titolo privato, possibile eredità “della lor famiglia Ottavia”8. La tesi della legittimità di questo papa è larga-mente condivisibile, considerando che nessun antipapa si autodefinì in questo modo. Benedetto X è passato alla sto-
7 BORGIA, Istoria, cit., p. 173. 8 Ivi, p. 170.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
212
ria come tale – così come Clemente III e Anacleto II – solo perché, come papi, uscirono sconfitti nello scontro con le fazioni a loro avverse. Ovviamente non è questo il nocciolo della questione in tale frangente, ma il fatto che Borgia vol-le forzatamente allontanare ogni possibile relazione tra Be-nedetto X e il possibile potere esercitato dai Tuscolani sulla città di Velletri. Non fu tenero il giudizio di Clemente Car-dinali nei confronti del Borgia: «Così il desiderio di onorare la patria guasta la storia, e la deforma con brutte contradi-zioni: e così imbevuti di erronee idee, i padri nostri fecero dipingere nella sala consiliare del palazzo il portento di Au-gusto che impone il silenzio alle rane»9.
Nell’Ottocento Tommaso Bauco raccolse quanto pro-dotto dai suoi predecessori compilando un’opera che pos-siamo definire storiograficamente completa che risente però del fatto di essere stata concepita senza la diretta verifica delle fonti, nonostante il sacerdote dichiarasse subito di es-sersi accinto a scrivere una nuova storia di Velletri per ri-mediare agli errori degli “storici patrii”. Egli si appropriò delle allora recenti analisi critiche di Clemente Cardinali, ma poi accettò acriticamente tutto il resto lasciandosi anda-re anche ad alcune congetture visionarie. Egli citò costan-temente “Veletri” con questa grafia giustificandola con un diretto collegamento con le lingue volsca e latina, non te-nendo in considerazione il fatto che la grafia “Velletri” fos-se in uso nei documenti del Comune cittadino sin dal XIII secolo. Accolse solamente le parti dell’Opera imperfetta di Clemente Erminio Borgia già accettate da Alessandro Bor-gia, probabilmente senza prendere diretta visione dell’origi-nale, mentre ignorò completamente i fatti relativi ai secoli X e XI pur ampiamente trattati nell’Istoria del Borgia.
9 CARDINALI, Iscrizioni, cit., pp. 55-56.
IL PROBLEMA DELLE FONTI STORIOGRAFICHE
213
Il problema ovviamente non riguarda le opere e gli au-tori su citati, che rimangono apprezzabili nel loro contesto e nella loro funzione di registrazione di eventi municipali. Non si tratta di “fare le pulci” alle passate generazioni di scrittori, ma di registrare l’attuale mancanza di revisione cri-tica dell’edito a vari livelli e di proporre percorsi praticabili e possibilmente innovativi che non siano un insieme di co-noscenze tramandate. Si tratta di cogliere l’essenza dei fatti e delle vicende della storia locale di Velletri. Il fatto è che nella storiografia contemporanea della città persistono ele-menti che non trovano alcun riscontro effettuale e vengono ancora oggi acriticamente riportati. Ne vogliamo fornire al-cuni esempi:
– Velletri libero comune mai sottomesso a Signori feudali.
È questo probabilmente il simbolo cittadino di cui i velletrani vanno più fieri, ma che contrasta con i documenti conservati presso l’archivio capitolare che registrano a caval-lo dell’anno Mille la presenza per più di un secolo di una famiglia ducale, che inoltre contribuì alla rinascita della cit-tà. È altrettanto innegabile però che Velletri, a partire dal 1089, come data post quem, e per tutto il periodo medievale, abbia potuto gloriarsi di una effettiva autonomia cittadina. Luigi Cardinali nel tentativo di accreditare questa tesi ri-dusse il contratto di enfiteusi del 946 a “traccia del sistema governativo de’ Longobardi in Velletri”. In ogni modo, for-se non del tutto convinto di quanto egli stesso andava pro-ponendo, concluse quasi scusandosi il suo saggio: «Che se non fossero da indi poi ricosciute come vere, avrei qualche ragione a sperare tal cortese accoglienza a questo monu-mento»10.
10 CARDINALI, Di un antico sigillo comunale, cit., p. 28.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
214
– L’arx veliterna e la zona di Castello.
Ancora oggi alcuni fanno derivare il toponimo Castello dalla rocca (arx), che figurava le antiche colonie romane lo-calizzate sulla sommità di colline in grado di garantire il controllo e la difesa dei territori. Pur considerando innega-bile la questione topografica, non si ha memoria documen-taria dell’arx veliterna fino al XX secolo ed è oltremodo dif-ficile accettare una tale derivazione toponomastica. Tito Li-vio nella sua storia racconta solamente delle mura abbattute e dello scioglimento del Senato, in ogni modo è alquanto improbabile che i cittadini di Velletri del secolo XI, che re-gistrarono il toponimo Castello, lo abbiano fatto riferendo-si alle parole dello storico latino. È invece indubitabile che a Velletri esistesse un castello ancora nella metà di questo secolo, come documentato dal contratto del 1042 conserva-to presso l’archivio capitolare, e che da esso possa derivare l’odierno toponimo. Nessuno degli “storici patrii”, d’altra parte, fa menzione dell’arx veliterna. La grafia trova spazio per la prima volta agli inizi del Novecento negli scritti di Tersenghi11 e di Mancini12 per poi passare ad identificare il punto più alto della città. La presenza del castello fu negata con forza da Luigi Cardinali poiché, a suo dire, non c’era “niuna memoria nelle antiche carte” e stimava l’etimologia provenire dalla “topografica elevazione di quella parte della città”, in contrapposizione alla tesi proposta da Clemente Erminio Borgia nel suo manoscritto13. Luigi Cardinali, al-meno all’inizio della sua attività storica, ripeté molte delle
11 TERSENGHI, Velletri, cit. pp. 35-36. 12 G. MANCINI, Saggi di scavo attorno e sotto la chiesa di S. Maria della
Neve o delle Ss. Stimmate, e scoperta di un tempio volsco, in Notizie degli Scavi di Antichità, XII, «Accademia dei Lincei», 1915, p. 68.
13 CARDINALI, Di un antico sigillo comunale, cit., p. 10.
IL PROBLEMA DELLE FONTI STORIOGRAFICHE
215
tesi già espresse da Theuli, Alessandro e Stefano Borgia dei quali egli si dichiarò “sincero ammiratore della loro dottri-na, e imitatore loro”14.
– Origine del motto Est mihi libertas Papalis et Imperialis.
Nella sua forma attuale, il motto compare per la prima volta nella rappresentazione dello stemma veliterno del 164315. Esso derivava da una iscrizione incisa su un “anti-chissimo sigillo di metallo trovato frà alcune ruine di Velle-tri, e conservato già nel museo di Giovanni Paolo Ginnet-ti”16, la cui figura fu pubblicata per la prima volta da Luigi Cardinali nel 181817, il quale attribuì il sigillo al XIII-XIV secolo. Su di esso si leggeva: Signum Communis Veletri, Sit vo-bis papalis libertas imperialis. Su questo motto stranamente Theuli non si sbilancia: “Donde habbia havuto principio scritto tanto honorevole, io non l’hò potuto trovare”18, per poi favoleg-giare sull'origine iconografica dello stemma e del suo signi-ficato simbolico. È solamente Alessandro Borgia a spiegarne la provenienza, come riconoscimento della libertà imperiale da parte di Giustiniano e Narsete, citando come unica fon-te l'Opera imperfetta scritta da suo padre, di cui riporta un intero stralcio19. La tesi accolta dal Borgia nella sua Istoria fu dovuta non ad una inadeguata capacità critica dell’autore, ma fu il risultato evidente della sua strategia, che mirava ad esaltare ad ogni costo la grandezza della sua città. Egli infatti ignorò completamente un’altra tesi di suo padre, che opi-
14 CARDINALI, Di un antico sigillo capitolare, cit., p. 65. 15 ZACCAGNINI, Est mihi libertas …?, cit., p. 4. 16 BORGIA, Istoria, cit., p. 71. 17 CARDINALI, Di un antico sigillo comunale, cit., pp. 26-27. 18 THEULI, Teatro, cit., p. 133. 19 BORGIA, Istoria, cit., p. 121.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
216
nava la presenza di un castello già costruito nella parte più elevata di Velletri. Ancora una volta Bauco riportò acriti-camente la notizia20 citando come fonte diretta il mano-scritto, del quale sembrerebbe non aver preso visione. Rela-tivamente alle libertà papali, Luigi Cardinali ne confermò l’antichità “già dimostrata da Alessandro Borgia, Bonaven-tura Theuli e Giuseppe Prosperi”21. Secondo questi autori le antiche libertà papali erano state espressamente confer-mate da Gregorio IX nel 1235 e fatte risalire al secolo VIII, al tempo della lotta iconoclasta – la fonte è sempre l’Opera imperfetta22, – una tesi che trova spazio ancora oggi nei testi enciclopedici23 e in alcune recenti pubblicazioni24.
– Chiesa di S. Clemente situata presso Papazzano.
Alessandro Borgia, nell’intento di allontanare da Velle-tri anche il semplice sospetto che la città fosse stata sotto il dominio del consul et dux Demetrio di Melioso, ricorda nei pressi di questa contrada la presenza di «antiche ruine e an-tichi edifizi»25, di cui però non vi era traccia neanche allora. La tesi fu ripresa acriticamente dal Bauco26 ed è ancora oggi avvalorata dagli studiosi contemporanei27.
20 BAUCO, Storia, cit. I, pp. 79-81. 21 CARDINALI, Di un antico sigillo comunale, cit., p. 23. Giuseppe De
Prosperis visse a cavallo dei secoli XVII e XVIII e nel 1713 pubblicò una Dissertatio historico legalis de regimine civitatis veliternae.
22 BORGIA, Istoria, cit., p. 141. 23 Velletri, in Enciclopedia Italiana (1937) [edizione on-line consul-
tata il 16 maggio 2014]. 24 L. GATTO, L’Italia nel Medioevo, la vita degli italiani nell’età di mez-
zo, 2012 (e-book). 25 BORGIA, Istoria, cit., p. 157. 26 BAUCO, Storia, cit. II, p. 44. 27 COGOTTI, La Cattedrale, cit. p. 53 e nota.
IL PROBLEMA DELLE FONTI STORIOGRAFICHE
217
– Convento di S. Francesco edificato su un sito benedettino.
La notizia, ancora oggi avvalorata, venne riportata da Theuli28 e fu già confutata da Alessandro Borgia, che la de-finì una “pia credenza” del Conventuale29. Theuli racconta che il convento, l’attuale “casermaccia”, fu costruito su un sito precedentemente occupato dall’abbazia di S. Rufo di cui era stato abate papa Anastasio IV. L’autore aveva ripreso la notizia dalla “vita dei Papi” del Platina, basata sul Liber pontificalis, dove comunque la notizia non era riportata30. Anastasio IV era indicato dal Platina come abate dell’ordi-ne di S. Rufo di Velletri (?), una notizia che studi recenti sul papato del XII secolo smentiscono categoricamente, esclu-dendo ogni collegamento tra Corrado di Suburra e il cano-ne regolare di S. Rufo31. Non è improbabile che l’erronea attribuzione di Bartolomeo Sacchi sia dovuta al fatto che il successore di Anastasio IV, papa Adriano IV, fu effettiva-mente abate di S. Rufo ad Avignone. Borgia in ogni modo non si accontentò di smentire la notizia, ma la rimodellò nel tentativo di legare ad ogni costo l’illustre personaggio al-la città di Velletri. Egli congetturò che Anastasio IV fosse stato priore di S. Anastasio, “che buon ben essere che di-pendesse dalla Badia di S. Rufo in Francia, la qual forse col favor de nostri Vescovi Francesi, si era nelle nostre Contra-de dilatata”.
28 THEULI, Teatro, cit., pp. 158-159. IDEM, Il Convento di S. France-sco, cit., p. 441.
29 BORGIA, Istoria, cit., p. 231. Con “pia” egli volle sottolineare la buona fede del Theuli del quale continuò ad assimilare acriticamente molte altre tesi.
30 DUCHESNE, Le Liber Pontificalis, cit., II, p. 388. 31 I. STUART ROBINSON, The Papacy, 1073-1198, Continuity and In-
novation, Cambridge 1990, p. 73.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
218
– Il problema delle lapidi apocrife.
DEO SALVATORI ... ANNO DNI C. Clemente Cardinali dedicò al caso delle lapidi apocrife una intera se-zione del suo lavoro sulle antiche iscrizioni veliterne32. Tra queste la lapide manifestamente falsa, che nella chiesa di S. Salvatore ne testimoniava una frequentazione cristiana nel primo secolo dopo Cristo. Il Borgia, pur consapevole della non veridicità, cercò di avvalorarne l’antichità spostandone la compilazione al principio del VI secolo33. La tesi fu avva-lorata acriticamente ancora da Gabrielli34, mentre Bauco, pur confermando l'antichità della chiesa, sulla scia degli studiosi contemporanei la disse composta nel XV secolo35. Anche Luigi Cardinali fece propria la tesi del Borgia secon-do la quale la prima comunità cristiana di Velletri sarebbe risalita ai tempi di S. Clemente vescovo – tesi già sostenuta da Theuli – e si sarebbe radunata nel luogo dove sarebbe sorta in seguito la chiesa di S. Salvatore36.
SPQ Veliternus. Il XV secolo, che guardò al recupero della latinità classica, fu innegabilmente fecondo anche di grossolane manipolazioni. Alla seconda metà di questo se-colo si può infatti assegnare anche la lapide su cui era inciso il motto SPQ Veliternus, descritta per la prima volta da An-tonio Mancinelli. L’umanista ne parlò nel suo commento ai Carmi di Orazio pubblicato a Venezia nel 1492, lamentan-done la distruzione ad opera di un “livore ductus quidam ex Aquapendente oriundus”, familiare del cardinale Rotomagen-
32 CARDINALI, Iscrizioni, cit., pp. 218-223. 33 BORGIA, Istoria, cit., pp. 87-88. 34 A. GABRIELLI, Illustrazioni Storico-Artistiche di Velletri, 1907, pp.
67-69. 35 BAUCO, Storia, cit., II, pp. 8-12. 36 CARDINALI, Di un antico sigillo capitolare, cit., p. 29, n. 54.
IL PROBLEMA DELLE FONTI STORIOGRAFICHE
219
se, del quale Mancinelli dice di tacere il nome per non con-segnarlo alla storia come era successo a Erostrato, distrutto-re del tempio di Diana Efesina37. Sembrerebbe comunque apparentemente inspiegabile una distruzione basata sull’invi-dia, da parte di un funzionario pubblico alle dirette dipen-denze del cardinale, di un reperto archeologico così impor-tante, a meno che l’opera non fosse stata frutto di una vol-gare imitazione contemporanea. C’è poi una coincidenza temporale quanto meno singolare tra il ritrovamento della lapide veliterna, avvenuta secondo Mancinelli nella già di-ruta chiesa di Santo Stefano, e il rinvenimento di quella su cui era incisa la scritta SPQ Lanivinus. Di quest’ultima Mancinelli era perfettamente a conoscenza, poiché era stata riportata da Martino Filetico nel suo commento ad Orazio pubblicato solo pochi anni prima. Proprio questa testimo-nianza epigrafica servì a Mancinelli per rilevare l’errore tra le due città di Lavinio e Lanuvio, vulgato nelle stampe pre-cedenti al suo commento sulla Geographia di Strabone. Non sembrerebbe invece che Landi abbia effettivamente visto questo marmo, che dice “trovato questi anni passati, men-tre si fatbricava (così) la Chiesa di S. Rocco”38. Borgia fa-cendo fede al Landi la dice ritrovata “160 anni addietro”, tempo che farebbe cadere la data del ritrovamento all’anno della compilazione del Compendio (1563). Clemente Cardi-nali, non avendo visto la lapide, non entrò nel merito della sua autenticità, essendone testimoniate altre dello stesso te-nore, sorrise però di coloro che ritenevano “che possa inda-garsi la età del sasso da quelle parole di Livio nelle quale si
37 Ho consultato l’edizione stampata nel 1495, sempre a Venezia,
da Benedetto Fontana dove il riferimento è alle pp. 118-119. 38 LANDI, Compendio, cit., pp. 6-7.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
220
fa menzione del senato veliterno è puerilità indegna de’ giorni nostri”39. – Velletri anticamente divisa in dieci zone o decarcie.
La tesi, ancora oggi avvalorata, deve la sua fortuna a Luigi Cardinali, il quale fantasticò di come, dopo le incur-sioni longobarde, i velletrani cominciassero a ricostruire la città partendo dalla decarcia di S. Salvatore40, confermando la tesi del Borgia secondo cui la chiesa doveva considerarsi la prima costruita in Velletri dopo la cattedrale, poiché di essa si aveva memoria già dal I secolo. È probabilmente questa la ragione per cui ancora oggi si ritiene che questo quartiere sia il più antico della città. La tesi fu poi amplifi-cata da Augusto Tersenghi, il quale nel panorama della sto-riografia cittadina può godere di grande autorevolezza. Le capacità di analisi di questo autore rimangono però effetti-vamente deboli a fronte dell’enorme messe di dati che egli ebbe a disposizione durante il lunghissimo periodo, oltre sessant’anni, in cui ricoprì l’incarico di bibliotecario comu-nale. Il valore del suo lavoro rimane confinato, a mio pare-re, nelle parti in cui egli descrisse lo stato della Velletri a lui contemporanea e che di grande valore storico sono succes-sivamente diventate a seguito degli eventi bellici legati alla seconda guerra mondiale.
– La deformazione prospettica.
Vale a dire interpretare ciò che è avvenuto anticamente alla luce della condizione attuale. Questa deformazione è ben visibile ad esempio nelle ricostruzioni architettoniche
39 CARDINALI, Iscrizioni, cit., p. 80. 40 CARDINALI, Risposta alla lettera, cit., pp. 69-71.
IL PROBLEMA DELLE FONTI STORIOGRAFICHE
221
di Velletri. Esse si soffermano sulla rappresentazione baroc-ca ed è difficile convincere che sia esistita una Velletri me-dievale “diversa” da quella che viene oggi comunemente rappresentata, nella quale non esistono né il palazzo comu-nale né tutti gli altri edifici oggi visibili ad eccezione della Torre del Trivio. Si ha difficoltà ad ammettere che possa es-sere esistito un castello sulla sommità di Velletri perché si immagina, e si è immaginato in passato, un castello resi-denziale – come quello di Sermoneta, per intenderci, tipico del tardo Medioevo – e non qualcosa aderente alla realtà e molto meno imponente costruito con legno e pietra. Ter-senghi, pur rinnegandolo, lo immaginava «munito di torri, ripari, muri merlati»41. È questa un’idea falsificante della storia e soprattutto dannosa. Il metodo regressivo42 è uno strumento prezioso per guardare al passato, ma non si può cadere nella tentazione di interpretarlo come semplice preannuncio di ciò che si è realizzato in seguito e soprattut-to ipotizzare qualcosa senza il necessario riscontro docu-mentario, e fantasticare così uno spopolamento della città nella sua parte settentrionale tra XIII e XIV secolo43. Fanno sorridere le interpretazioni di Tersenghi44, il quale vorrebbe dimostrare la derivazione del toponimo Ponte di Mèle da “miele”, associandolo ad una abbondante apicoltura prati-
41 TERSENGHI, Velletri, cit., p. 36. 42 Il metodo consiste nel confrontare le fonti di età moderna con
quelle precedenti, sostenuta e dimostrata dall’opera di Jean Coste per la Campagna romana secondo il quale la conoscenza del territorio nelle epoche passate può essere possibile ripercorrendo a ritroso le tappe della catena di testimonianze, andando dal più noto al meno noto (J. COSTE, Il metodo regressivo, in IDEM, Scritti di topografia medieva-le, cit., pp. 17-24).
43 TERSENGHI, Velletri, cit., p. 17. 44 Ivi, pp. 302-303.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
222
cata in epoca medievale in questa zona solamente per asso-nanza fonetica, peraltro limitata a quel periodo45, e che pu-re ancora oggi viene riportata non soltanto negli ambienti “culturali” cittadini46.
45 Sarebbe difficile ai nostri giorni far associare, agli odierni abi-
tanti di Velletri, soprattutto i più giovani, il termine mèle a miele. Per l’origine del toponimo si veda a p. 166.
46 S. DEL LUNGO, La toponomastica archeologica della provincia di Roma, II, 1996, p. 107.
FONTI DI ARCHIVIO E BIBLIOGRAFIA Fonti
Archivio Capitolare di Velletri (ACV) Archivio Storico Comunale di Cori (AsCC) Archivio Storico Comunale di Sermoneta (AsCS) Archivio Storico Comunale di Velletri (AsCV) Archivio Notarile di Velletri (ANV) Archivio Segreto Vaticano (ASV) Archivio di Stato di Roma (ASR) Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Fonti inedite
C. BORGIA, Descrizione della città di Velletri al 1709, ms., AsCV, MS-IV-19.
C. E. BORGIA, Storia di Velletri (Opera imperfetta), ms., s. d. (fine sec. XVII), AsCV, MS-IV-19.
Fonti edite
A. ACCHIONI, V. CICCOTTI, V. DANI, G. GROSSO, G. MONTAGNA (a cura di), Velletri, Strade e Contrade nella Storia, Centro Studi Veli-terno, Velletri 2005.
H. AHRWEILER, M. BALARD, Eupsychia: mélanges offerts à Hélène Ahrwei-ler, Paris 1998.
R. AMBROSI DE MAGISTRIS, Storia di Anagni, Roma 1889. M. AMELOTTI, Per una storia del notariato meridionale, Roma 1982. A. J. ANDREA, Contemporary sources of the fourth crusade, London-Boston-
Köln 2000. G. ARNALDI, Le origini dello Stato della Chiesa, Torino 1987.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
224
M. ASPRONE, Il diritto d’asilo e lo status di rifugiato, Roma 2012. A. AUGENTI, Il Palatino nel Medioevo: archeologia e topografia (secoli VI-
XIII), Roma 1996. L. AUVRAY (a cura di), Les registres de Grégoire IX, Paris 1896-1907. C. G. BASCAPÉ, Sigillografia. Il sigillo nella diplomatica, nel diritto, nella sto-
ria, nell’arte, Milano 1969. T. BAUCO, Storia della Città di Velletri, Velletri 1851. C. BAUER, Studi per la storia delle finanze papali durante il pontificato di Si-
sto IV, in «ASRSP», 50 (1927), pp. 319-400. B. BAVANT, Le duches byzantin de Rome, in «Mélanges de l’Ecole française
de Rome. Moyen-Age, Temps modernes» 91 (1979), pp. 41-88. B. BELARDINI, Nuove acquisizioni sul cimitero paleocristiano di Velletri fuori
Porta Napoletana, in «Rivista di Archeologia Cristiana», LXVIII (1992).
V. BEOLCHINI, Tusculum II, una roccaforte dinastica a controllo della valle Latina, Roma 2006.
V. BEOLCHINI, P. DELOGU, La nobiltà altomedievale in città e fuori: il caso di Tusculum, in S. CAROCCI (a cura di), La nobiltà romana nel Me-dioevo, Roma, «École française de Rome», 359, 2006, pp. 137-169.
C. BIANCA, Martino Filetico, in «Dizionario Biografico degli Italiani», 47, 1997.
M. A. BOLDETTI, Osservazioni Sopra I Cimiteri De' Santi Martiri, Ed Anti-chi Christiani di Roma, Roma 1720.
A. BORGIA, Istoria della chiesa e città di Velletri, Nocera 1723. S. BORGIA, De cruce veliterna, Roma, per i tipi della Sacra Congregazio-
ne, 1780, traduzione di M. LOZZI, ed. (a cura di) L. Bertelli - B. Pallotti, Velletri 2005.
IDEM, Breve Istoria del Dominio temporale della Sede Apostolica nelle Due Si-cilie, Roma 1788.
M. BOTTICINI, New evidence on Jews in Tuscany, in Mercanti e banchieri ebrei, Zakhor, in «Rivista di storia degli ebrei d’Italia», I, Roma 1997.
P. BREZZI, Roma e l’impero medievale (774-1252), in «Storia di Roma» (Istituto di studi romani), X, Bologna 1947.
C. CALISSE, I Prefetti di Vico, in «ASRSP», 10 (1887), pp. 1-136; 353-594.
M. T. CACIORGNA (a cura di), Le pergamene di Sezze, 1181-1347, in Codi-ce diplomatico di Roma e della regione romana, 5, Roma 1989.
EADEM, L’influenza angioina in Italia: gli ufficiali nominati a Roma e nel La-zio, in «Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes», T. 107, 1. 1995, pp. 173-206.
FONTI DI ARCHIVIO E BIBLIOGRAFIA
225
EADEM, Marittima Medievale, Territori società, poteri, Roma 1996. EADEM, Ufficiali forestieri nel Lazio, in J. C. MARIE-VIGUER (a cura di), I
podestà dell'Italia comunale. Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII-meta XIV sec., Roma, 2000, (Nuovi Studi storici, 511), pp. 815-846.
EADEM, L’abbazia di Fossanova, vicende e problemi di un’abbazia tra stato della Chiesa e Regno (secoli XII-XIII) pp. 93-94, in Il monachesimo ci-stercense nella Marittima medievale. Storia e Arte. «Atti del Convegno (Abbazia di Fossanova-Valvisciolo, 24-25 settembre 1999)», Casa-mari 2002.
EADEM (a cura di), Santa Maria di Grottaferrata e il cardinale Bessarione. Fonti e studi sulla prima commenda, Roma 2005.
EADEM, Una città di frontiera. Terracina nei secoli XI-XIV, Roma 2008. M. CANCELLIERI, Privernum: i mosaici della domus dell'Emblema figurato.
Dati vecchi e nuovi, «Atti III Coll. AISCOM», 1996. G. CAETANI (a cura di), Regesta Chartarum: Regesto delle pergamene
dell’archivio Caetani, III, Sancasciano Val di Pesa 1928. C. CARBONETTI, Tabellioni e scriniari a Roma nei secoli IX-XI, in «Archivio
della Società romana di storia patria», 102 (1979) [ma 1980], pp. 77-156.
EADEM, Documentazione scritta e preminenza sociale, in S. CAROCCI (a cu-ra di), La nobiltà romana nel Medioevo, Roma, «École française de Rome», 359, 2006.
C. CARDINALI, Iscrizioni Antiche Veliterne, Roma 1823. L. CARDINALI, Di un antico sigillo comunale, Estratto dal Giornale Enci-
clopedico di Napoli, Anno XII, Num. XII, Dicembre 1818. IDEM, Risposta alla lettera del ch. Angiolo Uggeri sopra alcuni edifizi veliterni
del secolo XI, in Memorie romane di antichità e di belle arti, I, Roma 1824.
IDEM, Di un antico sigillo capitolare, Osservazioni, in Dissertazioni della Pon-tificia Accademia romana di archeologia, II, Roma 1825.
IDEM, Dell’autonomia di Velletri nel sec. XIV, in Atti della società letteraria volsca, Velletri 1839.
A. CARILE, Per una storia dell’impero latino di Costantinopoli (1204-1261), Bologna 1978.
S. CAROCCI, Aspetti delle strutture familiari nel Lazio tardomedievale, in «ASRSP», 110, (1987), pp. 151-176.
IDEM, Tivoli nel basso medioevo, società cittadina ed economia agraria, in «Nuovi Studi Storici», 2, Roma 1988.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
226
IDEM, Baroni di Roma. Dominazioni signorili e lignaggi aristocratici nel Due-cento e nel primo Trecento, (Collection de l'École française de Rome) Roma 1993.
IDEM, Barone e podestà. L'aristocrazia romana e gli uffici comunali nel Due-Trecento, in J. C. MARIE-VIGUER (a cura di), I podestà dell'Italia co-munale. Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII-meta XIV sec., Roma, 2000, (Nuovi Studi storici, 511), pp. 847-875.
IDEM, Feudo, vassallaggi e potere papale nello Stato della Chiesa (metà XI sec.-inizio XIII sec.), in Fiefs et féodalité dans l’Europe méridionale (Italie, France du Midi, Péninsule ibérique) du Xe au XIIIe siècle (Colloque in-ternational organisé par le Centre Européen d’Art et Civilisation Médiévale de Conques et l’Université de Toulouse-Le Mirail, Conques, 6-8 juillet 1998), Toulouse 2002.
IDEM (a cura di), La nobiltà romana nel Medioevo, Roma, «École française de Rome», 359, 2006.
S. CAROCCI, M. VENDITTELLI, L’origine della campagna romana. Casali, castelli e villaggi nel XII e XIII secolo, con saggi di Daniela Esposito, Mauro Lenzi e Susanna Passigli, Roma, «Miscellanea della Società Romana di Storia Patria», 47, 2004.
A. CASTRORAO BARBA, Ville romane e riusi tra Tardantichità e Altomedioe-vo: per un bilancio nazionale, in F. REDI, A. FORGIONE (a cura di), «Atti del VI Congresso Nazionale di Archeologia Medievale», L’Aquila 12-15 settembre 2012, Firenze 2012.
T. CECCARINI, L. CRESCENZI, Il materiale marmoreo, in Museo Civico di Velletri, «Cataloghi dei Musei e delle collezioni del Lazio», 6, Roma 1989.
G. CHERUBINI, Pellegrini, pellegrinaggi, giubileo nel Medioevo, Napoli 2005. V. CICCOTTI, Inventario Archivio Notarile – Serie I, Protocolli Notarili
(1392-1650), Velletri 2001. IDEM, Inventario Archivio Notarile – Serie II, Protocolli Notarili (1651-1787),
Velletri 2004. F. CIPOLLINI (a cura di), Pier Damiani, figura, aspetti dottrinali e memoria
nella diocesi di Velletri. Giornate di studio. Velletri, 9-10 novembre 2000, Venafro 2003.
C. CITTER, L’Italia centrale tirrennica in età carolingia. Spunti di riflessione alla luce del dibattito attuale, in G. VOLPE, P. FAVIA (a cura di), «At-ti del V Congresso Nazionale di Archeologia Medievale», Foggia-Manfredonia 30 settembre – 3 ottobre 2009, Firenze 2009.
FONTI DI ARCHIVIO E BIBLIOGRAFIA
227
G. CLEMENTE, Toponomastica e agiotoponomastica: strumenti, metodi e casi di studio per la conoscenza archeologica del territorio, in F. REDI, A. FORGIONE (a cura di), «Atti del VI Congresso Nazionale di Ar-cheologia Medievale», L’Aquila 12-15 settembre 2012, Firenze 2012.
S. COCCIA, Le fortificazioni nel Lazio meridionale. Il quadro storico-archeologico dalla tarda antichità all’incastellamento, in G. GIAMMA-
RIA (a cura di), Castelli del Lazio meridionale, Roma-Bari 1998. M. COGOTTI, La cattedrale di S. Clemente a Velletri, Roma 2006. D. A. CONTATORE, De Historia Terracinensi libri quinque, Roma 1706. R. CORDOVANI, I luoghi abitati dai cappuccini nel Lazio dal 1528 al 1578,
in «L’Italia Francescana», 53, 1978. A. CORTONESI, Ninfa e i Caetani: affermazione della signoria e assetto del
territorio (secoli XIII-XIV), in Ninfa, una città, un giardino, «Atti del Colloquio della Fondazione Camillo Caetani, Roma-Sermoneta-Ninfa 7-9 ottobre 1988», Roma 1990.
J. COSTE, La via Appia nel Medio Evo e l’incastellamento, ora in Scritti di Topografia medievale. Problemi di metodo e ricerche sul Lazio, a cura di C. CARBONETTI, S. CAROCCI, S. PASSIGLI, M. VENDITTELLI, (Nuovi studi Storici, 30), Roma 1996.
IDEM, Strade da Roma per Sermoneta, in Sermoneta e i Caetani, dinamiche politiche, sociali e culturali di un territorio tra Medioevo ed età moderna, «Atti del Convegno della Fondazione Camillo Caetani. Roma-Sermoneta 1993, 16-19 giugno», Roma 1999.
L. CRESCENZI, Archeologia, territorio, museo, Velletri, Quaderni della Bi-blioteca Comunale, 2,Velletri 1981.
G. CRESSEDI, Velitrae, in Italia romana: municipi e colonie, Istituto di Stu-di Romani editore, Roma 1953.
IDEM, Il castello di S. Gennaro presso Lanuvio, in «Rendiconti lincei» (1952), VII, pp. 287-292.
G. CROCIONI, La toponomastica di Velletri, in «Bollettino della Società Geografica Italiana», Roma 1901.
P. DALENA, Vie di pellegrinaggio nel Sud Italia verso Gerusalemme nel Me-dioevo, in Roma-Gerusalemme, lungo le vie Francigene del Sud, I, Napo-li 2008.
M. G. DE FINO, Proprietà imperiali e diocesi rurali paleocristiane nell’Italia Tardo Antica, in G. VOLPE, M. TURCHIANO (a cura di), Paesaggi e insediamenti rurali in Italia meridionale fra Tardoantico e Altomedioevo, «Atti del 1º seminario sul Tardoantico e Altomedioevo in Italia meridionale, (STAM 1), (Foggia 2004)», Bari 2005.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
228
D. DE FRANCESCO, Partizioni fondiarie e proprietà ecclesiastiche nel territorio romano tra VII e VIII secolo. Prospettive di ricerca alla luce dei dati epi-grafici, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen-Age», 110 (1998).
EADEM, La proprietà fondiaria nel Lazio, secoli IV-VIII, storia e topografia, Roma 2004.
E. DE MINICIS, Alatri, in Lazio Medievale, 33 abitati delle antiche diocesi di Alatri, Anagni, Ferentino, Veroli, Roma 1980.
G. B. DE ROSSI, Bullettino Archeologia Cristiana, 4, Roma 1863. P. L. DE ROSSI, La Comunità ebraica di Terracina (sec. XVI), Cori 2004. P. L. DE ROSSI, E. DI MEO (a cura di), Il Catastum bonorum di Cori
(1668-1696). Con un inventario dei beni comunali (1401), «Quaderni dell’Archivio Storico», 2, Cori 2009.
A. DE SANTIS, Inventario delle pergamene, «Quaderni della Biblioteca Comunale», 1, Velletri 1978.
S. DEL FERRO, Il ruolo delle signorie monastiche nell’articolazione del popola-mento del Lazio medievale. La Diocesi di Veroli, in G. MACCHI JANICA (a cura di), Geografie del popolamnto: casi di studio, metodi, ricerche, «Atti della giornata di studi 24-26 settembre 2008», Siena 2009.
S. DEL LUNGO, La toponomastica archeologica della provincia di Roma, II, Roma 1996.
IDEM, Toponimi in Archeologia: La Provincia di Latina, Italia (British Ar-chaeological Reports, International Series, S911), 3, Oxford 2001.
P. DELOGU, Territorio e dominii della regione pontina nel Medio Evo, in Nin-fa, una città, un giardino, Roma 1990.
T. DI CARPEGNA FALCONIERI, Le trasformazioni onomastiche e antroponi-miche dei ceti dominanti a Roma nei secoli X-XII, in «Mélanges de l'É-cole française de Rome. Moyen-Age», 106 (1994).
IDEM, Popes through the Looking Glass, or «Ceci n’est pas un pape», in Fram-ing Clement III, (Anti)Pope, 1080-1100, «Reti Medievali Rivista», 13, 1 (2012), pp. 121-136.
L. DUCHESNE, Le Liber Pontificalis, (2 voll.), Paris 1886-1892. P. EGIDI (a cura di), Necrologio dei SS. Ciriaco e Nicola nella via Lata, in
Necrologi e libri affini, della città di Roma, I, Roma 1908. S. ELIODORO, Campania Tardoantica (284-604 d.C), Bari 2005. A. ESPOSITO, Una ‘descriptio’ relativa alla presenza ebraica nel Lazio meri-
dionale nel tardo Quattrocento, in «Latium», 2 (1985). EADEM, Gli ebrei della regione di Campagna alla fine del Medioevo: prime in-
dagini, in «Latium», 7 (1990).
FONTI DI ARCHIVIO E BIBLIOGRAFIA
229
EADEM, La presenza ebraica in una regione pontificia nel tardo Medioevo: il Patrimonio di S. Pietro in Tuscia e Viterbo, in «Italia Judaica», Gli ebrei nello Stato pontificio fino al Ghetto (1555), Pubblicazione degli Ar-chivi di Stato (47), Roma 1998.
D. ESPOSITO, Tecniche costruttive murarie medievali, murature ‘a tufelli’ in area romana, Roma 1997.
P. FABRE, L. DUCHESNE, Le Liber Censuum de l’Eglise romaine, I, Paris 1902-1910.
G. FALCO, Il Comune di Velletri nel Medio Evo (secoli XI-XIV), in «ASRSP», 36 (1913); 37 (1914); 38 (1915); 39 (1916).
IDEM, L'amministrazione papale nella Campagna e nella Marittima dalla ca-duta della dominazione Bisantina al sorgere dei Comuni, in «ASRSP», 38 (1915), pp. 677-707.
IDEM, I Comuni della Campagna e della Marittima nel Medio Evo, in «ASRSP», 42 (1913); 48 (1925); 49 (1926) ora in IDEM, Studi sulla storia del Lazio nel Medioevo, 2 voll., Roma 1988.
F. FERRUTI, Note sul culto di San Michele Arcangelo, in «Quaderni dell'Ar-chivio Storico Comunale di Castel Madama», Bollettino di studi storici, 2007.
A. FINETTI, La zecca e le monete di Perugia nel Medioevo e nel Rinascimento, Perugia 1997.
V. FIOCCHI NICOLAI, Topografia cristiana di Velitrae e territorio in età Tar-doantica: una messa a punto, in Augusto a Velletri, «Atti del convegno di studio (Velletri 16 dicembre 2000)», Velletri 2001.
D. FIORANI, Architettura e cantiere delle strutture fortificate, in G. GIAM-
MARIA (a cura di), Castelli del Lazio meridionale, Roma-Bari 1998. I. FREZZA FEDERICI, G. SPAGNOLI, Almanacco, Amelia 1999. A. GABRIELLI, Gli Statuti della città di Velletri, Velletri 1912. IDEM, Alcuni capitoli del 1547 per un banco di prestito a pegno tenuto dagli
ebrei in Velletri, Velletri 1917. IDEM, Un Conclave a Velletri, Elezione e Residenza di Lucio III, Velletri
1923, rist. anast., Velletri 1995. IDEM, Di un’antica confederazione tra Velletri e Cori, in «Bollettino dell’As-
sociazione veliterna di Archeologia e Arte», Velletri 1926. A. GALIETI, La tomba di Prosperetto Colonna in Civita Lavinia, in «ASRSP»,
31 (1908), pp. 211-219. L. GALIETI, La presenza ebraica a Civita Lavinia, Velletri 2004. P. L. GALLETTI, Del Primicerio della Santa Sede, Roma 1776. G. GHINI, La villa degli Ottavi a Velletri, in Augusto a Velletri, «Atti del
convegno di studio (Velletri 16 dicembre 2000)», Velletri 2001.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
230
G. GIAMMARIA (a cura di), Castelli del Lazio meridionale, Roma-Bari 1998.
Gli Ebrei e il Lazio (secoli XV-XVII), «Archivi e Cultura», XL (2007), Ro-ma 2008.
K. GÖRICH, Die de Imiza. Versuch über einer römische Adelsfamilie zur Zeit Ottos III, «Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken», 74 (1994), pp. 1-41.
G. GRECO, Lezioni di Storia della Chiesa, 1, Appunti e materiali di lavo-ro, Università degli Studi di Siena, a.a. 2009-2010.
G. L. GREGORI, Velletri tardorepubblicana e imperiale. Materiali e appunti per un profilo di storia istituzionale e sociale, in L. DRAGO TROCCOLI (a cura di), Il Lazio dai Colli Albani ai monti Lepini tra preistoria ed età moderna, Roma 2009.
GREGORIO MAGNO, Registrum Epistularium, in Opere di Gregorio Magno, Roma 1992.
F. GREGOROVIUS, Storia della città di Roma nel Medioevo, Torino 1973. J. GUIRAUD, Les registres d’Urbain IV, Paris 1901. M. HARTMANN LUDOVICUS, Ecclesiae S. Mariae in Via Lata Tabularium,
I, Vienna 1895. K. J. VON HEFELE KARL, H. LECLERCQ, Histoire des Conciles d'après les
documents originaux, IV, I, Parigi 1911. É. HUBERT, L’incastellamento dans le Latium, Remarques à propos de fouille
reécentes, Annales HSS, 3, mai-jun 2000. Il Chronicon Farfense di Gregorio da Catino: precedono la Constructio Farfen-
sis e gli scritti di Ugo di Farfa, a cura di U. BALZANI, 2 voll., in «Fonti per la storia d’Italia», XXXIV, Roma 1903.
Il Regesto di Farfa compilato da Gregorio da Catino, a cura di I. GIORGI, U. BALZANI, «Biblioteca della R. Società romana di storia patria», 5 voll., Roma 1879-1914.
Il Regesto sublacense dell’undicesimo secolo, a cura di L. ALLODI, G. LEVI, Roma 1885.
F. ISOLDI (a cura di), Il Diario attribuito a Gentile Delfino (1370-1410), in RIS II (Rerum Italicarum Scriptores), XXIV, Città di Castello 1912.
F. P. KHER, Regesta Pontificum Romanorum, Italia Pontificia, II, Latium, Roma 1907.
C. LAMPE, Contributi alla storia di Velletri medioevale, in «Castelli Roma-ni», XLV, 6, 2005.
A. LANCONELLI, La terra buona. Produzione, tecniche e rapporti di lavoro nell'agro viterbese fra Due e Trecento, Bologna 1994.
FONTI DI ARCHIVIO E BIBLIOGRAFIA
231
A. LANDI, Compendio delle Cose della Città di Velletri, MDLXIV, mano-scritto pubblicato in «Quaderni della Biblioteca Comunale», 4, in-troduzione e note di M. T. BONADONNA-RUSSO, Velletri 1985.
S. LAURENTI, Statuta civitatis Corae, Roma 1732. F. LAZZARI (a cura di), Antonio Mancinelli (1452-1505) pedagogo, gramma-
tico e umanista, «Quaderni della Biblioteca Comunale», 10, Velletri 2005.
IDEM, Il Monte di pietà di Velletri (1470-1940), «Quaderni della Biblioteca Comunale», 9, Velletri 2005.
IDEM, La decarchia medievale, innovazione o persistenza?, in «Annali del La-zio meridionale», 2 (2009).
IDEM, Castra e proprietà medievali del monastero di S. Andrea in Silice (Le Castella), in «Annali del Lazio meridionale», 2 (2011).
IDEM, Il privilegio di Gregorio VII del 14 marzo 1081 ovvero il recupero delle proprietà ecclesiastiche in vario modo alienate, in «Annali del Lazio meridionale», 2 (2013).
IDEM, Il ripopolamento delle antiche civitates romane del Lazio meridionale nell’ottica del primo incastellamento (X-XI secolo), in «Annali del Lazio meridionale», XIV/1, 27 (2014).
IDEM, I Teofilatti nel necrologio del sec. XI del monastero dei SS. Ciriaco e Nico-la in via Lata, in «Annali del Lazio meridionale» XIV/2, 28 (2014).
F. LAZZARI, M. LOZZI, Gli Epigrammi di Antonio Mancinelli, «Quaderni del Centro Studi Antonio Mancinelli», 1, Tivoli 2009.
R. LEFEVRE, Sulla «signoria di Lariano», in «ASRSP», 101 (1978), pp. 375-383.
M. LENZI, Forme e funzioni dei trasferimenti patrimoniali dei beni della Chie-sa in area romana, in «Mélange de l’École française de Rome. Moyen Age», 111, 2 (1999).
IDEM, La terra e il potere. Gestione delle proprietà e rapporti economico-sociali a Roma tra alto e basso medioevo (secc. X-XII), «Miscellanea della So-cietà romana di storia patria» 40, Roma 2000.
IDEM, Per la storia dei casalia del territorio romano dell’alto Medioevo, Note di lavoro, in S. CAROCCI, M. VENDITTELLI, L’origine della campagna romana, casali castelli e villaggi nel XII e XIII secolo, «Miscellanea del-la Società romana di Storia Patria», XLVIII, Roma 2004.
G. LEVI (a cura di), I Registri dei cardinali Ugolino d’Ostia e Ottaviano degli Ubaldini, Roma 1890.
«L’Italia Militare», Torino 1864. M. LILLI, Velletri, Carta archeologica, Roma 2008.
VELLETRI NEL MEDIOEVO
232
E. LUCIDI, Memorie storiche dell’antichissimo municipio ora terra dell'Ariccia, Roma 1796.
A. LUZZATTO, Note sulla presenza ebraica a Orte tra i secoli XIII e XIV, «Quaderni dell’Accademia dei signori disuniti della città di Orte», 7, 1993.
G. MACCHI JANICA (a cura di), Geografie del popolamnto: casi di studio, metodi, ricerche, «Atti della giornata di studi 24-26 settembre 2008», Siena 2009.
A. MAI, Scriptorum veterum nova collectio e Vaticanis codicibus edita, Roma 1831.
R. MAMMUCARI, Velletri, viaggio dentro la città, Velletri 1995. A. MANCINELLI, Horatius cum commentariis, Venezia 1495. IDEM, Sermonum decas, Roma 1503. IDEM, Primus epigrammaton libellus, Roma 1503. IDEM, Vitae Sylva, Venezia 1508. G. MANCINI, Saggi di scavo attorno e sotto la chiesa di S. Maria della Neve o
delle Ss. Stimmate, e scoperta di un tempio volsco, in «Notizie degli Scavi di Antichità», 12 (1915).
IDEM, Scoperta di un antico sepolcreto cristiano nel territorio veliterno, in «Nuovo Bullettino di Archeologia Cristiana», 28 (1922).
F. MARAZZI, Il patrimonium Appiae: beni fondiari della Chiesa Romana nel territorio suburbano della via Appia tra il IV e IX secolo, in «Archeolo-gia laziale», 10 (1990).
IDEM, Roma, il Lazio, il Mediterraneo: relazioni fra economia e politica dal VII al IX secolo, in La storia economica di Roma nell’alto Medioevo alla luce dei recenti scavi archeologici, «Biblioteca di Archeologia Medieva-le», Firenze 1993.
IDEM, I Patrimonia Sanctae Romanae Ecclesiae nel Lazio (secoli IV-X). Strut-tura amministrativa e prassi gestionali, «Istituto storico italiano per il Medio Evo», Roma 1998.
G. MARCHETTI-LONGHI, S. Maria “de Secundicerio”. Topografia medievale di Roma, in «Bullettino Archeologico comunale di Roma», 54 (1926).
J. C. MARIE-VIGUER (a cura di), I podestà dell'Italia comunale. Reclutamen-to e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII-meta XIV sec., (Nuovi Studi storici, 511), Roma 2000.
M. MARINO, Cenni sulle trasformazioni e sul funzionamento delle istituzioni politico-amministrative della città di Tivoli dai trattati del 1257 e 1259 alla restaurazione, in Archivio storico comunale di Tivoli, Inventario del-la sezione pre-unitaria (1257-1870), Roma 2003.
FONTI DI ARCHIVIO E BIBLIOGRAFIA
233
G. MAROCCO, Monumenti dello Stato Pontificio, Roma 1833-1837. C. MENGARELLI, Le indagini archeologiche nel sito di Colle Palazzo: il conte-
sto tardo-antico, in Museo e Territorio, IV, Roma 2005. A. MERCATI, Il decreto e la lettera dei cardinali per l’elezione di Celestino V,
in «Bollettino dell’Istituto Storico Italiano e Archivio Muratoria-no», 48 (1932).
J. P. MIGNE, Patrologiae latinae, t. CLXXIV, Appendix ad Hariulfum, Lute-tiae Parisiorum 1854.
G. MILANI, I comuni italiani, Roma-Bari 2005. G. B. MITTARELLI, A. COSTADONI, Annales camaldulenses ordinis Sancti
Benedicti, I, Venezia 1755. A. MOLINARI, Siti rurali e poteri signorili nel Lazio (secoli X-XIII), in «Ar-
cheologia Medievale», 37 (2010), pp. 129-142. M. MOMBELLI CASTRACANE, L’organizzazione del potere nel ducato di Ser-
moneta tra il 1501 e il 1586, in Sermoneta e i Caetani, dinamiche poli-tiche, sociali e culturali di un territorio tra Medioevo ed eta moderna, «Atti del Convegno della Fondazione Camillo Caetani. Roma-Sermoneta 1993, 16-19 giugno», a cura di Luigi Fiorani, Roma 1999.
G. MOR CARLO, L’età feudale, II, Milano 1953. R. MORGHEN, Carta di S. Andrea in Selci, in Statuti della Provincia Ro-
mana, «Fonti per la storia d’Italia», Roma 1930. G. MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, LXV, Venezia
1854. M. P. MUZZIOLI, Sui tempi di insediamento dei coloni nel territorio, in Urba-
nizzazione delle campagne nell’italia antica, a cura di L. QUILICI e S. QUILICI GIGLI, Roma 2001.
O. NARDINI, L’anfiteatro di Velletri, in «Bollettino dell’Associazione veli-terna di Archeologia, Storia e Arte», 1930, pp. 29-36.
IDEM, Iscrizioni rinvenute in Solluna, in «Notizie degli scavi di antichità», Roma 1922.
F. M. NERINI, De templo et coenobio sanctorum Bonifacii et Alexii historica monumenta, Roma 1752.
A. NIBBY, Analisi Storico-topografica-antiquaria della carta de’ dintorni di Roma, II, Roma 1848.
A. NICOLA, Non disperi l’umana fragilità, Il dramma dell’uomo negli scritti di san Gregorio Magno, Torino 2005.
D. ORANO, Appendice al diario di Marcello Alberini, in «ASRSP», 19 (1896).
VELLETRI NEL MEDIOEVO
234
D. PACCHIANI, Le origini della presenza ebraica a Roma e nel Lazio, in R. PADOVANO (a cura di), La presenza ebraica a Roma e nel Lazio. Dalle origini al ghetto, Padova 2009.
S. PANNUZI, Recenti indagini archeologiche presso la chiesa di S. Aurea nel borgo di Ostia antica, in «Atti del IV Congresso Nazionale di Ar-cheologia Medievale», 26-30 settembre 2006.
EADEM (a cura di), Il castello di Giulio II ad Ostia antica, Firenze 2009. N. PARISE, Cardinali Luigi, in «Dizionario Biografico degli Italiani», 19,
1979. E. PARZIALE, Castrum Sancti Ianuarii: il castello degli Annibaldi presso Vel-
letri, in «Arte medievale», n. s. III (2004), 1, pp. 59-70. H. PATTERSON, Rural settlements and economy in the middle Tiber valley:
AD 300-1000, in «Archeologia Medievale», 37 (2010), pp. 143-161. N. PAVONCELLO, Le comunità ebraiche laziali prima del bando di Pio V, in
«Rinascimento nel Lazio», fascicolo monografico di «Lunario ro-mano», IX, 1980.
P. PENSABENE, Ostiensium marmorum decus et decor, Studi architettonici, Roma 2007.
G. PESIRI, Sermoneta: 1499-1503, in Roma di fronte all’Europa al tempo di Alessandro VI, «Atti del Convegno. Città del Vaticano-Roma, 1-4 dicembre 1999», a cura di M. CHIABÒ - S. MADDALO - M. MIGLIO - A. M. OLIVA, Roma 2001, pp. 657-704.
IDEM, La presenza agostiniana a Cori nelle “Notitie” di padre Tommaso Bona-soli, in «Annali del Lazio meridionale», 2 (2005).
E. PETRUCCI, Pievi e Parrocchie nel Lazio nel basso Medioevo, in Pievi e par-rocchie in Italia nel basso Medioevo, sec. XIII-XV, Roma 1984.
P. PORTA (a cura di) Anonimo Romano, Cronica, XVIII, Milano 1981. P. PRESSUTTI (a cura di), Regesta Honorii papae III, I, Roma 1888. L. QUILICI, La via Appia antica attraverso il territorio di Velletri, in Augusto
a Velletri, «Atti del convegno di studio, (Velletri 16 dicembre 2000)», Velletri 2001.
A. REMIDDI, Velletri, memorie storiche, 2, Velletri 1982. F. M. RENAZZI, Storia dell'università degli studj di Roma, detta la Sapienza, I,
Roma 1803. I. P MANOY, , in Deltion tēs Historikēs kai, Ethnolo-
gikēs Hetaireias tēs Hellados, 2, Athenais 1885, 1889. F. ROTH, O. E. S. A., Cardinal Richard Annibaldi: First Protector of the
Augustinian Order 1243-76, in «Augustiniana», II (1952), pp. 26-60, 108-49, 230-47; III (1953), pp. 21-34, 283-313; IV (1954), pp. 5-24.
FONTI DI ARCHIVIO E BIBLIOGRAFIA
235
A. RUGGERI, Appendice topografica, in M. T. CACIORGNA (a cura di), Santa Maria di Grottaferrata e il cardinale Bessarione. Fonti e studi sul-la prima commenda, Roma 2005.
R. SABBADINI, Antonio Mancinelli, saggio storico-letterario, Velletri 1878. M. SANFILIPPO, Agro Romano: storia di un nome e di tante realtà diverse, in
«Studi in onore di Giosuè Musca», Bari 2000. F. SANTONI, Notarius civitatis. Rileggendo le fonti tra VI e XI secolo, (pp.
205-223), in Civis/Civitas. Cittadinanza politico-istituzionale e identità socio-culturale da Roma alla prima età moderna, «Atti del Seminario internazionale (Siena-Montepulciano 10-13 luglio 2008)», a cura di C. TRISTANO e S. ALLEGRIA, Montepulciano 2009.
F. SAVIO, Gli Annibaldi di Roma nel secolo XIII, in «Studi e documenti di storia e diritto», XVII (1896).
G. SAVIO, Monumenta onomastica romana Medii Aevi (secc. X-XII), II, Roma 1999.
U. SAVO, Velletri nelle sue cartoline d’epoca, Velletri 2007. C. SCACCIA SCARAFONI (a cura di), Le carte dell’archivio capitolare della
cattedrale di Veroli, ISALM, Roma 1960. R. SCURO, La presenza ebraica a Vicenza e nel suo territorio nel Quattrocen-
to, in Ebrei nella Terraferma veneta del Quattrocento, «Atti del Conve-gno di studio (Verona, 14 novembre 2003)» a cura di G. M. VA-
RAINI e R. C. MUELLER, in «Quaderni di Reti Medievali», 5, Fi-renze 2005.
G. SILVESTRELLI, Città, castelli e terre della regione romana: ricerche di storia medioevale e moderna sino all’anno 1800, Roma 1993, Ripr. facs. del-l'ed. Roma 1940.
S. SIMONSOHN, The Apostolic See and the Jews. Documents, «Pontifical In-stitute of Mediaeval Studies», Toronto 1990.
G. SCHNEIDER GRAZIOSI, L’antico cimitero cristiano di Velletri, in «Bullet-tino della Commissione Archeologica Comunale di Roma», XLI (1913).
IDEM, L’antica «Porta Romana» di Velletri, in «Bollettino d’Arte», I-II, 1917, pp. 7-27.
A. SOMMERLECHNER (a cura di), Innocenzo III Urbs et Orbis, «Atti del Congresso Internazionale Roma, 9-15 settembre 1998», Istituto storico italiano per il medio evo, «Società romana di storia patria», Roma 2003.
F. R. STASOLLA, Il ruolo delle signorie monastiche nell’articolazione del popo-lamento del Lazio medievale, in G. MACCHI JANICA (a cura di), Geo-
VELLETRI NEL MEDIOEVO
236
grafie del popolamnto: casi di studio, metodi, ricerche, «Atti della gior-nata di studi 24-26 settembre 2008», Siena 2009.
EADEM, Per una ricerca sul medioevo rurale nel Lazio meridionale, in G. GHINI (a cura di), «Lazio e Sabina», 7, Roma 2012.
E. STEVENSON, Documenti dell’archivio della cattedrale di Velletri, in «ASRSP», 12 (1889), pp. 63-133.
I. STUART ROBINSON, The Papacy, 1073-1198, Continuity and Innovation, Cambridge 1990.
A. TERSENGHI, Velletri e le sue contrade, Velletri 1975, rist. anast. dell'e-dizione del 1910.
T. TESTONE, I Regesti delle pergamene dell’Archivio Capitolare di Velletri, Velletri 1998.
A. THEINER, Codex diplomaticus dominii temporalis Sanctae Sedis, 3 voll., Roma 1861-1862.
B. THEULI, Teatro Historico di Velletri, Velletri 1644, (rist., Bologna 1968).
IDEM, Il Convento di S. Francesco in Velletri, in «Apparato Minoritico del-la provincia di Roma», Roma 1648.
A. TOAFF, Il vino e la carne. Una comunità ebraica nel Medioevo, Bologna 1989.
G. TOMASSETTI, Del sale e del focatico del Comune di Roma nel Medioevo, in «ASRSP», 20 (1897), pp. 313-368.
IDEM, La campagna romana, antica, medievale, moderna, II, nuova ed. ag-giornata, Curr. L. CHIUDENTI e F. BILANCIA, Firenze 1979.
P. TOUBERT, Les structures du Latium médiéval, Le Latium méridional et la Sabine du IX siècle à la fin du XII siècle, «École Française de Rome», «Bibliothèque des Ècoles françaises d'Athènes et de Rome, 221», 1973.
B. TRIFONE, Le carte del monastero di San Paolo di Roma dal secolo XI al XV, in «ASRSP», 31 (1908), pp. 267-313.
M. VENDITTELLI, Signori, istituzioni comunitarie e statuti a Sermoneta tra il XII e il XIV secolo, in Sermoneta e i Caetani, dinamiche politiche, socia-li e culturali di un territorio tra Medioevo ed età moderna, «Atti del Convegno della Fondazione Camillo Caetani. Roma-Sermoneta 1993, 16-19 giugno», a cura di L. FIORANI, Roma 1999.
IDEM (a cura di), Sutri nel Medioevo. Storia, insediamento urbano e territorio (secoli X-XIV), Roma 2008.
D. VERA, Forme della grande proprietà e poteri della città in Italia tra Costan-tino e Gregorio Magno, in «Mélange de l’Ecole française de Rome», Antiquité T. 111, 2, 1999.
FONTI DI ARCHIVIO E BIBLIOGRAFIA
237
A. VERONESE, Famiglie di banchieri ebrei attive nel Ducato di Urbino tra XIV e XV secolo, in «Zakhor, Rivista di storia degli ebrei d’Italia», III, Roma 1999.
G. VILLANI, Cronica, Firenze 1832. G. VOLPE, Il ruolo dei vescovi nei processi di trasformazione del paesaggio ur-
bano e rurale, in Archeologia e società tra Tardo Antico e Alto Medioevo (a cura di G.P. BROGIOLO, A. CHAVARRÌA ARNAU), «SAP Società Archeologica», Mantova 2007.
G. R. VOLPI, Latium vetus sacrum et profanus, IV, De Veliternis et Coranis, Padova 1727.
C. WICKHAM, Nobiltà romana e nobiltà italiana prima del mille: parallelismi e contrasti, in S. CAROCCI (a cura di), La nobiltà romana nel Medioe-vo, Roma, «École française de Rome», Roma 2006.
IDEM, Roma medievale, Crisi e stabilità di una città, 900-1150, Roma 2013. R. ZACCAGNINI, Est mihi libertas …? Il punto sullo stemma di Velletri, Velle-
tri 1991.
Abbazia di Grottaferrata, 171, 173 Abramo da Velletri ebreo, 202 Acquapuzza, 69, 85n, 114 Adriano I papa, 22n, 172 Adriano IV papa, 71n, 89n, 217 Adriano dux, 33n Aisaida, 56, 58 Alatri, 43n, 79, 80, 80n, 87, 87n Albano, 26, 47, 52n, 55, 56, 58,
104, 116n, 131 Alberico princeps, 32, 33, 47, 52,
56n Alberico III di Tuscolo, 48, 51 Alberico da Barbiano, 108 Alberini v. Ilperini Alessandro II papa, 54 Alessandro IV papa, 81, 83, 85n,
92, 133 Alessandro VI papa, 118, 118n Alfonso di Calabria, 115 Algido, 90, 146, 175n Alperino v. Ilperino Aluino presbitero, 188 Amato Paribone, 67 Amelia, 97 Amico di Biagio, 200 Anacleto II antipapa, 66, 212 Anagni, 43n, 70, 73, 78, 79, 79n,
80n, 83, 87n, 88, 94n, 108, 146, 199, 201
Anastasia moglie di Milone, 41
Anastasio martire, 80n Anastasio IV papa, 89n, 217 Ancaria, 171 Andrea de Stesante, 142n Andrea di Giannettola, 201 Andrea di Giovanni, 104 Andrea di Nicola di Bartolomeo,
100 Angelo caldarario, 123 Angelo de Cantusecuto, 104 Angelo dello Schiavo ebreo, 200 Angelo di Ventura ebreo, 201 Annibaldi famiglia, 70, 81, 82,
83, 84, 85, 87n, 90, 91, 93, 93n, 159
Annibaldi Giovanni di Trasmon-do, 93
Annibaldi Niccolò di Riccardo senatore di Roma,
Annibaldi Paolo della Molara, 113 Annibaldi Pietro, 70, 84 Annibaldi Riccardello, 90, 90n Annibaldi Riccardo vescovo, 81,
81n, 83, 84n, 196 Annibaldi Riccardo di Giacomo
de Urbis, 93 Annibaldi Teobaldo, 87 Annibaldi Trasmondo, 85 Anzio, 29n, 171 Ardea, 116 Arenata v. S. Andrea in silice
INDICE DEI NOMI E DI LUOGO
VELLETRI NEL MEDIOEVO
240
Ariccia, 85n Arrigo II, 26 Arrigo VII di Lussemburgo, 94 Artemisio monte, Celio, Spina, 62,
140, 167 Artena, Montefortino, 146 Arzignano, 202, 203n Assisi, 88, 195 Attendolo Micheletto, 113 Augusto Cesare Ottaviano, 21n,
22n, 171, 174 Avignone, 89n, 94, 95, 98, 101,
102, 108, 134, 161n, 217 Baduaro consul et dux, 189 Baldovino I, 77, 78n Balduino, 33n Barozzi Giacomo da Vignola,
147n, 148 Bassiano, 80n, 85 Bauco Tommaso, 82n, 93n, 176,
208, 212, 216, 218 Bello di Giovanni massaro, 124 Benedetto VII papa, 49 Benedetto VIII papa, 46n, 50 Benedetto IX papa, 50, 51, 51n Benedetto X antipapa, 51, 211 Benedetto XI papa, 93, 91 Benedetto XII papa, 98 Benedetto abate subl., 46n, 47 Benedetto Campanino consul et
dux, 33n, 139n Benedetto da flumen, 33n Benedetto di Leone di Aza, 33n Benedetto di Sergio, 33n Benedetto Mitcino, 33n Beniamino de Melone ebreo, 204 Bentorello di Benedetto ebreo, 192 Beolchini Valeria, 52n Bernardino Lorenzo, 135 Berta ancilla Dei, 55, 56 Berta figlia di Giovanni di Deme-
trio, 55, 56, 57
Biagio di Cola di Nardo, 202 Bindo de’ Bardi senatore di Ro-
ma, 104, 194 Biondo Flavio, 129 Bisanzio, 19 Bolagai v. Ponte di Mèle Boldo Ludovico uditore, 192n Bona figlia di Giovanni di Deme-
trio, 55, 56, 56n, 57 Bonadonna Russo M. Teresa,
108n, 117n, 209n Bonanni Boccabelli podestà, 120 Bonasoli Tommaso padre agosti-
niano, 198n Boncore famiglia ebrea, 201 Bonifacio vescovo, 20 Bonifacio VIII papa, 75, 88, 91,
92, 93, 121, 209 Bonifacio IX papa, 105, 111, 197 Boniza abitante del castello di
Velletri, 17, 38, 38n Boniza di Demetrio consul et dux,
38n, 45n, 57 Borgia Alessandro, 13, 14, 15, 16,
34, 35n, 37n, 60, 66n, 67n, 70, 89n, 93n, 115n, 125, 131n, 151n, 176, 181n, 181n, 182n, 183n, 186n, 187n, 188n, 208, 209, 210, 211, 212, 215, 216, 217, 218, 219, 220
Borgia Cesare, 117 Borgia Clemente Erminio, 15,
210n, 211, 212, 214 Borgia Pietro di Gorio, 117 Borgia Rodrigo v. Alessandro VI Borgia Stefano, 14, 26, 66n, 83n,
133, 215 Bosone Breakspeare, 71n Branca di Giovanni, 96 Brancaleone degli Andalò, 83 Bretoni, 109, 110 Caciorgna Maria Teresa, 198n Cacumen monte v. Artemisio
INDICE DEI NOMI E DI LUOGO
241
Caesariana massa, 44 Caetani famiglia, 84n, 91, 108,
109, 118, 198 Caetani Benedetto conte Palatino
e di Pofi, 94n, 98, 109 Caetani Bonifacio, 94n Caetani Giovanni, 142 Caetani Giacomo conte Palatino,
109 Caetani Niccolò (Nicola), 98, 99,
142 Caetani Onorato I, 44n, 107,
108, 109, 111, 123, 142, 197 Caetani Sanzia, 103 Caiano, Caniano fondo, 166, 183 Campagna provincia, 71, 73, 75,
76, 76n, 79, 80, 80n, 81, 85n, 90, 91, 92, 99, 101, 108, 112, 142, 197, 198n, 199, 205n
Campoleone, 116n, 143n Campomorto, S. Pietro in formis,
44n, 62, 114, 116, 142, 143n, 173
Cancellieri Lazzaro senatore di Roma, 102, 196
Cantelmi Giacomo, 90 Capocci Niccolò, 102 Caprolace lago, 46n Capua, 146 Carano, 62, 165, 183 Cardinali Clemente, 9, 128n,
210, 212, 218 Cardinali Luigi, 66n, 76, 82n,
95n, 126, 126n, 208, 208n, 213, 214, 215, 216, 218, 220
Carlo Magno, 175n Carlo VIII, 117, 144 Carlo di Durazzo re di Napoli,
110 Casa della Ragione, 156 Casafondata, 151 Casale dei Corsi, 151 Casale Moreni, 56
Case Nuove, 151 Castelgandolfo, 117 Castrum vetus, 44, 44n, 49, 64n, 143 Caterina del Balzo, 108 Cecco Cimini, 110 Cecco Mancini, 103 Celestino V papa, 132 Celio monte v. Artemisio Cencio Savelli camerario v. Ono-
rio III Ceprano, 98 Champagne, 144 Chiese:
- San Clemente in Roma, 21 - San Donato in Fogliano, 46n - San Pietro in Cori, 84n - San Pietro in Fondi, 107 - San Pietro in Roma, 34 - Sant’Alessio in Roma, 100 - Sant’Arcangelo in Cori, 84n - Sant’Aurea in Ostia, 131, 132, 133, 133n, 134 - Sant’Oliva in Cori, 84n - Santa Maria di Fossanova, 46n - Santa Maria in via Lata in
Roma, 55, 132n - Santa Sabina in Roma, 100
Chiese in Velletri: - San Benedetto, 16, 177n - San Blasio, 16, 177n - San Clemente, 16, 20, 21,
28, 36, 37, 51n, 64, 65, 65n, 80, 81, 82, 82n, 86, 122, 130, 134, 138, 139, 154, 159, 167, 174, 176, 179, 181, 216
- San Dionisio, 16, 177n - San Giacomo di Teto, 177n - San Martino, 152, 154, 156n,
159 - San Michele Arcangelo, 128n,
154
VELLETRI NEL MEDIOEVO
242
- San Nicola, 16, 177n - San Pantaleone, 177n - San Pietro in querceto, 16,
22, 30, 30, 173, 174, 177n, 180 - San Rocco, 129, 148n, 150,
152, 177, 219 - San Salvatore, 154, 159, 218,
220 - San Tomao, 30, 172, 173 - Sant’Agnese, 177n - Sant’Antonio, 148n, 149,
156, 157 - Sant’Antonino in strada, 16,
177n - Santa Lucia, 16, 45, 86, 88,
174n, 202 - Santa Maria della Neve, 214n - Santa Maria in Trivio, 157,
202 - Santa Maria dell’Orto, 60,
180 - Santa Maria in Portella, 150,
150n - Santa Maria in Pontone, 150,
150n - Santa Maria e SS. Giovan-
ni e Paolo iuxta silice, 51 - Santo Stefano, 30, 128, 172,
177, 219 Circeo, 37n, 47 Cisterna, 44n, 85n, 96, 97, 103n,
142, 172 Clemente III antipapa, 60, 61,
61n, 207 Clemente IV papa, 90 Clemente V papa, 93 Clemente VI papa, 188n Clemente VII antipapa, 104, 107,
108, 110 Cluver Philipp, 129 Cola Ciccaroni massaro, 124 Cola di Nardo sindaco del castel-
lo di Lariano, 113, 202
Cola di Rienzo, 99, 100, 101 Cola Guerci notaio, 123 Colli Albani, 29n, 146, 165 Colonna famiglia, 91, 93, 101,
109n, 111, 113, 114, 115, 198 Colonna Agapito, 198 Colonna Fabrizio, 110 Colonna Niccolò, 111 Colonna Oddone v. Martino V Colonna Prosperetto, 128n Colonna Stefano, 103 Comacchio valli, 140, 166 Conca, 44n, 142 Confraternita del Gonfalone, 151n Contatore Domenico Antonio, 72 Conti famiglia, 70, 104 Conti Adinolfo, 109 Conti Alto, 112 Conti Jacopo, 116 Conti Ottaviano vescovo, 70 Conti Ugolino v. Gregorio IX Corfù, 78n Cori, 69, 70, 70n, 72, 84, 84n,
85n, 90, 94, 94n, 104, 109, 124n, 149, 193, 198, 204
Corradi Angelo abate, 173 Corradino, 90n Corrado II il Salico, 51n Corrado di Suburra v. Anastasio
IV Cortona, 201 Costantino, 44n Costantino V, 23n Costantinopoli, 77, 78, 78n, 82n Costanza abitante del castello di
Velletri, 17, 38, 38n Costanza città, 111 Costanza di Stefano de Imiza, 56 Costanza moglie di Giovanni di
Demetrio, 38n, 55, 56, 57 Coste Jean, 221n Crescenzi famiglia, 47, 48, 49, 50,
53, 56n, 57
INDICE DEI NOMI E DI LUOGO
243
Crescenzio [presente al placito del 942], 33n
Crescenzio (II), 48, 49 Crescenzio di Melioso, 55 Crescenzio di Teodora, 42, 49,
64n D’Angiò Carlo, 89, 90, 92, 144 D’Angiò Carlo II, 93 D’Angiò Giovanna di Napoli,
111 D’Angiò Luigi duca, 110 D’Estouteville Guglielmo cardina-
le Rotomagense, 114, 127, 128n, 134, 151n, 218
Daiferio consul et dux, 41, 48 Dattero di Manuello ebreo, 201 Dattolo di Manuele iudeus de Co-
ra, 198 Dazani Pietro, 67 de Albiòn Juan, 117 de Fonseca Antonio, 117 de Imiza famiglia, 48, 56n de Imiza Stefano, 56, 57 de Malleotiis Paolo podestà di
Velletri, 111 de Primicero famiglia, 56n De Prosperis Giuseppe, 216, 216n Del Bufalo Pietro, 109 Del Vecchio Antonio, 109 Decarcie, Carcie in Alatri, 79,
79n, 80n, 87, 87n Decarcie, Carcie in Anagni, 79,
79n, 80n Decarcie in Bassiano, 80n, 85,
85n Decarcie in Corfù, 78n Decarcie in Fiandra, 77, 77n Decarcie in Sermoneta, 84, 84n,
87 Decarcie in Sezze, 79, 80, 80n,
83, 86, 87 Decarcie in Velletri, 38, 76, 76n,
80, 80n, 83, 86, 87, 88, 99, 105, 107n, 122, 124, 154, 155, 216 - Castello, 88, 124, 154, 220 - Collicello, 83, 88, 124, 154, 156 - Portella, 78, 88, 124, 146, 154, 156, 192 - S. Lucia, 88, 156, 202 - S. Maria, 88, 156, 202 - S. Salvatore, 88, 124, 154, 220
Della Porta Giacomo, 147n Della Rovere Giuliano v. Giulio II Della Valle famiglia, 115 Demetrio arcarius, 33 Demetrio di Melioso consul et dux,
15, 16, 27, 33, 33n, 36, 37, 44, 45, 45n, 46, 46n, 47, 52, 52n, 53n, 54, 55, 57, 137, 168n, 180, 181, 182, 189, 190n, 216
Demetrio di Giovanni, 54, 55, 56, 57, 58
Diana Efesina, 127, 219 Diocesi:
- Alatri, 87n - Albano, 26 - Anagni, 87n - Ferentino, 87n - Gabi e Labico, 131 - Ostia e Velletri, 67, 67n, 130,
131, 131n, 132, 132n - Palestrina, 131 - Porto e Santa Rufina, 132,
132n - Sabina, 131, 132n - San Marco, 132n - Sant’Adriano, 132n - Sant’Eustachio, 132n - Santa Maria in Portico, 132n - Santa Maria in via Lata, 132n - Santa Sabina, 132n
VELLETRI NEL MEDIOEVO
244
- SS. Silvestro e Martino ai Monti, 132n
- Veroli, 36n, 87n - Tuscolo, 131, 132n
Domenico prete, 43, 138 Ducato romano, 23, 26, 43 Egidio d’Albornoz, 101, 103 Elia di Benedetto ebreo, 204 Emanuele di Menaguzolo ebreo,
201 Emilia Romagna, 192n Enrico V, 63 Eugenio III papa, 67, 67n, 131n Eugenio IV papa, 113, 114, 202 Euplogio praefecto Urbis, 21 Faiola castello, 62, 114, 116 Faiola mcchia, 106, 151 Federico Barbarossa, 68 Federico II, 73, 85, 89 Ferentino, 83, 87, 205n Filetico Martino, 128, 129n, 219 Flora di Aleuccio ebrea, 201 Foliano (Fogliano) fondo, 46,
46n, 49, 50, 50n Fondi città, 72, 98, 99, 107, 108,
109 Fondi e contrade in Velletri:
- Acquavivola, aqua viva, aqua bibula, Aqua buia, 16, 36, 140, 179, 183, 184
- Acqua di Erbellone, 164, 183 - Acqua Lucia, 62 - Acqua Palomba, 62, 164 - Ancarano, 22, 171, 182 - Ara di Stanga, 115n - Bagno Nuovo, 164 - Bassetti, 175, 183 - Bespoleto, 167, 182 - Bussetuli, Bussitoli, 175 - Calvello, 167, 168, 182, 182n - Campo Mosevo, 165, 183
- Capanna Murata, 165, 171 - Capitancelli, 175 - Carano, Plagaro Carano, 165,
183 - Carbonara, 174, 180 - Carcano, Carciano, 175, 183 - Casa Catelli, 169 - Casale dei Pescatori, 137,
140, 164, 170, 182 - Casale Cerqua revaliosa, 28,
30, 180, 184 - Casale Cesarea, 30, 137, 173,
182 - Casale in plano de formis, 175 - Casconi v. Cosconi - Castel Ginnetti, 151 - Cesa Presbitero, 169, 182 - Cesa Raineri, 164, 169, 183 - Cigliolo, Lociolu, 140, 171,
176, 176, 183 - Colle Cicerchia, 174 - Colle d’Oro, 174, 175 - Colle dei Marmi, 167 - Colle dell’Orto, 179 - Colle di Benione manioso,
164 - Colle Formica, 174 - Colle Ionci, Gliocni, 28, 171,
182 - Colle Ospedale, 173 - Colle Ottone, 167, 168, 168n - Colle Palazzo, 36, 36n, 179 - Colle Perino; Casale Colle de
Ilperino, 174, 174n, 175, 178 - Colle Petrone, 140 - Colle Pipino, 140 - Colle S. Giovanni, 168 - Colle Scarano v. Ancarano - Cornarolo, 173, 182 - Cosconi, 22, 168, 169, 178, 182 - Cripta Rubea, 172, 182 - Due amanti, Domanti, 28,
169, 182
INDICE DEI NOMI E DI LUOGO
245
- Episcopio, 86, 138 - Forconi, 168, 182 - Formello, 172, 182 - Gizzi, 28, 164, 175, 183 - La Chiusa, 176 - La Parata, fundus Paritorum,
28, 29, 171, 182 - Lazzaria, 29n, 44n, 143, 165 - Le Corti, 16, 164, 175, 178 - Lociolu v. Cigliolo - Lupacchiotti, 175 - Malatesta, 115n, 164, 174,
175, 175n - Mensa latronis, 164, 183, 184 - Monaci, 165, 172 - Mucianus, 169 - Muracce, 165 - Orselli, 174, 182 - Paganico, 22, 28, 168, 170,
177n, 181, 182 - Papazzano, 16, 28, 140, 176,
183, 216 - Paritorum v. La Parata - Ponte di Mele, Bolagai, 140,
165, 166, 169, 221 - Prato di Canudello, 164 - Prato di Maggio, 165 - Pullano, Puliano, 28, 178, 183 - Rioli, Revoli, 28, 140, 176, 183 - S. Pietro, 16, 22, 28, 30, 172,
173, 174, 177n, 180, 182 - S. Stefano, 28, 38, 172, 177,
178, 183 - S. Tomao, S. Tommaso, 22,
28, 30, 172, 173, 183 - Salginano fossato, 165, 183 - Sambuci, 176, 183 - Scazi; Scazzi, 28, 51n, 165,
171, 182, 183 - Soleluna, 22, 28, 170, 182 - Stuti, 165, 166, 183 - Terra del fontanile, 164 - Tevola, 140
- Tornarolo v. Cornarolo - Torano, 174, 182 - Valle dell’Orto, 179 - Valle di Cento Gocce, 164 - Vallescura, 176, 183
Fontana Benedetto tipografo, 219n Fontana di Caiano, 166 Fozio, 27n Fra’ Raimondo, 91 Franchi, Franchi Ilperini, 19, 27,
39, 71n, 175n Franco [presente al placito del
942], 33n Franco comes, vir nobilis, 16, 47,
53n, 57, 174n Frangipane Riccardo, 103n, 109n Fumone, 85n Gabrielli Attilio, 71n, 72, 195n,
218 Gaio Ottavio, 171 Gallese, 43n Galliani Francesco notaio, 121n Garigliano, 32, 171 Gauderico vescovo, 27, 27n, 66,
66n Gelasio I papa, 20 Gelasio II papa, 63 Genazzano, 110 Genzano, 45, 166 Gesualdo Alfonso vescovo, 192n Giacomo di Acquasparta, 127, 128 Giacomo di Velletri podestà di
Sutri, 98 Ginnetti Giovan Paolo, 126,
126n, 215 Ginnetti Marzio cardinale, 126n,
173, 173n Ginnetti palazzo, 15 Giorgio de Cannapara dux, 33n Giovanni VIII papa, 66 Giovanni X papa, 32, 33n Giovanni XII papa, 34, 47
VELLETRI NEL MEDIOEVO
246
Giovanni XIII papa, 41, 49 Giovanni XV papa, 49 Giovanni XIX papa, 50 Giovanni XXII papa, 93, 96, 98 Giovanni XXIII antipapa, 112 Giovanni camerarius, 67, 139 Giovanni consul et dux nel 913,
34n Giovanni eminentissimus consul et
dux nel 913, 34n, 57 Giovanni da Ceccano, 94n Giovanni di Demetrio consul et
dux, 16, 33n, 38n, 45, 45n, 46, 46n, 49, 54, 55, 57, 174n
Giovanni di Giuratto di Meo, 201 Giovanni di Maria Antedonia, 139 Giovanni di Pietro Mete, 100 Giovanni Diacono, 27, 66 Giovanni illustris vir, dux marito di
Costanza de Imiza, 56 Giovanni Mincio v. Benedetto X Giovanni patricius, 50 Giovanni scrinario, 43 Giovanni superista, 33n Giovanni vescovo (a. 593), 64, 65 Giovanni vescovo (a. 1087), 60 Giovanni vescovo verolano, 34n Giovanni vir nobilis marito di Bo-
na, 55, 57 Giulio II papa, 125, 134 Giustiniano, 15, 215 Goffredo di Toscana e Lorena, 51 Gori famiglia, 192n Grasso macellaio cittadino di Vel-
letri, 193 Gregorio II papa, 167 Gregorio II dei Conti di Tuscolo,
50, 54, 54n, 52n Gregorio VII papa, 38, 51, 59,
59n, 130 Gregorio IX papa, 62, 68n, 69,
73, 73n, 74, 83, 85, 88, 105, 119, 130, 134, 164, 216
Gregorio X papa, 92 Gregorio XI papa, 134 Gregorio XIII papa, 135 Gregorio consul et dux dei Conti
di Tuscolo, 49, 52, 52n, 50, 50n
Gregorio consul et dux marito di Teodora di Demetrio, 53n, 57
Gregorio del prete franco, 52, 52n
Gregorio dell’Aventino, 33n Gregorio di Santo Apostolo, 73n Gregorio Magno papa, 44n, 64,
65n Gregorio marito di Berta, 57, 58 Gregoriopoli, 133n Grottaferrata abbazia, 129n, 170n,
171, 173 Gualtiero di Sumoroso, 90 Guglielmo II vescovo di Troia, 82n Guglielmo de Braio, 91 Guglielmo di Novara, 90 Guido Frassia prete, 51 Guidoni Crispino notaio, 142n,
200n Guidoni Pietro, 85 Guittimanno scriniario, 43, 54 Herdonia, 26 Iacobuzi Leonardo notaio, 97 Ildebrando di Soana, v. Gregorio
VII Il perini famiglia, di Sant’Eusta-
chio, 175n - Ilperino, Alperino, 175n - Giacomo de Alperinis, 175n
Innocenzo II papa, 66 Innocenzo III papa, 46n, 60, 70,
78, 78n, 79, 81, 92, 175, 178 Innocenzo IV papa, 81, 87, 88,
191 Innocenzo V papa, 81
INDICE DEI NOMI E DI LUOGO
247
Innocenzo VI papa, 101 Iovine Cola Salomone, 194 Jacob di Mosè ebreo, 202 Jacovacci Giacomo podestà di
Velletri, 125n Jannelli Davide di Pietro, 67 Josep di Abramo ebreo, 202, 203n Julianus fondo, 44n Ladislao di Durazzo re di Napoli,
111, 112 Landi famiglia, 192n Landi Ascanio, 15, 73, 93n, 108,
108n, 110, 110n, 117, 127, 129, 208, 209, 209n, 211, 219
Landolfi Luca magister, 194 Lanuvio, 44n, 93n, 128n, 129,
143, 143n, 146, 169, 219 Lariano castello, 28, 62, 85n, 90,
90n, 91, 104, 105, , 113, 114, 116, 153, 153n, 156, 156n, 161, 175n, 202, 209
Lariano sabino, 175n Latroni famiglia, 164 Lavinio, 129, 219 Lazio, 14, 24, 24n, 26n, 29n,
36n, 37n, 42n, 68, 69n, 78, 91, 98n, 128n, 131n, 152n, 191n, 192n, 199, 205n
Le Castella, 44n, 50n, 142, 164 Lello Tudini massaro, 124 Leno Alessio, 195, 197 Leno Giordano, 195, 197 Lenzo ebreo, 194 Leonardo di Gorio v. Nardo di
Gorio Leonardo Patrasso, 88 Leo dux Terracinensis, 48 Leo consul et dux, 189, 190n Leone (I) vescovo di Velletri, 15,
34n, 35, 37, 64, 181, 188, 188n
Leone (II) vescovo di Velletri, 179 Leone di Musetto ebreo, 199 Leone secundicerio, 188 Lepini monti, 29n, 68n Lepontonne casale, 116n Lerici (Lercia) Giovanni, 117,
117n Licaonia isola v. Tiberina Lione, 81, 195 Liutprando da Cremona, 34 Lollius Cyrius, 20 Lorenzo detto Grievolo della re-
gione Ripa, 194 Lotario dei Conti di Segni v. In-
nocenzo III Lucio III papa, 68, 68n Ludovico il Bavaro, 96, 101 Ludovico il Pio, 26 Maderno Carlo, 157 Maecia, 165 Maenza, 37n Malabranca Angelo, 99 Malabranca Latino vescovo, 132 Malatesta Roberto, 115, 115n,
116 Mancinelli Antonio, 82n, 102n,
110, 110n, 113, 117, 127, 128, 129, 140n, 143, 148, 153, 153n, 154, 157, 202n, 203, 209n, 218, 219
Mancinelli Giovanni, 203 Mandra, Casale della Mandria,
44n, 143 Manfredi figlio di Federico II, 89 Manilano fondo, 36n Manuele di Boncore ebreo, 201 Manuele di Leone di Musetto
ebreo di Orte, 199 Marca Anconitana, Marche, 85n Marco Aurelio imperatore, 129 Marchi Jannis Egidio podestà di
Amelia, 97
VELLETRI NEL MEDIOEVO
248
Maria moglie di Gregorio di Tu-scolo, 52n
Marino città, 104, 108, 109, 146, 151, 204
Marino II papa, 33, 59 Marittima, 46n, 50, 53, 63, 68,
69, 71, 73, 75, 76, 79, 80, 80n, 81, 81n, 85n, 90, 91, 92, 99, 101, 107, 108, 112, 160, 191, 193, 196, 197, 198, 200
Marozia madre di Alberico prin-ceps, 32
Marozia senatrix madre di Grego-rio di Tuscolo, 49, 52, 52n, 53
Marozia nipote di Demetrio di Melioso, 47, 52, 52n
Marozza illustrissima femina moglie di Demetrio di Giovanni, 57, 58
Marozza nobilissima femina moglie di Demetrio di Melioso, 46, 57
Martino IV papa, 89 Martino V papa, 107, 112, 134 Maruti, 151 Massarucoli Angelo di Amelia, 97 Matano fosso, 150, 150n Melati Jacopo, 96 Meliosi famiglia, 46, 48, 49, 52,
52n, 53, 55 Melioso piscator, 55, 55n Mezzaposta, 151 Milone vir nobilis, 41 Molara castello, 96 Mons Maiorinulus castello, 180 Montalto di Castro, 101, 201 Montefortino v. Artena Monticelli Ludovico, 117 Morandino di Boccobardi, 102,
157 Mormosolio monastero, 67n, 131n Morone Giovanni G. vescovo, 135 Mosè (Musetto) di Abramo ebreo
di Velletri, 202 Mosè Remos ebreo di Maiorca,
198
Mulini, 81, 139, 172 - del Giudice, 139 - della Pentoma, 139 - del Pertuso, 139
Muro Lucano castello, 111 Musetto di Abramo ebreo de Ur-
be, 199 Napoli, 32n, 88, 110, 111, 117,
126n, 145 Nardo di Gorio, 103, 103n, 192n Nardo di Stefano sindaco del ca-
stello di Lariano, 113 Nemi, 44n, 115, 116n, 127, 143,
166 Nepi, 43n Niccolò III papa, 90 Niccolò V antipapa, 96 Niccolò V papa, 114 Niccolò di Piglio, 99 Nicola consul et dux, 189 Nicolai Nuzio Giovanni, 144n Ninfa, 23n, 63, 68n, 69, 70, 85n,
88n, 99, 108, 109, 121, 141, 198
Norma, 23n Onorio III papa, 71n Orazio, 127, 129, 129n, 218 Orléans, 21 Orsini famiglia, 91, 98, 104, 115 Orvieto, 89 Orte, 43n, 199, 199n Osterie di Sermoneta, 151 Ostia, 67, 67n, 85n, 112, 112n,
131, 132, 132n, 133, 133n, 134
Otone Marco Salvio, 166n Otricoli, 43n Ottavia famiglia, 14, 209, 211 Ottaviani famiglia, 57 Ottaviano de’ Conti vescovo, 70 Ottavio Onesimo, 146 Ottone I, 26, 34, 167n Ottone III, 48, 49, 56n, 167n
INDICE DEI NOMI E DI LUOGO
249
Ottone nipote dell’antipapa Cle-mente III, 60
Oufentina, 165 Paglia fiume, 101 Palestrina, 41, 42, 101, 131 Paliano, 85n Palino Giovanni notaio, 124n Palomba Giovanni di Stefano, 103 Pantaleoni Jacovello, 106 Paolo di Nuzio Paolozzo, 110 Paolozzi Pucciarello sindaco, 109 Papareschi famiglia, 164 Parlatore Pietro, 106 Parrocchia S. Clemente, 81 Parrocchie in Cori, 84n Pasquale II papa, 38, 59, 62, 63,
166, 167 Pasqualini Lelio, 21 Patrimonio di S. Pietro, 19, 32,
70, 196, 199n, 200 Patrimonium Appiae, 23, 31n, 46n,
143n, 166 Pedica, 143n Peraudi Raimondo cardinale, 117 Persio, 129n Perugia, 73, 93, 93n, 102, 132,
145, 145n, 157 Petrella Puccio massaro, 124 Piacentino di Sante di Lariano,
154 Pier Damiani, 51, 52n, 54, 67n,
131 Pietro consul et dux, 189 Pietro da Morrone v. Celestino V Pietro de Seniorecto, 54 Pietro di Pietro abitante del ca-
stello di Velletri, 38n Pietro di Gianni Grasso abitante
di Orte, 199 Pietro di Sumoroso, 89 Piglio, 99 Pio II papa, 114 Piperno, Priverno, 37n, 92, 149,
151, 193, 205
Platina v. Sacchi Bartolomeo Pomptina, 165 Ponte di Mèle, Bolagai, Malagai,
Mell, 140, 165, 166, 169, 183, 221
Ponte Minello, 45, 166, 183 Ponte S. Stefano, 179, 183 Ponziano di Cola di Terio, 142n Porte in Cori, 149, 193 Porte in Velletri:
- Furia o Figura, 149, 150n - Metabo o Matano, 148n, 150 - Napoletana o Inferiore, 21,
21n, 148, 148n, 150n, 151n, 152
- del Vescovo, 151n - Portella, 148, 148n, 149, 150,
177, 193 - Romana o Superiore, 147,
147n, 148, 148n, 150n, 152, 152n
- S. Lucia, 148n, 153 - S. Martina, 148n, 150n
Preneste v. Palestrina Presciano fondo, 44n, 143, 143n Provins, 144 Publilia, 165 Quadra di Pusterla, 149n, 193 Rainalducci Pietro v. Niccolò V
antipapa Riccardo duca di Gaeta, 63 Roberto da Ginevra v. Clemente
VII Rocca di Papa, 90, 116 Roccarespampani castello, 73 Roccasecca dei Volsci, 37n Roffredo consul et dux, 36n Roma, 13, 15, 17, 20, 21, 22,
22n, 23, 23n, 24n, 26n, 31n, 32, 33, 40, 43n, 46, 46n, 47, 48, 49, 50, 51n, 52n, 55, 60, 61, 62, 65, 67, 68, 71n, 73, 81, 83, 85, 89, 90, 93, 94,
VELLETRI NEL MEDIOEVO
250
94n, 95, 95n, 96, 97, 98, 98n, 99, 100, 100n, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 111, 112, 112n, 113, 115, 115n, 117, 120, 123, 126n, 130, 131n, 140, 142, 144, 145, 147, 158, 161, 161n, 162n, 164, 168n, 169, 189, 190, 191n, 194, 195, 196, 200, 203, 209
Romano consul et dux, 189, 190n Rubeo Giovanni, 67 S. Anastasio, 82n S. Andrea in Silice e Arenata
chiesa e monastero, 28, 45, 49, 50n, 61, 64n, 164, 172, 173, 173n, 177n
S. Angelo in Pescheria, 71, 71n S. Arnoldo, 77n S. Benedetto monastero, 43, 138 S. Callisto, 82n S. Ciriaco in via Lata monastero,
49, 49n, 50, 51n, 55, 56, 57, 169
S. Clemente, 14, 21, 66, 66n S. Eleuterio, 82, 82n S. Erasmo monastero, 42n S. Francesco convento e chiesa,
88n, 89n, 102, 110, 122, 142, 147, 156, 168n, 195, 217
S. Francesco d’Assisi, 88 S. Gennaro castrum, 28, 93, 93n,
143, 166, 170 S. Geraldo, 110 S. Pietro in formis, v. Campomorto S. Ponziano, 82, 82n S. Rufo abbazia in Velletri, 89n, 217 S. Salvatore ad duos Amantes mo-
nastero in Roma, 169 SS. Bonifacio e Alessio monaste-
ro, 45n Sabello fondo, 58 Sabina, 85n, 131, 132n, 175n Sacchi Bartolomeo detto il Plati-
na, 89n, 108n, 217
Sagazzolo di Manuele ebreo, 194, 201
Salerno, 147 Salomone ebreo di Velletri, 194 Salomone Abramo ebreo di Cori,
204 Sammato dello Schiavo ebreo,
192, 194 Santa Croce famiglia, 115 Santa Maria Palomba, 116n Santi abitante di Velletri, 138 Sasso abitante del castello di Vel-
letri, 17, 38, 38n Savelli famiglia, 91, 101, 113,
114, 115, 116, 116n Savelli Buccio di Giovanni pode-
stà di Velletri, 98 Savelli Cencio v. Onorio III Savelli Cola figlio di Buccio, 98 Savelli Francesco, 98 Savelli Giovanni Battista cardina-
le, 115 Savelli Guglielmo figlio di Buccio,
98 Savelli Luca, 73 Savelli Pandolfo, 98 Scambi Antonio notaio, 71n Scaptia, 165, 171 Scotia, 139 Segni, 73, 78, 134, 149 Semisano fondo, 41 Serafi Ludovico notaio, 201n,
202n Sergio I papa, 133 Sermoneta, 63, 69, 80n, 83, 84n,
87, 99, 118, 146, 149, 151, 152, 193, 198, 221
Serrone, 85n Sezze, 69, 74n, 75n, 79, 79n, 80,
80n, 83, 85, 85n, 86, 87, 91, 92, 94n, 99, 108, 112, 146, 162
Sforza Alessandro, 129n Sillano Pignatelli, 112 Silvestro II papa, 41
INDICE DEI NOMI E DI LUOGO
251
Simone di Benedetto da Civita ebreo, 204
Simone di Dattilo di Terracina ebreo, 203
Simone di Velletri giudice in Amelia, 97
Sisto IV papa, 115, 161n Sonnino, 37n Sorresca lago, 46n Spalvieri Fabrizio, 110 Spina monte v. Artemisio Spoleto, 85n Stefania senatrix, 41 Stefaniani famiglia, 50, 57 Stefano de Imiza consul et dux, 56,
57 Stefano de Melious piscator, 55,
55n Stevenson Enrico, 14, 35, 45n,
54n, 181 Strabone, 129, 219 Strozzi Annibale, 109, 109n Subiaco, 63 Subiaco monastero, 33, 33n, 40,
46, 47 Sutri, 43n, 51, 98, 180 Symarde Niccolò, 103 Tagliacozzo, 90n Tenar Cola, 142n Teodora II, 49 Teodora di Demetrio, 45n, 53n,
57 Teodosio, 20, 170 Teofilatti famiglia, 49, 49n, 56n Teofilatto presbitero, 184 Teofilatto Senator romanorum, 32,
56n Teofilatto vestarario, 33n, 50n Teofilatto de Ilperino, 174n Terracina, 41, 42, 42n, 48, 72,
73, 75n, 85, 85n, 92, 94n, 99, 101, 108, 116, 121, 121n, 149, 151, 162, 193, 198, 203, 205
Tersenghi Augusto, 76, 150, 156n, 158, 159, 214, 220, 221
Theuli Bonaventura, 13, 15, 16, 88n, 89n, 138n, 148, 150, 152, 167n, 176, 192n, 208, 209, 210, 211, 215, 216, 217, 217n, 218
Tiberina isola, 45n, 47, 53n Tito Livio, 214, 219 Tivera o Tiberia, 63, 82, 82n Tivoli, 33, 41, 42, 43, 63, 67, 95,
95n, 109, 112n, 199 Tommaso cardinale di Sant’Ange-
lo, 103 Tommaso di Lucca, 83n Torri:
- de’ Foschi, 159 - degli Annibaldi, 159 - dei Monaci, 29n - del Monumento, 29n - del Padiglione, 29n - del Trivio, 101, 156, 157,
221 - di Cacaritto, 159 - di Capo d’Anzio, 29n - di Lazzaria, 29n - di Presciano, 29n - di Spaccasassi, 29n - Orlando, 115n
Torrecchia Nuova, 45n Torrecchia Vecchia, 45n, 62, 63,
164 Toscana, 51, 192n Tozzi Pietro massaro, 123 Trabatiana massa, 44n, 166 Tradito da Cori medico, 121n Troia città della Puglia, 82n Tuscia, 73, 85n, 91, 100, 112,
199n Tuscolani famiglia, Conti di Tu-
scolo, 17, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51n, 53, 53n, 58, 164, 175n, 211, 212
Tuscolo, 41, 67, 131, 160
VELLETRI NEL MEDIOEVO
252
Ubaldo d. Allucingoli v. Lucio III Ugo cardinale, 67n, 70n, 131n Ugo di Provenza, 32 Ugolino dei Conti di Anagni ve-
scovo, 70, 88 Ugolino dei Conti di Segni v.
Gregorio IX Umbria, 192n Urbano II papa, 38, 60, 65 Urbano IV papa, 90, 91 Urbano V papa, 103, 104, 107 Urbano VI papa, 103n, 108, 109,
110 Urbino, 149n, 193 Veliki Kriback, 147n Velli Lorenzo di Giacomo pode-
stà di Velletri, 114 Venezia, 127, 127n, 153n, 219,
219n Ventura dello Schiavo ebreo, 194 Ventura di Angelo ebreo, 201 Ventura di Boncore ebreo, 201 Ventura Niccolò, 103 Veroli, 36n, 42, 42n, 43, 75n Vescovo monte, 62, 164, 183 Via Appia, 22n, 28, 69n, 145,
146, 172, 177n, 178, 181 Via Appia vecchia, 45, 166 Via Caiana, 166, 183 Via Casilina, 146 Via di Presciano, 143n Via Lata, 174n Via Latina, 92, 146 Via Mactorina, 145, 181 Via Pedemontana, 92, 146 Vicenza, 202, 202n Vie in Velletri:
- via Acquavivola, 179
- via Borghesia, 152, 153 - via dei Lauri, 147 - via della Caranella, 179 - via della Stamperia, 192 - via della Torre, 159 - via della Trinità, 192 - via delle Morelle, 159 - via delle Quattro Vasche, 164 - via di Carano, 165 - via di Rioli, 169, 177n - via Fossatello, 164 - via Furio, 149, 159 - via Le Corti, 164 - via Maestra, 152 - via Menotti Garibaldi, 152 - via Metabo, 151n - via Paganico, 177n, 181 - via Portella, 149, 200 - via Retta, 151, 152 - via S. Biagio, 177n - via S. Francesco, 159 - via S. Nicola, 177n - via Vecchia di Napoli, 151,
152 - viale Guglielmo Oberdan, 181 - viale Regina Margherita, 147,
152 - viale Salvo D’Acquisto, 181 - vicolo Gagliardi, 159
Vignola vd. Barozzi Giacomo Vitelleschi Giovanni, 113 Viterbo, 112, 199n Vittore chierico, 21
Wickham Chris, 190
Zaccaria papa, 22n, 23n Zizinni fondo in Albano, 47, 52n
Volumi pubblicati:
LAZZARI FRANCO, LOZZI MARIO, Gli Epigrammi di Anto-nio Mancinelli, Velletri, Quaderni del Centro Studi «An-tonio Mancinelli», 1, Tored 2009. LAZZARI FRANCO, Velletri nel Medioevo, Velletri, Qua-derni del Centro Studi «Antonio Mancinelli», 2, 2011. MCLELLAN DUGALD, Antonio Mancinelli ad Orvieto: mae-stro comunale, pubblico intellettuale e interprete delle Muse, Quaderni del Centro Studi «Antonio Mancinelli», 3, Tored 2014.
Edizioni TORED – 2015
Stampato nel mese di aprile 2015 da Editrice Lombardi srl Via Paterno, 29f – 00010 Villa Adriana, Tivoli (Roma)