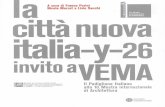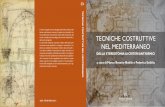Nino Molinu, Allegoria come segno e bi-sogno di cambiamento dell'uomo
Nel segno di Antigone
Transcript of Nel segno di Antigone
Nel segno di Antigone: disobbedienza femminista e queer1
di Brunella Casalini(prossima pubblicazione sulla rivista “Genesis” nella sezione Lectures)
«Io sono fatta per condividere l'amore non l'odio.» (Antigone)
I. IntroduzioneSono stata invitata a parlare della figura di Antigone come “archetipo della donna disobbediente” nell'ambito di un programma di lavori, quale quello della Scuola estiva delle storiche, dedicato ai movimenti femministi contemporanei e alla presenza delle donne nei movimenti di protesta. Guardando a questa figura letteraria con la lente della contemporaneità – come è stato fatto per altre figure, quali Lisistrata e Pentesilea2 – ho cercato di rintracciarne la presenza nel dibattito contemporaneo, associandola a immagini di donne disobbedienti legate al presente, immagini diverse eppure vicine, quali quelle delle madri di Plaza de Mayo, della ballerina sul toro di Zuccotti Park, della ragazza con il vestito rosso investita dai lacrimogeni della polizia in piazza Taqsim o della donna con il reggiseno celeste trascinata dalla polizia in Piazza Tahrir. In altri termini, ho pensato ad Antigone e alle interpretazioni femministe che ne sono state offerte
1 Il presente testo è stato preparato per la lezione tenuta presso la Scuola estiva delle storiche, Fiesole (FI), il 27 agosto 2014.2 Sullo sciopero del sesso pacifista ispirato alla Lisistrata di Aristofane, cfr. Sex strike, in Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Sex_strike (ultima consultazione 16 dicembre 2014). Per quanto riguarda la figura di Pentesilea, nell'ambito di una riflessione sulla forma politica del tumulto quale forma di ribellione che, nell'epoca della governance, sostituisce la rivoluzione propria dell'epoca della sovranità, cfr. Augusto Illuminati e Tania Rispoli, Tumulti. Scene dal nuovo disordine planetario, Roma, DeriveApprodi, 2011.
1
domandandomi in che modo l'eredità del pensiero femminista abbia permeato i movimenti sociali contemporanei, incidendo sia sulle forme sia sui contenuti della protesta.
In questa prospettiva, mi sono posta tre obiettivi principali: in primo luogo, definire il concetto di disobbedienza, cogliendo le differenze tra il concetto di disobbedienza civile e nozioni simili quali obiezione di coscienza, disobbedienza politica e potere destituente. Una volta delimitati i confini del concetto di disobbedienza sul piano teorico-politico, il mio secondo obiettivo è di ricordare alcune tra le principali interpretazioni della figura di Antigone offerte dalla riflessione femminista3. Bonnie Honig ha osservato che nella filosofia politica contemporanea, grazie soprattutto ad alcune teoriche femministe, il richiamo alla figura di Antigone ha consentito la nascita e l'elaborazione di una nuova forma di umanesimo che si contrappone a quello di stampo illuminista. Se un tempo era Edipo la figura più spesso evocata per rappresentare un umanesimo incentrato sul valore della razionalità umana, dell'autonomia, dell'individualità, oggi è Antigone la figura cui si rifanno quanti vogliono ricordare l'esperienza comune, familiare a tutti gli esseri umani, dell'elaborazione del lutto, della sofferenza procurata dalla perdita di una persona cara, sofferenza legata alla nostra natura corporea ed emotiva, al nostro coinvolgimento con l'altro, alla nostra fragilità e vulnerabilità4. Nelle conclusioni, infine, come terzo obiettivo di questa mia esposizione, mi propongo di offrire qualche spunto di riflessione sul modo in cui credo che questo “nuovo umanesimo” abbia trovato cittadinanza nei movimenti sociali contemporanei, soprattutto mediante il ruolo politico che il corpo, per tanto tempo espulso dallo spazio pubblico, gioca in quella forma particolare di espressione della disobbedienza che è l'occupazione della piazza e delle strade.
Prima di iniziare il nostro percorso, ricordiamo che
3 Cfr. Feminist Readings of Antigone, a cura di Fanny Söderbäck, New York, State University Press of New York, 2010; Interrogating Antigone in Postmodern Philosophy and Criticism, a cura di S. E. Wilmer e Audroné Žukauskaité, Oxford Oxford University Press, 2010.4 Cfr. Bonnie Honig, Antigone, Interrupted, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, p. 23.
2
l'Antigone, scritta da Sofocle intorno al 440 a.C., si incentra sul destino della progenie incestuosa di Edipo e Giocasta: Antigone, Ismene, Polinice ed Eteocle. Polinice ed Eteocle sono morti l’uno per mano dell'altro nel confronto armato in cui si sono affrontati per decidere il destino del governo della città di Tebe, fino a quel momento affidata ad Eteocle.
Dopo la morte dei due fratelli, lo zio Creonte assume il potere e, convinto di agire da buon governante, che ha a cuore l’interesse della patria, decide di offrire le onoranze funebri a Eteocle e di negarle a Polinice, cosicché «sia lasciato insepolto e sfigurato, pasto di uccelli e di cani»5, in quanto nemico e traditore della città. Nessuno potrà dare sepoltura a Polinice, che rimane un nemico anche quando ridotto a un corpo morto e inerme. Antigone, invocando il sacro dovere familiare di onorare i defunti, decide di disobbedire all'ordine di Creonte, rifiutandosi di giudicare il fratello secondo la logica politica dell'amico/nemico. Antigone tenta di ottenere la complicità della sorella Ismene; quest'ultima, però, si rifiuta di assecondarla e le ricorda che le donne non hanno una posizione pari agli uomini:
Noi, dobbiamo ricordarci che siamo due donne, incapaci di tenere testa a degli uomini; e poi, che siamo governate dai più forti e quindi è nostro dovere obbedire a questi ordini, e ad altri ancora più ingrati. […] Agire al di là dei propri limiti è assolutamente insensato6.
Per il crimine commesso in nome dell'amore per il fratello morto, Antigone viene punita da Creonte con la reclusione a vita in una caverna lontana dalla città, dove riceverà viveri sufficienti per sopravvivere. Sepolta viva, Antigone decide di togliersi la vita. Emone, suo fidanzato e figlio di Creonte, alla vista del corpo dell'amata privo di vita, si suicida. Lo stesso di lì a breve farà sua madre, Euridice, dopo essere stata raggiunta dalla notizia della disgrazia. La tragedia si chiude con un Creonte annientato («non sono più nulla»), ridotto ad un «uomo morto», che, tardivamente pentito, concede sepoltura a tutti.
5 Sofocle, Antigone, in Id., Antigone, Edipo re, Edipo a Colono, BUR, Milano 1997, p. 57.6 Ivi, p. 47.
3
2. Presupposti concettualiCome anticipato, la prima tappa del nostro percorso prevede un lavoro preliminare sul concetto di disobbedienza e, più in particolare, sui concetti di disobbedienza civile, obiezione di coscienza, disobbedienza politica e potere destituente7. Si tratta per lo più di idee antiche, intorno al cui chiarimento sul piano teorico-concettuale si è cominciato a lavorare, però, solo in tempi relativamente recenti, sulla spinta di specifiche esperienze di lotta, quali il grande sciopero indetto dagli operai della General Motors tra il 1936 e il 1937, durante il quale fu sperimentata la pratica del sit-down strike8; l'esperienza delle lotte non violente gandhiane; quella delle lotte per i diritti civili dei neri negli Stati Uniti, che dalle lotte gandhiane in parte trassero ispirazione; la protesta contro la guerra in Vietnam; e, infine, per arrivare ad oggi, le lotte recentissime che richiamavo all'inizio, in particolare quelle dei movimenti globali contro le politiche neoliberiste. Molti tra i testi teorici più importanti sull'argomento cui fare riferimento, se si eccettuano gli scritti di Henry David Thoreau, di metà Ottocento, e quelli gandhiani, risalgono alla seconda metà del Novecento; basti pensare al lavoro sulla Disobbedienza civile di Hannah Arendt del 19709 e alle pagine dedicate da John Rawls al tema della disobbedienza civile in A Theory of Justice (1971).
Rawls dà la seguente definizione di disobbedienza civile: «un atto di coscienza pubblico, non violento, e tuttavia politico, contrario alla legge, in genere compiuto con lo scopo di produrre un
7 Sull'argomento v. Norberto Bobbio, Una definizione di disobbedienza civile, tratto da Dizionario di politica diretto da Norberto Bobbio, Nicola Matteucci, Gianfranco Pasquino, Torino, Utet, 1976, pp. 316-320, ora disponibile al seguente indirizzo internet: http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1029:una-definizione-di-disobbedienza-civile&catid=92:approfondimenti-sulla-nonviolenza&Itemid=80 (Ultima consultazione 26 luglio 2014) e Pasquale Pugliese, Disobbedienza civile, Unimondo.org: http://www.unimondo.org/Guide/Politica/Disobbedienza-civile/(desc)/show (ultima consultazione 26 luglio 2014). 8 Cfr. Raffaele Laudani, Disobbedienza, Bologna, Il Mulino, 2010, p. 115.9 Per una ricostruzione critica del concetto di disobbedienza civile, cfr. op. cit.
4
cambiamento nelle leggi o nelle politiche del governo»10. La disobbedienza civile è volta a cambiare leggi ingiuste e non mette in discussione la struttura delle istituzioni politiche di una società, della quale anzi accetta e riconosce la legittimità. Come scriveva Martin Luther King nella sua Lettera dalla Prigione di Birmingham (1963):
Un individuo, che trasgredisce una legge che in coscienza ritiene ingiusta e di buon grado accetta la pena rimanendo in prigione al fine di sollevare la coscienza della comunità contro la sua ingiustizia, in realtà mostra il massimo rispetto per la legge11.
Rawls è uno tra i primi ad offrire un'analisi filosofica sistematica sul ruolo e sulle motivazioni della disobbedienza civile nell'ambito di una democrazia costituzionale liberale, ovvero in una società parzialmente giusta, dando per scontato che non c'è necessità di giustificare la disobbedienza alle leggi di un governo tirannico, così come d'altra parte non è possibile trovare una giustificazione ragionevole alla disobbedienza in una società politica perfettamente giusta.
Criticare duramente una legge e poi obbedire ad essa non è disobbedienza. Rifiutarsi di obbedire ad una legge, ma nascondere la propria azione è disobbedienza, ma non disobbedienza civile; manca, infatti, perché si possa parlare di disobbedienza civile, la volontà di indebolire la legge, violandola e facendo appello alla coscienza di chi ha voluto quella legge o la sostiene.
La disobbedienza civile è un atto politico perché non solo si indirizza al senso comune della maggioranza, ma lo fa sulla base di principi di giustizia, non sulla base di interessi o principi morali e religiosi personali12. È, inoltre, un atto palese e non violento che può essere paragonato nelle sue finalità ad un discorso pubblico perché ha la funzione di un appello. In quanto tale, la disobbedienza può essere difesa e legittimata come appartenente all'ambito della libertà di espressione13. Come il discorso pubblico, la disobbedienza civile ha una finalità pedagogica, di educazione morale pubblica. In questo
10 John Rawls, Una teoria della giustizia, Milano, Feltrinelli, 1984, p. 503.11 Cit. in Pugliese, Disobbedienza civile, cit.12 Cfr. Rawls, Una teoria della giustizia, cit., p. 504.13 Cfr. ibidem.
5
senso, è “civile” perché disobbedire a una legge ingiusta può essere fatto rientrare nei doveri del cittadino nella vita pubblica.
Chi compie un'azione di disobbedienza civile è pronto, sostiene Rawls, ad andare incontro alle conseguenze sul piano penale della violazione della legge giudicata ingiusta. Come diceva Gandhi, chi compie un atto di disobbedienza civile sa di andare incontro alla prigione, di camminare in direzione del carcere14. Così definita, la disobbedienza civile si distingue tanto dalla resistenza attiva e organizzata quanto dall'obiezione di coscienza. Nel primo caso il militante che fa ostruzionismo attivo a un regime non fa appello al senso di giustizia della maggioranza; piuttosto ritiene che esso sia fondamentalmente errato e si debba spingere in direzione di un suo cambiamento anche con la violenza. Chi agisce con questo spirito non è disposto ad accettare le conseguenze che la legge attribuisce al suo gesto, perché non nutre alcuna fedeltà nei confronti della legge.
Si parla, d'altra parte, di obiezione di coscienza e non di disobbedienza civile quando chi si rifiuta di obbedire alla legge «non fa appello alle convinzioni della comunità, e in questo senso l'obiezione di coscienza non è un atto compiuto in pubblico»15. Chi fa obiezione di coscienza lo fa prima di tutto per aver salva la propria anima e non per educare la morale pubblica.
Di recente, nell'ambito del dibattito pubblico statunitense, al fine di descrivere quanto avvenuto a Zuccotti Park, a New York, nell'autunno del 2011, ovvero con riferimento al movimento Occupy Wall Street, è stata proposta un'ulteriore distinzione tra disobbedienza civile e disobbedienza politica. Se la disobbedienza civile non ha come fine il mettere in discussione le istituzioni e la struttura di governo, la disobbedienza politica per contro oppone resistenza al modo stesso in cui si è governati. Come ha scritto Bernard E. Harcourt: «Occupy Wall Street è stato politicamente disobbediente in questo preciso senso del termine: esso ha disobbedito non solo alla struttura civile delle leggi e delle istituzioni politiche, ma alla politica in senso ampio»16, rifiutando la razionalità
14 Cit. in Judith Butler, Performing the political, in First Supper Symposium; Second Course, 21 maggio 2014: https://www.youtube.com/watch?v=QeHPfXUmY3g (ultima consultazione 4 agosto 2014).15 Rawls, Una teoria della giustizia, cit.16 Bernard E. Harcourt, Political Disobedience, in «Critical Inquiry», 39, 1
6
politica consueta, i discorsi e le strategie di una politica partitica. La resistenza del movimento Occupy Wall Street alle forme di politica tradizionali si è spinta fino ad abbracciare la negazione di ogni figura di leader e di qualsiasi forma organizzativa di tipo gerarchico. A Tahrir Square, a Puerta del Sol, a piazza Syntagma ad Atene, come a Zuccoti Park a New York e a Gezy Park a Istanbul, la forma in cui la disobbedienza politica si è espressa è stata quella dell'occupazione dello spazio delle strade e delle piazze, non uno spazio vuoto, ma uno spazio occupato e controllato dallo stato, sicché gli occupanti sapevano che la loro azione poteva suscitare una reazione delle forze dell'ordine che in qualsiasi momento potevano procedere alla rimozione forzata degli occupanti. L'occupazione, come forma espressiva che nelle sue molteplici declinazioni (dalla creazione di cucine da campo, alla celebrazione di matrimoni e di nascite) manifesta la volontà di rimanere indefinitamente nello spazio pubblico, è sempre minacciata dalla possibilità dell'esercizio della violenza e della forza da parte della polizia17.
Un altro concetto recente, utilizzato per descrivere gli stessi avvenimenti, è quello di “potere destituente”, espressione con la quale, in contrapposizione alla nozione di potere costituente18, si intende descrivere una mobilitazione popolare che «non è motivata prioritariamente da una finalità istituzionalizzante»19. Il potere destituente è espressione di un puro desiderio di libertà che si muove fuori dalla logica della rappresentanza politica. La figura concettuale cui Pierandrea Amato e Luca Salza fanno ricorso per descrivere
(2012), pp. 33-55; in particolare, p. 34.17 Cfr. W. J. T. Mitchell, Preface to “Occupy: Three Inquiries in Disobedience”, in «Critical Inquiry», 39, 1 (2012), pp. 1-7 e Id., Image, Space, Revolution: The Arts of Occupation, ivi, pp. 8-32.18 Scrive Giorgio Agamben: «A partire dalla rivoluzione francese, la tradizione politica della modernità ha concepito i cambiamenti radicali sotto forma di processi rivoluzionari che agiscono da pouvoir constituant, “poteri costituenti” di un nuovo ordine istituzionale. Penso che si debba abbandonare questo paradigma e tentare di pensare qualcosa come una puissance destituante, un “potere puramente destituente”, che non possa essere catturato nel circolo della sicurezza» (Id., Per una teoria del potere destituente, Conferenza pubblica (Atene, 16 novembre 2013), trascrizione a cura di ΧΡΟΝΟΣ, traduzione di Giacomo Mercuriali: <http://www.sinistrainrete.info/societa/3401-giorgio-agamben-per-una-teoria-del-potere-destituente-.html> - ultima consultazione 21 dicembre 2014).19 Raffaele Laudani, Disobbedienza, cit., p. 12.
7
questa forma politica è proprio quella di Antigone:
Antigone. Il suo rifiuto di applicare la legge sovrana, la politica che ci impone come vivere, la sua violenza della non violenza, destituente e forte, scatena una metamorfosi politica della polis, in grado di fare cadere il sovrano. La diserzione dall’ordine del potere sprigiona una carica politica imprevedibile che fa del gesto della figlia di Edipo un movimento che allude a una forma di potere senza fondamento. Una politica destituente ha un compito limitato ma preciso: creare le condizioni, cioè, il vuoto, perché un’altra politica, quella che oggi appare impossibile, possa accadere. Indica il primo movimento da fare: per scatenare un politica dell’evento, l’evento della politica si annida in una diserzione singolare da ciò che è, per infrangere il corso normale della storia e produrre una molteplice, estatica, pluralità. Il potere destituente, in questo senso, è una figura nichilistica della politica che non sprigiona nulla di nichilistico.20
È l'Antigone lacaniana dell'eccesso e della dismisura, alla quale la sorella Ismene rimprovera: “Tu brami l'impossibile”, l'eroina dei teorici contemporanei del potere destituente. Non i contenuti del suo messaggio, ma il suo gesto, il potere creativo del suo “No!”, vengono messi in luce da questa lettura. Non è così, come vedremo, nelle interpretazioni femministe.
3. Antigone a Gezy ParkIn un articolo dal titolo Antigone a Gezy Park dell’estate del 2013, Marina Terragni, pubblicato nella rubrica Maschile/Femminile del «Corriere della Sera», raccontava che una delle donne in piazza ha urlato ai poliziotti: «Fermatevi! Sono io che vi ho messi al mondo!» e commentava così quell'evento:
Quella donna, come Antigone, ha fatto irrompere un altro ordine in quella situazione di terribile disordine e di rapporti di forza. Ha richiamato gli uomini armati a una legge fondamentale e superiore, che agisce da sempre anche se non è scritta. Non si è limitata a dire, come avrebbe potuto:
20 Pierandrea Amato e Luca Salza, Il potere destituente. Materiali e frammenti, in «Doppiozero», 4 luglio 2014: <http://www.doppiozero.com/materiali/rivolte/il-potere-destituente> (ultima consultazione 8 agosto 2014).
8
«Fermatevi perché la legge non consente quello che state facendo». Ha detto ben di più e di meglio.Si è presa tutta l’autorità per stare sopra alla legge. Si è richiamata alla sua sapienza materna contro quel disprezzo della vita che vedeva intorno a sé. Si è riferita al primato dell’amore e all’inviolabilità dei corpi vivi come Antigone, che violando le leggi della città in nome di una legge superiore […] si ostinò a dare pietosa sepoltura al cadavere del fratello Polinice.Come anche Ilaria Cucchi e tutte quelle sorelle e madri di detenuti morti nelle carceri italiane e non solo italiane, che non si arrendono alla brutalità dei rapporti di forza e lottano per dare una sepoltura giusta ai loro amati.Quella donna è l’esempio di un’autorità che non ha bisogno del potere, dispositivo difettoso e inventato ben dopo, perché fa riferimento a ciò che esiste da sempre: la vita, e l’interdipendenza tra noi creature umane.21
Le considerazioni di Terragni pongono in evidenza due aspetti: evocano la distinzione tra potere e autorità22, propria del femminismo italiano della differenza sessuale, e fanno della figura di Antigone non una figura esemplare dell'obiezione di coscienza23 o
21 Marina Terragni, Antigone a #GezyPark, «Io Donna. Il femminile del Corriere della sera», 6 luglio 2013: http://www.zenit.org/it/articles/fermatevi-sono-io-che-vi-ho-messi-al- mondo - (ultima consultazione 21 dicembre 2014). In un'intervista rilasciata qualche giorno prima, la Terragni aveva sostenuto questa stessa interpretazione e alla domanda: «Oggi, la figura di Antigone può essere ancora presa come modello?», aveva risposto: «Sì, solo che, come ho già spiegato, Antigone è presa in genere come modello di disobbedienza civile, come ribelle ed anarchica. Invece, il senso di Antigone è quello di ubbidire a una legge che viene prima di tutte le altre e prima degli dei: il primato della vita e delle relazioni di dipendenza fra essere umani. In questo senso Antigone rappresenta un modello di autorità perché, come la donna turca, ricorda questa verità essenziale che viene prima di tutto. È il primato della vita e dei corpi» (Ead., "Fermatevi, sono io che vi ho messi al mondo!", L'autorità femminile al centro di un dibattito all'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, in «Zenit.org», 25 giugno 2013: http://www.zenit.org/it/articles/fermatevi-sono-io-che-vi-ho-messi-al-mondo – ultima consultazione 21 dicembre 2014).22 Sul tema, cfr. Luisa Muraro, Autorità, Rosenberg & Sellier, Torino 2013.23 Se si sottolinea la solitudine di Antigone, dovremmo interpretare il suo gesto come espressione di obiezione di coscienza (così, per esempio, Laudani, Disobbedienza, cit.). Si tratterebbe invece di disobbedienza civile qualora si considerassero le frasi con cui Emone ricorda al padre che il popolo, che tace solo per paura, è in realtà dalla parte di Antigone e si sottolineasse la possibilità di un coinvolgimento di Ismene, possibilità che si fonda su due indizi: la duplice
9
della disobbedienza civile, ma, più correttamente, potremmo dire ora, sulla base del chiarimento concettuale sopra proposto, una figura della disobbedienza politica. Antigone è femminista non nella misura in cui sfida il potere di Creonte, non nella misura in cui si rifiuta di obbedire ad una legge ingiusta, ma in quanto contrappone all'universo di valori politici fondato sul disprezzo e il sacrificio della vita, un diverso ordine di valori. Contrappone a un'idea di politica incentrata sul ricorso alla forza e alle gerarchie una diversa visione della politica fondata sulle relazioni, sull'amore e sull'interdipendenza umana.
Da sottolineare la frase dell'articolo della Terragni che dice:
Come anche Ilaria Cucchi e tutte quelle sorelle e madri di detenuti morti nelle carceri italiane e non solo italiane, che non si arrendono alla brutalità dei rapporti di forza e lottano per dare una sepoltura giusta ai loro amati.
Anche se non credo sia l'intenzione dell'autrice dell'articolo, tuttavia, questa frase suggerisce un'interpretazione maternalista di Antigone che non è priva di rischi. Jean Bethke Elshtain, nel suo Antigone's Daughters del 198224, nel sorprendersi del fatto che ancora Antigone non fosse emersa nella sua veste di eroina femminista, prendendo le distanze dal femminismo anti-familista degli anni '70, sottolineava il ruolo della famiglia e dei legami familiari nel contrastare l'utilitarismo, l'individualismo e il potere statale ed esaltare i valori della cura e della dignità umana. In Elshtain, Antigone assurge a figura esemplare di una virtù materna che conosce il valore della vita e lo esprime prima di tutto attraverso il pianto dei morti; un esito per certi versi paradossale se pensiamo che Antigone non è madre e non vuole diventarlo – è il suo stesso
sepoltura di Polinice e il fatto che Ismene, interrogata da Creonte, confessa di aver trasgredito anche lei il suo ordine. Sulla complicità tra sorelle lavora l'interpretazione del testo proposta da Honig (cfr. Ead., Antigone, Interrupted, cit.). Le interpretazioni femministe, tuttavia, insistono non tanto sull'ingiustizia del singolo decreto di Creonte, ovvero di una singola legge, ma sull'ingiustizia del sistema di valori che ne sta alla base, appoggiando quindi la teoria della “disobbedienza politica”.24 Jean Bethke Elshtain, Antigone's Daughters, in «Democracy», 2, 2 (1982), pp. 39-45. Per una critica dell'impostazione di Elshtain, cfr. Honig, Antigone, Interrupted, cit.
10
nome, derivato da anti-ghenos, a ricordarcelo. Elshtain ricollega alla figura di Antigone le Madres de Plaza de Mayo e le donne coraggiose che durante la seconda guerra mondiale affrontarono i nazisti per poter seppellire i loro familiari maschi morti. L'interpretazione di Elshtain presenta tuttavia dei problemi: non mette in discussione la separazione tra pubblico e privato, tra stato e famiglia, su cui si fondava la lettura hegeliana di Antigone ma ne capovolge semplicemente il segno, ribadendo il carattere universale, astorico ed eterno della maternità come esperienza femminile; costruisce, inoltre, una possibile solidarietà sociale sul pianto delle madri più che sulla nostra comune condizione di vulnerabilità e mortalità25. La capacità delle Madres de Plaza de Mayo di deprivatizzare il loro lutto e dare ad esso un travolgente significato politico si può attribuire – come fa in un recente lavoro Ludmilla Bazzoni – proprio alla loro trasfigurazione della maternità, al loro renderla incommensurabile rispetto all'esperienza di senso comune:
[…] le Madres... sostengono di essere sempre incinte e sempre sul punto di partorire, e poi stravolgendo qualunque criterio, di essere state esse stesse partorite dai figli desaparecidos26.
4. Antigone: nostra sorella? I dubbi di Luisa MuraroIl femminismo italiano ha tardato a rivendicare la sorellanza con la figura di Antigone della quale continua a circolare un'immagine ambivalente. Nel volume Tre lezioni sulla differenza sessuale Luisa Muraro parla del suo scarso amore per la figura di Antigone e ricorda come questo sentimento fosse condiviso tra le sue compagne della Libreria delle donne di Milano. In una recensione polemica scritta nel 1983 al volume dal titolo Mia sorella Antigone dell'ebrea olandese Grete Weil, la posizione delle autrici che collaboravano con Via Dogana (i cui testi venivano pubblicati anonimi), ricorda Muraro,
25 Cfr. Bonnie Honig, Antigone, Interrupted: Greek Tragedy and the Future of Humanism, Inaugural lecture as the Sarah Rebecca Roland Professor in Political Science at Weinberg College of Arts and Sciences, Northwestern University, 8 marzo 2010: <https://www.youtube.com/watch?v=NwClVN8GJOU> (ultima consultazione 1 agosto 2014).26 Ludmilla Bazzoni, La vida venciendo a la muerte, introduzione di Olivia Guaraldo, L'iguana editrice, Verona 2013, p. 119.
11
era categorica. Vi si leggeva infatti:
Antigone non è una sorella di nessuna donna, è un'invenzione del mondo maschile, tutta interna alla dialettica della moralità… Una donna in carne e ossa non ha posto in questo gioco e se vi entra può restare schiacciata dall'enormità delle cose che avvengono e dal non avere criteri per ragionare27. Per Muraro, Antigone rimane la figura esemplare di quelle che lei chiama «le donne supplenti», ovvero quelle donne che «vanno a mettersi – spesso di propria iniziativa e operando trasgressioni che sembrano (ma non sono) atti di libertà, ne sono invece il surrogato – dove le manda il padre e dove gli uomini non hanno la voglia o il coraggio di mettersi»28.
5. Irigaray: Antigone e le genealogie femminiliCome ricorda la stessa Muraro, anche il rapporto di Luce Irigaray con la figura di Antigone è difficile29. In un primo momento, Irigaray si sofferma soprattutto sul carattere ambiguo e discorde della figura di Antigone, sul suo essere «bisognosa d’interpretazione femminile che la faccia uscire dall’imprigionamento nell’ordine simbolico degli uomini»30. Ancora in Etica della differenza sessuale, per Irigaray Antigone è «l’antidonna, una produzione della cultura scritta dai soli uomini»31. La figura di Antigone viene salvato solo legandola al tema delle genealogie femminili; allora, scrive Muraro, «Antigone diviene
27 Luisa Muraro, Seconda Lezione. Il concetto di genealogia femminile, in Ead., Tre lezioni sulla differenza sessuale e altri scritti, a cura di Riccardo Fanciullacci, Napoli, Orthotes, 2011, pp. 45-46.28 Cfr. ivi, p. 47.29 Sull'interpretazione di Antigone nei testi di Irigaray, si veda anche: Rachel Jones, Irigaray, Cambridge (UK), Polity press, 2011, cap. 7 e Francesca Brezzi, Antigone e la philía. Le passioni tra etica e politica, Milano, FrancoAngeli, 2004, cap. 7.30 Luisa Muraro, Le genealogie femminili (testo inedito in italiano, scritto nel settembre 1990 e pubblicato, nella traduzione inglese di Patricia Cicogna, col titolo Female Genealogies, in Engaging with Irigaray, a cura di Burke-Schor-Whitford New York, Columbia University Press, 1994, pp. 317-333), ora consultabile al seguente indirizzo Internet: <www.diotimafilosofe.it/down.php?t=3&id=42> (ultima consultazione 26 luglio 2014)31 Irigaray, L'etica della differenza sessuale, cit. in ivi.
12
[...] la donna la cui “‘fede’ e ‘fedeltà’ alla genealogia materna sono punite con la morte da un tiranno per assicurarsi il potere politico»32.
Per Irigaray la cultura e la filosofia occidentale hanno soffocato e rimosso la differenza sessuale. La donna è stata rinchiusa nella logica del medesimo: il problema, per Irigaray, non è la sua riduzione ad Altro, ma la sua riduzione ad Altro del Medesimo. La lettura che Hegel, nella Fenomenologia dello spirito, propone di Antigone è esemplare del modo in cui, anche quando ha parlato di questa differenza, la filosofia ha finito per collocare la donna in una posizione gerarchicamente inferiore, legandola alla passività del suo sesso, contrapposto al carattere attivo del sesso maschile. Hegel accorda alla donna una relazione con l'universale e un valore etico distintivo alleato con la sua specificità sessuata, ma ripete un modello in cui la donna è subordinata e sacrificata al ruolo di colei che deve sostenere l'uomo nel viaggio verso lo sviluppo spirituale, uno sviluppo spirituale verso l'autocoscienza in cui la donna è inclusa in modo solo incompleto. In particolare è compito etico della donna dare sepoltura ai morti e con questo atto trasformare un fenomeno naturale in spirituale. Dando conto dell'interpretazione hegeliana, Irigaray scrive in Speculum:
L'uomo […] non si sottrae alla morte (naturale), ma l'importante è trasformare in movimento dello spirito questo avvenimento accidentale che riguarda l'individuo singolo e che, per il suo carattere naturale, separa la coscienza da se stessa tagliandole la strada del ritorno in sé perché diventi coscienza di sé33.
Alla donna, dunque, spetta il culto del morto, mentre all'uomo la cultura della morte: l'uomo deve infatti essere disposto a sacrificare la vita per la comunità, prima di tutto nella guerra. Ponendo l'uomo morto nel ventre della terra, la donna lo «riassocia ad una comunità – religiosa – la quale tiene sotto il proprio controllo le violenze della materia singola e le basse vitalità che, accanendosi sul morto, potrebbero nuovamente distruggerlo. Questo supremo dovere costituisce la legge divina, ovvero l'etica positiva nei confronti del
32 Muraro, Le genealogie femminili, cit.33 Luce Irigaray, Speculum, Milano, Feltrinelli, 1993 (I 1989), p. 200.
13
singolo»34. La donna svolge così una funzione essenziale per la comunità, ma rimane esclusa dalla polis e dal processo storico-statuale.
La relazione asimmetrica tra uomo e donna è riscontrabile anche nel rapporto tra Antigone e Polinice, quel rapporto che Hegel descrive come ideale perché non macchiato dal desiderio e quindi esempio di relazione pura. Se il fratello può ottenere in quanto uomo riconoscimento dalla polis indipendentemente da Antigone, quest'ultima per contro può ottenere riconoscimento solo dalla relazione con il fratello. Secondo Irigaray, d'altra parte, lungi dall'essere una relazione d'amore puro, come nell'idealizzazione hegeliana, il rapporto di Antigone con il fratello è fin dall'inizio macchiato dal desiderio, un desiderio “notturno”, che ricorda la linea incestuosa di Antigone. Rifacendosi alla lettura dell'Antigone di Lacan35, Irigaray vede Antigone mossa da un desiderio che ripete
34 Ibidem.35 Per Lacan l'azione di Antigone è etica in quanto svolta in nome dell'unicità e irripetibile singolarità del fratello, e per questo non può essere colta nell'ordine simbolico, ovvero nell'ordine del linguaggio, se non come ciò che lo eccede, che non è in grado di cogliere. Secondo Lacan, Antigone non incarna la legge divina ma il desiderio puro, il puro e semplice desiderio di morte (un desiderio che va oltre il principio di piacere): «Antigone porta fino al limite il compimento di ciò che si può chiamare il desiderio puro, il puro e semplice desiderio di morte come tale. Questo desiderio, lei lo incarna» (Jacques Lacan, Il seminario. Libro VII. L'etica della psicoanalisi, 1959-1960, Torino, Einaudi, 1994, p. 356). La sua scelta la porta oltre l’ambito del discorso razionale e delle norme collettive della soddisfazione umana. La sua posizione trascende l'opposizione binaria che struttura le nostre vite etiche e sociali quotidiane. Poiché la sua scelta della morte non può essere compresa secondo norme strettamente razionali, non può essere letta come se rappresentasse una qualche semplice antitesi tra libertà e tirannia o tra individuo e stato. Antigone – osserva Lacan – dice di aver scelto la morte già prima del decreto di Creonte contro la sepoltura di Polinice e di fronte a Ismene si definisce come già morta. La scelta di Antigone potrebbe definirsi kantiana per la sua devozione ad un'idea pura di dovere – come fa notare ancora Lacan –, ma è anche espressione di un desiderio profondamente individualizzato, il cui contenuto non può essere universalizzato in una massima etica universale. La scelta di Antigone e il suo desiderio sono puri perché lei rifiuta la rivendicazione dell'Altro di dettarne forme e contenuti. La bellezza di Antigone sta allora nel suo scegliere un bene che si colloca al di là di tutti i beni riconosciuti, oltre il principio del piacere. È questo che dà alla sua statura una carattere monumentale e la pone a modello di un'etica creativa e non conformista. Nella sua bellezza, Antigone viene definita da Lacan come un «Oggetto Sublime».
14
quello della madre verso il figlio (ovvero il desiderio di Giocasta verso Edipo). In questo modo la sua lettura della tragedia di Sofocle sposta l'attenzione dalla relazione tra Antigone e Creonte a quella tra madre e figlia, una relazione che in Speculum sembra impossibilitata ad uscire da un rapporto confusivo e a trovare un proprio specifico percorso verso l'autocoscienza, e per questo rimane identificata con il materno. Antigone ci aiuta a capire perché Irigaray assegni così tanta importanza alle genealogie femminili, un tema centrale nella filosofia della differenza sessuale. Il destino di Antigone è determinato sia dal conflitto con Creonte che dal suo ripetere il destino materno, è per entrambe queste cause che ella finisce sepolta viva e rimane priva di una dimora tra gli uomini. Ora, secondo Irigaray, per non ripetere questo tragico destino, le donne devono saper costruire delle genealogie femminili che consentano loro di stabilire relazioni senza la mediazione del desiderio maschile: la genealogia permette di non confondere madre e figlia e al tempo stesso di identificarsi con il proprio sesso senza confondersi con la madre e il ruolo materno. In Éthique de la différence sexuelle, Irigaray insisterà sul questi concetti, sottolineando come il mondo dell'etica femminile debba avere sempre due dimensioni verticali e orizzontali:
“– fille → mère, mère → fille– l'entre-femmes, ou entre «soeurs»”36.
La lettura dell'Antigone da parte di Irigaray muta nel momento in cui la filosofa belga tenta di recuperare un originario sapere materno che è stato rimosso e cancellato. La riduzione della donna all'altro del medesimo si è verificata in un particolare momento della storia antica rispetto al quale Antigone si colloca ancora in una fase di transizione, come dimostrano in particolare tre aspetti della sua storia: “il rispetto per l'ordine vivente e per i viventi, il rispetto per l'ordine della generazione e non soltanto della genealogia, il rispetto per l'ordine della differenza sessuata, e non sessuale”37.
In Tra mito e storia: la tragedia di Antigone, Irigaray scrive:
36 Luce Irigaray, Éthique de la différence sexuelle, Les editions de minuit, Paris, 1984, p. 106.37 Luce Irigaray, All'inizio, Lei era, Bollati Boringhieri, Milano 2012, p. 126.
15
Antigone cerca di dare a suo fratello una sepoltura perché egli rappresenta una singolare concreta identità sessuata che deve essere rispettata in quanto tale: «come il figlio di sua madre». Per Antigone, l'identità umana non è ancora diventata una, neutra, universale come la renderà l'ordine di Creonte. L'umanità è ancora due: uomo e donna38.
Antigone afferma, dunque, insieme al valore della genealogia, al valore della fedeltà al rapporto con la madre, anche quello della generazione. Nel rapporto con il fratello emerge l'importanza della differenza sessuata, del sapersi confrontare con un'umanità che – sostiene Irigaray – fin dall'inizio è due e non uno. Riconoscere l'altro differentemente sessuato vuol dire, per Irigaray, riconoscere che la modalità con cui egli percepisce il mondo non può che essere diversa dalla modalità con cui lo percepisce un individuo diversamente sessuato: il mondo dell'altro rimane in questo senso “trascendente”:
Riconoscere questa trascendenza consente all'umanità di emergere dall'indifferenziazione e di entrare in un mondo culturale relazionale. La dimensione trascendente che esiste, o dovrebbe esistere, tra due differenti identità sessuate può garantire all'umanità un ordine culturale capace di proteggerci dall'essere immersi o dal ricadere nell'indifferenziazione39.
Una volta affermata questa differenza, si tratta non di superarla, attraverso un momento dialettico, ma di arrivare a integrare le due visioni etiche senza sacrificarne nessuna grazie al fiorire di una cultura relazionale. L'etica della differenza sessuale di Irigaray, sotto questo profilo, ha una forte dimensione utopica: si tratta di reinventare non solo la donna ma anche l'uomo in una relazione in cui né la soggettività maschile né quella femminile saranno costruite mediante la riduzione dell'altro al medesimo.
Per arrivare a definire un diverso ordine etico che sia rispettoso delle differenze sessuate tra uomo e donna, è necessario però, secondo Irigaray, anche andare oltre la razionalità monologica che ha ridotto il molteplice all'uno e adottato un atteggiamento di dominio non solo rispetto alla donna, ma anche rispetto alla natura. Sotto questo profilo, Antigone, secondo Irigaray, ci ricorda
38 Ivi, p. 127.39 Ivi, p. 142.
16
l'importanza del corpo, della natura e dell'armonia tra ordine cosmico e mondo umano. Se Creonte inaugura una cultura dell'onnipotenza dell'uomo sulla natura, che non tiene conto dell'importanza dell'armonia cosmica, una cultura che vuole sottomettere e sfruttare la terra, Antigone è attenta all'equilibrio cosmico e in particolare all'equilibrio tra il dio della luce e il dio dell'oscurità:
Dare sepoltura a Polinice significa provare a mantenere un equilibrio complesso tra i due dei, tra i due mondi. Non si tratta di favorire il dio degli inferi – come troppo spesso è stato detto in rapporto al carattere di Antigone, e anzitutto da Creonte stesso –, ma di fare in modo di non bloccare un possibile passaggio tra i due mondi, un passaggio che non è soltanto necessario al fratello morto, ma anche, più in generale, all'armonia dell'intero kosmos40.
Non è possibile, dunque, secondo Irigaray, riconsiderare il ruolo della donna nella polis senza riesaminare più in generale il rapporto tra gli esseri umani e il mondo naturale. Polemizzando con l'interpretazione lacaniana che vede Antigone spinta da una pulsione di morte, Irigaray scrive: “Invece di essere sottomessa a pulsioni di morte, come è stato detto, Antigone lotta per preservare gli esseri viventi e il loro ambiente. Non può accettare la sopravvivenza al posto della vita”. La vita che Creonte vuole imporre ad Antigone è simile allo spirito che continua ad animare l'atteggiamento dell'economia patriarcale verso gli esseri umani e la natura, ovvero uno spirito animato dalla volontà di uccidere di fatto, eliminando le condizioni per una vita vivibile, senza commettere apertamente un crimine41.
Molti sono stati gli appunti mossi a Irigaray, prima tra tutte la critica di essenzialismo e la sottovalutazione di altre importanti differenze oltre quella sessuata, a cominciare dalle differenze tra culture ed etnie. Non entro qui nel merito dei limiti della teoria della differenza sessuale e delle sue ambiguità. Restando sulla figura di Antigone, vorrei piuttosto soffermarmi sulle ragioni per cui Irigaray troppo poco si concentra nella sua analisi sulla valenza politica dello scontro che Antigone ingaggia con Creonte. Non è solo l'attenzione
40 Ivi, p. 128.41 Cfr. ivi, p. 134.
17
per la ricostruzione di una genealogia femminile a distogliere la sua attenzione da questa dimensione conflittuale della tragedia; è questo, infatti, un elemento rispetto al quale Irigaray sembra esplicitamente prendere le distanze. Nel momento stesso in cui dice di essere arrivata ad una migliore comprensione di Antigone anche grazie ad un'esperienza personale che l'ha vista, come Antigone, «espulsa dalla polis, dalla città, dalla società umana», scrive, infatti, che al contrario di Hegel e di molte femministe lei non ha mai pensato all'utilità di un conflitto diretto con gli uomini42. In questo senso, Antigone sembra essere, per lei, una figura più culturalmente che non politicamente significativa. In effetti, il femminismo della differenza sessuale mi sembra aver da sempre privilegiato la strada del lavoro culturale, del lavoro tra donne, in vista della creazione di un lessico, di un simbolico e di un'autorità femminile – sebbene Irigaray si sia impegnata in anni recenti anche nella battaglia per il riconoscimento di diritti sessuati, battaglia che, per altro, è sembrata accentuare le ambiguità della sua posizione intorno alle implicazioni della teoria della differenza sessuale, spingendola in una direzione conservatrice piuttosto che utopica43.
6. Antigone e la lotta per la ridefinizione dei confini dell'umano in Judith ButlerJudith Butler, nel suo Antigone's Claim, si chiede perché le interpretazioni più influenti dell'opera di Sofocle, come quelle di Hegel, Lacan e Irigaray, non abbiano letto il personaggio di Antigone come una figura politica e abbiano visto piuttosto nel suo gesto il tentativo di articolare una «opposizione prepolitica alla politica, giungendo […] a rappresentare la parentela come quella sfera che condiziona la possibilità della politica senza neppure entrarvi»44. Contro queste interpretazioni, Butler tenta di riportare Antigone nell'ambito della politica e ne propone una lettura che ne fa una
42 Cfr. ivi, p. 124.43 Cfr. Pheng Cheah, Elizabeth Grosz, Judith Butler, Drucilla Cornell, The Future of Sexual Difference: An Interview with Judith Butler and Drucilla Cornell, in «Diacritics», 28, 1 (1998), pp. 19-42.44 Judith Butler, La rivendicazione di Antigone. La parentela tra la vita e la morte, Torino, Bollati Boringhieri, 2003, p. 13.
18
figura parodica che, assorbendo il linguaggio stesso dello stato cui si ribella, mette in dubbio performativamente la normatività sociale legata al genere e alla parentela. Antigone, dunque, come figura politica che non cerca l'aiuto e il sostegno dello stato per l'implementazione di obiettivi politici femministi, che non segue le vie istituzionali, ma – come la figura di Rosa Parks, evocata in Parole che provocano. Per una politica del performativo – può essere piuttosto vista come simbolo di una politica democratica radicale. Dal punto di vista politico, dice infatti Butler, la valenza della figura di Antigone non ha a che fare con la politica come rappresentazione, ma con «la possibilità politica che si delinea quando si palesano i limiti della rappresentazione e della rappresentabilità»45.
Sono cieche per Butler quelle interpretazioni che leggono la contrapposizione tra Antigone e Creonte come un conflitto tra famiglia e stato. Antigone è tutt'altro che rappresentativa del genere e della parentela e la sua azione non può essere limitata all'ambito dei doveri legati alla dimensione della famiglia come dimensione prepolitica; al contrario, essa svela la politicità costitutiva della famiglia stessa. Contrariamente a quanto sostenuto da altre interpretazioni, Butler insiste sul fatto che Antigone non può essere considerata a rigore né rappresentativa della parentela né del genere femminile. Non è rappresentativa della parentela perché, ricorda Butler, «Antigone è figlia di un legame incestuoso e consacrata a un impossibile amore incestuoso per il fratello e a un legame di morte con lui». In un passo della tragedia Antigone confessa che sfida Creonte in nome del fratello, ma non avrebbe fatto la stessa cosa per i suoi figli, se fosse stata madre, né per suo marito, se fosse stata sposata. In un passo che Butler definisce «vituperevole», afferma:
Morto il marito, ne avrei avuto un altro; e da un altro uomo avrei avuto un figlio, se quello mi fosse mancato: ma ora che mio padre e mia madre sono in fondo all'Ade, non è mai più possibile che mi nasca un fratello46.
45 Ivi, p. 12.46 Ivi, p. 23. Bonnie Honig ha offerto una soluzione molto interessante a proposito delle ragioni per cui Antigone ricorre a questa frase ambigua. La frase di Antigone conterrebbe tre allusioni: 1. un'allusione al contesto storico, e in particolare all'orazione funebre di Pericle, in cui si offre ai genitori che perdono un figlio la soluzione di non metterne al mondo soltanto uno; 2. un'allusione testuale al
19
Antigone rappresenta la degenerazione della parentela più che la parentela ideale. Non solo è figlia e sorella di Edipo, non solo è fredda e ostile verso gli altri membri della sua famiglia, ma il suo stesso atteggiamento verso Polinice sembra non essere dettato solo da amore fraterno.
Antigone, d'altra parte, non è rappresentativa neppure del genere femminile nella misura in cui più volte nel testo si sottolinea come le sue azioni «costringano gli altri a considerarla “uomo”»47.
Antigone giunge […] ad agire in modi che sono definiti da uomo non solo perché agisce in aperta sfida alla legge, ma anche perché assume la voce della legge quando agisce contro la legge. Non si limita a commettere l'atto rifiutando di obbedire all'editto, ma lo ripete anche rifiutando di negare di essere stata lei a commetterlo, appropriandosi in tal modo della retorica della capacità di agire di Creonte48.
Il linguaggio stesso di Antigone, il suo desiderio di rendere pubblico il suo atto, si avvicina a quello della sovranità.
Quando all'inizio della tragedia, Ismene le consiglia: «Ma almeno non rivelare ad alcuno questa intenzione», Antigone risponde: «Ahimè gridalo forte: sarai molto più odiosa se tacendo non la proclamerai a tutti». Al pari di Creonte, Antigone vuole che il suo atto linguistico sia radicalmente e intelligibilmente pubblico quanto l'editto stesso49.
La sfida che Antigone pone a Creonte – e con lui alla polis – è
discorso di Creonte quando rivolgendosi a Emone gli dice che morta Antigone potrà avere un'altra donna; 3. un'allusione intertestuale all'episodio di Intafrene raccontato nelle Storie di Erodoto. Bisogna ricordare che nella Tebe democratica del V secolo era stato avviato un processo di riforma dei riti funebri che doveva portare ad abolire le espressioni pubbliche particolarmente ostentate del lutto e del pianto tipiche delle società aristocratiche, delle quali erano protagoniste soprattutto le donne. Cfr. Bonnie Honig, Antigone, Interrupted, cit. Sull'importanza della regolamentazione del culto dei morti e il «divieto di funerali individuali maestosi e di modalità eccessive di lamento» nella polis democratica greca, si veda anche Olivia Guaraldo, Comunità e vulnerabilità. Per una critica politica della violenza, Pisa, ETS, 2012, cap. II. 47 Butler, La rivendicazione di Antigone, cit., p.18.48 Ivi, p. 24.49 Ivi, p. 44.
20
data dal mettere in discussione con la sua fedeltà al fratello, che non può non rappresentare la deformazione della parentela nella sua forma ideale, la definizione stessa di famiglia pubblicamente accettata e il modo in cui sono tracciati i confini della polis, le regole di inclusione ed esclusione, quelle regole che rendono alcuni corpi inintelligibili, che fanno sì che alcune morti possano essere onorate e altre non siano considerate degne di essere piante50. In Antigone's Claim, Butler ricorda le vittime dell'AIDS, ma in Precarious Life include anche coloro che sono morti in Afghanistan e in Iraq, nelle guerre condotte in nome della lotta al terrorismo. In quest'ultima opera scrive:
Antigone, rischiando la morte per aver sepolto il fratello, contro la proibizione di Creonte, ci offre un chiaro esempio del rischio politico che opporsi al divieto del pubblico lutto comporta, specie in una situazione in cui potere sovrano e unità nazionale vengono esasperati. Quali sono le barriere culturali da abbattere al fine di portare alla luce le perdite di cui ci viene chiesto di non piangere, al fine di nominare, e quindi di includere nella categoria dell'umano, quanti sono stati uccisi dagli Stati Uniti e dai loro alleati?51.
Creonte ha vietato per Polinice ogni cerimonia funebre, ma Antigone tenta ugualmente e ostinatamente di piangere pubblicamente il fratello, anche se il suo gesto sarà considerato criminale. Nell'atto di sfida di Antigone Butler legge la messa in discussione del regime pubblico di intelligibilità, la possibilità di ridefinirlo, ponendo fine a esclusioni inaccettabili:
Essa non è l'umano ma parla con il linguaggio dell'umano; le viene vietata l'azione, tuttavia agisce e il suo atto non è una semplice assimilazione a una
50 Ad un certo punto della tragedia, al rimprovero di Creonte che le dice che neppure Eteocle le avrebbe dato ragione, Antigone risponde: «Ma suo fratello è morto, non il suo schiavo!» (corsivo mio). La stessa Antigone, quindi, in realtà, è disposta a escludere dall'umano coloro che sono caduti in condizione di schiavitù. Tina Chanter ha riletto la tragedia di Sofocle proprio alla luce della questione della schiavitù, ampiamente ignorata dalle interpretazioni precedenti. Cfr. Tina Chanter, Whose Antigone? The Tragic Marginalization of Slavery, Albany, State University of New York Press, 2011.51 Judith Butler, Vite precarie. I poteri del lutto e della violenza, a cura di Olivia Guaraldo, postmedia books, Milano 2013, p. 66.
21
norma esistente. Agendo, come chi non ha alcun diritto ad agire, sovverte il vocabolario della parentela che rappresenta un presupposto dell'umano, sollevando implicitamente la questione di che cosa debbano realmente essere quei presupposti52.
Antigone diventa così colei che si batte per una legalità alternativa, diventa portavoce di tutti coloro che oggi continuano ad essere esclusi dalla cittadinanza, che non appartengono ad alcuno stato-nazione, i cui diritti sono sistematicamente violati, che sono privi di un preciso status socio-ontologico. La sua voce e i suoi gesti articolano una denuncia che riguarda quel «fuori costitutivo» che è sempre stato condizione implicita di esistenza stessa della sfera pubblica, di quella «nuda vita» cui, secondo Giorgio Agamben, sono costretti coloro che vivono come soggetti giuridici in uno status ontologico sospeso. Antigone esprime la possibilità di agire politicamente di coloro che sono collocati in quel «regno in ombra» che, secondo la definizione di Hannah Arendt, perseguita la sfera pubblica.
Per Žižek53 ed Edelman54 l'idea di Butler che Antigone possa arrivare a trasformare l'ordine simbolico, ad aprire un nuovo «campo dell'umano», mediante la «riarticolazione della norma», la rivendicazione di una parentela che trasgredisce le regole dell'ordine simbolico, è dettata dall'ottimismo tipico di certo ingenuo umanesimo liberale americano. Per Žižek è necessario tracciare una distinzione netta tra una «riconfigurazione performativa», ovvero «uno spostamento sovversivo che rimane all'interno del campo egemonico e che, per così dire, conduce a una guerriglia interna per rivoltare i termini del campo egemonico contro di esso, e l'atto molto più radicale di una completa riconfigurazione dell'intero campo di definizione delle condizioni stesse della performatività strutturata
52 Butler, La rivendicazione di Antigone, cit., p. 111.53 Cfr. Slavoj Žižek, Il soggetto scabroso. Trattato di ontologia politica, Raffaello Cortina, Milano 2003, pp. 327-330 e Id., Benvenuti nel deserto del reale, Meltemi, Roma 2002, pp. 86-89. Sulla lettura di Antigone in Butler e Žižek, cfr. Sarah De Sanctis, From Psychoanalysis to Politics: Antigone as Revolutionary in Judith Butler and Žižek, “Opticon1826”, 14, 2012, pp. 27-36.54 Lee Edelman, No Future. Queer Theory and the Death Drive, Duke University Press, Durham-London 2004, pp. 102-109.
22
socialmente»55. Butler, secondo il filosofo di Lubiana, finisce in una posizione che consente solo «riconfigurazioni» marginali del discorso egemone, e questo perché prende le mosse da un'interpretazione errata del simbolico lacaniano:
Lacan ha riconcettualizzato la pulsione di morte freudiana come la forma elementare dell'atto etico, ovvero di un atto irriducibile all'atto linguistico, il cui potere performativo fa affidamento su un insieme prestabilito di regole e/o norme simboliche. […] Antigone rischia la sua intera esistenza sociale, sfidando il potere sociosimbolico della Città, incarnato dal governante (Creonte), e «cade in una specie di morte» (cioè subisce una morte simbolica, un'esclusione dallo spazio sociosimbolico). Per Lacan, non c'è atto etico vero e proprio senza il rischio di questa momentanea «sospensione del grande Altro», della rete sociosimbolica che garantisce l'identità del soggetto: si assiste a un atto autentico solo quando il soggetto rischia un gesto che non è più «coperto» dal grande Altro56.
Da una prospettiva lacaniana, quindi, secondo Žižek, Butler è troppo ottimista in quanto sopravvaluta la forza delle pratiche di «riconfigurazione/spostamento performativo» e sottovaluta la rottura totale e senza compromessi che Antigone attua rispetto ai valori comuni della polis57. Žižek (in questo, mi sembra, non diversamente dai teorici del potere destituente), insomma, sembra fermarsi al “No!” di Antigone e leggere in quell'atto di negazione l'inizio di qualcosa di totalmente nuovo, capace di una rottura radicale con il passato.
Per altri interpreti, come Moya Lloyd58, la prospettiva teorica di Butler ha il limite di lasciare aperti troppi interrogativi sia sulla concezione di democrazia radicale, alla quale allude senza fornirne una chiara elaborazione teorica, sia sulla scarsa fiducia nel ruolo dello stato e del riconoscimento di diritti (basti pensare alle molte obiezioni che Butler solleva circa la rivendicazione del diritto al matrimonio da parte delle coppie omosessuali59). La democrazia
55 Slavoj Žižek, Il soggetto scabroso, cit., p. 329.56 Ibidem.57 Cfr. ivi, p. 330.58 Moya Lloyd, Butler, Antigone and the State, in «Contemporary Political Theory», 4 (2005), pp. 451-468 e Ead., Judith Butler, Cambridge (UK) Polity Press, 2008 (I 2007), cap. 6.59 Butler è consapevole che nella rivendicazione del diritto al matrimonio da parte
23
radicale di Butler è concepita come uno spazio di continua contestazione delle norme che rendono invivibile la vita di alcuni, negando loro piena umanità, e scatenano spesso nei loro confronti una violenza normativa che è fondata proprio su un processo di “derealizzazione”. Quando l'altro non viene riconosciuto come umano, quando neghiamo quella comune vulnerabilità che ci accomuna come esseri umani corporei, bisognosi dell'altro per la formazione del nostro stesso sé, la violenza, il terrore e l'orrore prendono più facilmente piede. C'è un umano che, secondo Butler, sembra potersi riconoscere nell'esperienza della perdita e della vulnerabilità:
La perdita e la vulnerabilità sono conseguenze del nostro essere corpi socialmente costituiti, fragilmente uniti gli uni agli altri, che possiamo sempre perdere, ed esposti agli altri, sempre a rischio di una violenza che da questa esposizione può derivare60.
7. Qualche considerazione conclusivaLe interpretazioni di Antigone proposte da Irigaray e da Butler ci pongono di fronte a due diverse visioni e strategie politiche femministe. Per la prima il problema è costruire un'autorità femminile che renda possibile l'affermazione di una “democrazia che comincia a due” – come recita il titolo di uno dei suoi numerosi lavori – che tenga conto della differenza tra i sessi, che per Irigaray rimane senz'altro la più universale e la più importante delle differenze. Per la seconda, quell'autorità non deve attendere di essere costruita in un qualche spazio utopico, ma può essere rivendicata mediante l'espropriazione del «discorso dominante e 'autorizzato'»; si tratta per questo di ricordare la possibilità che sempre rimane disponibile per chi si è visto negare fino a quel momento il potere
delle coppie omosessuali si nasconde un pericolo: «I recenti tentativi di favorire i matrimoni lesbici e gay incoraggiano anche una norma che minaccia di rendere illegittime e abiette quelle intese sessuali che non sono conformi alla norma matrimoniale, sia nella sua forma esistente che in una possibile forma riveduta» (Judith Butler, La disfatta del genere, a cura di Olivia Guaraldo, Roma, Meltemi, Roma 2006, p. 29). 60 Butler, Vite precarie, cit., p. 46.
24
sociale di riappropriarsi di termini quali “libertà” e “democrazia” per risignificarli al fine di includere chi è stato escluso61, non solo per ragioni legate al sesso, ma anche alla razza, alla classe, all'identità di genere e all'orientamento sessuale, nonché spesso perché collocato all'intersezione di più assi di dominio. In questo senso la prospettiva democratica di Judith Butler risponde meglio – a mio avviso – alla complessità del presente. È significativo, tuttavia, che, pur nella distanza delle loro visioni filosofiche62, uno degli insegnamenti che sia per Irigaray che per Butler viene da Antigone è aver sollevato la questione del corpo, dei suoi bisogni, dei suoi desideri e delle condizioni di vivibilità che esso trova all'interno del corpo politico. Di una politica e di un pensiero politico che si sono appropriati del corpo come metafora, ma hanno obliterato «la radice corporea dell'umano», la sua dipendenza e relazionalità63. Come scrive Adriana Cavarero64:
Umana corporeità e identità femminile, dunque, nell'Antigone insieme si tengono in un solo tremendo e impolitico concetto. Cosicché il corpo, che la città fin dall'inizio straordinariamente esclude in quanto nemico ricacciandolo fuori dalle mura, nella contingenza scenica è, sì, quello morto di Polinice e poi quello sepolto ancor vivo di Antigone, ma è nel suo ruolo simbolico nient'altro che il corpo in quanto tale: angoscioso regno di muliebre potenza inscritto nella nuda vita e nella cifra del sangue65.
La cifra del corpo è centrale anche per le esperienze dei movimenti politici contemporanei cui accennavo all'inizio di questo mio lavoro: da più parti è stato sottolineato, infatti, come uno dei
61 Cfr. Judith Butler, Parole che provocano. Per una politica del performativo, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2010.62 Per una ricostruzione delle ragioni della distanza di Butler dalla prospettiva della differenza sessuale di Irigaray, cfr. Cheah, Grosz, Butler, Cornell, The Future of Sexual Difference: An Interview with Judith Butler and Drucilla Cornell, cit.63 Guaraldo, Comunità e vulnerabilità. Per una critica politica della violenza, cit., p. 40. 64 Cavarero è considerata, insieme a Butler, una delle teoriche contemporanee di un nuovo umanesimo centrato sul tema della vulnerabilità corporea, cfr. Ann V. Murphy, Corporeal Vulnerability and the New Humanism, in «Hypatia», 26, 3 (2011), pp. 575-590.65 Adriana Cavarero, Antigone, in Ead., Corpo in figure. Filosofia e politica della corporeità, Milano, Feltrinelli, 2003 (I 1995), pp. 17-62; in particolare, p. 20.
25
caratteri inediti della contemporanea «arte dell'occupazione» degli spazi pubblici, dettata dal malcontento verso gli effetti di precarizzazione delle condizioni di vita prodotti dalle politiche neoliberali, sia stato un desiderio di dare carne e corpo alla protesta, anche attraverso lo svolgimento in pubblico di attività quotidiane di solito riservate a spazi privati, come dormire, mangiare, cantare66, ecc. (durante l'occupazione in piazza Tahrir è stato anche celebrato un matrimonio ed è nato un bambino). Ben sapendo di rischiare, si è scelto di rispondere con la non violenza ai tentativi di rimozione forzata da parte della polizia, avendo deciso, quindi, di contrapporre la propria condizione di vulnerabilità alla forza67.
66 Ha scritto Butler a proposito della protesta di piazza Tahrir: «After all, in Cairo, it was not just that people amassed in the square: they were there; they slept there; they dispensed medicine and food, they assembled and sang, and they spoke. Can we distinguish those vocalizations from the body from those other expressions of material need and urgency? They were, after all, sleeping and eating in the public square, constructing toilets and various systems for sharing the space, and so not only refusing to be privatized – refusing to go or stay home – and not only claiming the public domain for themselves – acting in concert on conditions of equality – but also maintaining themselves as persisting bodies with needs, desires, and requirements. Arendtian and counter-Arendtian, to be sure. Since these bodies who were organizing their most basic needs in public were also petitioning the world to register what was happening there, to make its support known, and in that way to enter into revolutionary action itself. The bodies acted in concert, but they also slept in public, and in both these modalities, they were both vulnerable and demanding, giving political and spatial organization to elementary bodily needs. In this way, they formed themselves into images to be projected to all of who watched, petitioning us to receive and respond, and so to enlist media coverage that would refuse to let the event be covered over or to slip away. Sleeping on that pavement was not only a way to lay claim to the public, to contest the legitimacy of the state, but also quite clearly, a way to put the body on the line in its insistence, obduracy and precarity, overcoming the distinction between public and private for the time of revolution. In other words, it was only when those needs that are supposed to remain private came out into the day and night of the square, formed into image and discourse for the media, did it finally become possible to extend the space and time of the event with such tenacity to bring the regime down. After all, the cameras never stopped, bodies were there and here, they never stopped speaking, not even in sleep, and so could not be silenced, sequestered or denied – revolution happened because everyone refused to go home, cleaving to the pavement, acting in concert» (Judith Butler, Bodies in Alliance and the Politics of the Street, eipcp: <http://www.eipcp.net/transversal/1011/butler/en>, ultima consultazione 1 agosto 2014).67 Come ha scritto Mitchell, infatti: «The demand of occupatio is made in the full
26
Mi sembra che le riflessioni femministe interpretino meglio lo spirito delle lotte dei movimenti globali contro le politiche neoliberiste, rispetto alla chiave di lettura che hanno proposto i teorici del potere destituente, per i quali Antigone pone le condizioni per la creazione del nuovo nella misura in cui il suo gesto configura “un vuoto” e anela all'impossibile: il tema comune, infatti, non è solo la resistenza al potere, ma soprattutto la resistenza ad un potere che non è in grado di valorizzare il rapporto tra oikos e politica, privato e pubblico. Nella Grecia del V secolo, in cui Antigone si batte contro Creonte, l'avvento della democrazia fu segnato dalla separazione tra cittadinanza, appartenenza alla polis, e appartenenza a quella comunità economica o religiosa che un tempo era la famiglia, come rappresentazione del mondo dei bisogni; oggi, quella separazione sembra implosa per effetto delle politiche neoliberali che hanno cancellato i confini tra pubblico e privato per sottoporre la vita a nuove e più subdole forme di sfruttamento. Antigone sceglie di seppellire il corpo del fratello morto in nome della philia, un amore che non ha bisogno di essere ricambiato, e che contrappone all'odio che ispira la politica di Creonte68. Non è solo la capacità di dire “No!” di Antigone che ci affascina. La sua disobbedienza continua a parlarci e la sua figura continua ad essere evocata perché abbiamo bisogno di pensare alla possibilità di una politica che non sia solo guidata dalla logica amico/nemico o dall'interesse, ma sia mossa dal desiderio e da sentimenti supererogatori, da quel sentimento dell'amore, invocato da tanti cartelli del movimento di protesta newyorkese attraverso messaggi quali: «Occupy your heart» e «Let us develop a kind of dangerous unselfshiness» (citazione da Martin Luther King), «Choose love over fear», «You can crash the flowers, but you can't stop the spring», «Join the resistance, fall in love», «The new global currency is love», «Love keep us grounded»69.
knowledge that public space is, in fact, pre-occupied by the state and the police, that its pacified and democratic character, apparently open to all, is sustained by the ever-present possibility of violence» (Mitchell, Image, Space, Revolution: The Arts of Occupation, cit., p. 10).68 Sull'importanza del tema della philìa in Antigone, cfr. Guaraldo, Comunità e vulnerabilità, cit., pp. 42-55.69 Sul tema dell'amore nei movimenti globali degli ultimi anni, si veda il film documentario di Velcrow Ripper, Occupy Love, 2013, e il sito: <http://occupylove.org/>. L'amore è per lo più considerato nelle nostre società un
27
concetto che ha a che fare con la sfera privata, che non ha una valenza politica, se non in termini negativi come emozione fusionale sfruttata politicamente soprattutto dai regimi totalitari. In anni recenti si sono avuti, tuttavia, diversi tentativi di arrivare ad una definizione politica positiva e non fusionale dell'amore, basti pensare ai lavori di Michael Hardt, ma anche ad autrici femministe come bell hooks, Chela Sandoval e Martha Nussbaum.
28