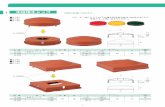Antigone a Crotone
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Antigone a Crotone
¶APOIM IAKø™il proverbio in grecia e a roma
a cura di emanuele lelli
introduzione di renzo tosi
postfazione di riccardo di donato
· i ·
PISA · ROMA
FABRIZIO SERRA EDITORE
MMX
PHILOLOGIAAN TIQVA
an internat ional journal o f clas s ic s
2 · 2009
PISA · ROMA
FABRIZIO SERRA EDITORE
MMX
Amministrazione e abbonamentiFabrizio Serra editore®
Casella postale n. 1, succursale n. 8, i 56123 Pisa,tel. +39 050 542332, fax +39 050 574888, [email protected]
I prezzi ufficiali di abbonamento cartaceo e/o Online sono consultabilipresso il sito Internet della casa editrice www.libraweb.net.
Print and/or Online official rates are available at Publisher’s website www.libraweb.net.
I pagamenti possono essere effettuati tramite versamento su c.c.p. n. 17154550o tramite carta di credito (American Express, Visa, Eurocard, Mastercard)
Uffici di Pisa: Via Santa Bibbiana 28, i 56127 Pisa,tel. +39 050 542332, fax +39 050 574888, [email protected]
Uffici di Roma e Redazione: Rita Gianfelice, Via Carlo Emanuele I, i 00185 Roma,tel. +39 06 70493456, fax +39 06 70476605, [email protected]
*Autorizzazione del Tribunale di Pisa n. 23 del 14 · 6 · 2007
Direttore responsabile: Fabrizio Serra
Sono rigorosamente vietati la riproduzione, la traduzione, l’adattamento, anche parziale o perestratti, per qualsiasi uso e con qualsiasi mezzo effettuati, compresi la copia fotostatica,
il microfilm, la memorizzazione elettronica, ecc., senza la preventiva autorizzazionescritta della Fabrizio Serra editore®, Pisa -RomaOgni abuso sarà perseguito a norma di legge.
*Proprietà riservata · All rights reserved
© Copyright 2010 by Fabrizio Serra editore®, Pisa -Roma
Stampato in Italia · Printed in Italy
www.libraweb.net
issn 1971-9078issn elettronico 2035-3561
isbn 978-88-6227-343-5
SOMMARIO
¶APOIM IAKø™
· I ·
Emanuele Lelli, Premessa 9
Abbreviazioni 11
Renzo Tosi, Introduzione 13
1. EsiodoAndrea Ercolani, Enunciati sentenziosi nelle Opere e Giorni di Esiodo 31
2. ArchilocoLuca Bettarini, Archiloco fr. 201 W.2: meglio volpe o riccio? 45
3. AlceoEmanuele Lelli, La pragmatica proverbiale di Alceo 53
4. TeognideFederico Condello, Proverbi in Teognide, Teognide in proverbio 61
5. EschiloMaurizio Grimaldi, Il proverbio in Eschilo: un aspetto della tecnica drammatica 87
6. SofoclePierpaolo Peroni, Inconsapevoli profezie 105
7. Sofocle, AntigoneGiovanni Di Maria, Antigone a Crotone 127
8. ErodotoLorenzo Miletti, «Ippoclide non se ne cura!»: Erodoto storico delle forme brevi 137
9. CratinoEmanuele Lelli, Il proverbio a teatro 145
10. AristofaneSilvio Schirru, Due ateniesi «ai corvi». Espressioni proverbiali negli Uccelli di Ari-
stofane 155
11. AristoteleMichele Curnis, «Reliquie di antica filosofia»: i proverbi in Aristotele 163
12. MenandroSilvio Schirru, Proverbi e sentenze nelle commedie di Menandro 215
13. Menandro, MonosticiCarlo Pernigotti, Il migliore dei testi possibili? Osservazioni su proverbi, sentenze e
critica testuale 229
8 sommario
7. Sofocle, Antigone
ANTIGONE A CROTONE
Giovanni Di Maria
on c’è forse un testo, tra quelli che ci sono pervenuti dalla civiltà greca, che abbiaavuto un destino postumo più ‘alto’ dell’Antigone di Sofocle. Senza trascurare le An-
tigoni successive fino a Vittorio Alfieri e alcune incursioni dell’eroina sofoclea nel teatrod’opera del xviii secolo, George Steiner osserva che la grande fortuna di questa tragediaha avuto inizio nel 1788 con la pubblicazione del Voyage du jeune Anacharsis en Grèce dans lemilieu du quatrième siècle avant l’ère vulgaire dell’abate Jean Jacques Barthélemy,1 un’operain sette volumi corredata da un atlante con cartine, incisioni e disegni, che narra il viag-gio immaginario nella Grecia del iv secolo a.C. del giovane scita Anacharsis, il quale, trai racconti delle sue esperienze di viaggio, include una rappresentazione dell’Antigone chelo colpisce profondamente.
Il successo dell’opera di Barthélemy contribuisce a rendere popolare il mondo dei Gre-ci e sembra anche dare origine a una moda intorno alla figura dell’eroina sofoclea. Un in-teresse che andando molto presto ben oltre il gusto dei lettori del Voyage, superando cioèuna visione del tragico cui la figura di Antigone sembrava rispondere particolarmente be-ne, si trasforma, trova prospettive diverse e produce effetti a catena che continuano a ri-prodursi ininterrottamente dal periodo a cavallo tra xviii e xix secolo fino ai giorni no-stri. Così le riscritture, traduzioni, messe in scena e riletture di questo mito si sono tantomoltiplicate da essere oramai difficilmente calcolabili, come in un gigantesco, caleido-scopico work in progress che, una volta iniziato, non ha più saputo arrestarsi.
Antigone, oltre a generare e rigenerare teatro, è stata, e continua ad esserlo, fonte di ispi-razione letteraria ed oggetto di riflessioni e dispute filosofiche, filologiche e politiche. Assimilata dall’idealismo tedesco e tradotta da Hölderlin, la tragedia viene definita da Hegel «una delle opere d’arte più eccelse e per ogni riguardo più perfette di tutti i tempi».2Karl Kerény, d’altra parte, in tempi più vicini a noi, ne parla come della «conquista più grandiosa per l’umanità».3 Ancora oggi Antigone, dopo essere passata nel secolo scorso perAnouilh, Brecht, Marguerite Yourcenar, Maria Zambrano, Heidegger, Cocteau, JacquesLacan e il Living Theatre, solo per citare alcuni nomi, continua ad avere ulteriori risonan-ze, con accentuazioni particolari nella recente letteratura post-femminista4 o in lavori tea-trali perturbanti e ‘scandalosi’ come Cleansed di Sarah Kane,5 giovane, disperata esponen-te della nuova drammaturgia britannica scomparsa tragicamente pochi anni orsono.
Qualche parte del testo di Sofocle in alcuni casi ha suscitato delle riserve. In particola-re un passo centrale della tragedia, fondamentale per Hegel,6 nel quale Antigone, già con-
1 G. Steiner, Le Antigoni, trad. it. Milano, 1995. Sul voyage du jeune Anacharsis, Claudio Franzoni, Viaggiare conBarthélemy: il viaggio come conoscenza, in I Greci. Storia, Cultura, Arte Società, vol. 4, tomo i, Torino, 2002.
2 G. W. F. Hegel, Estetica, a cura di Nicolao Merker, p. 522, Torino, 1967.3 K. Kerény, Edipo, due saggi. - Edipo i, in K. Kerény, J. Hillman, Variazioni su Edipo, Dallas, 1991, ed. it. Milano,
1992. 4 J. Butler, La rivendicazione di Antigone. La parentela tra la vita e la morte, Torino, 2003.5 S. Kane, Cleansed, Londra, 1998.6 Hegel nella Fenomenologia dello spirito, riprendendo senza citarli esplicitamente i versi 904-912 dell’Antigone, os-
serva come «tra fratello e sorella ha luogo la relazione pura. Essi sono il medesimo sangue che per altro in essi è giun-
N
128 giovanni di maria
dannata da Creonte a subire un castigo atroce (la tomba), esprime e spiega i suoi senti-menti e le sue ragioni in quella che forse è un’estrema, inattesa, disattesa e neanche trop-po velata supplica al nuovo re di Tebe. Un cedimento alla vita che, per un istante, uma-nizza e forse rende meno sublime l’immagine dell’intransigente fanciulla che, fino adallora, ha mostrato di desiderare solo l’incontro con Ade.
Oltre ad avere a suo tempo infastidito Goethe,1 questo passaggio del testo sofocleo po-trebbe in effetti porre una distanza notevole tra la natura dei sentimenti di Antigone e lasensibilità contemporanea. Inoltre, il contenuto e la forma di questa lamentazione, op-ponendosi al tema della fascinazione per Ade e i suoi oscuri richiami, sembrano rompe-re sia la coerenza formale dell’opera, che postulerebbe ‘alta’ e di inamovibile nobiltà laposizione dell’eroina, sia la ‘durata’ psicologica del mito in una prospettiva che, per farel’esempio più noto, all’inizio del secolo scorso, aveva reso possibile a Freud, attraversouna rilettura esemplare dell’Edipo re, la scoperta del relativo ‘complesso’ e dei suoi risvolticlinici (il triangolo edipico e la sua relazione con la sessualità infantile precedente l’etàdella ‘latenza’).2
Riguardo alla ricerca di un elemento psicologico nucleare e fondante del mito di Anti-gone, viene spesso indicata la lettura che Jacques Lacan ha dato della tragedia.
Se mai si riuscisse a riportarne il pensiero in sintesi, Lacan considera le scelte, i senti-menti, il coraggio temerario e il ‘fulgore insopportabile’ della giovane eroina tebana ‘al dilà del principio di piacere’; così ella, più che richiamare il bello, è direttamente un ‘baglio-re di bellezza’ che, in una ‘posizione’ tra la vita e la morte, in un luogo liminare (la tom-ba), non necessita di alcun maquillage: Antigone è quello che è. Una figura originaria, su-blime e perturbante della pulsione di morte freudiana: «la pulsione di morte illustrata».3
Per accogliere questa prospettiva, anche a riconoscere che dal bios umano partano dav-vero delle pulsioni dirette al raggiungimento di uno stato inanimato4 e metterle in rela-zione con la figura della figlia ribelle di Edipo, si tratta di giungervi superando quei pochiversi della tragedia, centrali per Lacan5 e fondanti per Hegel, che ci appaiono densi, rile-
to alla sua quiete e all’equilibrio. Essi allora non si appetiscono reciprocamente; non hanno dato né ricevuto l’un l’al-tro questo esser-per-sé, ma sono reciprocamente libera individualità. Perciò l’elemento femminile, ha come sorella,il più alto sentore dell’essenza etica; […] Perciò la perdita del fratello è insostituibile per la sorella, e il suo dovere ver-so di lui è quello supremo». G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, vol. ii, traduzione di Enrico De Negri, Firen-ze, 1973, p. 17.
1 J. P. Eckermann, Conversazioni con Goethe, Torino, 2008.2 S. Freud, Opere, vol. 3, pp. 242-244, Torino, 1980, e Idem, Il tramonto del complesso edipico (1924), in Idem, Opere
vol. 10, Torino, 1978. Sulle differenti risonanze nel xx secolo dell’Antigone rispetto all’Edipo re, Karl Kerény, op. cit.,pp. 9-10, ha osservato: «Antigone, la conquista più grandiosa per l’umanità, non ha mai esercitato sui posteri l’effettoche ebbe a esercitare un’altra tragedia del poeta, che, in modo diverso, ha scosso il nostro secolo, Edipo re. Forse unasimile scossa sarebbe potuta venire anche da un’opera poetica più modesta – è a partire da Antigone, infatti, che So-focle diventa un poeta tragico sempre più perfetto – purché avesse assunto come tema lo stesso destino. Non si trat-ta dell’effetto immediato, irresistibile di ciò che artisticamente e umanamente è riuscito in modo incomparabile a unpoeta; non è in gioco l’azione prodotta su un numero incalcolabile di persone, gioiose di accoglierla, un’azione chesarebbe maturata nel moto spirituale di una nuova atocomprensione: giacché all’inizio si è avuta su di un solo uomoe fu lui a suscitare quel moto. Tale moto ha un nome: psicoanalisi. Se è derivato dall’Edipo re sofocleo, ciò accadde so-lo perché Freud, fece propria, o scoprì dentro di sé un germe, questa tragedia».
3 J. Lacan, Il seminario. Libro vii, Torino, 2008.4 S. Freud, Al di là del principio di piacere (1920), Torino, 1975.5 J. Lacan, op. cit., p. 298. Alle pp. 326-327, alludendo alle perplessità di «un certo autore» (probabilmente Goethe),
Lacan osserva come è proprio nel momento della sua «lamentazione» in una condizione «tra le due morti» che si ha«il momento di superamento, di realizzazione dell’Ate di Antigone». Il giudizio espresso da Goethe, riguardo un ab-bassamento di tono nella figura di Antigone che improvvisamente, abbandonato il suo algido fulgore, sembra svilir-si, andrebbe, per Lacan, ribaltato dalla considerazione che andando verso la tomba, la fanciulla è già ‘tra le due mor-ti’: «Quando comincia questo pianto? Dal momento in cui varca la soglia tra la vita e la morte, dove quel che ha giàdetto di essere prende forma esteriormente. Da tanto tempo ci ha detto di essere già nel regno dei morti, ma stavol-
7. sofocle, antigone 129
vanti e problematici quanto culturalmente lontani. Sono i versi 904-912 nei quali la gio-vane eroina protesta e spiega le ragioni del sentimento che la lega al fratello Polinice, unsentimento così sacro e in lei così radicato, da averla spinta violare l’editto di Creonte.
Antigone espone in questi termini i motivi di un gesto dovuto all’amore per il fratellomorto:Certamente non avrei intrapreso questa audacia sfidando il volere della città né per i figli, né se aves-si visto putrefarsi il corpo del mio sposo. E dunque in ossequio a quali principi ragiono così? Se aves-si perduto il marito, avrei potuto trovarne un altro e avere da lui un altro figlio, se mi fosse morto unfiglio; ma ora che mio padre e mia madre giacciono sotto la terra, non potrò avere un altro fratello.1Sono alcuni versi che, come accennato avanti, hanno fatto discutere parecchio. Se da unaparte Hegel pensa di ritrovarvi lo spirito più alto della civiltà greca, dall’altra Goethe, com-mentando un testo ‘hegeliano’ di Hermann Hinrichs sull’essenza della tragedia antica, os-serva: «nell’Antigone c’è un passo che mi è sempre sembrato un difetto, e per il quale nonso cosa darei se un eccellente filologo ci dimostrasse che è stato inserito in un secondotempo e che non è autentico». Successivamente precisa:dopo che, nel corso della tragedia l’eroina ha superbamente esposto le ragioni della sua condottarivelandoci tutta la nobiltà e la purezza della sua anima, alla fine, quando sta avvicinandosi alla mor-te, adduce a propria giustificazione un ulteriore motivo che è davvero pessimo e rasenta il ridico-lo. […] Ciò che ha fatto per suo fratello, dice, non lo avrebbe fatto per dei figli se fosse stata madre enemmeno per un marito. Perché, continua, se mi fosse morto il marito avrei potuto risposarmi, ese mi fossero morti i figli ne avrei potuti mettere al mondo altri, con un nuovo marito. Ma con miofratello è diverso. Non posso riavere un fratello perché mio padre e mia madre sono morti e dun-que non c’è nessuno che potrebbe generarlo. Questo almeno è il senso nudo e crudo del passo che,sulle labbra di un’eroina condotta a morte, altera secondo me l’atmosfera tragica e mi sembra trop-po ricercato oltre che troppo simile a un calcolo dialettico.2
Stabilita in seguito, anche se in modo non definitivo, l’appartenenza al testo sofocleo diquesto passaggio, rimane da capire se quei versi abbiano la funzione di innescare la tra-gedia e invigorire il mito che la sostiene o invece possano esservi sottratti senza alterarneil senso; vanificando però le molte e autorevoli opinioni di quanti hanno speculato sullaloro centralità.
ta la cosa è un dato di fatto». Dunque il punto di vista di Goethe si tradurrebbe in un «insensato controsenso perchéper Antigone la vita non può essere affrontata, non può essere vissuta e pensata che da questo limite dove ella ha giàperso la vita, dove è già al di là della vita – ma da dove può vederla, viverla sotto forma di ciò che è perduto». Su que-ste considerazioni ci sarebbe da osservare che, nel momento della lamentazione, Antigone non è fisicamente dentrola tomba e che l’esecuzione della pena non è ancora stata ordinata, dunque la condizione ‘tra le due morti’ per lei èancora soltanto una prospettiva terrificante e lei, in questo preciso momento della tragedia, si sta rivolgendo a Cre-onte e al Coro. Dunque il suo pianto avviene quando Creonte non ha ancora ordinato alle guardie di condurla defi-nitivamente al luogo del supplizio e non è del tutto certo che la condanna (la tomba) sarà eseguita, né, dal testo, ri-sulta esplicito che si tratti di una condanna a morte sicura o di un castigo esemplare che, per la sua lentezza, avrebbein astratto potuto sortire altri esiti o ripensamenti. Creonte, prima di fare eseguire il verdetto e prima della replica diAntigone, emette la ‘sentenza’ e commina la pena: «muratela nella sua camera sepolcrale e lì abbandonatela, sola, se-gregata da tutti, sia che intende morire, sia che voglia sopravvivere nella tomba» (vv. 885-889). La successiva lamen-tazione di Antigone, che avviene prima dell’esecuzione della pena, crea effettivamente nella tragedia una tensione di-versa, tuttavia ciò non ci fa sperare più di tanto in una grazia concessa in extremis alla condannata: ciò infatti, oltread umanizzarlo in anticipo, salverebbe Creonte dalla rovina e non avrebbe la resa drammaturgica data dalla sua insi-stita sordità. Il suo ripensamento infatti avverrebbe ‘in tempo’, nel momento giusto e sperato; Creonte da questo pun-to di vista è invece un magnifico antieroe egodistonico, un maestro del fuori-sinc e un modello inarrivabile per quel-le psicologie contemporanee che studiano i meccanismi del come fare le cose giuste al momento sbagliato e rendersiinfelici.
1 Sofocle, Antigone, in Antigone, Edipo re, Edipo a Colono, a cura di F. Ferrari, Milano, 1982. Tutti i versi riportati initaliano successivamente appartengono alla medesima traduzione.
2 J. P. Eckermann, op. cit., Conversazione 28 marzo 1827, p. 472.
130 giovanni di maria
Può essere utile in proposito riportare alcune considerazioni di George Steiner:
Nessun lettore profano potrà fornire un contributo agli argomenti contraddittori sull’autenticità ol’interpolazione dei versi 904-920 che hanno diviso i classicisti, i filologi e gli studiosi della tragediagreca a partire dal 1821. Ma ciò che il profano noterà è la luce gettata da questo dibattito inconci-liabile sui limiti sia della filologia sia dell’intuizione. La mia sensazione – che deriva in parte dagliallestimenti dell’Antigone che ho visto, dove questo passo veniva a volte incluso, a volte omesso – èche questo passo faccia parte della tragedia.1
Nobile o sconcertante, autenticata o discutibile, la formula nella quale è condensata l’af-fettività di Antigone pone, ritengo, un problema che in una certa misura esula anche daalcune possibili intenzioni sofoclee; dalla questione ad esempio che per il drammaturgogreco, si trattasse o meno di tracciare una figura arcaica capace di negare, opponendosiin nome della tradizione a Creonte, la cogenza di nuove leggi e l’ordinamento giuridicodella polis (vv. 162-210). Il problema potrebbe essere un altro, e tale in realtà da rendere,ai giorni nostri, un po’asfittico il mito di Antigone.
Per quanto vi possano essere dei tentativi interessanti di ‘recuperare’ alla contempo-raneità la Philía di Antigone,2 ‘quel’ sentire e ‘quel’ lutto rischiano tuttavia di apparirci ir-rimediabilmente lontani; tanto che una risonanza profonda, in senso psicologico, di que-sto aspetto fondante del mito, la ricerca di una sua componente archetipica che riaffiorinel presente3 o una semplice identificazione in veste di spettatori teatrali contemporaneicon ‘quelle’ ragioni, così come sono sinteticamente esplicitate dall’antagonista di Cre-onte, ci sembrano oggi davvero poco probabili.
È quanto mai probabile invece che la ‘posizione’ di Antigone e la comprensione deisuoi sentimenti si rendessero accessibili al pubblico teatrale greco in altri modi.
Erodoto inserisce nel libro iii, 119 delle Storie il racconto del re persiano Dario e dellacattura di Intafrene che, insieme ad altri, aveva tramato una congiura:
Era convinto che lui e i suoi congiunti tramassero un colpo di stato. Li fece arrestare tutti insie-me e imprigionare in attesa di esecuzione. Ma la moglie di Intafrene veniva continuamente allaporta del re piangendo e gemendo: perseverando in questo atteggiamento, finì per suscitare la
1 G. Steiner, op. cit., p. 310. 2 F. Brezzi, Antigone e la Philía, Milano, 2004.3 Se mai si volesse ricercare una componente archetipica nell’Antigone, azzarderei che andrebbe trovata partendo
dal riconoscimento in Dioniso e di una funzione animica del femminile come guida di chi assiste al rito della trage-dia. Di sicuro, per noi, questo è uno sfondo un po’esoterico dell’opera e di ciò che vi accade. Tuttavia, a parte gli espli-citi riferimenti testuali a una catarsi necessaria (invocazione del coro al dio perché salvi la città dal morbo che afflig-ge tutto il popolo – versi, 1137-1145 –, colpisce l’ironia del testo che, in più punti, irride alle preoccupazioni di Creonteper la sua integrità sessuale: l’autonegazione della sua componente femminile, con il rischio abbastanza ridicolo diun’inversione di ruolo, cui lo portano il dialogo con Antigone (vv. 484-485) e con Emone (741, 756), può richiamare laparallela ‘rigidità identitaria’ di Penteo gabbato da Dioniso in Baccanti di Euripide (vv. 821-861). Dunque, come già os-servato da Hegel (Estetica, cit., p. 1360), «se l’unilateralità deve essere superata, è dunque questo individuo che, nellamisura in cui ha agito come l’unico pathos, deve essere soppresso e sacrificato». L’elemento catartico della tragedianon riguarderebbe i destini e le figure di Antigone dal fulgore perturbante o di Creonte legislatore inflessibile ‘presiin sé’, ma si attiverebbe a partire dal mancato o equivoco dialogo tra i due: dalla reciproca illustrazione di sé nella ne-gazione dell’altro usato come mero elemento di contrasto, fino a suscitare nello spettatore uno stato nel quale po-trebbe originarsi il bisogno di un’apertura al Sé nell’accezione junghiana del termine. Le funzioni di Anima/Animus,la congiunzione degli opposti, maschile-femminile, passando per la morte metaforica, la putrefazione e la rinascitanella ‘nuova progenie’, rappresentata dal simbolo dell’androgino, esplicati dallo psicologo svizzero attraverso le me-tafore e le immagini del processo alchemico (in proposito, Psicologia e alchimia e Psicologia del tranfert) sono l’opus checonduce al Sé. Celebrando Dioniso – come Sıva indiano, dio infero ma anche generatore di vita e danza, capace di at-tivare energie femminili – le conseguenze funeste del reciproco disconoscimeto tra due personalità rigide e tra duepassioni dominanti (Antigone-Creonte), possono essere superate e poi integrate in ciò che Jung ha chiamato indivi-duazione: processo il cui punto di approdo è, appunto, il Sé con le sue implicazioni personali, spirituali e collettive. Unarchetipo nel quale la congiunzione degli opposti (e la spiritualità che ne consegue) ha una funzione cruciale.
7. sofocle, antigone 131
compassione di Dario, il quale le inviò un messaggero a riferirle queste parole: ‘Donna, il re Da-rio ti concede di salvare la vita di uno dei tuoi parenti imprigionati: scegli pure chi vuoi fra tutti’.E lei, dopo aver riflettuto, così rispose: ‘Se il re mi concede la vita di uno solo, allora fra tutti scel-go mio fratello’. Quando Dario ne fu informato si stupì molto, e le mandò a dire: ‘Donna, il re sidomanda perché abbandoni tuo marito e i tuoi figli e scegli che a sopravvivere sia tuo fratello, ilquale ti è certo più estraneo dei tuoi figli e meno caro di tuo marito’. E lei replicò: ‘O re, se diovuole io posso avere un altro marito, e altri figli, se perdo quelli che ho; ma poiché mio padre emia madre non sono più vivi, in nessun modo potrei avere un altro fratello. È per questa ragio-ne che ti ho dato quella risposta’. A Dario parvero molto sagge le parole della donna: soddisfat-to di lei, oltre al fratello le lasciò libero anche il maggiore dei figli; tutti gli altri invece li mandòa morte.1
La coincidenza tra gli argomenti usati dalla supplice di Dario e la ‘lamentazione’ di An-tigone è evidente, così qualche traduttore ha parlato di una ‘citazione’ erodotea inseritada Sofocle nel suo testo.2 Lacan invece considera ininfluente questa coincidenza: «Non èche perché due passi si assomigliano che si deve pensare che il secondo sia la copia delprimo. E poi perché questa copia sarebbe inserita proprio lì?».3 Confrontando i versi, sipuò invece intuire l’inclusione nella tragedia di alcuni motivi (il re e la supplice) e di unragionamento (il perché della preferenza accordata al fratello) che esprimono un sentirecomune, condensato in espressioni che, con sensibilità moderna, diremmo popolari; ciòche, in altro modo, Goethe aveva avvertito come un corpo estraneo all’opera. La prefe-renza accordata, tra gli affetti familiari, all’amore per il fratello, vi ha l’accento di un do-vere espresso in una formula che dà l’impressione di essere comunemente nota e maga-ri ritualizzata: un modo di dire, forse influenzato da una retorica sofistica, che in primabattuta deve creare stupore e incuriosire (la reazione immediata di Dario: perché tra tut-ti i congiunti salvare proprio il fratello?), poi suscitare stima (il dono della ulteriore libe-razione del figlio maggiore).
Supponendo che il pubblico di Sofocle avesse ascoltato la maschera di Creonte dareuna risposta alle parole proverbiali della maschera di Antigone, analoga a quella data dalre Dario alle speculari parole usate dalla moglie di Intafrene, non si sarebbe generata al-cuna tragedia. La sordità del nuovo re di Tebe è invece tale e così sottolineata (si pensi al-lo scambio di battute con Emone ) da fargli ignorare anche le più diffuse e popolari del-le ragioni. Così nei versi 904-912 è probabilmente racchiuso il sentimento collettivo cheforse poteva far apprezzare meglio al pubblico di Sofocle Antigone come eroina tragica,e non come ‘folle dalla nascita’ (parole del re suo zio, vv. 561-562). Si tratta di un sentirecomune che passa attraverso una formulazione quasi certamente nota e condivisa che,nell’economia del dramma, acquista un forte rilievo proprio in quanto, non meno dellealtre ragioni, ma forse ancora più scandalosamente, viene deliberatamente ignorata daCreonte. È un momento del dramma nel quale la ragazza, già condannata al suppliziodella tomba, presenti Creonte e il coro, appare meno sublime del solito e sta probabil-mente svolgendo davanti al sovrano e all’opinione pubblica della propria città, la suaestrema difesa: si ‘abbassa’, diventa ‘femminile’, cerca di commuovere, prova a convin-cere, dubita delle sue divinità (di certo non particolarmente care al nuovo re di Tebe), ra-giona con modalità quasi causidiche e ricorre ad un sofisma forse noto a tutti e non sol-tanto ad Erodoto.
1 Erodoto Storie, iii,119, a cura di Fulvio Barberis, Milano, 1989.2 F. Ferrari, op. cit., Introduzione, p. 8. Milano, 1982.3 J. Lacan, op. cit., p. 299.
132 giovanni di maria
Se poi nel ragionamento di Antigone si volesse scorgere anche un richiamo allusivoalla storia persiana di Erodoto – che si può supporre fosse popolare – e alla magnanimi-tà mostrata in quel racconto dal re Dario per la supplice, allora questa citazione conter-rebbe anche un velato appello alla clemenza, al buon senso e alla saggezza di un Creon-te finalmente legittimato nel ruolo di re e giudice. Dario farebbe giurisprudenza.
In ogni caso resta visibile un atteggiamento diverso da parte dell’eroina, un cambia-mento: vi è come un’apertura al suo antagonista rispetto ai passi nei quali lei discono-sceva totalmente l’autorità dello zio divenuto re, e la negava con tale fiera accettazionedella morte da farlo dubitare persino della propria virilità (vv. 450-470, 473-585).
Creonte, invece, reagisce rivolgendosi alle guardie ed ordinando loro di affrettarsi nel-l’eseguire la condanna. Antigone, udito il comando, replica: «Ahimé, ecco un ordine chedichiara prossima la morte’ (vv. 933-934), Creonte le risponde: «Non ti incoraggio davve-ro a illuderti che questo verdetto non abbia compimento» (vv. 935-936). A questo puntoAntigone, fallita la sua difesa, ha un sussulto di orgoglio aristocratico: torna sui suoi pas-si, si riposiziona e si rivolge all’opinione pubblica, agli dei a lei cari (miracolosamente tor-nati al loro posto) e ai principi della città, cioè a quelli del suo stesso blasonato ambien-te: «O Tebe, città dei miei padri, o dei aviti, mi trascinano via e più non posso tardare.Guardate o principi tebani, quale sopruso, e da quali uomini, subisco, io, dei vostri re ul-tima figlia, solo perché onorai la pietà» (vv. 937-943).
La fanciulla ritorna così ad assumere un atteggiamento altéro, ma meno fulgido e ‘fol-le’, meno divinamente invasato che in altri momenti della tragedia (si pensi a come, al-l’inizio del dramma, ‘Lei’ si pone rispetto ad Ismene): un modo più ‘laico’ ed esplicita-mente politico, considerato l’invito, rivolto alla città e all’aristocrazia, a delegittimareCreonte e reagire al suo sopruso. Volendo vi si potrebbe scorgere un ulteriore, dispera-to tentativo di essere liberata dalla morsa incombente di Ade, magari sperando in unasollevazione a guida aristocratica in suo favore.
Dunque il bagliore ctonio che emana da Antigone – così bene evocato da MargueriteYourcenar1 e così evidente allo sguardo di Lacan da fargli affermare che la fanciulla, nel-la ‘posizione’ della doppia morte, ‘è’ quel fulgore – nel corso della tragedia varia sensi-bilmente di intensità, e in realtà sembra scendere proprio lì dove per Lacan raggiungel’apice.2 In particolare ai versi 891-928, latitanti i ‘suoi’ dei, l’attrazione per Ade dell’eroi-
1 M. Yourcenar, Antigone o della scelta, Parigi, 1957, in M. Yourcenar, Fuochi, Milano, 1984.2 J. Lacan, op. cit., p. 301, osserva che, ad uno sguardo attento, non vi è simmetria tra Antigone e Creonte: «è
certo che perlomeno uno dei due protagonisti, fino in fondo, non conosce né timore né pietà, ed è Antigone. É perquesto, tra l’altro, che essa è il vero eroe». In un altro passaggio, riferito alla condanna e alla successiva ‘lamenta-zione’ di Antigone, p. 326, aggiunge: «A questo punto si produce il vero cambiamento di luce della tragedia, cioè ilÔ̄ÌÌfi˜, il pianto, il lamento di Antigone, ed è molto significativo che molti commentatori se ne siano scandalizza-
ti». Con ciò Lacan intende sottolineare che in quel momento si rende ancora più evidente la fulgida, eroica, posi-zione di Antigone ‘tra le due morti’. Il settecentesco punto di vista sulla ‘lamentazione’ espresso nel Voyage du Jeu-ne Anacharsis dall’abate Barthélemy, precedente ad un dibattito destinato a durare all’infinito, sembra invecepiuttosto immediato e non privo di una sana ovvietà: «son coeur fier et indomptable, cédant à la voix impérieusede la nature, a montré un instant de faiblesse, et fait entendre ces accents douloureux!». Credo sia da notare in pro-posito – anche per evidenziare che il cambiamento di luce non esalta, contrariamente a ciò che ritiene Lacan, l’eroi-smo di Antigone ma lo attenua – come l’inflessibilità esibita da Creonte e la sua fretta di dare esecuzione alla con-danna senza volere dare ascolto ad altre ragioni, muti completamente di motivazione e riguardi stavolta il timoredel femminile e di una pietà incarnata in Antigone che, di fronte alla prospettiva della morte, diviene corporea edonna: si fa corpo, femminile e dolente, consegnato al volere del sovrano e deprivato della gioia di avere un mari-to e di generare dei figli. Ciò avviene una prima volta quando, in risposta ad Antigone che, mutando di segno, met-te a nudo se stessa e il suo toccante destino, Creonte enuncia, con esibita e sprezzante noncuranza, il dispositivodella ‘sentenza’ di condanna e ne ordina l’esecuzione (vv. 883-890); una seconda volta, quando, dopo il pianto dellafanciulla, ordina l’esecuzione del verdetto e nega ad Antigone ogni speranza di essere graziata (vv. 931-932, 935-936).
7. sofocle, antigone 133
na – illustrazione esemplare di un desiderio incolmabile perché senza oggetto, perciò ‘aldi là del principio di piacere’ – sembra invertirsi in un più naturale desiderio di fuga da-gli inferi, mentre pare assumere un’evidenza ancora più marcata il ruolo ‘civile’ e nor-mativo di un sentimento granitico, ‘codificato’ in parole già note che non sono di Anti-gone più di quanto lo siano della collettività. Una ragione espressa con parole non ‘sue’,e neanche di Sofocle, il cui significato ‘pubblico’, al pubblico greco, poteva apparire chia-ro, indiscutibile, essenziale, profondamente assimilato e persino ‘logico’. Un sentimentonon negoziabile e irreversibile, le cui prepotenti determinanti culturali rinviano a un mo-do prestabilito e accettato d’intendere il rapporto tra fratello e sorella nella gerarchia de-gli affetti familiari; un rapporto lontano dalla nostra sensibilità che si ipostatizza in unaformula persuasiva, con ogni probabilità ripetuta e ascoltata spesso.
In altri termini – conclusione ovvia – Antigone è messa in scacco dall’amore che, percultura, deve anche al fratello ‘deviante’ (vv. 904-912) non meno di quanto la spinga allamorte un destino inscritto nelle vicende e nel genoma suo e della sua progenie (vv. 1-7,460-464, 853-871).
Lavorando due anni orsono insieme a Giusi Norcia ad un documentario, inevitabil-mente ‘polifonico’, sulle ragioni di Antigone, ci eravamo perciò chiesti più e più volte do-ve potessero essere rintracciabili eventuali sopravvivenze della philía di Antigone; una sua‘durata’ non tanto nelle profondità di tutto l’inconscio collettivo occidentale,1 quanto, co-me reminiscenza, nelle tradizioni della Grecia o dell’Italia meridionale. Abbiamo pensa-to al lutto e al culto dei morti in Sicilia, al patriarcato, al cosiddetto ‘familismo amorale’del sud Italia, ad eventuali richiami nascosti nelle pieghe della letteratura isolana, tutta-via ci sembrava che del preciso sentimento che ‘possiede’ e agita l’eroina tebana, esclu-dendo ogni implicazione incestuosa,2 non vi fossero, nel presente, tracce sicure. In par-ticolare, confortati peraltro dalle opinioni di Anna Beltrametti ed Eva Cantarella,3stavamo maturando l’idea che la fortuna del mito di Antigone, soprattutto durante il se-colo scorso, fosse legata essenzialmente al tema della ribellione al potere o al potere co-me espressione del ‘maschile’. Ciò è particolarmente evidente in alcune pregevoli lettu-re e riscritture del mito, più o meno recenti, non prive di implicazioni femminili efemministe.4 Tuttavia, in queste e in altre rielaborazioni, avvertivamo come lo smarrirsi
Ancora una volta l’autorità e la virilità esibite da Creonte sembrano celare o compensare un’insicurezza. Solo chein questa parte della tragedia la ‘risposta virile’ del re non nasce in reazione all’eroismo, a sua volta ‘virile’, e in più‘folle’, di Antigone, ma dalla palese femminilità mostrata improvvisamente dalla ragazza che va al supplizio. Cre-onte, in altre parole, si nega a sentimenti opposti opponendovi la stessa rigidità: dall’imbarazzo di dovere ricono-scere in Antigone un eroe, passa al rifiuto, nell’esercitare il potere, di cedere alla pietà e riconoscersi il diritto adesprimere una parte di sé sensibile al femminile, che vorrebbe dire, dare un’anima a se stesso e al suo ruolo pub-blico. Ovviamente questa risposta reattiva ed emotiva, questa negazione dell’anima, lo conduce ad affrettare ma-sochisticamente il proprio destino: da una parte facendogli stringare catastroficamente i tempi enfaticamente ‘ma-schili’ delle sue decisioni, dall’altra facendogli rallentare delle scelte equilibrate e perciò spingendolo a subire gli esititragici dei suoi ripensamenti tardivi (In proposito, anche n.10). Rimane infine da considerare, ma è una riflessionemolto azzardata per gli strumenti di chi scrive queste note, se le due opposte ‘posizioni’ di Antigone – il fulgoreeroico e ctonio da una parte, il femminile rimpianto per la vita e le sue promesse dall’altra – alludano a un ingan-no di Dioniso ai danni di Creonte e della città inerte, il che farebbe forse della figlia ‘anarchica’ di Edipo una mani-festazione dei voleri del dio.
1 La ‘Psicologia archetipica’ di Hillman, a differenza di quella junghiana, considera l’inconscio collettivo occi-dentale quasi esclusivamente greco. In particolare, per un collegamento tra l’inconscio e Ade, si può vedere: J. Hill-man, Il sogno e il mondo infero, Hillman, 1979, ed. it. Milano, 1984.
2 In proposito, J.P. Vernant, P. Vidal-Naquet, Mito e tragedia nell’antica Grecia, Torino, 1977.3 Per considerazioni sull’arcaicità della figura di Antigone, gli interventi di Anna Beltrametti ed Eva Canta-
rella in Le Ragioni di Antigone, audiovisivo di G. Di Maria e G. Norcia, Siracusa, 2006 (riedizione 2008).4 In proposito, F. Brezzi op. cit., in particolare, Parte seconda, La femminilità rifiutata?, e J. Butler, op. cit.
134 giovanni di maria
di un nucleo profondo della tragedia, un aspetto tanto fondamentale quanto difficile daindividuare e riportare al presente.
Avevamo così maturato l’idea che ogni empatia con le ragioni fondamentali e i senti-menti di Antigone fosse al giorno d’oggi impossibile e che, per quanto affascinanti, mol-te risonanze contemporanee di questo mito potessero essere in larga parte frutto di unmalinteso.
Chiuso comunque l’audiovisivo – nel quale la relazione tra il mito e la cultura popo-lare veniva semplicemente evocata dal racconto di un cantastorie – lo abbiamo propostoin alcuni festival e in qualche incontro. In uno di questi, organizzato a Roma da un ami-co analista junghiano, a fine proiezione, Franca Lettieri, una simpatica signora originariadi Crotone, visibilmente toccata dal filmato, mi avvicinò per dirmi come finalmente aves-se capito, attraverso Antigone, quale sentimento doloroso aveva segnato profondamen-te l’esistenza di sua nonna e di riflesso quale cupa tonalità affettiva si era, per molti anni,riverberata sulla vita dell’intera famiglia. All’origine vi era il lutto mai elaborato per lascomparsa precoce di un fratello che l’anziana signora, peraltro appartenente alla buonaborghesia della città, era solita sottolineare con la continua, ossessiva, ripetizione di unproverbio abbastanza conosciuto e diffuso nella Calabria ionica: «Mariti mi n’abbrazzu,figghi mi ni fazzu, frati e soru comu fazzu?».1
La traduzione è più o meno la seguente: «Mariti posso abbracciarne (averne più diuno), figli ne posso generare, ma come faccio se perdo fratelli e sorelle?»
Avuta questa informazione, dopo un attimo di incredulità, sono corso a Crotone edho intervistato la signora Franca Napoli Lettieri, zia della mia informatrice, che mi ha ripetuto il proverbio e il contesto nel quale sua madre era solita recitarlo. Ho successi va-mente sentito alcuni anziani del posto che lo conoscevano e ho registrato anche una va-riante che ne lascia immutato il senso. Ho provveduto, inoltre, a rimontare il documen-tario e ad integrarlo con queste nuove informazioni.
In effetti il proverbio, la cui recitazione non può che essere femminile, contestualizza-to, inoltre, nella difficile elaborazione di un lutto per la scomparsa del fratello, sembravaripetere in traduzione dialettale le parole di Antigone e riproporre il nucleo della sua phi-lía nella tragedia di Sofocle.
Credo in definitiva che la scoperta casuale di questo proverbio, la sua specularità coni versi più discussi dell’Antigone di Sofocle e con le parole della moglie di Intafrene nellastoria persiana di Erodoto, possa un po’contribuire ad una migliore comprensione dellapiù controversa, affascinante e fortunata figura tragica dell’antichità. Il proverbio dellaCalabria ionica che ho raccolto e qui riportato, sembra chiarire almeno un aspetto del-l’affettività di Antigone e darvi una sorprendente e inattesa continuità; non per un sup-posto carattere archetipico di questo affetto giacente nei meandri dell’inconscio colletti-vo occidentale, quanto per la sua associazione ai vincoli familiari e all’elaborazione dellutto in un’area culturale, limitata e greca, come quella di Crotone.
Il proverbio di Crotone potrebbe offrire così un contributo ad una ‘archeologia dei sen-timenti’ attraverso il ritrovamento di una specifica ‘codificazione del dolore’ relativa allutto della sorella per la scomparsa del fratello che, partendo dalle vertiginose altezze rag-giunte in oltre due secoli dall’Antigone di Sofocle, poteva anche apparirci lontana, inna-
1 Il proverbio si trova pubblicato nel volume I ditti ‘i l’antichi, a cura di D.G. Paonessa, Crotone, 1983. Da me in-tervistato, il curatore del libro dà un’interpretazione del proverbio che esclude ogni relazione tra quest’ultimo, Anti-gone, la philía e l’elaborazione del lutto, sostenendo in buona sostanza che nella cultura calabrese il rapporto fratel-lo-sorella non avrebbe un rilievo particolare nella gerarchia degli affetti: il proverbio alluderebbe semmai a possibiliconflitti tra i figli nell’economia dei rapporti familiari.
7. sofocle, antigone 135
turale, poco comprensibile e forse sconcertante. È probabile insomma che il proverbionon sia un lascito di Antigone, un passaggio dalla cultura ‘alta’ a quella popolare, quantoil perpetuarsi di un sentire, capace, in una certa misura, di fare riaffiorare nel presente illogos e il pathos di parole il cui senso sembrava si fosse smarrito nel tempo e nella praticadi un’interpretazione infinita; ciò aggiunge forse qualcosa, e toglie qualcos’altro, alla let-tura di un testo (il testo teatrale per eccellenza) rispetto al quale «il concetto di com-prensione totale è una finzione» e noi siamo «solo interpreti di interpretazioni».1
1 G. Steiner, op. cit. pp. 11, 320.
composto in carattere dante monotype dallafabrizio serra editore, pisa · roma.
stampato e rilegato nellatipografia di agnano, agnano pisano (pisa) .
*
Giugno 2010
(cz3/fg22)
Tutte le riviste Online e le pubblicazioni delle nostre case editrici(riviste, collane, varia, ecc.) possono essere ricercate bibliograficamente e richieste
(sottoscrizioni di abbonamenti, ordini di volumi, ecc.) presso il sito Internet:
www.libraweb.net
Per ricevere, tramite E-mail, periodicamente, la nostra newsletter/alert con l’elencodelle novità e delle opere in preparazione, Vi invitiamo a sottoscriverla presso il nostro sito
Internet o a trasmettere i Vostri dati (Nominativo e indirizzo E-mail) all’indirizzo:
*
Computerized search operations allow bibliographical retrieval of the Publishers’ works(Online journals, journals subscriptions, orders for individual issues, series, books, etc.)
through the Internet website:
www.libraweb.net
If you wish to receive, by E-mail, our newsletter/alert with periodic informationon the list of new and forthcoming publications, you are kindly invited to subscribe it at our
web-site or to send your details (Name and E-mail address) to the following address: