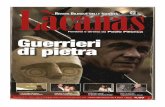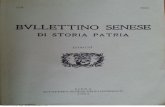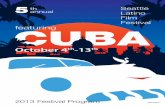One Language, One Nation, and One Vision: NBC Latino, Fusion, and Fox News Latino
I semitismi antichi nel latino
Transcript of I semitismi antichi nel latino
L'ITALIA E IL MEDITERRANEO
ANTICO Atti del Convegno
della Società Italiana di Glottologia
Testi raccolti a cura di Addolorata Landi
Fisciano - Amalfi - Raito, 4-5-6 novembre 1993
ESTRATTO
GIARDINI EDITORI E STAMPATORI
IN PISA
L'ITALIA E IL MEDITERRANEO
ANTICO Atti del Convegno
della Società Italiana di Glottologia
Testi raccolti a cura di Addolorata Landi
Fisciano - Amalfi - Raito, 4-5-6 novembre 1993
ESTRATTO
GIARDINI EDITORI E STAMPATORI
IN PISA
INDICE
Premessa 9
JAVIER DE Hoz, Areas lingu{sticas y lenguas vehiculares en el extremo Medi-terraneo occidental 11
EMILIO PERUZZI, Il greco in Italia dai Micenei ai Tarquini 45
Resoconto dèlla discussione (giovedì 4 novembre, pomeriggio) 59
,pA.oLo MARTINO, .Il problema dej $i;mitismi an(ichi nel latino 65
HELMUT Rlx, L'etrusco fra l'Italia e il mondo mediterraneo 119
DOMENICO SILVESTRI , Preistoria e protostoria linguistica nel Mediterraneo 139
Resoconto della discussione (sabato 6 novembre , mattina) 173
7
IL PROBLEMA DEI SEMITISMI ANTICHI NEL LATINO
O. In seguito alle recenti acquisizioni archeologiche ed epigrafiche che hanno documentato una densità finora insospettata di contatti tra Semiti (soprattutto Fenici, Aramei e Cartaginesi) e popolazioni della penisola italiana (specialmente Etruria, Lazio, Campania) nel corso del 1 millennio a.C. 1
, appare sempre più inspiegabile il fatto che non si sia riusciti finora a rilevare un congruo numero di interferenze lessicali semitiche nel latino arcaico e classico. Rispetto alle sopravvivenze di sostrato e alle voci di origine etrusca, italica, greca, celtica, gli imprestiti, sia pure tardi, di sicura origine semitica diretta nel latino, quando non vengono categoricamente esclusi come «Phantasiegebilde»2, sono ammessi in numero sorprendentemente esiguo. Chi compulsa il Verzeichnis der nichtlateinischen Worter della Grammatica di Leumann-Hofmann-Szantyr, s'imbatte solo in tre lemmi ebraici, uno punico ed uno arabo3
, di questi solo due (tun'ica e Carthiigo) si possono considerare semitismi antichi, nel Sachverzeichnis del secondo volume, la voce Semitismen (p. 867) rimanda a Hebraismen. In un'opera di grande spessore come la Storia della lingua di Roma di G Devoto (Devoto 1983) si cercherà invano una menzione di apporti fenici o punici. vi si troverà un solo rapido accenno ad ebraismi nel tardo latino cristiano. Anche nella Storia della lingua latina di V Pisani, il bilancio degli imprestiti extra-italici non mediati dal greco, dall'illirico, dal celtico e dall'etrusco è scarno: un solo semitismo diretto, tun'ica4 Quanto alla possibilità di riflessi linguistici in latino della fre-
1. Una rassegna degli studi più recenti è in Moscati 1993. Nell'ultimo trentennio il quadro dei dati statistici sulle iscrizioni fenicio-puniche in Italia si è notevolmente modificato (Amadasi Guzzo 1967). Nella sua rassegna del 1977, S. Moscati censiva circa 170 iscrizioni fenicio-puniche in Italia, dal IX al I sec. a. C., con addensamento nel periodo della colonizzazione cartaginese della Sicilia e della Sardegna: 550-238 a. C. (Moscati 1979). 2. Cf. Leumann-Hofmann-Szantyr I 766: «Von Semitismen darf man im Spatlatein nur im Sinne direkter oder indirekter Hebraismen der Vulg. und der Ecci. sprechen, die Punismen, die Wolfflin u. a. bei Schriftstellern wie Fior finden wollten, sind Phantasiegebilde». Come si vede, il punto di vista è qui focalizzato sul latino tardo; si deve dedurre che a maggior ragione il giudizio sia ritenuto valido per l'antico. 3. Leumann-Hofmann-Szantyr Il, 198: l'impiego di homo in forme pronominali indefinite (nemo) si sarebbe incrementato nel tardo latino cristiano per influsso di gr avtl-Qcon:oç e di ebr 'if , *woino antecedente preistorico microasiatico comune a lat. vfnum e ad ebr yayin (I 61); ebr k"th6net termine di confronto per il fenicismo titnfca (I 186); pun. qarthadast modello di lat. Carthiigo (I 232). 4. «Se qualche parola extra-italica è giunta al protolatino sulla via di scambi commerciali, è difficile dire: forse risale così in alto l'imprestito di tunica, parola di origine semitica come il gr xnwv» (Pisani 1962, 161).
65
quentazione commerciale e della colonizzazione fenicia e cartaginese dell'occidente mediterraneo - oggetto principale del presente studio -, gli indoeuropeisti sono generalmente scettici. Il Meillet, Esquisse 87, parla di «peu de mots, traces rares», e ne cita solo tre. (saccus, cadus, tunica), di cui almeno due passano per grecismi. A. Ernout, nel libro Aspects du vocabulaire latin (1954), su 75 pagine dedicate ai prestiti nel latino (greci, estruschi, celtici e germanici), riserva solo un accenno ai semitismi, precisando che si tratta per lo più di voci mutuate dal greco o dall'etrusco5 Nencioni 1939, 7 dichiara che «ben scarsi sono i resti della lingua cartaginese (nel latino) e arduo il ritrovamento di precise corrispondenze latino-puniche». Anche la Geschichte der lateinischen Sprache di Friedrich Stolz (1910), dopo le rielaborazioni di A. Debrunner (1922) e di W P Schmid (1966), riserva solo 10 righi al semitico su circa venti pagine dedicate all' «influsso delle altre lingue sul latino» (greco, etrusco, celtico, messapico, venetico e illirico), in particolare sono citati due vocaboli punici (ave, magii1ia) e una terza (tunica) attribuita ad una non meglio precisata «lingua semitica orientale» (Stolz-Debrunner-Schmid 1973, 64) Le voci latine che la tradizione letteraria e glossografica antica ha riconosciuto come semitismi, quando non sono citazioni d'autore rimaste ai primi stadi del processo di ambientamento dell'imprestito, non godono in genere di credibilità, in mancanza di prove linguistiche certe. Sembra che in questo campo l'interesse prevalente degli studiosi si sia rivolto piuttosto alla ricerca delle solidarietà lessicali preistoriche e protostoriche tra i domini linguistici afroasiatico e indoeuropeo, o nel quadro del più ampio ambiente indomediterraneo. Non esistono, dunque, studi complessivi sui semitismi diretti nel latino, studi che non mancano invece per il greco. Nel quadro delle migliorate conoscenze della storia dei popoli del Mediterraneo antico, mi propongo qui di affrontare il problema inquadrandolo in una serie di questioni metodologiche6
1 Nella storia degli studi sui contatti tra lingue semitiche e latino si possono individuare tre momenti, caratterizzati da diversi orienta-
5. «Quant aux autres langues du bassin méditerranéen, africaines, sémitiques, asianiques, etc., elles n'ont fourni que des noms isolés, désignant des objets venus par la voie commerciale, étoffes, parfums, bois, plantes, pierres précieuses, ustensiles, animaux exotiques, etc., dont la plupart du reste, comme on a vu, ont été introduits en ltalie par l'intermédiaire des Grecs, ou plus rarement des Étrusques. Ils ne dépassent pas le nombre des emprunts de ce genre que la langue de tout pays est appelée à contracter au cours de relations de ses habitants avec les nations étrangères» (Ernout 1954, 92). 6. Per ragioni di opportunità di documentazione ho cercato di fornire riferimenti a idee e ipotesi le più varie, ma nello stesso tempo riservandomi di caso in caso di sottolineare i diversi gradi di ipoteticità.
66
menti prevalenti. In una prima fase si sono istituite connessioni di ordine etimologico tra singole voci latine, etrusche, greche e termini attestati in lingue mesopotamiche, asianiche, accadiche, ecc., senza un adeguato ambientamento storico linguistico 7 , successivamente è prevalsa la tendenza ad inquadrare tali connessioni in un tessuto di solidarietà culturali e linguistiche preistoriche emergenti nei cosiddetti "sostrati" preindoeuropei e presemitici8
; un terzo momento, caratterizzato da più vaste cognizioni storico-linguistiche e maggiore impe-
7 Di presenze linguistiche di origine semitica nel latino si sono occupati anzitutto gli esperti di lessicografia semitica, a cominciare dagli studi pionieristici di Samuel Bochart (1595-1667), di Wilhelm Gesenius (1786-1842), di Ernest Renan (1823-1892). Una prima lista di semitismi nel latino e nel greco è in W Gesenius, Scripturae linguaeque Phoeniciae monumenta quotquot supersunt edita et inedita, Leipzig 1837, 383-395. Il saggio di Alols Vanicek sui prestiti nel greco e nel latino (1878) e quello di W Muss-Arnolt (1892), dedicato espressamente ai semitismi nel greco e nel latino, sono essenzialmente compilazioni di voci greche e latine confrontate per lo più con l'ebraico. E. Weidner, in «Glotta» 4, 1913, 303-4 classificava anche lat. idus e marra tra le trasmissioni lessicali mesopotamiche verso l'Occidente (sum. itu, bab. marru); per G Sigwart, Zur etruskischen Sprache, «Giotta» 8, 1917, 138-168, lat. idus, toga, urbs, murus, subulo sarebbero prestiti dal sumerico (p. 152). Anche le congruenze semiti· che orientali delle sette voci latine studiate da Cohen 1938 (carcer, canna, columba, coleus, elementum, maritus, tabula) restano storicamente vaghe. Erkki Salonen 1974, 144, elenca sette voci latine (canna, cannabis, cornu, lanx, nap(h)tha, nitrium, saccus) per cui ritiene utili connessioni accadiche, senza però proporre persuasive ricostruzioni storico-etimologiche. Alquanto vaghi appaiono anche i paralleli istituiti tra il saturnio latino e versi babilonesi, tra aruspicina ed epatoscopia etrusco-italiche e mesopotamiche (Fehling 1980, 12-3). A. Boissier, «MSL» 11, 330 e 12, 35 spiegava il primo membro del composto haruspex con l'assiro har 'fegato'; cf. J Nougariol, «Bui!. Acad. Inscr et Belles-Lettres», 1955, 509 sgg. 8. Nel 1910 A. Cuny istituiva rapporti tra latino, greco e lingue semitiche di N-0 nel quadro di una ipotetica parentela preistorica (Cuny 1910). Nella stessa prospettiva, C. Autran proponeva una parentela genealogica tra sumerico e indoeuropeo (Autran 1925, 1926), indagando solidarietà lessicali e morfologiche di sostrato tra lingue semitiche e indoeuropee, specie anatoliche. Sulla stessa linea Maccarrone 1938. M. Cohen, che può considerarsi il fondatore delle ricerche sui contatti semiticoindoeuropei, pur muovendosi sempre nell'ambito delle suggestioni sostratistiche, introduce due concetti nuovi e destinati a grande fortuna: quello delle "parole sughero" ("mots bouchons"), veri e propri elementi lessicali erratici, "relitti" di sostrato che navigano in uno spazio vastissimo; e quello, correlato al primo, delle "parole viaggianti" ("mots voyageurs'', "Wanderworter"), irradiate da lingue che hanno corso in ambienti interetnici (1929, 1931). Gli studiosi delle convergenze preistoriche tra i.-e. e semitico (H. M!àller, A. Cuny, G I. Ascoli, J Kurylowicz, S. Levin, M. Fraenkel, L. Brunner, A. R. Bomhard, ecc.) fanno leva su ipotesi genealogiche e tipologiche. Cf. F Aspesi, Possibilità e limiti di un'odierna fonematica storico-comparativa camitosemito-indeuropea, «Atti Sodai. G!ott. Mii.» 21, 1979-80, 81-87 Una speciale menzione merita L. Heilmann, che anche per tale stadio preistorico ha privilegiato le affinità da contatto: «Si può riconoscere nel cam-sem. e. nell'i.-e. un insieme di isoglosse [ ] che costituiscono la prova di un"'affinità" [ .. ] anche [ ] 'nostratica', qualora da questo appellativo si escluda ogni significazione genealogica» (1949, 81).
67
gno critico, è segnato da progetti di accertamento di riflessi linguistici di contatti preistorici e storici tra singole lingue e culture. ma in genere i più antichi orientalismi nel latino vengono spiegati nel contesto di correnti d'imprestito dal Vicino Oriente verso l'Italia antica mediate essenzialmente dal greco9 Quest'ultimo orientamento sembra oggi in piena vitalità, accanto ad un filone di studi tipologici a volte non esenti da suggestioni genealogistiche.
Si può osservare che proprio la distinzione tra re 1 i t ti e impresti ti meriterebbe una maggiore attenzione, per un più puntuale ambientamento storico-linguistico e cronologico di questi ultimi. Il recente incremento delle nostre cognizioni, specie in campo archeologico ed epigrafico sul versante semitico, dovrebbe quanto meno attenuare la diffidenza degli storici del latino, anche perché la rarità dei semitismi certi si può spiegare con motivi diversi e concorrenti. di ordine storicogeografico (tipologia dei contatti tra le culture) e, nello stesso tempo, linguistico (distanza tra i sistemi grammaticali) e specificamente sociolinguistico (restrizione delle occasioni di interferenza a determinati registri e situazioni), senza considerare inoltre le caratteristiche dei testi latini arcaici. i materiali a noi noti del latino arcaico provengono per lo più da particolari registri (linguaggio giuridico, religioso, letterario), che di regola sono refrattari ai forestierismi, comprendendo quote di lessico delle istituzioni ereditarie.
2. Dunque, alcune considerazioni metodologiche s'impongono: e nsaputo che le interferenze lessicali (imprestiti) e semantiche (calchi) sono il risultato più cospicuo del contatto linguistico, che è una manifestazione del contatto culturale, ma si tratta di esiti finali, "precipitati" linguistici di un processo culturale. Ad una piena valutazione di quest'ultimo concorrono, a supporto dei criteri linguistici10
, dati ete-
9. Interessano di riflesso anche il latino gli studi centrati sui semitismi nel greco (Miiller 1877; Lewy 1895; Mayer 1960; Masson 1967), importanti per il tentativo di inquadramento storico-linguistico e cron,ologico di alcuni fatti. Nel suo studio del 1967 sui più antichi prestiti semitici in greco, Emilia Masson classifica tra i semitismi "certi" anche le "parole viaggianti" di cui si possa ipotizzare un tramite semitico. 10. Perché si verifichi l'interferenza devono determinarsi condizioni di vario ordine: 1. l'esistenza del contatto stesso e una certa consistenza delle sue dimensioni diatopiche, diacroniche, diastratiche; 2. la motivazione dell'interferenza (prestigio, necessità di designazioni nuove, moda, ecc.); 3. la volontà o la possibilità da parte dei parlanti di recepirla, 4. la capacità del sistema di incorporarla. Inoltre, prestiti, specialmente quelli non pienamente integrati, rimangono a volte ai margini del sistema e conservano particolari connotazioni. In uno stùdio del 1927, M. Cohen delineava le caratteristiche dei termini veicolati, che appaiono come corpi estranei nel sistema lessicale della lingua di arrivo, per vari motivi, tra i quali meritano menzione: a) l'isolamento nel sistema: in genere non trovano solidarietà in altre formazioni corradicali, se non in
68
rogenei. archeologici, epigrafici, storici, letterari, geografici11 Certo le evidenze extralinguistiche possono prospettare verosimiglianze o mere possibilità, che però, in mancanza di prove linguistiche dirette, non si trasformeranno mai in dati di ricostruzione storica. Purtroppo l'agnizione di semitismi nel latino antico si ferma in molti casi a questa fase indiziaria, ma pur sempre legittima, in attesa che il progresso degli studi e delle cognizioni, nei due ambiti disciplinari, indoeuropeo e semitico, possa fornire più solide certezze. Un più consistente apporto dei semitisti appare in questa prospettiva assai desiderabile. In passato, i glottologi indoeuropeisti hanno manipolato a volte con disinvoltura i materiali semitici, la cui utilizzazione corretta richiede l'impegno e la competenza degli specialisti, anche perché, in presenza di lacune nella documentazione fenicia e punica, si è fatto ricorso sistematicamente a forme ebraiche, ugaritiche, accadiche, e persino arabe, senza inserirle in un convincente contesto linguistico e culturale.
Indubbiamente, per quanto riguarda il latino, molto resta ancora da chiarire sulla provenienza, sulla tipologia, sulla cronologia degli imprestiti più antichi. Ernout 1954, 58 individuava nel latino, oltre ai calchi semantici, diverse categorie d'imprestiti. "popolari", "semicolti", "colti" e "libreschi" Molti di essi si sottraggono ad un preciso ambientamento storico-linguistico. Intanto non sappiamo bene con quali culture e con quali lingue i Latini siano venuti a contatto prima del loro insediamento definitivo nel Lazio, né conosciamo la durata e
qualche derivato seriore; b) la presenza, anche nella stessa lingua, di allotropi fonetici, morfologici e semantici (gabata, gavena), e determinazione mediante suffissi ricorrenti in voci d'imprestito: micrasiat. -ano (Biinàteanu 1969); etr -ital. -ar (calp-ar), c) la confrontabilità con voci di altre lingue, specialmente greche (o etrusche) caratterizzate dal medesimo isolamento e prive di corrispondenze fonetiche e morfologiche regolari, d) le congruenze di ordine storico e geografico tra fatti di cultura e fatti di lingua. 11. È possibile, ad es., che la presenza di "prestiti multipli", distribuiti nel tempo e/o nello spazio, sia condizionata dalla dislocazione dei centri e degli itinerari commerciali, cf. Biiniiteanu 1969, 207; «Les objets adoptés, avec leur "étiquette", soit l'expression qui !es désignait, ne touchent que certains centres, qui servent comme points de départ pour !es pénétrations ultérieures. Je citerai des cas où le meme mot présente dans une seule langue plusieurs significations, ce qui s'expliquerait par des emprunts successifs, à des époques différentes, le terme penetrant une seconde fois dans la langue, mais avec le sens changé, à cause de circostances inconnues et qui restent encore à ètre élucidées». Si consideri poi la difficoltà di applicare alla famiglia semitica il quadro delle affinità dovute a parentela genealogica che è stato elaborato per le lingue indoeuropee: Garbini, 1984, 218: «La parentela semito-camitica non è di tipo genealogico (ormai si può incominciare a dirlo), come non è di tipo genealogico la parentela che lega tra di loro le lingue semitiche»; l'elevato numero di omofoni di molte radici semitiche (Cohen 1970 sgg.) attesterebbe dunque «diffusione limitata ad aree linguistiche parziali» (Garbini, cit. 235).
69
l'intensità di tali contatti. Il latino ha certo recepito interferenze durante i secoli della sua preistoria e protostoria, sia fuori della penisola italiana che dopo l'insediamento nel Lazio. Ma il grande cambiamento si è verificato, come osservava nel 1954 A. Ernout [Ernout 1954, 21], con il passaggio di questi «émigrants» da un genere di vita continentale e settentrionale a una vita meridionale e mediterranea, soprattutto in seguito ai contatti con popolazioni che percorrevano il mare. L'Ernout cita Etruschi, Greci e altri non meglio precisati «peuples de la mer>>, che portavano con le loro navi i prodotti esotici di cui facevano commercio. È opinione diffusa che il latino "preletterario" ( dall'VIII sec. al 241 a.C., fine delle I guerra punica) attraversò il periodo più turbolento della sua evoluzione, la ricostruzione dei suoi processi evolutivi si trasforma in una ricostruzione coerente, che merita il nome di "storia" solo quando viene collocata sullo sfondo degli eventi storici e socio-economici che hanno caratterizzato quella comunità linguistica in quell'epoca, nella quale una società di contadini si è trasformata in una società di mercanti entrando in contatto con altre culture finitime e non. A tal proposito si è parlato molto di Micenei, Greci, Etruschi, Sabini, ma Fenici e Cartaginesi sono rimasti un po' in ombra.
Una ricognizione delle voci latine di possibile ascendenza semitica va inquadrata certo in una concezione processuale del contatto, cioè in una prospettiva di sociolinguistica storica (Prosdocimi 1976), che consenta di ricostruire le condizioni socio-economiche e culturali dell'interferenza. Senza sottovalutare le possibilità euristiche della paleontologia linguistica, che può sempre illuminare sia sostrati linguistici preistorici altrimenti irraggiungibili, sia "itinerari di imprestito" di epoche protostoriche e storiche (cf. Aspesi 1988), è importante una valutazione, in base alle fonti, delle varie situazioni di contatto e delle strategie linguistiche implicite o esplicite adottate nel Mediterraneo antico: politiche linguistiche, uso di interpreti12
, epigrafia bilingue, atteggiamenti e comportamenti dei parlanti, reali situazioni di interazione, ecc. Si sa che, già in età romulea, Roma e le altre città del Lazio erano «sicuramente poliglotte» (sono parole di G Maddoli, 1980, 54), anche se le componenti alloglotte non sembra che potessero esprimersi ufficialmente, come pare doversi dedurre, per i tempi successivi, dalla !ex sacra del Comizio e dagli altri documenti ufficiali. Ancora nel 180 a.C., come sappiamo da Livio 11,42, ai Cumani veniva concesso di parlare latino in publico, ed aipraecones di esercitare il ius vendendi in lingua latina. A Prosdocimi 1976 il merito di aver segnalato la rilevanza sociolinguistica di tale notizia.
12. Cf. W I. Snellman, De interpretibus Romanorum deque linguae Latinae cum aliis nationibus commercio, 1-2, Leipzig 1914, 1919.
70
La rarità di semitismi sicuri in latino esige una spiegazione. La presenza più cospicua di grecismi nella lingua "standard" non contraddice le precedenti considerazioni, se si considera la parentela genetica tra le due lingue, la contiguità delle tradizioni istituzionali e il prestigio del greco in rapporto alla tipologia e alla cronologia di tali imprestiti. I semitismi nel latino arcaico si sono venuti a trovare piuttosto in una condizione analoga a quella degli imprestiti etruschi. «Le parole etrusche accettate dal latino in questi primi secoli della sua storia - scriveva il Devoto nella sua Storia della lingua di Roma (1983, 79)- sono state molte di più (di quelle accertate). Ma nonostante la diversità delle origini, o forse appunto per questo, sono state energicamente assimilate nella forma e, quel che più conta, nello spirito: la tradizione, dell'origine etrusca si perde rapidamente e solo in pochissimi esempi [ ] resiste fino all'età storica». La rarefazione e la scomparsa dei contatti ha potuto agevolare l'assimilazione e la radicale trasformazione dell'imprestito con l'obliterazione della sua provenienza, dapprima nella coscienza dei parlanti, poi nel sapere dei glossografi dei secoli successivi ed infine nell'opinione degli etimologi moderni. Si aggiunga che la profonda e rapida trasformazione che ha investito il latino con la "crisi" del V sec. a.C. (Devoto 1940, XIX sgg.) ha reso incomprensibile il latino arcaico agli stessi Romani dei secoli successivi. Solo "esperti" ( auvELÙrrawt) riuscivano a interpretare a Polibio un'iscrizione del VI secolo. Con queste vicende storiche del latino deve fare i conti la ricerca di semitismi nel latino di età monarchica e della prima età repubblicana.
Una speciale attenzione merita la dimensione diastratica del fenomeno. Sono i linguaggi tecnici e settoriali che veicolano di solito gli imprestiti. Siamo nel campo dei contatti di adstrato, limitati a particolari situazioni di interscambio e a particolari gruppi di parlanti. La direzione dell'interferenza non è determinata tanto da una situazione di diglossia diffusa, quanto da necessità concrete, che promuovono in ambienti sociali più aperti agli scambi l'uso di un codice speciale, di una "lingua del pane" accanto alla "lingua del cuore", per usare una terminologia cara alla sociolinguistica francese. Il fenicio potrebbe aver funzionato come l'inglese o il portoghese dell'epoca del colonialismo, pur senza produrre, forse, fenomeni cospicui di pidginizzazione. La specificità dei contatti inter-etnici configura contesti istituzionali rigidi (principalmente gli scambi commerciali) che, con le loro ritualità, restringono il raggio delle interferenze lessicali, che non sono mai costanti nel tempo e nello spazio, a "campi concettuali" assai precisi. L'interferenza, in queste condizioni, quando non è caduca (ché in tal caso produce imprestiti "effimeri"), presenta consistenti fenomeni di variazione, come attestano frequenti allotropie e allomorfie di sospetti semitismi, oppure la loro radicale ristrutturazione morfologica.
71
È lecito presumere che i forestierismi del lessico commerciale internazionale non siano penetrati che raramente nell'uso comune e ufficiale e quindi non abbiano avuto larga diffusione nei più antichi documenti scritti del latino che noi conosciamo. La nostra conoscenza del latino ,arcaico è certo limitata dalla natura dei documenti a noi pervenuti. E altresì opportuno sottolineare qui la particolare selettività del latino classico, non ancora lingua internazionale, condizionato dalle scelte stilistiche e lessicali degli scrittori. Dobbiamo invece ammettere, in linea di principio, che il latino popolare, specialmente il linguaggio degli scambi commerciali, dovette essere recettivo di forestierismi. La dimensione in cui si manifestano questi fenomeni è sempre l'oralità, il registro colloquiale, mentre la lingua scritta, più attenta alla tradizione normativa grammaticale e ortografica, è refrattaria all'assimilazione di forestierismi, soprattutto se essi, come nel caso dei prestiti fenici, presentano problemi di resa di fonemi estranei alla tradizione ortoepica e ortografica nazionale. Si pensi alla costante repulsione della tradizione grammaticale latina, ancorata alla testualità letteraria, per i cosiddetti "barbarismi"
3. I limiti cronologici dell'indagine sono tendenzialmente contenuti tra l'inizio della colonizzazione fenicia in Occidente (VIII sec. a.C.) e la conquista romana di Cartagine (146 a.C.), ma la scarsità di fonti antiche pone spesso la necessità di fare riferimento a documenti neopunici e a glosse tardolatine di sospetta origine punica. Le più tarde iscrizioni fenicio-puniche provenienti dall'Italia datano al I sec. a. C., ma non va dimenticato che il neopunico sopravvisse nelle colonie d'Italia almeno fino al Ili sec. d.C. e in Africa fino al VI secolo. Restano ovviamente fuori del nostro campo di osservazione le convergenze tra lingue indoeuropee e afroasiatiche che si fanno risalire al sostrato, nel quadro di un'ipotetica comunione "nostratica" o indomediterranea, mentre solo marginalmente è opportuno considerare il problema di eventuali riflessi linguistici della cosiddetta "precolonizzazione", cioè della frequentazione commerciale fenicia degli empori occidentali tra il X e l'VIII secolo13 Tuttavia, nel campo delle somiglianze lessicali tra voci latine e semitiche normalmente attribuite al sostrato, il dubbio che a volte si abbia a che fare piuttosto con interferenze del II millennio tra lingue semitiche di N-0 e lingue i.-e. del Mediterraneo, magari con una mediazione micenea, rimane aperto. Il sospetto è motivato dai risultati della ricerca archeologica, che ha documentato una cospicua componente micenea (e cipriota) accanto a quella fenicia in Sicilia, in Sardegna e nell'Italia centro-meridionale nella seconda metà
13. Cf. Bunnens 1979, 315 sgg., Garbini 1980, 125 sgg., Bondì 1983, 64 sgg.
72
del Il millennio14 In questa prospettiva le ipotesi sui miceneismi nel Lazio (Peruzzi 1980) si ambienterebbero in uno sfondo di traffici interetnici ai quali l'elemento semitico non fu estraneo. G Maddoli, tracciando nel nostro Convegno di Pisa del 1980 un quadro delle frequentazioni precoloniali del Lazio, ebbe a parlare di Micenei, Greci d'Asia, levantini di diversa provenienza, mescolati a Phoinikes» (p. 50) Forse in tale contesto andrebbe collocata l'iscrizione di S. Susanna, presso Rieti, se essa è fenicia e databile al XIII secolo, come ha supposto Garbini 1985a. In qualche caso potrebbe rivelarsi troppo semplicistico, se non del tutto arbitrario, etichettare certe voci latine come "voci di sostrato" o "semitismi veicolati dal greco", sottovalutando i possibili effetti linguistici di una presenza fenicia nel Mediterraneo occidentale durata, con alterne vicende, per ben mille anni.
4. È impresa davvero ardua, ma imposta da esigenze teoriche e metodologiche, distinguere tra "congruenze" attribuibili ai sostrati (relitti e "mots bouchons", che possono avere riflessi indipendenti in lingue indoeuropee e in lingue semitiche) e "imprestiti", cioè interferenze unidirezionali, tra i quali non sempre è facile discernere i semitismi diretti da quelli indiretti (di trafila greca o greco-etrusca). Certo non si può escludere che isoglosse tra lingue semitiche e latino siano da ricondurre a quella realtà di mescolanza e di osmosi culturale, cui si dà il nome di indomediterraneo, che ha preceduto l'avvento di Semiti e Indoeuropei e i loro reciproci contatti (Pisani 1938, Belardi 1954; 1955, Silvestri 1974, 1982), oppure ad una fase successiva in cui si sarebbero create più strette convergenze tipologiche tra indoeuropeo e semitico, rilevate dal Meillet e più recentemente da Belardi e Ramat15 Forse a questo stadio il Garbini colloca l'epoca in cui il semitico sarebbe «matrice di forme indoeuropee», postulando cioè un filone semitico nell'indoeuropeo e nel sostrato prelatino (Garbini 1988, 78 sg.) Il problema è complicato dalla pratica impossibilità di distinguere strati pre-semitici e protosemitici nel vicino Oriente, in considerazione della forte capacità delle lingue semitiche di assimilare elementi eteroglottici (Belardi 1954, 633; Fronzaroli 1977, 43, Silvestri 1982, 148) Per una distinzione tra imprestiti e voci di sostrato è indicativa, a volte, l'arealità delle isoglosse: una voce di improbabile etimo indoeuropeo, attestata in un'area mediterranea vasta (greco, latino, Asia Minore, Vicino Oriente, ecc.) potrebbe essere relitto di un
14. Cf. Bandì 1983, 67; A. Di Vita, Libia: l'espansione fenicia nel Mediterraneo, Roma 1971, 82 sgg.; L. Vagnetti, I Micenei in Italia, «PP» 25, 1970, 359 sgg., Maddoli 1980' 43-64. 15. Cf. P Ramat, Macroaree tipologiche?, «AION» 10, 1988, 89.
73
antichissimo termine di sostrato (Silvestri 1982, 183), se invece può vantare connessioni indoeuropee, si può pensare al frutto di una "fusione" con un termine di sostrato (come nel caso della coppia lat. imber accad. imbaru, cf. Mayer 1964, 223) In questo quadro vanno certo collocati molti fitonimi.
Ma gli stessi Fenici possono essere stati, in epoche protostoriche, veicolo di termini eteroglottici. greci, microasiatici, di sostrato. Possono sopravvivere nel latino fatti protostorici (della "precolonizzazione") diffuse o veicolate dai Fenici, fra cui miceneismi o voci del fondo egeo-microasiatico16 Una lingua 'internazionale' del II millennio sarebbe stata diffusa dai Micenei, con interferenze anche in area semitica17 In altri termini, anche se non si può escludere che nomi di oggetti commerciabili e di recipienti risalgano all'epoca neolitica (Silvestri 1974, 199), è anche possibile che voci di sostrato, "parole viaggianti" designanti oggetti di vasto commercio, siano state diffuse proprio dai Fenici unitamente agli oggetti stessi, e che quindi il feniciopunico sia la "fonte immediata" dell'imprestito. Potrebbe essere il caso di lat. fucus 18
Viceversa, talune congruenze lessicali di sostrato, se presenti anche in lingue semitiche, possono essere erroneamente confuse con i fenicismi penetrati direttamente nel latino e/o nel greco nel corso del I millennio19
16. N. Maccarrone ipotizzava (1938-1939) che l'espansione sumero-accadica possa aver trasmesso voci semitiche poi passate al greco e al latino. Altri termini che passano per semitismi greci possono essere anche voci diffuse originariamente in area microasiatica. così cadus I xaùoç per Neumann 1961, 175 ss., Cf. Pisani 1966, 43. 17 C. H. Gordon, Homer, Capthor and Canaan, «Anadolu Arastirmalari» 1, 1955, 139 ss., Homer and Bible. The Origin and Character of East Mediterranean Literature, «Hebrew Union College Annua!» 26, 1955, 43-108; Fronzaroli 1959, 71. Ad es., lflium sembrerebbe voce del sostrato egeo (gr ÀELQLov), con connessioni africane (DELG 629; Masson 1967, 59. M. Cohen, «BSL» 50, 1, 1954, 43). 18. fùcus, -i, m. 'fuco, sp. di lichene che s'attacca alle rocce del mare e serve a tingere in rosso: belletto (Lichen Roccella L. )'è termine di antica attestazione (Plauto, Terenzio). All'ipotesi di un prestito da gr cplixoç (n.) 'alga, lichene' (Omero) pone difficoltà la corrispondenza lat. f = gr cp in un prestito antico (cf. purpura), per cui s'invoca la consueta mediazione etrusca (Ernout 1954, 51). Considerazioni extralinguistiche potrebbero suggerire l'ipotesi di un fenicismo: «Peut-ètre !es deux mots [fucus e cplixoç] ont-ils été empruntés séparément à la mème langue - on admet généralement que le grec provient du sémitique, hébreu puk-, et apportés par !es marins qui faisaient commerce du fard ( car le nom du produit a du précéder celui de la piante camme ebur a précédé elephantus)» (Ernout, Zoe. cit. ). L'ipotesi semitica (Lewy 1895, 47-8, cf. ebr puk 'belletto per gli occhi') è scartata da Chantraine (DELG 1231). Il vero tramite di questo fitonimo mediterraneo in latino e in greco può essere stata la lingua franca dei commerci, cf. DELL 258. Leumann-Hofmann-Szantyr I 162 accenna ad una «beidseitige Entlehnung aus einer Mittelmeersprache». 19. Ad esempio, Plinio (7, 208) attribuiva espressamente ai Fenici lat. cum ba 'bar-
74
Occorre distinguere tra fenomeni di trasmissione e fenomeni di propagazione di fatti linguistici. In definitiva, non sembra che finora sia stato applicato al fenicio e al punico il noto concetto di "intermediazione" linguistica, usato, e spesso abusato, a proposito dei cosiddetti etruschismi e grecismi in latino. In ogni caso la distinzione tra fenicismi "diretti" e "indiretti" appare inadeguata. Le etichette "grecismi" ed "etruschismi" appaiono effettivamente alquanto rigide.
4.1 Una quota cospicua di semitismi nel latino è classificata generalmente tra gli impresti ti dal greco20
, quando ~uesto può vantare una più antica attestazione dell'imprestito semitico 1 È significativo che lo stesso nome latino dei Cartaginesi sia di origine greca22 Ma nel caso
ca' (omofono di cumba 'lectica' attribuito da Pesto 56,33 ai Sabini): "cumbam Phoenices (invenerunt)" Si tratta certo di termine tecnico nautico, come spiega Isid. Orig. 19, I, 25: 'lembus nauicula breuis, qui alia appellatione dicitur et cumba et caupulus'; 'locus imus nauis, quod aquis incumbat' (ibid. Il, 1). Esso è probabilmente connesso con lat. e ii p a, 'navis piscatoria' (Nonio 535, 26), che designa anche un recipiente per liquidi fatto di doghe lignee ('botte, tino e sim.'), e sembra solo omofono di ciipa 'manovella' (vedi avanti). Ora, varie forme semitiche antiche, riconducibili alla radice q-b-', designano recipienti per liquidi: cf. fen. qb', ugar qb't 'bacile' e kp 'coppa', ebr qubba'at 'coppa', ace. qabutu, ecc. (cf. lat. gabata), ma non mi risulta che nel semitico sia presente la specializzazione semantica nautica. Anche se si tratta di un termine da collocare certamente in una vasta serie lessicale indomediterranea per 'cavità'· gr xun:T) (e xuµ!)T)· "tQWYÀTJ Hes.), etr cupe, sanscr kupal} 'cavità' e kumbhd- 'vaso', ecc. (Lombardo 1957; Cardona 1968; Silvestri 1974), ciò non esclude a priori che le forme latina ed etrusca siano imprestiti, più che relitti: la specializzazione semantica "nautica" della variante cumba e la sua forma fonetica (infisso nasale e labiale sonora) si spiegherebbero bene in ambiente fenicio. 20. Nei commerci greci svoltisi nella valle del Tevere durante il secolo VIII «è presente anche una componente di origine orientale forse fenicia, ma più probabilmente mediata da Greci» (Colonna 1974, 307). 21. La già nota tipologia delle categorie semantiche interessate ai più antichi prestiti semitici in greco (zoonimi, fitonimi, termini tecnici, della navigazione, nomi di vasi, ecc.) denuncia per Mayer 1960, 335, «rapporti esclusivamente limitati alla sfera commerciale. Il linguaggio della navigazione annovera in latino quattro o cinque termini indoeuropei che attestano una tecnica assai primitiva. Giunti sulle rive del Mediterraneo, i Latini hanno preso in prestito molte voci relative all'arte della navigazione e alla prassi dei commerci marittimi da gente di mare più esperta, principalmente dai Greci»; cf. O. Castellani Pollidori, I più antichi grecismi nautici in latino, «Atti e Memorie dell'Accademia Toscana «La Colombaria» 22, 1957, 183-264; Ernout 1954, 45 sgg. 22. Poenus 'Cartaginese' è retroformazione da *Poenicus, aplol. < *Poin(fc)-icos < gr <I>otvtx-tx6ç (Leumann- Hofmann-Szantyr I 235). Gr cpoi:vt!; 'porpora, dattero', e 'fenicio' non è voce semitica, ma di tramite egeo (G Bonfante, The Name of the Phoenicians, «Classica! Philology» 36, 1941, 1 ss. Sterling Dow, Corinthiaca. I. The Month Phoinikaios, «American Journal of Archaeology» 46, 1942, 69 ss.); cf. le forme micenee po-ni-ke str sing. di cpoi:vt!; 'fenice', po-ni-ki-ja '(carri) dipinti di rosso', po-ni-ki-jo 'n. di erba o spezia' Il latino ha dovuto recepire il grecismo puniceus <
75
dei realia del commercio è possibile che la vera fonte sia ancora una volta la lingua franca, e che quindi non abbia molto senso parlare di grecismi tout court. Specialmente quando il termine latino trova corrispondenza nel punico, il ricorso al "deus ex machina" del greco appare ingiustificato, a meno che non si tratti di nomi di recipienti di fattura greca o di oggetti di provenienza orientale, come certe piante, erbe aromatiche e spezie. cas(s)ia, cinnamum, crocus, cuminum, murra, nardus, sesamum, ecc., che si presumono portate, assieme al vocabolo che le designava, dal vicino Oriente su navi greche (in realtà sappiamo che a tali traffici partecipavano anche navi fenicie e fenicio-cipriote) A ragione Garbini 1988, 70, giudica estremamente riduttiva e arbitraria la limitazione dei contatti antichi tra lingue semitiche e indoeuropee mediterranee agli imprestiti in greco: «perché solo in greco e non anche in latino? In fondo i rapporti tra Roma e Cartagine, e prima ancora tra Cartagine e gli Etruschi, potevano favorire [ ] dei prestiti diretti, garantiti da una solida base storica». Garbini ha segnalato alcune suggestive "convergenze" tra semitico, greco e latino, oppure tra semitico e latino, che restano però a volte sospese tra la prospettiva della comunione di sostrato e quella dell'imprestito, come nel caso di due termini di area rurale: cupa 'manovella'23 e capo 'cappone'24
Per la loro natura, le condizioni speciali della loro circolazione e lo status dei loro utenti, le parole viaggianti possono presentare una accentuata polimorfia e polisemia, con inevitabili ripercussioni nella documentazione letteraria latina in cui sono state fissate, per lo più come glosse o barbarismi. Il più alto tasso di semitizzazione del greco e le lacune della documentazione fenicia hanno indotto gli studiosi a classificare senz'altro come grecismi quei semitismi che si trovano anche in greco. Queste considerazioni valgono soprattutto per quella serie di semitismi di presunto tramite greco che presentano difficoltà di ordine
<pOLVLXEtoç in epoca arcaica, come si desume dalla conservazione del dittongo in Poeni e dal trattamento di cp. La forma latina attesterebbe una trafila popolare (DELL 518). 23. Lat. cii p a, a e 'manovella della macina' nel frantoio delle olive (Cato Agr 12 e 21) è stato spiegato con gr xcintri 'impugnatura, manico, remo', ma anche 'manovella della macina' (da Omero in poi), con a etrusco o italico (Ernout 1928, 148; 1954, 66). Garbini 1988, 75 confronta il siriaco qupii 'stanga, leva' e l'aramaico giudaico qopii lasciando però incerta la collocazione storico-culturale e cronologica di tali convergenze: troppo poco sappiamo della semantica e quindi dell'etimo di aram. d'Imp. qp e fen. qp' (DISO 261). 24. Le forme lat. ciipo e capus 'cappone', di etimo incerto (DELL 98), si inquadrano, con cabus 'cavallo castrato', caballus ed altre forme, in un contesto di congruenze pre-indoeuropee mediterranee (Silvestri 1974, 173 sg.) più agevolmente che nel quadro delle forme arabe citate dal Garbini (1988, 75), poco convincenti per motivi storici e semantici.
76
fonetico o semantico o culturale. Una nutrita serie di coppie lessicali latine e greche (come avvertiva Pisani 1962) possono attestare due vie d'imprestito indipendenti25
Per i fitonimi non è indicativa l'epoca dell'introduzione della relativa pianta in Italia, a volte esattamente databile (come per il ciliegio coltivato) In genere, i fitonimi di origine orientale designano tanto la pianta quanto il frutto o il prodotto, essendo tali voci quasi sempre di attestazione alquanto tarda, si preferisce considerarli mediati dal greco (Emout 1954, 39) Ma è anche vero che autori latini tendono a citarli nella forma greca per vezzo letterario o per formazione libresca26
, e che certi prodotti (frutti, aromi, condimenti) sono stati conosciuti per via commerciale prima dell'introduzione della pianta stessa. Rimane pertanto aperta la possibilità di un imprestito diretto27
, specialmente nei casi di divergenze formali o semantiche
25. Ad es., lat. suppiirus nelle più antiche attestazioni in autori di commedie e atellane (Plauto, Epid. 232, Afranio, Novio, Varrone) designa una veste di lino, e così è inteso da Varr L.L. 5, 131, e da Pesto 406, 8 L. 'vestimentum puellare linteum, quod et subucula, i. e. camisia, dicitur'; cf. Non. 540, 8. Lucano 2, 364 ha il neutro suppiirum. Proprio in Lucano (I sec. d.C.) appare per la prima volta il termine nell'accezione di 'vela di parrocchetto', tecnicismo della marineria (5, 427). Nello stesso tempo appaiono nelle fonti latine le forme con l nella prima sillaba. slparum (Sen. ep. 77,1, Stazio, Silv. 3, 2, 27); slpharum è in un fr di Frontone, retore del II sec. originario della Numidia (p. 38 Haines) e in Tertull. apol. 16. 8; de pali. 4, dove vale anche 'vessillo'; cf. Isidoro Etym. 19, 3, 4 (slparum). Pressapoco contemporaneo è il derivato slparium 'tela' (termine di teatro) e 'cortina per difendere dai raggi del sole il tribunale del pretore' (Quint. 6, 1, 32; 6, 3, 72). Cf. A. E. Housmann, Siparium and supparus, «Classica! Quarterly» 13, 1919, 149-152. La tarda attestazione delle forme greche abtaQoç, 'velo, cortina di teatro', che non compaiono prima del II sec. d.C. (Arriano, Epict. diss. 3,2,18), il vocalismo interno delle voci latine e altri indizi, come la geminazione della labiale, hanno indotto a dubitare dell'imprestito greco (DELL 668). Valorizzando un'osservazione di Varrone (5, 131. supra a quo supparus, nisi id quod item dicunt Osce), Ernout 1928, 234 postulava una mediazione osca del grecismo. Mancini 1990, 74-82, accetta l'ipotesi dell'oschismo: supparus si sarebbe formato in ambiente italico da un possibile *paros 'veste di lino', antico grecismo (cf. mie. pa-we-a e om. cpàQoç) determinato con il prefisso sub-; il gr abtaQoç, a(cpaQoç sarebbe invece un relitto mediterraneo, una parola viaggiante caratterizzata da «una semantica oscillante tra designazione iperonimica e designazione specialistica» (p. 79). Nel IV secolo l'osco *supparo- sarebbe passato in latino. La duplice accezione del termine, quella tecnica della navigazione e quella generica di tessuto e indumento, si spiegherebbero bene postulando un comune etimo semitico, se ha ragione Hommel in LEW, che pensa ad ass. suparraru 'stendere' In tal caso la voce semitica sarebbe passata indipendentemente al greco e all'italico, e da qui latino dopo l'esaurimento dei processi di indebolimento del vocalismo breve interno (inizi del III sec. a.C.). 26. Non desta perciò meraviglia l'osservazione di Plinio dell'esistenza di molti fiori «privi di nome» (sine nominibus), per cui bisogna indicarli con i termini greci «quia nostris maiore ex parte huius nomenclaturae defuit cura» (n.h. 21. 49.52). Cf. Plin. N.H. 5, 1, che definisce «ineffabilia» alcuni nomi di popoli e di città della Libia. 27 Lat. canna ae 'canna' e 'vaso' è riportato comunemente a gr xavva 'id.' a sua
77
con la forma greca corrispondente. In questi casi è particolarmente arduo ricostruire le vie e i tempi dell'interferenza28
A questa categoria di semitismi in greco e latino si deve applicare la stessa considerazione che Ernout 1954, 41 ritiene valida per molte coppie di voci (liliumlÀELQLOV; malualµa"A.6.xri, rosa!f}oùov, ecc.) comunemente ascritte al sostrato: «Ces noms sont trop proches de leur correspondants grecs pour qu'on puisse les en séparer, trop éloignés aussi pour qu'on puisse les considérer comme empruntés directement du grec».
4.2. Analogo discorso va fatto per i semitismi considerati di tramite etrusco29 Gli stessi Semiti che frequentavano i porti etruschi di Gravisca, di Pyrgi, di Punicum, approdavano e commerciavano negli altri empori del Lazio, Roma compresa. La triangolazione CartagineRoma-Caere come percorso di mercanti punici è confermata dalle iscrizioni etrusche provenienti da Cartagine, e specialmente dalla tessera del VI sec. contenente la sequenza mi puinel kar{}azie; essa, redatta forse a Roma (H. Rix), potrebbe essere il documento di un "Poenus", se invece in puinel è da vedere la forma etrusca di latino Poenulus, si pone un problema del valore di tale ipocoristico, che ri-
volta di origine semitica. assiro-bah. qanu, ebr qane(IJ) [DELL 93]; attestato da Varrone Atac. in poi, ma il derivato cantilis è già in Plauto e Catone. Ernout 1954, 30 non esclude che si tratti di «mot voyageur» (cf. Cohen 1938, 181). Ma l'attestazione punica qn' (DISO 259) rende meno cogente il ricorso alla mediazione greca e possibile una linea di prestito indipendente. 28. È il caso di g a 1 ba n u m (n.) e -us (m.) 'galbano, gomma prodotta da una pianta ombrellifera della Siria' (Plin. Suet. ), che corrisponde a gr xaÀ()avri (Theophr hist. plant. 9, 9, 2); ma si noti che il greco risponde normalmente al sem. /J con l'aspirata. Per sostenere la tesi del grecismo occorre postulare (con DELL) l'influenza di galbus sulla fonetica della voce latina, e resta comunque inspiegata la divergenza morfologica (André 1956145; Masson 1967, 60; E. D. Francis, «Giotta» 53, 1957, 62). Inoltre il vocalismo interno e l'età della documentazione ci orienterebbero per un imprestito posteriore agli inizi del III sec. a.C. (esaurimento dei fenomeni di indebolimento delle vocali brevi interne), a meno di non postulare un precedente • galbtinum. Ora il nome del prodotto e della pianta è chiaramente di origine sem. occidentale (DELG 1212), cf. ebr , !Jelbantih e presuppone un aram. !Jalbtin- (LEW I 578). 29. È obiettivamente difficile riconoscere fenicismi diretti in etrusco. Priva di fondamento sembra l'ipotesi di Devleeschouwer 1969: etr. avi/ «pourrait provenir d'un très ancien emprunt au sémitique, et plus précisément au phénicien, qui a été, avant le grec, la langue commerciale des cotes et iles méditerranéennes» (p. 533), oppure da qualche altra lingua della medesima matrice. Ma le evidenze semitiche si limitano a una forma araba, senza rispondenze persuasive nelle lingue di N-0. Inoltre l'autore si muove nel quadro dell'indimostrabile ipotesi genealogica del M(llller- i.- e ·~el- < * e~el- 'tourner, rouler' e sem. IJ-~-1- 'id.' riposerebbero su un pre-indoeuropeosemitico *ha~al- 'tour, roulement, cycle (de saisons)'
78
corre anche nella commedia plautina, e che opportunamente E. Paratore traduce 'il Cartaginesuzzo'
Il toponimo Agylla, "AyvÀÀa, antico come di Caere (Strab. 5,2,3), potrebbe essere fenicio: 'iigullii 'la Rotonda', femm. di 'iigol 'rund', dalla radice 'g/ 'essere rotondo'30 La connessione etimologica è da mettere in rapporto con gli esiti lasciati dal derivato con preformante in nasale ma'ggiil 'cinta di accampamento militare, cerchio di carri, ecc.' in toponimi nordafricani (Miigiiria, in Plauto) e in punicismi come miigiilia 'capanne berbere rotonde' (vedi avanti)31
L'accertata partecipazione di correnti aramaiche ai commerci dell'orientalizzante rendono possibile il confronto tra aramaico talitii 'ragazza' ('taÀL'fra Mc. 5,41) e etr tali{}a che figura inciso sullo specchio vulcente ES. IV 2, 413 (prima metà del IV sec. a. C.) accanto ad una figura femminile nell'atto di carezzare un giovane nudo (cruisie) il quale le offre un fiore32
A volte si parla di semitismi "di tramite greco-etrusco", ma sarebbe più corretto definirli "di epoca etrusca"
na blium 'sp. di arpa'33 è certo confrontabile con etr naplan (coppa di Avle Vipinas, TLE 942, raffigurante satiro con otre sulle spalle), che risale al V sec. a.C., grecismo per K. Olzscha, C. De Simone, G Colonna34
, ma probabile prestito diretto dal punico secondo Heurgon e Masson35
; per il significato e la cronologia le voci etrusca e latina vengono considerate derivate da gr
30. «Rotonda» si presentava Caere a chi la osservava dal lido, come notava Th. Mommsen, Storia di Roma, ed. it. Milano 1966, I, 160; cf. Schroder 1869, 135; H. Lewy, «KZ» 59, 1932, 188 sgg. 31. Forse di queste possibili connessioni etimologiche converrebbe tenere conto, in sede di storia, nel valutare la tradizione recepita da Strabone 5, 2, 3, che attribuisce ai Pelasgi la fondazione di Agylla, e quella di Solino che attribuisce agli stessi Pelasgi l'introduzione dell'alfabeto nel Lazio: «Agyllam a Pelasgis qui primi in Latium litteras intulerunt» (2, 7 ed. Mommsen); cf. M. Cristofani, L'introduzione e la diffusione dell'alfabeto etrusco, in Aufstieg und Niedergang der romischen Welt, I, 2, Berlin -New York 1972, 466 sgg. 32. Per A. J Pfiffig, Die etruskische Sprache, Graz 1969, 174, etr tali{}a ricalcherebbe il gr taÀtùa, ace. di taÀtç,-tùoç 'Madchen, Braut'; cf. G Colonna, «Studi Etruschi» 43, 1975, 215 sg., G e L. Bonfante, Lingua e cultura degli Etruschi, Roma 1985, 180. Vedi ora A. J Pfiffig, Zu tali\ta auf einem etruskischen Bronzenspiegel des 5. Jahrhunderts, «Mediterranean language Review» 4-5, 1989, 43-46. 33. Ov art. am. 3,237; nablum 'lira con 10-12 corde' è di attestazione più recente (Vulg.). 34. K. Olzscha, «Glotta» 48, 1970, 285; C. De Simone in Aufstieg und Niedergang der romischen Welt, I, 2, Berlin-New York 1972, 504, n. 6; G Colonna, Nomi etruschi di vasi, «Archeologia classica», XXV-XXVI, 1973-74, 132-150. 35. J Heurgon in Mélanges J Carcopino, Paris 1966, 515-522; Masson 1967, 69, n. 3; cf. DELG 732.
79
va(3À.a(ç) 'anfora' e 'arpa', a sua volta fenicismo certo: l'oggetto è di orig. "sidonia" (i:oii LLÒwv(ov va(3Àa) secondo Sopatro, poeta comico greco attivo in Alessandria (IV-III sec. a.C.), cf. Athen. IV 175 b, c, d. va(3À.aç «EUQf]µa cf>mv(xwv». Al semitico si attribuisce la radice nbl con i due significati di 'anfora' e secondariamente 'strumento musicale a forma di anfora' in base a ebr nébel 'arpa' e a punico nbl 'vaso, otre, giara' (DISO 173).
4.3 Nencioni 1939 individuava tre grandi aree di provenienza delle «innovazioni africane nel lessico latino» l'egiziana, la punica e la libico-berbera. Un nutrito manipolo di voci latine senza etimologia indoeuropea certa è comunemente riportato all'antico egiziano, se tali voci trovano rispondezza in voci egiziane o copte. Certo si può trattare di impresti ti relativamente tardi, veicolati dal greco, come baris, attestato da Properzio 3,11,44 (donde il più tardo barca)< gr j)agLç 'imbarcazione egiziana' (Herod. 2,96), a sua volta da egiz. br, copto bari; oppure importati in età imperiale (cuci, sari, cici, cummi, ecc; cf. Nencioni 1939, 23 sgg.) Ma non è da escludere che qualche termine, specialmente se risulta presente in semitico, possa essere stato diffuso nel Mediterraneo dai Fenici che, frequentando gli empori egiziani, potrebbero averlo recepito e quindi trasmesso, in tempi più recenti, anche al punico. In tali casi è indicativa la cronologia e la qualità delle attestazioni. Ad esempio, di e bur, oris, s.n. 'avorio' (da Plauto in poi) sappiamo che è un imprestito come ÈÀ.-Écpaç, e che è stato adattato nella flessione di robur (Ernout 1954, 18) Per DELL 190 «La forme plus proche qu'on connaisse est égyptien iib, iibu, copte Ej)ou, Ej)u On ne connait ni l'origine du mot ni la voie par où il est passé en latin». Una mediazione fenicio-punica immaginano Walde e Hofmann (LEW I 389) e Nencioni 1939, 13. Possibile sopravvivenza di un'antica isoglossa indomediterranea per Pisani e Silvestri 1974, 117
Il punico potrebbe essere stato anche intermediario di imprestiti antichi da altre lingue africane. Alcuni vocaboli latini che hanno congruenze nei dialetti berberi sono considerati probabili «accatti africani», vale a dire punici36 Tra questi, lat. sirpe (PI. Rud. 630), pianta ombrellifera (thuya) originaria della Cirenaica, il cui succo era utilizzato come condimento, è inseparabile dal gr o(À.cpwv (oÉÀ.nov Hes.), e presuppone la solita trafila etrusca. Da sirpe derivano *lac-sirpicium > lasserpicium (Plauto, Pseud. 816; Cato agr 116; Plin. N.H 19, 38, Petr Sat. 35) e la forma abbreviata laser (Ernout 1928, 190) Anche se il termine greco è documentato in fase più antica (Solone, Erodoto) e il condimento era molto usato nella cucina greca (Theophr hist. plant.
36. Cf. Gerola 1942, 365 sg., H. Schuchardt, Die romanischen Lehnworter im Berberischen, «Sitzungsberichte Wien» 188, 4, 1918, 77
80
6,3,1), non possiamo escludere, trattandosi di mercanzia africana, anche un imprestito punico diretto (Nencioni 1939, 31-32) Dunque berbero aselbu, azlaf, ecc. 'juncus maritimus' potrebbe essere la forma antica del fitonimo (mediterraneo o semitico), mentre waserkenni 'fogliame di thuya' andrebbe classificato tra gli imprestiti latini37
5 Qualsiasi agnizione di semitismi diretti in latino è ostacolata dalla carenza delle fonti fenicio-puniche e dalla mancata attestazione di semitismi nel periodo preletterario del latino. Si aggiunga il fatto dell'unidirezionalità delle interferenze, per la nostra incapacità di individuare antichi latinismi e grecismi commerciali nelle lingue semitiche. Eppure per spessore cronologico e densità geografica, per intensità di penetrazione e per gli aspetti qualitativi e quantitativi, la presenza fenicia e punica in Italia pone il problema dei motivi della esiguità dei riflessi linguistici. Tale presenza è ampiamente documentata anzitutto da evidenze storiografiche. Del ruolo primario della <I>mv(xwv vmmÀ.(a (Strab. I, 3, 2, C. 48) nella storia del Mediterraneo antico è consapevole la tradizione storiografica antica38
, che la critica moderna tende generalmente a rivalutare. Mentre poco possiamo dire dei riflessi linguistici della cosiddetta "precolonizzazione" che, tra gli ultimi secoli del II millennio e gli inizi del millennio successivo, vide il Mediterraneo occidentale percorso da Micenei e Fenici, una situazione ben diversa si profila per la fase dell'espansione coloniale. L'espansione fenicia nel Mediterraneo comincia tra il IX e l'VIII sec. con la fondazione delle colonie africane di Cartagine (814 a.C.), Utica, Leptis Magna, Ippona, Adrumeto, ecc. Sandro Filippo Bondì poteva scrivere nel 1975 che la componente fenicia riemerge nella storiografia più recente in piena autonomia come una delle grandi discriminanti della storia del I millennio a.C., accanto a quella greca e romana.
È ormai difficile condividere una radicata opinione che Nencioni 1939 riassumeva così. « gli scambi punico-latini trovarono un grave ostacolo nel fatto che Roma e Cartagine furono sempre, nella lingua e nelle istituzioni, oltre che nei rapporti politici, due mondi estranei e ostili». In realtà questo non è vero almeno fino al III saecolo a. C., quando si delinea il conflitto politico e il latino si avvia ad assumere un ruolo egemone nel quadro linguistico del Mediterraneo. A difficoltà linguistiche dei mercanti che percorrevano il Mediterraneo antico allude l'osservazione di Sallustio nel Bellum Iugurtinum. «Mare ma-
37 Ch. H. Schuchardt, cit., 16. Invece Gerola 1942, 355, accomunava il termine berbero alle voci del sostrato in base al suffisso -en(n)-. 38. Thuc. VI, 2, 6; Diod. V, 12, 3; 35, 5; Mela Il, 123; Paus. X 17, 2, 9; Sii. XII 359-60; Isid. Etym. XIV 6, 39; ecc.
81
gnum et ignara lingua commercio prohibebant» (18,7). Ma è noto che il contatto prolungato tra mercanti eteroglotti tende a sviluppare una "lingua franca" degli scambi commerciali, è perciò legittimo postulare l'esistenza di una qualche forma di "Verkehrssprache" mediterranea antica che, se pure non è giunta verosimilmente a creare forme di pidgin, avrà quanto meno utilizzato un lessico tecnico composito. Più che di "imprestiti", occorre parlare a volte di voci tecniche d'uso internazionale ("parole viaggianti"), non integrate o solo parzialmente integrate nelle singole lingue. Solo in casi particolari i neologismi entrano nel sistema standard, spesso per tramite letterario o per estensione ad altri registri d'uso, quello colloquiale (ave) o quello giuridico (arrabo e arbiter), su cui vedi infra.
Alla lingua franca risale certo la più antica parola latina di origine semitica, tunfca, che Pisani 1962, 161 attribuiva al "protolatino"
tUnica 'tunica' (PI. Trin. 1134) nome di capo di vestiario, per Ernout e Meillet è «emprunté au meme mot qui a fourni gr XL'twv; terme de commerce, du sans doute aux Phéniciens, cf. hébr bthoneth. Mais on ne peut dire si le mot a été emprunté directement ou s'il y a eu quelque intermédiaire ( étrusque?)» (DELL 707). Szemerényi 1968, 195 pone un fen. kit(t)on < kit(t)iin, passato già nel mie. kito, cf. ug. ktn, ace. kitu (Fronzaroli 1959, 67). Per Ernout 1954, 67 la corrispondenza u: w farebbe pensare a una mediazione etrusca. Mancini 1992, 46: «Rispetto a un fenicio ktn il latino ha recepito una variante che ha subito una metatesi, fatto che, a mio avviso, si spiega qualora si consideri anche tunica un termine trasmesso al latino attraverso il canale di un pidgin commerciale con il fenicio come lingua lessicalizzatrice: una deformazione di lessemi per metatesi può rientrare nella tipologia delle lingue di contatto». Non possiamo escludere tuttavia l'ipotesi della sostantivizzazione di una forma aggettivale *k(i)tun-ica (cf. byssica, byssina vestis) con sincope della pretonica e semplificazione del nesso iniziale (cf. laena I gr xì...a'iva), in fen. ktn sembra designare tanto il 'lino' quanto la 'veste di lino' Sulla semplificazione di et- cf. Leumann-Hofmann-Szantyr, I, § 190 a) Il suffisso -ica determina un altro imprestito: barca < *bar-ica39 Avremmo in tal caso un altro esempio di ambientamento morfologicio di un imprestito che esige una via di penetrazione indipendente da quelle di mie. ki-to e di gr XL TWV, per cui Mayer 1960, 318 pensava a una mediazione "mediterranea" Considerata la presenza fenicia in Italia nel corso della prima metà del I millennio a.C. ed oltre, non è necessario postulare un imprestito fenicio per il greco, e punico per il latino con l'usuale mediazione etrusca, come pensava Nencioni, 1939, 42.
Un punicismo antico sicuramente indipendente dal greco è Carthagò 'Cartagine' < *qrt-IJ,dst 'città nuova', anche in un'iscr da Olbia del III sec. a.
39. Cf. P Katz, Tunica, barca, «IF» 57, 1940, 264.
82
C.40• fen. pun., ug., ebr qrt 'città' (DELL 102) La forma ionica
Kagxriùwv4 , interessata dall'anafonesi di *ii, deve essere anteriore all'epoca
alfabetica (non più tarda dell'VIII sec. a.C.)42, e presenta altro tipo di "com
binierte Dis- und Assimilation" (Leumann-Hofmann-Szantyr I, 232) e differente suffissazione che potrebbero indiziare una diversa via d'imprestito. Anche a non voler accettare l'ipotesi di Neiman 1966, che pensa per il nome greco di Cartagine a un fen. * Kark-Hadas ( cf. la forma aramaica krk 'fortezza', < * kark- 'città' probabile voce di sostrato presemitico, attestata nel top. Karkemis sul medio Eufrate; bibl. in Aspesi 1988, 166), la suffissazione latina mediante un morfema (-iigo, -iiginis) ricorrente in fitonimi, denuncia un comportamento autonomo ed è un tipico esempio di quel fenomeno di interferenza morfologica che R. Gusmani chiama «induzione di morfemi». Forse dovremmo credere all'etimologia di Isidoro (15, 1, 30), che pensa ad un primo adattamento del toponimo semitico nella forma Carthada (attribuita a Catone da Solino, 27, 10) «quod Phoenica lingua exprimit civitatem novam», successivamente («mox») mutata, «sermone verso», in Carthago, il che denuncerebbe una fase di assestamento dell'imprestito. Un diverso adattamento della voce punica è l'etr karltazie, che corrisponderebbe in latino a un *Carthadius, su tavoletta d'avorio proveniente da Cartagine43 Sulla forma -adadel secondo elemento del composto, cf. Macom-adas, in Sardegna (Schroder 1869, 85).
Il lessico della navigazione, dei realia e della prassi del commercio costituisce uno di quei campi semantici ai quali si può applicare la nozione di «emprunt nécessaire»44
, che ricorre quando in un ambiente linguistico si introduce una "cosa" nuova assieme al suo nome. Per il fenicio-punico c'è naturalmente da aspettarsi che interferenze lessicali di ambiente mercantile risalgano soprattutto al periodo dell'Orientalizzante e interessino aree specifiche della penisola italiana. Etruria, Lazio, Campania, Italia meridionale, Sicilia, Sardegna. Tra i termini del lessico commerciale vanno annoverati quelli designanti beni di scambio: minerali45 , monete, pesi, vasi e recipienti in genere. È noto
40. Cf. G Chiera, Qarthadasht = Tharros?, «Rivista di Studi Fenici» 10, 1982, 197-202. 41. J Friedrich, KaQX'l'JÒWV und Carthag6, in «IF» 39, 1921, 102-104; «Revue des Études Indo-Européennes» 3, 1943, 20-29. 42. Il tipo onomastico poteva essere giunto a conoscenza dei Greci anche prima della fondazione di Cartagine. Si noti che,una Qrt!Jdst 'città nuova' è attestata anche a Cipro nell'VIII sec. a.e. (CIS 1, 5); cf. E. Lipinski, La Carthage de Chipre, «Studia Phoenicia (Orientalia Lovaniensia Analecta»), 15, 1983, 209-234. 43. E. Benveniste, La tablette d'ivoire de Carthage, «SE» 7, 1933, 245-249. 44. Su ciò v L. Deroy, L'emprunt linquistique, Paris 1956, 138. 45. Il ferro assume nomi diversi nelle lingue indoeuropee, alle quali sembra sconosciuto prima del loro assestamento nelle sedi storiche (Bertoldi 1950, 8 sgg.). L'antecedente della voce latina ferrum, *bhers-om o *fers-om, è stato confrontato con
83
che raramente i nomi di vasi delle lingue classiche si possono spiegare con certezza nel quadro del patrimonio lessicale indoeuropeo ereditato e spesso presentano corrispondenze più o meno regolari con voci anindoeuropee di circolazione mediterranea (di sostrato o semitiche o microasiatiche). Quando non si rivelano sòlidarietà indomediterranee in questo campo lessicale (Pisani 1966), il veicolo più probabile di tale circolazione mediterranea di parole e di cose è da individuare verosimilmente nella navigazione fenicia46
, anche se non bisogna dimenticare la possibilità di una più remota fonte accadica che, nel corso del II mìllennio, può aver veicolato "mots voyageurs" lungo la pista microasiatica e quella siro-palestinese, verso l'area greca. Resta poi sempre aperta la possibilità di un tramite miceneo nei contatti commerciali con l'Occidente.
Ora per andare oltre la mera possibilità formale del rapporto etimologico occorre ricostruire le condizioni sociolinguistiche dell'interferenza. In due studi recenti (Martino 1986, 1987) ho individuato nell'ambiente linguistico eterogeneo degli empori internazionali della costa etrusco-laziale-campana (Pyrgi-Caere, porto tiberino-Roma, Anzio-Satricum, Cuma, ecc.), ambienti atti al fenomeno dell'interferenza nel lessico commerciale; e soprattutto nella contiguità dell'ambiente mercantìle e di quello processuale del Foro delle origini, la condizione di una serie di importanti imprestiti lessicali fenici nel latino arcaico. L'arra e l'arbitrato, da prassi private tra mercanti, sono diventati istituti giuridici romani, anche se hanno continuato a funzionare fuori del ius civile nel quadro di quello che sarebbe poi denominato ius gentium. Ipotizzavo che i Fenici avessero diffuso negli empori etrusco-laziali una radice semitica ('rb 'entrare') di ampia diffusione nel lessico commerciale, e che alcuni di tali termini da essa derivati fossero passati, per motivi storicamente accertabili, dall'ambiente delle
sem. brzl, con attestazioni in fen., pun., aram. d'Imp., accad. (parzillu), arabo, ecc. (DISO 43); forse di tramite etrusco (DELL 299), e comunque del tutto indipendente, com'è ovvio, dal greco o(begoç. Devoto 1983, 52 inserisce ferrum nella lista delle voci conf- di sospetta origine mediterranea. L. R. Palmer, La lingua latina, Torino 1977, 46 postula un prestito da qualche ignota lingua asiatica (cf. LEW), che per Tomback 55 sarebbe l'ittita. In ogni caso è sorprendente questa isolessi latino-semitica che esclude il greco. Sul possibile collegamento della voce fenicia con il toponimo sardo Bortigali v. Garbini in AA.VV. 1983, 161. Fronzaroli, Fon. ug.; Krogmann «KZ» 64, 267 sgg.; V. Georgiev, «KZ>~ 63, 250 sgg. ricorda il ruolo delle miniere etrusche. 46. Se si considera la dimensione geografica della "Verkehrssprache" mediterranea che occorre postulare attiva nella prima metà del I millennio, si possono applicare anche al latino e all'etrusco le considerazioni fatte per il greco da Banateanu 1969; 206: «Il parait [ ... ] que la riche gamme de termes qui désignent en grec les vases soit liée aux emprunts faits par les Grecs chez les peuples de la culture méditerranéenne, ou aux emprunts véhiculés par les Phéniciens, marchands de vin dans l'antiquité» (spaziato mio).
84
contrattazioni a quello del processo (assai contigui nel foro arcaico), assestandosi poi nella sfera del linguaggio giuridico latino (arra, arrabo, arblter) o nel gergo dei tribunali (arillator, rabula) Tali voci andrebbero considerate, in definitiva, come mutuazioni dal lessico commerciale (Martino 1986, 1987)
La voce 'rb 'entrare (come garante)' avrebbe designato un istituto del diritto commerciale cartaginese, creato per le esigenze del traffico internazionale e imposto nel trattato del 509 anche nei negozi con i Romani. secondo il testo polibiano del trattato (3, 22) i contratti effettuati da Romani nelle zone d'influenza cartaginese, per essere assistiti dalla Ùl]µoo(a :rtLattç, dovevano essere eseguiti davanti ad un xfjgu!; iì ygaµµan:uç, letteralmente 'banditore o scriba' (cf. n. 61). Le funzioni di tale personaggio presentano strette analogie con le competenze dell'arbiter romano delle origini, che prima di essere inquadrato con la legis actio per iudicis arbitrive postulationem nel diritto del pretore, operava extra ius per la soluzione di controversie minori, spesso di natura commerciale, con funzioni di stima e di garanzia generica informate alla discrezionalità, tali competenze riemergono poi istituzionalizzate nell'arbitrium empti venditi e nell'arbitrium pecunia compromissa dell'Edictum Perpetuum (II sec. a.C.). Siccome è certo che gli stranieri a Roma, non potendo litigare con il sistema del ius civile, ricorrevano ad arbitri privati, è assai probabile che questi ultimi siano stati denominati con un termine punico, dato che essi dovevano svolgere mansioni assai simili a quelle dell'analogo funzionario cartaginese. Tali funzioni si poterono esprimere nella 'garanzia di pubblicità', che a Roma si chiamò con un termine semitico di presunta mediazione greca. arrabo < fen. *'rbn 'garanzia' (cf. 'rb 'garante'). Un ulteriore indizio significativo che la radice semitica circolava nel Lazio arcaico come "parola viaggiante" del pidgin commerciale è il pun. marob 'sponsor' ( < fen. m 'rb) nel di~corso in punico di Annone nel Poenulus plautino (con il "Phoenician Shift" ii > 6, che non ricorrerebbe invece in gr j3gaj3i::uç, che presuppone forse una mediazione aramaica)47 La stessa radice 'rb, attestata anche in antroponimi egiziani fin dal VI sec., designa in papiri di età tolemaica un intermediario e garante nei contratti ('rb.tj)48
, che non può non essere messo in rapporto, per le sue funzioni, con il :rtQOITTUTl]ç TO'Ù €µ:rtog(ou che operava nella città mercantile di Naucrati (Her 2, 178), con il :rtWÀ.~Tl]ç che nei secoli VI-V «frequentava i barbari e assicurava gli scambi commerciali con i cittadini» a Epidamno (Plut. Mor 297 F) e con altri simili personaggi sia nel mondo greco (cf. Plat. Leg 917 e; Theophr , fr 97 Wimmer) sia in quello semitico antico49 Il fen.-pun. 'rb 'garante' è stato adattato alla morfologia
47 P Martino, Un semitismo antico nel greco. ~Qa~Euç, «Studi e Saggi linguistici» 28, 1988, 231-253. 48. Ch. F Nims, The Title 'rbt and "Letters of Agreement", «The Journ. of. Egypt. Archaeol.» 24, 1938, 78-82. 49. Cf. P Garelli, Marchands et tamkara assyriens ec Cappadoce, «Iraq» 39, 1977,~ 103 sgg., B. Porten, J C. Greenfield, The Guarantor at Elephantine-Syene, «JAOS» 89, 169, 153-158.
85
latina (*arb-a-ter), in un'epoca anteriore all'indebolimento delle vocali brevi interne, mediante il suffisso -ter che ha conservato una antica funzione "equativa" di eredità indoeuropea50
, con un processo di adattamento morfologico assai più lineare di quello che è presupposto, ad esempio, dalla forma Carthiigo (v infra)
Alla circolazione di questa voce semitica negli ambienti commerciali internazionali dei secoli VIII-VI, Etruria compresa, ho riportato altri due termini latini. arilliitor (arribliitor in Gloss.) 'sensale' e 'commerciante ambulante', che sarebbe un adattamento latino di etr ari/ 'intermediario', attestato come epiteto di Atlante, e rabula 'avvocato che sa solo gridare', «in multis intentus negotiis» (P.-F ), collocabile nell'ambiente popolare del Forum (rabula de foro: Cic. Or 15, 47). Quest'ultimo, termine, se non è da collegare al pun. rb srsrm 'chef des courtiers, inspecteur du marché'51
, può essere l'adattamento latino di una forma punica di tipo qtal ('rab, con dileguo di ['] iniziale), e suggerirebbe una interpretazione del plautino rabo (Truc. 687) diversa dalla tradizionale. In anni recenti nuove acquisizioni epigrafiche hanno arricchito la documentazione da me considerata. La forma 'rbt, incisa su una coppa per bere di provenienza libanese o cipriota, databile alla fine del V sec. o al primo quarto del IV sec. a.C., interpretata da alcuni autori52 come 'offerta, dono', viene ora ricondotta da C. Grottanelli (1988) al lessico delle contrattazioni del commercio internazionale mediterraneo e interpretata come 'tessera hospitalis, ouµf3oÀov' Inoltre, un rotolo di piombo rinvenuto a Pech Maho, località della Linguadoca sulla costa Narbonese, databile alla prima metà del V sec. a. C., contiene sul verso un testo etrusco e sul recto un testo ionico che descrive una transazione tra indigeni e mercanti stranieri e contempla il versamento dell'àggaf3wv in presenza di un "terzo" garante53
Interferenze maturate negli ambienti interetnici degli scambi commerciali possono penetrare eccezionalmente in altri settori della lingua, è il caso delle formule di saluto che, com'è noto, vengono facilmente assunte in ambienti eteroglotti.
aue, haue è un punicismo comparso verso la fine della Repubblica (Cic., Cat., Sali.) In epoca imp. appaiono documentati gli allotropi aue, haue, con un abbreviamento della vocale finale che obbedisce alla legge delle parole giambiche. Le grafie più antiche non hanno h- (Thes. Il, 1300 sgg.), per Leumann-Hofmann-Szantyr I, 174 la forma deaspirata è popolare; ma si noti che per Quintiliano (1, 6, 21) la pronuncia «sine adspiratione et producta
50. Cf. E. Benveniste, Noms d'agent et noms d'action en indo-européen, Paris 1948, 119; Martino 1986, 115. 51. Cf. gr ÙQXɵ:n:oQoç: Répertoire de l'épigraphie sémitique, 12061•2•3•; DISO 271. 52. Cf. Amadasi Guzzo 1987b. 53. J Pouilloux, Un texte commerciai ionien trouvé en Languedoc et la colonisation ionienne, «Scienze dell'antichità - Storia, Archeologia, Antropologia», 2, 1988, 535-555.
86
secunda syllaba» sarebbe propria dei «litterati». Le forme avete, avet6 cominciano ad essere attestate da Sallustio (Cat. 35,5) in poi, ave6 'sto bene' è ancora più tardo. Il progressivo incremento della flessione e della vitalità della voce, che non si comporta come altri verbi difettivi (Nencioni 1939, 41) è indizio della rapida assimilazione di un imprestito della formula di saluto punica auo «Uiue», che ha valore di singolare, non solo di plurale, come sostenevano Thurneysen e Walde (DELL 56). Nel Poenulus plautino (v 998; cf. 994; 1001) «au6» è il saluto del cartaginese Annone, che lo schiavo Milfione interpreta come formula di saluto. L'adattamento latino aue è evidentemente una creazione analogica su uale, salue. Si noti che ancora in Plauto le formule di saluto prevalenti sono saluus, saluere (DELL 56).
Se è possibile che per qualche tempo prima dell'VIII secolo !'Etruria e il Lazio siano state precluse alla navigazione fenicia da una lega sardoetrusca in funzione anti-orientale (Garbini 1991), è certo che la colonizzazione euboica riallaccia il circuito tra le coste siro-fenicie e le campano-laziali-etrusche, aprendo «spazi di grande sviluppo all'industria levantina ed alla stessa presenza fenicia in Italia» (Maddoli 1980, 54) Nell'VIII secolo i Fenici si installano in Sicilia, Sardegna e Malta. A Ischia nell'VIII sec. operava, a contatto con i primi coloni greci, una colonia di Fenici, ad essi sembrerebbe che si siano sostituiti verso la fine del secolo elementi «siriani» o «aramei» (Bondì 1983, 68), ai quali va attribuita l'iscrizione "aramaica" su anfora greca con un simbolo religioso fenicio54
La componente fenicia (o meglio cipro-fenicia, se si ammette con il Garbini una scarsa partecipazione dei Fenici di Siria-Palestina ai commerci dell'Orientalizzante, in se?uito alla crisi provocata dalla conquista assira), e quella aramaica5 hanno un ruolo primario in questo
54. Garbini 1978, 150: «La presenza di una parola e di un numero aramaico in un'anfora di fattura greca è segno inequivocabile di rapporti commerciali con la Siria». Cf. Buchner 1978. Alla "componente siriana" nell'Orientalizzante dell'Italia centro-meridionale è attribuito lo scarabeo con iscrizione "siro-fenicia" o "aramaica" della fine del sec. VIII, dalla necropoli di Macchiabate, presso Francavilla Marittima (Cosenza); Garbini 1978a, 426 segnala !'«importanza del ruolo aramaico e in particolare degli Aramei della zona di Zincirli e Carchemisch nel fenomeno dell'Orientalizzante». Contra: Amadasi Guzzo 1987, 1987a, 21, con bibl. Si aggiungano i frammenti iscritti da Pithekoussai del terzo quarto dell'VIII sec. (Buchner 1978, Amadasi Guzzo 1987a), le iscr fenicie sulla patera dell'orientalizzante antico di Pontecagnano e sulla coppa argentea della tomba Bernardini di Palestrina (fine VIII- inizio VII sec. a.C.). 55. Lat. cotta na, -6rum, n. pl., 'fichi piccoli della Siria' comincia ad essere attestato con il I sec. d.C. (Plin. n.h. 13, 51. «in ficorum autem [genera habet Syria] Caricas et minores eiusdem generis, quas cottana vocant»; Stat. silu. 4,9; Martial. 4, 88, 6; 7, 53, 7; 13, 28; Juven. 3, 81-3: cottona); non è certo che si tratti di imprestito dal gr x6navov, Elboç cruxwv µLXQWV (Hes.), attestato tre secoli più tardi (Ateneo, IX, 385 a) e considerato a sua volta imprestito semitico (Lewy 1895, 22), confrontato da Er-
87
grandioso fenomeno di influssi levantini56 Ma con la metà dell'VIII sec. (età romulea), le componenti greche presenti nell"'Orientalizzante" laziale «risultano portatrici di merci e di idee non solo greche ma anche orientali, collegate come sono, attraverso una catena di mediazioni, ai porti del Levante (Cipro, Fenicia, Siria settentrionale, dove prosperano i fondaci greci (Al Mina, Sukas, ecc.), senza tutta via escludere rapporti diretti per il tramite fenicio»57
Nella fase dell'orientalizzante recente (dalla metà VII agli inizi VI sec. ), dopo l'alleanza etrusco-cartaginese e la battaglia di Alalia (545 a.C.), la componente punica deve essersi rafforzata nella Roma etrusca e nei centri costieri tra i quali Pyrgi. L'imperialismo di Cartagine comincia con la seconda metà del sec. VIII e si incrementa nel VII, all'epoca dell'influsso etrusco in Roma. Per le presenze nel Lazio arcaico cf. Bunnens 1979 Il grande mutamento sociale avvenuto nell'epoca dei Tarquini vede affermarsi la classe dei commercianti accanto alla vecchia aristocrazia terriera. I mutamenti socio-economici e culturali, come osservava Pisani 1962, 168, «debbono aver esercitato un profondo influsso sulla lingua che, da mezzo di espressione d'una comunità agricola e guerriera, deve tramutarsi in quello d'una città a tendenze egemoniche, capitalistica, industriale e commerciale, aperta a culture esterne. ».
Alla ricostruzione della situazione sociolinguistica concorrono evidenze culturali. sincretismo religioso, onomastica, dati archeologici. Ad esempio, la frequentazione dell'area del Foro Boario da parte dei Fenici sembra documentata dal santuario di Melqart-Ercole che vi è
nout e Meillet con ebr qii(6nlqii(iin 'piccolo', f. qe(anna. L'ipotesi di Bron 1985, che si tratti piuttosto di aramaismo è fondata non tanto sulla notizia pliniana della provenienza siriana dei cottana (la latitudine semantica del termine Syria in latino è nota) quanto sull'attestazione di qut(ayn 'fichi' in al-MuqaddasI, geografo arabo del X secolo di origine palestinese, e di qut(én I qot(én in dialetti arabi moderni della SiriaPalestina ( cf. S. Fraenkel, Die aramaischen Fremdworter im Arabischen, Leiden 1886, 148). Poiché il vocalismo interno della forma latina orienterebbe per un imprestito non più antico del III sec. a.C., si deve postulare un accatto dal greco ellenistico; del resto abbiamo attestazioni fenicio-puniche di q(n 'piccolo' con vari sensi (v c6th6n ), ma non con quello di 'fichi' I fichi secchi erano alimenti a lunga conservazione («nuces ve! caricae parvae» Gloss. V 654,4) ideali per essere stivati nelle navi commerciali. Nulla di certo possiamo dire sulla preistoria di lat. ambiibaia f. 'flautista, prostituta', non attestato prima dell'epoca imperiale (Porph. ad Hor Sat. 1, 2, 1); parola e cosa sono originarie della Siria: sir abbùb 'flauto', abbùbay 'suonatrice di flauto'; per -mb- cf. sambucus, sambatus. 56. G. Garbini, I Fenici in Occidente, «Studi Etruschi» 34, 1966, 116-121 (poi con modifiche, in I Fenici. Storia e religione, Napoli 1980, 125-150; Garbini 1991, Heurgon 1969, Tusa 1971. 57 Cf. G Colonna, in Civiltà del Lazio primitivo (catalogo della mostra), Roma 1976, 31 (spaziato mio). Cf. AA.VV, 1977
88
stato identificato58 Sul culto di Astarte a Pyrgi agli inizi del V secolo testimoniano le lamine auree, per il medesimo culto a Roma vedi Moscati 1979, 5059
Al VI sec. risalgono le prime iscrizioni puniche. In Sicilia e Sardegna esse attestano la vitalità della lingua per ben nove secoli (dal VI sec. a.e. al Ili d.C.) in centri sia costieri che interni. (Moscati 1977, 1979; Amadasi Guzzo 1978) Platone (Lett. VIII, 353 e) paventava la scomparsa della lingua greca in Sicilia ad opera della <l>mv(xwv ùuvaOLda.
La presenza fenicia in Etruria fino alla seconda metà del VII sec. e in Campania fino al VI secolo fu riconosciuta già agli inizi del nostro secolo da Kahrstedt 191260 Al periodo etrusco della monarchia risalgono i primi trattati commerciali internazionali, quello del 535 tra Cartagine ed Etruschi (Arist. Poi. 3,9,1280a) e quello del 509 tra Cartagine e Roma, quest'ultimo garantiva ai Romani parità di diritti con i Cartaginesi nella Sicilia punica e sanciva il divieto per i Cartaginesi di molestare le città del Lazio (Ardea, Anzio, Laurento, Circei, Terracina), su cui Roma vantava l'egemonia61 Con ciò si riconosce implicitamente che tali centri erano frequentati da Cartaginesi. Questi si obbligano, tra l'altro, a «non costruire alcun luogo fortificato nel territorio latino».
I secoli V-IV segnano la fase del consolidamento dell'impero cartaginese. Degli inizi del V sec. è il documento più importante di questa «influenza punica di tipo certo religioso, ma verosimilmente anche politico» (Moscati 1979, 46) su Etruria e Lazio arcaico: la bilingue etrusco-punica di Pyrgi, il porto di Caere, che fu il punto di smistamento per l'Italia (Moscati 1974) Da qui l'ipotesi di un controllo cartaginese della costa etrusca e dei "circuiti che risalgono il Tirreno" sul
58. Cf. D. Van Berchem, Hercule Melqart à l'Ara Maxima, «Rend. Pont. Ace. Arch.» 33, 1959-60, 61 sgg., R. Bloch, Hannibal et les dieux de Rame, in D. Briquel, Ch. Guittard, A. Rouveret, Recherches sur les religions de l'Italie antique, Genève 1976, pp. 32-42; cf. M. G. Amadasi Guzzo, in «Rivista di Studi Fenici» V, 1, 1978, 111. 59. Sulla presenza di Semiti nel quartiere trasteverino del Gianicolo, dove fu localizzato il culto della dea Furrina, cf. L'area del santuario siriaco del Gianicolo. Problemi archeologici e storico-religiosi, Roma, Quasar 1982. 60. Con questa posizione, ampiamente condivisa, sembra in disaccordo Garbini 1980, 132: le città fenicie già in crisi non avrebbero partecipato ai commerci dei prodotti dell'orientalizzante (Garbini 1991). 61. Cf. H. Bergston, Die Vertriige der griechisch-romischen Welt von 700 bis 338 v. Chr Miinchen-Berlin 1962; K. E. Petzold, Die beiden ersten romisch-karthagischen Vertriige und das foedus Cassianum, in Aufstieg und Niedergang der romischen Welt, I, 1, 1972, 364 sgg., C. Marek, Die Bestimmungen des zweiten romisch-punischen Vertrag uber die Grenzen der karthagischen Hoheitgewiisser, «Chiron» 7, 1977, 1 sgg.
89
finire del VI secolo (Bondì 1983, 94) Pallottino 1984, 104 parla di «protettorato» Anzi, con l'impiego della lingua punica su lamine d'oro, il sovrano Thefarie Velianas avrebbe riconosciuto «l'influenza politica di Cartagine fino alle porte di Roma» (Moscati 1979, 55) Poco più a nord di Pyrgi è localizzato il porto di Punicum.
Si aggiunga che verso la fine del VI sec. ripresero verosimilmente i traffici fenici in Occidente, favoriti dalla politica antiellenica dei Persiani (Garbini 1966; 1980, 125 sgg.) Il secondo trattato CartagineRoma del 348 a.C. (Liv 7, 27, 2, Pol. III, 24), menzionando tra i contraenti anche Utica e Tiro, dimostra che i Fenici d'Oriente continuavano ad avere interessi economici negli stessi mercati62
Questa menzione di Tiro non può non essere messa in rapporto con il nome latino della città fenicia. Sa rr a, - a e; già Ennio, secondo Probo ( Georg 2,506), «dicit Poenos Sarra oriundos»63 Sarra è verosimilmente più antico del grecismo Tyrus (in Cicerone, Livio, Virgilio, Mela ecc.), visto che per Gellio 14, 6, il nome Sarra per Tyrus è una pedanteria erudita. Il nome fenicio fi' 'roccia'64 va vocalizzato $6r65 cf. assir fiUrru, già nelle tavole di El Amarna e in testi egiziani della XIX dinastia (Wagner 1957, 81). La sibilante iniziale è una fricativa sorda alveolare enfatica con forte compressione glottidale, esito normale del fiiide cananaico, che troviamo anche nel nome greco ~LOWV, mentre la dentale di Tugoç attesterebbe la distinzione fonematica pre-fenicia, anteriore al XIV sec. (Cardona 1968a, Rosén 1979, 8). Il timbro della vocale della prima sillaba si spiega se ammettiamo una geminazione della rotata nel nome fenicio. L'etimologia di Servio «quae enim nunc Tyros dicitur, olim Sarra vocabatur a pisce quodam, qui illic abundat, quem lingua sua sar appellant» (ad Virg. cit.) tradirebbe il tentativo di spiegare un etimo ormai oscuro. Problematica è la connessione con il toponimo sardo Tharros, tuttavia spiegata da Wagner 1957,78 sgg. con la fonetica paleosarda, cf. Cardona 1968, 11. Un termine tecnico nautico senza etimo indoeuropeo è sa b u r r a 'zavorra di nave', 'massicciata' (PI., Virg., Liv ) Il collegamento con sabulum 'sab-
62. Cf. A. Ferjaoui, Recherches sur les relations entre l'Orient phénicien et Carthage. Carthage 1992, 50. Il trattato fu rinnovato per la terza volta nel 306 (Liv 9, 43, 26). 63. L'agg. Sarranus 'fenicio' è in Virg. Georg. 2, 506, in luv 10, 38 e in Silio Italico, e tornerebbe per Vattioni 1979, 186 in una serie di antroponimi latino-punici ( < ~rn). La forma Sura in Plauto (Poen. 405), nome di una pettinatrice fenicia, è forse da gr ~U(.>a; comunque, trattandosi di schiava, il nome proprio può identificarsi con l'etnico. 64. Harris 1936, 142; Fuentes Estaftol 218. La presenza della radice in accadico e in antico egiziano potrebbe indiziare una voce di sostrato, da collegare alla serie lessicale (oronimi e idronimi) studiata da L. Lun, Due toponimi prelatini delle vicinanze di Bolzano: Sarentino e Tàlvera, «Studi Etruschi» 16, 1942, 419-436, e riportata alla base *SAR(A) 'roccia isolata' e 'isola', isolessi «d'area mediterranea, con esclusione dell'etrusco» (p. 429). 65. Theodoretus (V sec. d.C.): TuQoç ~ÒQ i:fi È:rtLXWQicp :rtQooayoQEUE'tUL cpwvfi: cf. Lewy 84; Friedrich 1957, 222.
90
bia', per la parte iniziale della parola, e con il suffisso -ur(r)-, di provenienza etrusca (Ernout 1954, 48) o mediterranea (Gerola 1942, 365), per la seconda, è a dir poco incerto. Il problema è complicato dall'irregolarità dei riflessi romanzi it. zavorra e sp. zahorra, in cui non si spiega l'esito afficato [dz-] della sibilante latina e il timbro [9]66 Ora il termine latino ha una precisa corrispondenza semantica e formale nella radice semitica fibr 'rassem bler, amasser' (DISO 241) attestata nell'ugar fibrt 'assembramento', nell'ebraico biblico fibr 'id.' (f!ibUr 'mucchio'), nel giudeo aramaico, nel Talmud di Babilonia e nell'aramaico del Frahang-i-Pahlavik (XVIII, 18: ~BL-WN- = pahl. citan 'raccogliere'), cf. anche ar f!Ubrat 'mucchio (di cereali)' Inoltre, un antroponimo Saburra compare in iscr latino-puniche e in autori latini67 L'etimologia semitica scioglie l'enigma degli esiti romanzi, apparentemente irregolari. È noto, infatti, che la coppia delle sibilanti non enfatiche /si lzl è correlata nel semitico a una sola enfatica /fil senza opposizione di sonorità, ed è anche incerto se la sua realizzazione nel fenicio-punico fosse sibilante, come suppone A. Murtonen68
, oppure affricata alveodentale /[ ts] [ dz ]/ con coefficiente di sonorità irrilevante (Cardona 1968a, 13). Mentre, per rendere tale fonema enfatico, il greco disponeva della ~'ij'ta (o di digrammi < T~>, <TL> ), il latino antico non aveva altra risorsa che il segno della sibilante <s>, magari intensa <ss> (che del resto è documentata nel latino arcaico, ed è da postulare anche per imprestiti antichissimi in greco come XQl!Ooç), successivamente anche la "littera graeca" < z > 69 L'incertezza sulla resa del!' enfatica semitica è testimoniata ancora in Girolamo (Co mm. in Isaiam 11,1): «sade littera cuius proprietatem et sonum inter set z latinus sermo non exprimit». Dunque la forma saburra è tipica della lingua letteraria, dietro di essa si cela probabilmente una pronuncia popolare con l'iniziale affricata (*tsaburra I *dzaburra), da cui potrebbero dipendere direttamente gli svi-
66. Restano poco convincenti i tentativi di P Skok, Saburra, «Archivum Romanicum» 14, 1930, 395-406 di rintracciare il passaggio s- > z- in imprestiti germanici, arabi, greci: lo stesso autore riconosce che z- resta in questo caso una «curieuse innovation», «un intrus, vraisemblablement récent» (p. 404), e postula un precedente *saburna con assimilazione di s- alla successiva consonante sonora. J Hubschmid. Lat. saburra, *zaburra, «Revue de Linguistique Romane» 27, 1963, 374-376, Gerola 1942, 365 e G Devoto, Avviamento all'etimologia italiana, Firenze 1968, 463, pensavano (con il Corominas) al sostrato: la parola "mediterranea di tipo occidentale" sarebbe arrivata all'italiano attraverso dialetti settentrionali (genovese e veneziano) «e perciò corretta (senza ragione) da sa- in za- (Devoto). J Corominas, Diccionario critico etimologico de la lengua castellana, IV, Berna 1954, 803, spiega l'iniziale di cast. zahorra, arag. zaborra 'piccola pietra, massicciata' come un "catalanismo" 67 Cesare, Beli. Afr 48; Lucano 4, 772; Appiano Beli. civ. 2, 45); cf. v Vattioni 1979, 189. 68. A. Murtonen The Semitic sibilants, «JSS» 11, 1966, 135-150. 69. È noto che anche gr <~> veniva reso nel latino arcaico con <ss>· cf. A. Funck, Die Verba auf -issare und -izare, «Archiv f. lat. Lexik. u. Gramm.», 3, 1886, 398-442; M. Leuman, Griechische Verben auf -izein im Latein, in Kleine Schriften, Ziirich un Stuttgart 1959, 156-70; R. Arena, Contributi alla storia di lat. -issò, «Helikon» 5, 1965, 97-122; X. Mignot, Un cas d'adaptation phonétique. Le suffixe grec -(~co en latin, «Word» 24, 1968, 290-4.
91
luppi romanzi. Analogo sviluppo dell'enfatica semitica è nel sardo mittsa, su cui vedi avanti.
marra, ae, attestata dal I sec. d.C., designa un 'rampone o uncino di ferro' (Plin. n.h. 17, 159; 18, 147) e, nel lessico agricolo, la 'marra', strumento di metallo che serve per radere il terreno (Colum. 10, 72), con continuazioni romanze occidentali (REW 5370), tra le quali una di pertinenza marinara. 'ciascuna delle estremità triangolari dei bracci dell'ancora'70 Essa va messa in rapporto con la notizia di Plinio (n.h. 9, 45) che il pesce silurus «in Danubio marris extrahitur». La forma greca medievale attestata da Esichio (µagg6v ÈgyaÀei:ov cnùegoùv) sembra provenire dal latino (H. Lewy, «KZ» 58, 1930, 33, n. 1, DELL 388). Una sua etimologia semitica (DELL 388; LEW II 43) è stata proposta dapprima da E. Weidner e G R. Driver71
, i quali hanno rintracciato il pendant accadico nella forma assira marru 'zappa', che ricorre nel Codice di Hammurabi e in lettere della prima dinastia babilonese (Chicago Assyr Dict. 10, 1977, 287), qui l'uso dell'ideogramma MAR indicherebbe un'origine sumerica del termine. Il siriaco ha mar(r)ii e l'arabo marr(un) 'zappa' Per la possibilità di una trasmissione di termini dell'agricoltura dal punico in latino, occorre tenere presente la diffusione di fattorie agricole puniche nell'Africa e nella Spagna latina, cui ha accennato il prof. De Hoz, e il prestigio del trattato di agricoltura del cartaginese Magone, «rusticationis parens» ( cf. nota 77)
Non abbiamo notizie esplicite sul grado di conoscenza del punico a Roma durante gli ultimi secoli della Repubblica72 L'uso della lingua cartaginese nel Poenulus è un unicum nella commedia latina antica. Il fatto si presta a considerazioni di ordine sociolinguistico e culturale. La vis comica dell'esperimento linguistico plautino risiede nell'esoticità del punico per l'uditorio romano. Il discorso lungo di Annone viene parafrasato in latino, ma altri 14 brevi brani del V atto non sono tradotti, eppure lo svolgimento della vicenda, e i giochi di parole creati da Plauto, presuppongono un qualche grado di competenza di ~uella lingua negli ascoltatori. Si deve perciò presumere, con il Rollig7
, che il pubblico che assisteva alle commedie plautine poco dopo la seconda guerra punica, non era del tutto ignaro di punico; molti erano stati in
70. Cf. M. Cortelazzo, P Zolli, Dizionario etimologico della lingua italiana, III, Bologna 1983, 723. 71. E. Weidner in «Glotta» 4, 1913, 303; G R. Driver, On the Etymology o/marra 'Hoe' in Latin, «Classica! Review» 36, 1922, 166-7 72. Sulla situazione in Sicilia durante la prima guerra punica sono indicativi fatti di mescolanza etnica e di bilinguismo come quello del racconto liviano relativo a «Hippocrates et Epicydes, nati Carthagine sed oriundi Syracusis exule auo, Poeni ipsi materno genere» (24, 6, 2). 73. Rollig 1980, 288.
92
Africa al seguito di Scipione, altri in Italia avevano avuto contatti con Cartaginesi e alcuni avevano posseduto schiavi punici. «Carthaginienses multi Romae servierunt» (Cic. Tusc. 3, 53). Sulla presenza di schiavi siri ed ebrei in Italia fin dal II sec. a.C. esiste un'abbondante bibliografia 74
Per quanto riguarda i primi secoli dell'era volgare, è noto che esistevano a Roma delle minoranze linguistiche, le quali, come osserva I. Kajanto75
, non potevano aver dimenticato la lingua materna. In questo periodo il latino non era più soltanto la lingua dell'Urbe. I punicismi potevano entrare direttamente nel latino delle province e poi diffondersi. Inoltre, non va dimenticato che nell'antichità classica circolava quella letteratura fenicia e punica che a noi manca. Una cpoLVLXLX1Ì LO'tOQLa, scritta da Layx.ouvLa'frwv in fenicio ('tii cpoLv(xwv yÀ.wun), fu tradotta, com'è noto, da Filone di Biblo in greco in 8 libri e conservata da Eusebio di Cesarea76 A Roma giunse il trattato di agricoltura in 28 libri di Magone cartaginese, tradotto «ex senatusconsulto» (Colum. 1, 1, 13) in latino da Decimo Silano77 Nel I sec. a.C. erano conosciuti a Roma anche i Libri Punici attribuiti al re lempsale, dei quali circolava una traduzione, che Sallustio dichiara di aver consultato per conoscere la storia dell'Africa ( B .J 17, 7). Da questa fonte lo storico apprende forse il nome delle case dei contadini Numidi (mapalia), che per le pareti ricurve ricordano le carene delle navi (Iu. 18, 8). Le stesse glosse puniche presuppongono conoscenze linguistiche negli autori latini: ad es. Avieno Ora Marit. 268: «Punicorum lingua conseptum locum gaddir vocabant» ( cf. Plin. 4, 120) Sappiamo da Sallustio (B. J 28, 47) che, all'epoca della guerra giugurtina, mercatores e incolae italici vivevano nelle città della Numidia. Viceversa, sappiamo da Cicerone che le città del Lazio, soprattutto quelle litoranee, avevano subito in passato una «corruptela ac mutatio morum» per la mescolanza linguistica e culturale («no vi sermones ac disciplinae») dovuta alla frequentazione di barbari, fra i quali vengono espressamente
74. H. Solin, Juden und Syrer im romischen Reich, in Die Sprachen im romischen Reich der Kaiserzeit, cit., 301-330., Die Namen der orientalischen Sklaven in Rom, in L'onomastique latine, Paris 1977, 205-220. 75. I. Kajanto, Minderheiten und ihre Sprachen in der Hauptstadt Rom, in Die Sprachen im romischen Reich der Keiserzeit (Kolloquium vom 8. bis 10 April 1974), KolnBonn 1980, 84. 76. Prep. Evangelica IV 156 sgg. (Migne PG 19-24: PG 21, 271). Cf. O. Eissfeldt, Ras Shamra und Sanchunjaton, Halle 1939. 77 Plin. N.H. 18,5,22; Varr rust. 1,1,10. Cf. J Heurgon, L'agronome carthaginois Magon et ses traducteurs en latin et en grec, «CRAI» 1976, 441-458; Scriptorum Romanorum de re rustica re/iquiae, ed. F Speranza, I, Messina 1974 75 sgg. Colum. 12, 4, 2 conosce un altro autore cartaginese di agricoltura: Hamilcar o Halcar
93
menzionati Etruschi e Cartaginesi, che venivano «alteri mercandi causa, latrocinandi alteri» (Rep. 2,4)78 Nel de oratore 3, 12, 44 Cicerone stigmatizza la rustica asperitas e la peregrina insolentia che avevano corrotto il linguaggio del Foro (rusticitas e peregrinitas per Quint. 11, 3, 30). Se nella prima è da vedere la presenza delle lingue italiche, nella seconda si celano certo lingue extra-italiche, esse non potevano essere che il gallico e il punico, nonostante lo scetticismo di Ernout 1928, 31, che preferisce interpretare la peregrina insolentia come I"' accento" straniero degli avvocati non romani. Il giudizio di Cicerone è comunque una illuminante testimonianza dell'atteggiamento della cultura ufficiale romana nei confronti delle interferenze alloglotte.
Nel latino degli ultimi secoli della Repubblica affiorano nella documentazione alcune voci di sospetta origina punica.
còthò(n), -onis m. (f.), còthònum, -i, n. 'porto scavato dall'uomo'· Serv ad Aen. l, 427· portus effodiunt, i. e. cotona faciunt. Carthaginienses cothone fossa utuntur, non naturali portu (cf. P.-F , 37); Cothon è nome di un porticciolo artificiale di Cartagine e di Adrumentum, nella regio Byzacena, in Africa sett. (Auct. belli Africi 62,5; Strab. 833; App. Pun. 127). Per questo «mot sémitique» (DELL 146) non c'è un'etimologia sicura. Bochart pensava a ktn 'incidere', ma manca ogni evidenza nel fenicio-punico; Schroder 127, Friedrich 1970 ed altri lo riconnettono a q{n 'piccolo', cf. accad. qatanu 'essere sottile', attestato in punico (DISO 257, Tomback 287), radice cui Jean e Hoftijzer ricollegano gr yaùov «'tÒ Èx µtxQWV cÌJxoùoµ1]µÉvov» dell' Etym. Magnum. Kw-ttwv è inoltre il nome di una piccola isola presso Citera, sede di un culto fenicio (Steph. Biz.). Non si può asserire con certezza che il toponimo punico abbia rapporti di parentela con il termine greco omofono che designa un recipiente per liquidi. Tuttavia, se ammettiamo la possibilità di un'applicazione metaforica, attribuibile al gergo nautico, del nome di un recipiente a quella di un porto che ne richiama qualche caratteristica formale, non necessariamente le dimensioni, ma forse la ristrettezza dell'imboccatura (cf. xo'tUÀ.1] 'cavità' [già in Horn. E. 306] e poi 'vaso'), è possibile istituire un rapporto tra questa voce e gr xw-ttcov 'coppa'' che è privo di etimologia79 Per il tipo di metafora toponimica, si potrebbe confrontare ZayxÀ.1], dQÉJtavov e dQEJtUV1J, Obba (su cui vedi avanti). Si aggiunga che il quadro geolinguistico è completato da etr qutum I qutun 'n. di vaso' in quattro iscrizioni etrusche (TLE 63, ecc.), quto nell'iscrizione falisca Ve 242b da
78. «Est autem maritimis urbibus etiam quaedam corruptela ac mutatio morum: admiscentur etiam novis sermonibus ac disciplinis, et importantur non merces solum adventiciae, sed etiam mores, ut nihil possit in patriis institutis manere integrum» (Rep. 2, 4). 79. Per le difficoltà connesse con un inquadramento di xcfrfrcov e di XO'tUÀ.TJ nella nota serie lessicale indomediterranea per 'rotondità', cf. Belardi 1954, 620, n. 5; Silvestri 1974, 160.
94
Civita Castellana (Mancini 1990, 44), tutte su oggetti dell'Orientalizzante medio (675-625 a.C.), e da lat. gut(t)us 'brocca, ampolla dal collo stretto' (Hor Sat. 1,6), di solito considerati senz'altro grecismi80 In etrusco ci aspetteremmo un calco dell'accusativo *qutuna, secondo la norma, ma Colonna 1973, 141 pensa ad un prestito greco *cutus, giunto nella prima metà del VII secolo indipendentemente nell'Etruria e nel Lazio dalla Sicilia, dove x&l'toç (cf. x&l'ta JtO'ttlQLa, Hes.) designava un recipiente per liquidi e un pesce. Siccome i xool'tovEç, come dichiara la Suda, facevano parte del vasellame di bordo delle navi, ciò autorizza a pensare che gli Etruschi ne abbiano appreso il nome nei loro porti, nell'epoca delle più antiche navigazioni greche nel Tirreno» (Colonna, cit. 141). La glossa festiana «cothones appellari portus in mari non naturales, sed arte et manu factos» lascia intendere che il sostantivo sia inteso come nome comune, ancorché di genere grammaticale incerto e ai margini della lingua standard.
Lo stesso tipo di metafora ritorna in o b ba (Varr Men. 114; Laber com. 60) 'poculi genus, quod nunc ubba dicitur Varro: Calenas obbas et Cumanos calices' (Non. 146, 8; 545, 1, Ca/es è città della Campania), se è reale la congruenza con il toponimo Obba, presso Cartagine (Liv 30,7,10) istituita da M. Niedermann e accettata da Ernout e Meillet (DELL 454; Ernout 1928, 205). Ma anche in questo caso la connessione rimane fortemente ipotetica. Cf. ebr 'ob 'otre per acqua o vino?
Certamente punica è considerata la glossa g i r ba 'pila ubi tisanae pistantur' (CGL V 298, 32), che appare per la prima volta nella metà del V sec. d.C. in Cassio Felice, scrittore di medicina di origine africana, l'origine semitica è stata proposta da G Helmreich in «ALL» 1, 1884, 327; cf. DELL 275. Nencioni 1939, 44 cita il talmud. girbti(h) 'otre di pelle', aram. gertib, ar girtib 'otre', e il top. Girba, ne(3a, isoletta della piccola Sirte, che Schroder 1869, 100 intendeva erroneamente come gir Ba' al 'Wohnung Baals' Ma nel bovese e nei dialetti italoromanzi meridionali è diffusa la forma cirma 'sacchetto, bisaccia e sim.' che risale certo al greco medievale XLQ(3a ·nfiea µLXQa (Hes.), senza antecedenti nel greco antico e ignota al neogreco. Probabilmente la voce suditaliana, se succedanea della tardo-latina, continua una forma importata direttamente dall'Africa o diffusa, forse durante le guerre puniche, dal sermo castrensis, come congetturava il Rohlfs81 Una forma grb
80. Ernout 1954, 67; C. De Simone, Die griechischen Entlehnungen im Etruskischen, Il, Wiesbaden 1970, 18 ecc., I rapporti greco-etruschi alla luce dei dati linguistici, in Interferenza linguistica. Atti del Convegno della SJG (Perugia, 24 e 25 aprile 1977), Pisa 1977, 51, Colonna 1973, 140 sg. Lat. guttus e guturnium (cuturnium in Paolo-Pesto 44, 12 L.) avrebbero subito l'influsso paretimologico di guttur e di gutta, che spiegherebbe la sonora e la geminazione (Mancini 1990, 45). G Alessio, in «SE» 29, 1961, 204, vi ha connesso anche il tardo lat. cucuma; cf. M. Cohen, cit. in DELL 818. 81. G. Rohlfs, Lexicon Graecanicum Jtaliae Inferioris, Tubingen 1964, 239. Infondata la congettura *qui/ma di G. Alessio, Lexicon Etymologicum, Napoli 1976, 340.
95
'brocca' è attestata nell'aramaico d'Impero per il V sec. a.C. 82 Cf. accad. guriibu 'tubo' (LEW I 602; Chicago Assyr Dict. 5, 136 sg.)83
In tutti questi casi la difficoltà più grave non è tanto la tarda attestazione delle voci latine quanto la sporadicità della documentazione nelle lingue semitiche interessate.
Uno scrittore di origine nordafricana come Macrobio (IV sec. d. C.), commentando l'impiego dell'aggettivo ca m u ru s nelle Georgiche virgiliane (3,55), osserva che «Vergilius peregrina verba non respuit», ad imitazione dei veteres, i quali «Punicis Oscisque verbis usi sunt» (Sat. 6, 24, 3). L'aggettivo camur, camurus 'curvato verso l'interno (detto delle corna dei buoi)' è vocabolo raro in latino e sembrerebbe proprio del lessico zootecnico: è usato da altri due autori del IV secolo, Avieno (Arat. 429) e Prudenzio (Perist. 1253); è stato accostato ai nomi propri etrusco-latini Camurius, Camurenus, e indiziato di punicità da Ernout e Meillet (DELL, 91). La tradizione glossografica opera il conguaglio paretimologico con il grecismo camera 'volta' e parla di «verbum graecum»: Nonio, 30, 7 «camerum 'obtortum', unde et camerae, tecta in curuitatem formata»; Isid. (Etym. 12, 1, 35) cita un xaµouQ che «verbo Graeco curvum significai», ma lo riferisce al dorso dei cammelli arabici. Il rapporto con gr xaµétQa mediante l'osco, già accolto da Ernout 1928, 135, che richiama anche i toponimi Cameria nel Lazio e Camerinum in Umbria, è ritenuto dubbio da Chantraine (DELG 489) che tuttavia respinge per la voce greca l'ipotesi dell'aramaismo. Per una verifica dell'altra fonte suggerita da Macrobio, quella punica, dobbiamo attendere il contributo critico dei semitisti. Il Rosén classifica - forse correttamente - il talmudico qmrwn 'Wolbung' tra i grecismi nell'ebraico: < xaµétQLov; circa quest'ultimo, egli ritiene erroneamente che si tratti di tardo prestito latino nella koiné (in realtà è un derivato di xaµétQa), e quindi fa risalire in definitiva la forma talmudica a lat. camur84 Ma l'aggettivo latino, termine tecnico e raro, isolato nel lessico latino, ha tutta l'aria di essere esso stesso un imprestito. Il senso 'tomba' che gr xaµétQa assume in iscrizioni può far pensare a sem. qbr 'tomba', attestato in ugar , ebr , aram., ma anche in iscr fenicie, puniche e neo-
82. A. Cowley, Aramaic Papyri of the fifth Century B. C., Oxford 1923, 81. DISO 53. 83. Una storia diversa ha la voce it. ghirba 'sacco impermeabile per trasportare acqua', diffusa nel gergo militare della prima guerra mondiale e tuttora vitale nelle caserme anche in senso metaforico 'vita, pelle' (DELL 491), forse appresa dai soldati italiani (dall'arabo girba 'otre di pelle') durante la guerra libica (1911-12), come pensava V Pisani («Paideia» 18, 1963, 10) o durante l'occupazione coloniale dell'Abissinia (G. Rohlfs, cit.), dove la voce amarica girba 'container (for water or honey) made of calf skin' sarebbe passata nel gergo militare degli occupanti con il senso 'secchio per acqua di pelle o tela' Cf. ge'ez garab 'leather bag', saho girbo, afar girib: W Leslau, Comparative Dictionary of Ge'ez, Wiesbaden 1987 201. 84. H. B. Rosén, Die Sprachsituation im romischen Paliistina, in Die Sprachen im Romischen Reich der Kaiserzeit (Kolloquium vom 8. bis 10 Aprii 1974), Koln-Bonn 1980, 215-239; cf. p. 232.
96
puniche (DISO 250; Tomback 283), dalla radice verbale qbr 'seppellire'; tale forma verbale si trova anche nell'iscrizione fenicia di Pyrgi. Sullo scambio tra [b] e [m] in iscr neopuniche cf. Rollig, 1980, 296.
mappa, - a e, f., 'salvietta, drappo, banderuola con cui si dava nel circo il segnale dei giochi (CatoAgr 11, 5) è considerata da Quintiliano 1, 5, 57 voce punica. «mappam circo quoque usitatum nomen Poeni sibi vindicant». Sulla scorta di tale glossa H. Lewy, «KZ», 59, 1932, 190-1 pensa a una voce punica corrispondente a ebr [Talmud] *manpii 'tovaglia' < menapii 'geschwungenes Tuch, Fahne' Diversamente in DISO 163 si postula un fen.-pun. mph. Per la possibile derivazione da mapp-iilia < mpllnpl 'cadere', per risegmentazione paretimologica, vedi la voce seguente.
mapalia, -ium, n. pi. 'capanne, tende' è già in Catone, hist 78 (in Fest.): mapalia quasi cohortes rotundae»; Sall. B. J 18,8: «aedificia Numidarum agrestium, quae mapalia illi vocant, oblonga, incurvis lateribus tecta, quasi navium carinae sunt»85
; Agostino parla di Mapalia, rione di Cartagine e dell'etnico Mappalienses (Vattioni 1968, 440). I sensi traslati, attestati nel latino popolare, 'frottole' (Petr 58,13), 'confusione' (Sen. Apoc. 9,1. «mera mapalia fecistis») si spiegherebbero bene con la provenienza punica del vocabolo, come spiega Fest. 133 (266 L.): «mapalia casae Poenicae appellantur; in quibus quia nihil est secreti, solet id vocabulum solute viventibus obici»86 Un accostamento di miipiilia 'tenda, capanna, ecc.' a mappa per etimologia popolare fu proposto in passato da E. Miiller-Graupa e M. Pellegrini87
, mentre H. Lewy, «KZ», 59, 1932, 190 chiama in causa ebr mappiiliih 'ruderi'88
Vattioni 1976, 532, 1979, 180 propone la radice mpllnpl 'cadere', di vasta diffusione (DISO 181, Tomback, 218), che si ritroverebbe in antroponimi latino-punici e che potrebbe spiegare anche il senso specifico di mappa 'fazzoletto che si fa cadere nel circo per dare il segnale di inizio dei giochi' (ma non del tardo lat. ecci. nappa 'tovaglia dell'altare', che sembra dissimilato da mappa, cf. nespila < mespila). La connotazione del "cadere", contenuta in ebr mappai 'cascame, vagliatura' (Koehler-Baumgartner, 552), è invece rilevante nel tardo lat. mamphula «panis Syriaci genus quod, aut ait Verrius, in cli bano antequam percoquatur, decidi t in carbones cineremque» (Verri o in Fest. 126, 11 Lucil. Sat. 1250).
85. Vedi pure 46, 5. Cf. Plin. N.H. 5, 2, 22; Virg. Georg. 3, 340: raris habitata mapalia tectis», Lucan. Phars. 4, 684; Tac. hist. 4, 50; Serv adAen. I, 41, Martial. 8, 53, 3; 9, 13, 7 86. C. F. Russo, Divi Claudii Apoc., Firenze 1964, cf. ital. 'fare casino' M. Pellegrini, cit., 381 considera voce fenicia anche matta 'stuoia' (di epoca imperiale), cf. ebr mittiih 'coperta' 87 E. Miiller-Graupa, Mapalia, «Philologus» 73, 1914, 302-317; Zu Sen. Apok., in «Philologus» 85, 1930, 303-321 e M. Pellegrini «Studi Italiani di Filologia Classica» 17, 1909, 377 88. Vedi anche Ch. Le Coeur, Les "mapalia" numides et leur survivance au Sahara, «Hespe,ris» 24, 1937, 29-45; G Marcy, Remarque sur l'habitation berbère dans l'antiquité. A propos des "mapalia", «Hesperis» 29, 1942, 23-40; Heinze «Hermes» 61, 64; W Goldberger, «Glotta» 20, 1932, 146.
97
Notevoli somiglianze fonetiche e semantiche con la voce precedente presenta lat. magalia 'capanne rotonde di tribù berbere nomadi' (Serv ad Aen. 1, 421), attestato dal II sec. a. C. 89 Per Consenzio si tratta di barbarismo che designa le «Afrorum casae» (Cons. de barb. ). Qui abbiamo diverse possibilità etimologiche. Lat. miigiilia è senz'altro voce punica per Walde e Hofmann (LEW 11,9), per Ernout e Meillet (DELL 377), per Nencioni 1939, 45 (che scarta l'ipotesi del Beguinot di un'origine berbera) e per H. Lewy, «KZ» 59, 1932, 188 sgg., che pone una radice 'gl 'rund sein', donde ebr 'iigol 'rund', femm. 'iigullii, cui sarebbe riportabile anche il nome antico di Caere: Agylla, VAyuÀÀa; invece il derivato con preformante nasale ma'ggiil 'cinta di accampamento militare, cerchio di carri', 'falce' (cf. anche ma'glla 'Walze, Rolle') potrebbe stare alla base di lat. miigiilia. Il fatto che determinati luoghi caratterizzati da una struttura rotonda (per lo più vulcani, insenature, accampamenti militari, nuclei abitati o singole case) conservino nel loro nome tale connotazione rilevante, non è inconsueto nel Mediterraneo antico: vedi sopra i casi di Kc!:n'twv, Zayx.Àf], L\gÉrmvov, L\grnavri, Obba. Si potrebbe aggiungere ~'tQOyyuÀf] 'Stromboli' che «XUÀELtat µÈv ÒrtÒ tO'Ù oxi)µatoç» (Strab. 6, 2, 11). La somiglianza fonetica avrebbe attratto magiilia 'ruderi, ecc.' nella semantica di mapiilia 'case rotonde'
Una diversa ipotesi si basa sul toponimo punico m'rt, che è stato accostato al greco MÉyaga (CIS I, 247, 5-6; 248, 4), Mayer 1960 e Masson 1966 hanno chiamato in causa ebr me'iirii 'caverna, casupola' per gr µÉyaga µayaga 'grotte, buchi dove si gettavano le vittime vive da sacrificare a Demetra' (Menandro in Fozio), che sembrerebbe solo omofono del più antico µÉyagov 'sala, palazzo' (malgrado Lewy 83). Il lemma mgr 'casa di campagna' in DISO 142 si basa solo sulle glosse latine, ma è da confrontare con DISO 163 e 166: pun. epigr mqr 'capanna di legname', bt mqr' 'maison en charpente, batisse légère en bois' In questo caso occorre postulare una ristrutturazione morfologica da parte del latino. Inoltre, in tale ipotesi, la voce latina magalia troverebbe un antecedente immediato nel toponimo Magaria, sobborgo di Cartagine, che è in Plaut. Poen. 86 ( = 'le Baracche'?). Per chiarire il rapporto tra le due forme può essere utile Isid. Etym. 12,4: «. magalia dieta quasi magaria, quia magar Punici novam villam dicunt» (cf. CGL 5, 82), si deve notare, a tal proposito che la villae romane, comprese le più antiche, site nel Foro Boario e nel Campo Marzio, erano circondate da recinti lignei (saepta). L'apparente suffisso -iilia potrebbe conservare in sé traccia della laterale della radice semitica e alludere ad un valore collettivo; ed è significativo in tal senso l'uso del neutro plurale sia nella forma latina che in quella greca ('tà µayaga).
Una radice mkr 'commerciare', con attestazioni in punico, ebraico biblico, ugaritico e accadico90
, potrebbe essere l'etimo di lat. macellum 'mercato',
89. Hemina hist. 38: «Sinuessae magalia addenda murumque circum ea»; cf. Virg. Aen. 1, 421. 90. Theol. Wb. zumAlten Test. IV, 1984, 870; Koehler-Baumgartner 552; Tomback 177; DISO 150.
98
gr µaxEÀ.À.ov; cf. ebr miklii 'griglia, chiusura' (DELG 660), ;gare (à petit bétail)' nelle tre occorrenze bibliche, come segnala L. de Meyer , che ritiene recenziore la forma greca µaxEÀ.À.oç, 'mercato della carne', forse imprestito dal latino, mentre µaxEÀ.À.ov 'chiusura' è attestato nel IV sec. a.C. in una grande iscrizione di Epidauro (IG IV, 1, 102). O. Masson92 valorizza una glossa di Varrone: «Iones ostia hortorum macellotas (vocant) et castelli (ostia) macella» (L.L. 5, 146), che attesterebbe il significato originario dell'imprestito, per in!epretare µaxEÀ.aç, come 'preposto alla griglia (alla chiusura del tempio)' E da confrontare con pun. mqr' 'staccionata di legno' (DISO 166; vedi magalia)? Il fenicismo (su cui v anche Lewy 1895, 111) si sarebbe affiancato a forum per designare il mercato, in quanto termine del lessico commerciale. Un altro riflesso della voce semitica in Sicilia sarebbe per il de Meyer il toponimo MaxEÀ.À.a 'comptoir commerciai établi par les Phéniciens' (p. 151). La trafila che è stata postulata per la voce latina sarebbe *makfrrum > *makirrum > *makerrum (forma qatil con e < i in vicinanza di r) > *makellum93 Ma si osservi che un *makar-lo- avrebbe dato lo stesso esito. Sul toponimo sic. Macara (Eraclea Minoa) cf. J Bérard, La Magna Grecia, 81
simila, ae 'fior di farina', di attestazione tarda (Celso, Marziale; ma sim i I a g ò , - in i s, con lo stesso suffisso di Carthiigo, è già in Catone e Plinio) è voce semitica per Lewy KZ 58, 28 sgg. Ernout e Meillet parlano senz'altro di voce giunta in epoca imperiale assieme al prodotto, imprestito di qualche «langue méditerranéenne ou orientale», ma citano solo l'assiro samidu, che ha lo stesso senso (DELL 626) Il LEW II 538 esclude la mediazione del greco oEµ(baÀ.tç, per cui Szemerényi «JHS» 94, 1974, 156 postula un intermediario ittita. Si noti che gli Indoeuropi che hanno raggiunto il Latium Vetus hanno portato con sé la conoscenza di pochi nomi di cereali coltivati, certo ignoravano il nome del 'grano" far sembra che avesse altro significato e frumentum è specializzazione secondaria (Ernout 1954, 22).
Una vera e propria "crux" etimologica è la pertinenza etimologica di lat. crux 'strumento di supplizio, palo, croce' (dal IV sec. a.C.), ambigenere come molti imprestiti. In Ennio è maschile, è usato da Plauto (Pers. 795) come termine ingiurioso: 'ribaldo' Il sospetto che si tratti di «terme de civilisation» proveniente dal punico (DELL 153; cf. Pisani 1962, 150; LEW I, 296) si basa sulla probabile origine punica del «servile supplicium» (Tac. hist. 4,11) della crocifissione (Zestermann e Fulda in «PWRE» IV, 1901, coll.
91. L. de Meyer, L'étymologie de macellum 'marché', «L'Antiquité Classique» 31, 1962, 148-152. 92. O. Masson, Un mot pseudo-lydien. MaxÉÀaç, «Archiv Orientalni» 18, 4, 1950, 7-10. 93. Assai più problematica appare invece la parentela di macellum con merx 'merce' e merces 'prezzo della merce', termini isolati nel latino, per i quali si è pensato a un sostantivo come ebr makar 'prezzo' (Num. 20, 19 ecc.) mediante una metatesi klr (de Meyer cit., n. 24).
99
1728 sgg., Mansberg, «Zeitschrift fiir Kulturgeschichte» 7 ,64) Anche in questo caso mancano solidi elementi linguistici.
Una voce considerata «africana» da Festo (163, 12) è nepa (nepas) -ae 'scorpione' (animale e costellazione). La presenza di [p], ignoto alle parlate berbere ha fatto pensare a un'origine punica94
Una revisione in questa luce meritano alcune glosse classificate come sarde o sicule. Bertoldi 1950, 21-48 metteva in evidenza riflessi punici nella toponomastica e nei dialetti della Sardegna, indipendenti dalla mediazione greca e trasmessi dal latino locale, a volte documentati anche in fonti antiche.
Ha buone possibilità di essere un punicismo irradiato dal latino della Sardegna il lat. mastruca, -ae, 'veste di pelle di montone', già in Plauto (Poen. 1313) nella forma mastruga con valore di improperio contro il cartaginese Annone. Il termine conservò in latino connotazioni spregiative, se Cicerone parla di Sardorum mastruca (pro Scauro, 45) in tono deliberatamente irrisorio, «inridens ex industria», come osserva Quint. 1, 5, 8; in altro luogo (de prov. cons. 15) Cicerone parla di res in Sardinia cum mastrucatis latrunculis. La tradizione grammaticale latina cita questo «vestimentum Sardorum» come esempio di barbarolexis95 Mentre per il Walde-Hofmann (LEW, s.v) e per il Bertoldi (1950, 36) si tratterebbe di vocabolo sardo, «mediterraneo occidentale» per Gerola 1942, 365 e Nencioni 1939, 35 sgg. (a causa del suffisso -iica), Ernout e Meillet (DELL 389) parlano di probabile origine fenicia. Essendo il vocabolo, già plautino, pienamente integrato nel lessico latino, anche sotto il profilo fonetico e morfologico, le speciali connotazioni che abbiamo rilevato non possono attribuirsi ad esotismo; non è da escludere che tali connotazioni riflettano valutazioni e pregiudizi romani nei confronti dei Cartaginesi, tanto più che la sua natura di verbum peregrinum è ben presente nella coscienza dei parlanti, che l'hanno confinato nel sermo plebeius.
Tralasciamo la toponomastica sicula e sarda di possibile origine semitica (Bérard 81, Friedrich 1957, Wagner 1954; Serra 1953, 1960) che non ha precise rispondenze nel latino. Ma alcuni lessemi punici come macom 'luogo', attestati in toponimi sardi (Macomadas) sono documentati nel latino arcaico: Plauto, Poen. 930.
Degna di considerazione sembra a M. Wagner e J Friedrich96 l'origine punica di sardo mittsa, minsta 'fonte, polla d'acqua', con nasale epentetica (miza
94. Cf. S. Gsell, Histoire ancienne de l'Afrique du Nord, Paris 1913, I, 313; Nencioni 1939, 37 95. Consent. 5, 386, 247; cf. Don. 4, 392, 7; Pomp. 5, 384, 21, cf. Isid. Orig. 19, 23, 5. 96. M. Wagner 1957, 105; Dizionario etimologico sardo, Heidelberg 1962, II 120-121, Friedrich 1957, 223; cf. Cardona 1968; 11.
100
è in documenti volgari sardi) < *mi~~ii' < *mWjo < ~' 'herausgeben' (cf. ebr m~h 'expressit'), con una palatalizzazione di u nel punico volgare, di cui resterebbe traccia nella forma plautina mysehi 'Ausgang' (Poen. 931) Anche in questo caso, come in zavorra, la sibilante enfatica avrebbe dato esito affricato.
Altri punicismi, conservati nelle parlate sarde moderne e documentati dalle glosse, presuppongono una ininterrotta vitalità nel latino regionale sardo.
L'origine punica di log. e camp. tsikkiria 'aneto' è testimoniata da una glossa di Dioscoride: 'Pwµai:m àv~wvµ, "AcpQOL OLXXLQLa (3, 60); se lat. sicera (in Gerolamo) e gr o(XEQa (neutro indecl.) 'bevanda inebriante' (Galeno 19, 693; Sept., NT) possono dipendere da ebr sekiir (F Zorell, Lex. Gr N T., Roma 1990, 1201), la forma sarda deve rimandare al sostrato punico: Wagner 1957, 104; cf. Garbini 1988.
Sardo tsippiri 'rosmarino', diffuso in aree lessicali costiere coincidenti con l'area archeologica delle necro~oli puniche, è inseparabile dalla glossa punica zib(b)ir dello Pseudo-Apuleio e dal toponimo composto Rusibiritanus 'promontorio del rosmarino'98
, nella Mauritania Caesariensis (Bertoldi 1950, 41 sgg.). O. Szemerényi in «Gnomon» 1971, 674, richiama accad. ziparru, sum. zabar Per altri riflessi in area semitica vedi Garbini 1988, 74.
In linea di massima esorbitano dai limiti cronologici della presente rassegna anche i numerosi punicismi penetrati nel latino d'Africa e i semitismi indiretti, penetrati tramite l'ebraico, la Vulgata (400 d.C.) e il latino della Chiesa. in genere sono ebraismi adattati al latino, ma non mancano forme aramaiche penetrate dapprima nel giudeo-greco alessandrino. Le voci esclusivamente neotestamentarie sembrano per lo più di origine aramaica (Mancini 1992, 55) Sulle particolarità del latino africano cf. Leumann-Hofmann-Szantyr II 766. Vattioni 1979 elenca 273 antroponimi fenicio-punici attestati nelle iscrizioni latine e greche del Nordafrica. Alcuni di essi potrebbero celare voci puniche più antiche99
Un elemento da considerare è la vitalità del neopunico in Africa in una situazione di diglossia («latino punico»100
; per le iscrizioni semiti-
97 Cf. Corpus Medicorum Latinorum, IV, 1927, p. 145: «a Graecis dicitur libanotis, alii ycteritis, Itali rosmarinum, Punici zibbir»; «herba rosmarinum .. Afri zibir». 98. Fen. pun. r's' 'capo'; cf. topon. gr Pwoooç CIG 3497; Rusadir Plin. V, 1. 99. Ad es., i nomi Dudda e Adudda, noti da iscr latino-puniche, sono connessi con il nome di Didone da Vattioni 1979, 161, che pensa alla radice dd' 'mammella', forzando la glossa serviana «Didonem vocat, ut supra diximus, Poenorum lingua viraginem» (ad Aen. 4, 674). 100. Harris 1936, Segert 1976; M. G. Amadasi Guzzo, Cultura punica e cultura Lati-
101
che con eterogrammi greci o latini. Amadasi Guzzo 1987) Il trilinguismo punico-greco-latino negli emporia della Tripolitania nel I sec. è attestato da Apuleio, il cui figliastro Sicinius Pudens, interrogato in giudizio è descritto «vix singulas syllabas fringultiens»; infatti «loquitur nunquam nisi Punice et si quid adhuc a matre graecissat; enim latine loqui neque vult neque potest» (Apol. 98) L'imperatore Settimio Severo (193-211 d.C.), nativo di Leptis Magna, pronunciava il latino con accento africano, come attesta l'Historia Augusta (Sept. Sev 19)101
, nel VI secolo, lo storico nordafricano Aurelio Vittore lo definisce «litteris latinis sufficienter instructus, graecis sermonibus eruditus, punica lingua eloquentia promptior» (Epitome de Caesaribus, 20, 8) Sull'onomastica personale e la teonimia cf. Moscati 1977, 50 sgg. Il bilinguismo latino-punico è documentato anche nelle leggende monetali dei regni neopunici della Numidia e della Mauritiana, latine al dritto e neopuniche al rovescio102 Le glosse puniche sono numerose in autori di età imperiale, specialmente di origine africana. Apuleio, Frontone, Flora (II sec.), Agostino (IV sec.), Prisciano (VI sec.), e in scrittori di cose africane (Sallustio, I sec. a.C.), in Plinio (I sec.), in Gerolamo (IV sec.), in grammatici. Quintiliano, Consenzio, Donato, Pompeo, ecc., infine nei glossografi.
6. È noto che la cronologia degli imprestiti nel latino può giovarsi del coordinamento di fatti di cultura ed eventi storici databili con dati archeologici, che possono illuminare la storia della parola in questione, ma il criterio più sicuro resta quello linguistico. Fatti fonetici, morfologici, semantici, sia nella lingua di partenza che nella lingua di arrivo, possono rivelarsi preziosi "indici" dell'imprestito (L. Deroy, L'emprunt linguistique, Paris 1956, 47-61) e della sua datazione.
6.1 Vari elementi di cronologia relativa sono certo ricavabili dalla storia del latino. Si sa, ad esempio, che il latino tra il VI e il III secolo, l'epoca del più intenso contatto con l'elemento punico, è andato incontro ad una serie di cospicui mutamenti. affermazione dell'accento intensivo iniziale con i fenomeni concomitanti, indebolimento delle sillabe interne e finali, sincopi, rotacismo, ecc. i semitismi che presen-
na in Tripolitania. Osservazioni in base alle iscrizioni puniche e alle iscrizioni bilingui, in Bilinguismo e biculturalismo nel mondo antico. Atti del Colloquio interdisciplinare (Pisa 28 e 29 sett. 1987), Pisa 198, 23-32. Bilingui latino-puniche e trilingui latinogreco-puniche provengono anche dalla Sardegna (Amadasi Guzzo 1967). 101. Cf. Ch. Courtois, Saint Augustin et le problème de la survivance du punique, «Revue africaine» 94, 1950, 258-282; Vattioni 1968, 1977 102. E. Acquaro, La monetazione punica, Milano 1979, 9 sgg.
102
tana sibilante intervocalica devono essere penetrati dopo l'esaurimento del fenomeno del rotacismo (IV sec. a.C.). Ma non è un criterio assoluto: è noto che [s] e [~] confluiscono in fenicio con [s], anche se iscrizioni neopuniche presentano a volte un grafo speciale che si usa traslitterare con <ç> per l'enfatica, per la cui resa in greco Belardi aveva supposto una sibilante geminata, poi semplificata, ma conservata anche tra vocali ( cf. gr XQUooç). Le iscrizioni anteriori al I sec. a. C. (introduzione di <z> nell'alfabeto latino) devono aver reso con <s> o con <ss> ( cf. lat. <ss> = gr <~>) anche la spirante sonora [ z] Per la denasalizzazione di [m] in [b], cf. Rollig 1980, 296.
6.2. Se un presunto imprestito si sottrae all'indebolimento delle vocali brevi interne in latino, è possibile che sia giunto posteriormente al IV sec. a.C. (supparus, cottana) Sappiamo inoltre che una tendenza all'apocope delle brevi finali investì il fenicio, ma non c'è accordo sulla datazione. Secondo Friedrich 1922 le vocali brevi finali sarebbero cadute a cominciare dal 400 a. C. Per Harris e Garbini la caduta sarebbe molto più antica. fine II millennio a.C. Nello studio storico del vocalismo fenicio, non si hanno elementi sicuri per una cronologia relativa dei fatti evolutivi, ma solo per inferire la pertinenza dell'imprestito latino al fenicio-punico. Tanto il passaggio *a primario e secondario in *o («Early Canaanite Shift»), che investì le parlate cananee nell'ambito del semitico di N-0, almeno a metà del II millennio103
, quanto il più recente «Phoenician Shift», che comportò la labiovelarizzazione anche di a brevi toniche (ma non in sillaba chiusa da doppia consonante), sembrano anteriori ai primi prestiti cananaici nelle lingue classiche104 Inoltre sembrerebbe che alcune forme plautine si sottraggano al passaggio a > 0
105, e questo relativizza ogni attribuzione al
fenicio-punico, specialmente se si rapportano questi fatti all'ipotesi del Peruzzi, Aspetti culturali, 153 sgg., secondo cui i Prisci Latini rendevano lo! con /':J/ o addirittura con /a/ nella zona costiera del Lazio, come sembrerebbe potersi dedurre dal trattamento di prestiti greci. cassis < x6-tl'Lç; lancea < ÀOYX.lJ, catfnus < XO'tUÀl], patera< JtOl'TJQa, etr spanti < OJtOVÒELOV
10~. Harris 1939, 43-45; S. Segert, Zum Ubergang ii> 6 in den kanaaniiischen Dialekten, «Archiv Orientalnf» 23, 1955, 478 ss. R. Zadok, in «Die Welt des Orients» 9, 1977-8, 38-44. Garbini 1988a. 104. In fenicio *ii > *6 (e poi > u) almeno agli inizi del I millennio (Szemerényi 1968: fen. *gamiil è passato al gr xaµ11J..oç prima di tale epoca (prima del "Canaanite Shift" in *gamòl). 105. Cf. Dotan 1971, 1976. Tale fenomeno fenicio si sarebbe conservato attivo fino ai primi secoli dell'era volgare.
103
A volte il trattamento delle forme semitiche in latino può essere illuminato dalla forma assunta da vocaboli semitici in autori tardi come Gerolamo106
, il Dioscoride latino, Isidoro, ecc.
6.3. I processi di adattamento morfologico dell'imprestito, quasi sempre imprevedibili, comportano a volte deformazioni per attrazione paronimica o sostituzione completa, anche quando l'interferenza interessa lingue strutturalmente vicine come latino e greco ( cf. ergastulum < ÈQYUITTTJQLOV). Tali processi di trasformazione delle finali possono interessare anche parti non suffissali, come nel caso di Carthiigo. Qui il segmento finale del toponimo punico, che conteneva nessi consonantici inusuali per il latino, è stato sostituito per "induzione" con un morfema carico di connotazioni sociolinguistiche. -iig6 determina prestiti come andriigo, latinizzazione di àvbgaxvri (André 1956, 31) ed altri fitonimi (similiigo, ecc.) Inoltre, le desinenze in -a in semitismi non devono considerarsi necessariamente indici di aramaismi, come si è pensato (Rosén 1979, 13) per gr -a (aA.cpa, ecc.) Gli adattamenti di parole latine e greche in lingue semitiche confermano che aleph finale corrisponde a lat. -us, gr -oç e tutt'al più può indicare un "nome di funzione" 107 Un aleph desinenziale si cela evidentemente anche dietro la resa -i ( < -ius) ed -e ( < -us) di nomi propri latini nelle iscrizioni latino-puniche, essa fu intesa dal Février come basata sul vocativo, la forma casuale più usata nella conversazione, mentre il Friedrich pensava ad una mediazione etrusca, dato che gli adattamenti punici di antroponimi greci si basano invece sul nominativo ( cf. Rollig 1980, 292)
6.4. Non è possibile individuare con sicurezza possibili imprestiti semantici, che pure sono frequenti nella fenomenologia del contatto linguistico108 I calchi sintattici attribuiti al contatto con lingue semitiche risalgono per lo più all'era volgare. L'espressione icere (o ferire) foedus per 'concludere un'alleanza' (Cicerone e Livio) rimanderebbe
106. C. Siegfried, Die Aussprache des Hebriiischen bei Hyeronymus, «ZfaW» 4, 1884, 66-67; E. F Sutcliffe, St. Jerome's pronunciation of Hebrew, «Biblica» 29, 1948, 113-125. 107 Cf. J.-G. Février, L'inscriptionpunico-lybique de Maktar, «Journal Asiatique» 237, 1949, 85-91. nab. kljrk' < :XLÀLaQ:xoç; Id., La prononciation punique des noms propres latins en -us et -ius, «Journal Asiatique» 241, 1953, 465-71. 108. F O. Copley, Plautus, Poenulus 53-55, «AJPh» 91, 1970, 77-8 crede di riconoscere nel plautino Pultiphagonides 'mangiatore di polenta' (che nel Prologo del Poenulus l'autore stesso dichiara nome latino della commedia modellata, com'è noto, sul KaQX'IJ06vwç della commedia attica nuova), un calco costruito con un punico *karch 'pea, porridge' e la radice di lat. ed6 mangiare'
104
al sacrificio che suggella il patto, l'espressione sarebbe per Fehling 1980, 11 un calco diretto dalla lingua fenicia o cartaginese, senza mediazione del greco (dove pure si trova OQXLa 't'aµvELv (Omero, Erodoto). Greco e latino sarebbero debitori di una locuzione fenicia, attestata in ebr kiirat berit 'secuit pactum' Fuori strada sembra il Fehling quando considera calchi semitici (accadici o cananaici) all'origine della polisemia di termini latini del linguaggio commerciale (privi di dirette corrispondenze nel greco) come pendere 'pendere', 'ponderare' e 'pagare' (che egli confronta con accad. siikalum, ebr siikal, itt. gank), pacare 'pacificare' e 'pagare', riportato a forme causative della radice semitica slm, ecc. (Fehling 1980, 13 sg.)109 Tali analogie, che si potrebbero agevolmente riscontrare in altre tradizioni linguistiche, trovano una più facile spiegazione nella universale tendenza ad utilizzare procedimenti metaforici per specializzazioni semantiche. Quanto a lat. pacare, è noto che il senso 'concludere un affare con un accordo' è da inquadrare nel contesto delle istituzioni giuridiche arcaiche latine e italiche (XII Tab. 1, 6; 8,2, o. prupukid, ecc.) Ben altro fondamento hanno i calchi sintattici ebraici veicolati dal cristianesimo in greco e in latino e interpretati come cristianismi influenzati dall'ebraico110 Il tipo urbem urbium è considerato punicismo da E. Wolfflin, «ALL» 8, 452, senza necessità (Leumann-Hofmann-Szantyr, II 55) Ebraismi sarebbero la ripetizione del sostantivo in funzione distributiva ( cata mane mane) e quella del positivo al posto del superlativo (bonas bonas per optimas. Leumann-Hofmann-Szantyr, II 254, 163)
7 In definitiva, la mia impressione è che i tempi siano maturi per tracciare un bilancio complessivo dei semitismi nel latino più antico. Occorre però una considerazione approfondita dei nuovi materiali fenicio-punici per tentare di definire un quadro globale di corrispondenze fonetiche e per descrivere le linee di comportamento del latino negli adattamenti morfologici, nonché un cronologia dei fatti evolutivi semitici in rapporto a quelli del latino in tutte le sue fasi storiche. La tarda datazione di talune attestazioni non dovrebbe comportare una loro programmatica esclusione dallo studio di fenomeni antichi, trattandosi di lessico che resta ai margini del codice standard. I grandi progressi compiuti nei vari settori delle lingue semitiche antiche lasciano bene sperare.
PAOLO MARTINO ~
109. Sulla semiticità della nozione di 'capitale' in greco, xecpétÀ.mov (Fehling 1980, 17) si esprime anche Szemerényi 1971, 573. 110. Cf. Leumann-Hofmann-Szantyr, II 87 e passim, F Blass - A. Debrunner, Grammatica del greco del Nuovo Testamento, Brescia 1982, 55 sgg.
105
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
AA.VV 1966: Rapporti tra Greci, Fenici, Etruschi ed altre popolazioni alla luce delle nuove scoperte, Quad. Ace. Lincei LXXXVII 1966.
AA.VV 1971. L'espansione fenicia nel Mediterraneo, Relazioni del Colloquio in Roma 4-5 maggio 1970, Roma 1971
AA.VV 1977· Lazio arcaico e mondo greco («PP» 32), Napoli 1977 AA.VV 1983: Fenici e Arabi nel Mediterraneo. Atti del Conv Linceo, Ro
ma 12-13 ott. 1982, Roma 1983. AA. VV 1992: Lingue e culture in contatto nel mondo antico e altomedievale.
Atti dell'VIII Conv intero. di Linguisti (Milano 10-12 sett. 1992), Brescia 1993.
ACQUARO 1978: E. ACQUARO, Cartagine. un impero sul Mediterraneo, .Roma 1978.
AISTLEITNER 1967· J AISTLEITNER, Worterbuch der ugaritischen Sprache, Berlin 1967, 3. ed.
ALONI 1982: A. ALONI, Osservazioni su gr KALlOL, «Atti del Sodai. Glott. Mil.» 23, 1982 [1984] 42 e in «Acme» 36, 43-49
ALrnEIM 1951. F ALTHEIM, Geschichte der lateinischen Sprache, Frankfurt am Main 1951, 284-297
AMADASI Guzzo 1967· M. G AMADASI Guzzo, Le iscrizioni fenicie e puniche delle colonie in Occidente, Roma 1967
AMADASI Guzzo 1970: M. G AMADASI Guzzo, Nuove iscrizioni puniche in Italia, «Cultura e scuola» XXXVI 1970, 151-8.
AMADASI Guzzo 1972. M. G AMADASI Guzzo, Epigrafia punica in Sicilia, «Kokalos» 18-19, 1972-73, 278-89
AMADASI Guzzo 1987· M. G AMADASI Guzzo, Fenici o Aramei in Occidente nell'VIII sec. a. C.?, in Studia Phoenicia V Phoenicia and the East Mediterranean in the First Millennium B.C., Leuven 1987, 35-47
AMADASI Guzzo 1987a. M. G AMADASI Guzzo, Iscrizioni semitiche di nordovest in contesti greci e italici (X-VII sec. a.C.), in «Dialoghi di Archeologia» 1987, 13-27
AMADASI Guzzo 1987b: M. G AMADASI Guzzo, "Under Western Eyes", «Studi Epigrafici e Linguistici» 4, 1987, 121 127
AMADASI Guzzo 1987c: M. G AMADASI Guzzo, Cultura punica e cultura latina in Tripolitania. Osservazioni in base alle iscrizioni puniche e alle iscrizioni bilingui, in Bilinguismo e biculturalismo nel mòndo antico. Atti del Colloquio interdisciplinare tenuto a Pisa il 18 e 19 settembre 1987, Pisa 1987' 23-33.
AMADASI Guzzo 1978: M. G AMADASI Guzzo, Il punico, in Popoli e civiltà dell'Italia antica, vol. VI (Lingue e dialetti), a c. di A. L. Prosdocimi, Roma 1978, 1015-1028.
ANDRÉ 1956: J ANDRÉ, Lexique des termes de botanique en latin, Paris 1956. ASPESI 1978: F AsPESI, Considerazioni sullo studio dei rapporti fra lingue
camita-semitiche e indeuropee, «Atti del Sodai. Glott. Mil.» 19, 1978, 55-67
106
ASPESI 1988: F ASPESI, Storie e preistorie linguistiche a contatto in area semitica e dintorni. A proposito di qualche nome d'architettura. «AION-L» 10, 1988, 161-176.
AuBET 1987· M. E. AuBET, Tiro y las coloniasfenicias de Occidente, Barcelona 1987
AUTRAN 1925: Ctt. AuTRAN, Sumérien et indo-européen. L'aspect morphologique de la question, Paris 1925.
AUTRAN 1926: CH. AuTRAN, De quelques vestiges probables, méconnus jusqu'ici, du lexique méditerranéen dans le sémitique d'Asie Mineure, et notamment de Canaan, «1A», 209, 1926, 1-79.
AYMARD 1957· A. AYMARD, Les deux premiers traités entre Rome et Carthage, «Revue des Etudes Anciennes» 59, 1957, 277-93.
BANÀJEANU 1969· V BANAJEANU, Termes grecs pour dèsigner les "vases" formés avec le suffixe égeo-asianique -ano et avec d'autres suffixes, «Revue Roumaine de Linguistique», 14, 1969, 205-19
BARR 1967· J BARR, St. Jerome and the sounds of the Hebrew, «JSS» 12, 1967, 1-36.
BELARDI 1954: W BELARDI, Una nuova serie lessicale indomediterranea, «RAL» VIII, 9, 1954, 610-644.
BELARDI 1955: W BELARDI, Un'innovazione nel sostrato, «RAL» VIII, 10, 1955, 308-331
BENZ 1972: F L. BENZ, Persona/ Names in the Phoenician and Punic Inscriptions, Roma 1972.
BERTOLDI 1950: V BERTOLDI, Colonizzazioni dell'antico Mediterraneo occidentale alla luce degli aspetti linguistici, Napoli 1950.
BERTOLDI 1953: V BERTOLDI, Contatti e conflitti di lingue nell'antico Mediterraneo, «PP» 8, 1953, 407-448 ( rist. in «ZRPh» 57, 1937, 137-169).
B1s11967· A. M. B1s1, L'irradiazione semitica in Sicilia in base ai dati ceramici dei centri fenicio-punici dell'isola, «Kokalos» 134, 1967, 30-60.
BOISACQ 1938-50: E. BoISACQ, Dictionnaire étymologique de la langue grecqùe étudiée dans ses rapports avec /es autres langues indo-européennes, Heidelberg-Paris 1938-50.
BoNoì 1975: S. F BoNDÌ, Ricerche fenicie a Roma. 1963-1975, «Bibbia e Oriente» 17, 1975, 66-74.
BoNoì 1975a. S. F BoNoì, L'espansione cartaginese in Italia, «Cultura e Scuola» 56, 1975, 66-74.
BoNoì 1983: S. F BoNDÌ, L'espansione fenicia in Italia, in AA.VV 1983, 63-95.
BoNDÌ 1988: S. F BoNoì, Problemi della precolonizzazione fenicia nel Mediterraneo centro-occidentale, in Momenti 1988, 243-55
BONFANTE 1941. G BONFANTE, The Name of the Phoenicians, «Classica} Philology» 36, 1941, 1-20.
Bosctt-GIMPERA 1951. P Bosctt-GIMPERA, Phéniciens et Grecs dans l' extrèmeoccident, «La Nouvelle Clio» 3, 1951, 269-296.
107
BoscH-GIMPERA 1972: P BoscH-GIMPERA, Les Phéniciens. leur prédécesseurs et [es étapes de leur colonisation en Occident, «CRAI» 1972, 464-74.
VAN DEN BRANDEN 1969: A. VAN DEN BRANDEN, Grammaire phénicienne, Beyrouth 1969.
BRÉAL-BALLY 1885: M. BRÉAL-A. BALLY, Dict. étym. latin, Paris 1885.
BROCKELMANN 1913: C. BROCKELMANN, Gundriss der vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen, voli. 1-11, Berlin 1913 (rist. Hildesheim 1961).
BRON 1985: F BRON, Sur un emprunt sémitique en grec et en latin, «Revue de philologie, de littérature et d'Histoire anciennes» 59, 1, 1985, 95-96.
BROWN 1968: J P BROWN, Literary contexts of the common Hebrew-Greek vocabulary, «Journal of Semitic Studies» 13, 1968, 163-191
BRUNNER 1969: L. BRuNNER, Die gemeinsamen Wurzeln des semitischen und des indogermanischen Wortschatzes. Versuch einer Etymologie, Bern 1969.
BucHNER 1978: G BucHNER, Testimonianze epigrafiche semitiche dell'VIII sec. a.C. a Pithekousai, «PP» 33, 1978, 130-142.
BUNNENS 1979: G BuNNENS, L'expansion phénicienne en Méditerranée. Essai d'une interpretation fondé sur une analyse des traditions littéraires, Inst. Beige de Rome, Bruxelles 1979.
BUNNENS 1983: G BUNNENS, La distinction entre phéniciens et puniques chez les auteurs classiques, «Atti del I Congr di Studi fenici e punici» (Roma, 5-10 nov 1979), Roma 1983.
BuRCHARDT 1909: M. BuRCHARDT, Die altkanaaniiischen Fremdworter und Eigenname im Àgyptischen, Leipzig I, 1909; Il, 1910.
CARDONA 1968: G R. CARDONA, Gr xuµl3axoç, itt. kiipabi-, ebr kof3a' I qof3a', in «AION-L» 8, 1968, 5-16.
CARDONA 1968a: G R. CARDONA, Per la storia del «!fiide» semitico, «AION-0» 18, 1968, 1-14.
CARPENTER 1958: R. CARPENTER, Phoenicians in the West, «AJA» 62, 1958, 35-53.
CHANTRAINE 1928: P CHANTRAINE, Sur le vocabulaire maritime des Grecs, Paris 1928.
COARELLI 1982: F CoARELLI, Il Foro Romano, l, Roma 1982; 2, 1985. CoHEN 1927· M. CoHEN, Sur le nom d'un contenant à entrelacs dans le monde
méditerranéen, «BSL» 27, 1927, 81-120. CoHEN 1929· M. CoHEN, Quelques voyages de mots, «BSL», 29, 1929, 132-
137 COHEN 1931. M. CoHEN, Quelques mots périméditerranéens, «BSL», 31,
1931, 37-41 CoHEN 1938: M. COHEN, Mots latins et mots orientaux, «BSL» 39, 1938, 179-
183. CoHEN 1955 M. CoHEN, Cinquante années de recherches, Paris 1955.
108
CoHEN 1970: M. CoHEN, Dictionnaire des racines sémitiques ou attestées dans les langues sémitiques, Paris 1970 sgg.
COLONNA 1973: G COLONNA, Nomi etruschi di vasi, «Archeologia classica» 25-26, 1973-74, 132-150.
COLONNA 1974: G COLONNA Preistoria e protostoria di Roma e del Lazio, Roma 1974.
CRISTOFANI 1983: M. CRISTOFANI, Gli Etruschi del mare, Milano 1983. CRISTOFANI 1991. M. CRISTOFANI, Gli Etruschi e i Fenici nel Mediterraneo, in
«Atti del Il Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici (Roma 1987)», Roma 1991, I, 67-75.
CuNY 1910: A. CuNY, Les mots du fonds préhellénique en grec, latin et sémitique occidental, in «REA» 12, 1910, 154-164; 14, 1912, 222-226; 24, 1922, 89-92.
CuNY 1946: A. CuNY, Invitation à l'étude comparative des langues indoeuropéennes et des langues chamito-sémitiques, Bordeaux 1946.
D' ARMs 1981. J H. D' ARMs, Commerce and socia/ standing in Ancient Rome, Cambridge (Mass.), Harvard Un. Press, 1981.
DEBERGH 1976: J DEBERGH, Les études phéniciennes et puniques à Rome (1963-1974), «Revue beige de philologie et d'histoire» 54, 1976, 89-122.
DE FRUTOS REYES 1991. G DE FRurros REYES, Carthago y la politica colonia/. Los casos norteafricano e hispano, Ecija 1991
DELG· P CHANTRAINE, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, Paris 1968, rist. 1990.
DELL: A. ERNOUT, A. MEILLET, Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots, Paris 19594
DE MARTINP 1980: F DE MARTINO, Storia economica di Roma antica, voli. 1-11, Firenze 1980.
DEVLEESCHOUWER 1969: J DEVLEESCHOUWER, La parenté de l'étrusque avi/ 'année', «Orbis» XVIII, 2, 1969, 529-534.
DEVOTO 1940: G DEVOTO, La crisi del latino nel V secolo a. C., «Studii Clasice» 6, 1964, 17-23; poi in Devoto 1983, XIX-XXVI.
DEVOTO 1983: G DEVOTO, Storia della lingua di Roma, Bologna 1940; rist. a c. di A. L. Prosdocimi, Bologna 1983.
DISO: CH.-F JEAN, J HoFTIJZER, Dictionnaire des Inscriptions sémitiques de l'Ouest, Leiden 1960.
DOTAN 1971-2: A. DoTAN, Vowel Shift in Phoenician and Punic, «AbN» 12, 1971-2, 1-5.
DOTAN 1971. A. DOTAN, Phoenician a > o Shift in some Greek Transcriptions, «Ugarit Forschungen» 3, 1971, 293-297
DoTAN 1976: A. DOTAN, Stress Position and Vowel Shift in Phoenician and Punic, «lsrael Orientai Studies», 6, 1976, 71-121
EILERS 1986: w EILERS, Einige akkadische Etymologien, in w Meid, H. Trenkwalder (Hgg.), Im Bannkreis des alten Orients. Studien zur Sprachund Kulturgeschichte des Alten Orients und seines Ausstrahlungsraumes.
109
Karl Oberhuber zum 70. Geburtstag gewidmet, Innsbruck, Inst. f. Sprachw d. Univ , 1986, 31-44.
ERNOUT 1928: A. ERNOUT, Les éléments dialectaux du vocabulaire latin, Paris 1928.
ERNOUT 1930: A. ERNOUT, Les elements étrusques du vocabulaire latin, «BSL», 30, 1930, 82-124.
ERNOUT 1954: A. ERNOUT, Aspects du vocabulaire latin, Paris 1954. FEHLING 1980: D FEHLING, Lehnubersetzungen aus altorientalischen Spra
chen im Griechischen und Lateinischen, «Glotta» 58 1980, 1-24. FÉVRIER 1971 J G FÉVRIER, Transcription et translittération des noms de per
sonnes puniques, néopuniques et libyques, «Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques (BAC)», 1971, 215-16.
FoLLET 1953: R. FoLLET, Sanchuniaton, personnage mythique ou personne historique?, «Biblica», 34, 1953, 81-90.
FRIEDRICH 1922: J FRIEDRICH, Der Schwund kurzer Endvocale im Nordwestsemitischen, «Zeitschrift fiir Semitistik und Verwandte Gebiete» 1, 1922, 3-14.
FRIEDRICH 1947· J FRIEDRICH, Griechisches und Romisches im phonikischen und punischem Gewande, in Festschrift Otto Eissfeldt, ed. J Fiick, Halle 1947, 109-124.
FRIEDRICH 1953: J FRIEDRICH, Vulgiirpunisch und Vulgiirlatein in den neupunischen Inschriften, «Cahiers d<r Byrsa», 3, 1953, 99-111
FRIEDRICH 1957· J FRIEDRICH, Zur Frage punischer Lehnworter im Sardischen, «Die Sprache», 3, 1957, 221-4.
FRIDRICH-ROLLIG 1970: J FRIEDRICH-W RoLLIG, Phonizisch-punische Grammatik, Roma 1951, 1970 2a ed.
FRONZAROLI 1959· P FRONZAROLI, I rapporti fra la Grecia e l'Oriente in alcuni studi recenti, «Atene e Roma» 4, 1959, 65-79.
FRONZAROLI 1977· P FRONZAROLI, L'interferenza linguistica nella Siria settentrionale nel III millennio, in L'interferenza linguistica. Atti del Convegno della S.I.G (Perugia 24 e 25 apr 1977), Pisa 1977, 27-43.
GARBINI 1963: G GARBINI, L'espansione fenicia nel mediterraneo, «Cultura e Scuola», 7, 1963, 92-97
GARBINI 1977· G GARBINI, I dialetti del fenicio, «AION» 37, 1977, 283-94. GARBINI 1978: G GARBINI, Un'iscrizione aramaica a Ischia, «PP» 33, 1978,
143-150. GARBINI 1978a. G GARBINI, Scarabeo con iscrizione aramaica dalla necropoli
di Macchiabate, «PP» 33, 1978, 424-26. GARBINI 1981. G GARBINI, Camita-semitico e indoeuropeo, in «Atti del So
dal. Glott. Mil.» 21, 1979-80 [1981], 4-18; poi in Le lingue semitiche. Studi di storia linguistica, Napoli 1984, 253-268.
GARBINI 1984: G GARBINI, Le lingue semitiche. Studi di storia linguistica, seconda ed., Napoli 1984.
GARBINI 1985: G GARBINI, Esploratori e mercanti non greci nel Mediterraneo
110
occidentale, in G Pugliese Carratelli (ed.), Magna Grecia. Prolegomeni, Milano 1985, 245-264.
GARBINI 1985a. G GARBINI, Scrittura fenicia nell'età del bronzo dell'Italia centrale, «PP» 225, 1985, 446-451
GARBINI 1988: G GARBINI, Convergenze indeuropee-semitiche tra preistoria e protostoria, «AION», 10, 1988, 67-80.
GARBINI 1988a. G GARBINI, Il semitico nordoccidentale. Studi di storia linguistica, Roma 1988.
GARBINI 1989· G GARBINI, Innovazione e conservazione nelle lingue semitiche, in Innovazione e conservazione nelle lingue. Atti del Convegno della S.I.G (Messina 9-11 nov 1989), Pisa, Giardini, 1991, 113-125.
GARBINI 1991 G GARBINI, I Fenici e la prima Etruria, in Miscellanea etrusca e italica in onore di M. Pallottino, I, Roma 1991, 261-267
GEROLA 1942: B. GEROLA, Substrato mediterraneo e latino, «Studi Etruschi» 16, 1942, 345-368.
GEW· H. FRISK, Griechisches etymologisches Worterbuch, Heidelberg 1960-1970.
GIANNELLI 1938: G GIANNELLI, Roma tìf:{l'età delle guerre puniche, Bologna 1938.
GoNZALES WAGNER 1984: E. C. GoNZALES WAGNER, El comercio punico en el Mediterraneo a la luz de una nueva interpretacion de Los tratados concluidos entre Roma y Carthago («Memorias de Historia Antigua» VI), Oviedo 1984.
GRAs 1985: M. GRAs, Trafics tyrrhèniens archai"ques, Rome 1985 GRATWICK 1971 A. S. GRATWICK, Hanno's Punic Speech in the Poenulus of
Plautus, «Hermes», 99, 1971, 25-45 GRoTIANELLI 1988: C. GRoTIANELLI, Of Goods and Metals. On the Economy
of Phoenician Sanctuaries, «Scienze dell'Antichità. Storia, archeologia, antropologia» 2, 1988, 243-255.
GULLETIA 1987· M. I. GuLLETIA, Monete e vasi. esempi di interferenze lessicali, in «ASNP», 17, 1987, pp. 959-969
HALFF 1963: G HALFF, L'onomastique punique de Carthage. Réperoire et commentaire, «Karthago», 12, 1963-64, 63-146.
HANDEL 1932: J HANDEL, Graeco-Semitica. Substantiva Graeca in -aç terminantia cum vocibus semiticis comparata, «Eos» 34, 1932, 183-193.
HAPP 1963: H. HAPP, Zur spiitromischen Namengebung, «BNF», 14, 1963, 20-62.
HARDEN 1971 D HARDEN, The Phoenicians2, Harmondsworth 1971.
HARRIS 1936: Z. S. HARRIS, A Grammar of the Phoenician Language, New Haven 1936.
HARRIS 1939· Z. S. HARRIS, Developmentofthe Canaanite Dialects, New Haven 1939
HEILMANN 1949· L. HEILMANN, Camita-semitico e indoeuropeo. Teorie e orientamenti, Bologna 1949.
111
HEHN 1911. V HEHN, Kulturpflanzen und Haustiere in ihrem Ubergang aus Asien nach Griechenland und Italien, Berlin 1911.
HERZOG 1897): R. HERZOG, Namenilbersetzungen und Verwandtes, «Philologus», 56, 1897, 33-70.
HEURGON 1969: J HEURGON, Rome et la Meditérranée occidentale jusqu'aux guerres puniques, Paris 1969. Trad. it. Il Mediterraneo occidentale dalla Preistoria a Roma arcaica, Bari 1972.
IEW· J PoKORNY, Indogermanisches etymologisches Worterbuch, BernMiinchen 1959-69
ILEVBRARE 1970: J A. ILEVBRARE, Language and the Process of Cultura[ Assimilation in Ancient North Africa, in «Nigeria and the Classics», 12, 1970, 80-85.
JEAN-HOFTIJZER 1985: J C. JEAN-J HoFTIJZER, Dictionnaire des inscriptions sémitiques de l'ouest (= D1so), Leiden 1965.
JURET 1942: A. JuRET, Dict. étymol. grec et latin, Macon 1942. KAHRSTEDT 1912: U KAHRSTEDT, Phoenikischer Handel an der italischen
Westkiiste, «Klio» 12, 1912, 461-73. KAJANTO 1963: I. KAIANTO Onomastic Studies in the Early Christian Inscrip
tions of Rome and Carthage, Helsinki 1963. KAIANTO 1968: I. KAIANTO, The Significance of non-Latin Cognomina, «La
tomus» 27, 1968, 517-34. KRAHMALKOV 1970: CH. KRAHMALKOV, The Punic Speech of Hanno, «Or» 39,
1970, 52-74. LAZZARINI 1973: M. L. LAZZARINI, I nom~ dei vasi greci nelle iscrizioni dei
vasi stessi, «Archeologia classica» 25-26~ 1973-74, 341-375. LEUMANN-HOFMANN-SZANTYR: M. LEUMANN, J B. HOFMANN, A. SZANTYR,
Lateinische Grammatik. Band 1. M. LEUMANN, Lateinische Laut- und Formenlehre, Miinchen, Beck, 1926-285
, Neuausg. 19772 Band2 · G B. HoFMANN, Lateinische Syntax und Stilistik, neubearbeitet von A. Szantyr, Miinchen, Beck, 1965, verb. Nachdr 1972. Band 3: Stellenregister und Verzeichnis der nichtlateinischen Worter, Miinchen, Beck, 1979.
LEVIN 1971. S. LEVIN, The Indo-European and Semitic languages. an exploration of structural similarities related to accent, chiefly, in Greek, Sanskrit and Hebrew, Albany 1971.
LEVIN 1975: S. LEVIN, The Indo-European and Semitic languages: a Reply to Oswald Szemerényi, «Glotta» 15/4, 1975, 197-205.
LEVIN 1977· S. LEVIN, Greek Occupational Terms with Semitic Counterparts, in Paleontologia linguistica. Atti del VI Convegno Internazionale di Linguisti (Milano, 2-6 sett. 1974), Brescia 1977, 175-180.
LEW· A. WALDE, G B. HoFMANN, Latenisches etymologisches Worterbuch, Heidelberg 1906, 19654
LEWY 1895: H. LEWY, Die semitischen Fremdworter im Griechischen, Berlin 1895 (rist. 1970).
LoMBARDO 1957· L. LOMBARDO, Isoglosse greco-sanscrite di origine anaria, «RIL» 91, 1957, 223-263.
112
MACCARRONE 1938-1939: N MACCARONE, Contatti lessicali mediterranei, .«AGI» 30, 1938, 120-131, 31, 1939, 102-113.
MADDOLI 1980: G MADDOLI, Contatti antichi del mondo latino col mondo greco, in Alle origini del latino. Atti del Convegno SIG (Pisa 7 e 8 dic. 1980), Pisa 1982, 43-64.
MANCINI 1990: M. MANCINI, Aspirate greche e geminate latine, Roma 1990. MANCINI 1992: M. MANCINI, L'esotismo nel lessico italiano, Roma 1992. MANNI 1973: E. MANNI, Roma e l'Italia nel Mediterraneo antico, Torino 1973. MARTELLI 1984: M. MARTELLI, Per il dossier dei nomi etruschi di vasi. una
nuova iscrizione ceretana del VII sec. a. C., in «Bollettino d'arte del Ministero per i beni culturali e ambientali» 27, 1984, 49-54.
MARTINO 1986: p MARTINO, Arbiter, Roma 1986. MARTINO 1987· P MARTINO, Il nome etrusco di Atlante, Roma 1987 MARTINO 1988: P MARTINO, Un semitismo antico nel greco: ~Qa~Évç, «SSL»
28, 1988, 231-253. MASSON 1967· E. MASSON, Recherches sur les plus anciens emprunts sémiti
ques en grec, Paris 1967 MAssoN 1969· O. MASSON, Recherches sur les Phéniciens dans le monde hellé
nistique, «BCH», 93, 1969, 679-700. MAssoN 1986: M. MASSON, A propos des critères permettant d' établir l'origine
sémitique de certains mots grecs, in «GLECS» 24-28/2, 1979-84 (1986), pp. 189-231
MAssoN-SZNYCER 1972: O. MASSON, M. SzNYCER, Recherches sur les Phéniciens à Chipre, Genève-Paris 1972.
MASTRELLI 1970: C. A. MASTRELLI, Correnti mediterranee nella terminologia del governo del timone, «BALM» 10-12, 1970, 11-21
MAYER 1960: M. L. MAYER, Gli imprestiti semitici in greco, «Rend. Ist. Lombardo, cl. Lettere», 94, 1960, 311-351.
MAYER 1960a. M. L. MAYER, Richerche sul problema dei rapporti fra lingue indoeuropee e lingue semitiche, «Acme» 13, 1960, 77-100.
MAYER 1961. M. L. MAYER, Note etimologiche I, «Acme» 14 1961, 231-236. MAYER 1964: M. L. MAYER, Note etimologiche III, «Acme», 17, 1964, 223-9. MAYER MODENA 1967· M. L. MAYER MODENA, Note etimologiche IV, «Acme»
20, 1967' 287-291 MAzzARINO 1947· S. MAZZARINO, Tra Oriente e Occidente, Firenze 1947 MEILLET Esquisse: A. MEILLET, Esquisse d'une histoire de la langue latine,
Paris 1928 (1952 6a ed., 1966 rist. ). MrnA.Escu 1938: H. MrnA.Escu, La versione latina di Dioscoride, «Ephemeris
Dacoromana» (Annuario della Scuola Romena di Roma) 8, 1938, 298-348.
M0LLER 1911. H. M0LLER, Vergleichendes indogermanisch-semitisches Wi.irterbuch, Gottingen 1911.
MOMENTI 1988: Momenti precoloniali nel Mediterraneo antico. Atti del Convegno Internazionale (Roma 14-16 marzo 1985), Roma 1988.
113
MOSCATI 1964: S. MoscATI, An Introduction to the comparative grammar of the Semitic Languages. Phonology and Morphology, Wiesbaden 1964.
MOSCATI 1966: S. MOSCATI, Il mondo dei Fenici, Milano 1966. MoscATI 1971. S. MoscATI, Tra Cartagine e Roma, Milano 1971 MoscATI 1973: S. MoscATI, Centri artigianali fenici in Italia, «Rivista di Studi
Fenici», 1, 1973, 37-52.
MOSCATI 1974: S. MoscATI, Problematica della civiltà fenicia, Roma 1974.
MOSCATI 1977· S. MOSCATI, I Cartaginesi in Italia, Milano 1977 MoscATI 1979: S. MoscATI, Le iscrizioni fenicio-puniche, in Le iscrizioni pre
latine in Italia (Atti dei convegni lincei, 39), Roma 1979, 45-55.
MoscATI 1988: S. MoscATI, Dimensione tirrenica, «Rivista di studi Fenici» 16, 1988, 133-44.
MoscATI 1993: S. MoscATI, Nuovi studi sull'identità fenicia, «Mem. Ace. Lincei» s. 9, vol. 4, fase. 1, 1993, 3-89
MowAT 1869· R. MowAT, De l'element africain dans l'onomastique latine, «RA», 1, 1869, 233-256.
MOLLER 1877· A. MOLLER, Semitische Lehnworte im alteren Griechisch, «BB» 1, 1877, 273-301
Muss-ARNOLT 1892. W Muss-ARNOLT, On Semitic Words in Greek and Latin, «Transactions of the American Philological Association» 23, 1892, 35-157
NADJO 1989: L. NADJO, L'argent et /es affaires à Rome des origines au Ile siècle av. J -C. étude d'un vocabulaire téchnique, Paris, Peeters, 1989.
NEIMAN 1966: D NEIMAN, Carchedon ='New City', «JNES» 25, 1966, 42-47 NENCIONI 1939· G NENCIONI, Innovazioni africane nel lessico latino, «Studi
Italiani di Filologia Classica» N.S. 16, 1939, 3-50. NEUMANN 1961 G NEUMANN, Weitere mykenische und minoische Gefiisser
namen, «Glotta» 39, 1961, 172-78. PALLOTTINO 1963: M. PALLOTTINO, Les relations entre /es Étrusques et Cartha
ge du VIr au IIr siècle avant J C., «Cahiers de Tunisie» 44, 1963, 23-29 PALLOTTINO 1984: M. PALLOTTINO, Storia della prima Italia, Milano 1984. PECKHAM 1968: J B. PECKHAM, The Development of the Late Phoenician
Scripts, Harvard Semitic Series, vol. XX, Cambridge 1968. PERUZZI 1970: E. PERUZZI, Origini di Roma, I, Bologna 1970. PERUZZI 1973: E. PERUZZI, Origini di Roma, II, Bologna 1973. PERUZZI 1978: E. PERUZZI, Aspetti culturali del Lazio primitivo, Firenze,
Olschki (Accademia Toscana La Colombaria. Serie Studi, 47), 1978. PERUZZI 1980: E. PERUZZI, Mycenaeans in Early Latium, Roma 1980. PISANI 1938: V PISANI, L'unità culturale indo-mediterranea anteriore all'av
vento di Semiti e Indeuropei, in Scritti in onore di Alfredo Trombetti, Milano 1938, 199-210.
PISANI 1959· V PISANI, Indeuropeo e camita-semitico, in «AION» 3, 1949, 333-339; poi in Saggi di linguistica storica, Torino 1959, 71-78.
114
PISANI 1959a. V PISANI, Kleinasiatische Worter und Laute in Griechischen und Lateinischen, «Die Sprache» 5, 1959, 143-151
PISANI 1962: V PISANI, Storia della lingua latina, 1. Le origini e la lingua letteraria fino a Virgilio e Orazio, Torino 1962.
PISANI 1966: V PISANI, Relitti "indomediterranei" e rapporti greco-anatolici, «AION-L», 7, 1966, 41-51
PROSDOCIMI 1976: A. L. PROSDOCIMI, Il conflitto delle lingue. Per una applicazione della sociolinguistica al mondo antico, in La Magna Grecia nell'età romana. Atti del XV Conv di studi sulla Magna Grecia (Taranto, 5-10 ott. 1975), Napoli 1976, 139-221
PYRGI 1981. Die Gottin von Pyrgi. Archiiologische, linguistische und religionsgechichtliche Aspekte. Akten des Kolloquiums zum Thema (Tiibingen, 16-17 Januar 1979), 1981
RIBEZZO 1950: F RIBEZZO, Sulla originaria unità linguistica e culturale del/' Europa mediterranea, in Atti del I Congr intern. di Preistoria e Protostoria mediterranea (Firenze-Napoli-Roma 1950), Firenze 1950.
R6LLIG 1980: W R6LLIG, Das Punische im Romischen Reich, in Die Sprachen im Romischen Reich der Kaiserzeit (Kolloquium vom 8. bis 10 April 1974), Koln-Bonn 1980, 283-299.
RosÉN 1979· H. B. RosÉN, L'hébreu et ses rapports avec le monde classique. Essai d' évaluation culture/le, Paris 1979
RuozzI SALA 1974: S. M. RuozzI SALA, Lexicon nominum Semiticorum quae in papyris Graecis in Aegypto repertis ab anno 323 a. Ch. n. usque ad annum 70 p. Ch. n. laudata reperiuntur (Testi e Documenti per lo studio dell'Antichità, 46), Milano 1974.
SALONEN 1974: E. SALONEN, Uber einige Lehnworter aus dem Nahen Osten im Griechischen und Lateinischen, «Arctos» 8, 197 4, 139-144.
SAN NICOLÒ 1932: M. SAN NICOLÒ, Parerga Babylonica I. Zum vorderasiatischen Ursprung des griechischen ÙQQa~c.Ov, «Archiv Orientalni» IV 1932, 34-38.
ScHIFMAN 1964: I. SCHIFMAN, Die phonikische Kolonisation des westlichen Mittelmeeres, «Das Altertum» 10, 1964, 195-201
SCHMIEDT 1965: G SCHMIEDT, Antichi porti d'Italia, «L'Universo» 45, 1965, 225-274.
ScHRODER 1869: P ScHRODER, Die phOnikische Sprache, Halle 1869 SEGERT 1976: ST SEGERT, A Grammar of Phoenician and Punic, Miinchen
1976. SERRA. 1953: G SERRA, Appunti sull'elemento punico e libico nell'onomastica
sarda, in «Vox Romanica» 13, 1953, pp. 51-65. SERRA 1960: G SERRA, L'action du substrat lybique sur la structure des mots
de la langue sarde, «Orbis» 9, 1960, 404-18. SILVESTRI 1974: D SILVESTRI, La nozione di indomediterraneo in linguistica
storica, Napoli 1974. SILVESTRI 1977, 1979, 1982: D SILVESTRI, La teoria del sostrato. Metodi e
miraggi, l-3, Napoli 1977, 1979, 1982.
115
STOLZ-DEBRUNNER-SCHMID 1973: F STOLZ, A. DEBRUNNER, w p SCHMID, Geschichte der lateinischen Sprache, Berlin 1966; ed. it. Storia della lingua latina, Bologna 1973, 3a ed.
SzEMERÉNYI 1964: O. SzEMERÉNYI, Structuralism and Substratum. IndoEuropeans and Semites in the Ancient Near East, «Lingua» 13, 1964, 1-29
SzEMERÉNYI 1968: O. SzEMERÉNYI, Ree. a Masson 1967, in «IF» 73, 1968, 192-97
SzEMERÉNYI 1971. O. SzEMERÉNYI, Ree. a DELG, in «Gnomon» 43, 1971, 573.
SzEMERÉNYI, (1974), O. SzEMERÉNYI, The Origins of the Greek Lexicon. ex Oriente Lux, «The Journal of Hellenic Studies» XCIV 1974, 144-157
SZNYCER 1967· M. SzNYCER, Les passages puniques en transcription latine dans le «Poenulus» de Plaute, Paris 1967
ToMBACK 1978: R. S. TOMBACK, A comparative semitic lexicon of the Phoenician and Punic languages, Missoula, Montana 1978.
TouTAIN 1896: J TouTAIN, Les cités romaines de la Tunisie, Paris 1986, pp. 167-196.
TusA 1971 V TusA, L'espansione fenicia nel Mediterraneo, Roma 1971 TusA 1974: V TusA, La civiltà punica, in Popoli e civiltà dell'Italia antica,
III, Roma 1974, 9-107 TusA CuTRONI 1974: A. TusA CuTRONI, Monetazione punica e sua circolazio
ne nell'Italia antica, in Popoli e civiltà dell'Italia antica, III, Roma 1974, 109-120.
V ANICEK 1878: A. VANICEK, Fremdworter im Griechischen und Lateinischen, Leipzig 1878.
VATTIONI 1968: F VATTIONI, S. Agostino e la civiltà punica, «Augustinianum» 8, 1968, 434-467
VATTIONI 1976: F VATTIONI, Glosse puniche, «Augustinianum» 16, 1976, 505-555.
VATTIONI 1977· F VATTIONI, Onomastica punica nelle fonti latine nordafricane, «Studi Magrebini» 9, 1977, 1-7
VATTIONI 1979: F VATTIONI, Antroponimi fenicio-punici nell'epigrafia greca e latina nel Nordafrica, «AION-Archeologia e storia antica» I, 1979, 153-191
WAGNER 1953: M. L. WAGNER, Die Punier und ihre Sprache in Sardinien, «Sprache» 3, 1954, 27-43, 78-109.
WARD 1963: W A. WARD, Notes on Some Semitic Loan-Words and Persona/ Names in Late Egyptian, «Orientalia» N.S. 32, 1963, 413-36.
WARD 1968: W A. WARD, The Role of the Phoenicians in the Interaction of Mediterranean Civilizations, Beirut 1968.
WEINREICH 1974: U WEINREICH, Languages in Contact. Findings and Problem, New York 1953; ed. it. a c. di G R. Cardona, Lingue in contatto, Torino 1974.
WEiss 1966: H. J WEiss, Zum Problem der Fremd- und Lehnworter in den Sprachen des christlichen Orients, «Helikon» 6, 1966, 183-209.
116
WILL 1972: E. WILL, Le monde grec et l'Orient. Le V"me siècle, Paris 1972. W6LFFLIN 1889· E. WoLFFLIN, Die ersten Spuren des afrikanischen Lateins,
«ALL» 6, 1889 , 1-7 WUTHNOW 1930: H. WuTHNOW, Die semitischen Menschennamen in griechi
schen Inschriften und Papyri des vorderen Orients, Leipzig 1930. YoYOTTE 1960: J YoYOTTE, Remarque sur le nom du "gage", «GLECS» 8,
1957-60, 24. ZuccKER 1943: F ZuccKER, Semitische Namen auf den neugefundenen In
schriftstelen van Minturnae, «Hermes» 78, 1943, 200-204.
117
RESOCONTO DELLA DISCUSSIONE (Sabato 6 novembre)
Relazioni di H. Rix, P. Martino, D. Silvestri
A. L. PRosnoc1M1: [Nell'intervento ho divagato; qui presento il succo del divagare]. Spesso Domenico Silvestri cifa spaziare per aree e tempi inusuali; questa volta ci ha proposto qualcosa di planetario (o quasi): Sono affascinato dal tema che implica la monogenesi delle lingue, e ne è testimone un mio articolo su 'lingua e preistoria' (A. L. Prosdocinii, Lingua e preistoria. Appunti di lavoro, in Philias Charin. Miscellanea in onore di Eugenio Manni, Roma 1979, pp. 1833-1890): ci tengo molto, forse come i padri tengono ai figli meno fortunati, e conto di tornarci. Lì trattavo in termini speculativi dell'origine del linguaggio umano entro i sistemi segnici; come si vede non sono alieno dalle avventure e dalla fantascienza; lo sono quando riconosco un'impronta che definirei 'americana' (è una qualifica di mentalità, non di geografia). Non voglio insistere su questo, che è più una questione di gusto, se non per un lato intrinseco al nostro tema: la provabilità dì ciò che si afferma in termini appropriati. Tra la provabilità di parentela in senso boppiano (e restrittivamente: non del Bopp delle parentele lontane) e la provabilità degli orizzonti proposti esiste un abisso - col che non si vuol dire che tutto non abbia una propria legittimità, solo che è una legittimità che non va confusa o mescolata con altra di altro tipo. Per i miei gusti oltre un certo livello di lontananza linguistica di spazi, tempi, società, il discorso non può essere fattuale ma speculativo, dove 'speculativo' è qualifica positiva, se ben applicato, perchè il solo appropriato.
D. SILVESTRI: In margine alla relazione di Martino, che mi sembra ricca e puntuale, mi limiterò a porre il problema di eventuali lingue tramiti del passaggio di termini semitici in latino. In molti casi, ovviamente, si tratta di trasmissione diretta; ma altre volte può esserci stato un tramite greco (se non addirittura etrusco). Ma esiste anche un'altra prospettiva, che ci proietta su un piano cronologico più antico: la possibilità dell'affioramento, sia in latino sia in lingue semitiche, di termi- · ni del cosiddetto «sostrato mediterraneo». Con questo non voglio riaprire vecchie questioni, ma sottolineare soltanto che i fenomeni di interferenza linguistica protostorica vanno sottratti alla tentazione di visioni unidimensionali ed unidirezionali.
A Rix, che è un Maestro nel campo della linguistica etrusca, oltre ai ringraziamenti e complimenti dovuti per la sua relazione, vorrei solo dire che per me il nome nazionale degli Etruschi (tipo TURS/TRUS) va riesaminato, sulla base della commutazione dei morfi derivativi (N/
173
K, cfr. Turs[a]n[oi]l[E]trusci, Tu[r]sci), nel quadro di presumibili fenomeni di autonimia (opzione N o «etrusca») e di eteronimia (opzione K o «sabino-latina»). Penso, in tal senso, al caso parallelo di Velzna-1 Volsci ed all'azzeramento dell'opzione in Olsoi, che ritorna per altro anche * Etrusia>Etruria) e penso anche alla possibilità di riconnettere in tal senso Aus[o]ni ed Osci (Opscus di Ennio, Annali in Festus 234,29 ha tutta l'aria di ricostruzione paraetimologica dotta) . .
1: DE Hoz: Al prof. Martino, una propuesta sobre una posible fuente de elementos punicos en su segunda fase, época final de la Republica. Los ultimos descubrimientos epigraficos en el Sur de Espada demuestran que el punico no ha desaparecido alli antes de la época imperial. Los Balbos sabemos que en familia hablaban punico, y por otra parte los romanos recibieron form.as de administraci6n de las minas y agricolas que eran punicas y ofrecian cauces para los préstamos .
. Al profesor Rix, respecto al texto de Pech Maho me parece probable que la presencia del texto etrusco se explique por la presencia de mercaderes etruscos en la zona. En el texto griego se habla de Èv aQd}µtj'l, «en moneda». En esa época yen el Sur de Francia la referencia puede ser a las monedas tipo Auriol. Estas monedas aparecen s6lo en tres ionas: 1) las proximidades de Ampurias - Ampurias que es mencionada en el texto grjego corno lugar de origen de la mercancia, 2) las proximidades de Marsella, 3) Etruria fondamentalmente en torno a Volterra. Otra observaci6n, escéptica en la misma linea del prof. Rix, respecto a la conexi6n egipcia. Hoy dia algunos investigadores, pero reitero mi escepticismo, volverian a favorecer otra alternativa para relacionar a los tursha; Cat6n menciona en el Sur de Espafia un toponimo Turta, Polibio recogi6 de un tratado romano-cartaginés la menci6n de Mastia Tarseion, y recientemente han aparecido en Andalucfa los primeros fragmentos de ceramica micénica, micénica final, III C, en la Peninsula Ibérica. Ahora algunos arque6logos estan replanteando los elementos orientales del final de la Edad del Bronce andaluza y creen en la posibilidad de conexiones con el Egeo.
P. MARTINO: Al prof. Prosdocimi vorrei dire che ho considerato i risultati degli studi di Coarelli e di altri sul Foro romano arcaico, special·mente sul Foro boario dell'VIII secolo, per ambientare possibili semitismi in un contesto plurilinguistico di scambi in cui è accertata la presenza di Fenici e Cartaginesi. Presenze alloglotte potrebbero individuarsi in connotazioni particolari di voci latine: if Poenulus plautino non va tradotto 'cartaginese'' ma piuttosto 'cartaginesuzzo' (come ha fatto Ettore Paratore), avendo valenza sociolinguistica di ipocoristico. Ed è interessante il possibile rapporto con la forma epigrafica puine/ di cui ha parlato poco fa il prof. Rix. Ringrazio il prof. Silvestri per le sue
174
osservazioni. Sono persuaso che le lingue «franche» abbiano un ruoìo nel recupero e nella diffusione di termini antichi e possono essere veicolo, diciamo fonte immediata, di elementi di sostrato. Capisco che il problema è molto complesso. Mi rendo conto poi dell'importanza, in questo contesto, del latino-punico dell'Africa ma anche della Spagna. · Al prof. Peruzzi, che ringrazio, vorrei ribadire la mia convinzione che ogni ipotesi etimologica deve certo fondarsi su dati linguistici, ma ha bisogno anche di un persuasivo ambientamento culturale. Nel testo scritto della mia relazione, che ho qui abbreviato per motivi di tempo, accenno alla presenza di un porto denominato Punicum a pochi chilometri a nord di Pyrgi. Quanto ad arbiter, non posso offrire qui tutti i dati che ritengo significativi e ché si trovano esposti nei lavori citati. Nel ~iritto romano l'arbiter non è, certo, un garante nel senso giuridico. E però personaggio inizialmente estraneo al diritto, ed anche dopo la sua comparsa nel diritto pretorio delle legis actiones, opera sempre extra ius, come un mediatore richiamandosi costantemente all'aequum bonum, non alla /ex. Indubbiamente le sue funzioni cambiano con il tempo. Cambiano strutturalmente, radicalmente, una volta che la funzione stragiuridica viene inquadrata nel sistema giudiziario. Quanto alla formazione, anche qui troviamo (come in Carth-ago) un radicale adattamento morfolo_gico mediante il suffisso -ter che in latino conserva, com'è noto, un'antica funzione «equativa» indoeuropea ( cf. matertera 'simile alla madre'). L'ipotesi su suburra nasce dalla debolezza dell'etimologia vulgata, che è piuttosto cervellotica quanto alla formazione e postula «ammasso di sabbia» come nozione semantica originaria per il termine tecnico. Non mi risulta che la radice semitica *~br assuma, nelle sue attestazioni antiche, il significato tecnico di «zavorra»; ma questo non invalida a mio avviso l'ipotesi: la forma semitica designa infatti un 'ammassare materiali', non solo sabbia, che è poi il nucleo fondamentale del concreto di 'zavorra', che ho riportato al lessico nautico fenicio. Le attestazioni della radice in fenicio-punico, ugaritico, ebraico biblico, a~amaico o sono senza contesto o non presentano un termine tecnico nautico. Ma le specializzazioni tecniche sono di regola sviluppi secondari. Ad ogni modo, nulla dal punto di vista fonetico si opporrebbe a che un semitico *~abiir, nelle lingue di N.O. ~abor 'ammassar~ materiali', fosse morfologizzato e accolto come saburra in latino. E un'ipotesi da valutare.
M. NEGRI: Il motivo principale per cui ho chiesto subito di parlare è che ho sentito il desiderio di rallegrarmi con.Domenico Silvestri per questa splendida relazione. Però, per pagarmi questo piacere, devo anche dire qualcosa di specifico. Dunque, vi inviterei a rivedere quella bella cartina in seconda pagina dove ci sono i punti «amministrativi» che sono stati rilevati nel Mediterraneo. Noterete che Lerna è, e giu-
175