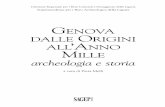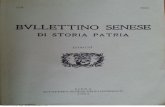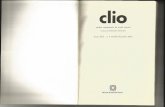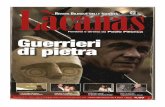«Del Cimiterio de gli antichi Hebrei». La catacomba ebraica di Monteverde nel IV centenario della...
-
Upload
studiromani -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of «Del Cimiterio de gli antichi Hebrei». La catacomba ebraica di Monteverde nel IV centenario della...
STUDI ROMANIR I V I S T A T R I M E S T R A L E D E L L ’ I S T I T U T O N A Z I O N A L E D I S T U D I R O M A N I
O N L U SDIREZIONE E AMMINISTRAZIONE
00153 ROMA - PIAZZA DEI CAVALIERI DI MALTA N. 2 - TELEFONO 06/574.34.42/5 - Fax 06/574.34.47www.studiromani.it
e-mail: [email protected]
ANNO LI - NN. 1-2 GENNAIO-GIUGNO 2003
S O M M A R I O
MARCO SBARDELLA: Le origines catoniane: Ipotesi di datazione, intitolazione, struttura 3
MASSIMILIANO GHILARDI: «Del cimiterio de gli antichi hebrei». La catacomba ebraica diMonteverde nel IV centenario della scoperta . . . . . . . . . . . . 15
SIMONA BENEDETTI: Progetti e realizzazioni nel cortile del palazzo dei Conservatori inCampidoglio (con 12 tav. f.t.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
FEDERICO DE MARTINO: Profilo di Anastasio Fontebuoni (con 12 tavv. f.t.) . . . 71
ISABELLA DE STEFANO: Quaranta anni di studi sulla pittura del Settecento a Roma (con4 tavv. f.t.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
GIUSEPPE IANNACCONE: L’alienata euforia. La malattia di Roma negli scritti di AnnaMaria Ortese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
FRANCO MARTINELLI: La Venere di Cirene al Museo Nazionale delle Terme. Afroditeattraverserà le acque? (con 2 tavv. f.t.) . . . . . . . . . . . . . . 135
Membri dell’Istituto scomparsi — UMBERTO LEVRA: Ricordo di Filippo Mazzonis . . . 140
R A S S E G N E
LANDO SCOTONI: Studi geografici — CRISTIANA RINOLFI: Diritto romano — GIULIA PIC-CALUGA: Religione romana — FILIPPO CANALI DE ROSSI: Storia romana antica —MARCO DE NICOLO: Storia del Risorgimento — MARCO DE NICOLO: Storia contem-poranea — PIETRO SAMPERI: Territorio, città, monumenti — FRANCO MARTINELLI:Sociologia e ricerca sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
C R O N A C H E
ELEONORA PELLEGRINI - MARCO DE NICOLO - VALERIA G. A. TAVAZZI - MARIA D’ALESIO
- MARIA LUISA GIAMPIETRO: Vita culturale (coordinatore FERNANDA ROSCETTI) —DARIO REZZA - SERENA TERRACINA - MARIO CIGNONI - ABDUL HADI PALAZZI: Vitareligiosa — MARIA D’ALESIO: Mostre d’arte — GIOVANNI ANTONUCCI: Il teatro —RAOUL MELONCELLI: La musica . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Vita dell’Istituto Nazionale di Studi Romani: Corpo Accademico e organi direttivi al 30giugno 2003. — Assemblee dei Membri — Il conferimento del Premio «Cultori diRoma » — Il «Certamen Capitolinum»: l’esito del LIIII concorso e il bando del LV— Il LXXVII anno accademico dei Corsi — Nuove pubblicazioni (FERNANDA
ROSCETTI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
In copertina: Il chiostro dell’ex convento di S. Alessio sede dell’Istituto (disegno di A. TAMBURLINI)
ABBONAMENTO 2003: € 25,82 (estero € 36,15)UN NUMERO SEPARATO: € 15,49 (estero € 26,86)
L’abbonamento decorre dal primo fascicolo dell’annata - Per le rimesse in denaro effettuare iversamenti sul c.c.p. n. 25770009 intestato all’Istituto Nazionale di Studi Romani.
Spedizione in abbonamento postale - 45% art. 2 comma 20/b L. 662/96 - Roma
« DEL CIMITERIO DE GLI ANTICHI HEBREI».
LA CATACOMBA EBRAICADI MONTEVERDE NEL
IV CENTENARIO DELLA SCOPERTA *
L 31 MAGGIO 1578, fuori Porta Salaria, nella vigna di proprietà diI Bartolomeo Sanchez, come è noto nella storia degli studi, cavato-ri di pozzolana rinvennero accidentalmente alcune gallerie di un an-tico complesso cimiteriale ipogeo cristiano. La data esatta della sco-perta di tale catacomba, oggi denominata «Anonima di via Ana-po » (1), ci è nota da un breve passaggio della monumentale opera di
* Desidero ringraziare per la cortese disponibilità e per i numerosi e preziosi consigliche hanno avuto la gentilezza di offrirmi i professori Mario Mazza e Andrea Giardina.
(1) Al momento del rinvenimento si credette di aver riportato alla luce il cimitero diPriscilla e tale denominazione rimase nella storia degli studi sino all’età del de Rossi, che ri-tenne, invece, le gallerie scoperte accidentalmente nel 1578 parte del coemeterium Iordano-rum (G. B. DE ROSSI, Scoperte nell’arenaria tra i cimiteri di Trasone e dei Giordani sulla ViaSalaria Nuova, in «Bullettino di Archeologia Cristiana», IV [1873], p. 8), nonostante la pro-posta del Garrucci che vedeva in esse parte del cimitero di Trasone (R. GARRUCCI, Storia del-l’arte cristiana nei primi otto secoli della Chiesa, I-VI, Prato 1873-1881, I, p. 63). Nuovi dub-bi di attribuzione furono formulati da P. STYGER, Die römischen Katakomben. Archäologischeforschungen über der Ursprung und die Bedeutung der altchristlichen grabstätten, Berlino1933, p. 265, ma l’identificazione col cimitero dei Giordani rimase fino alla scoperta, nel1966, della tomba del martire Alessandro, che le fonti reiteratamente indicavano in coemete-rio Iordanorum, nella vicina regione catacombale di Villa Massimo (U. M. FASOLA, Le recentiscoperte nelle catacombe sotto Villa Savoia. Il « Coemeterium Iordanorum ad S. Alexan-drum », in Actas del VIII Congreso Internacional de Arqueologia Cristiana, Barcelona, 5-11octubre 1969, Città del Vaticano 1972, pp. 273-297). Da allora al cimitero è rimasta la deno-minazione «meno nobile, ma sicuramente più veritiera» (cfr. V. FIOCCHI NICOLAI, Storia e to-pografia della catacomba anonima di via Anapo, in Die Katakombe «Anonima di via Anapo».Repertorium der Malereien, a cura di J. G. Deckers - G. Mietke - A. Weiland, Città del Vati-cano 1991, p. 7) di «Anonimo di via Anapo», nonostante vada lamentata ancora oggi, a cir-ca trenta anni di distanza dal cambiamento di nome ed anche in sedi altamente scientifiche,la mancata ricezione di tale significativa nuova attribuzione.
16 MASSIMILIANO GHILARDI
Antonio Bosio (2) che, involontariamente, in tale frangente – moti-vando la ragione per cui non ebbe la possibilità di investigare perso-nalmente tali gallerie – ci fornisce un prezioso elemento autobiogra-fico, uno dei rari di tutto il suo impegnativo trattato, permettendocidi indicare nel 1575 il suo anno di nascita (3). La data della impreve-dibile scoperta, pur se fonti contemporanee sembrano essere menoprecise (4), è confermata da due celebri avvisi urbinati (5), conservatinella Biblioteca Vaticana, che, proprio per il loro particolare stile di-vulgativo, contribuiscono a documentare lo scalpore e l’interesse su-scitato; il primo avviso, pubblicato alla vigilia della festa dei santiPietro e Paolo dello stesso anno, permette di comprendere l’interes-samento e il riconoscimento ufficiale delle più alte gerarchie eccle-siastiche (6), mentre il secondo, redatto e reso pubblico il 2 agosto,mostra come la ricezione del ritrovamento nella società romana del-l’ultimo venticinquennio del XVI secolo fu elevatissima, tanto che,addirittura, le strutture di protezione approntate furono divelte per
(2) Cfr. A. BOSIO, Roma sotterranea, Roma 1632, p. 511: « facendosi alcune caue di poz-zolana, l’anno del Signore 1578. alli 31. di Maggio, s’aperse vna bocca di Cimiterio».
(3) Ibidem: «non fù da noi veduto, perche all’hora erauamo fanciulli, in età di tre anni,e dapoi fù rouinato, e guasto; in modo, che quando cominciammo ad attendere à quest’ope-ra; già il tutto era sottosopra, e coperto».
(4) O. PANCIROLI, Tesori nascosti dell’alma città di Roma, Roma 16252, p. 24, scrivendoin un momento in cui il cimitero era perduto (la prima edizione è, infatti, del 1600) e nonavendo fonti certe cui rivolgersi riferisce della scoperta del cimitero per l’anno 1590. Grego-ry Martin (1542-1582), religioso britannico che risiedette in Roma dalla fine del 1576 allaprimavera del 1578, redigendo in patria tra il 1580 ed il 1581 l’opera Roma Sancta riferì delrinvenimento per l’anno 1579: « the greatest Vault of al, was found of late an. 1579: ful ofdead bodies, with their monuments and superscriptions both Greke and Latin, almost a milewithout the gate Pinciana, estemed to be Coemiterium Priscillae. There are altars, and theimages of Christ and his Apostles, evident tokens of antiquitie, when the Christians in timeof persecution assembled into these vaults or Cryptes to divine service, and to burie theirdead ». Cfr. G. BRUNER PARKS, Gregory Martin. Roma Sancta, Roma 1969, p. 44.
(5) Si tratta, come noto, di corrispondenze pubbliche inviate da Roma alla corte ponti-ficia di Urbino; tali fogli sparsi, documenti di primaria importanza per la conoscenza dellavita quotidiana, furono in un secondo momento rilegati e tornarono in possesso della Biblio-teca Vaticana. Si veda J. A. F. ORBAAN, Documenti sul barocco in Roma, Roma 1920, pp.LIV-LXIV.
(6) Bibl. Vat. Lat. Urb. 1046, f. 256: «Di Roma li XXVIII di Giugno 1578. A Porta Sa-lara si è scoperto il cimiterio di santa Priscilla matrona Romana, doue, mentre visse, ragu-nò molti corpi S.ti fra quali Leonida Padre di Origene, et uno di gli Ap.li di Christo, et rico-nosciuto il luogo il Papa u’ha mandato il Card.le Sauello, il G.nle de’ Giesuiti, et Mons.rMarc’Ant.o Mureto».
« DEL CIMITERIO DE GLI ANTICHI HEBREI» 17
l’alto numero dei fedeli e curiosi accorsi sul luogo (7). Un ulterioredocumento manoscritto dell’età di Gregorio XIII, ricordando gli av-venimenti dell’anno 1578, offre la conferma del grande afflusso difedeli e visitatori ai sotterranei tornati in luce e la presenza di nume-rosi «periti dell’antighità» (8). L’entusiasmo provocato dall’impreve-dibile scoperta (9), che oggi potrebbe sembrare eccessivo, in realtà,deve giustificarsi con le condizioni storiche e sociali del tempo: i po-chi cimiteri antichi allora noti e frequentati, privi ormai di decora-zioni, offrivano una parziale visione del loro stato originario ai visi-tatori. Si trattava, infatti, di piccole aree visitate ininterrottamentedall’antichità e collegate con le basiliche suburbane, nelle quali icorpi dei santi titolari mai erano stati rimossi e portati dentro la cit-tà, come San Sebastiano, San Lorenzo, San Pancrazio, Sant’Agnese,San Valentino (10). La nuova catacomba rinvenuta intatta rivelò, inve-ce, un mondo impensato, un’altra Roma o, come si scrisse, una sub-terranea civitas (11) che, inserendosi nel delicato dibattito controrifor-mistico sulla Chiesa delle origini, avrebbe potuto offrire documenti
(7) Bibl. Vat. Lat. Urb. 1046, f. 302: «Vicino al Cimitero di S.ta Priscilla trouato li dipassati, si sono scoperti sotto terra alquanti Cappelletti, et Oratorij di stucco ornati con ua-ghissimi lauori, doue concorsi tutta Roma, rompindo li steccati fattili attorno per ord.e delCard.le Sauello».
(8) Bibl. Vat. Lat. Urb. 12214, f. 66: «Intorno all’istesso tempo fuori di Porta Salaria nelcavare la Pozzolana si trovò inspiratamente il famoso Cimiterio di Priscilla smarito sin daltempo de Gothi circondato da varie seppolture de Sacri Martiri con iscrittioni di lingue di-verse; mandovvici il Papa incontinente il Cardinal Savelli Vicario à certificarsi del tutto, et al-tri molti vi andarono periti dell’antighità, e fra l’altre cose degne di memoria dell’Ambascia-tore di Francia Luigi Castagnero, e da Marc Antonio Moretto, ambe due di grande eruditio-ne, fu riconosciuto il sepolcro di Leonida Padre d’Origine defonto già più d’anni mille, etrecento ».
(9) Cfr. H. V. SAUERLAND, De coemiterio D. Priscillae Romae invento in Canicularibusanno 1578, in «Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchenge-schichte », II (1888), pp. 209-214, ed il commento di G. B. DE ROSSI, ibidem, pp. 214-217.
(10) Cfr. V. FIOCCHI NICOLAI, Origine e sviluppo delle catacombe romane, in Le catacombecristiane di Roma. Origini, sviluppo, apparati decorativi, documentazione epigrafica, a cura diV. Fiocchi Nicolai - F. Bisconti - D. Mazzoleni, Regensburg 1998, pp. 9-69, partic. p. 9. Cfr.G. SEVERANO, Memorie sacre delle Sette Chiese di Roma. E di altri luoghi, che si trovano per lestrade di esse, Roma 1630, pp. 426-427: «si serrarono poi per quest’effetto li medesimi Cimi-terij; lasciandosene vna parte esposta alli Fedeli; doue dalle Chiese, ch’erano sopra di essi,entrandoui potessero sodisfare alla diuotione loro; come vediamo esser fatto nella Chiesamedesima di S. Sebastiano; in quella di S. Lorenzo fuori delle mura; & in quella di S. Pan-cratio: doue hanno continuato i Fedeli di andare».
(11) Cfr. C. BARONIO, Annales Ecclesiastici, I-XI, Roma 1588-1605, II, p. 59.
18 MASSIMILIANO GHILARDI
inoppugnabili (12) per combattere le «capziose argomentazioni» so-stenute senza fondamenti dalla parte protestante (13).
Tra i molti dotti, curiosi e fedeli accorsi vanno certamente ricor-dati, oltre al cardinale Giacomo Savelli, Segretario di Stato sottoGregorio XIII, menzionato negli editti sopra citati, il romano Pom-peo Ugonio (14), il futuro cardinale sorano Cesare Baronio (15), e so-prattutto il domenicano spagnolo Alfonso Chàcon (16) (meglio notocome Ciacconius) e il fiammingo Philippe de Winghe (17), che – dopoaver fatto ritrarre in acquerello le principali testimonianze pittoriche
(12) I cimiteri sotterranei, infatti, dovevano essere considerati «arsenali, donde si piglia-no le armi da combattere contro gli Eretici», come ci ricorda il padre oratoriano GiovanniSeverano in A. BOSIO, Roma sotterranea, cit., p. 6. Cfr. V. FIOCCHI NICOLAI, San Filippo Neri,le catacombe di San Sebastiano e le origini dell’archeologia cristiana, in San Filippo Neri nellarealtà romana del XVI secolo, Atti del Convegno di Studio in occasione del IV Centenariodella morte di S. Filippo Neri (1595-1995), 11-13 maggio 1995, a cura di M. T. BonadonnaRusso - N. Del Re, Roma 2000, p. 116.
(13) Cfr. A. D. WRIGHT, The Counter-Reformation. Catholic Europe and the Non-Chris-tian World, London 1982, p. 89. Le immagini dipinte nelle gallerie sotterranee, infatti, finiro-no per essere parte determinante nell’acceso dibattito religioso circa gli usi e i costumi dellaChiesa primitiva e non di rado furono utilizzate per scopi di catechesi; per il delicato feno-meno delle conversioni a Roma tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento si vedano inumerosi contributi presenti nel volume monografico Dall’infamia dell’errore al grembo diSanta Chiesa. Conversioni e strategie della conversione a Roma nell’età moderna, in «Ricer-che per la storia religiosa di Roma», X (1998). Per la riscoperta di Roma sotterranea cristia-na in prospettiva apologetica si vedano le recenti riflessioni di A. VAUCHEZ in Il mito di Ro-ma. Da Carlo Magno a Mussolini, a cura di A. Giardina - A. Vauchez, Roma-Bari 2000, pp.94-96.
(14) Per un rapido ritratto dell’Ugonio, professore di Eloquenza del Bosio all’Archigin-nasio, cfr. E. JOSI, s.v. Ugonio, Pompeo, in Enciclopedia Cattolica, XII, Roma 1954, p. 716.
(15) Cfr. C. BARONIO, Annales, cit., I, 460: cuius quide generis imagines complures inspexi-mus in antiquissimo Priscilla coemeterio via Salaria nuper refosso. Per le opere e la vita delcardinale sorano si veda quanto raccolto da A. PINCHERLE, s.v. Baronio, Cesare, in DizionarioBiografico degli Italiani, VI, Roma 1964, pp. 470-478.
(16) Per meglio conoscere la sua figura si vedano E. JOSI, s.v. Chacòn (Ciacconius), in En-ciclopedia Cattolica, III, Roma 1949, p. 1368; A. RECIO VEGANZONES, La «Historica DescriptioUrbis Romae», obra manuscrita de Fr. Alfonso Chacòn O.P. (1530-1599), Roma 1968 e ID.,Alfonso Chacòn. Primer estudioso del mosaico cristiano de Roma y algunos diseños chaconia-nos poco conocidos, in «Rivista di Archeologia Cristiana», L (1974), pp. 295-329.
(17) Cfr. G. J. HOOGEWERFF, Philips van Winghe, in «Mededelingen van het Nederlan-dsch historisch Instituut te Rome», VII (1927), pp. 59-82; E. JOSI, s.v. Winghe, Philips Van,in Enciclopedia Cattolica, XII, Roma 1954, pp. 1702-1703 e la più ampia e recente monogra-fia di C. SCHUDDEBOOM, Philips van Winghe (1560-1592) en het Onstaan van de christelijkeArcheologie, Groningen 1996.
« DEL CIMITERIO DE GLI ANTICHI HEBREI» 19
portate alla luce – riferirono poi ad Antonio Bosio, quando il cimi-tero era di nuovo inaccessibile, i particolari della scoperta, divulgatipiù tardi nella Roma sotterranea (18). Perduto il monumento per unafrana causata dai cavatori di pozzolana, come il Bosio stesso ci in-forma (19), nei più l’interesse ben presto si spense, ma per un piccolonumero di eruditi la scoperta costituì, invece, l’incentivo a ricercarealtri cimiteri sotterranei, a ricopiarne le immagini affrescate (20) o in-cise ed a trascriverne le iscrizioni (21).
Alla morte del de Winghe, prematuramente scomparso poco piùche trentenne a Firenze nel 1592, il diciassettenne Antonio Bosioereditò le copie delle pitture da lui fatte eseguire nelle catacombe econ esse certamente il desiderio e la passione irrefrenabile per le an-tichità cimiteriali sotterranee paleocristiane; fu così che, a partiredall’anno successivo, il giovane studioso, di probabili natali malte-si (22), cominciò a frequentare le gallerie ipogee della campagna roma-
(18) Cfr. A. BOSIO, Roma sotterranea, cit., pp. 511-530.(19) Nonostante gli ‘‘ steccati ’’ e la grande risonanza che la scoperta meritatamente ebbe,
si continuò ad utilizzare l’area come cava di materiale edilizio e, come Bosio ci dice (Romasotterranea, cit., p. 513) « fù il Cimiterio finito di rouinare da’ cauatori; i quali ancor’essi nonandarono impuniti: percioche mentre l’andauano guastando, cadde sopra di loro tanta terra,che rimasero estinti ». Dimenticate le gallerie per quasi trecentocinquanta anni, tornarononuovamente alla luce il 15 dicembre del 1921, per intuito di Enrico Josi, allora ispettore del-la Commissione di Archeologia Sacra, che decise di calarsi nei cavi di fondazione di alcunifabbricati in corso di edificazione ad opera della Cooperativa ‘‘Voluntas et Labor ’’ all’angolotra via Salaria e via Anapo. Per le notizie del ritrovamento moderno e per una prima descri-zione delle gallerie, in cui si riconobbero le pitture pubblicate da Bosio (ma che questi, comedetto, non aveva avuto modo di ammirare), si vedano i contributi di E. JOSI, Note di topogra-fia cimiteriale romana. I. Il ‘‘ coemeterium Iordanorum’’ sulla via Salaria nova, in «Studi Ro-mani », III (1922), pp. 49-70; ID., Relazione del ritrovamento della regione scoperta il 31 mag-gio 1578 sulla via Salaria nuova, in «Nuovo Bullettino di Archeologia Cristiana», XXVIII(1922), pp. 120-128; V. FIOCCHI NICOLAI, Storia e topografia, cit., pp. 6-7.
(20) Cfr. U. UTRO, Disegni degli affreschi della catacomba di via Anapo, in Aurea Roma.Dalla città pagana alla città cristiana, a cura di S. Ensoli - E. La Rocca, Roma 2000, pp.513-514.
(21) Cfr. G. WATAGHIN CANTINO, Roma sotterranea. Appunti sull’origine dell’Archeologiacristiana. Roma nell’anno 1600, in «Ricerche di Storia dell’arte», X (1980), pp. 5-14.
(22) Per conoscere più da vicino la sua luminosa figura è necessario rivolgersi alle paginedi G. B. DE ROSSI, La Roma sotterranea cristiana, I-III, Roma 1864-1877, I, pp. 12-46. Unasola breve monografia tuttavia, ormai centenaria, è stata dedicata all’insigne studioso (A. VA-LERI, Cenni biografici di Antonio Bosio con documenti inediti, Roma 1900) e non molti sonostati gli studi sulla sua figura e sul suo operato; tra questi si vedano i ritratti delineati da: H.LECLERCQ, s.v. Bosio (Antoine), in Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie, II, Paris
20 MASSIMILIANO GHILARDI
na (23), ritrovando ed esplorando circa trenta antichi cimiteri (24), purse le premesse rappresentate dalla sua prima avventurosa ricognizio-ne non dovettero essere particolarmente esaltanti (25).
Una delle scoperte, tuttavia, certamente più singolari del Bosio,della quale egli stesso, motivandone la ragione della presenza all’in-terno della Roma sotterranea, volle dare notizia è quella del cimiterogiudaico della via Portuense, oggi purtroppo di nuovo completa-mente inaccessibile. Il 14 dicembre dell’anno 1602, infatti, il giovaneesploratore, assieme a due compagni, penetrò all’interno delle galle-rie cimiteriali ebraiche non restandone, tuttavia, particolarmente col-pito (26). Decisamente singolare è il modo in cui lo studioso, e dopodi lui l’oratoriano Giovanni Severano che fu incaricato di curare l’e-dizione dell’opera postuma, presenti, dunque, la notizia del ritrova-mento, dimostrandoci in maniera inequivocabile i propri sentimentiverso la comunità giudaica e le credenze popolari irrispettose delproprio tempo: « Non dourà parer strano, che in quest’Opera de’Cimiterij sacri poniamo il Cimiterio de’ gli Hebrei; quasi che mesco-
1925, pp. 1084-1093; A. LODOLINI, s.v. Bosio, Antonio, in Enciclopedia Italiana, VII, Milano1930, p. 550; É. VAN CAUWENBERGH, s.v. Bosio (Antonio), in Dictionnaire d’histoire et de géo-graphie ecclésiastique, IX, Paris 1937, pp. 1318-1319; A. FERRUA, s.v. Bosio, Antonio, in Enci-clopedia Cattolica II, Roma 1949, pp. 1943-1944; P. PELAGATTI, s.v. Bosio, Antonio, in Enci-clopedia dell’Arte Antica, II, 1959, pp. 144-145; N. PARISE, s.v. Bosio, Antonio, in DizionarioBiografico degli Italiani, XIII, Roma 1971, pp. 257-259.
(23) Per le ricerche del maltese e in particolare per il metodo innovativo da lui introdot-to si veda il saggio di G. CANTINO WATAGHIN, Archeologia e «archeologie ». Il rapporto conl’antico tra mito, arte e ricerca, in Memoria dell’antico nell’arte italiana, I-III, a cura di S. Set-tis, Torino 1984-1986, I, pp. 169-217, spec. pp. 206-211.
(24) Cfr. PH. PERGOLA, Le catacombe romane. Storia e topografia, Roma 19982, p. 36.(25) È, infatti, noto che il 10 dicembre del 1593 il Bosio, assieme ad «alcuni altri genti-
l’huomini curiosi» capitanati dall’Ugonio, si perse nella catacomba di Domitilla; cfr. A. BO-SIO, Roma sotterranea, cit., p. 195: «mancandoci i lumi iui conuenisse morire, e con i nostriimmondi cadaueri maculare quei sacri Monumenti: percioche essendo quella la prima volta,che entrammo in questi così vasti Cimiterij incogniti; erauamo (come inesperti) venuti senzagl’istromenti, che l’esperienza poi, con il pericolo, e necessità, ci fece conoscere esser neces-sarij per questa sotterranea peregrinatione. Pigliammo dunque risolutione di ritornarcene indietro; & ancorche hauessimo segnate in più luoghi le strade, contuttociò non senza grandifficoltà ci fù permesso di ritrouar l’adito, per il quale erauamo entrati in queste oscurecauerne ». Si veda a proposito di tale notissimo episodio il commento di G. SCHNEIDER-GRA-ZIOSI, La prima esplorazione sotterranea cimiteriale di Antonio Bosio, in «Nuovo Bullettino diArcheologia Cristiana», XVIII (1912), pp. 133-143.
(26) Tutta la descrizione del rinvenimento e la prima interpretazione sono contenute nellibro II, capitolo XXII, pagine 141-143 della Roma sotterranea.
« DEL CIMITERIO DE GLI ANTICHI HEBREI» 21
liamo le cose profane con le sacre: poiche non per mescolarle; maper separarle ci è parso necessario farne particolar mentione: accio-che si sappia che i nostri sacri Cimiterij non sono stati mai profana-ti, né contaminati da’ cadaueri di Hebrei, né di Gentili: e che si co-me questi bruciauano i cadaueri loro, e li faceuano i sepolcri cospi-cui in luoghi publici; ò li riponeuano in alcune Edicole, e stanzesotterranee separate: così quelli imitando i loro, e nostri antichi Pa-dri, che si sepelliuano nelle spelonche, e nelle cauerne in sepolcri in-tagliati nelle pietre, haueuano in Roma il Cimiterio loro particolare;che è questo della Via Portuense, del quale hora trattaremo» (27). Ta-le passo, introduttivo al vero e proprio commento alla scoperta, èsin troppo esplicativo per necessitare di ulteriori spiegazioni e, comeevidente, può essere facilmente utilizzato, oltre a sintetizzare le co-noscenze seicentesche sulle pratiche funerarie antiche, per illustrarele condizioni sociali di assoluta prostrazione della comunità ebraicadel tempo nei confronti della società (28). Il Bosio, infatti, presentan-dosi come voce ufficiale della Chiesa controriformata – la pubblica-zione dell’opera, come è noto, fu fortemente voluta dalle alte gerar-chie ecclesiastiche – dimostra di essere « figlio del proprio tempo» ele sue parole irrispettose e piene di luoghi comuni riflettono assaibene la considerazione della Chiesa cattolica verso il mondo israeli-ta (29). Le parole dello studioso maltese sono, altresì, importanti per
(27) Cfr. A. BOSIO, Roma sotterranea, cit., p. 141.(28) Per conoscere più da vicino la storia degli ebrei d’Italia tra la metà del XVI secolo e
la fine del XVII e lo stato di profonda sottomissione cui erano sottoposti è certamente ne-cessario rivolgersi alle illuminanti pagine di A. MILANO, Storia degli ebrei in Italia, Torino1963, pp. 236-292.
(29) I comportamenti della Chiesa verso gli ebrei romani, fatti di tolleranza, atteggia-menti contraddittori e avversione completa, sono ben troppo noti per affrontarli nel detta-glio; per chi volesse, tuttavia, approfondire tali aspetti è necessario consultare i volumi di E.P. RODOCANACHI, Le Saint Siège et les Juifs. Le ghetto à Rome, Paris 1891; K. STOW, CatholicThought and Papal Jewry Policy, 1555-1593, New York 1977 e A. ZANOTTO, L’atteggiamentodella Chiesa nei confronti degli Ebrei dal XV al XVIII secolo, Roma 1991. L’opera più com-pleta e aggiornata è comunque quella di S. SIMONSOHN, The Apostolic See and the Jews, I-VIII, Toronto 1989-1991. Per conoscere, inoltre, la linea di condotta delle autorità ecclesia-stiche dell’epoca nei confronti del mondo ebraico e i susseguenti riflessi nel mondo civile ècertamente utile rivolgersi al saggio di R. SEGRE, Il mondo ebraico nei Cardinali della Contro-riforma, in Italia Judaica, «Gli ebrei in Italia tra Rinascimento ed Età Barocca», Atti del IIConvegno internazionale, Genova 10-15 giugno 1984, Roma 1986, pp. 119-138. Cfr. pureEAD., La Controriforma: espulsioni, conversioni, isolamento, in Gli ebrei in Italia. Storia d’Ita-lia Einaudi, Annali, 11, I-II, a cura di C. Vivanti, Torino 1996-1997, I, pp. 709-778.
22 MASSIMILIANO GHILARDI
farci comprendere numerosi altri aspetti socio-economici della co-munità giudaica del tempo, primo tra tutti il mondo lavorativo. Conl’ausilio delle fonti letterarie (30) – nel caso specifico Marziale e Stazio –,infatti, il Bosio presenta una caratteristica del mondo lavorativo giu-daico del tempo che, se si volesse attribuire veridicità alle sue paro-le, potrebbe provare una poco nota e inedita continuità dal mondoantico: «poiche quest’arte di cambiar’il solfo con vetri rotti era par-ticolarmente esercitata da gli Hebrei in quel tempo; si come ancorhoggidì l’esercitano, andando li meschini con la cesta in mano tuttoil giorno gridando per Roma con lamenteuoli voci, in testimoniodella miseria, e dannatione loro» (31). Le attività lavorative propriedella comunità giudaica dell’età barocca, in realtà, pur se generica-mente ascrivibili al mondo del commercio (32) dovettero essere preva-lentemente ben differenti, a giudicare da fonti primarie decisamentepiù aggiornate e affidabili (33). Lo stesso Bosio, in realtà, era ben co-sciente che le medesime fonti classiche (34) si proponevano volontaria-mente di presentare il mondo giudaico – impenetrabile e pertantoostile – sotto una lente deformante che produceva solo satire confu-
(30) Il Bosio dimostra sempre di avere una profonda conoscenza delle fonti antiche e atale proposito il de Rossi disse – analizzando a fondo la sua opera – che evidentemente do-vette leggere « da un capo all’altro tutte le opere de’ padri, latini, greci, orientali, e le colle-zioni de’ concilii e de’ canoni, le epistole de’ romani pontefici e degli scrittori ecclesiastici, leantiche liturgie, le storie e le cronache di tutti i secoli cristiani, le raccolte di vite de’ santi, itrattati d’ogni maniera spettanti a materie sacre, compresi perfino gli scolastici». Cfr. G. B.DE ROSSI, La Roma sotterranea, cit., I, p. 32. A ribadire di recente la maggiore importanza nelBosio per le fonti antiche rispetto all’attività archeologica si veda il lavoro di S. DITCHFIELD,Text before Trowel: Antonio Bosio’s Roma sotterranea Revisited, in The Church Retrospective,Studies in Church History 33, a cura di R. N. Swanson, Woodbridge 1997, pp. 343-360.
(31) A. BOSIO, Roma sotterranea, cit., p. 141.(32) Cfr. S. SIMONSOHN, The Apostolic See, cit., VII, pp. 415-417.(33) Per avere un’idea generale delle attività prevalenti svolte dagli ebrei a Roma nel tar-
do Cinquecento e nella prima metà del Seicento, secondo quanto ricavabile da atti giudiziarie documenti notarili, si vedano a puro titolo di esempio i recenti lavori di A. ESPOSITO, I rap-porti tra Ebrei e Cristiani nella Roma del Rinascimento. Gli intermediari privilegiati, in Un’al-tra Roma. Minoranze nazionali e comunità ebraiche tra Medioevo e Rinascimento, a cura diEad., Roma 1995, pp. 109-119, e S. FECI, La popolazione ebraica nelle fonti giudiziarie roma-ne: i Processi del Tribunale Criminale del Governatore (1619-1639), in Popolazione e società aRoma dal medioevo all’età contemporanea, a cura di E. Sonnino, Roma 1998, pp. 787-797.
(34) Per la raccolta moderna degli autori antichi con testi di interesse giudaico si vedanoS. REINACH, Textes d’auteurs grecs et romains relatifs au judaïsme, Paris 1895, e M. STERN,Greek and Latin Authors on Jews and Judaism, I-III, Jerusalem 1974-1984.
« DEL CIMITERIO DE GLI ANTICHI HEBREI» 23
se e ripetitive: «poiche se bene faceuano arti mecaniche, e tal voltada’ Poeti sono chiamati mendichi; ve n’erano contuttociò delli facul-tosi, e ricchi» (35).
Ancora grazie all’aiuto offerto dalle fonti letterarie, che – comericordato – lo studioso dimostra di conoscere approfonditamente (36)
e che ponevano il quartiere abitativo ebraico della Roma antica nelTrastevere (37), veniamo a conoscenza di un prezioso elemento riguar-dante gli ‘‘ spazi sacri ’’ della comunità giudaica (38) e la memoria ri-spettosa che si aveva di essi nel tramandarli nel tempo: «anzi duròl’habitatione de’ Giudei in Trasteuere sin’a’secoli poco lontani da’nostri; rimanendo ancora memoria presso i vecchi moderni Hebreiper traditione hauuta da gli antichi loro, del luogo, oue era la Sina-goga non molto lontano dalla Chiesa di S.Saluatore in Curte» (39). Lostudioso maltese, che scrive molti decenni dopo l’istituzione del ser-raglio di papa Paolo IV (40) – voluto anche per «proteggere la santità
(35) A. Bosio, Roma sotterranea, cit., p. 142.(36) Sulle fonti letterarie e il loro utilizzo negli studi e nelle ricerche degli antiquari si ve-
da il classico saggio di A. MOMIGLIANO, Ancient History and the Antiquarian, in «Journal ofthe Warburg and Courtauld Institutes», XIII (1950), 3-4, pp. 285-315.
(37) Ciò sarebbe, infatti, provato da un noto passo della legatio ad Gaium di Filone Ales-sandrino; cfr. Ph., leg., 23, 155: t hn per a n t o u T i b er e w v p o t a m o u m e g al h n t hv ‘R wm h v a’ p o t o -m hn [hÇn ] o u’ k h’g n oe i k a t e c o m en h n k a i o i’k o u m en h n p r ov ’I o u d a iw n. Cfr. per tale testo lo studiodi C. KRAUS REGGIANI, I rapporti tra l’impero romano e il mondo ebraico al tempo di Caligolasecondo la ‘Legatio ad Gaium’ di Filone Alessandrino, in «Aufstieg und Niedergang der Rö-mischen Welt», II 21, 1 (1984), pp. 554-586.
(38) Certamente utile per conoscere le valenze sacrali positive e negative del concetto di« spazio » nella mentalità giudaica è lo studio di R. DI SEGNI, Spazi sacri e spazi maledetti nel-la Roma ebraica, in Luoghi sacri e spazi della santità, a cura di S. Boesch Gajano - L. Scaraffia,Torino 1990, pp. 113-120. Per il concetto astratto di «spazio » nella mentalità collettiva dellaseconda metà del XVI secolo, il momento in cui si forma il Bosio, è indicato il saggio di M.BOITEUX, Espace urbain, pratiques rituelles, parcours symboliques: Rome dans la seconde moitièdu XVI ème siècle, in Rome: l’espace urbain et ses reprèsentations, a cura di F. Hinard - M. Ro-yo, Tours 1993, pp. 111-145.
(39) A. BOSIO, Roma sotterranea, cit., p. 142.(40) Paolo IV Carafa, infatti, istituì il 14 luglio del 1555 il Ghetto ebraico, promulgando
la bolla intitolata Cum nimis absurdum nella quale si prescrivevano le ordinationes circa Ju-deorum vivendi modum (cfr. Bullarium Romanum – taurinensis editio – I-XXVI, Torino1857-1896, VI, 498b-500b). Per la rigida politica di tale pontefice nei confronti degli ebrei siveda quanto raccolto da L. PASTOR, Geschichte der Päpste, I-XVI, Freiburg 1901-19334, VI,pp. 515-519, mentre per l’istituzione del serraglio, il suo ruolo socio-culturale e la sua chiu-sura verso l’esterno e impenetrabilità, si vedano gli studi di K. STOW, Sanctity and the Con-struction of Space: the Roman Ghetto, in Luoghi sacri, cit., pp. 593-607; ID., The Consciou-sness of Closure: Roman Jewry and its ‘‘Ghet ’’, in Essential Papers on Jewish Culture in Re-
24 MASSIMILIANO GHILARDI
dello spazio cristiano dalle impurità» (41) –, testimonia dunque la re-cente ubicazione, coatta e non (42), della numericamente cospicua co-munità israelita (43) (dalla evidente crescita esponenziale (44) in una cit-tà con meno di 200.000 abitanti (45)) in un luogo ristretto, e contri-buisce a delineare con assoluta chiarezza il forte attaccamento delle
naissance and Baroque Italy, a cura di D. Ruderman, New York 1992, pp. 386-400 e ID.,Theater of Acculturation: the Roman Ghetto in the Sixteenth Century, Seattle 2000.
(41) Cfr. A. FOA - K. STOW, Gli ebrei di Roma. Potere, rituale e società in età moderna, inRoma, la città del papa. Vita civile e religiosa dal giubileo di Bonifacio VIII al giubileo di papaWojtyla, Storia d’Italia Einaudi, Annali 16, a cura di L. Fiorani - A. Prosperi, Torino 2000, p.572. Si pensi, inoltre, che come testimoniato dal Lanciani molte chiese furono sconsacrate odemolite per essersi trovate ubicate all’interno dell’area destinata alla popolazione ebraica;per la lista di tali chiese cfr. R. LANCIANI, Storia degli scavi di Roma e notizie intorno le colle-zioni romane di antichità, I-IV, Roma 1902-1912, IV, pp. 18-19.
(42) Già prima, infatti, dell’istituzione ufficiale del Ghetto la comunità degli ebrei di Ro-ma si era concentrata, certamente per le migliori possibilità commerciali, nel Rione S. Ange-lo, ove poi, dunque, crebbe il quartiere cinto da porte; cfr. A. ESPOSITO, Gli Ebrei romani al-la fine del Medioevo, in Un’altra Roma, cit., p. 143. A conferma di tale dato si veda pureS. DELLA PERGOLA, Distribution résidentielle des juifs dans quelques villes européennes et àRome en particulier (recherche en cours), in «Revue des études juives», CXLVIII (1989), 1-2,p. 82.
(43) La consistenza demografica della comunità giudaica, infatti, al tempo del sacco lan-zichenecco di Roma doveva aggirarsi sulle 1772 unità, appartenenti a 373 famiglie; cfr. A.ESPOSITO, La presenza ebraica a Roma dal Duecento al Sacco: aspetti demografici e sociali, inUn’altra Roma, cit., p. 129. Tale dato, ricavabile con assoluta certezza dalla Descriptio Urbis,sarebbe, a detta del Livi, corrispondente al 3,2% della intera popolazione romana; cfr. L. LI-VI, Un censimento di Roma avanti il sacco borbonico, Roma 1914, pp. 68-69. Per la DescriptioUrbis, censimento della popolazione cittadina di Roma, si vedano lo studio di D. GNOLI, De-scriptio Urbis o Censimento della popolazione avanti il Sacco borbonico, in «Archivio dellaSocietà Romana di Storia Patria», XVII (1894), pp. 375-520 e il più recente commento di E.LEE, Descriptio Urbis. The Roman Census of 1527, Roma 1985. Per gli aspetti storici legati alcelebre sacco della città di Roma si veda il noto volume di A. CHASTEL, The Sack of Rome,1527, Princeton 1983.
(44) Un censimento voluto dal cardinal Gerolamo Rusticucci nel 1592, contenuto nelCod. Urb. Lat. 1060, II, f. 473A e databile al I agosto di quell’anno, proverebbe infatti per lasola città di Roma l’esistenza di circa 3500 ebrei, quasi il doppio di quelli esistenti meno disettanta anni prima. Cfr. J. DELUMEAU, Vie économique et sociale de Rome dans la secondemoitié du XVI e siècle, I-II, Paris 1957-1959, I, pp. 214-217. Per conoscere meglio la figura diGerolamo Rusticucci, nato a Fano nel 1537 e spentosi a Roma nel 1603 dopo aver ricopertoil ruolo di Segretario di Stato con papa Pio V, si veda il ritratto delineato da P. SANNAZZARO,s.v. Rusticucci, Gerolamo, in Enciclopedia Cattolica, X, Roma 1953, p. 1482.
(45) Alla fine del XVII secolo gli ebrei di Roma sarebbero aumentati sino alle 9000 o10000 unità; per tale dato, a mio avviso non del tutto pienamente probabile, si veda D. CA-LABI, The Jews and the City in the Mediterranean Area, in Mediterranean Urban Culture,1400-1700, a cura di A. Cowan, Exeter 2000, p. 66.
« DEL CIMITERIO DE GLI ANTICHI HEBREI» 25
nuove generazioni verso la tradizione secolare, caratteristica tipica eimmutabile del mondo giudaico.
Dopo aver documentato l’esistenza in antico di una consistentecomponente sociale giudaica e averne provato l’ubicazione nell’areaalla destra del fiume sino ai suoi giorni (46), il Bosio ipotizza, alla lucedella propria scoperta, l’esistenza di un’estesa area funeraria subitoal di fuori delle mura transtiberine: «ne segue, che doueuano haue-r’ancora in Roma il loro particolare Cimiterio, fuori d’vna delle por-te di Trasteuere: & essendo la Via Portuense più agiata, e comoda,per esser piana, e più vicina della montuosa Aurelia; ne viene inconseguenza, che il Cimiterio, del qual’hora trattaremo, ritrouato danoi nella Via Portuense, fosse il Cimiterio de gli Hebrei. Et oltre àgli altri sudetti, si aggiunge vn’altro non leggiero argomento: poicheancor’hoggidì vsano gli Hebrei di sotterrare i morti loro vicino allamedesima Porta Portuense; dal che n’hà pigliato il nome il CampoGiudeo » (47). Pur sorvolando sulla banale motivazione che l’autoreadduce per giustificare la localizzazione topografica della catacombagiudaica della via Portuense – la prima ad essere portata alla lucedelle sei giudaiche che l’archeologia ci ha restituito (48) e per moltotempo l’unico cimitero ipotizzato per gli ebrei dell’antichità (49) – ilpasso bosiano si dimostra efficace per illustrare un ulteriore aspetto,quello funerario, della a lui coeva comunità giudaica; questa, infatti,
(46) Per conoscere meglio gli aspetti sociali di Trastevere nell’età barocca si veda lo stu-dio di A. LEPRE, Aspetti sociali di Trastevere nel Seicento, in «Studi Romani», XXIV (1976),3, pp. 331-351.
(47) A. Bosio, Roma sotterranea, cit., p. 142.(48) Per avere una visione d’insieme sui complessi cimiteriali ipogei extraurbani della co-
munità giudaica di Roma si vedano, con precedente bibliografia, i puntuali studi di D. MAZ-ZOLENI, Le catacombe ebraiche di Roma, in «Studi Romani», XXIII (1975), 3, pp. 289-302, edi C. VISMARA, I cimiteri ebraici di Roma, in Società romana e impero tardoantico, II. Roma:politica, economia, paesaggio urbano, a cura di A. Giardina, Roma-Bari 1986, pp. 351-388,490-503.
(49) La seconda catacomba giudaica ad essere scoperta, infatti, fu quella cosiddetta diVigna Randanini sulla via Appia, che vide la luce solo nel 1859. Per il rinvenimento di talecomplesso funerario suburbano e per una prima sommaria descrizione si vedano principal-mente, oltre alla relazione preliminare presentata da E. HERZOG, Le Catacombe degli Ebrei inVigna Randanini, in «Bullettino dell’Instituto di Corrispondenza Archeologica» (1861), pp.91-104, i lavori di R. GARRUCCI, Il cimitero degli antichi Ebrei scoperto recentemente in VignaRandanini, Roma 1862, e di O. MARUCCHI, Breve visita al cimitero giudaico di Vigna Randani-ni, Roma 1884.
26 MASSIMILIANO GHILARDI
come noto anche da altre e più evidenti testimonianze, possedevauna delle proprie aree destinate alle sepolture nel luogo un tempoappartenuto alla prima comunità (50), un raro e affascinante esempiodi continuità topografica legato ad aspetti etnici.
La narrazione del Bosio procede con il racconto particolareggia-to del modo in cui si dovette verificare la scoperta, e le osservazioniche l’archeologo maltese riporta sono decisamente utili per una lun-ga serie di considerazioni: « il detto Cimiterio dunque fù ritrouato inquesto modo. Non restando contenti di quei due soli aditi Cimite-riali descritti nel precedente Capitolo, seguitammo di ricercare tut-tauia con diligenza le Vigne, e luoghi della Via Portuense. E pero ilSabbato 14.di Decembre dell’anno 1602. essendo vsciti dalla mede-sima Porta in compagnia del Marchese Giouan Pietro Caffarelli no-bile Romano, e di Giouanni Zaratino Castellino gentil’huomo ornatodi belle lettere, entrammo in quel medesimo primo diuerticolo, chesi troua à man diritta, salimmo il detto Colle Rosaro, e penetrammoin vna Vigna, che fù altre volte del Vescovo Ruffino, & in quel tem-po era posseduta dalli figliuoli del q. Mutio Vitozzi. Nell’estremitàdi questa Vigna, che riguarda il Teuere ritrouammo vna bocca digrotta angusta, difficile, e pericolosa, stando alla rupe di vna balza,alla quale soggiace vn vallato; oue sono sotto al Cimiterio gran cauedi tufo. Entrati dunque per questa bocca con il corpo chino, pene-trammo nel Cimiterio; il qual’è intagliato nel tufo, (ancorche in al-cuni luoghi assai tenero) & è di mediocre grandezza; percioche indue hore, che vi stemmo, ci parue di hauerlo circondato tutto; sebene si conosceua esserui de gli altri aditi, e strade ripiene, le qualipuò essere che girino molto più. Questo Cimiterio è fatto alla ma-niera de gli altri con le sue sepolture intagliate nelli muri; & in alcu-ni luoghi hà delle fosse ancora, e sepolcri cauati nel pauimento:habbiamo però osseruato in esso vna cosa differente da gli altri Ci-
(50) Una disputa giudiziaria, infatti, per motivi legati a concessioni sepolcrali nell’area diPorta Portese è recensita da K. STOW, The Jews in Rome. Volume II, 1551-1557, Leiden-NewYork-Köln 1997, pp. 835-837. Tale documento, datato al 23-24 luglio dell’anno 1556, aiutapertanto a conoscere più in dettaglio l’esistenza di tale cimitero ebraico extramuraneo e con-tribuisce a chiarire la netta distinzione di questi ultimi dai luoghi di sepoltura cristiani. Aproposito della separazione totale dei cimiteri ebraici e cristiani si veda quanto raccolto da R.BONFIL, Les juifs d’Italie à l’époque de la Renaissance. Stratégies de la différence à l’aube de lamodernité, Paris 1995, pp. 212-215.
« DEL CIMITERIO DE GLI ANTICHI HEBREI» 27
miterij, & è che per il più li sudetti monumenti non sono chiusi contegole, e marmi; ma con mattoni intonicati di calce, doue quasi sem-pre con lettere rosse si vedeua esserui stati scritti gli Epitaffi: alcunide’ quali erano scolpiti anche nella calce, e di essi ne habbiamo ri-trouati molti; però tutti in Greco, e guasti, secondo, che sono statiaperti li sepolcri da’ curiosi, & auidi Cauatori, e leuati parte de’mattoni, e calce, sopra i quali erano scritti; di modo, che da loronon se ne può cauare senso alcuno perfetto» (51).
Dalla attenta lettura di questo lungo brano, dunque, è possibilericavare preziose e molteplici informazioni; si apprende, infatti, cheil Bosio, non soddisfatto delle proprie ricerche lungo il percorsodella via Portuense, si dedicò con immensa dedizione alla ricogni-zione approfondita di tutte le vigne e terreni suburbani prima di ri-conoscere il cimitero ebraico. Ciò è significativo per illustrare unaspetto poco approfondito dell’attività bosiana: egli, infatti, implici-tamente dimostra di aver grande libertà di movimento in tutti i ter-reni pubblici e privati della campagna romana e di poter svolgere inessi attività di ricerca archeologica, contrariamente alle norme eccle-siastiche vigenti. Egli, dunque, doveva possedere – in pura linea ipo-tetica – una sorta di riconoscimento ufficiale della propria attivitàinvestigativa, un incarico o un « lasciapassare » che lo rendeva im-mune dall’essere colpito dalle severe norme che erano inflitte a co-loro che si dilettavano a scopo di lucro alla ricerca di catacombe e‘‘ corpi santi ’’ (52). Va, infatti, rilevato che la ‘‘ cava dei corpi santi ’’,
(51) A. BOSIO, Roma sotterranea, cit., p. 142.(52) L’esistenza di autorizzazioni rilasciate dalle autorità ecclesiastiche a coloro che in-
tendevano esplorare i cimiteri sotterranei è provata da un passo poco noto di un’operetta dicarattere ufficiale (contenuta nel codice Vat. Chig. G III 82, ff. 1-111 e parzialmente edita dalpadre Ferrua) redatta tra il 1662 e il 1667 dal Sagrista del Palazzo Apostolico sotto Alessan-dro VII Ambrogio Landucci, intitolata Pratica per estrarre li corpi de’ santi Martiri da’ sagricimiteri di Roma, ove si legge: «ha si bene il zelo di molti sommi Pontefici, particolarmentedi Clemente VIII di Paolo V di Urbano VIII e del regnante Alessandro VII, che Iddio salvi emantenghi lungo tempo alla sua santa Chiesa, sotto grandissime pene pecuniarie, corporali espirituali, come di scomunica maggiore, riserbata alla Sede Apostolica provisto per l’indenni-tà di questi S. Cimiteri non solo divietando che da quelli non si cavi cosa alcuna benchè mi-nima, ma che neanco chi sia, di qualsiasi stato, grado o condizione ardisca d’entrarvi senzaespressa licenza della Santa Sede o Suoi Ministri». Cfr. A. FERRUA, Sulla questione del vaso disangue. Memoria inedita di Giovanni Battista de Rossi, Città del Vaticano 1944, p. 121. Di unpermesso rilasciato al Bosio da Clemente VIII, probabile in linea di principio ma in realtà as-solutamente ignoto, parla con sicurezza J. J. GAUME, Les Trois Rome. Journal d’un Voyage en
28 MASSIMILIANO GHILARDI
che in realtà solo più tardi diventerà un fenomeno diffusissimo, giàall’età del Bosio aveva cominciato a prendere piede (53): ciò è, adesempio, dimostrato da alcuni documenti ufficiali del tempo di papaClemente VIII, in cui si rendeva nota l’illiceità della pratica, e Vic-tor Saxer ha recentemente raccolto un buon numero di documenti,permessi per estrarre reliquie dai cimiteri, rilasciati in prima personadal pontefice a testimoniare la volontà ferma delle alte gerarchiedella Chiesa di regolamentare e limitare le manomissioni delle galle-rie cimiteriali (54). In un documento ufficiale conservato nella Biblio-teca Apostolica Vaticana è, inoltre, possibile leggere: «1599 Ottobre2. Si è prohibito sotto pena della galera et scommunica papale, chenessuno possa entrare nelle grotte di San Sebastiano o d’altre chiesefuori di Roma, acciò non ne siano levate le reliquie come si face-va » (55), cui fa eco un bando del 4 agosto del 1604, conservato nellaBiblioteca Casanatense, dall’intestazione: «Editto che niuni possi en-trare nelle Grotte, Catacombe o Cimiteri». In tale documento, fir-mato dal cardinale Camillo Borghese (il futuro papa Paolo V) e in-dirizzato a coloro che sono soliti cavare reliquie, «ouero osse sottonome di Reliquie», si avvisavano tutti i «padroni, & affittuarij, òmezaroli delle vigne » della decisione di far murare l’accesso dellecatacombe nei loro terreni; di tali entrate, inoltre, si sarebbe dovutadare notizia, entro il mese in corso di agosto, al notaio Muzio Passa-rini e così si sarebbe dovuto comportare anche chi avesse scopertonel proprio terreno un « luogo che hauesse forma di Cimiterio» (56).Tali iniziative, dettate evidentemente dal ripetersi frequente di furtidi reperti ossei dalle gallerie cimiteriali – attività illecita nella qua-
Italie, I-IV, Paris 18574, IV, p. 84; cfr. pure ID., Histoire des Catacombes de Rome, Paris1848, pp. 97-98.
(53) Per tale pratica e per i criteri utilizzati per riconoscere i corpi dei martiri fino al1668, anno in cui una apposita Congregazione si pronunciò a tale proposito, si veda quantoraccolto da A. FERRUA, Sulla questione, cit., pp. VIII-XX.
(54) Per gli aspetti della ricerca archeologica del tempo legati alla devozione religiosa sivedano le puntuali osservazioni di V. SAXER, La ricerca dei ‘‘ corpi santi ’’ e le prime esplorazio-ni nelle catacombe, in Dopo Sisto V. La transizione al Barocco (1590-1630), Atti del Conve-gno, Roma 18-20 ottobre 1995, Istituto Nazionale di Studi Romani, Roma 1997, pp. 255-265(in particolare per i permessi rilasciati dai pontefici pp. 259-261).
(55) Cod. Urb. Lat. 1067, f. 620.(56) Cfr. J. A. F. ORBAAN, Documenti, cit., p. 134, e G. FERRETTO, Note storico-bibliografi-
che di archeologia cristiana, Città del Vaticano 1942, fig. 45.
« DEL CIMITERIO DE GLI ANTICHI HEBREI» 29
le fu coinvolto anche un personaggio di spicco molto vicino al Bo-sio (57) –, vanno inquadrate nell’ottica di voler porre un rimedio vali-do contro il depauperamento delle catacombe ma, più specificata-mente, miravano a frenare il fiorente mercato illegale delle reliquie:fu, infatti, convinzione generalizzata che possedere una seppur mini-ma particella di ‘‘ corpo santo ’’ permettesse di acquistare il diritto almiracolo o la protezione divina (58): fu così che senza il minimo sensocritico si commerciarono illegalmente improbabili reliquie, la cuicircolazione oggi ci appare risibile e difficilmente comprensibile (59).
L’esplorazione del cimitero giudaico, condotta dal maltese assie-me a due appassionati e noti letterati del tempo (60), dovette essere
(57) In tale reato fu coinvolto Giovanni Angelo Santini, detto il Toccafondo o Toccafon-di per la sorprendente abilità mostrata nel percorrere anche le gallerie più insidiose, che peralcuni anni – prima della sostituzione con il senese Santi Avanzino – fu il pittore incaricatodi ritrarre le immagini più suggestive che si ritrovavano nel sottosuolo. Questi, infatti, fu sor-preso a commerciare illecitamente reliquie da lui cavate illegalmente presso i cimiteri cristia-ni. Il ricordo di tale infamante episodio ci è trasmesso dall’Armellini che rinvenne negli Ar-chivi vaticani un estratto del processo a carico del pittore dal titolo: Notula delle cose confes-sate da Gio. Angelo Santino preso in flagrante con reliquie levate dal cimitero di santa Cetro-nella Felicita e Novella fuori Porta Pia, in cui il capo di imputazione era «escavatione et ven-dita di ossi sotto il nome di reliquie». Cfr. M. ARMELLINI, Gli antichi cimiteri cristiani di Ro-ma e d’Italia, Roma 1893, pp. 144-145.
(58) Per tale aspetto del sentimento popolare religioso, che si mosse nella logica assurdadella quantità piuttosto che della qualità, si veda L. FIORANI, Astrologi, superstiziosi e devotinella società romana del Seicento, in «Ricerche per la storia religiosa di Roma», II (1978), pp.97-162, partic. pp. 151-162.
(59) La conferma evidente che tale genere di mercato illecito, assai fiorente nell’età ba-rocca, fosse noto alle autorità ecclesiastiche, incapaci di porvi un serio rimedio, viene dalleparole del già menzionato Ambrogio Landucci, dalle quali possiamo altresì recuperare un ul-teriore elemento importante per comprendere la bassa considerazione in cui erano tenuti gliappartenenti alla comunità israelita: «mi spavento di più perché chi si induce cotanto sacrile-gamente e simoniacamente a vender in questa forma le sante reliquie per prezzo vile e finito,nell’istessa maniera talvolta venderà quelle d’un ladro, d’assassino e forse d’un Ebreo, et an-co d’una bestiaccia d’un cavallo o d’un asino »; cfr. A. FERRUA, Sulla questione, cit., p. 123.
(60) Se meno nota è la figura del marchese Giovan Pietro Caffarelli, la cui famiglia tutta-via come è noto era legata con vincoli di stretta parentela al papa Paolo V Borghese, maggio-ri informazioni possediamo su Giovanni Zaratino Castellini, nato nel 1570 e spentosi nel1649. Per tale «gentil’huomo ornato di belle lettere» che, come il Bosio, formò la propriapreparazione presso i Gesuiti del Collegio Romano, si vedano A. FERRUA, Giovanni ZaratinoCastellini raccoglitore di epigrafi, in «Epigraphica », XX (1958), pp. 121-160; ID., GiovanniZaratino Castellini umanista e raccoglitore d’epigrafi, in «La Civiltà Cattolica», CX (1959), 2,pp. 492-501; ID., Giovanni Zaratino Castellini e l’epigrafia paleocristiana, in «Rivista di Ar-cheologia Cristiana», XXXVI (1960), pp. 73-104. Per un più rapido affresco si veda il ritrat-
30 MASSIMILIANO GHILARDI
particolarmente complessa se – come il brano testimonia – l’accessoalle gallerie era parzialmente franato e occluso («vna bocca di grottaangusta, difficile, e pericolosa»), ed il percorso iniziale richiese diprocedere in maniera non del tutto agevole («entrati dunque perquesta bocca con il corpo chino, penetrammo nel Cimiterio»). Ciòche i curiosi indagatori dovettero perlustrare della necropoli sotter-ranea fu, però, se confrontato con le conoscenze moderne del cimi-tero, solo una minima parte («è di mediocre grandezza») e due oresoltanto bastarono alla completa ricognizione («percioche in dueore, che vi stemmo, ci parue di hauerlo circondato tutto»). La cer-tezza, tuttavia, che altri anditi sotterranei dovessero essere presenti èventilata tra le righe dalle parole del Bosio («se bene si conosceuaesserui de gli altri aditi»), ma la pericolosità delle gallerie parzial-mente franate (« strade ripiene, le quali può essere che girino moltopiù »), forse anche a causa di una cava di materiale tufaceo sotto-stante («oue sono sotto al Cimiterio gran caue di tufo»), consigliòagli esploratori di non procedere oltre. La breve visita al monumen-to non impedì, tuttavia, al «Colombo della Roma sotterranea», co-me definì padre Giuseppe Marchi l’archeologo barocco (61), di scor-gere aspetti peculiari del cimitero e di presentarne lucide riflessio-ni nella Roma sotterranea. Pur riconoscendo forti analogie architet-toniche del cimitero giudaico con le catacombe cristiane (62) (« questoCimiterio è fatto alla maniera de gli altri»), dalle quali non sembra-va differire neanche per tipologie funerarie (63) essendo riconoscibi-li loculi parietali e formae pavimentali («sepolture intagliate nellimuri; & in alcuni luoghi hà delle fosse ancora, e sepolcri cauati nelpauimento »), il Bosio, infatti, sottolinea l’apparente peculiare diffor-mità nella tecnica e nei materiali utilizzati per chiudere i sepolcri
to delineato da M. PALMA, s.v. Castellini, Giovanni Zaratino, in Dizionario Biografico degliItaliani, XXI, Roma 1978, pp. 755-766.
(61) Cfr. M. GHILARDI, Subterranea civitas. Quattro studi sulle catacombe romane dal me-dioevo all’età moderna, Roma 2003, p. 79 nota 18.
(62) Si è, infatti, recentemente ribadito che le catacombe ebraiche strutturalmente non sidistinguono minimamente da quelle cristiane coeve; cfr. PH. PERGOLA, Le catacombe, cit., p. 84.
(63) Per l’analisi tipologica delle sepolture giudaiche comparate alle omologhe dei cimi-teri cristiani, pur se limitatamente alla catacomba di Vigna Randanini sulla via Appia e aglialtri complessi funerari del suburbio meridionale di Roma, si veda l’approfondita analisi diD. NUZZO, Tipologia sepolcrale delle catacombe romane. I cimiteri ipogei delle vie Ostiense,Ardeatina e Appia, BAR International series 905, Oxford 2000, pp. 135-138.
« DEL CIMITERIO DE GLI ANTICHI HEBREI» 31
(« habbiamo però osseruato in esso vna cosa differente da gli altriCimiterij, & è che per il più li sudetti monumenti non sono chiusicon tegole, e marmi; ma con mattoni intonicati di calce»), aspettoche, tuttavia, la riscoperta moderna del monumento avrebbe ridi-mensionato. I loculi alle pareti, sulle chiusure originarie dei qualistando al racconto bosiano dovevano essere dipinti o incisi epitaffifunebri esclusivamente in lingua greca («quasi sempre con lettererosse si vedeua esserui stati scritti gli Epitaffi: alcuni de’ quali eranoscolpiti anche nella calce, e di essi ne habbiamo ritrouati molti; peròtutti in Greco »), risultavano, però, tutti dischiusi a testimoniare unaevidente e preventiva frequentazione da parte di cercatori di imma-ginari tesori (« guasti, secondo, che sono stati aperti li sepolcri da’curiosi, & auidi Cauatori»). Tale particolare, riferito dal Bosio de-scrivendo la propria scoperta, potrebbe in effetti documentare cheegli non fu il vero e proprio scopritore moderno del cimitero, damolto tempo già frugato, ma solo il divulgatore primo di quest’ulti-mo. Che la memoria del cimitero giudaico non si fosse totalmenteperduta dai secoli della tarda antichità (64), infatti, potremmo anchericavarlo – oltre che dall’incontrovertibile racconto del maltese – daun rapido accenno che sembra farne nel pieno Medioevo il diario diviaggio di un pellegrino ebreo spagnolo alla ricerca della trama com-plessa della diaspora della sua gente. Il giudeo Beniamino di Tude-la (65), peregrinando nella sesta decade del XII secolo dalla Spagna si-no al vicino Oriente alla ricerca dei propri confratelli sparsi nel Me-diterraneo, si soffermò brevemente anche nella descrizione somma-ria della città di Roma (66) e nel conciso affresco che ne dà – ricco di
(64) Per la storia delle esplorazioni sotterranee nei secoli che seguirono l’abbandono ge-neralizzato dei complessi catacombali mi sia perdonato il rimando ai miei Le catacombe diRoma dal Medioevo alla Roma sotterranea di Antonio Bosio, in «Studi Romani», XLIX(2001), 1-2, pp. 27-56; Le catacombe di Roma tra la tarda antichità e l’alto medioevo, in «Au-gustinianum », XLII (2002), 1, pp. 205-236.
(65) Cfr. M. ROSETTI, s.v. Benjamin (Ben Jonah) of Tudela, in Encyclopedia Judaica, IV,Jerusalem 19784, pp. 535-538.
(66) La descrizione della visita a Roma è stata analizzata da A. BERLINER, Geschichte derJuden in Rom von der ältesten Zeit bis zur Gegenwart (2050 Jahre), I-II, Frankfurt 1893, II,pp. 30-33, e da R. DI TUCCI, Beniamino da Tudela e il suo viaggio, in «Bollettino della R. So-cietà Geografica Italiana », VII (1941), pp. 496-517, ma lo studio di quest’ultimo che negatotalmente l’attendibilità storica del viaggio è, forse, troppo condizionato dal momento stori-co in cui fu compilato per essere considerato valido.
32 MASSIMILIANO GHILARDI
tradizioni favolistiche e improbabili leggende medievali (67) – potreb-be essere celato, come già l’oratoriano seicentesco Paolo Aringhitraducendo la Roma sotterranea in latino sembra aver intuito (68), ilcimitero della via Portuense: si ricorda, infatti, che « in un’altra ca-verna, in una collina sulla riva del Tevere, sono sepolti i dieci piimessi a morte dall’autorità» (69). In questa breve espressione del dia-rio di Beniamino, compilato – come gli itinerari altomedievali dellacittà di Roma – ad uso dei pellegrini che avrebbero voluto intra-prendere la stessa peregrinazione, sarebbe così affascinante ricono-scere il cimitero giudaico di Monteverde, posto invero in una collinaa poca distanza dal fiume, nel quale l’immaginario giudaico tardo-medievale poneva la sepoltura dei leggendari ‘‘dieci martiri ’’ ebreimessi a morte dagli imperatori romani (70).
Per quanto riguarda le chiusure infrante dei loculi, oltre ad avernotato che i resti epigrafici esclusivamente redatti in greco dovevanopresentarsi, vista la totale frammentarietà, completamente incom-prensibili («da loro non se ne può cauare senso alcuno perfetto») –cosa che, come vedremo verrà smentita dalla riscoperta archeologicamoderna del cimitero –, il maltese propone personali riflessioni e in-terpretazioni: «non è da merauigliarsi, che gli Hebrei vsassero di fa-r’i loro Epitaffi in lingua Greca, e non nell’Hebrea: percioche la lin-gua Greca in quei tempi era talmente in fiore, che non era stimatoeloquente, chi non haueua cognitione di lettere greche . . . Quindi è,che gli Hebrei faceuano i loro Epitaffi in lingua Greca; perche re-stassero à perpetua memoria ne’ secoli futuri, e più facilmente po-tessero da tutti esser’intesi. Si potrebbe anche dire, che detti Epitaffifossero fatti in greco, perche forsi erano in quei sepolcri sepellitiGiudei natiui di Grecia: percioche di loro n’era piena; come riferi-sce Filone; . . . può essere dunque facilmente, che questi Giudei Gre-
(67) Per una breve ma puntuale antologia di brani di letteratura giudaica incentrati suRoma si veda quanto recentemente raccolto in Tutto l’oro e l’argento di Roma. L’immagine diRoma nella tradizione ebraica, a cura di M. Procaccia - A. Spagnoletto, Bologna 2000.
(68) L’Aringhi pubblicò una versione latina del testo bosiano che, più che una traduzio-ne, era un completo rifacimento in due tomi dell’opera del maltese. Cfr. P. ARINGHI, Romasubterranea novissima, I-II, Roma 1651, I, pp. 399-400.
(69) Cfr. Binyamin da Tudela. Itinerario (Sefer massa’ot), a cura di G. Busi, Rimini 1988,p. 20.
(70) Cfr. M. D. HERR, s.v. Ten Martyrs, The, in Encyclopedia Judaica, XV, Jerusalem19784, pp. 1006-1008.
« DEL CIMITERIO DE GLI ANTICHI HEBREI» 33
ci concorrendo à Roma per negotij loro, e morendo quiui, se li fa-cessero gli Epitaffi nella lingua loro natiua greca» (71). Alla luce delleconoscenze scaturite dalla riscoperta moderna del monumento, sipotrebbero, tuttavia, affinare le acute intuizioni del Bosio circa l’a-spetto linguistico dell’antica comunità giudaica di Roma tardoanti-ca (72); le numerose iscrizioni in lingua greca (73), infatti, oltre a testi-moniare una superficiale ellenizzazione del gruppo, possono aiutarea documentare l’alto tasso immigratorio (74) e la prevalente attivitàcommerciale svolta dai membri di detta comunità (75), motivo per cuichiaramente la lingua greca era certamente più indicata rispetto allalatina.
Proseguendo nella descrizione del cimitero il dotto antiquarioseicentesco si sofferma a ribadire l’estrema semplicità architettoni-ca degli spazi visitati, in cui si potevano vedere due soli cubicoli didimensioni ridotte, e la povertà decorativa dell’intero complesso:« Tornando hora alla descrittione del Cimitiero. Questo è fatto mol-to alla rustica, e rozzamente non hauendo altro, che due soli Cubi-coli, e quelli ancora molto piccioli, & ignobili, com’è tutto il Cimite-rio; nel quale non si vede ne pure vn frammento di marmo, ne pit-tura, ne segno alcuno di Christianità» (76).
L’unico elemento decorativo inciso o dipinto – evidentementefunzionale a livello simbolico e liturgico – presente in grande ab-bondanza, a giudicare dalle parole dello studioso che ne segnala la
(71) A. BOSIO, Roma sotterranea, cit., p. 142.(72) Per conoscere più approfonditamente le dinamiche sociali della comunità giudaica
operante nella Roma tardoantica è utile la consultazione di L. V. RUTGERS, The Jews in LateAncient Rome. Evidence of Cultural Interaction in the Roman Diaspora, Leiden-New York-Köln 1995.
(73) Come avremo modo di vedere in seguito, la riscoperta agli inizi del XX secolo delcimitero ha permesso di riportare alla luce 201 iscrizioni in buono stato di conservazione –segno evidente che doveva trattarsi di una regione differente da quella visitata nel XVI seco-lo – delle quali 166 in lingua greca e 35 in latino. Cfr. J. B. FREY, Corpus Inscriptionum Iudai-carum. Recueil des inscriptions juives qui vont du III e siècle avant Jésus-Christ au VII e siècle denotre ère, Vol. I, Europe, Città del Vaticano 1936, pp. 206-359.
(74) Cfr. C. VISMARA, I cimiteri, cit., p. 356. Si veda pure EAD., Ancora sugli Ebrei di Ro-ma, in « Archeologia Classica », XXXVIII-XL (1986-1988), pp. 150-161, e EAD., Orientali aRoma: nota sull’origine geografica degli Ebrei nelle testimonianze di età imperiale, in «Dialo-ghi di Archeologia», ser. III, V (1987), pp. 119-121.
(75) Cfr. D. MAZZOLENI, Le catacombe, cit., p. 291.(76) A. BOSIO, Roma sotterranea, cit., p. 143.
34 MASSIMILIANO GHILARDI
presenza reiterata su quasi ogni sepoltura, è il candelabro eptalic-ne (77), simbolo che, come è stato recentemente chiarito, sembra ap-parire assai precocemente nelle iconografie giudaiche (78): «solo (qua-si per ogni sepoltura) si vede dipinto di color rosso, ò impresso nel-la calce, il Candelabro delle sette lucerne: vsanza peculiare de’ Giu-dei, che perseuerò fin’a’tempi nostri; come ne faceuano testimonian-za li Titoli, leuati dal moderno Cimiterio loro per ordine della sacraRiforma; in molti dei quali era scolpito il Candelabro; e partico-larmente in capo d’vna strada, che non hà esito, si vede dipinto dicolor rosso sopra li monumenti vna gran figura del medesimo» (79).In queste ultime parole il Bosio ci porta nuovamente a conoscenzadi un interessante dato storiografico, testimoniando a lui la contem-poranea politica restrittiva applicata dalla Chiesa alle aree sepolcra-li della comunità ebraica; oltre, infatti, a vietare cerimonie funebripubbliche, per le quali gli eventuali colpevoli sarebbero stati perse-guiti da pesanti sanzioni economiche e pene corporali sarebbero sta-te comminate ai parenti più prossimi dei defunti (80), furono emanatida papa Urbano VIII in data 8 e 23 ottobre 1625 due decreti chestabilivano che nessuna lapide o pietra tombale potesse essere appo-sta sulle tombe degli ebrei negli Stati pontifici e quelle già esistentidovessero essere violentemente rimosse (81). Tale feroce interdizione,che colpì prevalentemente il principale cimitero giudaico di Romaposto sulle pendici dell’Aventino prospiciente il Circo Massimo, ilfamoso Ortaccio degli ebrei (82), fu ribadita da papa Pio VI (1775-1799) nel 1775 e rimase in vigore sino al 1846, anno in cui papa PioIX (1846-1878) nel primo anno di pontificato la revocò (83).
(77) Per tale candelabro, la menorah, e per tutti gli altri numerosi simboli del repertoriofigurativo giudaico presente nelle catacombe romane si veda la monumentale opera di E. R.GOODENOUGH, Jewish Symbols in the Greco-Roman Period, I-XIII, New York 1953-1968 e inparticolare II, pp. 3-50.
(78) Cfr. Temi di iconografia paleocristiana, a cura di F. Bisconti, Città del Vaticano2000, p. 14.
(79) A. BOSIO, Roma sotterranea, cit., p. 143.(80) Cfr. A. ZANOTTO, L’atteggiamento della Chiesa, cit., p. 44.(81) Cfr. A. MILANO, Storia, cit., p. 453.(82) Cfr. U. GNOLI, Topografia e toponomastica di Roma medievale e moderna, Roma
1939, 52, 195, e A. ESPOSITO, Gli Ebrei romani, cit., p. 148.(83) Cfr. A. MILANO, Il cimitero ebraico sull’Aventino, in «La Rassegna mensile di
Israel », IX (1934), pp. 243-245.
« DEL CIMITERIO DE GLI ANTICHI HEBREI» 35
Certamente è interessante notare che, pur se, come si è accenna-to, il rinvenimento della catacomba nel XX secolo probabilmente ri-guardò una parte del cimitero non indagata nel Seicento (84), la gran-de menorah dipinta descritta e pubblicata in disegno dal Bosio, chela vide sul muro di fondo di una galleria cieca (« in capo d’vna stra-da, che non hà esito, si vede dipinto di color rosso sopra li monu-menti »), fu riconosciuta dagli scavatori moderni che inequivocabil-mente la identificarono in una grande decorazione alta circa 1 metroposta su una parete occupata da più loculi sovrapposti (85), a testimo-nianza del fatto che almeno una parte della riscoperta interessò l’a-rea delle perlustrazioni bosiane. Ma il Bosio sottolinea anche comeil candelabro a sette braccia era possibile osservarlo impresso sullelucerne, rinvenute tutte estremamente frammentarie, ad eccezione diun unico esemplare che si riporta in disegno: «ritrouammo ancoraquiui molte lucerne di terra cotta rustiche, e rozze, e quasi tutte rot-te: vna solamente intiera, nella quale era impresso il sudetto Cande-labro » (86). Tale particolare, congiunto alla già ricordata devastazionedelle iscrizioni funerarie, se da un lato è significativo per provare lalunga frequentazione del cimitero anche a scopo vandalico, dall’altroè altresì indicativo per sottolineare il grande numero di lucerne esi-stenti in tali gallerie, come anche lo scavatore del principio del XXsecolo notò, portando l’eloquente esempio di ben circa cinquantalucerne rinvenute in un segmento di galleria di poco più di 2 metridi lunghezza (87).
Dai numerosi indizi raccolti l’erudito antiquario maltese conclu-de, pur rimettendosi al giudizio più sereno dei posteri, che le galle-rie da lui rinvenute presso la collina di Monteverde sulla via Por-tuense siano senza dubbio quelle di un cimitero ebraico: «dal nonritrouarsi dunque in questo Cimiterio segno alcuno di Christianità:dall’hauer letto in vn frammento, che si trouò d’vn’Iscrittione, que-
(84) Cfr. C. VISMARA, I cimiteri, cit., p. 362.(85) Cfr. N. MULLER, Il cimitero degli antichi ebrei posto sulla via Portuense, in «Disserta-
zioni della Pontificia Accademia Romana di Archeologia », ser. II, XII (1915), p. 258 e tav. XI, 1.(86) A. BOSIO, Roma sotterranea, cit., p. 143.(87) Cfr. N. MULLER, Il cimitero, cit., p. 245. Per le tipologie delle lucerne attestate pres-
so tale cimitero si veda M. T. PALEANI, Su alcune lucerne fittili rinvenute nella catacombaebraica di Monteverde a Roma, in Historiam pictura refert. Miscellanea in onore di padre Ale-jandro Recio Veganzones O.F.M., Città del Vaticano 1994, pp. 407-423.
36 MASSIMILIANO GHILARDI
sta parola concisa, CU N A G W G, cioè Sinagog; e dalle altre cose so-pradette habbiamo giudicato, e crediamo fermamente, che questofosse il proprio Cimiterio de gli antichi Hebrei, rimettendoci però àpiù sano, e miglior giuditio» (88).
Il «miglior giuditio» auspicato dal Bosio, tuttavia, tardò ad arri-vare, poiché il cimitero giudaico della via Portuense, già parzialmen-te franato e certamente instabile al tempo della sua visita, precoce-mente dovette cadere in oblio (89). Il richiamo stimolato dal suo rin-venimento infatti, se comparato ad esempio al grande successo ori-ginatosi dal recupero della catacomba ‘‘ anonima di via Anapo’’, chefu certamente strumentalizzata dalla Chiesa a fini propagandistici edella quale sopra volutamente si sono ripercorse alcune tappe, do-vette essere ben limitato e anche cercando di recuperare ulterioridati da fonti contemporanee anche non ebraiche si può comprende-re che la ricezione di tale scoperta a livello sociale fu praticamentenulla. L’oblio che interessò le gallerie cimiteriali ebraiche della viaPortuense, anche se dunque in parte imputabile a cause naturali,ovvero al cedimento strutturale delle stesse, in parte può aiutare acomprendere lo scarso interesse dell’opinione pubblica seicentescaverso le testimonianze antiche della comunità giudaica e la limitataimportanza della componente ebraica nel mondo della cultura, dalquale progressivamente gli ebrei furono estromessi (90).
Dovette trascorrere circa un secolo e mezzo dalla scoperta bo-siana, a giudicare dalle menzioni letterarie, prima che le gallerie del-la catacomba ebraica di Monteverde potessero tornare ad essere in-dagate; in esse, infatti, dovette penetrare per primo dopo il Bosiol’oratoriano veronese Giuseppe Bianchini (91), nominato segretariodell’Accademia di Storia Ecclesiastica per volontà di papa BenedettoXIV, il ricordo della visita del quale ci è trasmesso nella descrizione
(88) A. BOSIO, Roma sotterranea, cit., p. 143.(89) Cfr. D. MAZZOLENI, Le catacombe, cit., p. 293, e C. VISMARA, I cimiteri, cit., p. 361.(90) Per il graduale irrigidimento dell’isolamento culturale verso la componente ebraica,
pur alternato a fenomeni momentanei di processi di ristrutturazione inversi all’elitismo antie-braico di derivazione tardomedievale, si vedano le considerazioni di R. BONFIL, Lo spazio cul-turale degli ebrei d’Italia fra Rinascimento ed Età barocca, in Gli ebrei, cit., pp. 413-473, par-tic. pp. 421-423.
(91) Per conoscere meglio la sua personalità è consigliabile la visione di S. ROTTA, s.v.Bianchini, Giuseppe, in Dizionario Biografico degli Italiani, X, Roma 1968, pp. 200-205.
« DEL CIMITERIO DE GLI ANTICHI HEBREI» 37
della via Portuense nel libro I dell’opera dell’incisore siciliano Giu-seppe Vasi (92). Il ricordo dell’esistenza del cimitero ci è trasmesso poi,l’anno successivo alla menzione del Bianchini, da Ridolfino Venuti (93)
che lo cita discorrendo di alcune iscrizioni greche (94), ma è solo con lavisita di Gaetano Migliore, nel decennio compreso tra il 1770 e il1780 (95), che si tentò una nuova indagine archeologica del monumen-to sotterraneo (96). Le sue parole, conservate in un documento mano-scritto depositato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, sono tut-tavia indicative per far comprendere l’elevato stato di avanzato degra-do delle gallerie e dei cubicoli e i pericoli che lo stesso esploratoredovette correre per indagarne solo un piccolo settore (97). Le frane delfragile sottosuolo dovettero, però, aumentare se nessun altro appas-sionato ricercatore si cimentò nel recupero del cimitero giudaico pri-ma della ricognizione operata dal gesuita padre Giuseppe Marchi incompagnia dell’ingegnere Temistocle Marucchi e dell’architetto Fran-cesco Fontana nel gennaio del 1843 (98); già in occasione di tale perlu-
(92) Cfr. G. BIANCHINI, in G. VASI, Delle magnificenze di Roma antica e moderna, I-X, Ro-ma 1747-1761, I, p. 70: « il Bosio vi ritrovò anche un Cimitero degli antichi Ebrei; ed io serven-do di compagnia all’Emo, e celebratissimo Letterato e Antiquario il Sig. Cardinal Passionei, fuia visitarlo; e molte Iscrizioni vi osservai, e molti simboli, allusivi ai loculi sepolcrali di quella in-felicissima Gente. Tra le altre cose v’era in più lapidi il candelabro con le sette lucerne».
(93) Per conoscere più da vicino la personalità di tale studioso nato a Cortona nel 1705 efondatore, assieme ai fratelli Filippo e Niccolò Marcello e al prozio abate Onofrio Baldelli,dell’Accademia Etrusca Cortonese si veda il ritratto di P. DUCATI, s.v. Venuti, Ridolfino, inEnciclopedia Italiana, XXXV, Roma 1950, p. 139.
(94) R. VENUTI, Dissertazione sopra due antiche greche iscrizioni, in «Giornale de’ Lette-rati di Roma», (1748), p. 147.
(95) Cfr. J. B. FREY, Corpus, cit., p. 207.(96) Il numeroso materiale epigrafico rinvenuto nelle ricognizioni settecentesche fu di-
sperso in diverse collezioni; per seguire le vicende di tali iscrizioni, custodite presso il MuseoBorgiano di Velletri, il Museo Borbonico di Napoli, il Museo Epigrafico del Laterano, il Mu-seo Kircheriano e la collezione di San Paolo fuori le mura si veda J. B. FREY, Corpus, cit.,pp. 207-208.
(97) Cod. Vat. Lat. 9143, f. 127b: «et quantum quidem per imminens periculum, ac ter-rae rimas irrepere licuit, concamerati operis ruinoso pariete reliquias, non sine praeruptis inmuro cinerariis cellulis, oculatus testis inspexi; ac certe hebraicorum etiam emblematum pro-trita hac illac fragmenta videre sum visus. Sed quando fugientes ex vetustate, et dubia, ut interrae visceribus, luce lineas in muro assequi adlaboro, congesta ibi temere lapidum strues,ac ruitura iam iam in caput unde unde saxa, saniori consilio pedes foras emittere suaserunt».
(98) Cfr. G. MARCHI, Monumenti delle arti cristiane primitive nella metropoli del Cristia-nesimo, Roma 1844, p. 21: «era gran tempo ch’io avevo interrogato i viventi nostri cavatoride’ cimiterj, e fatto interrogare i padroni tutti e coltivatori delle vigne che sono sulla falda
38 MASSIMILIANO GHILARDI
strazione, però, non si riuscì ad identificare l’accesso alla catacomba eci si dovette convincere che «gli accessi al giudaico cimitero di Mon-te Verde si sono interamente sottratti all’occhio e al piede del ricerca-tore » (99). Alcuni anni più tardi il fratello minore del grande archeolo-go Giovanni Battista de Rossi (100), Michele Stefano, geologo e geofisicoche per alcuni anni diresse l’Osservatorio geodinamico di Rocca diPapa (101), redigendo un’attenta analisi geologica ed architettonica dellecatacombe romane, pubblicata ne La Roma sotterranea cristiana, con-statò – assieme ai mutamenti morfologici dell’intero colle di Monte-verde – il completo crollo del cimitero (102).
Le ricerche condotte anche a titolo personale da amanti delleantichità al fine di riportare alla luce le vestigia dell’antico cimiterogiudaico, delle quali esemplare testimonianza preziosa ci è fornitadal Lanciani (103), furono in un certo senso coronate quando, sul finiredi ottobre dell’anno 1904, la Commissione di Archeologia Sacra fuavvisata del rinvenimento di alcune gallerie ipogee nell’area della vi-gna di proprietà dei marchesi Pellegrini Quarantotti, situata circa unchilometro e mezzo fuori Porta Portese (104), vicino all’attuale stazione
dal Bosio descritta, se mi sapevano dar conto di qualche bocca che mettesse in quelle spe-lonche: ma niuno mai aveva saputo darmi risposta che m’appagasse. Aspettai quindi il gen-najo di questo 1843, quando terminata colà la potatura delle viti, il terreno si rimane ignudoper modo, che di se non può nascondere nè una piega sola. In tre diversi giorni, avendo acompagni l’ingegnere Temistocle Marucchi, l’architetto Francesco Fontana e qualc’altro dique’molti che sogliono esser meco in cotali esplorazioni, esplorai palmo a palmo tutta la col-lina, senza potermi imbatter mai nella bocca ch’era l’oggetto unico di mie ricerche».
(99) Ibidem.(100) Cfr. N. PARISE, s.v. de Rossi, Giovanni Battista, in Dizionario Biografico degli Italiani,
XXXIX, Roma 1991, pp. 201-205.(101) Cfr. P. CORSI, s.v. de Rossi, Michele Stefano, in Dizionario Biografico degli Italiani,
XXXIX, Roma 1991, pp. 230-235.(102) Cfr. G. B. DE ROSSI, La Roma sotterranea, cit., I, p. 50: «sul Monte Verde era il ce-
metero degli Ebrei trovato dal Bosio, ed ora per i naturali cambiamenti del colle al tuttoscomparso ».
(103) Racconta, infatti, il Lanciani che nell’anno 1892 per intere settimane fu testimoneoculare dei tentativi vani di un ricercatore dilettante, pittore di professione ma del quale almomento di redigere tale memoria aveva dimenticato il nome, di scavare un passaggio attra-verso un denso strato di terra sciolta, in un’area che era stata puntellata da un giardiniere al-l’ingresso di quello che costui aveva definito essere un ‘‘palazzo sotterraneo’’; cfr. R. LANCIA-NI, New Tales of Old Rome, London 1901, p. 247.
(104) Cfr. N. MULLER, Il cimitero, cit., pp. 217-219. La notizia del ritrovamento ci è altresìtestimoniata, ad esempio, da alcune memorie di contemporanei: si può, infatti, leggere in un
« DEL CIMITERIO DE GLI ANTICHI HEBREI» 39
di Trastevere e più precisamente tra il cimitero di Ponziano e que-st’ultima (105). L’indagine archeologica, subito mostratasi complessaper la friabilità eccessiva del materiale tufaceo nel quale le gallerieerano ricavate, fu affidata dall’allora Segretario della Commissionedi Archeologia Sacra barone Rodolfo Kanzler, in accordo con l’I-spettore della stessa Augusto Bevignani, al professore universitariotedesco Nikolaus Müller, che da circa un ventennio si occupava ap-profonditamente delle antichità giudaiche di Roma e che pochi anniprima, il 12 aprile dell’anno 1885, si era reso protagonista del rinve-nimento del cimitero giudaico della via Appia Pignatelli (106). Gli sca-vi, come previsto resi difficili da continue frane e cedimenti del ter-reno, iniziarono alla fine del mese di novembre del 1904 e, compati-bilmente con i doveri di professore universitario del responsabiledelle operazioni scientifiche – come egli stesso fu costretto ad am-mettere –, proseguirono nel 1905 e 1906 con aiuti finanziari offertidalla «Società Berlinese per l’incremento della scienza del Giudai-smo » (107). I risultati, tuttavia, nonostante le numerose difficoltà in-contrate dagli scopritori furono decisamente sorprendenti e dalledescrizioni del Müller è possibile comprendere che, oltre l’area giàdescritta dal Bosio, si poterono investigare regioni del cimitero maiprima di quel momento esplorate (108). Fu, infatti, possibile riconosce-
appunto del Lanciani redatto il 18 febbraio dell’anno successivo (cfr. Notes from Rome byRodolfo Lanciani, a cura di A. L. Cubberley, Roma 1988, pp. 399-400) e in una lettera invia-ta da Seymour de Ricci alla Académie des Inscriptions et Belles-Lettres di Parigi (si veda in« Comptes rendus de l’Académie des inscriptions et belles-lettres» [1905], pp. 245-247).
(105) Cfr. C. VISMARA, I cimiteri, cit., p. 361.(106) Cfr. N. MULLER, Le catacombe degli Ebrei presso la via Appia Pignatelli, in «Mittei-
lungen des Deutschen Archäologischen Instituts Römische Abteilung », I (1886), pp. 49-56.(107) Cfr. N. MULLER, Il cimitero, cit., p. 219.(108) Sul muro di chiusura di un loculo, in realtà, durante gli scavi dell’inizio del XX se-
colo fu possibile scorgere, tracciata a carboncino, la firma del Toccafondi (cfr. G. SCHNEIDER
GRAZIOSI, La nuova sala giudaica nel Museo Cristiano Lateranense, in «Nuovo Bullettino diArcheologia Cristiana», XXI (1915), p. 13, nota 2) che, non avendo partecipato all’esplora-zione guidata dal Bosio del dicembre dell’anno 1602, aveva evidentemente ispezionato per-sonalmente ulteriori gallerie non visitate dal maltese; ciò, confortando quanto sopra propo-sto – ovvero le peregrinazioni solitarie del pittore romano alla ricerca di reliquie e materialiarcheologici (cfr. supra, nota 57) –, potrebbe dunque spiegare l’espressione del Bosio presen-te nella Roma sotterranea che indicava per certo l’esistenza di ulteriori gallerie difficilmentepraticabili: «se bene si conosceua esserui de gli altri aditi», permettendoci di ipotizzare nelToccafondi l’informatore dell’esploratore maltese.
40 MASSIMILIANO GHILARDI
re l’accesso originario alla catacomba – un ampio vestibolo e seigradini che portavano alla prima galleria ipogea – e si documentò,contrariamente alle descrizioni bosiane, un grande numero di tipolo-gie funerarie (109), quattro cubicoli (110) e loculi contraddistinti da ricchicorredi applicati esternamente alle chiusure (111). Sulla base dei nuoviscavi, che contribuirono a documentare una catacomba ben più va-sta di quella che era possibile presumere in base alle precedentiesplorazioni (112), si poté redigere una planimetria affidabile delle gal-lerie (113) e si formulò, principalmente basandosi sulle numerose epi-grafi rinvenute (114), una prima cronologia del monumento sotterraneo.L’errata interpretazione di un accurato epitaffio redatto in lingua la-tina fece supporre allo scavatore un’origine del cimitero nel I secolod.C. (115) – ipotesi condivisa da molti studiosi (116) –, pur se già negli an-ni trenta padre Antonio Ferrua sosteneva con forza una datazioneche non poteva spingersi più indietro del III secolo (117) e con lui si èschierata la maggior parte degli studiosi moderni (118).
(109) Cfr. N. MULLER, Il cimitero, cit., p. 221.(110) Ibidem, 225. A. BOSIO, Roma sotterranea, cit., p. 143 aveva documentato l’esistenza
di due soli cubicoli.(111) Cfr. N. MULLER, Il cimitero, cit., pp. 249-252.(112) L’edizione definitiva degli scavi è stata pubblicata da N. MÜLLER, Die jüdische Kata-
kombe am Monteverde zu Rom, Leipzig 1912.(113) Sulla base della pianta redatta e pubblicata dal Müller e dalle descrizioni che lo
stesso fa delle gallerie è stata saggiamente proposta l’esistenza di tre distinte regioni cimite-riali; cfr. C. VISMARA, I cimiteri, cit., p. 365.
(114) Cfr. supra, nota 73. Le iscrizioni recuperate negli scavi del Müller furono donate pergentile concessione dei marchesi Pellegrini Quarantotti, proprietari della vigna ove eranostate recuperate, al Museo Cristiano Lateranense che fu, per l’occasione, dotato di una nuo-va sala espositiva; cfr. G. SCHNEIDER GRAZIOSI, La nuova sala, cit., pp. 13-56. Per una accura-ta bibliografia epigrafica si veda quanto raccolto da J. B. FREY, Corpus, cit., pp. 208-211.
(115) Cfr. N. MULLER, Il cimitero, cit., pp. 302-305.(116) Cfr. J. B. FREY, Corpus, cit., p. LV.(117) Cfr. A. FERRUA, Sulla tomba dei Cristiani e su quella degli Ebrei, in «La Civiltà Cat-
tolica », LXXXVII (1936), 4, p. 309.(118) Cfr. D. MAZZOLENI, Le catacombe, cit., p. 294 e C. VISMARA, I cimiteri, cit., p. 359; ad
una datazione di I secolo pensa, invece, H. G. LEON, The Jews of Ancient Rome, Philadel-phia 1960, p. 66, pur se il suo lavoro è stato sottoposto ad un severo giudizio della critica. Sene vedano, dunque, i commenti e i limiti segnalati da E. M. SMALLWOOD, in «Journal of Ro-man Studies», LI (1961), pp. 243-244; A. MOMIGLIANO, in «Gnomon », XXXIV (1962), pp.178-182; F. M. HEICHELHEIM, in «Phoenix », XVI (1962), pp. 135-137.
« DEL CIMITERIO DE GLI ANTICHI HEBREI» 41
Negli ultimi mesi dell’anno 1913, nella stessa area ma in pro-prietà Rey, tornarono casualmente alla luce poche gallerie apparte-nenti ad una nuova regione mai indagata del cimitero giudaico; laCommissione di Archeologia Sacra in accordo con la Sovraintenden-za ai monumenti, riconosciute le critiche condizioni di quanto sco-perto e vista l’impossibilità di poter conservare il monumento perl’alto rischio di crolli, decise, sotto la supervisione degli ispettoripontifici Enrico Josi e Giorgio Schneider Graziosi (119), di spogliare legallerie di tutta la suppellettile archeologica, e tale dolorosa sceltadovette tuttavia rivelarsi vincente, poiché nel 1915 tale area del ci-mitero era già andata completamente distrutta (120). Anche quanto ri-maneva del restante settore del cimitero giudaico, ciò che era statoriportato alla luce dalle campagne di scavo di inizio secolo, andòcompletamente e definitivamente perduto in una rovinosa frana, unadelle centinaia che dovettero interessare il fragile suolo della zona,verificatasi – come una relazione ufficiale, redatta al fine di docu-mentare la realizzazione di un piano di sviluppo edilizio destinatoalla costruzione di case popolari, ci testimonia (121) – il 14 ottobre del1928. Le cause che concorsero a tale devastante crollo, oltre allacattiva qualità naturale del suolo, vanno ricercate, secondo quanto ilDe Angelis d’Ossat ha potuto ricostruire nella sua analisi geologicadelle catacombe romane, nella poca compattezza dello strato geolo-gico nel quale erano scavate le gallerie e principalmente nel fattoreantropico, che è da riconoscersi nella sempre più frequente e indi-scriminata asportazione del materiale tufaceo dell’area – il celebretufo di Monteverde – e nello spianamento continuo del terreno vol-to a creare aree fabbricabili (122).
La revisione storiografica dei documenti e degli studi sul cimite-
(119) Per un brevissimo ritratto dello Schneider Graziosi, valente conoscitore di questionicimiteriali caduto in combattimento sul Carso nel Settembre del 1916, si veda G. BOVINI,Rassegna degli studi sulle catacombe e sui cimiteri ‘‘ sub divo ’’, Città del Vaticano 1952,pp. 88-89.
(120) Per la notizia del rinvenimento e una pianta schematica del cimitero si veda R. KAN-ZLER, Scoperta di una nuova regione del cimitero giudaico della Via Portuense, in «Nuovo Bul-lettino di Archeologia Cristiana», XXI (1915), pp. 152-157.
(121) Cfr. F. PIPERNO, Relazione sul disastro del 14 ottobre 1928, Roma 1929.(122) Cfr. G. DE ANGELIS D’OSSAT, La geologia delle catacombe romane, Città del Vaticano
1938, pp. 25-27.
42 MASSIMILIANO GHILARDI
ro giudaico della via Portuense o di Monteverde permette, dunque,una buona serie di considerazioni sul monumento stesso e, cosa for-se assai più interessante perché del tutto trascurata, sulla società deltempo della prima esplorazione del Bosio. La ricezione che si ebbea livello sociale di tale rinvenimento dovette essere, anche a causadella scarsa propaganda che se ne fece, assai minima e per com-prendere tale aspetto può certamente risultare indicativo il confron-to con la scoperta contemporanea del cimitero della via Salaria. Lainsufficiente divulgazione del cimitero, che certamente non avevameriti per essere coinvolto nel vasto dibattito riformistico che si ori-ginò sulla Chiesa primitiva, congiunta al cattivo stato di conservazio-ne delle gallerie permise che di esso si perdessero assai presto letracce. Le parole del Bosio, tuttavia, consentono, essendo in un cer-to senso lo studioso la voce ufficiale della Chiesa barocca, di com-prendere l’atteggiamento delle gerarchie ecclesiastiche nei confrontidel mondo ebraico; i luoghi comuni e le parole irrispettose proferitedall’antiquario maltese riflettono, dunque, il pensiero del mondodotto seicentesco, del quale l’autore della Roma sotterranea è certa-mente uno dei maggiori rappresentanti. Alcune sue espressioni discherno e disprezzo verso la comunità israelita consentono a pienotitolo di porre la sua monumentale opera, limitatamente tuttavia alladescrizione del rinvenimento del cimitero ebraico, accanto alla lungaserie di opere a stampa di carattere antiebraico che videro la lucetra la metà del secolo XVI e i due successivi (123). La descrizione delcimitero di Monteverde, utilizzata sino ai nostri giorni solo per finiarcheologici ed antiquari, potrebbe perciò aiutare ad illustrare ecomprendere, secondo le linee di ricerca tracciate da Robert Bon-fil (124), generalmente accettate dagli studiosi (125), il modo di percepire il
(123) A proposito della letteratura antiebraica stampata in Italia in tale arco di tempo sivedano le considerazioni di F. PARENTE, Il confronto ideologico tra l’Ebraismo e la Chiesa inItalia, in Italia Judaica, Atti del I Convegno internazionale, Bari 18-22 maggio 1981, Roma1983, pp. 303-381.
(124) Cfr. R. BONFIL, Società cristiana e società ebraica nell’Italia medievale e rinascimenta-le: riflessioni sul significato e sui limiti di una convergenza, in Ebrei e cristiani nell’Italia me-dievale e moderna: conversioni, scambi, contrasti, Atti del VI Congresso internazionale del-l’AISG, San Miniato 4-6 novembre 1986, a cura di M. Luzzati - M. Olivari - A. Veronese, Ro-ma 1986, 238, p. 244.
(125) Alcuni studiosi, in realtà, ritengono che frequenti e reciproci dovettero essere i con-tatti e gli scambi culturali tra ebrei e cristiani (cfr. G. SERMONETA, L’incontro culturale tra
« DEL CIMITERIO DE GLI ANTICHI HEBREI» 43
mondo ebraico a partire dal tardo Rinascimento, contribuendo per-tanto a sottolineare la urgente necessità di mutare l’immagine idillia-ca del mondo ebraico italiano del Cinque e Seicento, visto dalla co-mune critica storiografica in profonda fusione intellettuale e socialecol mondo dei cattolici (126).
MASSIMILIANO GHILARDI
ebrei e cristiani nel Medioevo e nel Rinascimento, in M. Luzzati - M. Olivari - A. Veronese,Ebrei e cristiani, cit., pp. 183-184), mentre molti altri hanno condiviso le teorie di Bonfil; cfr.C. VIVANTI, Storia degli ebrei in Italia e storia d’Italia, in «Studi Storici», XXXI, (1990), 2, p.357 (saggio ora ripubblicato in Corrado Vivanti. Incontri con la storia. Politica, cultura e so-cietà nell’Europa moderna, a cura di M. Gotor - G. Pedullà, Roma 2001, pp. 409-461).
(126) Cfr. R. BONFIL, The Historian’s Perception of the Jews in the Italian Renaissance: To-wards a Reappraisal, in «Revue des études juives», CXXXIV (1984), pp. 59-82.