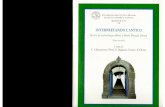Alla Scoperta del Cielo, Libretto per insegnanti Scuola secondaria
Transcript of Alla Scoperta del Cielo, Libretto per insegnanti Scuola secondaria
Alla scoperta
Dai banchi
di scuola
all’Universo:
Sistema
Solare,
stelle,
galassie…
FASCICOLO PER GLI INSEGNANTI
DELLA SCUOLA SECONDARIA
del cielo!
Alla Scoperta del Cielo! è un progetto educazionale
dell’Istituto Nazionale di Astrofisica
in collaborazione con il Settore Istruzione
del Comune di Bologna
Ideazione e testi di Leopoldo Benacchio, Istituto
Nazionale di Astronomia e Angela Turricchia,
Comune di Bologna, Settore Istruzione
Questo è il fascicolo per gli Insegnanti
della Scuola Secondaria
Il progetto è comprensivo di un sito Web:
www.scopriticielo.it
e-mail per comunicazioni, commenti
e suggerimenti: [email protected]
Alla realizzazione del sito ed al Progetto
hanno collaborato:
Caterina Boccato, Melania Brolis,
Elena Lazzaretto, Luca Nobili, Serena Pastore
(Istituto Nazionale di Astrofisica)
Un ringraziamento va agli oltre 1.500 insegnanti
che, nel periodo 2002-2005, hanno adottato
il Progetto nelle loro classi e, con le loro
osservazioni, hanno permesso di migliorarlo
e renderlo più fruibile.
Un particolare ringraziamento anche a
Gianfranco De Zotti, INAF - Osservatorio
di Padova, per le molte utili discussioni che
abbiamo avuto su come rendere comprensibili
le attuali teorie cosmologiche mantenendo
un accettabile livello di coerenza scientifica.
Grafica: Studio Link (www.studio-link.it)
Stampa: Stella srl, Trieste
In collaborazione con Editoriale Scienza srl
via Romagna 30 - 34134 Trieste
tel. 040.364810 - fax 040.364909
e-mail: [email protected]
www.editscienza.it
Dai banchi
di scuola
all’Universo:
Sistema
Solare,
stelle,
galassie…
FASCICOLO PER GLI INSEGNANTI
DELLA SCUOLA SECONDARIA
Alla scoperta
del cielo!
5
1. Cos’è “Alla Scoperta del Cielo” e come è organizzato.
Il progetto “Alla scoperta del Cielo” è di divulgazione inambiente didattico.
Cosa intendiamo con divulgazione in ambiente didatti-co? Sappiamo perfettamente che il lavoro didattico spet-ta all’insegnante di classe che conosce i bisogni culturalie umani dei suoi studenti, sappiamo però anche che l’A-stronomia è un buon veicolo per avvicinare i ragazzi/eallo studio delle materie scientifiche, proprio per il fasci-no che esercita su di loro. L’Astronomia, in altre parole, èuna buona “leva” per stimolare curiosità, coinvolgere ipropri studenti, farli agire e pensare anche in prima per-sona. Particolare non trascurabile poi è che si prestabene a “sperimentare” con strumenti poveri, fatti conmateriali semplici, poco costosi, facilmente reperibili.
Sappiamo peraltro che per questa materia, sia sui libri ditesto per le scuole che nei volumi di divulgazione, si tro-va molto spesso una trattazione o frettolosa, poco com-prensibile, quando addirittura con errori concettuali, ouna che indulge troppo a una presentazione “sensazio-nalistica” della materia, quasi pervasa da un bisognoimpellente di stupire a tutti i costi. Entrambi questiapprocci, purtroppo così frequenti, non coinvolgono glistudenti, se non marginalmente, non li attivano e inte-ressano. Inoltre, e questo è ancora più grave, spessoinducono chi legge a farsi concezioni errate.
Nostro obiettivo, con “Alla Scoperta del Cielo”, è quellodi offrire materiale scientificamente corretto, già speri-mentato in molte classi e da molti insegnanti e, soprat-tutto, che si possa prestare ad una personalizzazioneda parte vostra; a questo materiale voi potrete applica-re i vostri metodi, le vostre modalità di insegnamento/apprendimento tenendo conto della realtà della vostraclasse, di quali caratteristiche ha, delle difficoltà cherichiedono attenzione, dei tempi vostri e della vostraclasse.
Per questo diciamo che il materiale è di tipo divulgativoe voi potrete inserirlo all’interno della vostra program-mazione didattica.
Per ultimo richiamiamo un concetto semplice ma moltoimportante. Certamente parliamo di Astronomia, e quin-di pianeti, stelle e tutto il resto, ma, come siamo sicuripotrete constatare anche voi, questo percorso fa capiree interiorizzare bene ai ragazzi/e alcuni concetti di basesul metodo delle scienze in generale, come la necessitàdi osservare i fenomeni con cura, misurarli, provare ariprodurli. Astronomia quindi, ma anche parecchio di piùed in un modo che speriamo sia piacevole e stimolanteanche per voi.
Il progetto tocca praticamente ogni argomento impor-tante dell’Astronomia, dal Sistema Solare fino alla costi-tuzione dell’Universo. È strutturato su tre “tappe”, unsostantivo usato soprattutto in funzione dei ragazzi/e. Sitratta ovviamente di 3 sezioni principali in cui viene divi-sa la materia complessiva per i ragazzi/e di tutte le età,che costituiscono, nel loro svolgimento, sia un amplia-mento del punto di vista dell’osservatore, sia uno “svolgi-mento evolutivo” storico delle conoscenze umane:
• Il Sistema Solare• Le Stelle• Galassie ed Universo
Ogni sezione/tappa è divisa in 3 o 4 “notti” di osserva-zione, in un Osservatorio Astronomico di fantasia, in cuivengono introdotti i vari argomenti, suggerite esperien-ze e qualche spunto di riflessione e gioco. Ovviamentequesta metafora, le notti negli Osservatori Astronomicidi Monte Verde, Azzurro e così via è per i ragazzi/e, e lapotrete o meno utilizzare.
I materiali forniti sono di due differenti tipi: cartaceo esito Web. Il motivo di questa dicotomia è semplice: l’A-stronomia oggi è una Scienza che produce ed utilizzasplendide immagini a colori. L’inserimento di questeimmagini di altissima qualità in un libro porterebbe i
1.1 Come è strutturato il Progetto ed i suoi materiali di base
6
costi ad un livello impossibile da affrontare per la mag-gior parte delle classi.
Ecco quindi che i materiali principali, e comunque com-pleti ed autoconsistenti, vengono distribuiti su carta,mentre approfondimenti ed immagini vengono veicolatiattraverso il sito Web del progetto www.scopriticielo.it.Questo peraltro permette anche di rinnovare, o meglioaggiornare, il sito stesso con nuove immagini via via chesi rendono disponibili.
Il materiale cartaceo è disponibile, in forma elettronicaovviamente, nel sito, da dove può essere preso e fotoco-
piato per gli studenti, oppure in pratici e semplici volu-metti, che vengono spediti a un prezzo simbolico graziead una sponsorizzazione dell’iniziativa da parte dell’Isti-tuto Nazionale di Astrofisica ed al lavoro di tutti coloroche hanno contribuito al progetto, che viene fornito gra-tuitamente e libero da diritti d’autore.
D’ora in avanti parleremo del materiale cartaceo riferen-doci ai volumetti, ma eguali considerazioni valgono perle singole parti che, chi non li ha richiesti, potrà reperiredi volta in volta nel sito.
Svolgere tutto il contenuto del progetto, considerato iltempo che si può dedicare alle Scienze, può arrivare adimpegnare una classe per gran parte dell’anno scolastico.È quindi una scelta forte ed impegnativa che magari nontutti si sentiranno, o potranno, prendere. Ed infatti il mate-riale, ed il Progetto, sono strutturati per essere divisi in tretronconi, le tre “tappe” di cui abbiamo parlato poco sopra.È quindi possibile praticarne solo una, ovvero uno degliargomenti principali. Seguendo quanto diremo su ognisingola tappa sarete perfettamente in grado di sceglierequale seguire per ogni classe, ovviamente se non volete opensate di avere la possibilità di seguire tutta la materia.
Questa possibilità di adottare solo una o due delle tretappe è particolarmente interessante in quanto potretecomunque seguire per tutto l’anno l’iniziativa con la clas-se, anche una volta che avrete esaurito la materia cheavete scelto.
Infatti ogni due settimane invieremo a tutti gli insegnan-ti iscritti al progetto un contributo da passare agli stu-denti, ma più “leggero” come ad esempio un aggiorna-
mento sulle scoperte astronomiche più recenti, un com-mento a notizie eventualmente comparse su giornali oTV, notizie e curiosità sulle imprese spaziali. In altreparole riceverete ogni due settimane una sorta di “bol-lettino” che potrete usare con le vostre classi per mante-nere vivo ed attuale l’interesse dei ragazzi/e tutto l’anno,senza dover impiegare troppo tempo e anche se decide-te di svolgere solo una parte della materia proposta, o didistribuirla su più di un anno scolastico.
Il progetto inizia a novembre e termina a maggio.Anche la distribuzione del materiale addizionale per glistudenti e la pubblicazione delle varie parti del sitoandrà di pari passo.
Durante tutto il periodo verranno comunque propostealtre iniziative utili per coinvolgere i ragazzi/e, chepotrete altrettanto decidere se utilizzare o meno: tra-smissioni radio dedicate sia tramite varie radio locali chesu Web e visite agli Osservatori Astronomici e Laborato-ri dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, presenti in moltecittà italiane.
Tutte le classi che partecipano al Progetto possono par-tecipare al Concorso che viene indetto ogni anno. I lavo-ri delle classi dovranno essere coerenti con il tema pro-posto, che viene cambiato di anno in anno. La scadenzaper la presentazione dei lavori è a metà Aprile, i lavorisono esaminati da una giuria di astronomi, insegnanti e
giornalisti. I migliori lavori vengono ogni anno pubblica-ti sul sito del progetto.
I termini precisi del Concorso, tema, tipologia dei lavorie scadenze, vengono comunicati all’inizio di dicembrecon l’invio direttamente sulla vostra posta elettronica.
1.2 Quali sono i tempi del Progetto e gli altri materiali a disposizione
1.3 Il Concorso abbinato al Progetto
7
I volumetti per i ragazzi/e contengono un testo, suddivi-so in tre tappe:
1. Sistema Solare, 2.Stelle, 3. Galassie e Universo.
Ogni tappa è successivamente scomposta in notti diosservazione, 3 o 4 a seconda della tappa, in cui sonoinserite molte esperienze per rendere concreti e verifica-re alcuni concetti e che costituiscono l’argomento dellanottata di osservazione. Tali “esperienze” sono eviden-ziate anche graficamente nella parte cartacea per gli stu-denti, in quanto costituiscono analogie concrete a quel-lo che succede nel cielo. Sono, in altre parole, semplifi-cazioni che permettono di chiarire concetti più generali.
Inoltre, al termine di alcune notti virtuali, sono presentischede aggiuntive con esperienze di approfondimento ocostruzione di strumenti.
Nei prossimi paragrafi qui di seguito troverete invece:• alcune osservazioni e suggerimenti di carattere gene-
rale che vi potranno essere utili durante lo svolgimen-to in classe delle attività e che risultano dall’esperien-za della sperimentazione nelle classi e da domandeche alcuni di voi ci hanno inviato;
• una visione complessiva introduttiva delle singole tap-pe, con i punti fondamentali trattati nella tappa;
• scomposizione e commenti relativi alle singole notti diosservazione;
• ulteriori schede e letture appositamente preparate pervoi in modo che voi possiate decidere se presentarle aivostri ragazzi;
• suggerimenti su dove e come approfondire tematicheche eventualmente vi interessino o che noi riteniamoimportanti ed un po’ di bibliografia sia per voi che peri ragazzi;
• una proposta di verifica, in forma di gioco, per valuta-re complessivamente come i ragazzi hanno reagito aglistimoli culturali proposti e che voi potrete scegliere sesomministrare o meno ai ragazzi.
Abbiamo scelto di affrontare pochi, ma fondamentaliconcetti, che risultano poi essere comuni a tutte e tre le
tappe; questi concetti sono: campo di attrazione gravita-zionale, magnetico, radiazione.
Tutti gli esperimenti proposti sono assolutamente realiz-zabili, provati e replicati in moltissime classi dai ragaz-zi/e. Vi consigliamo comunque di “provare” personal-mente gli esperimenti prima di farli coi ragazzi, proprioper mettere in evidenza punti particolarmente difficolto-si per la vostra classe.
Vi suggeriamo di iniziare un argomento facendolo prece-dere da un brainstorming iniziale che permetta di mette-re in evidenza le conoscenze possedute dai ragazzi/e e leeventuali concezioni errate (misconceptions) già presen-ti nelle conoscenze pregresse dei vostri studenti. Per fareciò, come sapete, occorre porre domande mirate esoprattutto, essere molto attenti nella loro preparazionein quanto una domanda mal formulata può fuorviare ilragionamento dello studente e quindi il risultato puònon essere attendibile. Ne troverete alcune nelle singoletappe che risultano particolarmente diffuse e che abbia-mo ritenuto importante sottolineare.
In realtà sarebbe opportuno fare anche un’analisi delleproprie conoscenze che forse possono essere datate: adesempio quanti di noi non associano il termine fascia diasteroidi alla zona di asteroidi presenti tra Marte e Giovetrascurando totalmente quella zona enorme che costitui-sce la fascia di Kuiper? Sicuramente questa era un’ideacorretta finché non è stata rilevata l’esistenza di questafascia, ma ormai questa scoperta risale a circa 50 anni orsono e non può essere più presentata come novità, anchese persiste ancora come tale in alcuni libri di testo.
Le schede con esperienze varie o costruzioni di semplicistrumenti inseriti al termine di alcune notti di osserva-zione sono state proposte proprio come momenti termi-nali del lavoro e come approfondimenti; suggeriamo per-tanto di fare il possibile per eseguire le costruzioni nelcontesto in cui sono inseriti, altrimenti si rischia che per-dano la loro valenza formativa, facendo diventare tuttal’attività semplice bricolage.
Suggeriamo inoltre di fare il possibile per svolgere tuttele esperienze suggerite, possibilmente a piccoli gruppi,
2. I volumetti per gli studenti. Considerazioni generali.
8
in modo che ogni ragazzo/a possa interagire con i com-pagni e collaborare con loro per imparare a raccogliere idati delle esperienze, ad elaborarli, a discutere le ipotesifatte, ad utilizzare cioè un modo di procedere che èanche tipico della ricerca scientifica.
Permetteteci qualche considerazione su alcuni puntiimportanti sottesi da quanto appena detto.Agli studenti viene spesso data l’impressione che laconoscenza scientifica sia interamente costituita da “fat-ti” dimostrati. Diversi autori rilevano come le Scienzevengano presentate prevalentemente come insiemi difatti anziché come processo di continua ricerca. È statocalcolato che il 98% dell’insegnamento in classe si basasui libri di testo e che il 90% del lavoro che gli studentisvolgono a casa è strutturato da questi materiali.
In questo quadro generale, tipico della realtà della scuo-la italiana, e non solo ovviamente, il materiale che pre-sentiamo ai ragazzi/e prevede un lavoro personale e unmomento di “studio” anche individuale.
Può apparire, ad una osservazione superficiale, un sem-plice materiale di lettura e quindi leggibile e fruibilecome tale; in realtà all’interno del testo sono presentatemolte esperienze pratiche che andrebbero comunqueeseguite; questo è in altre parole, o almeno cerca diessere, un materiale “attivo” o, per meglio dire, cherichiede una partecipazione attiva. Ci rendiamo contoche il Laboratorio nella scuola secondaria ha una valenzadisciplinare e viene svolto in ambienti idonei apposita-mente predisposti; in questo caso le esperienze propostepossono essere svolte anche in classe e con materialepovero, ma è comunque importante che vengano svolte.Questo perché permettono di affrontare concetti chepoi, gli studenti stessi, dovranno trasferire, per analogia,ad altri ambiti o anche dovranno estenderne le applica-zioni a situazioni diverse. Questa situazione “diversa” èquello che viene definito un problema “insight” per la cuisoluzione c’è bisogno di una idea creativa; vengono cioèpresentati problemi che stimolano un pensiero di tipo“produttivo” e con “alta tensione cognitiva” e pertantoparticolarmente importanti per studenti della scuolasecondaria.
Ricordiamo che il Profilo educativo, culturale e profes-sionale, che rappresenta ciò che un ragazzo dovrebbesapere e fare al termine del primo Ciclo di istruzione (inquesto caso ci riferiamo esplicitamente ai ragazzi/e del-la scuola secondaria di primo grado) è declinato in diver-se articolazioni tra cui “il ragazzo si pone in modo attivo difronte alla crescente quantità di informazioni e di sollecita-zioni esterne, non le subisce ma le decifra, le riconosce, le
valuta anche nei messaggi impliciti negativi e positivi, che leaccompagnano”. Relativamente agli strumenti culturali ilragazzo, al termine del primo ciclo di istruzione, “osservala realtà, per riconoscervi relazioni tra oggetti, regolarità, …effettua misurazioni ...sviluppa atteggiamenti di curiosità,attenzione e rispetto della realtà naturale, di riflessione sul-le proprie esperienze, di interesse per i problemi e l’indaginescientifica; è consapevole che la comprensione dei concettiscientifici necessita di definizioni operative che si possonoottenere soltanto con la ricerca e con esperienze documen-tate e rinnovate nel tempo; comprende che i concetti e leteorie scientifiche non sono definitive, ma in continuo svi-luppo, al fine di cogliere aspetti sempre nuovi, diversi e piùcomplessi della realtà”.
Abbiamo insomma inserito schede al termine di alcunenotti di osservazione per offrire momenti in cui il “fare”,il documentare, il raccogliere dati ed informazioni vieneutilizzato come momento utile per approfondire le cono-scenze; ad esempio la costruzione del cannocchiale, chepure è di semplicissima esecuzione, può essere utilizzatatranquillamente come momento di approfondimentodelle tematiche relative all’ottica geometrica permetten-do così ai ragazzi di applicare conoscenze teoriche aduna attività “produttiva”.
Per quanto riguarda la parte di spettroscopia, invece, lacostruzione dello spettroscopio può costituire unmomento riepilogativo anche di verifica delle conoscen-ze acquisite proprio all’interno un problema “insight”come si diceva prima.La scheda di approfondimento relativa alla costruzionedelle immagini astronomiche, permetterà agli studentidi comprendere quanto le immagini mostrate dai mediae che tanto colpiscono la loro fantasia, sono sia fruttodella raccolta di dati sia della rielaborazione di questidati che implica un intervento dell’intelligenza umana edello scegliere delle convenzioni che consideriamocomuni.
9
3. La prima Tappa. Il Sistema Solare: concetti e contenuti.
Attenzione consigliamo di seguire la lettura con a fianco ilmateriale o il volumetto corrispondente per i ragazzi/e e dileggerlo man mano, in modo da poter verificare quantodiciamo. L’esposizione qui sotto è infatti, necessariamente,schematica. È da ricordare inoltre che moltissimo materialeiconografico e ulteriori approfondimenti per la classe sonodisponibili sul sito www.scopriticielo.it. Trattiamo in mag-gior estensione la prima parte, o “tappa”, quella del SistemaSolare, vuoi perché alcuni concetti generali ritornano anchenelle altre parti, vuoi perché è la prima affrontata e quindiriteniamo necessario essere un po’ più dettagliati per stabi-lire anche un terreno d’intesa con voi che leggete.
Il Sistema Solare è un argomento trattato in ogni ordinedi scuola e in genere viene presentato, nei vari testi sco-lastici, come un catalogo di corpi, caratteristiche, al limi-te curiosità. In genere è poco emozionante, a metà traScienze e Geografia, e non motiva i ragazzi. Inoltre sepensiamo agli strabilianti progressi nella conoscenza delSistema Solare ottenuti negli ultimi 25 anni ci rendiamoconto come la trattazione sia anche vecchia e poco rea-listica. La conoscenza che abbiamo oggi non è più “com-plessa”, è invece assai più completa.
Le concezioni che possono costituire ostacolo all’acqui-sizione di conoscenze più approfondite cui quindi abbia-mo prestato particolare attenzione nella stesura dellepagine per gli studenti, sono le seguenti:
• La Luna c’è quando non c’è il Sole.• Di notte il Sole “va via”. • Le distanze tra i pianeti sono confrontabili con le
dimensioni dei pianeti stessi.
Come può avvenire la rimozione di una misconception èancora tutto da dimostrare, diciamo però che possiamocostruire delle situazioni didattiche apposite per facilitarneil superamento e l’osservazione della posizione del Sole edella Luna nel cielo è una di queste. La presenza contem-poranea del Sole e della Luna durante il dì in genere osser-vata personalmente dal RAGAZZO/A pone in discussionela sua concezione e quindi ne facilita la rimozione.
Anche in questo l’Astronomia è, in effetti, un facilitatoreimportante per l’insegnante perché permette di mettere
il ragazzo/a, con l’osservazione, di fronte alla possibilecontraddizione fra quel che pensa e quel che osserva. Losviluppo di una semplice ma consapevole osservazione(in certi giorni ho visto in cielo sia il Sole che la Luna) lofa riflettere sul suo modello mentale acquisito (io pensoche la Luna c’è quando non c’è il Sole). Semplicissimoquindi per l’insegnante e molto efficace.Una attività significativa proprio per costruire una situa-zione didattica apposita per il superamento dell’ultimaconcezione ostacolo citata sopra e che potrebbe esseresvolta durante tutta la prima tappa, semplice e moltocoinvolgente per i ragazzi/e, è la “costruzione del Siste-ma Solare in scala”. Per fare questo è opportuno proble-matizzare la situazione e da questa poi partire con ridu-zione e calcoli. Trovate un modulo didattico nel sitowww.polare.it. Si tratta del modulo 5 del “Progetto Cie-lo!”, ma tratta soltanto la parte Sole e pianeti; diciamoche quella è la riduzione in scala del Sistema planetariodel Sole. Inoltre nelle prime pagine abbiamo introdotto tutta unaterminologia che per alcuni studenti non è comune; inqueste situazioni riteniamo importante introdurre findall’inizio la terminologia corretta in modo da mettere inevidenza le caratteristiche del corpo celeste considerato.
Abbiamo voluto mettere in evidenza nelle quattro nottirelative al Sistema Solare la sua caratteristica fondamen-tale, ovvero il fatto di essere un “sistema fisico”. Effetti-vamente questa sua caratteristica è già presente nelnome, ma viene in genere sottovalutata o ignorata: nonsi prende cioè mai in esame il nome “Sistema Solare”,cioè sistema del Sole.
Abbiamo fatto questa scelta perché permette di pensa-re ad una trattazione unitaria per introdurre, in modosemplice, concetti molto importanti; cercheremo per-tanto di avvicinare, i ragazzi/e ai campi di forza che gio-cano un ruolo nel Sistema Solare e a quel che tieneinsieme tutti questi corpi così diversi. E questo vienefatto per tutte le classi, convinti che i ragazzi/e quandoarrivano in aula, hanno già conoscenze, informazioniacquisite in centomila modi diversi e che essi stessirielaborano con quelle che sono le competenze tipichedel loro livello di età.Quello che vi abbiamo fornito è uno schema generale e
10
possono esistere tantissime possibilità di “evadere” dal-lo schema proposto: in questo caso il tempo necessariopuò aumentare e spesso si rischia di perdere il collega-
mento logico che unisce le varie esperienze dando allaproposta un’omogeneità complessiva.
Nella prima notte del Sistema Solare abbiamo introdottoil suggerimento di iniziare a guardare il cielo. Questo èimportante: i ragazzi/e non sono abituati a farlo, nonsono abituati ad osservare. L’idea è che imparino ad alza-re gli occhi spesso, per brevi momenti, per vedere dove èil Sole, dove e se c’è la Luna, che forma ha e così via. Sirendono conto, sviluppando questa semplice abitudine,che il cielo è una parte, importante, del nostro ambiente.Il fatto fondamentale per cui non si osserva più il cielo èche, nel mondo moderno, esso non “serve” più come ser-viva alle generazioni precedenti, per l’orientamento, per ilcalendario, per la cronologia. Occorre quindi riportare iragazzi/e all’osservazione in quanto tale, perché rappre-senta una capacità comunque fondamentale e non soloper l’astronomia, ma per tutte le materie scientifiche.
Passiamo poi a definire la forma del Sistema Solare. Iragazzi/e pensano, dalle illustrazioni nei libri o anchedalle immagini TV, che il Sistema Solare sia sostanzial-mente costituito dal Sole e nove pianeti, con grande con-fusione sulle dimensioni, distanze e relativi rapporti. Dia-mo quindi un approccio subito alla “vera” forma, sferica,del Sistema Solare, dandone una doppia visione dall’in-terno e dall’esterno. Viene suggerito di eseguire un sem-plice esercizio, semplicemente contando passi nel corri-doio o cortile della Scuola, per riuscire a dare un’idea diqueste dimensioni.
In particolare per il primo biennio elementare occorreprestare attenzione all’introduzione del concetto di“sistema”.
Due note importanti a proposito di questa prima nottedel Sistema Solare:1. Occorre prestare molta attenzione ai disegni del Siste-
ma Solare e alle rappresentazioni che ne vengonodate. I concetti importanti che vogliamo trasmetteresono: la forma del Sistema Solare e le distanze effetti-vamente esistenti tra i corpi del Sistema Solare.
2.Vorremmo far presente una delle maggiori “trappole”che si incontra nel linguaggio comune: la differenza fradì e giorno. Sembra una pignoleria ma crediamo siaimportante utilizzare una terminologia corretta findalle prime classi elementari e il termine dì è bendiverso dal termine giorno in quanto dì deve essere
utilizzato per indicare le ore di luce mentre il giornosono le tradizionali 23 ore, 56 minuti e un tot di secon-di. I ragazzi/e (ed anche noi stessi) dobbiamo utilizza-re, quando parliamo in ambiti disciplinari, il linguaggiodella disciplina, non il linguaggio comune.
SCHEDE
(costruzione del cannocchiale):La scheda invita alla costruzione di un cannocchiale. Puòessere posta ai ragazzi, soprattutto se hanno già trattatol’ottica geometrica, come un problema di studio deisistemi di lenti, quindi applicazione delle conoscenzeacquisite ad un caso non teorico, ma per la costruzionedi uno strumento che potrete usare durante tutta la tap-pa del sistema solare, un buon oggetto di osservazione èla Luna, lo studio della sua parte illuminata, dei crateri emonti. Comunque questa osservazione non dovrebbesoppiantare quella ad occhio nudo, da farsi per pochiminuti ma parecchie volte al dì ed alla notte.
Lo strumento presentato non è il classico cannocchialegalileiano che permetteva la visione raddrizzata deglioggetti. Per costruire quest’ultimo è necessaria una len-te divergente nell’oculare (il costo di questa lente si aggi-ra attorno agli 80 euro). La scelta di presentarvi il can-nocchiale con le due lenti convergenti è stata dettatanon soltanto da un costo inferiore, ma anche dal fattoche l’uso delle lenti convergenti permette di misurare ladistanza focale e questo può essere fatto senza problemidai ragazzi/e. Può essere quindi un modo per avvicinarlialla misura, eventualmente agli errori che si commetto-no nell’eseguire alcune misure; non è invece possibile farmisurare la distanza focale di una lente divergente (il cuifuoco è virtuale). L’uso della lente divergente non per-mette quindi la comprensione complessiva dell’uso dellostrumento, a meno che non si pensi ad una serie ulterio-re di lezioni di ottica a nostro avviso troppo pesante.
3.1 Prima notte
11
Nella seconda notte si affronta, in modo estremamentesemplice e diretto, un punto concettuale importante: lapredominanza del Sole e la sua azione gravitazionale,magnetica ed elettromagnetica. La predominanza delSole, della sua massa, influisce sulla forma e sull’equilibriodel Sistema Solare e dei singoli corpi che lo compongono.
Sono di particolare importanza i concetti di campo, nelcaso gravitazionale e magnetico, e di dipendenza dellaquantità di energia ricevuta per unità di area, dall’inver-so del quadrato della distanza dalla sorgente.
Detto così può risultare eccessivamente complicato, maal contrario l’esperienza ottenuta sul campo fa vedereche i ragazzi/e accettano molto naturalmente l’introdu-zione di questi concetti che semplificano tutta la tratta-zione, dandole unitarietà. Ad esempio, domanda classi-ca, capiscono immediatamente perché i pianeti e le stel-le sono “rotondi” come dicono i ragazzi.
Particolare attenzione occorre porre al concetto di mas-sa che viene introdotto. Ricordiamo che la massa puòessere anche presentata come la quantità di materia cheun corpo possiede. Collegato alla massa c’è l’azione gra-vitazionale del corpo.
Ancora attenzione per quanto riguarda il campo magne-tico. Proprio per questo sono stati presentati due tipi diesperienze diverse: • uno collegato all’attrazione gravitazionale e abbiamo
parlato di tiro alla fune o di gomma lasciata cadere, • l’altro invece collegato al magnetismo per introdurre il
campo magnetico del Sole.
Sappiamo che spesso si utilizza la calamita per rappre-sentare l’attrazione gravitazionale, ma è un’approssima-zione eccessiva. D’altra parte il Sole e i pianeti possiedo-no sicuramente campo gravitazionale, solo alcuni (Sole,Terra…) possiedono anche campo magnetico; è quindiimportante mantenere la differenziazione tra le caratte-ristiche diverse dei due fenomeni che pure si presentanocome azione a distanza.
Ricordiamo, anche se lo abbiamo già detto, che esistonodue zone di asteroidi: la zona tra Marte e Giove e lafascia di Kuiper e che le dimensioni delle due zone sonoterribilmente diverse (occorre prestare attenzione per-ché spesso vengono confuse).Per ogni punto abbiamo cercato di fornire alcuni esperi-menti per rendere più chiaro ciò di cui stiamo parlando.
Sono esperienze semplici, ma che, proprio per questomotivo, riteniamo debbano essere svolte.
In questa tappa infatti vengono affrontati alcuni problemi“cruciali”, spesso materia di domanda da parte dei ragaz-zi/e più curiosi o interessati: perché la Luna non cade sul-la Terra? Perché i pianeti stanno lì? Il tentativo fatto è sta-to quello di far giungere gli studenti alla comprensioneattraverso analogie con casi concreti, casi che loro sonoabituati a toccare con mano, ma che spesso non vedonoproprio perché fanno parte della quotidianità.
Per quanto riguarda l’abitudine ad osservare ricordiamoche è sufficiente un buon binocolo per osservare la Luna evedere dei monti e crateri lunari. È comunque importante,come detto sopra, che i ragazzi si abituino a guardare ilCielo, più avanti avremo bisogno di questa loro abitudine.
E visto che in questa tappa si parla di Sole si può comin-ciare ad osservare il Sole, (ovviamente con le dovuteprecauzioni come suggerito) soprattutto al mattinoquando si va a scuola o di pomeriggio tardi e discuteresulle osservazioni fatte.
SCHEDE
1. La prima permette di analizzare come cambia la quan-tità di luce che colpisce uno schermo al variare delladistanza dello schermo dalla sorgente.Occorre fare attenzione ad una situazione che si puòcreare: quando allontaniamo la lavagna luminosa laparte di schermo illuminata è più grande. In questasituazione il linguaggio non ci aiuta e dobbiamo pre-stare attenzione alle domande che poniamo ai ragaz-zi/e facendoli anche ragionare sulle loro risposte: unarisposta superficiale può infatti essere che “illumina dipiù”.
2.La seconda è un’estensione matematica che permettedi ampliare il discorso introducendo la grandezza“intensità luminosa”.
3. La terza invita i ragazzi/e a costruire ed utilizzare unrivelatore casalingo di raggi cosmici. Come vedretecon materiali semplicissimi si riesce a costruire unaggeggio che rivela le tracce del passaggio di particel-le cariche, che ci provengono dal Sole, ma anche datutte le altre stelle. Ai ragazzi/e l’esperienza vieneposta in modo interrogativo per vedere se i ragazzi/ecollegano i risultati dell’esperienza con quanto dettonel testo a proposito del Sole come sorgente anche diparticelle cariche. Questa esperienza verrà ripresaanche quando parleremo delle stelle.
3.2 Seconda notte
12
4.La quarta permette di verificare che per avere un cam-po magnetico non necessariamente è indispensabileuna calamita, ma è sufficiente una corrente elettrica; sela corrente elettrica cessa, cessa il campo magnetico. Lacostruzione è semplice, ma è importante la parte diripensamento che i ragazzi/e devono fare, eventualmen-te si può prevedere una discussione collettiva per trarrele conclusioni. Quando parliamo di campo magnetico
pensiamo immediatamente alla calamita; in realtà i cor-pi celesti possono avere un campo magnetico senza ave-re una calamita all’interno! La scheda permette di“costruirsi” un campo magnetico senza avere una cala-mita grazie alla presenza di cariche elettriche in moto.Questo è importante da far rilevare ai ragazzi per elimi-nare la concezione che abbiamo che ci porta a vederestrettamente collegato calamita e campo magnetico.
Nella terza notte sul Sistema Solare ritorniamo sul con-cetto di campo gravitazionale ed analizziamo i vari corpiche compongono il Sistema Solare stesso, dai pianeti aisatelliti, asteroidi, comete e altro e vedremo l’importantepunto delle dimensioni e distanze relative, mantenendo ilcollante fondamentale dell’attrazione gravitazionale.
Probabilmente questa parte è svolta in modo differenteda come vi aspettate. Piuttosto che una lunga elencazio-ne di proprietà, caratteristiche e così via il discorso sisnoda lungo i concetti importanti che abbiamo introdot-to nelle pagine precedenti, soprattutto il campo gravita-zionale. È importante che i ragazzi/e, che hanno giàaffrontato i concetti, vedano ora la applicazione dellaloro importanza e come essi semplifichino la compren-sione di quanto osserviamo.
Ribadiamo sul concetto di campo gravitazionale ed ana-lizziamo i vari corpi che compongono il Sistema Solare,dai pianeti ai satelliti, asteroidi, comete e altro e vedre-mo l’importante punto delle dimensioni e distanze rela-tive, mantenendo il collante fondamentale della attra-zione gravitazionale.
Quando si parla di pianeti e satelliti ci si aspetta che ven-gano elencate moltissime proprietà e caratteristiche. Inquesto caso invece si è scelto di presentare una tabellariassuntiva su cui far ragionare gli studenti e su cui farloro applicare gli importanti concetti introdotti nellepagine precedenti.
Dato però che essi si aspettano anche immagini dei pia-neti, caratteristiche e così via abbiamo concentrato que-sti contenuti nelle pagine Web del sito www.scopriticie-lo.it, che per questa parte sono particolarmente ricche diimmagini e descrizioni che, come detto, i ragazzi/e pro-babilmente si attendono. È quindi importante, questavolta, che gliele facciate consultare estensivamente,anche se dopo aver discusso del contributo che inviamoper loro. Chi proprio non potesse farlo facilmente a scuo-
la e/o non volesse dire ai ragazzi di farlo da soli a casa adesempio, può sostituire la sessione Web con la consulta-zione di un buon libro o enciclopedia sul Sistema Solare,purché molto recente.
SCHEDE
Come altre possibili esperienze, opzionali, diamo questavolta: • Un cruciverba riassuntivo, in genere ai ragazzi/e piace.• Per la 1° e 2° media diamo una semplice esperienza sul-
la gravità, che in genere riesce molto chiara. • Per la terza media e prima superiore suggeriamo di
leggere un passaggio del Sidereus Nuncius di G.Galilei,dove descrive la scoperta dei satelliti di Giove. Il branoè abbastanza lungo, sta a voi introdurlo cercando dicomunicare la chiave di lettura giusta: lo stupore diquesto scienziato che alza al cielo per la prima volta uncannocchiale molto rudimentale e vede chiaramentel’inatteso, anzi l’impossibile per la dottrina del tempo,assestata oramai da centinaia di anni. È un momentochiave per la scienza moderna.
Il testo è riportato anche in questo fascicolo come appen-dice.Se avete fatto eseguire l’osservazione della Luna, i ragaz-zi si saranno resi conto che la Luna ha le fasi. La com-prensione del perché vediamo la Luna in fase è abba-stanza complicato e prevede un percorso prolungato(una sequenzialità delle esperienze possibili è visibile nelsito www.polare.it progetto Cielo! modulo 5) possiamoinvece introdurre una simulazione, visibile nel sito delprogetto.
3.3 Terza notte
13
Come avete sicuramente notato, la seconda notte èquella cruciale e in quella sono stati introdotti i concettiche ci hanno accompagnato per tutto lo svolgimentodell’argomento:
• Campo gravitazionale• Campo magnetico• Campo di radiazione• Vento solare
Da questi quattro “elementi” sono state fatte discenderetutte le caratteristiche del sistema, proprio nel tentativodi far comprendere che si tratta di un “sistema fisico” dicorpi soggetti ad interazioni fra di loro.
In particolare riteniamo importante che i ragazzi/e rive-dano al termine di quest’argomento le osservazioni rela-tive al campo gravitazionale e magnetico (qualora nonsiano state già svolte consigliamo pertanto di proporrequelle schede; per chi invece non le ha eseguite puòessere il momento per introdurle e farne momenti di di-scussione).
Chiudiamo con quella che può essere definita una visio-ne d’insieme: di nuovo il problema delle distanze, ma conun piccolo passo all’esterno del Sistema Solare cioè ver-so le stelle.
Quello che vi consigliamo è comunque di fare una picco-la parte del percorso suggerito nel sito Planetario Virtua-le, vedi sotto, quella sulla gravitazione. In quella parte lavelocità di caduta, di orbita e di fuga da un pianeta èmostrata visivamente facendo “sparare” gli studenti conun cannoncino virtuale. Questa parte raccomandiamovivamente di farla provare ai ragazzi/e, magari introdu-cendola voi in quanto rappresenta una visualizzazione diuna esperienza già svolta dai ragazzi/e con la gomma.
Un’ulteriore esperienza potrebbe essere quella, sempregestita da voi, di cercare “errori” nei libri di testo e neifumetti. Ce ne sono moltissimi: sistemi solari contenutiin una sola pagina, senza minimamente tenere conto delrapporto fra dimensioni e distanze effettive dei pianetidal Sole, sistemi solari costituiti solo dai pianeti, senzatenere conto della nube di Oort, orbite estremamenteellittiche di pianeti attorno al Sole, soprattutto della Ter-ra. Ovviamente questo processo deve portare i ragazzialla consapevolezza dell’importanza di porsi sempre inmodo attento di fronte alle diverse fonti di informazione.
Siti in cui informarsi• Il Planetario Virtuale, www.pd.astro.it/pianetav, i pri-
mi paragrafi, raggiungibili dall’indice, affrontano ifenomeni del dì, della notte, fino al Sistema Solare.
Nella quarta notte passiamo in rassegna le più recentiscoperte sul Sistema Solare, in particolare quelle che han-no a che fare con i corpi “trans plutoniani” e le comete.
Introduciamo infine una delle ricerche più recenti e brillan-ti del momento, quella di sistemi planetari in altre stelle.
Con queste pagine termina l’analisi dei corpi del SistemaSolare proprio esaminando quei corpi che normalmentenon vengono considerati parte del sistema stesso e cheorbitano nella fascia di Kuiper e la nube di Oort e che sonopiù alla ribalta nei media (“il decimo pianeta” che ritornaoramai ogni anno a far parlare di sé).
Abbiamo ritenuto importante far comprendere agli allie-vi/e le dimensioni di questo Sistema, le distanze che inter-corrono tra i corpi che lo compongono, le loro dimensioni eanche le forze che intervengono tra i corpi stessi.
In particolare al termine di quest’ultimo contributo ritenia-mo importante che i ragazzi/e rivedano le osservazionirelative al campo gravitazionale e magnetico.
Quest’ultimo contributo si chiude con quello che può esse-re definito una visione di insieme: di nuovo il problema del-le distanze, ma con un piccolo passo all’esterno del SistemaSolare cioè verso le stelle, che rappresenteranno la prossi-ma tappa.
SCHEDE
1. Con il nome di “cometa” presentiamo una scheda chepuò apparire infantile, ma che permette di visualizzarequello che avviene all’entrare di un nucleo cometarionella zona dei pianeti; proprio per vedere la posizionedella “chioma” della cometa rispetto al Sole.
3.4 Quarta notte
3.5 Conclusioni sulla tappa “Sistema Solare”
14
• Per una visione d’insieme, sempre dallo stesso sito,potete trovare molte informazioni ed immagini, cheuseremo anche noi in seguito, nella sezione “SistemaSolare” di “Viaggio nel Cosmo”.
Trovate facilmente entrambi dalla “mappa del sito” diwww.lestelle.net.
• Un buon sito descrittivo, sul Sistema Solare è “TheNine Planet”, di Bill Arnett l’indirizzo è: http://seds.lpl.arizona.edu/nineplanets/nineplanets/nineplanets.html. È in un inglese molto semplice e valesenz’altro lo sforzo per chi non è tanto familiare conquella lingua.
Se volete ulteriori attività, poiché uno degli obiettivi prin-cipali consigliati è quella di indirizzare i ragazzi/e allaosservazione del Cielo, Sole, Luna, cambiamento dì – not-te (in particolare per i ragazzi/e delle classi seconda-terzadella scuola primaria), si possono svolgere alcune attivitàlegate al sistema di riferimento, ai concetti di “grande-piccolo”, “vicino-lontano”, “corpo luminoso-corpo illumi-nato” per cui potete vedere i moduli didattici 1 e 2 del“Progetto Cielo!” nel sito www.polare.it le unità didatti-che interessate sono la 1.1, 1.6, e 2.5. e il modulo 5 relativoalle distanze tra corpi del Sistema Solare.
15
4. Seconda tappa. Le stelle: concetti e contenuti.
Seguiremo anche in questa tappa la scelta metodologicaoperata per il Sistema Solare, ovvero introdurremo, einsisteremo nelle quattro notti, sul minor numero possi-bile di concetti fondamentali realmente importanti percapire il “fenomeno stelle”.
È un argomento a tratti difficoltoso, ma estremamentericco di fascino; vogliamo quindi dare ai ragazzi/e unacornice corretta in cui inquadrare notizie ed immaginiche si possono, oggi come oggi, ritrovare facilmente suimedia o su Web, in cui la comunicazione ed il linguaggiocomunemente usati spesso induce ad errori, a interpre-tazioni personali, a banalizzazioni.
Vogliamo mettere in evidenza la caratteristica fonda-mentale di ogni stella, cioè il fatto che ognuna di esse èun “sistema fisico” che tende all’equilibrio.
Per questo verranno ripetutamente presentate propriole forze che entrano in questo difficile gioco di equilibri,alcune delle quali sono già emerse durante lo studio delSistema Solare. Tornerà in ballo il problema delle distan-ze reali di questi corpi celesti e di come essi ci appaiono,di quali sono realmente le più vicine o le più lontane e dicome fanno gli astronomi a valutarne la distanza.
Anche questa volta abbiamo ritenuto importante pre-stare attenzione ad alcune concezioni che possonocostituire ostacolo all’acquisizione di conoscenze piùapprofondite e questo abbiamo cercato di riportarlonella stesura delle pagine per gli studenti, proprio perevitare il rafforzamento di queste idee. Qualcuno di voipotrebbe trovare interessante all’inizio effettuare unbreve brainstorming su “Cosa sono le stelle e cosa ne saitu ” per verificare lo stato delle conoscenze della classe.In questo caso consigliamo di non sistematizzare lerisposte dei bambini, ma semplicemente di registrarle.In questo modo potranno via via confrontare le lororisposte con quello che imparano nelle varie fasi di que-sta tappa.
Le tipiche e più frequenti concezioni errate sulle stellesono:
• Le stelle hanno le punte, perché è così che appaiono altelescopio.
• Le stelle fanno parte del Sistema Solare. • Le stelle sono rotonde. • Tutte le stelle hanno le stesse dimensioni. • Tutte le stelle sono bianche. • La Stella Polare è la più brillante del cielo. • Le costellazioni sono raggruppamenti di stelle associa-
te fisicamente tra loro. • Se al posto del Sole ci fosse un buco nero, la Terra ver-
rebbe inghiottita immediatamente da esso. • I buchi neri hanno un colore nero e non possono quin-
di essere rivelati in nessun modo.
Ribadiamo quanto detto nelle pagine precedenti relativeal Sistema Solare ed inoltre vogliamo ricordare che ilsuperamento di una misconception è difficilmente veri-ficabile a distanza di breve periodo. Tale superamentoandrebbe valicato su un periodo di tempo più lungo diquello di un anno scolastico, proprio per verificarne lamodifica in seguito all’introduzione di ulteriori concetti ealla luce di rielaborazioni personali che possano averemodificato la concezione primitiva
Ad esempio, per tentare di superare la prima si può,dopo che si è messo in evidenza attraverso una discus-sione in classe, che i ragazzi/e hanno realmente quest’i-dea, portare in classe una lampada abbastanza potenteinvitandoli a guardarla. Per guardarla i ragazzi/e strizze-ranno gli occhi, guardando la lampada attraverso leciglia: vedranno comparire dei “raggi” che possono esse-re assimilati ai “raggi” delle stelle. Sarebbe opportunoricordare ai ragazzi/e che si parla di fasci luminosi piùche di raggi. Stiamo parlando del fenomeno fisico notocon il termine di diffrazione.
Da ricordare inoltre alcune “trappole” del nostro linguag-gio comune come le “stelle cadenti”, che sono semplicimeteoriti delle dimensioni di 1 millimetro, o le “stellecomete”. Dato che i ragazzi/e hanno appena studiatometeore e comete è bene far rimarcare loro come orasappiano che questi corpi non sono “stelle”, termine cheè stato loro dato dagli antichi.
16
Nella prima notte il concetto fondamentale è passato airagazzi/e con la considerazione che l’unica “cosa” che noiriceviamo dalle stelle è la radiazione. Da questa radia-zione, in particolare nel nostro caso dalla luce, dobbiamofar discendere tutte le informazioni possibili.
Occorre quindi che i ragazzi/e imparino a lavorare con laluce; che consolidino il concetto della differenza fraoggetti luminosi e oggetti illuminati. È importante checapiscano come si possono studiare le stelle, risalendodalla luce che riceviamo alle loro caratteristiche. Proprioper questo è importante che lavorino con la luce del Solee delle lampade e con i prismi.
Consigliamo di far svolgere praticamente tutte le atti-vità suggerite anche all’interno delle pagine: è impor-tante che i ragazzi/e abbiano esperienze concrete cuifare riferimento.
Viene anche iniziato il discorso che l’Astronomia è unascienza in cui l’osservazione è un elemento fondamenta-le, non è una scienza sperimentale nel significato che dia-mo comunemente a questo termine: su questo concettotorneremo ampiamente in seguito per mettere in rilievoche cosa si intende per “osservazione” in Astronomia,dato che è notevolmente diverso da quello che si intendein altre scienze sperimentali. Questo ci permetterà anchedi fare un discorso semplice e non pedante sul linguaggio,basato proprio sulle esperienze effettuate dai ragazzi/e.
SCHEDE
• Costruzione di un semplice spettroscopio con materia-le povero.
• Una scheda guida per l’esperienza
Sappiamo che l’argomento trattato in queste schede èmeno conosciuto rispetto alle precedenti, ma crediamosia importante affrontarla con i ragazzi proprio per intro-durre l’aspetto corpuscolare della radiazione luminosa. Il problema nasce dal fatto che spesso ci si trova, comeinsegnanti, di fronte alla domanda: “Come fanno gli astro-nomi a comprendere di che cosa sono composte le stelle?”
A questo proposito si può fare ricorso a un laboratorio dichimica (che in genere nelle classi secondarie di secondogrado esiste), ma si può anche eseguire l’esperienza di“bruciare” sostanze diverse in una stanza buia. Se faccia-mo bruciare ad esempio del sale da cucina la fiammarisulta gialla; chiaramente se fosse possibile utilizzare unbecco Bunsen sarebbe meglio, ma sappiamo che talistrumenti non possono essere utilizzati se non in condi-
zioni di estrema sicurezza, quindi è meglio lasciare per-dere, ma si può comunque far cadere qualche grano disale su una candela accesa o su un accendino! Questaesperienza si chiama saggio alla fiamma e permette diindividuare quali sostanze diverse vengono bruciate.La costruzione dello spettroscopio permette di affinarel’osservazione e di vedere ben più chiaramente quali ele-menti bruciano e le loro caratteristiche
Di seguito alcune domande stimolo che possono essererivolte ai ragazzi e che possono costituire punti nodalidell’attività stessa.
Ricordare che dalle stelle, ad esempio il Sole, riceviamola luce che vediamo con i nostri occhi, cioè la radiazionevisibile. Si tratta pertanto di interpretare ciò che la luceci dice attraverso una analisi attenta, anche attraversol’uso di strumenti.
• Osservare attraverso lo spettroscopio la luce di diver-se lampade ed evidenziare la differenza tra i diversispettri ottenuti.
Classificare i diversi spettri in spettri continui e spettri arighe: sono tutti spettri di emissione in quanto il riscal-damento del filamento della lampada o del gas internoalla lampada conduce all’emissione di radiazione e quin-di nel nostro caso particolare di luce visibile. È importan-te ricordare che il sensore che “raccoglie” la luce emessadalle lampade è il nostro occhio e quindi quello che stia-mo osservando è la luce visibile.
All’interno di questa grande classificazione si possonoevidenziare gli spettri di assorbimento che sono ben visi-bili qualora si utilizzino lampade con copertura colorata.In quest’ultimo caso la “copertura” assorbe una partedella luce emessa ed in corrispondenza sono visibili del-le bande scure.
• Si possono raggruppare tutti gli spettri osservati incategorie? Che caratteristiche hanno queste categorie?
Fare una corrispondenza tra tipo di spettro e tipo di lam-pada (ad esempio la luce prodotta da lampade a filamen-to ha uno spettro continuo); quella prodotta da una lam-pada a doppio tubo (le lampade a risparmio energetico)ha uno spettro a righe (righe luminose).• Si può estendere il ragionamento ed ipotizzare di qua-
le tipo sia lo spettro del Sole? Quale tra gli spettri chesi sono osservati si può ritenere essere più simile aquello del Sole?
4.1 Prima notte
17
La risposta che in genere i ragazzi danno è che la luce delSole avrà uno spettro simile a quello della lampada a fila-mento perché la vedono bianca in modo uguale ed inol-tre perché, anche se sanno perfettamente che il Sole ècostituito di gas la differenza fra il Sole stesso e il gascontenuto in una lampada non è così ben chiaro.
Per fare questo è opportuno aver osservato lo spettro dimolte lampade, per questo la costruzione dello spettro-scopio può essere utile in modo che la generalizzazionesia più facile.
Al momento della osservazione della luce del Sole èimportante prestare molta attenzione a quello che sivede. Sono infatti visibili sottilissime linee scure, ma poi-ché sono sottilissime spesso ad una osservazione super-ficiale non vengono evidenziate.
È importante che i ragazzi/e capiscano come si posso-no studiare le stelle, risalendo dalla luce che ricevia-mo, alle loro caratteristiche. Con lo spettroscopio rag-giungiamo anche l’obiettivo di consolidare l’importanzadell’osservazione in Astronomia.
Nella seconda notte affrontiamo un punto concettualeimportante: le stelle che sono poco luminose, ovvero chevediamo come poco luminose, lo sono realmente o no?Questo ci permette di introdurre il discorso delle distan-ze e della loro misura. Introduciamo il problema se ciòche ci arriva dalle stelle è soltanto la luce visibile e comequesto tipo diverso di radiazione può essere letto.
Vengono affrontati in questa notte alcuni concetti fon-damentali per l’argomento stelle, in particolare facciamocapire come si interpreta l’informazione che ci arriva dal-le stelle, cioè il segnale luminoso.
In questa tappa infatti vengono affrontati alcuni problemi“cruciali”: l’interpretazione del segnale luminoso inviatodal Sole, l’analisi della luminosità apparente delle stelle eil concetto di luce come “corpuscolo”. Quest’ultimo con-cetto è nascosto dalla metafora del contenitore che pos-siamo riempire d’acqua, che può quindi essere accumula-ta. Diamo inoltre il primo messaggio sul fatto che la lumi-nosità delle stelle che ci appare e la distanza sono legate.
Uno snodo concettuale ed operativo importante è l’in-troduzione della parallasse, che è l’unico modo “diretto”a nostra disposizione per misurare le distanze stellari.Abbiamo messo le virgolette proprio per mettere in evi-denza che non è una misura diretta in senso fisico deltermine in quanto non la misuriamo direttamente attra-verso un confronto con l’unità di misura.
La parallasse può essere introdotta in molti modi diver-si, noi abbiamo scelto il più semplice, consigliando unaesperienza, nel testo, che può essere fatta da tutti nelcorridoio della scuola. Se desiderate un’introduzionediversa vi diamo più sotto dei suggerimenti. In effettiquel che importa è che i ragazzi/e facciamo mente loca-le, e capiscano, l’effetto di parallasse e cosa incide sulla
misura (base di misura, capacità di misurare angoli mol-to piccoli).
Si consiglia di prestare particolare attenzione all’esecuzionedi questa parte.
SCHEDE
Proponiamo diverse attività:• Una che introduce il problema della correlazione
distanza-luminosità della sorgente luminosa, cioè del-la stella. L’esperienza è semplice ma permette di colle-gare concetti già affrontati precedentemente e in par-ticolare l’importanza del fatto che se non avessimopunti di riferimento esterni faremmo molta fatica acomprendere le distanze dei lampioni, da qui la faticadegli astronomi che nel cielo non hanno punti di riferi-mento e quindi se li devono creare.
• Una che approfondisce il concetto di “accumulazionedella luce”.
• Una che permette di far familiarizzare i ragazzi/e con ilconcetto di luminosità apparente. Interessante perchépermette una classificazione delle stelle secondo uncriterio di luminosità e che può permettere quindi unaanalogia con la classificazione stellare per luminositàfatta dagli antichi e quindi permettere una parentesistorica importante.
• Una che invece suggerisce l’osservazione del cielo peravere un’idea del numero di stelle visibili.
In particolare la costruzione dello strumento per contarequante sono le stelle visibili può portarvi a stare una seracon i vostri studenti fuori a guardare il cielo (vi suggeria-mo questa attività d’inverno, quando è ben visibile Orioneuna costellazione facilmente riconoscibile; questa e ilGrande Carro ci permettono un orientamento eccezio-nale).
4.2 Seconda notte
18
SCHEDA
In questo caso vi suggeriamo un ulteriore strumentonato da una semplificazione del notturnale o notturnila-bio che veniva usato dagli antichi per leggere l’ora.
Le due versioni che alleghiamo sono rielaborazioni diquello utilizzato, ma si prestano per le prime esperienzedi avvicinamento al cielo dei ragazzi/e.
Questa versione risulta essere particolarmente sem-plificata. È sia un aiuto a trovare la Polare per chi pro-prio non riesce a riconoscerla sia un modo per far giun-gere i ragazzi/e all’acquisizione del concetto che il cie-lo sembra ruotare sopra le nostre teste (proprio comese la Terra fosse ferma!!)
Costruzione:• Tagliare lungo la circonferenza esterna lo strumento.
Conservare il cerchio interno.• Tagliare la lancetta e la finestrella da cui si deve
vedere attraverso.• Sovrapporre dal basso verso l’alto nell’ordine: cer-
chio, lancetta A e fissare con un fermacampione incorrispondenza della crocetta e del centro del cer-chio che devono risultare esattamente sovrapposti.La lancetta deve poter ruotare.
Come usarlo:• Guardare l’ora sull’orologio e posizionare la fine-
strella sull’ora voluta.• Cercando nel cielo il Carro Maggiore la lancetta
dovrà sovrapporsi ai due puntatori.• Il fermacampione rappresenterà la Polare che, dal-
l’osservazione della sua posizione sullo strumento,sarà facile da identificare nel cielo.
Ricordiamo che per identificare la Polare bastacercare i duepuntatori del CarroMaggiore, unirli e prolungare lasemiretta:
Notturnale - versione A
19
SCHEDA
È una versione più complicata e permette di dedurrel’ora dalla posizione del Carro Maggiore rispetto aquella del Carro Minore e quindi della Polare.
Costruzione:• Tagliare esattamente lungo la circonferenza esterna
lo strumento. La parte interna va conservata.• Tagliare le due lancette e la finestrella nella lancet-
ta A.• Sovrapporre dal basso verso l’alto, nell’ordine: lan-
cetta B, cerchio, lancetta A e fissare con un ferma-campione in corrispondenza delle due crocette e delcentro del cerchio che devono risultare esattamentesovrapposti. Il tutto deve poter ruotare.
Come usarlo:• Ruotare B sulla data del giorno in cui si effettua l’os-
servazione del cielo, la freccia deve essere diretta inbasso, lo strumento va tenuto in mano dalla frecciaB. Ci si deve rivolgere verso Nord.
• Ruotare A finché questa nuova freccia si dirige ver-so i puntatori dell’Orsa Maggiore (il fermacampionecoinciderà così con la stella Polare).
• Nella finestrella compare l’ora in cui si effettua l’os-servazione.
Non scoraggiarsi se alle prime osservazioni l’ora trova-ta con questo strumento non corrisponde esattamen-te con quella segnata dal nostro orologio; ripeteteancora l’osservazione, via via che vi impratichite inquesto “lavoro” i due orari tenderanno sempre più acoincidere!!
Notturnale - versione B
20
Nella terza notte ci occupiamo delle distanze delle stel-le. È un argomento estremamente importante per gli astro-nomi perché dalla determinazione della distanza si pos-sono ricavare parametri fondamentali della stella stessacome la sua luminosità intrinseca, la massa ed altro.
In realtà l’unico modo diretto di determinare la distanzaè la parallasse, ma questo è possibile soltanto per quellepochissime stelle che sono molto vicine, in termini astro-nomici ovviamente, alla nostra Terra.
La misura effettiva della distanza di una stella col metododella parallasse è estremamente complesso nella realtàdella pratica astronomica, ma il concetto della misura èinvece molto semplice e verificabile in modo immediatoanche a scuola. Per questo abbiamo ritenuto importanteintrodurre il discorso fissando così il primo gradino della
“scala delle distanze”, che è quello su cui si basano poitutte le successive misurazioni. È importante che noistessi, come insegnanti, abbiamo chiaro il concetto discala delle distanze: è proprio una scala ed ha gli stessiproblemi se la base della scala non è stabile, la scala cade.Se le prime misure non sono “esatte” l’errore di questamisura risulterà amplificato sulle misure successive.
Proprio per questo riteniamo importante questa tappa:sembra breve, ma è importante che vengano eseguite leesperienze, alla portata di qualunque ragazzo/a, perchérappresenta una delle poche misure che suggeriamo di fare.Rimane ancora un discorso molto qualitativo, ma per-mette almeno di intuire i passaggi successivi.
Non abbiamo suggerito attività in quanto già le espe-rienze proposte nella notte di osservazione permettonoun avvicinamento alle problematiche proposte.
Nella quarta notte affrontiamo il problema delle dimen-sioni delle stelle e di che cosa succede, nel corso del tem-po, a stelle di dimensioni diverse. Parliamo quindi di evo-luzione stellare e con questa puntata terminiamo l’argo-mento stelle.
Riteniamo sia importante ricordare sempre che l’Astro-nomia è una scienza osservativa. Occorre che i ragazzi/eacquisiscano la differenza fondamentale che l’astrono-mia ha rispetto alle scienze sperimentali; in questo sen-so l’osservazione in astronomia è diversa da un’osserva-zione ad esempio in Fisica o alle sperimentazioni che sipossono fare in quasi tutte le altre scienze, come la Chi-mica, la Fisica, ecc.
L’osservazione in Fisica ha come obiettivo quello di evi-denziare gli elementi fondamentali di un fenomeno per
poi poterlo riprodurre in laboratorio (eventualmentemolto semplificato, considerando solo alcune variabili).
In Astronomia, non possiamo riprodurre praticamentenulla in laboratorio, come abbiamo già detto, ma tutte leinformazioni che possediamo sui corpi celesti sonodovuti all’osservazione: quindi per osservazione inten-diamo sia osservazione che raccolta di tutto ciò che i cor-pi celesti ci “inviano”.
Una sottovalutazione di questa differenza rischia dicreare o di consolidare nei ragazzi/e delle misconcezioniche sono comunque già presenti e che i media tendonoa rinforzare. Quello che tentiamo quindi di fornire è un’i-dea di quelle che sono le attuali conoscenze e ipotesi chegli scienziati fanno.
La seconda notte è, ancora una volta, la notte crucialeper l’osservazione in quanto si introduce l’interpretazio-ne del segnale luminoso inviato dal Sole, l’analisi dellaluminosità apparente delle stelle e il concetto di lucecome “corpuscolo”.
Abbiamo tentato, come avete visto in tutti i contributi dinon antropomorfizzare le stelle: termini come la stellanasce, vive e muore non vengono utilizzati. È importan-te evitare di far credere ai ragazzi che le stelle sono esse-ri viventi! Gli astronomi possono usare una terminologia
4.3 Terza notte
4.4 Quarta notte
4.5 Conclusioni sulla tappa “Le Stelle”
21
di questo tipo, ma sono perfettamente coscienti di starelavorando con dei modelli, non con la realtà; per i nostriragazzi/e questo è quasi incomprensibile perché lavoria-mo con oggetti molto lontani da loro e tendono ad uti-lizzare questa terminologia in senso stretto e quindi adinterpretare le stelle come esseri viventi.
Gli esperimenti proposti tentano di dare ai ragazzi un’i-dea, almeno approssimativa, di un modello e dei modellicui gli astronomi fanno riferimento (ovviamente i model-li usati dagli astronomi non sono quelli presentati nelcontributo, sono invece modelli matematici).
Non dimenticate di far consultare spesso il sito www.sco-priticielo.it ai ragazzi per approfondimenti e altre notizie,ma anche solo per vedere le belle immagini a colori dellatappa delle stelle.
Siti in cui informarsiPer le stelle, oltre alle pagine Web di quest’iniziativa,potete trovare, per i ragazzi/e, in www.lestelle.net icapitoli di “Starchild” dedicati agli argomenti che trattia-mo.
Per i più grandi e interessati può essere interessanteandare a qualche capitolo del “Planetario Virtuale”http://www.pd.astro.it/pianetav/, vedere ad esempioi paragrafi, presenti nell’indice:• La gravità terrestre: che cos’è e come agisce• La forza gravitazionale, la velocità di fuga e le orbite
22
5. Galassie ed Universo: concetti e contenuti.
Questo è un argomento che spesso sfocia nel fantasticoo anche nel mistico. Noi vorremmo invece continuarel’approccio alla conoscenza iniziato nelle due precedenti“tappe” e portare i lettori, anche i più piccoli, ad una ana-lisi “reale” dei dati attualmente in nostro possesso.
Vogliamo mettere in evidenza, nelle “notti” relative aquesto argomento, la caratteristica fondamentale cheogni Galassia è un “sistema fisico” che spesso tendeall’equilibrio. In particolare risultano in evidenza iseguenti concetti:
• Il concetto di sistema.• L’azione della gravità.• Il concetto di processo di formazione dell’energia.• La radiazione come modo di diffusione dell’energia.• Il concetto di modello.
La trattazione che diamo è ovviamente molto semplifi-cata, accessibile a tutti i ragazzi/e, ma corretta. Qualcu-no di voi potrebbe trovare interessante all’inizio effet-tuare un breve brainstorming su cosa è una galassia,quanto grande è, “dove è” (per capire se i bambini sannogià che il nostro Sole è solo una dei miliardi di stelle con-tenute nella nostra Galassia) per verificare lo stato delleconoscenze della classe. Tra le misconceptions che piùspesso ci troviamo dinanzi vi sono le seguenti:
• La Via Lattea è una striscia nel cielo. • Noi siamo al di fuori della Via Lattea perché la vediamo. • Le stelle della Via Lattea sono dentro il Sistema Solare.
Attenzione che i ragazzi/e spesso non identificano la ViaLattea, che è quella che si vede in cielo nelle notti miglio-ri, con la nostra Galassia.
Nella prima notte il concetto fondamentale è quello del-la gravitazione, la descrizione della Galassia e delle suecomponenti (gas, ammassi, disco, ecc.) L’approccio moltodescrittivo e divulgativo non tragga in inganno, in realtàintroduciamo decisamente il concetto che la Galassia èun sistema fisico, composto da molte parti, che noi sia-mo al suo interno (sistema di riferimento e punto diosservazione), che è in equilibrio dinamico.
E ancora il fatto che l’unica cosa che noi riceviamo dallestelle è la radiazione. Da questa radiazione, o meglio edovviamente dalla sua misura e studio, dobbiamo fardiscendere tutte le informazioni possibili, riprendendocon questo il discorso dell’Astronomia come scienzaosservativa.
La seconda notte affrontiamo il discorso della radiazio-ne in tutte le sue frequenze, l’occhio come recettore ealtri recettori. È particolarmente importante, anche sesembra molto discorsiva. Non vogliamo dire che è diffi-cile, ma che introduciamo concetti importanti e lo fac-ciamo in modo nuovo.
Il primo, importante concetto è quello di radiazione.Come corollario si può aggiungere che la radiazione cheinteressa l’Astronomia non è solo quella di un unico
oggetto-sorgente, il Sole ad esempio, o una delle stelleche vediamo puntiformi in cielo con gli occhi, ma diventala radiazione complessiva di una galassia, che è “somma”di quelle di tutti i corpi che la emettono, miliardi di stelleecc. Il primo passo è ovviamente la nostra Galassia.
Occorre far ragionare i ragazzi/e sul fatto che esistono“radiazioni” diverse da quelle che riceviamo con gli occhie che quindi non vediamo. Nonostante noi viviamoimmersi in radiazioni di vario tipo e le utilizziamo conti-
5.1 Prima notte
5.2 Seconda notte
23
nuamente (cellulari, TV, telecomandi di vari tipi etc.),abbiamo problemi a mettere in relazione queste con “laluce”, mentre si tratta sempre di radiazioni elettroma-gnetiche, semplicemente di frequenza diversa.
Si potrebbe anche svolgere una attività linguistica colle-gata al termine “vedere” come “rilevare”, introducendocosì l’idea che vedo con gli occhi, ma posso rilevare lapresenza di radiazioni anche con altri sensori. Gli esem-pi possono essere semplici: la pelle che si brucia quandostiamo al Sole, l’uso di un binocolo ad infrarosso, il cellu-lare che posto accanto ad una TV o monitor di PC (contubo catodico) disturba la immagine. Altra esperienzasemplice è quella possibile con una telecamera elettro-nica, oramai molto diffuse. Puntando un telecomando adinfrarossi (alcuni apricancelli o telecomandi TV) e azio-nandolo si vede il telecomando lampeggiare, cosa checon gli occhi non è possibile osservare. Simili e sempliciesperienze sono però estremamente importanti per farcomprendere che la radiazione visibile (quello che chia-miamo “luce”) è soltanto una piccola parte della radia-zione elettromagnetica, e rende più facile la compren-sione quando diciamo, ad esempio, che una stella emet-te vari tipi di radiazione.
Abbiamo per questo voluto avvicinare i ragazzi/e ad un con-cetto di “luce” totalmente nuovo rispetto alle modalità tra-dizionali: come vedete non parliamo di lunghezza d’onda,ma parliamo di radiazione.
L’Astronomia, come abbiamo più volte ripetuto, è unascienza osservativa, in cui la radiazione raccolta non èsoltanto la luce visibile, ma molto di più: c’è la radiazio-ne infrarossa, la radiazione X, le microonde, la radiazioneradio, l’ultravioletta... non visibile con gli occhi, ma visi-bile con opportuni rilevatori.
Ad ogni tipo di radiazione poi corrisponde un fenomenofisico diverso: stelle calde emettono di più nell’ultravio-letto, stelle fredde nell’infrarosso, stelle in cui avvengo-no fenomeni violenti nei raggi X. Di conseguenza l’emis-sione di una galassia, che è la “somma” delle emissioni ditante stelle, anche miliardi, sarà diversa a seconda deltipo di radiazione che osserviamo. In altre parole se sia-mo interessati a sapere dove sono in una galassia le stel-le più calde andremo a vedere la loro immagine all’ultra-violetto e così via. La somma di tutte le informazioni nel-le varie bande di radiazione ci permette di ricostruire itanti “volti” della stessa galassia, che corrispondono adiversi fenomeni fisici che ivi avvengono.
Questo amplia di molto il concetto di Astronomia chestiamo dando ai ragazzi: non è soltanto l’osservazionedel cielo stellato, ma una osservazione rivolta allo spazio.Stiamo facendo un salto qualitativo passiamo dal “cielo”“all’universo”, che i ragazzi vedono continuamente suigiornali, TV e altro. Il passaggio è delicato, ma i ragazzi/ein genere riescono bene a farlo magari instradati oppor-tunamente dall’insegnante.
SCHEDE
1. Si tratta di un approfondimento su come si ottengonole immagini astronomiche. È estremamente importan-te per aiutare i ragazzi/e a comprendere alcune infor-mazioni che ci vengono date dai media.
Un suggerimento: chi si trovasse nella situazione oppor-tuna (cielo terso e sufficientemente buio, possibilità diportare i ragazzi/e a scuola o altro luogo sicuro dopo iltramonto) potrebbe molto utilmente osservare la ViaLattea con loro, anche con l’ausilio di un normale bino-colo oltre che, naturalmente, ad occhio nudo.
Nella terza notte andiamo oltre la nostra Galassia. Ilconcetto che vogliamo che i ragazzi acquisiscano è anco-ra quello di “sistema”: quando abbiamo parlato di Siste-ma Solare abbiamo introdotto il concetto di sistema fisi-co; anche le Galassie sono sistemi fisici e anche gliammassi di galassie. Il “collante” che tiene unito il tuttoè principalmente l’attrazione gravitazionale.
Può essere utile a questo punto riprendere le esperienzelegate all’attrazione gravitazionale già svolte durante latappa relativa al Sistema Solare: un momento di ripassopuò servire a consolidare diversi concetti o eventual-
mente a verificarne, dove possibile, l’acquisizione ecomunque una maggiore interiorizzazione.
Le dimensioni del “mondo” di cui ci occupiamo in questanotte sono estremamente aumentate: per i vostri stu-denti non possiamo più parlare di passi e di scale di con-fronto, non regge perché parliamo di distanze enormi: seper la nostra Galassia parliamo di un diametro di cento-mila anni luce, per il Gruppo locale parliamo di un dia-metro di 5 milioni di anni luce e gli ammassi diventanosempre più grandi.
5.3 Terza notte
24
Queste dimensioni sono già difficilmente comprensibiliper noi adulti, a maggior ragione lo saranno per inostri/vostri studenti, possiamo quindi fare soltanto unquadro complessivo il cui concetto portante è ancorauna volta l’attrazione gravitazionale.
Nel sito del progetto poi, www.scopriticielo.it, altreimmagini e commenti per i vostri ragazzi/e, potete far-gliele consultare a scuola o da casa.
Nel corso della quarta notte affrontiamo la Cosmologia,ovviamente per cenni; come quella branca dell’Astrono-mia che affronta lo studio dell’Universo come un tutt’u-no. Se ci basiamo sull‘osservazione della radiazione elet-tromagnetica, luce visibile, onde radio, radiazione X, lateoria ci dice che comunque non riusciamo ad andareoltre a questo limite dei 2-300.000 anni, “prima”, verso leorigini, l’Universo era completamente opaco.Se vogliamo andare oltre occorre cambiare completa-mente metodo, dobbiamo cercare ed osservare ancora,
ma nel modo giusto. La teoria prevede che oltre quellimite si possa andare osservando altri “messaggeri diinformazione” diversi dalle radiazioni, ed esattamente ineutrini e le onde gravitazionali, entrambi presenti nel-l’Universo anche molto prima dei 300.000 anni dal BigBang.
È una nottata conclusiva, ma che apre porte verso unanuova conoscenza.
5.4 Quarta notte
Questa parte è sicuramente più teorica rispetto alle pre-cedenti, Sistema Solare e Stelle, ed è anche, proprio perquesto, la più complicata ma forse anche la più affasci-nante perché presenta un campo di studio in totale evo-luzione, anche grazie alle sempre nuove tecnologie uti-lizzate. Si è voluto mettere in evidenza in queste pagineche anche le conoscenze possedute dall’uomo sono incontinuo cambiamento ed evoluzione.
Ricordiamo qui una delle frasi che troverete anche neifascicoletti dei ragazzi e che vi invitiamo a far ben legge-re ai vostri ragazzi/e: Ogni teoria, infatti ha dei limiti di
applicazione entro i quali è definita. E questo vale perogni teoria fisica.In compenso nel sito www.scopriticielo.it i vostri ragaz-zi/e troveranno le più belle immagini di tutto il camminoalla scoperta del cielo.
Con questo abbiamo finito, vi ricordiamo che siamo avostra disposizione per qualunque chiarimento, per com-menti, suggerimento, proposta, critica. Vogliamo che ilprogetto diventi un po’ anche vostro e migliori anchegrazie alla vostra esperienza! Scriveteci a [email protected]. Grazie.
5.5 Conclusioni sulla tappa “Galassie ed Universo”
25
Appendice 1
Verifica suggerita per le prime e seconde classi della scuola
secondaria di primo grado
CACCIA NEL SISTEMA SOLARE La verifica proposta prevede che i ragazzi si muovano per la classe e ragionino in gruppo, pertanto non puòessere pensata come momento di lavoro individuale; è invece un momento di scambio e di dialogo.Ricordare inoltre che è un gioco e che le dimensioni e le distanze dei corpi non sono in scala.Dividere la classe in gruppi di tre/quattro studenti ognuno costituendo così un certo numero di squadre.
Uno dei gruppi è quello che dirige il gioco e quindi deve nascondere le immagini degli oggetti celesti (e le indi-cazioni per la tappa successiva) per i compagni. La posizione in cui vengono nascoste le immagini all’internodella classe (o comunque dell’ambiente in cui viene svolta la verifica) deve tener conto delle caratteristiche del-l’immagine dell’oggetto e in particolare della sua distanza dal Sole.L’insegnante dovrà verificare la correttezza della disposizione degli oggetti e da questo potrà dare una valuta-zione dello stesso gruppo che dirige il gioco.Ogni squadra deve recuperare almeno sette tra i 10 “oggetti” celesti che vengono nascosti per poter conside-rare la verifica positiva. Parliamo di immagini che proponiamo a colori (su www.scopriticielo.it) perché bastafarne un numero di copie limitato, ma che si possono eventualmente stampare in b/n oppure utilizzare libri,foto, testi in possesso della classe
Vince la squadra che ha trovato il maggior numero di immagini nel più breve tempo possibile. Occorre ricordare ai ragazzi che le definizioni date possono individuare anche più oggetti.
Il gioco comincia consegnando ad ogni squadra un foglietto iniziale (quindi occorre stampare tanti fogliettiquante sono le squadre).
Hai studiato le distanze che intercorrono tra i corpi del Sistema Solare. Devi cercare una stella cioè il Soleragionando su quale può essere la posizione in cui si trova.
1. Da qui vai all’estrema periferia del Sistema Solaredove incontri dei nuclei cometari, cioè delle roc-ce coperte di uno strato di ghiaccio e che sonocontenuti nella nube di Oort.
2. Il corpo che devi cercare ora si vede soltanto per-ché è illuminato dal Sole.
3. Ed ora invece cerca qualcosa con la “chioma”. 4. Quello che ora devi trovare è un pianeta non
troppo grande, abbastanza vicino al Sole, ma nontroppo, c’è roccia e acqua ed ha un satellite.
5. È strano, anche questo non fa luce, ha forma disigaro, ma non si fuma...
6. È spesso citata nelle canzoni, è un corpo roccioso
che appare ora bianco, ora giallo, ora rossiccio...7. Ruggine... ma allora è rosso; è più piccolo della
Terra ma ha un monte molto alto...8. È il più grande, è gassoso ed ha una macchia
enorme che potrebbe contenere due volte la Ter-ra!!
9. È un pianeta la cui superficie è coperta di crateriche fanno pensare al fatto che forse tantissimotempo fa anche la zona tra i pianeti contenessemolti asteroidi!
10. Ed ora devi trovare un pianeta con gli anelli:diversi pianeti li hanno, quindi BUONA CACCIA!
Foglietto iniziale
26
Nell’ultimo posto porre il Foglietto finale.
Prima di consegnare le immagini provate a ordinale secondo la distanza crescente dal Sole.
Foglietto finale
Oggetti celesti (1 copia per squadra)
27
Verifica suggerita per le terze classi scuola secondaria di primo
grado e per la prima classe della scuola secondaria di secondo
grado
1. Secondo te Giove è il pianeta che ha più satellitianche perché:
m È formato di gas
m Ha massa maggiore di tutti i pianeti, quindi hamaggiore attrazione gravitazionale
m Ha massa maggiore di tutti i pianeti, quindi haminore attrazione gravitazionale
m Risente meno del campo gravitazionale del Sole
m È l’unico pianeta ad avere campo magnetico
2. Ciò che “tiene assieme” il Sistema Solare è:
m l’attrazione gravitazionale dei corpi che locompongono
m la grande massa del Sole
m la presenza dei pianeti
m il campo magnetico solare
m la presenza della nube di Oort
3. Perché i pianeti ci appaiono luminosi?
m Perché producono luce propria, come le stelle
m Perché sono illuminati dal Sole
m Perché sono visibili solo di notte
m Perché hanno dei satelliti
m Perché possiedono atmosfere
4. Poni i diversi corpi celesti del Sistema Solareche conosci in ordine crescente di distanza dalla Terra.
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
...............................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
.................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
5. Poni ora i corpi celesti del Sistema Solare checonosci in ordine decrescente di distanza dal Sole.
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
...............................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
.................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
test
28
Appendice 2
Brano tratto dal Dialogo dei massimi Sistemi di Galileo Galilei
Questo brano, tratto dal Dialogo dei massimi Sistemi di Galileo Galilei, affronta il discorso dei satelliti diGiove. (Una copia, elettronica, di libero accesso ed utilizzo del Dialogo dei massimi Sistemi di G. Galilei si puòavere al sito www.liberliber.it)
SAGREDO. Per qual cagione chiamate voi Lune i quattro pianeti gioviali?
SALVIATI. Tali si rappresentan elleno a chi stando in Giove le riguardasse. Imperocché esse per se stesse sontenebrose, e dal Sole ricevono il lume, il che è manifesto dal suo rimaner eclissate quando entrano nel cono del-l’ombra di Giove; e perché di esse vien solamente illuminato l’emisferio che riguarda verso il Sole, a noi, che sia-mo fuor de i loro orbi e piú vicini al Sole, si mostrano sempre tutte lucide; ma a chi fusse in Giove si mostre-rebbero tutte luminose quando fussero nelle parti superiori de i lor cerchi, ma nelle parti inferiori, cioè tra Gio-ve e ‘l Sole, da Giove si scorgerebbon falcate: ed in somma farebbero a i Gioviali le mutazioni stesse di figureche a noi Terrestri fa la Luna. Vedete ora quanto mirabilmente si accordano co ‘l sistema Copernicano questetre prime corde, che da principio parevan sí dissonanti. Di qui potrà intanto il signor Simplicio vedere con quan-ta probabilità si possa concludere che non la Terra, ma il Sole, sia nel centro delle conversioni de i pianeti: epoiché la Terra vien collocata tra i corpi mondani che indubitatamente si muovono intorno al Sole, cioè sopraMercurio e Venere, e sotto a Saturno, Giove e Marte, come parimente non sarà probabilissimo e forse neces-sario concedere che essa ancora gli vadia intorno?
SIMPLICIO. Questi accidenti son tanto grandi e cospicui, che non è possibile che Tolomeo e gli altri suoiseguaci non ne abbiano avuto cognizione; ed avendol auta, è pur necessario che abbiano ancor trovata manie-ra di render di tali e cosí sensate apparenze sufficiente ragione, ed anco assai congrua e verisimile, poiché persí lungo tempo è stata ricevuta da tanti e tanti.
Brano dal Sidereus Nuncius di Galileo Galilei
Brano dal Sidereus Nuncius di Galileo Galilei, in cui l’autore descrive la fondamentale scoperta, col cannocchiale,dei 4 satelliti più interni di Giove, chiamati da allora “medicei” in quanto il Galilei dedica la scoperta, come si usavaal tempo, alla Signoria dei Medici di Firenze.
Il giorno sette gennaio, dunque, dell’anno milleseicentodieci, a un’ora di notte, mentre col cannocchiale osser-vavo gli astri mi si presentò Giove; poiché mi ero preparato uno strumento eccellente, vidi (e ciò prima non miera accaduto per la debolezza dell’altro strumento) che intorno gli stavano tre stelle piccole ma luminosissime;e quantunque le credessi del numero delle fisse, mi destarono una certa meraviglia, perché apparivano dispo-ste esattamente secondo una linea retta e parallela all’eclittica, e più splendenti delle altre di grandezza ugua-le alla loro.Fra loro e rispetto a Giove erano in questo ordine:
Ori. Occ.
29
cioè due stelle erano a oriente, una a occidente. La più orientale e l’occidentale apparivano un po’ maggiori del-l’altra: non mi curai minimamente della loro distanza da Giove, perché, come ho detto, le avevo credute fisse.Quando, non so da qual destino condotto, mi rivolsi di nuovo alla medesima indagine il giorno otto, vidi unadisposizione ben diversa: le tre stelle infatti erano tutte a occidente rispetto a Giove, e più vicine tra loro chela notte antecedente e separate da eguali intervalli, come mostra il disegno seguente:
A questo punto, non pensando assolutamente allo spostamento delle stelle, cominciai a chiedermi in qualmodo Giove si potesse trovare più ad oriente delle dette stelle fisse, quando il giorno prima era ad occidenterispetto a due di esse. Ed ebbi il dubbio che Giove non fosse per caso diretto, diversamente dal calcolo astro-nomico, ed avesse col proprio moto oltrepassato quelle stelle. Per questo con gran desiderio aspettai la nottesuccessiva: ma la mia speranza fu resa vana, perché il cielo fu tutto coperto di nubi.Ma il giorno dieci le stelle mi apparvero in questa posizione rispetto a Giove:
cioè ve n’erano due soltanto, ed entrambe orientali: la terza, come supposi, era nascosta sotto Giove. Eranocome prima sulla stessa retta con Giove, e poste esattamente secondo la linea dello Zodiaco. Quando vidi que-sto e compresi che in alcun modo potevano attribuirsi a Giove simili spostamenti, sapendo inoltre che le stel-le osservate eran sempre le stesse (nessun’altra precedente o seguente ve n’era entro grande intervallo sullalinea dello Zodiaco), mutando la perplessità in meraviglia, compresi che l’apparente mutazione non era di Gio-ve ma delle stelle da me scoperte; e per questo pensai di dovere da allora in poi osservare a lungo il fenomenoattentamente e scrupolosamente.Il giorno undici vidi questa disposizione:
solo due stelle orientali, di cui quella di mezzo distava da Giove il triplo che dalla stella più a oriente: questaera quasi il doppio dell’altra, quantunque la notte antecedente fossero apparse uguali. Stabilii dunque e con-clusi fuor d’ogni dubbio che in cielo v’erano stelle vaganti attorno a Giove, come Venere e Mercurio attorno alSole: cosa che finalmente fu osservata in maniera più chiara alla luce meridiana in numerose altre osservazio-ni. Fu anche notato che non sono solo tre, ma quattro, le stelle che compiono i loro giri attorno a Giove: la suc-cessiva narrazione dirà le lor permutazioni, osservate in seguito più esattamente: misurai anche al telescopiole loro reciproche distanze, nel modo spiegato più sopra: notai pure le ore delle osservazioni, soprattutto quan-do ne feci molte in una stessa notte: infatti son così veloci le rivoluzioni di questi pianeti che spesso si posso-no notare differenze anche orarie.Il giorno dodici, a un’ora di notte, così vidi disposte le stelle:
la stella più orientale era maggiore della più occidentale: tuttavia erano entrambe molto visibili e lucenti: l’unae l’altra distavano da Giove due minuti primi. All’ora terza cominciò ad apparire anche una terza stellina, primanon vista, che dalla parte orientale quasi toccava Giove, ed era molto piccola. Tutte erano sulla medesima ret-ta e disposte secondo la linea dell’eclittica.Il giorno tredici furono da me viste per la prima volta quattro stelle nella seguente posizione rispetto a Giove:
tre erano ad occidente e una ad oriente: formavano all’incirca una linea retta; ché quella che era in mezzo tra leoccidentali si scostava di poco dalla retta verso settentrione. La orientale era distante da Giove due minuti, e gli
Ori. Occ.
Ori. Occ.
Ori. Occ.
Ori. Occ.
Ori. Occ.
30
intervalli delle rimanenti e di Giove eran di un sol minuto ciascuno. Tutte le stelle mostravano la stessa grandez-za e, benché piccole, erano tuttavia lucentissime e di gran lunga più splendenti delle fisse di egual grandezza.Il giorno quattordici il tempo fu nuvoloso.Il quindici, alla terza ora di notte, quattro stelle eran rispetto a Giove nella posizione qui sotto raffigurata:
occidentali tutte e disposte quasi su una stessa linea retta; quella che, contando da Giove, era terza, si levavaun poco verso borea: la più vicina a Giove era la più piccola, le altre di seguito apparivan maggiori; le distanzefra Giove e le tre stelle seguenti erano uguali tutte e di due minuti, ma la più occidentale distava quattro minu-ti da quella a lei vicina. Erano alquanto luminose e per nulla scintillanti, quali sempre apparvero, e prima e dopo.All’ora settima c’erano solo tre stelle, e così si vedevano rispetto a Giove:
erano cioè esattamente sulla stessa retta: la più vicina a Giove era assai piccola, e lontana da quello tre minu-ti primi: da questa la seconda distava un minuto: la terza distava dalla seconda 4 minuti e 30 secondi. Dopoun’altra ora le due stelline di mezzo erano ancor più vicine: distavano infatti solo 30 minuti secondi.Il giorno sedici a un’ora di notte, vidi tre stelle disposte secondo quest’ordine:
due tenevano in mezzo Giove, distanti da lui zero minuti, 40 secondi da una parte e dall’altra; la terza, occidenta-le, distava da Giove 8 minuti. Quelle vicine a Giove apparivan non maggiori ma più luminose della più lontana.Il giorno diciassette, a ore zero e 30 minuti dal tramonto, la configurazione era la seguente:
una sola stella orientale distava da Giove 3 minuti; a occidente pure una, che distava da Giove 11 minuti. L’o-rientale appariva doppia dell’occidentale; non v’erano che queste due. Dopo quattro ore però, cioè verso l’oraquinta, cominciò ad emergerne nella parte orientale una terza che prima, io credo, era in congiunzione con laprecedente; tale era la posizione:
la stella di mezzo, vicinissima all’orientale, si allontanava da quella solo 20 minuti secondi, e declinava un pocoverso austro dalla linea retta condotta attraverso le due stelle estreme e Giove.Il giorno diciotto, a ore zero, 20 minuti dal tramonto, questo era l’aspetto:
la stella orientale era maggiore dell’occidentale e distante da Giove 8 minuti primi: l’occidentale distava daGiove 10 minuti.Il giorno diciannove, a due ore di notte, tale era la disposizione delle stelle:
v’erano cioè tre stelle esattamente in linea retta con Giove: una orientale, distante da Giove 6 minuti primi: traGiove e la prima seguente occidentale c’era una distanza di 5 minuti; questa distava da quella più a occidente4 minuti. Ero in dubbio se fra la stella orientale e Giove vi fosse una stellina, vicinissima a Giove, tanto che qua-si lo toccasse. All’ora quinta però chiaramente la vidi, che già occupava esattamente il punto medio fra Giove
Ori. Occ.
Ori. Occ.
Ori. Occ.
Ori. Occ.
Ori. Occ.
Ori. Occ.
Ori. Occ.
31
e la stella orientale, così che tale era la configurazione:
la stella vista per ultima era molto piccola, tuttavia all’ora sesta era quasi uguale in grandezza alle rimanenti.Il giorno venti, a un’ora, 15 minuti, apparve una consimile disposizione:
c’eran tre stelle tanto piccole che appena si potevano vedere: da Giove e fra loro non distavano più di un minu-to; ero incerto se ad occidente vi fossero due o tre stelline. Circa l’ora sesta erano disposte così:
l’orientale distava da Giove il doppio più di prima, cioè 2 minuti; quella di mezzo a occidente distava da Giovezero minuti, 40 secondi, dalla più occidentale zero minuti, 20 secondi. Infine, all’ora settima, si videro a occi-dente tre stelline:
quella più vicina a Giove distava da esso zero minuti, 20 secondi; fra questa e la più occidentale la distanza eradi 40 minuti secondi: tra esse se ne vedeva un’altra, volta un po’ verso mezzogiorno, lontana da quella più occi-dentale non più di 10 secondi.Il giorno ventuno, a ore zero, 30 minuti, v’erano a oriente tre stelline, egualmente distanti fra loro e da Giove:
le distanze, secondo stimai, erano di 50 minuti secondi. V’era anche una stella a occidente, distante da Giove4 minuti primi: l’orientale vicina a Giove era la più piccola; le altre alquanto maggiori, e quasi uguali fra loro.Il giorno ventidue, alle 2, la disposizione delle stelle era la seguente:
dalla stella orientale a Giove v’era una distanza di 5 minuti primi, da Giove alla più occidentale di 7 primi. Ledue stelle occidentali intermedie distavano reciprocamente di zero minuti, 40 secondi; la più vicina a Giove dis-tava da esso un minuto. Le stelline di mezzo eran più piccole di quelle estreme: si estendevano sulla medesimaretta secondo la linea dello Zodiaco, se non che quella centrale delle tre occidentali piegava un poco versoaustro. Ma, all’ora sesta di notte, apparvero in questa disposizione:
l’orientale era molto piccola, distante da Giove, come prima, 5 minuti. Le tre occidentali distavano egualmenteda Giove e fra loro, e le singole distanze erano di circa un minuto, 20 secondi; la stella più vicina a Giove appa-riva minore delle due seguenti: tutte si vedevano esattamente sulla stessa retta.Il giorno ventitré, a ore zero, 40 minuti dal tramonto, la disposizione delle stelle era all’incirca questa:
le tre stelle con Giove erano in linea retta secondo la linea dello Zodiaco, come sempre furono; due erano orien-tali, una occidentale. La più orientale distava dalla successiva 7 minuti primi, questa da Giove 2 minuti, 40secondi; Giove distava dalla occidentale 3 minuti, 20 secondi; erano tutte quasi eguali per grandezza. Ma all’o-
Ori. Occ.
Ori. Occ.
Ori. Occ.
Ori. Occ.
Ori. Occ.
Ori. Occ.
Ori. Occ.
Ori. Occ.
32
ra quinta due stelle, che prima eran vicine a Giove, non si vedevano più, nascoste, credo, sotto Giove; e tale eral’aspetto:
Il giorno ventiquattro si videro tre stelle, orientali tutte e quasi sulla stessa retta con Giove:
quella di mezzo deviava un po’ verso austro. La più vicina a Giove distava da esso 2 minuti, la seguente dista-va da questa zero minuti, 30 secondi, da questa la più orientale 9 minuti; erano tutte molto splendenti. All’orasesta solo due si offrivano alla vista, in questa posizione:
cioè esattamente sulla stessa retta con Giove, da cui la più vicina si allontanava 3 minuti; l’altra distava da que-sta 8 primi; se non mi inganno le due piccole stelle di mezzo prima osservate s’erano unite in una.Il giorno venticinque, a un’ora e 40 minuti, così era la disposizione:
v’erano dunque solo due stelle nella parte orientale, abbastanza grandi: la più orientale distava da quella dimezzo 5 minuti, quella di mezzo da Giove 6 minuti.Il giorno ventisei, a ore zero, 40 minuti, la collocazione delle stelle era questa:
si vedevan dunque tre stelle, delle quali due orientali, la terza occidentale rispetto a Giove: questa distava daesso 5 minuti; la stella centrale a oriente distava da Giove 5 minuti, 20 secondi; la più orientale da quella di mez-zo 6 minuti; erano poste sulla stessa retta e di ugual grandezza. All’ora quinta, la disposizione era quasi la stes-sa, diversa solo pel fatto che a oriente s’affacciava vicino a Giove una quarta stellina, minore delle altre, distan-te da Giove 30 minuti, ma che si levava un po’ dalla linea retta verso borea, come dimostra la figura seguente:
Il giorno ventisette, a un’ora dal tramonto, si vedeva una sola stella, orientale, secondo questa disposizione:
era molto piccola, e lontana da Giove 7 minuti.Il ventotto e ventinove per l’interporsi di nubi non si poté osservare nulla.Il giorno trenta, a un’ora di notte, le stelle si vedevano poste così:
una a oriente, distante da Giove 2 minuti, 30 secondi, due a occidente, di cui la più vicina a Giove distava daesso 3 minuti: l’altra distava da questa un minuto: la posizione delle due stelle estreme e di Giove era sullamedesima retta, ma la stella centrale si levava un po’ verso borea: la più occidentale era minore delle altre.L’ultimo giorno, alle due di notte, si videro due stelle a oriente, una ad occidente:
Ori. Occ.
Ori. Occ.
Ori. Occ.
Ori. Occ.
Ori. Occ.
Ori. Occ.
Ori. Occ.
Ori. Occ.
Ori. Occ.
33
La stella centrale delle due orientali distava da Giove 2 minuti, 20 secondi, la più orientale distava da questazero minuti, 30 secondi; l’occidentale distava da Giove 10 minuti: erano quasi sulla stessa retta, solo l’orienta-le più vicina a Giove si levava un poco verso settentrione. All’ora quarta
le due orientali erano ancor più vicine fra loro: distavano infatti solo 20 minuti secondi. La stella occidentaleapparve in queste osservazioni abbastanza piccola.Il giorno primo febbraio, alla seconda ora di notte, la posizione era la seguente:
La stella più orientale distava da Giove 6 minuti, la occidentale 8; ad oriente una stella, molto piccola, distavada Giove 20 minuti secondi: determinavano una linea esattamente retta.Il giorno due le stelle apparvero secondo quest’ordine:
Una sola a oriente, distante da Giove 6 minuti; Giove distava dalla stella occidentale più vicina 4 minuti; fraquesta e la più occidentale la distanza era di 8 minuti: erano esattamente sulla stessa retta, e quasi di egualgrandezza. Ma, all’ora settima, v’erano quattro stelle:
fra le quali Giove occupava il posto di mezzo. Di queste stelle la più orientale distava dalle seguenti 4 minuti,questa da Giove un minuto, 40 secondi: Giove distava dalla stella occidentale più vicina 6 minuti, questa dallapiù occidentale 8 minuti: erano ugualmente tutte sulla stessa retta, stesa secondo la linea dello Zodiaco.Il giorno tre, all’ora settima, le stelle erano disposte in questo ordine:
l’orientale distava da Giove un minuto, 30 secondi; l’occidentale vicina 2 minuti: da questa l’altra più occiden-tale si distanziava di 10 minuti: erano precisamente sulla stessa retta, e di ugual grandezza.Il giorno quattro, all’ora seconda, stavano attorno a Giove quattro stelle, due orientali e due occidentali, dis-poste esattamente sulla medesima retta, come nella seguente figura:
La più orientale distava dalla seguente 3 minuti, questa distava da Giove zero minuti, 40 secondi; Giove dista-va dalla occidentale vicina 4 minuti, questa dalla più occidentale 6 minuti. Di grandezza erano quasi uguali, lapiù vicina a Giove appariva un po’ minore delle altre. All’ora settima le stelle orientali distavano solo zero minu-ti, 30 secondi.
Giove distava dalla orientale più vicina 2 minuti, dalla occidentale seguente 4 minuti; questa distava dalla piùoccidentale 3 minuti; erano uguali tutte e sulla stessa retta, stesa secondo l’eclittica.Il giorno cinque il cielo fu nuvoloso.Il giorno sei apparvero solo due stelle che prendevan Giove nel mezzo, come si vede nella figura seguente:
Ori. Occ.
Ori. Occ.
Ori. Occ.
Ori. Occ.
Ori. Occ.
Ori. Occ.
Ori. Occ.
Ori. Occ.
34
l’orientale distava da Giove 2 minuti, l’occidentale 3 minuti: erano sulla stessa retta con Giove e pari per grandezza.Il giorno sette v’erano due stelle, entrambe orientali rispetto a Giove, disposte a questo modo:
le distanze fra loro e Giove erano uguali, cioè di un minuto primo; fra le stelle e il centro di Giove passava unalinea retta.Il giorno otto, a un’ora, v’erano tre stelle, orientali tutte, come nella figura:
quella vicina a Giove, abbastanza piccola, distava da esso un minuto, 20 secondi; quella di mezzo distava daquesta 4 minuti ed era abbastanza grande; la più orientale, molto piccola, distava da questa zero minuti, 20secondi. Ero incerto se vicino a Giove vi fosse una sola stellina o ve ne fossero due: un’altra si vedeva infatti tal-volta esser vicina a questa verso oriente, meravigliosamente piccola, distante dalla prima zero minuti e 10secondi soltanto: erano tutte sulla stessa linea retta, disposte secondo il corso dello Zodiaco. Alle tre la stellapiù vicina a Giove quasi lo toccava: ne distava infatti solo zero minuti e 10 secondi: le altre s’eran fatte più lon-tane da Giove: quella del centro distava infatti da Giove 6 minuti. Infine alle quattro quella ch’era prima la piùvicina a Giove, congiunta con esso, non si vedeva più.Il giorno nove, a ore zero, 30 minuti, stavano presso Giove due stelle a oriente, una ad occidente, in tal dispo-sizione:
La più orientale, che era abbastanza piccola, distava dalla successiva 4 minuti; quella di mezzo, maggiore, dis-tava da Giove 7 minuti; Giove distava dalla occidentale, che era piccola, 4 minuti. Il giorno dieci, a un’ora e 30 minuti, due stelline, molto piccole, entrambe orientali, furono viste in tale disposizione:
la più lontana distava da Giove 10 minuti, la più vicina zero minuti, 20 secondi; erano sulla stessa retta. Allequattro però la stella più vicina a Giove non appariva più: anche l’altra si vedeva tanto impiccolita che appenala si poteva distinguere, quantunque l’aria fosse chiarissima, ed era più lontana di prima da Giove, giacché nedistava 12 minuti.Il giorno undici, a un’ora, v’erano due stelle a oriente, una a occidente. La occidentale distava da Giove 4 minu-ti, la orientale più vicina
distava ugualmente 4 minuti da Giove; la più orientale distava da questa 8 minuti; erano abbastanza chiare esulla stessa retta. Ma alle tre una quarta stella, vicinissima a Giove, fu vista ad oriente, minore delle altre,distante da Giove
zero minuti, 30 secondi, e deviante un po’ verso aquilone dalla linea retta condotta attraverso le altre stelle:erano assai splendenti tutte, e molto visibili. Alle cinque e mezza già la stella orientale più vicina a Giove, fat-ta da lui più lontana, occupava il posto di mezzo fra Giove e la stella più orientale a lei vicina; erano tutte esat-tamente sulla stessa linea retta, di pari grandezza, come si può vedere dalla figura seguente:
Ori. Occ.
Ori. Occ.
Ori. Occ.
Ori. Occ.
Ori. Occ.
Ori. Occ.
Ori. Occ.
35
Il giorno dodici, a ore zero, 40 minuti, c’erano due stelle ad oriente, due parimenti ad occidente. La orientalepiù lontana distava da Giove 10 minuti, l’occidentale più lontana 8,
ed erano entrambe abbastanza visibili; le altre due erano vicinissime a Giove, e molto piccole, soprattutto quel-la ad oriente che distava da Giove zero minuti, 40 secondi; l’occidentale ne distava un minuto. Alle quattro lastellina che era più vicina a Giove ad oriente, non appariva più.Il giorno tredici, a ore zero, 30 minuti, apparivano due stelle ad oriente, due ad occidente.
L’orientale più vicina a Giove, abbastanza chiara, distava da esso 2 minuti; da questa la più orientale, meno visi-bile, distava 4 minuti. Fra le occidentali, la più lontana da Giove, meno visibile, se ne allontanava 4 minuti; fraquesta e Giove si interponeva una piccola stella più vicina alla stella più occidentale, distando da quella nonpiù di zero minuti, 30 secondi. Erano tutte sulla stessa retta, esattamente secondo la linea dell’eclittica.Il giorno quindici (il quattordici il cielo era stato coperto da nubi), a un’ora, tale era la posizione degli astri:
v’erano cioè tre stelle a oriente, e nessuna se ne vedeva a occidente: l’orientale più vicina a Giove ne distavazero minuti, 50 secondi; la successiva distava da questa zero minuti, 20 secondi; da questa ultima la più orien-tale distava 2 minuti, ed era maggiore delle altre; le più vicine a Giove erano infatti molto piccole. Ma, verso lecinque, delle stelle vicine a Giove se ne vedeva solo una,
distante da esso zero minuti, 30 secondi; la distanza da Giove della più orientale era aumentata: era infatti alloradi 4 minuti. Ma, alle sei, oltre le due, come ora si disse, poste ad oriente, si vedeva verso occidente una stellina,molto piccola, distante da Giove 2 minuti.
Il giorno sedici, alle sei, erano in tale posizione:
la stella orientale distava da Giove 7 minuti, Giove da quella che lo seguiva a occidente 5 minuti, questa dallarestante più occidentale 3 minuti: erano tutte quasi di ugual grandezza, abbastanza visibili, e sulla stessa linearetta, esattamente secondo il cammino dello Zodiaco.Il giorno diciassette, a un’ora, c’erano due stelle:
orientale una, distante da Giove 3 minuti, occidentale l’altra, distante 10 minuti: questa era alquanto minoredella orientale. Ma, alle sei, la orientale era più vicina a Giove, perché distava zero minuti, 50 secondi; la occi-dentale invece era più lontana, cioè 12 minuti. In entrambe le osservazioni erano sulla stessa retta, ed entram-be abbastanza piccole, soprattutto la orientale nella seconda osservazione.Il giorno 18, a un’ora, c’erano tre stelle, delle quali due occidentali, una orientale: la orientale distava da Giove3 minuti, l’occidentale più vicina 2 minuti;
Ori. Occ.
Ori. Occ.
Ori. Occ.
Ori. Occ.
Ori. Occ.
Ori. Occ.
Ori. Occ.
Ori. Occ.
36
la più occidentale distava da quella di mezzo 8 minuti: tutte erano esattamente sulla stessa retta, e quasi di parigrandezza. Ma, alle due, le stelle più vicine distavan da Giove per intervalli uguali: l’occidentale infatti ne dis-tava anch’essa 3 minuti. Alle sei però si vide una quarta stellina fra la più orientale e Giove, in tal disposizione:
la più orientale distava dalla seguente 3 minuti, la seguente da Giove un minuto, 50 secondi, Giove distava dal-la occidentale che lo seguiva 3 minuti, questa dalla più occidentale 7 minuti: erano quasi uguali, solo la orien-tale vicina a Giove era un po’ più piccola delle altre: erano sulla stessa retta, parallela all’eclittica.Il giorno 19, a ore zero, 40 minuti, si videro solo due stelle, occidentali rispetto a Giove
abbastanza grandi ed esattamente sulla stessa retta con Giove, disposte secondo il cammino dell’eclittica. Lapiù vicina distava da Giove 7 minuti, questa dalla più occidentale 6 minuti.Il giorno 20 il cielo fu nuvoloso.Il giorno 21, a un’ora, 30 minuti, si vedevano tre stelline abbastanza piccole, in questa disposizione:
l’orientale distava da Giove 2 minuti, Giove dalla occidentale che seguiva 3 minuti, questa 7 minuti dalla piùoccidentale: erano esattamente sulla stessa linea parallela all’eclittica.Il giorno 25, a un’ora, 30 minuti (nelle tre notti precedenti il cielo era stato coperto di nubi) apparvero tre stelle:
due orientali, le cui distanze reciproche e da Giove erano uguali, di 4 minuti; a occidente una distava da Giove2 minuti: erano esattamente sulla stessa retta, secondo il cammino dell’eclittica.Il giorno 26, a ore zero, 30 minuti, v’erano soltanto due stelle:
una orientale, distante da Giove 10 minuti, l’altra occidentale, distante 6 minuti: l’orientale era alquanto mino-re dell’occidentale. Ma alle 5 si videro tre stelle:
oltre le due già segnalate se ne vedeva una terza a occidente, presso Giove, molto piccola, che prima era nasco-sta sotto Giove, e ne distava un minuto; la stella orientale appariva più lontana di prima, distando da Giove 11minuti. Questa notte mi piacque osservare per la prima volta il cammino di Giove e dei pianeti vicini, secondola linea dello Zodiaco, in relazione ad una stella fissa: si vedeva infatti una stella fissa verso oriente, distantedal pianeta orientale 11 minuti, e poco volgeva verso austro, nel modo che segue:
Il giorno 27, a un’ora, 4 minuti, le stelle apparivano in tale configurazione:
la più orientale distava da Giove 10 minuti, la seguente, vicina a Giove, zero minuti, 30 secondi; l’occidentaleche seguiva distava 2 minuti, 30 secondi; da questa la più occidentale distava un minuto. Le più vicine a Giove
Ori. Occ.
Ori. Occ.
Ori. Occ.
Ori. Occ.
Ori. Occ.
Ori. Occ.
Ori. Occ.Fissa
Ori. Occ.Fissa
37
apparivano piccole, soprattutto l’orientale; le estreme invece erano molto visibili, particolarmente quella aoccidente; designavano esattamente una linea retta secondo il cammino dell’eclittica. Il cammino di questi pia-neti verso oriente si vedeva chiaramente dal riferimento alla predetta stella fissa; ad essa infatti Giove con ipianeti adiacenti era più vicino, come si può vedere nella figura. Ma alle 5 la stella orientale prossima a Giovene distava un minuto.Il giorno 28, a un’ora, si vedevano solo due stelle; una orientale, distante da Giove 9 minuti, una occidentale,distante 2 minuti: erano abbastanza visibili e sulla stessa retta: la stella fissa, perpendicolarmente a questalinea, cadeva sul pianeta orientale, come nella figura:
ma, alle 5, fu vista una terza stellina, distante ad oriente da Giove 2 minuti, in questa posizione:
Il giorno primo di marzo, a ore zero, 40 minuti, furono viste quattro stelle, tutte orientali, di cui la più vicina aGiove distava da esso 2 minuti; la successiva distava da questa un minuto, la terza zero minuti, 2 secondi, edera più luminosa delle altre: da questa la più orientale distava 4 minuti, ed era più piccola delle rimanenti.Segnavano una linea quasi retta, se non che la terza a contar da Giove era un po’ sollevata. La stella fissa for-mava con Giove e la stella più orientale un triangolo equilatero, come nella figura:
Il giorno 2, a zero ore, 40 minuti, c’erano tre pianeti, due orientali, uno occidentale, in tale configurazione:
Il più orientale distava da Giove 7 minuti, da questo il seguente zero minuti, 30 secondi; l’occidentale si allon-tanava da Giove 2 minuti; gli estremi erano più luminosi e più grandi dell’altro, che appariva molto piccolo. Ilpiù orientale sembrava un po’ elevato verso borea dalla linea retta condotta attraverso i restanti pianeti e Gio-ve. La stella fissa già notata distava 8 minuti dal pianeta occidentale, secondo la perpendicolare condotta dalpianeta stesso sulla retta passante per tutti i pianeti, come dimostra la figura annessa.Mi piacque aggiungere questi confronti di Giove e i pianeti vicini con la stella fissa, affinché da quelli chiunquepossa intendere che i movimenti dei pianeti medesimi, sia secondo la longitudine che secondo la latitudine,concordano minutamente con i moti che si traggono dalle tavole.Queste sono le osservazioni sui quattro Astri Medicei di recente per la prima volta da me scoperti, dalle qualipur non essendo ancora possibile addurre i loro periodi, è lecito dir cose degne di attenzione. In primo luogo,poiché ora seguono, ora precedono Giove ad uguali intervalli e si allontanano da esso solo ben poco spazio oraverso oriente ora verso occidente, e lo accompagnano sia nel moto retrogrado che nel diretto, a nessuno puònascer dubbio che compiano attorno a Giove le loro rivoluzioni, e nello stesso tempo effettuino tutti insiemecon periodo dodecennale il lor giro intorno al centro del mondo.
Ori. Occ.Fissa
Ori. Occ.
Ori. Occ.Fissa
Ori. Occ.Fissa
IND ICE
1. Cos’è “Alla Scoperta del Cielo” e come è organizzato .................................. 51.1 Come è strutturato il Progetto ed i suoi materiali di base............................... 51.2 Quali sono i tempi del Progetto e gli altri materiali a disposizione .............. 61.3 Il Concorso abbinato al Progetto ............................................................................ 6
2. I volumetti per gli studenti. Considerazioni generali................................... 7
3. La prima Tappa. Il Sistema Solare: concetti e contenuti............................. 93.1 Prima notte.................................................................................................................. 103.2 Seconda notte.............................................................................................................. 113.3 Terza notte ................................................................................................................... 123.4 Quarta notte................................................................................................................ 133.5 Conclusioni sulla tappa “Sistema Solare” ............................................................ 13
4. Seconda tappa. Le stelle: concetti e contenuti .............................................. 154.1 Prima notte.................................................................................................................. 164.2 Seconda notte ............................................................................................................. 174.3 Terza notte .................................................................................................................. 204.4 Quarta notte .............................................................................................................. 204.5 Conclusioni sulla tappa “Le Stelle”....................................................................... 20
5. Galassie ed Universo: concetti e contenuti ................................................... 225.1 Prima notte ................................................................................................................. 225.2 Seconda notte ............................................................................................................ 225.3 Terza notte................................................................................................................... 235.4 Quarta notte ............................................................................................................... 235.5 Conclusioni sulla tappa “Galassie ed Universo”................................................ 23
Appendice 1 ...................................................................................................................... 25Verifica suggerita per le prime e seconde classi della scuola secondaria di primo grado ................................................................................................................... 25Verifica suggerita per le terze classi scuola secondaria di primo grado e per la prima classe della scuola secondaria di secondo grado.......................... 27
Appendice 2 ...................................................................................................................... 28