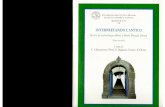Facoltà di Economia Il processo di selezione del personale: metodi e applicazioni Anno
Lamberto Caffarelli e la scoperta della Gnosi, Parte seconda - La riflessione personale
-
Upload
uninsubria -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Lamberto Caffarelli e la scoperta della Gnosi, Parte seconda - La riflessione personale
Conoscenza Luglio - Settembre 201414
LAMBERTO CAFFARELLIE LA SCOPERTA DELLA GNOSIdi Michele Olzi
Relativamente a quest'ultimo vedremonella terza e ultima parte della nostraricognizione sullo “gnosticismocaffarelliano”, come Caffarelli siavvicinerà alla realtà, e agli esponentidei gruppi neo-gnostici del XX secolo.Ora cercheremo invece di tratteggiarela componente gnostica nella riflessionedel musicista faentino attraverso partedella sua produzione artistico-letteraria,e con l'aiuto delle vicende biografichedel personaggio.Vogliamo perciò cominciare la nostratrattazione introducendo la crisi diLamberto Caffarelli, ovvero quando ilsuo percorso spirituale ebbe inizio:
“Finché arrivò una crisi, nel 1906, nelquale toccai il fondo dell'esaurimentonervoso, ma che però segna il primopasso d'un lentissimo miglioramento eincamminamento per nuove strade.Infatti dopo tale anno incominciai lostudio della teosofia, della filosofia,dell'inglese; studiavo anche me stesso,ma con poco frutto poetico [...]” 2
In questa lettera datata 16 Settembre1916, Lamberto Caffarelli racconta allasua musa e amata Giuliana Anzilotti delmomento cruciale in cui il Nostro si avviaper quel percorso spirituale checontrassegnerà l'intera sua vita.3Per entrare ancora più nello specifico,la crisi del 1906 rappresenta in realtà ilculmine di un processo interiore, il cuiesordio è riconducibile all'uscita diCaffarelli dal seminario vescovile (1896),luogo dove Lamberto aveva ricevuto lasua prima educazione religiosa emusicale.
Per capire cosa provasse e pensasse ilNostro nel svolgersi di quel marasmainteriore, ci rifacciamo ancora una voltaalla corrispondenza con la Anzilotti:
“Nell'anima mia avvenivano processi didistacco violento da tutto quello chem'era stato insegnato. Il primo puntoche io negavo era il peccato d'origine.Tutti i miei sarcasmi, la mia ira, la miarivolta erano contro quel principio. Mi
Parte seconda – La riflessione personale
Nella scorsa puntata abbiamo visto come tra i libri appartenutial Maestro di Cappella e organista Lamberto Caffarelli visi trovasse una nutrita collezione di “letteratura gnostica”,ovvero testi e documenti riguardanti sia il fenomeno storicodei primi secoli dopo la nascita di Cristo, sia l'avvento diquel movimento religioso fondato da Jules Doinel nel 1890conosciuto col nome di Église Gnostique, definito a suavolta come “Nuovo Gnosticismo”1.
Conoscenza Luglio - Settembre 2014 15
avvicinai alla natura; la dissi buona, maledissichi aveva detto che era maledetta ...Eropoliedrico: mondano, profano e sacro, satiricoe commovente, tendevo però ai significatiprofondi. Questa tendenza, questa esigenzamia mi portò allo studio della filosofia, dellateosofia dell'occultismo... Mi riappacificai coldogma del peccato originale. Ne capivo laprofondità... Ora poco a poco la religiositàè tornata in me, ma trasparente, arricchita...[...]”4.
La data questa volta è 5 Maggio 1916,Caffarelli nel corso dello scambio epistolarecontinua la disamina delle ragioni, e delsentire che in quei dieci anni hanno portatoalla svolta cruciale nella sua esistenza eriflessione. Un passaggio, un motivo, unconcetto in particolare attira la nostraattenzione: “Il primo punto che io negavoera il peccato d'origine”. La nozione dipeccato originario è il primo passo percomprendere l'intera esperienza/riflessionespirituale del Maestro.
Lungi dal voler entrare nel merito di unadiscussione teologica, quello che Caffarellidescrive nella lettera all'amata è la dimensioneannessa alla concezione di peccato d'originenella storia del Cristianesimo, ovvero quellacorporea. Il peccato d'origine (nella riflessionedel nostro) inevitabilmente legato al destinoultimo dell'anima, non permette al singolouna salvazione se non attraverso unassoluzione (verosimilmente attraverso unistituzione che è la Chiesa di Roma nel nostrocaso). Ciò che spinge Caffarelli a rivoltarsiinizialmente contro questa nozione è il fattoche l'uomo non possa ricercare da sé e persé la redenzione dell'anima, avendo comeaggravante il proprio corpo. Tuttavia laquestione cambia nel caso in cui il dogmadel peccato d'origine venga slegato dalladimensione corporea/materiale nell'uomo.Ciò è possibile nel caso in cui la “cadutaspirituale” dell'essere umano avvenga primadella creazione del mondo materiale in cuiesso attualmente vive.
- continua a pag. 17 -
Conoscenza Luglio - Settembre 201416
Emanuel Swedenborg, (Stoccolma, 29gennaio 1688 – Londra, 29 marzo 1772) èstato uno scienziato, filosofo, teologo echiaroveggente svedese. Se in una primafase di vita si segnalò soprattutto per le suequa l i tà d i ecce l l ente sc ienz ia to ,successivamente – dall'età di 56 anni – lasua esistenza fu caratterizzata da un'intensaspiritualità, in virtù della quale egli sostenevadi avere visioni e comunicazioni con entitàe mondi dell'invisibile. Elaborò anche unpensiero religioso originale, profondo edarticolato, di matrice cristiana, che tuttaviaprovocò la condanna della Chiesa Luteranadi Svezia (diretta però alla sola teoria e nonalla persona che l'aveva formulata). Al di làdegli aspetti relativi allo Swedenborg spiritualeed "indagatore" della sfera ultraterrena, forsei più conosciuti di un personaggio dallagrande complessità, meritano di essererimarcati anche i "lasciti" dello Svedese inaltre aree del pensiero umano, non sempremessi in adeguato risalto ma comunqueforieri di benefiche, importanti conseguenze.Riguardo la psicologia del profondo, adesempio, i suoi scritti inerenti ai simboli furonoprofondamente studiati ed ammirati da CarlGustav Jung. Per lo scienziato svizzero,nell'indagine della relazione tra esterioritàed interiorità, ossia tra conscio ed inconscio,va considerata con particolare attenzione lateoria delle corrispondenze, basilare nelpensiero swedenborghiano, che stabilisceil rapporto tra gli elementi fisici con glianaloghi elementi metafisici. Inoltre, apparelegittima la relazione del concetto diSwedenborg relativo al "Grande Uomo", ove ogni individuo è parte di un Uomo immenso vivente nel Mondo Spirituale,con la nozione junghiana di inconscio collettivo, relazione peraltro esplicitamente definita nelle parole dello stessoJung: "In un certo modo noi siamo parte di una grande anima unitaria, o, per esprimerci con Swedenborg, di ununico, immenso essere umano" (in "Il problema psichico dell'uomo moderno", 1931).Vanno inoltre sottolineate le straordinarie intuizioni di Swedenborg nella descrizione scientifica dell'universo, chepresentano similitudini significative con la fisica quantistica del XX secolo. In un'epoca nella quale Newton sostenevache la materia era composta da atomi permanenti ed impenetrabili messi in movimento da forze esterne, Swedenborginvece insegnava che essa era moto, manifestato in forme geometriche, ed era composta da una serie di particellein ordine crescente di grandezza, ciascuna delle quali era costituita da un vortice chiuso di energia che ruota conmoto spiraleggiante a velocità infinita, arrivando ad assumere un aspetto solido.Personaggio di straordinaria statura culturale e spirituale, stimato ovunque nell'Europa a lui contemporanea, Swedenborglasciò un'eredità di pensiero che influenzò significativamente non solo importanti figure della spiritualità e dell'esoterismoma anche filosofi, scrittori, artisti e movimenti culturali successivi (da Balzac a R.W. Emerson, da Goethe a Borges oltrea Lamberto Caffarelli, che fu suo lettore). Lo stesso Immanuel Kant, che pure criticò le idee swedenborghiane nell'operagiovanile “I sogni di un visionario spiegati con i sogni della metafisica“, sostenne in seguito, a proposito delletestimonianze sull'Aldilà del Veggente svedese, che "… mentre dubito di ciascuna di esse, tuttavia ho assoluta fiduciain esse se complessivamente considerate" (cit. in Brian Inglis, Natural and Supernatural: A History of the Paranormalfrom the Earliest Times To 1914, London: Hodder & Stoughton 1978). Nonostante ciò, mentre ovunque nel mondosono già state pubblicate in quantità le opere di Swedenborg (soprattutto “Arcana Coelestia”, considerato il suocapolavoro, tradotto in quasi tutte le lingue) e si registrano le presenze di sodalizi dedicati alla sua figura ed al suopensiero praticamente a tutte le latitudini del pianeta (Swedenborg Society, Swedenborg Foundation, Gruppi di StudioSwedenborghiani e persino Chiese, come la Swedenborgian Church of North America), in Italia – stranamente manon troppo – si deve prendere atto dell'assenza quasi assoluta di opere swedenborghiane tradotte nella nostra lingua(a parte rarissime eccezioni) o di iniziative culturali a lui ispirate, difficile dire se per inerzia beatamente inconsapevole,per pura e semplice incapacità o per pregiudiziale ostilità ideologica, avversa ad uno dei più grandi e soprattutto liberiricercatori dello spirito che la storia abbia mai conosciuto.
Emanuel Swedenborg (ritratto custodito nel Castello di Gripsholm, Svezia)
Conoscenza Luglio - Settembre 2014 17
Ciò porta a ipotizzare che, all'interno di ognisingolo essere caduto in questa esistenzamateriale imperfetta esista ancora una scintillache lo possa ricondurre allo stato diperfezione, o alla propria salvazione spirituale.In questo caso la natura corporea dell'uomo(così come il concetto di caduta/peccato)non sono d'intralcio alla sua redenzionepersonale, ma al contrario possono essereun supporto/punto di partenza per/verso lamedesima. Una concezione di matricesquisitamente gnostica.Partendo da questo principio possiamo cosìcomprendere l'eterogeneità delle letture,degli interessi e delle esperienze a cui ilMaestro aderisce nell'ambito delle nuovecorrenti spirituali del Novecento. Ancora piùnello specifico possiamo intuire come ilmusicista faentino ricerchi nella dottrina enel pensiero di vari gruppi esoterici e/ooccultisti, la stessa componente gnostica cheva maturando in sé stesso e nella suariflessione. Il processo di maturazione dello
“gnosticismo caffarelliano” è affiancato daaltri due tematiche, oltre a quella di peccatooriginario, e queste sono quelle direincarnazione e trascendenza.
Tornando agli eventi e date che costellanol'incedere intellettuale del Maestro di Cappellafaentino, quando Caffarelli scrive a GiulianaAnzilotti del suo incipit spirituale siamo nel1916. Caffarelli è nel pieno della sua faseteosofica5, e solo l'anno successivo (1917)per opera dell'antroposofo e amico AlcibiadeMazzerelli6 il nostro inizia a frequentarel'ambiente antroposofico italiano7. Come siè visto nell'articolo precedente, due anni piùtardi (1919) Caffarelli si scrive con il primateosofo, e in seguito antroposofo LodovicoLandini8. Da questa corrispondenza notiamoche Landini, oltre a prodigarsi nel procurareal musicista i classici dello studio dello gno-sticismo antico (quali l'opera di George RobertStowe Mead)9, fornisce a Caffarelli informa-zioni sui circoli spiritici di Bologna e sulle
Foto 1 - Appunto di Lamberto Caffarelli
Conoscenza Luglio - Settembre 201418
relative pubblicazioni. Non ci stupisce perciòtrovare tra i libri di Caffarelli uno dei capolavoridi Emanuel Swedenborg10 (v. pag. 16), LaSapienza Angelica sulla Divina Provvidenza11.Ciò che invece può particolarmente attirarela nostra attenzione è l'appunto del musicistafaentino rivenuto all'interno dell'opera sud-detta (v. foto 1 pag. 17). Su questo fogliettosi vede rappresentata una scala in settegradini, strutturata su due colonne, in cui ilprimo livello è contrassegnato da “Istinti –Corpo fisico” e l'ultimo da “Entschlüsse(Risoluzioni) – Geistmensch (Uomo spirito)”.Come possiamo ben osservare i primi e gliultimi tre gradini formano due ordini, relati-vamente “Natura inferiore: Centauro” e“Natura più alta: Angelo”. Ultima indicazione
su cui vogliamo porre l'accento sono le de-nominazioni, in alto a sinistra, in prossimitàdegli ultimi tre gradini (dal basso verso l'altro“Imagination”, “Inspiration”, “Intuition”.Queste ultime tre facoltà sono conosciutenella terminologia steineriana come i “Gradidella Conoscenza Superiore”.Prima di procedere, occorre aprire una piccolaparentesi. Nel precedente articolo abbiamodovuto fare una classificazione della“letteratura gnostica” nel Fondo Caffarelli,abbiamo perciò considerato due grandi grup-pi temporali: i primi vent'anni del Novecento,e il periodo di cinque anni compreso tra il1945 e il 1950. Riconsideriamo il primocontenitore temporale. Se facciamo unaprima cernita tra la letteratura di carattere
Disciplina del movimento che si situa fra musica, canto, danza, psicologia e spiritualità, l'Euritmia fu ideata agli inizidel XX secolo da Rudolf Steiner, il grande Maestro austriaco che Lamberto Caffarelli ebbe modo di conoscere aDornach (Svizzera) ed al cui movimento antroposofico il Musicista faentino aderì. A differenza della ginnastica,mediante la quale il soggetto opera con le energie fìsiche in rapporto alla gravità, l'Euritmia intende manifestare lanatura della parola e della musica, grazie al movimento corporeo, in una dimensione esperienziale dello spirito.L'Euritmia è stata definita dallo stesso Steiner "parola e canto visibili": infatti i movimenti compiuti dalla laringedurante la fonazione vengono resi visibili dal movimento del corpo e il contenuto del linguaggio si trasforma nelgesto euritmico che ha una profonda influenza sull'anima. L'Euritmia è oggi conosciuta a livello mondiale quale artescenica ed assume anche un ruolo significativo sia nella pedagogia steineriana Waldorf sia nella medicina antroposofica.
Conoscenza Luglio - Settembre 2014 19
occultista, teosofico e antroposofico, e pro-viamo a fare un'ipotesi su quali siano stati ip r im i “c l a s s i c i ” ( de l l a co r ren teTeo/Antroposofica) che Caffarelli dovrebbesicuramente aver letto, un particolare ci balzasubito all'occhio. Analizzando le opere diHelena Petrovna Blavatsky12 fondatrice (uf-ficialmente insieme ad altri tredici membri)della Società Teosofica, e di Rudolf Steiner13
primo rappresentante dell'Antroposofia, deiprimi vent'anni del Novecento presenti nellacollezione del Maestro faentino, ci accorgia-mo che la maggior parte di esse sono infrancese e provenienti da cataloghi/caseeditrici francesi. Appurato ciò proseguiamocol ragionamento: quali lavori letterari diquesti due personaggi il Nostro ha sicura-mente letto? Per quanto riguarda MadameBlavatsky non abbiamo dubbi, e tra i titoli“certi” ascriviamo i sei volumi della DoctrineSecrète14. Venendo allo Steiner il cerchio sirestringe, ma la scelta si sdoppia: la primascelta (in ordine cronologico) è L’Éducationde l'Enfant au Point de Vue Spirituel15, laseconda L’Initiation, ou la Connaissance desMondes Supérieurs16 (traduzione francesedi Wie erlangt man Erkenntnisse der höherenWelten? “Come si ottiene conoscenza deimondi superiori?”). A far pendere l'ago della
bilancia su una delle due opere di Steiner èun fattore in particolare. L'Iniziazione (cosìcome è stata più spesso tradotta in italiano)è stata una delle prime opere del Dottore17
a introdurre il concetto di “Gradi di Cono-scenza Superiore” (come abbiamo visto de-bitamente annotati e sviluppati nel suo“appunto spiritista”) e di “Natura dell'Essere”.
Prima di muovere qualsiasi altro passo nellanostra trattazione occorre sottolineare che:attraverso la corrispondenza con Landinisappiamo che Caffarelli all'alba del 1919 eraanche attento ai temi e ai personaggi delloSpiritismo italiano e europeo18; non potremoelencare tutte le idee di Steiner che hannoinfluenzato Caffarelli, né tanto meno tuttigli elementi “di gnosticismo” nella dottrinadel filosofo di Krajevic19; Caffarelli tra il 1919e 1920 si avvia, sempre su consiglio diMazzerelli allo studio della lingua tedesca ed iventa membro de l mov imentoantroposofico in Italia20. Al fine di porre lecondizioni perché la riflessione sullo“gnosticismo caffarelliano” possa meglioessere scomposta e continuata, spostiamoavanti il nostro arco temporale di analisi. Nel1925, dopo aver conosciuto di persona eincontrato in due diverse occasioni
Foto 2 - Altro appunto di Lamberto Caffarelli
Conoscenza Luglio - Settembre 201420
Caffarelli21, Rudolf Steiner muore. Nellostesso anno il musicista faentino dà allestampe per la Tipografia Montanari la suaopera maggiore, l 'Arte nel MondoSpirituale22.Il nostro obbiettivo, al momento, è dimostrare quale sia la maturazione intellettualedi Caffarelli alla luce della poliedricità delleesperienze vissute e di come tutte questesiano legate dalla componente gnostica cheattraversa anche l'iniziale riflessione sulpeccato originario. Per fare ciò ci avvaleremodi un appunto del Maestro ulteriormentesviluppato a livello grafico e concettuale. Il“foglietto volante23” (v. foto 2 pag. 19) inquestione proviene dal terzo volume dellaDoctrine Secrète di Madame Blavatsky 24.In quest'opera la fondatrice della SocietàTeosofica tratta de “l'Antropogenesi”, oformazione dell'uomo. Come si deducedell'appunto caffarelliano (sulla sinistra),nell'attuale periodo storico l'essere umanosi trova in un quinto stato generazionale
della sua esistenza spirituale (a partire da unipotetico primo la cui peculiarità, rispettoall'uomo, era che il corpo di quest'ultimofosse etereo, o invisibile) ed è orientato verso(l'alto) i prossimi futuri stadi. Nella fattispeciei due triangoli sovrapposti rappresentano lasoglia umana (in basso) e la soglia divina (inalto). Dietro a tale schematizzazione c'è unconcetto fondamentale, ovvero quello di“Evoluzione Spirituale”.È necessario aprire una breve parentesi:possiamo con una certa sicurezza affermareche gli interessi e i motivi alla basedell'antropogenesi del terzo volume dellaBlavatsky, della formazione della SocietàTeosofica, e del libro di Swedenborg(annotato in steineriana-caffarellianamaniera), sono gli stessi del musicista faentinoin questi anni. Come abbiamo accennatoprima, tra questi troviamo le tematiche direincarnazione e la trascendenza. Ora perquanto riguarda la Società Teosofica è statoampiamente documentato come tra i motivi
Figura 3 - Concezione dello spirito nella vita dell'uomo comune
Conoscenza Luglio - Settembre 2014 21
della sua fondazione vi fosse quello di studiarei fenomeni spiritici25, e di come all'internodella medesima si fosse ampiamente discussosull'insegnamento della reincarnazione odel la trasmigrazione26 . Ciò che èfondamentale in questa tematica, e ci collegadirettamente col tema della trascendenzanella dottrina teosofica è il fatto che:
1. Lo spirito dell'uomo è immortale,sopravvive alla morte e si reincarna in unaltro corpo quando questa è sopraggiunta.
2. Esiste una realtà Assoluta, Infinita,Immutabile che trascende tutte le cose,i pensieri e le azioni del singolo individuo.
3. Lo spirito, o Sé fondamentale nell'uomopuò entrare a far parte di questa realtà.
Tornando all'appunto nell'opera della teosofarussa, dietro al susseguirsi delle generazionispirituali dell'uomo esiste una realtà di cuiabbiamo appena accennato i caratteri. Tut-tavia sussiste anche un meccanismo altret-tanto nascosto e imperituro che regola il ciclo(karmico nella terminologia orientaleggiantedella Teosofia) di reincarnazioni e rinascite.Questo processo può essere chiamato“Evoluzione Spirituale”. Per meglio illustrarequesto concetto nella riflessione del Maestrodi Cappella faentino abbiamo così elaboratograficamente l'appunto (v. figura 3 pag.20). Come vediamo dalle rette oblique delloschema, nello svolgimento degli eventi storici,il progresso spirituale dell'uomo tende inevi-tabilmente verso un'inarrestabile progressoverso l'alto (verso un “Paradiso Perduto”come dirà Caffarelli) o un ripiegamento co-stante verso il basso (verso una “TerraPromessa”, sempre con le parole del nostro).L'unico punto di riferimento in tutto lo sche-ma è l'incrocio tra le due linee, che nellatotalità del contesto rappresenta il momentoin cui l'uomo può aver coscienza della ten-sione del suo evolversi in questa dimensionemetafisica: la crisi. Questo momento di auto-consapevolezza (contestualizzato nella con-cezione teosofica) porta il singolo a ripensare
e a rivoluzionare la sua visione dell'universodelle cose che lo circonda, la sua corporeitàcompresa. Si accorge così che il suo sostratomateriale finito può essere trasceso, o megliopuò essere superato in direzione di una realtàinfinità in cui potersi integrare nella “pienezzadi un essere”. Ciò tuttavia è possibile solonel caso in cui la dimensione del tempo nonsia lineare, ma bensì circolare (vedi figura4). Il continuo ciclo di morte-rinascita, cosìcome l'eterno ritorno del tempo non lasciache l'uomo rimanga estraniato nella sua crisi,ma lo mette in relazione con l'assolutezzadella realtà divina (un concetto di matricequasi panteistica in questo caso). In questoprimo passaggio teosofico, possiamo quindidire che l'evoluzione spirituale dell'uomo siala trascendenza del corpo, o meglio la rein-tegrazione dell'essere dell'uomo in una realtàpiù grande.
Questa tuttavia è solo una prima fase delpensiero e dello gnosticismo caffarelliano.Riprendendo lo schema dei “Gradi diConoscenza Superiore” nel libro diSwedenborg ci accorgiamo subito di unacosa: il Sé teosofico (che qui diviene Io, o Ichnella terminologia steineriana), viene postoal centro dei due ordini di gradini limitrofi (itre in alto e i tre in basso). Anziché esserecollocato in un processo di reintegrazione,l'Io si trova diviso tra due polarità, tra duenature, tra due impulsi come osserverà
Figura 4 - Concezione Teosofica
Conoscenza Luglio - Settembre 201422
Caffarelli nel secondo capitolo del suo L'Artenel Mondo Spirituale27. Nel suo capolavoroCaffarelli non dimentica di citare Steiner ela sua lezione di Metastoria (o Macrostoria)28
delle vicende umane, non tralasciando didare il suo contributo personale e originale.Già nel proposito del primo saggio (“L'artecome Forza Evolutiva del Divenire Naturalee Umano”) gli echi gnostici non tardano amanifestarsi:
“Il valore dell'Arte è nell'uomo: il valoredell'uomo nella sua particolare natura ecosmica posizione di ponte fra un mondoche è sotto di lui e uno che gli sta sopra […]L'Arte è figurare il mondo in un determinatomomento del suo aspetto umano osuperumano. Attorno all'uomo, invisibilmenteoperoso si muove il Macrocosmo […] IlCosmo ci insegnò quel che dovevamointendere per essenza e operazione dell'Arte,quel che era la ragione del lavoro dell'Artistae il significato attivo dell'opera d'Arte: quel
che dalla parte del soggetto compie essanell'artista, e quel che dalla parte dell'oggettoraggiunge nel Cosmo […] L'artista per il fattodi operare si riconosce non più natura, maspirito. Così dal suo proprio vivere nell'operagli viene la rivelazione che la forma della vitaascensiva è un Ordine: Ordine è l'organismod'uno sviluppo29”.
All'interno di quel processo evolutivo chepermette all'uomo di scrivere la storia dellospirito, l'artista ha un punto di vistaprivilegiato: la sua interiorità spirituale.Secondo Caffarelli esiste un ordine moraledelle cose visibili e invisibili dell'Universo, evi è un polo verso cui tutte queste sonoorientate, ossia il Bene. L'artista puòriconoscere la sua posizione in quest'ordine,in quanto opera armonicamente con le stesseforze che tutto reggono e regolano. Lo “statoluminoso di armonia” (nell'opera di Caffarelli)è la triplice unione di Vero, Religione eBellezza. Nella sua produzione l'uomo-artista
"Omaggio a Caffarelli", acquafortedi Pietro Lenzini del 1973. L'artisticoritratto del Maestro è riprodotto sullacopertina di "Lamberto Caffarelli –poeta pensatore musicista faentino"di AA.VV., a cura di GiuseppeFagnocchi, Mobydick, 2013. Si trattadi un'opera ponderosa (544 pagine),dal pregevolissimo valore scientifico ericcamente documentata sullapoliedrica figura del Caffarelli;soprattutto è una pietra miliare nellarinascita degl studi e dell'interesseculturale riguardo il Maestro di Faenza,rinascita che si sta legittimamente – efinalmente – affermando, con esitilusinghieri, in Italia ed all'estero.
Conoscenza Luglio - Settembre 2014 23
diventa principio di quel processo disalvazione spirituale, che altro non è chel'estremo esito nella Macrostoria dell'umanità:
L'incarnar bellezza è l'atto che salva l'artistadalla fragilità di ogni forma: poiché la realtàautoliberatrice e liberatrice del mondo ch'egliha attiva in sé, che si esplica nel e dal suospirito è quella appunto che dà ad ogniriflesso fenomenico il potere di riverberarenel suo fuggire quell'Idea di Bellezza che nonè passibile di morte.
Ma quindi che cosa vuol dire essere salvatiin questo universo Macrocosmico, in cuil'uomo si rifletto, o meglio ancora si ri-conosce?
Che vuol dire che redime sé medesimo?Questo: che egli del continuo afferma sécome spirito e si differenzia dalla natura: il
lavoro suo appunto è voler la Bellezza in unmondo dove il caos rimescola gli elementi:un atto di continua scelta fra il mondo dellaBellezza che ha in sé e quello elementareche ha contro. Così una perpetua adesioneavviene nello spirito dell'Artista al mondospirituale della Bellezza, al Cosmo che movi-menta negli spazi gl'impulsi ascensivi: nonmera adesione d'intelletto ma di tutta la vitae di tutta la carne e del moto del propriodivenire, e questa è salvazione30.
Comprendiamo così anche il significatodell'affermazione “L'Arte è il moto umanodel Cosmo31”. L'artista si costituisce come“forza ascensiva” del mondo nel suo creare.L'Arte diventa accesso alla dimensione dellospirito nel processo di mutamento delle cosenaturali e umane. L'uomo-artista riconoscen-do sé stesso come parte portantedell'universo, e dell'ordine morale che regola
Figura 5 - Concezione Antroposofica
Conoscenza Luglio - Settembre 201424
il tutto, identifica il suo produrre artistica-mente (Microcosmo), con la creazione in unarealtà più grande (Macrocosmo), poichéoperanti entrambi sullo stesso piano e conle medesime energie: quelle dello spirito.
Queste ovviamente risiedono (anche) nell'Ioimmortale dell'uomo. Tuttavia l'Arte ha ancheun'altra funzione, quella di un atto liberativo.La creazione artistica opera in armonia sullecose naturali e umane redimendole, eportandole sul piano della vera realtà dellospirito. Con una parola del Maestro:“transustanziazione”32.
Il tema della metamorfosi spirituale è unadelle tematiche che il neognosticismo,l'antroposofia e il Nostro musicista faentinohanno in comune in questi anni33.
Tuttavia la redenzione, il ritorno all'uno divino,la possibilità attraverso l'iniziale realtà delcorpo, e l'amore per/della sua vera natura disentirsi parte di un universo spirituale (di cuil'uomo è comunque riflesso e immagine)sono temi che pervadono l'intera opera delMaestro, ma che raggiungono il loro apicenel terzo capitolo del suo lavoro più grande.Ne “L'Arte nelle sue relazioni con le visioniprimordiali della Vita coi Dogmi Generatori”la funzione salvifica/spirituale dell'Arte spostail suo obbiettivo dall'uomo a intere civiltà.Seguendo sempre la lezione steinerianaCaffarelli inaugura un nuovo capitolo nellaScienza dello Spirito34 analizzando l'arte divari popoli. Sempre aiutandoci con l'appuntodel Maestro ulteriormente sviluppatograficamente (v. figura 5 pag. 23), possiamomostrare come, in ogni civiltà “L'opera d'arteè Dogma che diventa immagine e senso”35.
In ogni civiltà esiste un determinata for-ma/culto/abitudine che il singolo individuoutilizza per interfacciarsi col sacro, e con ladimensione dello spirito. L'insieme di questeforme di culto costituisce a sua voltal'immagine (stereotipata) che quella civiltàha del sacro, e questo è il Dogma. Renderevivo e dinamico il Dogma, attraverso la cre-
azione di un immagine che sia riflesso deldivenire prima naturale, poi umano e infinedivino, significa produrre un'opera d'arte.L'artista diventa sacerdote che celebral'unione tra Macrocosmo e Microcosmo nelcuore dell'uomo. Ritornando al nostro schemavediamo come Caffarelli considera i Dogmidell'arte indiana, egizia e greca, e dovepossono essere collocati rispetto alla sogliadel divino. Il dogma della civiltà indiana comeabbiamo già accennato è quello di “ParadisoPerduto”36.
La disposizione psichica della Maya fa tendereal cielo, ma non possono, o non hanno piùnecessità di raggiungerlo. L'arte egizia inveceè concepita come “L'arte della vita progres-siva dell'oltretomba”37, nel senso che ilvolume geometrico delle sue costruzioni fain modo di risuonare (nell'intimità di ogniuomo di quella civiltà, in quel “sentirecollettivo”) come il “declinarsi” inevitabileverso l'eternità della morte, anche in seguitoalla medesima. “L'arte in Egitto è plasmatada una visione del passato dell'individuo edell'umanità”, e “Gli egizi trasportano nellafisicità le luci dell'anima” significa che larappresentazione che hanno dello spiritodella loro civiltà è scolpito su ciò che dureràin eterno.
L'arte egizia è così un'arte monumentale elapidaria. L'arte greca non ha un vero eproprio Dogma artistico per Caffarelli, macome il musicista ben riassume “Il suo divinoè apoteosi del naturale fisico nell'Arte”38.
La plasticità delle forme della statuaria grecarende perfettamente l'idea di antropomor-fizzare i sentimenti e le virtù degli dei, ma ilrapporto con lo ieratico, con la dimensioneverticale a cui una possibile trascendenzaaspira è totalmente annullato. La dimensioneorizzontale (ben radicata sulla sogliadell'umano nello schema) dà adito alla ricerca,nella Natura, delle leggi nascoste che gover-nano un Universo, non più divino, ma umanotroppo umano. “Gli dei sono scesi in terra,ma non si ricordano più il cielo da dove son
Conoscenza Luglio - Settembre 2014 25
provenuti”39 (v. figura). Tutte queste formedi espressione artistica nelle civiltà considerate,vengono definite da Caffarelli come“precristiche”. “L'arte cristiana dovrà corpo-rificare la conoscenza dell'avvenire e delpresente sotto specie cosmica come vitavivente del singolo. Sarà perciò, essenzial-mente, arte della Vita integrale”40.Laddove il Dogma diventa immagine in cuil'uomo, e al contempo l'umanità intera siriconoscono e s'incarnano al fine di ripercor-rere al contrario la vicenda terrena in cui lospirito è addormentato, ciò diventa unaVisione Primordiale della Vita. L'arte cristicapermette l'accesso a tale visione attraversoil “Fatto Cristico”. Il Mistero del Golgota nonè più il lutto, ma la rinascita di una nuovacorporeità. Occorreva tuttavia un punto dipartenza e “Il Fatto del Golgatha avendo
posto Dio sul piano fisico e nella carne,esigeva il suo proprio mondo. Il vecchioequilibrio fu rotto: la vecchia natura fu vedutapiena dei demoni della dissoluzionegrecolatina”41.D i p r imo acch i to può sembrarel'interpretazione classica che viene fornitadella Crocefissione di Cristo, ma se seguiamoil Maestro Caffarelli sin nel cuore della suariflessione scopriamo che: “Il rapportod'amore stabilito nell'Avvenimento Cristicotra due Forze Cosmiche opposte è mostratocome immagine dei Tre Crocefissi. Sulla gran-de Immagine Cosmica dovranno modellarsi,per essere armonia, tutti gli aspetti del dive-nire umano.Con l'immissione dell'Energia-Cristo ogniastratto dualismo doveva diventare ordineconcreto. Ogni dualismo di corpo e anima,
Atena, statua bronzeadel IV sec. a.C. (MuseoArcheologico del Pireo, Atene)
Conoscenza Luglio - Settembre 201426
NOTE1 Cfr. Massimo Introvigne, Il ritorno dello gnosticismo, SugarCo, Milano 1993.
2 Giovanni Cattani (a cura di), Prose e poesie inedite, Fratelli Lega, Faenza 1982, pp. 15-16.
3 La corrispondenza, e la presenza di Annunziata Margherita Giuseppa Virginia Teresa Anzilotti (meglio conosciuta come Giuliana,1883-1917) nella vita del musicista faentino sarà fondamentale, non solo per la breve e intensa storia d'amore fra i due, ma ancheper la conoscenza delle più eminenti personalità del mondo dell'esoterismo e del nuove correnti spirituali. Tra questi (come vedremonella prossima puntata) ci saranno personaggi vicini agli ambienti neo-gnostici italiani del Novecento. Per una approfondimentobiografico sulla vita di Giuliana Anzilotti rimandiamo il lettore a Silvia Fanti, “Lamberto e Giuliana”, Giuseppe Fagnocchi, LambertoCaffarelli – Poeta, pensatore, musicista faentino, Moby Dick, Faenza, 2013, pp. 461-472.
4 Amedeo Casanova, “Lamberto Caffarelli, Vita, Catalogo delle opere, Scritti, Bibliografia”, in I Quaderni della Cattedrale di Faenza,I, «Organi, Organisti Cantorie», Fratelli Lega, Faenza 1964, pp. 12-13.
5 Anselmo Cassani, “Il magazzino dell'esoterismo – Una prima ricognizione del fondo Lamberto Caffarelli”, in La Biblioteca Comunaledi Faenza, la fabbrica e i fondi, Faenza 1999, p. 297.
6 Sul Alcibiade Mazzerelli (1873-1932) cfr. Michele Beraldo, “Lamberto Caffarelli e il suo rapporto con l'ambiente antroposoficoitaliano tra le due guerre”, in G. Fagnocchi, op. cit., p. 444, nota. 8.
7 Cfr., ibid., p. 423.
8 Per un primo profilo di Lodovico Landini, e dei suoi contatti con Caffarelli rimandiamo a ibid., pp. 421-454.
9 Si tratta di George Robert Stowe Mead, Frammenti di una fede dimenticata - Brevi studi sugli gnostici, principalmente dei primidue secoli, contributo allo studio delle origini cristiane, basato sui materiali piu recentemente ricuperati, trad. di M. L. Kirby e B.Fantoni, Ars Regia, Milano 1909, sulla vita e le opere del teosofo britannico cfr. “Mead, George Robert Stowe”, in Wouter Hanegraff(a cura di), Dictionary of Gnosis and Western Esotericism, Brill, Leiden 2006, pp. 785-786.
10 Su Emanuel Swedenborg (1688-1772) rimandiamo a “Swedenborg, Emanuel”, a cura di Jane Williams-Hogan in Dictionary ofGnosis and Western Esotericism, op. cit., pp. 1096-1105.
11 Emanuel Swedenborg, La sapienza angelica sulla Divina Providenza, trad. dal latino eseguita sull'edizione Tafel (Tübingen 1855)dal prof. Loreto Scocia, Fodratti, Torino 1874; segnaliamo inoltre la presenza di uno studio biografico sull'autore presente nel fondoCaffarelli e in lingua francese Jacques Matter, Emmanuel de Swedenborg - sa Vie, ses Écrits et sa Doctrine, Didier et Cie, Paris 1863.
12 Su Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) cfr. Marion Meade, Madame Blavatsky – The Woman Behind the Myth, AcademicPress Canada Limited, Toronto 1980, per il pubblico italiano sono disponibili anche Paola Giovetti, Helena Petrovna Blavatsky e laSocietà Teosofica, Edizioni Mediterranee, Roma 1991 e Sylvia Cranston, Helena Blavatsky - La straordinaria vita e il pensiero dellafondatrice del movimento teosofico moderno, Armenia, Milano 1994.
13 Sul fondatore dell'antroposofia Rudolf Steiner (1861-1925) non manchiamo di segnalare il più recente lavoro di Helmuth Zander,Rudold Steiner – Die Biographie, Piper Verlag, München 2011; cfr. Geoffrey Ahern, The Sun at Midnight – The Rudolf SteinerMovement and the Western Esoteric Tradition, The Aquarian Press, Wellingborough – Northamptonshire 1984; per il lettore italianoè disponibile anche Simone Rihouët-Coroze, Rudolf Steiner – La vita e l'opera del fondatore dell'Antroposofia, Convivio, Firenze1989.
14 Helena Petrovna Blavatsky, La Doctrine Secrète – Synthèse de la science, de la Religion et de la Philosophie, 6 Vv., PublicationsThéosophiques, Paris 1924-1931.
di materia e spirito, di cielo e terra si unificavacome ordine dell'attività umana nell'Io sono,- unità, come Volontà di evolvere, dei dueOpposti. Colui che questo Fatto Misticoesperimenta risuscita la materia, vive una
vita concreta spirituale. Il Cristianesimo im-mette nel mondo le Forze per le quali l'Artedell'Io, Arte di Spirito, Arte di redenzione ed'amore, Bellezza di amore e di pietà”42.
- continua -
RingraziamentiMarco Signorini, che l'Autore dell'articolo e la Redazione di “Conoscenza” ringrazianovivamente, ha realizzato gli schemi rappresentati nelle figure 3, 4 e 5, sviluppi grafico-teorici relativi all'appunto del M° Lamberto Caffarelli riportato nella foto 2. Si ringraziaaltresì la Biblioteca Manfrediana di Faenza per le scannerizzazioni delle foto 1 e 2 relativeagli appunti di Lamberto Caffarelli.
Conoscenza Luglio - Settembre 2014 27
15 Rudolf Steiner, L'Education de l'enfant au point de vue de la science spirituelle, Publications Theosophiques, Paris 1909.
16 Id., L'initiation ou la connaissance des mondes supérieurs, Publications Théosophiques, Paris 1912.
17 Questo era il soprannome di Steiner tra i suoi seguaci.
18 Ci sembra interessante segnalare tra le riviste specializzate dell'epoca, presenti appunto nel Fondo Caffarelli la presenza diAurora - Rivista bimestrale fiorentina di spiritismo, psicologia, frenologia e morale filosofica, Anno I, n. 1 (1870-1871) Firenze.
19 Vedi nota 7, Mazzerelli, uno dei maggior traduttori delle opere di Steiner in italiano passava dei ciclostili delle medesime aCaffarelli. Una di queste conferenze, presente presso il Fondo Caffarelli ha attirato la nostra attenzione: si tratta del riassunto diuna conferenza tenuta dallo Steiner a Berlino l'11 Novembre del 1904, il cui titolo è “I Manichei”.
20 M. Beraldo, op. cit., pp. 423-425.
21 Sull'incontro di Caffarelli con Steiner cfr. A. Casanova, A. Casanova, Caffarelli e l'Antroposofia”, in Rumagna, Anno III, n° 1(1971), pp. 77-82; cfr. M. Beraldo, op. cit., pp. 425-429.
22 Lamberto Caffarelli, L'Arte nel mondo spirituale – Tre saggi come introduzione a una conoscenza cosmico-spirituale dell'Arte,Antonio Montanari, Faenza 1925; ci sembra fondamentale informare il lettore che esistono le bozze di una versione de L'Arte nelmondo spirituale datate 1923.
23 Il termine si riferisce a una delle tante annotazioni che il Maestro scriveva su qualsiasi tipo di supporto cartaceo che gli potessecapitare a tiro, i medesimi poi sono stati poi ritrovati all'interno di diversi libri della sua collezione.
24 H. P. Blavatsky, “Anthropogenèse”, in La Doctrine Secrète – Synthèse de la science, de la Religion et de la Philosophie, La FamilleThéosophique, Paris 1935.
25 Cfr. James Santucci, La Società Teosofica, Elledici, Torino, 1999, p. 26.
26 Ibid., pp. 71-77.
27 Si tratta dei “I Tre Impulsi Frontali”, in L. Caffarelli, op. cit., pp. 71-161.
28 Con Metastoria Steiner intende la lettura della storia dell'umanità dal punto di vista spirituale, contestualizzando così gli eventistorici e politici, e le loro conseguenze sui diversi piani della “natura dell'essere” “Wesensglieder” (o quella che potremmo piùsemplicemente chiamare “fisiologia sottile”). Valutare e influire su tutto ciò, per il fondatore dell'Antroposofia, è compito dellaScienza dello Spirito.
29 L. Caffarelli, op. cit., pp. 20-22.
30 Ibid., pp. 46-47.
31 Ibid., p. 50.
32 Ibid., p. 71.
33 Nell'articolo precedente abbiamo osservato come nel fondo Caffarelli si trovino opere del vescovo della Chiesa Gnostica Italiana,Vincenzo Soro (1895-1949), in particolare La Chiesa del Paracleto - Studi su lo gnosticismo, Atanòr, Todi 1922. A pagina 191 dellasuddetta opera, nel cuore della trattazione sulla gnosi valentiniana da parte di Soro, vi è la seguente annotazione del musicistafaentino “Redenzione=Trasformazione”. Ora sempre restando nell'ambito degli scambi possibili (riteniamo di dover approfondirele ricerche prima esprimerci in maniera definitiva a proposito) tra Antroposofia e Neognosticismo, vorremmo citare il titolo di unautore antroposofo, si tratta del giurista ed economista Günther Wachsmuth (1893-1963), l'opera è Die Reinkarnation des Menschenals Phänomen der Metamorphose, herausgegeben von der Naturwissenschaftlichen Sektion am Goetheanum, Dornach 1935. Perun approfondimento biografico sul personaggio rimandiamo a Enrico Pappacena, Di alcuni cultori della Scienza dello Spirito,Andriola, Palo del Colle – Bari 1971, pp. 35-66.
34 L. Caffarelli, op. cit., p. 170. Si tratta della Geheimwissenschaft del 1910, presente nel Fondo Caffarelli nell'edizione franceseR. Steiner, La Science Occulte, Perrin et Cie, Paris 1914
35 L. Caffarelli, op. cit., p. 167.
36 Ibid., p. 175.
37 Ibid., p. 178.
38 Ibid., p. 183.
39 Ibid., p. 174.
40 Ibid., p. 181.
41 Ibid., p. 205.
42 Ibid., p. 207.