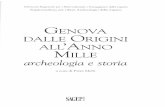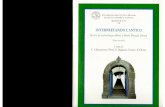La scoperta della più antica cassetta di piombo: ricostruzione storica e analisi tecniche (2013)
-
Upload
multiagent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of La scoperta della più antica cassetta di piombo: ricostruzione storica e analisi tecniche (2013)
SAN PIETRO IN CIEL D'ORO A PAVIA
MAUSOLEO SANTUAzuO DIAGOSTINO E BOEZTOMATERIALI ANTICHI E PROBLEMI ATTUALI
acura di
MARIA TERESA MAZZTLLT SAVINI
Comitato Pavia Città di Sant'Agostino2013
La scoperra della più antica casserra di piombo:ricostruzione storica e analisi tecniche
il contenuto della cassetta lignea, scoperta nell'aprile 2007 all'internodel basamento dell'aÍca di Sant'Agostino e ispezionata in data 20 ottobre2010, comprende, úa le altre cose, abbondanti frammenti metallici,riconducibili, a una osservazione macroscopica, a lastre di piombo e aelementi di medio-piccole dimensioni in rame.
Le lastre di piombo sono da riferire a una capsella, in pessimo stato diconservazione, ridotta in pezzi, e mancante di molte parti, lacunosa sualcuni margini. Il metallo è in gran parte alterato in carbonati di piombo.I frammenti conservati di maggiori dimensioni (fig. 1) sono in totale sei,a cui si aggiungon o Porzioni più piccole e numerosi frammenti minuri.
Le porzioni conservate sono pertinenti alle pareti laterali del conrenirore,che consisteva in una cassetta rettangolare (misure ricostruibili cm 48 x 18,h max conservata cm 1 1, ma probabilmente in origine un poco maggiore)tealizzata in una spessa lamina di piombo con spigoli arrorondati. Nonsono conservate la parte superiore e quella inferiore, cioè il coperchio e ilfondo. Non si può stabilire quindi se anch'esse fossero in piombo, oppurein altro materiale, legno, probabilmente (fig. 1). Lo spessore della laminaè di circa 1-3 mm.
Alcune parti della lamina sono ripiegate su loro sresse, in modo piùo meno schiacciato; in un frammento la piegatura costituisce quasi unadoppia lamina (fig. 1D). All'interno di almeno due angoli della capsellala lamina era inoltre piegata in verticale a formare un alloggio cilinJrico;questi alloggi tubolari dovevano servire per inserirvi in ciascuno un cilindrodi legno o di metallo, che poteva essere collegato al fondo della casserra e
si prolun gava forse in un peduccio che la teneva sollevata dal piano di
CosreNZA CucrNr
Metallogenesi s.a.s., Milano
Menle Pre R:ccnRDr
Università degli Studi di Pavia
Pavia, 26 febbraio 2011Terzo Convegno storico artisticoIl santuario di Agostino e Boezio
in età modernaRinnouamenti, restauri, conseruazione
594
aPpoggio. Oppure, più probabilmente, doveva servire come sosregno e
incastro di un probabile coperchio ligneo.
Non si nota alcuna traccia di saldature. Le lamine erano verosimilmenreassemblate insieme per ripiegatura; non si può escludere, anche sulla basedi confronti altomedievali, che la cassetta fosse ricavata daun'unica laminadi piombo piegata a costituire le pareti laterali verticali e rinforzata agliangoli dalla doppia piegatura sressal.
Un particolare degno di nota è che le lamine di maggiore dimensionemostrano in genere almeno un margine nefto, ben rifilato, mentre glialtri bordi risultano in gran parte rorri e smangiati (fig. 1). Causa diqueste roffure irregolari e conseguenti sbriciolamenti sembrano essere
stati alcuni chiodi in ferro che furono piantati e ribattuti nella lamina(fig. 2N. (Jn frammento reca ben visibili chiodi e fori relativi a chiodi,praticati sembrerebbe quasi al centro della parere del conrenitore (fig.2B). Altri frammenti mostrano solo quello che resra dei fori per i chiodipresso il margine irregolare, fori che sembra abbiano provocato le rorruree la frammentazione della lamina stessa. I margini rifìlati sono inveceperfettamente rettilinei e regolari, anche il loro sraro di conservazione è
buono.
In via d'ipotesi, si potrebbe pensare ad un fondo, realizzaro in legno onello stesso tipo di metallo, fissato alla cassema di piombo con chiodi diferro. Il fondo fu forse strappato via rudemente, causando danni ai marginidella cassetta. Oppure, la parte in piombo costituiva una robusta fascia dirinforzo interna di un cofaneffo di legno porratile, a cui era inchiodata. Maa quest'ultima interpr etazione osta la pres enza di tracce di una decora zioneincisa sulla parete della lamina (fìg. 3); tale decorazione, poco leggibile a
causa del pessimo stato di conservazione della cassetta, sembra costituitada due linee dritte parallele incise a bulino; I'incisione risulta piuttostoprofonda e marcata. Si può pensare quindi che la parre in piombocostituisse la fodera esrerna di una casserra di legno.
La presenza di fori di alloggio per chiodi sulle pareti della casserra dipiombo potrebbe essere collegata all'applicazione di decorazioni dimateriali non determinabili ("d esempio croci) o forse di maniglie per untrasporto più agevole, ma niente di tutto ciò è conservaro. Assieme ai restidella cassetta di piombo sono state rinvenure alcune laminette in rame (fig.4), che potrebbero essere riferite alla decorazione del coperchio ligneo.
l. E' il caso, ad esempio, della piccolacassetta di piombo conrenente ilreliquiario di sant'Apollinare dal Dossdi Thento, si veda più avanri, testocorrispondente alla nota 43.
595
c. cucrNr, M. P. Rrccannr - Le scopERTA DELLA prù eNrrcl cAssETTA Dr proMBo
La traslazione delle reliquie e la scoperra della casserta dipiombo
La cassetta di piombo in esame non ha finora destato molto interessenella storiogrufrasulle reliquie di Sant'Agostino: l'aftenzione degli studiosisi è rivolta semmai alla pregevole cassa d'argenro cosiddefta di Liutprando2.
Ricorderemo che la cassetta di piombo in cui erano riposte le ossa diSant'Agostino fu rinvenuta da alcuni muratori nel corso di lavori eseguitinella confessio, cioè nella cripta della chiesa pavese di San Pietro in Cield'Oro, il primo ottobre 1695; essa era (tutta fradicia dal tempon e posraall'interno di una cassett a d'argenro quella 'di Liutprando' contenuraa sua volta all'interno di un sarcofago di marmo bianco3. All'epoca, ilrinvenimento destò stupore oltre che grande emozione, poiché per secoli sierano perse le tracce delle reliquie del vescovo di Ippona.
Per cercare di stabilire quando la casserra di piombo venn e realizzata, è
necessario ripercorrere, almeno nelle linee essenziali, le complesse vicendeche interessarono le spoglie mortali di Sant'Agostino. Nel massimorispetto per le fonti e le tradizioni, nonché degli illustri studiosi che si sonofinora occupati della questione della doppia traslazione delle reliquie delSanto dottor e4, ceÍcheremo di seguire le tracce del conrenitore di piomboprovando a collocare i (pochi) dati in nostro possesso in un ordine logico.
I resti mortali di Sant'Agostino furono oggerro di due taslazioni causare
da grandi invasioni altomedievali: la prima volta da Ippona in Nord Africaalla Sardegna e in seguito dalla Sardeg na a Pavia. Non c'è alcun dubbiosulla storicità delle due taslazioni, mentre è molto difficile stabilirne ledate e le circost anze5 .
Sant'Agostino morì ad Ippona il 28 agosro 430, menrre la città eraassediata e in parte incendiata dai Vandali6. Sulla prima traslazione dellesante reliquie dall'Africaalla Sardegna le fonti medievali sono molto vaghe,mentre abbiamo maggiori dettagli su quella 'italiana', dalla Sardegna a
Pavia.
Il 'nucleo primitivo' fondamentalez per entrambe le taslazioni sono duebrevi passi di Beda, scritti tra il 725 e il 731, che costituiscono la basedella storia del duplice spostamentos. La prima traslazione da Ippona allaSardegna awenne 'a causa dei barbari'. Per quanto concerne la seconda,i Saraceni d.evastavano la Sardegna e profanavano la zona dov'erano le
2. A. Peroni, 1984, p. 238, frg. 144 e A.Peroni, 1967, pp.37-44 e 147-150; G.Panazza,1950, pp. 284-285. Entrambi glistudiosi datano le crocette applicate sui latidel reliquiario all'MII secolo.
3. X. Toscani, 2007, pp. 35, 59.
4. La bibliografia sull'argomenro è ampia,sebbene gli studi moderni siano relativamenrepochi e non esista un trattato comprensivoche riesamini entrambe le traslazioni; ilmaggior studio sull'argomenro è ancoraoggi quello di A.C. De Romanis 1931.Un ampio riesame delle fonti e degli studisull'argomento, centrato però sulla traslazionedalla Sardegna a Pavia, è in J.T.L. Hallenbeck,2000.
5. Sono le osserv azionidi A. L. Muratori,riprese un po' da tutti gli studiosi che si sonooccupati della questione, ad esempio A.C. DeRomanis, 1931 e L. Cherchi, s.d.
6. Come racconra Possidio, il suo primobiografo, edizione critica di A. Trapè,Blbllotheca Sanctorum vol. 1, col. 433, 1955.Secondo Possidio, le spoglie mortali del Santovennero deposte nella cattedrale detta BasilicaPacis e gelosamenre custodite dai cristiani diIppona. Sulla conquista vandala del NordAfrica, l'organizzazione di Genserico dellaprovincia Proconsolare, dove si trovavaIppona, e sullo sviluppo della Chiesa ariana a
spese di quella cattolica si veda Y. Modéran,2008 e T, Ghalia, 2008.
7. Il onucleo storico primitivoo, secondola definizione di A.C. De Romanis, 1931,ripresa da J.T.L. Hallenbeck, 2000, pp. 9-10.Le fonti relative alle traslazioni del corpodi Sant'Agostino sono ripercorse, fra glialtri, da M. Ansani, 2011, pp. 168-173, che
aggiunge anche l'analisi della documentazionemonastica pavese.
B. Beda il Venerabile, Chronica de sex ltuiusSaeculi Aetati bu.r <Liudbrandus audiensquod Sarraceni depopulata Sardinia etiamloca fedarent illa, ubi ossa sancti Augustiniepiscopi propter vastationem barbarorum olimtranslata et honorifice fuerant condita, misitet dato magno praetio accepit et transtulit
596
V-AI'JALXSTESCOPHRTE
reliquie; saputo ciò, il re longobardo Liutprando intervenne tramitesuoi agenti per ottenere le reliquie ad alto prezzo: esse furono trasferitedalla Sardegna a Pàvia, dove ricevettero una r.poltura onorevole ad operadello stesso re. I passi di Beda implicano che gli agenri reali compraronole reliquie, successivamente Liutprando le prese sorro Ia sua personalecustodia a Genova, e poi le portò a Pavia. Quindi la seconda traslazione,organizzata e condoffa da Liutprando che da un cerro momenro in poi vipartecipò personalmente, fu senza dubbio lunga e complicata.
Beda tuftavia non specifica molti aspetti delle due traslazioni - adesempiol'epoca in cui si svolse la traslazione 'africaní, quali fossero i 'barbari'che fecero precipitare gli eventi in Nord Africa, o in quale zona dellaSardegna le reliquie furono traslate e da chi gli agenti del re Liutprandole compraronoe. Egli non indica nemmeno owiamenre le modalitàpratiche del trasporto delle reliquiel0: sarebbe prerendere rroppo, rurraviapossiamo per il momento osservare che egli parladelle ossa sancti Augustini.In ogni caso, Beda è un contemporaneo degli awenimenti narrati ed è
attendibile. l
Sull'epoca della traslazione african a, La storiog rafra è divis a: da una parreun certo numero di studiosill la collega alla persecuzione del re dei VandaliThasamondo (496-523)"; alcuni storici esprimono dubbi, menrre altririfiutano questa daazionel3 e collegano lo sposramenro delle reliquie diSant'Agostino alla conquista musulmana dell'Africa bizantina nel tardoMI - iniziVIII sec. d.C. Questa seconda interpretazione, secondo la qualele devastazioni dei barbari di cui parla Beda devono essere imputate agliArabila, sembra in effetti la più convincenre. Ippona cadde in mano arabanel tardo VII secolo, sembra verosimile ritenere che le reliquie siano sraretrasferite nello stesso periodo. Se questa interpretazione è corretta, neconsegue che le spoglie mortali di Sant'Agostino rimasero per pochi anniin Sardegna.
Nei quattro secoli successivi agli scritti di Beda, e fino al XII secolo,i cronisti e i martirologi che si occuparono della questione riprodusseropiù o meno fedelmente i suoi testi, talvolta con qualche dettaglio in più.Ad esempio Paolo Diacono, il grande storico longobardo, ripete quasiparola per parola quanto scritto da Bedal5. Di essi, solo Adone di Vienneci dice che le reliquie - ossa beatiAugustini - ebbero una nuova deposizioneneI monasterium di Cella AureA, evidente riferimento a San Pietro in Ciel
ea in îcinis inique cum debito ranro patrihonore recondidir>, in MGH, AuctorumAntiquissimorum, vol. 13, d. Th. Mommsen,Berlino, 1898, p.321. Laltro passo di Beda
è nel suo Martyrologium: uln Africa sanctiAugustini episcopi, qui primo de sua civitatepropter barbaros Sardiniam translatus, nupera Liuthbrando rege Langobardorum Ticinisrelatus, et honorifice conditus est>, in ActaSanctorum, vol. 40, ed. J. Pinio, G. Cuper e J.Stiltingo, Parigi e Roma 1868, p.365.
9. Come rilevaJ.Tl. Hallenbeck, 2000, p. 10.
10. Si veda I'osservazione riportata da M.Ansani, 201I, p. 168: la storia del salvataggio
e della traslazione delle spoglie di S. Agostino<è certamente la storia di un trasporto, ma è,
anche e sopratturro, una storia di distorsionitestuali, di superfetazioni, di aggiunte, dimanip ol azio ni ideologiche, .
1 1. Sulla storiografia a favore e conrro unadatazione alla fine del V - iniziM sec. d.
C. della prima traslazione si veda J.TL.Hallenbeck, 2000, pp. 156-158, conbibliografia.
12. Aproposito della traslazione africana,ricorderemo che secondo una tradizione tardaThasamondo avrebbe esiliato in Sardegna,
e a Cagliari in particolare, molti vescovi,
monaci e cristiani del Nord Africa; ungruppo di esiliati aveva a capo san Fulgenzioda Ruspe, che avrebbe porraro con sé anche
le spoglie di sant'Agostino. Fulgenzio da
Ruspe fu consacraro vescovo nel 507,I'esiliodovrebbe quindi essere successivo d,507-508,Bibl. Sanct. Vol. V col. 1306.I vescovi delgruppo di Fulgenzio erano sesisanta o pir), e
portarono probabilmente con loro reliquie,libri e immagini sacre. La fonte principalesull'argomenro èla Vita Fulgentii del diaconocartaginese Ferrando, discepolo e forse
parenre di Fulgenzio sresso, PL. LXV, cl. ll7-150, ed. critica di G. G. LaPeyre. Ferrando,fonte diretta che racconta la storia dell'esilio,non fa però alcun cenno alla traslazionedelle reliquie di S. Agostino: anzi, ci riportadue circostanze che la rendono altamenteimprobabile. Per tumo ciò, L. Cherchi, s.d.
597
II
I
c. cucrNr, M. P. Riccannr - Le scopERTA DELLA prù lNlrca cAssETTA Dr proMBo
d'Oro 'a Pavia. Ma nessuno accenna al contenitore con cui le reliquievennero trasportate.
A questo primo' scarno nucleo di fonti, si aggiunsero molte nuoveinformazioni dal XII al XIV secolo, ad opera di .irqr. autori medievalir6che ampliarono notevolmente il ,"..orrìo delle d". traslazioni. Ma innessuno di questi resoconti, arricchiti da varie 'ricamature' e defor mazioni,troviamo riferimento alla cassetta di piombo in esame; tre di quesri autori- Filippo di Harvengt, Vincen zo diBeauvais e Iacopo da Var"gin. - parlanodi reliquias, due di essi - l'Anonimo del XII secolo e Vin cenzo di Beauvais
di ossa, ma nessuno dice come materialmente awenne il trasporto.Risulta impossibile stabilire anche dove le reliquie fossero conservare inSardegna, o chi le possedesse e le vendé agli agenti di Liutprando, veroe proprio 'impresario' del complesso trasferimento assieme alle autoritàecclesiastiche a lui vicinel7. Com'è stato sottolineato, però, le amp lificazionie deform azioni del racconto riguardano quasi .r.lulivamente la secondatraslazione, dalla Sardegna a Pavia, menrre per la prima la traslazlone'afticana' - le scarne notizie delle cronache aniiche ,ràr risultano alterarers.
Dato che la perma nenza in Sardegna sembrerebbe essere srara moltobrevele, in via d'ipotesi si potrebb. plnsare che le ossa di Sant'Agostinofossero arrivate dall'A frica in quesro contenitore di piombo e ch. ì, essosiano rimaste anche per la seconda traslazione2O. Il Nord Afric à, e la zonadell'Ouarsénis - fra Tunisia e Algeria - in particolare, è ricca di giacimentiminerari a solfuri soprattutto di zinco e di piomb o 2r. Una ,rilit azione'afúcani è dunque verosimile, almeno dal punro di vista pratico: nonmancava né la materia prima, né le maestr anze in grado di lavorarla.Ricorderemo i piatti d'argento prodotti nelle fabbriche di Cartagine nelperiodo vandalo, mentre per l'argenteria di epoca bizantina si veda adesempio la cosiddefta 'Capsella Africana' del Museo Sacro della BibliotecaApostolica Vaticana, un reliquiario in argenro della fine del V - inizi VIsecolo d.C. rinvenuto a Ain Zirara in Numidia e anch'esso prorerto da uncontenitore in piombo di quesro tipo22.
Un'ipotesi alternativa vede invece I'intervenro dei legati di Liutprando,che gestirono l'acquisto delle sante reliquie in Sardeg"" . ne org anizzaronoil complesso trasporto a Pavia. Essi poti.bbero aver commissionato in locola cassetta: un contenitore fatto con una robusta lastra di piombo, rea lizzatoespressamente per proteggere in modo adeguato le sante reliquie nel lungo
13. Come ha rilevato A. C. De Romanis,nessun documento del periodo vandalo néalcuno degli autori più antichi parla dellatraslazione in Sardegna in quel periodo; laprima volta che la traslazione africana vienecollegata ai Vandali è solo nel XIV secolo adopera di Giordano di euiedlinburg.
14. Lo studio approfondito delle fonti e
dei documenti relativi si deve a A.C. DeRomanis, 1931; egli suggerisce anche chenel periodo dei Vandali Agostino non eraancora venerato come santo, quindi nonc'erano preoccup azioni sulla profanazionedel suo corpo, J. T L. Hallenbeck, 2000,p. l5T.Sappiamo che gli Islamici, sotto ilcomando di Utman (G44-G56) e sotto ilquinto Califfo degli Umajj di, Abdalmalik(68 5 -7 0 5), devastarono l'Africa settentrio nalecancellandone ogni segno di vita cristiana:quanti porerono, dal Nord Africa andaronoin esilio, L. Cherchi, s.d.
15. Paolo Diacono, VI, 48, p.348:<Liutprand quoque audiens, quod Sarraceni,depopulata Sardinia, etiam loca illa, ubi ossa
s ancti Augustini ep is cop i p rop ter uastatio nembarbarorum olim translata et honorifce
fuerant condita, foedarent, misit, et datomagno pretio, accepit et transtulit ea in urbemTicinensem inique cum debito tanto patriltonore recondiditr. Sulle altre fonti - Adone diVienne, Mariano Scoto, l'Anonimo di Noyone Sigeberto di Gemblou, Rabano Mauro diFulda e Usuardo - che ripetono più o menofedelmente i testi di Beda, si veda A.C. DeRomanis, 1931 e J.TL. Hallenbeck,2000, pp.12-13. Qrrri tutti questi scrittori parlano di" ossa" .
16. Si rrarra della Historia ThanslationisCorporis Sancti Augustini redattada unAnonimo del XII secolo (la definizione è diJ.TL. Hallenbeck, 2000,pp. lg-20), dellaWta beati Augustini Hipponiensis episcopiscritta da Filippo di Harvengr attorno al1130, dello Speculum Maioris scritto daVincenzo di Beauvais nel 1253, inoltre ilcapitolo De Sancto Augustino della LegendaAurea di Jacopo daYaragine compostaatrorno aI 1260, e del Liber de laudibusciuitatis Ticiruensis scritto dall'Anonimo
598
papa Benedeffo VIII, in concomita nzaconproprio in San Pietro in Ciel d'Oro, allavescovi2s. Ciò non è improbabile, tuftavia
il concilio che si svols e a Pavia,presenza dell'imperarore e deici sembra 'inutile': le spoglie
V - AI{ALTSI E, SCOPE,RTE
;viaggio. E ben nota la ricchezzadelle miniere di piombo argentifero dellaSardegna e delle zone del Sulcis-Iglesienre e d.f Sarrabus i" particolare,non lontane da Caglia Íi23. Reperire la materia prima e gli
^rtigr^ni esperti
nella sua lavotazione certo non doveva essere tm problema.E' probabile che, una volta giunti a Pavia, i resti mortali del vescovo
d'Ippona venissero lasciati all'interno della casserra di piombo che li avevafino ad allora contenuti, anch'essa 'sacra' per il cont"rro .on le sacre reliquiedi Agosrino24.
In entrambe le ipotesi sopra formulate, la reali zzazione della casserra dipiombo in esame si situa fralafine del VII e i primissimi decenni dell'VIIIsecolo. Inoltre, s€ tale contenitore fu realizzxo per il rrasporto originaledelle reliquie, ne consegue che esse dovevano consistere effettivamenrein ossa' come le fonti più antiche affermano, date le piccole dimensionidella capsella plumbea. La sua manca ta citazione nelle fonti più antiche - epiù attendibili non esclude però la sua esisrenza: manca à.1 resro ognidettaglio pratico dei due trasferimenti. E negli scarni resoconti delle duettaslazioni il nostro contenitore di piombo .osiituiva un particolare del tuffotrascurabile. Esso comungue, estremamente modesto .à-. realizzazione eprivo di ornamenti e pretese artistiche, si presta bene ad essere interpretatocome una cassetta metallica per il trasporro delle reliquie25.
Per quanto concerne Pavia e la basilica di San Pietro in Ciel d,Oro,non sappiamo molto dell'edificio dell'WII secolo, a causa della completaricostruzione in forme romaniche awenu ta trala fine dell'Xl e gli inizi delXII secolo26. Nell'alto Medioevo ci doveva comunque essere uno spazioorganizzato per accogliere le reliquie del Santo dottor. . ,.nderle accessibilialla devozione di fedeli e pellegrini: si può pensare proprio alla cripta oconfessio, poiché nella chiesa era stato precedenrem."r. sepolto Boezio,martirizzato nel 52527. Inoltre, I'urna fu riaperta in diverse occasioni tral'B7B e il 1022: questo dovette riguardare
"r.h. la casserra di piombo inesame - se l'ipotesi della sua fabbric azione altomedievale è .orr.ìt".
Tuttavia, sempre in via ipotetica, una possibilità alternativa è che lacassetta sia stata tealizzata in occasione dell'imporranre ricogn izione delle^^l: --,: - l: r. ,
^ 's{ffienre per orúíe Él
Ticinese (Opicino de Canistris) nel 1330.Per tutto ciò e per i riferimenti bibliografici sirimanda a J .7.L. Hallenbeck, 2000, pp. l9-25 e, per i testi delle fonti, alla sua Appendixin fondo al volume, pp. 207-214.
17. J.T.L. Hallenbeck, 2000, pp. t5g-t72,con ampia bibliografra.
18. A.C. De Romanis, 1931.
19. Secondo L. Cherchi, s.d., sulla scorta diA.C. De Romanis, l93l e in base a quanroaffermato dall Anonimo del XII secolo, daFilippo di Harvengr e da Iacopo da Varagine,la traslazione dall'Africa sarebbe
"*.r,rti ,r.l710, menrre il trasferimenro delle reliquiedalla Sardegna a Pavia si sarebb. ,'ooltonel 7 20-721, conrrariamenre alla comuneopinione della storiografia che assegna laseconda traslazion e al725.Il periodo ,sardo'
sarebbe comunque di dieci-quindici anni almassimo.
20.I resti mortali di Santîgostino eranorimasti sepold a lppona. Se si fa risalirela secondatraslazione al 710, i quasi tresecoli di perma nenza in Nord Africa'giustificherebbero' il fatto che le reliquiedel dottore della Chiesa poressero esserecontenute all'interno della piccola cassettadi piombo in esame. Si può inoltre osservareche Beda, contemporaneo dell'awenimento,parla di'ossa' verosimilmente non a caso: cidoveva essere stata almeno una o meglio duericognizioni delle sacre reliquie durante le duetraslazioni.
21. E. Caustier, 1902, pp. 37g-3g0, sivedano le fotografie delle miniere nellefrgg.287,282. Le miniere di zinco e dipiombo dell'Ouarsénis (Algeria) e quelle digalgna di Djebba (Tirnisia) furono sfruttatenell'ottocenro e primi Novecento dalla societàbelga Vieille-Monragne, si veda il volumedel Centenaire lg37-1937, p.4g con fotodelle miniere del villagg;io di Bou Caîd,; la
rrlcfr€zza dfgiacímenri, ché si rirenevanoimmensi, fece nascere una sorta di febbre, p.,Io sfrumam ento dello zinco, simile a quellaper l'oro nel Klondyke, D.Briant a, 2007 , pp.299-300. Sull'esponazione di piombo dallaTirnisia nei primissimi anni del Novecenro,
599
F
WC cucrNr, M. P. Rrccenor - Le scopERTA DELLA prù eNtrce cAssETTA Dr proMBo
del santo erano comunque contenute nel prezioso reliquiario d'argento diI iutprando, a che scopo rcalizzare una casserra rustica di piomU"i Dopola ricogn izione del 1022 le reliquie furono ricollocare ,r.ll" confessio diSan Pietro in Ciel d'Oro, dopo di che si perse il ricordo della loro precisaubicazione2e. Nella docum entazione pubbli." del monasrero pavese non visono cenni alle prcziose reliquie agostiniane fino a tutro I'XI
^secolo3o.
Non abbiamo alcuna notizia della nosrra casserra di piombo fino allariscoperta del 1695. Come si è detto, il primo ottobre di q.r.ll'"nno i muratoriche lavoravano nello scurolo della basilica di San Pietro in Ciel d'Oro permettere in opera un'ancona di marffio, rinvennero nascosta nel muro una'cassa di marmo bianco' che ((era ben chiusa, e sigillata nelli quarro cantonicon piombo e chiavicelle di ferro))3l. Qesta cassa era .. b.i sigillata conquatro spine impiombate >>, cioè aveva un coperchio di marmo Je[e sressedimensioni chiuso .. da chiavelle incasrrare .or piombo in 4 partr >>. Daroche non era possibile aprirla senza rompere i quaftro angoli, ,i pro.edettegiocoforza così; una volta alzato il coperchio Ji -"rmo, si poté prenderele misure della cassa con precisione: ..di longhezzabr.3.Z,ii Urjn ezza dibr. 1. 1 e di altezza br. 1.7 >>; essa conteneva una cassetta che sembrava diIatta, invece era d'argento (di longhezza dtbr. L.Z, d'altezza oncre 5 l/Z edi largh ezza oncie 8 >>: il reliquiario cosiddefto di Liutprando. Dopo avernealzarc il coperchio, si videro .. delle ossa in qualche qu"ntità riposri in unacassetta di piombo tutta fradicia dal rempo, che r.l muoversi andava inPezzL>>. Di quest'ultima cassetta non vennero date le misure, verosimilmentePer il pessimo stato di conservazione. E' dunque quesra la prim a menzionenelle fonti della capsella in esame.
Purtroppo il sarcofago di marmo bianco andò distrutto durante lariapertura e non possiamo dire molto delle sue carameristiche; ci limiteremoad osservare che, per le sue dimensioni, d.oveva essere originariamentedestinato alla sepoltura di un adulto; certamenre non sono
"d.Jro pertinenti
i due coperchi di sarcofagi oggi conservati nella cripta di San pietro inCiel d'Oro e denominati pseudo sarcof"go di Sant'Agì, tino'32. Della cassamarmorea rinvenuta - e fatt a a pezzi - nel 1695 restano rurtavia due disegni,uno dei quali, realizzato a penna alla fine del XWI secolo, è corredatodalle misure in braccia pavesi33. Oltre a quelle del sarcofago, tale disegno ciriporta anche le dimensioni del cosiddefto reliquiario di Liutprando. Se siassume per il braccio pavese, pari a sedici once, I'equiv alenzaJi .- G2,927si ottengono le seguenti misure:
VVillavecchia, 1913, s.v. piombo.
22.8. Zanini et alii, 2005,VH. Elbern, 1991,pp. 1 3-14 con bibliografia. Chi scrive nonha però poturo avere visione della cassetta dipiombo di questo reliquiario.
23. Sulle miniere della Sardegna labibliografia è sterminata e non è questa lasede per ripercorrerla tutta. Ricorderemo solol'importante studio di M. Thngheroni, l9g5su lglesias.
24. E' interessante a questo proposito osseryareche la devozione popolare del XWII secoloriportava proprio questa credenza: secondoC. Capitani D'Arzago, quando la voce delritrovamenro delle reliquie di S. Agostinonel 1695 si diffuse aPavia, si parlava delrinvenimenro di una cassa di marmo bianco,contenente un'altra cassa d'argento (condentro le ossa d'un corpo... et alcu ni pezzi dipiombo qual dicono sij I'altra Cassa dentrocui fu porraro il Corpo di Santîgostinoda Sardegna in Pavia dal Re Liurprandolongobardo>, in C. Repos si, 2007, pp. 69-74.
25. Maria Teresa Mazzilli Savini ha ipotizzatoper prima che le reliquie di Sant'Agostinovenissero conrenure nella primigenia chiesadi S. Pietro in Ciel d'Oro, al loro arrivo aPavia, nella cassetta metallica con cui furonotrasporrare, M. T. Mazzilli Savini , 2007, pp.76-77.
26.Ilmonumento è sraro oggetto dinumerosi studi, in particolare quello piùesausrivo è di M.T Mazzilli Savini, 2007.
27. M.T. Mazzilli Savini , 2007, p.TG.
28. R.Maiocchi - N.Casacca 1905, vol. I,p. )Ofl: nTolte esse dal luogo, ove eranostate riposte da Liutprando, furono esposrealla viva pietà del Papa, dell'imperarore, deiVescovi e dell'immenso popolo accorso allostraordinario eventor. Laperrura portò ad unapiccola diaspora di reliquie.
29. R.Maiocchi - N.Casacca, 1905, p. )XII.
30. M. Ansani, 2011, p. 173: laprimamenzione si ha in un privilegio di pasquale
II del 1702; le spoglie del santo vennero
600
V-AhTALISI E SCOPH.RTE
- sarcofago di marmo bianco: cm 196,6 x 66,9 h 90,4
- reliquiario d'argento: cm 70,8 x 3 1,4 h 21,62 34
Come è srato sottolineato, il úutilizzo di un sarcofago romano come
reca per reliquie costituiva quasi la prassi3s; anche I'utilizzo di cassette dipiombo per contenere le reliquie risulta attestato in altri casi36.
Questo 'sistema di scatole cinesi' (fig. 5), secondo la felice definizione
di Maria Teresa MazziLLi Savini37, non costituiva un unicum, ma doveva
essere piuttosto frequente. Lo ritroviamo documentato infatti nel sepolcro
di Santa Giustina a Padova. Qui, nella cripta della basilica della santa,
fu scoperta nel ll77 un'narca di pietra dura, contenente al suo interno
una cassetta di piombo con le ossa della martire3s.larca consisteva in un
sarcofago romano ricavato da un blocco lapideo, di ridotte dimensioni
poiché originariamente destinato a una sepoltura infantile3e. Purtroppo
non ci sono dati precisi sulla cassetta di piombo, perché dal 1627 è
custodita nell'altare maggiore della basilica, che non è più stato aperto;
tuttavia abbiamo uno schizzo rinascimentale: la capsella plumbea aveva
il coperchio a doppio spiovente ed era lunga circa tre piedi o un braccio
e mezzo. Sulla datazione di questo contenitore non c'è accordo fra glistudiosi: alcuni ritengono che i resti della santa siano stati composti subito
dopo la sua morte nella cassa di piombo, a sua volta rinchiusa nel sarcofago
romano40, men te Zampieri ipotizza che ciò sia avvenuto dopo la riscoperta
del 1 1774r: in tal caso, la cassetta sarebbe stata realizzata nel XII secolo.
Sempre nella necropoli del complesso abbaziale di Santa Giustina
a Padova, ricorderemo che furono rinvenute altre sepolture in casse
di piombo, ad esempio quelle del presunto Tito Livio e del 'San Luca
Evangelistda2.
Il confronto più stringente per la nostra cassetta, e tanto più interessante
poiché in buono stato di conservazione, è costituito comunque dalla
capsella in piombo che conteneva il reliquiario d'argento di Sant'Apollinare
a Thentoa3 (fig. 6). Latten zione degli studiosi si è finora focalizzata sul
prezioso reliquiario datato al VII-VIII secolo che è di piccole dimensioni e
posro all'interno della cassetta plumbea. Quest'ultima è stata interpretatada Elbern come un recipiente che doveva (proteggere il sacro contenuto
contro le intemperie e contro la muratura (dell'altare)), secondo un'usanza
attestata anche nel caso della suddetta 'Capsella Africand del Vaticano44.
Secondo il gesuita Braun , eraprassi consolidata che i reliquiari sepolti negli
visitate da Gotefredo di Blanquefort nel
1099, e vi accenna anche un documento del
I 1 15 relativo a lohannes Christianus, ebreo
convertito che era stato monaco a San Pietro
in Ciel d'Oro, lbldem pp. 152-155, conriferimenti archivistici e bibliografia.
31 . X. Toscani, 2007 , pp. 39-59.
32. M.T. Mazzilli Savini, 2007 , p. 80. Si
rratta di due coperchi di sarcofagi a falde
oblique, realizzati in due tipi diversi di calcare
bianco delle Alpi, ritrovati dai Lateranensi
dopo il 1509 nel transetto Nord. Al lorointerno furono rinvenuti i resti di S. Appianoe dei santi giunti dalla Sardegna assieme alle
reliquie di Sant'Agostino. Nel Cinquecentoi due coperchi erano stati reimpiegati inverticale come spalle nel passaggio fra la
chiesa e la sacrestia.
33. L. Erba, 2007 , pp. 95 , ll2 e fig. 5. Le
misure indicate sono le seguenti: altezza braza
1 onze T,Iarghezza braza I onze 2,lunghezzabraza 3 onze 2.
34. Le misure del reliquiario d'argento sono
cm 70 x 32, altezza 20, G. Panazza, 1950, pp.
284-285.
35. M.T. Mazzilli Savini, 2007 , p. 77 .Si veda
anche, nel caso del sepolcro di Santa Giustinaa Padova, G.Zampieri, 2006, pp. 24-27. Solo
a titolo di esempio e senza alcuna pretesa dicompletezza, si pensi al caso dei reliquiari diSan Vitale e di San Marziale dall'abbazia diLeno (Brescia), contenuti all'interno di unsarcofago di marmo bianco, M.Ibsen, 2006,fig.p. 309.
36. Ad esempio a Trento, per il reliquiario '
di sant'Apollinare, si veda più avanti, testo
corrispondente alla nota 43. Di epoca
decisamente diversa, e con caratteristiche
molto differenti, è invece la cassa
parallelepipeda in piombo contenente le
spoglie di sant'Eusebio, conservata nel
Museo del Duomo di Vercelli, E. Destefanis,
2005. Essa fu realizzata nel 1581 quando
vennero riscoperti i resti del santo. Analoga
a quest'ultima è la cassa in lamine di piombosaldate dove sono conseryate le spoglie
di san Flaviano nell'omonima basilica di
60t
t. ilutrwr, &t{" rj" RxcilAmnx - La sil#I}HR.TA ruE,LLA pxù ANT[cA É*osET'T.A.t1.,tl
altari paleocristiani fossero riparati in contenitori esterni di vari fo"tèriali -
-o*'., ll.' lo^-^ nlo+-n45 I ^ l^^: ^ C-^ l^ -- ll J r. -r'metallo, legno, piet ra45. Le analogie fra la nostra casserra e quellJ ai Thento
sono strettissime sia dal punto di vista formale che delle cararreristiche ditealizzazione, tuttavia quella di Sant'Apollinare misura solo cm 7 ,5 x 5,5alla base, altezza cm 4.
Viene owiamente da escludere la realizzazione in un medesimocentro produffivo, poiché anche la zona di Thento è ricca di miniere digalena argent ifen, sfruttate sin dall'antichità46; e ci sembra altamenreimprobabile che Liutprando - se fu lui a far rcalizzare il conrenitore - abbiacommissionato la cassetta a flento. Se l'epoca di fabbric azione è il VII-\/III secolo, possiamo osservare tuttavia che doveva tÍattarsi di un tipo dicontenitore da trasporto e cons ervazione di oggetti importanti e preziosiche forse era abb astanza diffuso nell'alto Medioevo.
La strategia di indagine
Per lo studio degli elementi metallici sono srari effettuati duemicroprelievi: uno relativo alle lastre di piombo, ed il secondo sulla laminadi rame. I microprelievi sono stati inglobati in resina epossid ica,lucidaticon abrasivi via via più fini fino a 0.25 micron. Le sezioni trasversali deiframmenti sono state prima studiate in microscopia orrica, poi metall izzatia C (grafite) p.t le indagini al microscopio elettronico a scansione (SEM) e
per la campagna di microanalisi (EDS).
Lo strumento utilizzato è un microscopio elettronico a scansione conemettitore Schotry Field Emission, a pressione variabile TESCAN MiraXMU equipaggiato con il sistema EDAXTRIDENT XM 4 -LEXS, cosrituitoda EDS, \fDS e EBSD integrati.
I dati materici
In sezione trasversale, le lastre di piombo (fig. 7) presenrano una tessiturastratifi cata. Se il nucleo centrale conserva ancora intatto il materialeoriginario, gli strati concentrici dapprima rossastro e poi biancasrro, insuccessione verso l'esterno, sono la testim onianza del pesante degradosubito dal manufatto. Dall'immagine in microscopia ottica
- (fig.
7 A) è possibile stimare che il nucleo conservato è ridotto a circa t tE
m pn$À,{ffi0
Montefiascone, su cui è incisa la data1685; anche in questo caso la cassa
venne realizzata dopo il ritrovamenrodelle reliquie del santo; ringraziamoGabriele Bartolozzi Casti per la gentilesegnalazione.
37. M.T. Mazzilli Savini, 2007, p.77.Desideriamo ringraziare sentitamenregli architetti Giuseppe Mazzeo e JacopoPerego (Milano) che hann o rcalizzato laricostruzione grafica dei tre sarcofagi-reliquiari.
38. Per rurro quello che segue si vedaI'ampio studio di G. Zampieri, 2006.Santa Giusrina fu martirizzata nel304.
39.I1sarcofago era a cassa monoliticaa pianta rettangolare con coperchio inpietra inserito a incastro, di un tipoin uso per rufia I'età imperiale. Dopol'inuentio del 1 177 , il sarcofago con lacapsa quaedam plumbea contenente ilcorpo della santa venne nuovamentericollocato nella cripta, dove furiscoperto nel 1502.
40. M.Tonzig, 1932, p. 41.
41. G. Zampieri,2006, pp. 59-71, conbibliografia.
42. G. Zampieri,2003.
43. La chiesa altomedievale diSant'Apollinare sorgeva nell' anticoinsediamenro del colle di Doss di Thento,che domina la città. Il famoso reliquiariod'argento fu rinvenuto nel corso degliscavi eseguiti negli anni Venti del secoloscorso in corrispondenza dell'anticoaltare maggiore della chiesa, VH. Elbern,1991, p. 14.Il reliquiario d'argento haattirato I'attenzione di molti studiosi.Invece la capsella di piombo non è maistata oggerro di studi specifici, ma vienesolo citatain relazione al reliquiarioargenteo stesso; anche in occasione di unrecente restauro conservativo effettuatodalla Soprintendenza, non ne sono srare
effettuate analisi. Desideriamo ringraziaresentitamenre il dottor Silvano Zamboni,conservatore del Settore Archeologia del
602
V. ANALISI E SCOPERTE
dell'intera lamina. La patina di degrado che ricopre la lamina mostra una
stratific azione regolare e continua. La porzione biancastra più esterna è
cosriruita da cerussire (PbCO3), idrocerussite (Pb3(COr)z(OH)2), più raricloruri e solfati (anglesite, fig. 7B), mentre lo strato rosso è costituito da
ossidi misti di piombo(Il) e piombo(IV) (2PbO.PbO2).
La porzione conservata (fig. 7C) mostra una lega metallica costituitaprevalentemente da piombo, ma con frequenti inclusi (fig. 7D . fig. B). La
composizione chimica media della lamina metallica è riportata in Thbella
1; il rapporto tra i componenti principali della lamina, Pb/Sn, vari a tra 2le 15.
La tessitura mostra, in vari punti, un evidente isorientazione del metallo,da attribuire alla lavorazione delle lamine stesse. Le disomogeneità e i difettitessiturali sono ben distribuiti nel materiale, ma la loro composizione varia(fig. 8): i piir abbondanti sono quei granuli metallici che contengono Cue Sn, in rapporto circa 1:1 (fig. BA, BC e Thb. 2); molti di questi elementitessiturali contengono Ag (fig. 88, 8E), mentre solo in alcuni è presente
Sb (fìg. 8D) o Sn.
Il materiale che costituisce le lamine risulta quindi un piombo contenente
varie impurità. Il rapporto Pb/Sn è profondamente differente da quellomisurato sulle ampolle del tesoro del Duom o47 , dove il contenuto di Sn
può arcivare al 70 - 75 o/o (peltro).
Per contro, l. impurità tessiturali visibili in microscopia elettronica,awicinano il materiale a quello di alcuni reperti in piombo, dei semilavorati,
restituiti dai vecchi scavi di Castelseprio e databili al V secolo d.C.48. Anchein questi reperti sono presenti granuli di una lega metallica Cu - Sn, con
rapporti tra i due elementi prossimi a 1:1. In questo caso però elemento
minoritario presente nella lega è Fe, componente non rilevata nelle laminedella cassetta in esame.
La lamina di rame ha uno spessore variabile úa i 300 e i 500 micron(fìg. 9A). Lo strato esterno di alte razione è più ridotto rispetto a quantoriscontrato per il piombo. Il nucleo centrale, che conserva l'origin ariatessitura della lamina metallica (fig. 9B), è realizzato con un metalloavente inclusioni di argento (fìgg. 9C e 9D) . La presenza di queste piccoleinclusioni può essere attribuita ad un casuale inquinamento del metallodurante la Iavorazione, oppure rappresentare i testimoni di componentiminori, rispetto al rame, del giacimento originario.
Museo del Castello del Buonconsiglio a
Thento, per la gentile collaborazione e ilprezioso aiuto fornito.
44.V. H. Elbern, 1991, p. 14. :
45. Citiamo da V. H. Elbern, 1991, p.
14 nt. 17, con riferimenti bibliografici.
46. Sulle miniere del Monte Calisio
si vedano gli atti del convegno diCivezzano-Fornace del 1995, L. Brigo- M. Tizzoni, 1997; sulla lavorazione
dell'argento del Calisio, C. CuciniTizzoni, 1997.
603
ffi,cucrnr, M. P. Rrccanor - Le scopERTA DELLA prù enlrca cA.ssETTA Dr proMBo
Discussione e conclusioni
La cassetta di piombo in esame fu real izzata verosimilment e fra la finedel VII e gli inizi dell'VIII secolo. Quello delle reliquie di Sant'Agosrinofu un complesso trasporto, che necessitava di un contenitore adatto alloscopo, robusto ma allo stesso tempo 'pregevole'. Data l'epoca remota delledue traslazioni, non ci sono prove documentarie certe, ma solo indizi; unaconferma può comunque venire dalla datazione al radiocarbonio della telacontenuta nella cassetta indicante il periodo tra VII e VIII sec.
Pochissimi inoltre sono i confronti possibili con altre analisi di manufattiin piombo altomedievali. Come si è detto, uno dei pochi è cosriruirodalle laminette di piombo dal castrum altomedievale di Castelseprio,probabilmente di poco più antiche (V sec. d.C.); quesre ultime furonorinvenute sotto la vasca del battistero di San Giovan niae .In questo caso, inuna matrice di piombo puro, solo in parte alterato, sono contenuti inclusiabbondanti di una lega Cu-Sn e più rare particelle di Fe.
il piombo con cui fu realizzata la capsella di Sant'Agostino risultainvece contenere, oltre a inclusi di Cu-Sn, anche argento e, in misuramolto minore arsenico e antimonio. Questi componenti sono almenoteoricamente compatibili con una sua fabbric azione con metallo sardo.Ricorderemo infatti che sia i minerali della zona dell'Iglesiente-Arburese,sia quelli dell a zona del Sarrabus5o, entrambe nei pressi di Cagliari, sonodi galena antimonifera o riccamente argentifera. Nelle miniere di quesrezone inoltre sono presenti arsenico nativo e arsenopirite, calcopirite e
altri minerali di rame, antimonio nativo e antimonite, tetraedrite5l. Nonpossiamo dire niente, invece, del piombo nordafricano, di cui non sononoti studi o analisi rece nti52.
Se invece la cassetta di piombo venne realizzata in occasione dellaricognizione delle reliquie del 1022, ma questa ipotesi ci sembra altamenreimprobabile, è quasi impossibile stabilire da dove provenne la materiaprima - il minerale e il metallo - e dove essa venne fabbric ata.
Non è semplice dedurre le inform azioni tecnologiche e di proven ienzadei materiali metallici da questi dati. In letteratura, uno schema riassuntivodei giacimenti di argento sfruttati in tempi storici vede sei situazionigiacimentologiche differenti53. Inoltre gli elementi metallici inclusi nelpiombo possono rappresentare delle impurità all'origine, e quindi essere
47. F. Campi et al, 2002.
48. C. Cucini - M.P. Riccardi, c.s.
49. C. Cucini - M.P. fuccardi, c.s.
50. F. Secchi - M. Lorrai, 2001;Funedda, 20ll
5 1. P. Stara - R. Rizzo - G. Brizzi, 1993 e
P. Stara - R.Rizzo, - G. Thnca, 1996.
604
V-ANALISIESCOPERTE
uúLizzati come 'traccianti' per la prove nienza della materia prima, ma in
passaro il 'riciclo' di metallo per la produzione di nuovi manufatti eÍa
una prassi consolidata, e ciò portava a una miscelazione di materie prime
di differenre proven ienza. Gli inclusi metallici presenti nella lamina dipiombo della cassetta mostrano come si è detto un rapporto Cu/Sn di circa
1:1, ben lontano dalla composizione di residui di bronzo.
il piombo è un prodotto secondario del processo di fusione e
coppellazione della galena argentifensa, e di conseguenzail filo conduffore
per comprendere, la provenienza del piombo è da individuare nello
sfruttamento dei giacimenti di argento.
Per raccogliere dati aggiuntivi allo studio dei metalli e per cercare didipanare la complessa storia della cassetta in piombo, saranno necessarie
altre indagini, in particolare la misura delle abbon danze degli isotopi stabili
del piombo quali Pb'oa, Pb'06, Pb207 ,. p6zoa 55
)
52. Siveda la bibliografra relativa alla
nota 21.
53. N.H. Gale - Z.A. Stos Gale, 1981.
54. C. Cucini Tizzoni, 1997 .
55. R.H. Brill - E J. M'S7'ampler, 1967;A. Cincotti et a1.,2003; S. Baron et al.,
2009.
605
V - AhIAIISí H Sil{}PH,RT"H.
Fig. 1. Alcune delle lastre di piombodi maggiori dimensioni. Le laminepresenrano numerosi fori tondi (A),talvolta allineati, o chiodi ribarruri,anch'essi molto degradati, lacer azio-ni (8, C), piegarure ad angolo retto(C), oppure risultano ripiegate suloro stesse quasi a formare una dop-pia lamina (D)
Fig. 2.Alcuni particolari individuatisulle lamine di piombo. A - detta-glio di uno dei chiodi presenti entrola lamina di piombo osservaro allostereomicroscopio; B - chiodi e foridi chiodi presenri sulle lamine dipiombo
Fig. 3. Incisione probabilmenre rea-Iizzata a bulino, visibile su una dellelamine di piombo
Fig. 4. Placchette in rame rinvenu-te entro il contenuto della casserralignea
607
C. CucrNr, M. P. Rrccennr - Le scopERTA DELLA prù eNtrce cAssETTA Dr glX {} h,tffi $
I Fig. 5. Ricostruzione grafica dei trej sarcofagi-reliquiari conrenenri le
spoglie di Sant'Agostino in San Pie-tro in Ciel d'Oro a Pavia: sarcofa-go in marmo, reliquiario d'argenrodi Liutprando, casserra di piombo(elaborazione grafrca a cura degli ar-chitetti Giusepp e Mazzeo e JacopoPerego, Milano)
608
UONA NIALTHRAUIONE
llL
I àqrHFÀ trfisrÀt I trÀ frnilatrftMÀTÀ
c. cucrwr, M. P. RrccaRDr - LA scopERTA DELLA prù ANTTcA cASSETTA Dr proMBo
WWWl
WW,
Fig. 7. Lamine di Piombo. A: se-
zione trasversale della lamina dipiombo osservata in microscopiaottica; B: I'immagine in microsco-pia elettronica a scansione mostra ildettaglio della zona di alterazione dicolore rosso (in A); C: immagine inmicroscopia elettron ica a scansione(in elettroni retrodiffusi) della por-zione di lamina di piombo ben con-servata; D: spettro EDX delle diso-mogeneità della lamina di piombo
Fig.B. Immagini in elettroni re-trodiffusi (BSE) e microanalisi indispersione di energia (EDS), deidifetti della lamina di Piombo. A:lega Cu-Sn; B: piccole inclusioni diSn e Ag; C: inclusioni di Sn+As+Cu;D: Sn metallico; E: lega Cu+Sn+Ag
6r0
V-AbJAt{sI H 5ilOPHRTE.
Fig. 9. Lamine di Rame. A: sezione rrasversaledella lamina di piombo osservara in microscopiaottica; B: l'immagine in microscopia elettronica a
scansione (in elettroni retrodiffusi) mosrra il det-taglio della porzione non degradata del metallo;C: spettro EDS della composizione delle disomo-geneità presenti nel metallo; D: composizione del-la lamina di rame
Tabella 1. Composizione chimica della lamina dipiombo rilevata con microanalisi EDS "in siru"sulla porzione centrale della sezione trasversaledella lamina
Thbella 2. Composizione chimica degli inclusipresenti enrro la lamina di piombo, rilevate conmicroanalisi EDS
Figg. 10- I 1 Momenti dell'ispezione alla casserra
$n 4.5 4,2
Cu
6"3 42 4.7 47
0,6 06 05
4"3 4.7
ff.3 0.fi il3 0.5
14,7
0,8
Cu 52.2 i 32.0 ' 27.4
Pb
25.3
42"3
6tt