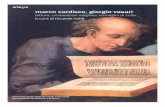L’ospedale e la chiesa di Santa Maria dei Raccomandati a Cittaducale: una ricostruzione storica...
-
Upload
beniculturali -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of L’ospedale e la chiesa di Santa Maria dei Raccomandati a Cittaducale: una ricostruzione storica...
Horti Hesperidum, III, 2013, 1 1
Horti Hesperidum
Studi di storia del collezionismo e della storiografia artistica
Rivista telematica semestrale
MATERIALI PER LA STORIA DELLA CULTURA ARTISTICA
ANTICA E MODERNA
a cura di FRANCESCO GRISOLIA
Roma 2013, fascicolo I
UniversItalia
2
I presenti due tomi riproducono i fascicoli I e II dell’anno 2013 della rivista telematica Horti Hesperidum. Studi di storia del collezionismo e della storiografia artistica.
Cura redazionale: Giorgia Altieri, Jessica Bernardini, Rossana Lorenza Besi, Ornella Caccavelli, Martina Fiore, Claudia Proserpio, Filippo Spatafora
Direttore responsabile: CARMELO OCCHIPINTI
Comitato scientifico: Barbara Agosti, Maria Beltramini, Claudio Castelletti, Valeria E. Genovese, Ingo Herklotz, Patrick Michel, Marco Mozzo, Simonetta Prosperi Valenti Rodinò, Ilaria Sforza
Autorizzazione del tribunale di Roma n. 315/2010 del 14 luglio 2010 Sito internet: www.horti-hesperidum.com
La rivista è pubblicata sotto il patrocinio e con il contributo di
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Dipartimento
di Scienze storiche, filosofico-sociali, dei beni culturali e del territorio
Serie monografica: ISSN 2239-4133 Rivista Telematica: ISSN 2239-4141
Prima della pubblicazione gli articoli presentati a Horti Hesperidum sono sottoposti in forma ano-nima alla valutazione dei membri del comitato scientifico e di referee selezionati in base alla com-petenza sui temi trattati. Gli autori restano a disposizione degli aventi diritto per le fonti iconografiche non individuate. PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA © Copyright 2013 - UniversItalia – Roma
ISBN 978-88-6507-551-7 A norma della legge sul diritto d’autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilm, registrazioni o altro.
Horti Hesperidum, III, 2013, 1 3
INDICE
SIMONETTA PROSPERI VALENTI RODINÒ, Presentazione 7 FRANCESCO GRISOLIA, Editoriale 9
FASCICOLO I SIMONE CAPOCASA, Diffusione culturale fenicio-punica sulle coste dell’Africa atlantica. Ipotesi di confronto 13 MARCELLA PISANI, Sofistica e gioco sull’astragalo di Sotades. Socrate, le Charites e le Nuvole 55 ALESSIO DE CRISTOFARO, Baldassarre Peruzzi, Carlo V e la ninfa Egeria: il riuso rinascimentale del Ninfeo di Egeria nella valle della Caffarella 85
4
ISABELLA ROSSI, L’ospedale e la chiesa di Santa Maria dei Raccomandati a Cittaducale: una ricostruzione storica tra fonti, visite pastorali e decorazioni ad affresco 139 MARCELLA MARONGIU, Tommaso de’ Cavalieri nella Roma di Clemente VII e Paolo III 257 LUCA PEZZUTO, La moglie di Cola dell’Amatrice. Appunti sulle fonti letterarie e sulla concezione della figura femminile in Vasari 321 FEDERICA BERTINI, Gli appartamenti di Paolo IV in Vaticano: documenti su Pirro Ligorio e Sallustio Peruzzi 343
FASCICOLO II
STEFANO SANTANGELO, L’ ‘affare’ del busto di Richelieu e la Madonna di St. Joseph des Carmes: Bernini nel carteggio del cardinale Antonio Barberini Junior 7 FEDERICO FISCHETTI, Francesco Ravenna e gli affreschi di Mola al Gesù 37 GIULIA BONARDI, Una perizia dimenticata di Sebastiano Resta sulla tavola della Madonna della Clemenza 63 MARTINA CASADIO, Bottari, Filippo Morghen e la ‘Raccolta di bassorilievi’ da Bandinelli 89 FRANCESCO GRISOLIA, «Nuovo Apelle, e nuovo Apollo». Domenico Maria Manni, Michelangelo e la filologia dell’arte 117 FRANCESCA DE TOMASI, Diplomazia e archeologia nella Roma di fine Ottocento 151
Horti Hesperidum, III, 2013, 1 5
CARLOTTA SYLOS CALÒ, Giulio Carlo Argan e la critica d'arte degli Anni Sessanta tra rivoluzione e contestazione 199 MARINA DEL DOTTORE, Percorsi della resilienza: omologazione, confutazione dei generi e legittimazione professionale femminile nell’autoritratto fotografico tra XIX secolo e Seconda Guerra Mondiale 229 DANIELE MINUTOLI, Giovanni Previtali: didattica militante a Messina 287
L’OSPEDALE E LA CHIESA DI
SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI A CITTADUCALE: UNA RICOSTRUZIONE STORICA TRA FONTI,
VISITE PASTORALI E DECORAZIONI AD AFFRESCO
ISABELLA ROSSI
La chiesa di Santa Maria dei Raccomandati, nonostante versi da molti anni in precarie condizioni conservative, è sicuramente tra gli edifici più interessanti di Cittaducale. Danneggiata a più ri-prese dai terremoti che hanno colpito il Lazio e la Marsica nel corso dei secoli e in particolare nel Novecento, la chiesa, il cui aspetto interno risaliva, al momento della chiusura al pubblico nel 1970, al restauro settecentesco, fu fortunatamente oggetto dell’interesse personale di Anna Maria Berti Bullo, moglie dell’allora comandante della Scuola Allievi Sottufficiali e Guar-die Forestali dello Stato ospitata nei locali dell’adiacente struttu-ra. Presa l’iniziativa personale di effettuare sondaggi all’interno per evitare che, una volta chiuso, l’edificio fosse dimenticato e rovinasse definitivamente, la studiosa giunse ad importanti sco-perte, documentate da una preziosissima relazione del marzo del 1971, tra cui la messa in luce di alcuni affreschi scialbati,
I. ROSSI
140
quattro-cinquecenteschi, tutt’ora inediti1. La loro analisi non
può prescindere da quella della chiesa e della sua storia, che si è cercato in questo articolo di riassumere collazionado tutte le fonti e i contribuiti degli studiosi che a lungo e con dedizione hanno approfondito molti aspetti della storia di Cittaducale e del suo territorio. Le visite pastorali, visionate e trascritte in oc-casione della ricerca, completano il quadro di riferimento e, sebbene non permettano di risalire oltre il 1682, forniscono al-cuni dati interessanti sulla storia del complesso e sulla confra-ternita che lo gestiva in origine. 1. La confraternita dei Raccomandati a Cittaducale: la Collatio del 1450 e le vicende dell’Ospedale Sulla scia delle scoperte del 1970-1971, la Berti Bullo rinveniva nei fondi dell’Archivio del Capitolo lateranense di Roma un do-cumento fondamentale. Datata 3 aprile 1450, la Collatio Homini-bus Fraternitatis Hospitalis Ecclesiae sub vocabolo Sanctae Marie de Re-commendatis Civitatis Ducate, è una conferma del privilegio, con-cesso dal «Capitolo e dai Canonici della Sacrosanta Chiesa Late-ranense», di «fondare e di edificare Ospedale e Chiesa con il nome di Santa Maria dei Raccomandati», sfruttando un terreno di proprietà del medesimo Capitolo. Successivamente, grazie al-
Il presente contributo è il risultato di un approfondimento della tesi in Storia dell’Arte Moderna, da me discussa nel 2007 nell’ambito del corso di Specia-lizzazione in Storia dell’Arte Medievale e Moderna dell’Università degli Studi ‘La Sapienza’ di Roma, sotto la guida del prof. Vincenzo Bilardello, che qui ringrazio per i preziosi consigli, per la disponibilità e per l’analisi acuta e mai scontata delle opere d’arte. Ringrazio inoltre, per l’aiuto e la cortesia dimo-stratami, il dott. Roberto Biondi e la dott.ssa Daniela Ciammetti dell’Archivio Arcidiocesano dell’Aquila, e don Mariano Pappalardo, parroco di Cittaducale. Un ringraziamento speciale va infine a Gianni Pittiglio per il costante e impagabile sostegno. 1 La relazione, datata 6 marzo 1971 (= Relazione 1971), è conservata presso
l’Archivio Restauri della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggi-stici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo (= ARSbap-Lazio), nella pratica relativa segnata Cittaducale (RI), Chiesa di Santa Maria dei Raccomandati, 193bis (= Santa Maria dei Raccomandati).
SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI A CITTADUCALE
Horti Hesperidum, III, 2013, 1 141
la scoperta di una lettera del 1774 conservata nello stesso archi-vio, fu possibile risalire alla data della concessione originaria, il 1365 e, quindi, di stabilire un punto fermo nella storia della congregazione nella cittadina2. La confraternita dei Raccoman-
dati del Salvatore ad Sancta Sanctorum era stata fondata a Roma su iniziativa del cardinale Pietro Colonna tra la fine del XIII e l’inizio del XIV secolo, attorno all’antica e popolare devozione per l’Acheropita, custodita dal Capitolo lateranense. I principi fondanti del sodalizio erano quelli caratteristici della fioritura associativa tipica della spiritualità tardo-medievale e si sostan-ziavano nella partecipazione attiva e responsabile all’organizzazione del culto ed alle pratiche della fede, ma con un atteggiamento di totale impermeabilità alle suggestioni dei movimenti penitenziale e flagellante, nonostante il termine di ‘raccomandati’ possa far pensare ad una confraternita di disci-plinati3. Appartenenti soprattutto al ceto di commercianti, im-
prenditori agricoli e proprietari di bestiame, che rappresentava l’elemento più vitale della società e dell’economia della Roma trecentesca, i Raccomandati diedero vita, inizialmente, ad una struttura tradizionale di stampo mutualistico, rispettosa dell’autorità religiosa come delle istituzioni civili. I primi statuti della ‘fraternità’ (1331) presentavano un’impostazione prevalen-temente devozionale: istanze assistenziali e caritative rivolte ai soli confratelli e una struttura costituzionale incerta e poco ge-
2 BERTI BULLO 1973, pp. 43-47. Cfr. Appendice documentaria I.
3 Sulla confraternita dei Raccomandati del Salvatore ad Sancta Sanctorum cfr.
PAVAN 1978, pp. 35-96 e PAVAN 1980, pp. 189-193. Si esclude la possibilità di una filiazione del sodalizio civitese dalla più famosa confraternita di Santa Maria dei Raccomandati di Roma che avrebbe poi assunto, alla metà del XIV secolo, la titolazione di confraternita del Gonfalone. I Raccomandati del Gonfalone erano disciplinati (o battuti). La vocazione all’assistenza ospeda-liera è invece connaturata ai Raccomandati del Sancta Sanctorum. Sull’argomento in generale si veda il recente ed approfondito contributo a cura di M. Gazzini, STUDI CONFRATERNALI 2011 nonché ESPOSITO 2013.
I. ROSSI
142
rarchizzata4. Successivamente la congregazione si impegnò in
opere di carità rivolte all’esterno: nel 1333 furono istituiti i primi centri assistenziali, organizzati prima in case riadattate, poi in veri e propri ospedali. La sensibilità per il problema della carità trovò presto nell’attività ospedaliera un’espressione a tal punto concreta da costituirne l’elemento caratterizzante: le parole So-cietas e Hospitalia furono, nel lessico elaborato dalla confraternita stessa, associate così di frequente da diventare di fatto sinoni-mi, ma con una progressiva preferenza del secondo termine sul primo5. E se questo è il contesto in cui si inserisce la concessio-
4 Il complesso più rilevante di norme riguardava la frequenza ai sacramenti,
la partecipazione a riunioni sociali, le messe e il banchetto comuni, la pre-ghiera quotidiana, le esequie dei confratelli defunti: tutte regole che avevano lo scopo di rafforzare il vincolo associativo. La solidarietà del gruppo, carat-terizzato da un numero limitato di adepti di cui si cercava di garantire l’omogeneità sociale, si concretizzava nell’aiuto reciproco, economico e mo-rale, verso chiunque fosse colpito da malattia o da improvvisa povertà. Cfr. PAVAN 1978 e PAVAN 1980. 5 Tra i primi edifici eretti dai Raccomandati si ricorda quello di Sant’Angelo
al Laterano, più noto come Ospedale del Salvatore, fondato nel 1348. Tali iniziative, sorte in un momento in cui la povertà cominciava ad essere perce-pita come problema non solo religioso ma anche sociale, spiega il successo ed il conseguente prestigio della confraternita: nel giro di pochi anni i Rac-comandati riuscirono a concentrare uno dei patrimoni più cospicui della cit-tà, grazie all’abbondanza dei lasciti testamentari e delle donazioni. In virtù dell’evidente ruolo di «ammortizzatore sociale» assunto nel corso del Trecen-to, la confraternita ottenne la protezione delle autorità cittadine e della Chie-sa, attraverso la concessione di indulgenze, privilegi ed esenzioni (Bonifacio IX nel 1397 e 1403; Martino V nel 1422; Eugenio IV nel 1433 e 1437; Nic-colò V nel 1448 e 1449; Sisto IV nel 1476). Nel 1408, sotto la spinta delle responsabilità connesse con la gestione dei nosocomi e con l’amministrazione dell’ingente patrimonio fondiario, si rese urgente una revi-sione e un ampliamento degli statuti: i Secunda Capitula fornirono una salda base statutaria, caratterizzata da una struttura più gerarchizzata e maggiore libertà di azione per i dirigenti, eletti dall’assemblea, peraltro esautorata da ogni potere decisionale. Con le Reformationes del 1474, si restrinse ulterior-mente la base del reclutamento con il divieto per i sodali di appartenere ad altre confraternite coinvolgendo, contestualmente, i membri nelle decisioni collegiali, per garantirne la concordia reciproca al fine di riorganizzare e am-
SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI A CITTADUCALE
Horti Hesperidum, III, 2013, 1 143
ne del 1365, alcuni eventi dalle forti ripercussioni sociali devono aver spinto la popolazione locale a dar vita a gruppi organizzati con finalità assistenziali: il giubileo del 1350, preceduto dalla famosa peste del 1348 e, soprattutto, una seconda terribile epi-demia, scoppiata nel 1363, due anni prima della ratifica della Collatio. Sebastiano Marchesi, autore dell’unica cronaca storica di Cittaducale (1592), racconta:
Questa fu la gran peste della quale Giovanni Boccaccio poeta di Certaldo fa menzione nel Decamerone suo, nella quale peste per maggior male segli aggionse una carestia universale di tutte le cose. Onde, e per l’una e per l’altra causa, non restò viva in Civita una terza parte delle genti […]. Durò questa afflizione quasi per tre anni continui fino all’anno del giubileo 1350 […]. Fu in questo anno [1363, n.d.a] in Civita una grandissima pestilenza che uccise meglio di doimila persone […]6.
Se l’Anno Santo, coincidente con la fine della pestilenza del 1348, aveva portato lungo la Salaria schiere di pellegrini prove-nienti dall’Abruzzo, dalle Marche, dal Piceno e in generale dai centri adriatici, inclusa la Puglia, la recrudescenza del morbo, appena un decennio dopo, deve aver sicuramente dato un ulte-riore impulso alla nascita della confraternita nonché alla fonda-
pliare le attività assistenziali a nuovi settori. Cfr. PAVAN 1978, p. 96 e PAVAN
1980, pp. 190-193 . 6 MARCHESI 1592 [ED. 2004], pp. 48, 52. La prima edizione del Compendio
storico di Cittaducale dall’origine al 1592 si deve all’iniziativa di un comitato di cittadini che nel 1875 rintracciò una copia del manoscritto originale, pur-troppo perduto, presso il marchese Dragonetti De Torres all’Aquila. Nel 1979 la Pro-Loco di Cittaducale e l’Archivio di Stato di Rieti curarono la ri-stampa anastatica del libro, fornendola di indici. Ad Andrea Di Nicola si de-ve un’accurata edizione critica basata sull’esemplare della Biblioteca Nazio-nale di Parigi, qui giunto, attraverso alterne vicende, grazie a Gabriel Naudé, dapprima segretario di Giovan Francesco Guidi di Bagno, vescovo di Rieti e, in seguito, al servizio del cardinal Mazzarino, dal quale era stato incaricato dell’acquisto di libri e di manoscritti in Italia e Fiandra. Cfr. Introduzione in MARCHESI 1592 [ED. 2004], pp. 1-8. Sugli itinerari giubilari nel Medioevo in Sabina, cfr. PAPÒ, CARROZZONI 1999.
I. ROSSI
144
zione di una chiesa e soprattutto di un ospedale. Inoltre, appare più che plausibile l’appoggio concesso dal Capitolo lateranense alla filiazione civitese, in una città di recentissima fondazione (1308) appartenente al Regno di Napoli, ma che di fatto ricade-va sotto la giurisdizione ecclesiastica della diocesi di Rieti e, quindi, dello Stato Pontificio7.
2. La chiesa e l’ospedale: la vicenda storica dalla fondazione alla chiusura al culto La chiesa e l’ospedale sorsero dunque su una proprietà del Ca-pitolo lateranse, indicata nella Collatio col termine casaleno che, in latino medievale, indica una domus semi-diruta o i ruderi di edifi-ci più antichi (fig. 1)8. Se il 1365 costituisce pertanto un termine
post quem per la costruzione del complesso, resta difficile stabi-lirne con esattezza la cronologia. È stato ipotizzato in passato che il documento potesse essere una spia di una mancata edifi-cazione delle strutture e che la confraternita, per non perdere i diritti acquisiti, avrebbe così provveduto a far ratificare la con-cessione9. Secondo questa lettura la chiesa risalirebbe alla se-
conda metà del XV secolo, anche se eretta in forme romaniche: un ritardo stilistico frequente nelle province lontane dai grossi poli culturali10. È il caso di notare, tuttavia, che nella Collatio la
formula adottata si riferisce già agli «uomini della confraternita dell’ospedale e della chiesa denominata Santa Maria dei Racco-
7 GUIDONI 1985, p. 170. Per la bibliografia sull’argomento, cfr. FIORE 1980,
CITTADUCALE E LA SABINA 1981, CAPEZZALI 1990, CITTADUCALE: LA
FONDAZIONE 1992, MARINELLI 1996. 8 Il capitolo di San Giovanni possedeva anche la chiesa di San Giuseppe e a
Santa Rufina, frazione di Cittaducale, la chiesa di Santa Maria del Popolo. 9 DI FLAVIO 1990, pp. 75-79.
10 Per Gavini la facciata è contemporanea a quella di Santa Cecilia e pertanto
databile all’ottavo decennio del XV secolo, mentre l’interno è dubitativamen-te assegnato al Trecento. Lo studioso supponeva l’esistenza di strutture più antiche sotto le decorazioni moderne. Cfr. GAVINI 1927-1928, II, pp. 224-225.
SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI A CITTADUCALE
Horti Hesperidum, III, 2013, 1 145
mandati», lasciando aperta l’ipotesi, più plausibile, che i due edi-fici già esistessero: la conferma del 1450, quindi, potrebbe esse-re stata necessaria per procedere ad un rinnovamento o ad una ricostruzione del complesso. Se gli anni Quaranta del secolo erano stati per Cittaducale densi di rivolgimenti politici, con al-terni passaggi sotto la giurisdizione dello Stato della Chiesa e del Regno di Napoli11, il decennio successivo coincise con una fase
di relativa pace che si ripercosse, da ciò che se ne può dedurre, anche sul versante progettuale ed artistico. Proprio al 1450, ad esempio, risale la commissione del ‘rigoglioso’ portale della chiesa di Sant’Agostino che, qualche anno più tardi (1455), fu dotata anche di una «Cona di rilievo» per l’altare maggiore di «artificiosissimo lavoro e molto ricca». Nello stesso periodo Mastro Andrea da Bergamo fu incaricato della realizzazione di una fontana da collocare davanti alla chiesa di San Giovanni, oggi scomparsa, che sorgeva proprio accanto a quella dei Rac-comandati. Non bisogna dimenticare, tuttavia, il disastroso ter-remoto di quell’anno che deve aver necessariamente segnato un brusco arresto nelle attività edilizie:
Del mese poi di dicembre il dì di Santa Barbara in Civita, ansi per tutto il Regno, cominciorno a sentirsi terribilissimi terremoti che continuorno per tutto il mese. Nel penultimo giorno di esso ne fu sentito uno così grande che un simile non che maggiore non fu udito in memoria delle genti giamai, che ruinarono molti edifizi e della terra e del contado ed in particolare delle chiese, con mortali-tà di infinite persone del territorio e di tutto il Regno; che Alfonso Re volse farle numerare e trovo esser arrivate al numero di tren-tamila e più12.
11 Cfr. BAZZINI 2011, pp. 549-552, nota 40, p. 549. Secondo Marchesi Citta-
ducale tornò a far parte del Regno di Napoli nel 1442. Cfr. MARCHESI 1592
[ED. 2004] pp. 66-68. 12 MARCHESI 1592 [ED. 2004], pp. 66-68. Tra gli avvenimenti più drammatici
che coinvolsero la popolazione si ricordano anche le epidemie del 1477 e del 1484 (cfr. MARCHESI 1592 [ED. 2004], pp. 75, 77), e il sisma del marzo 1502 in seguito al quale «si spallarono molti edifizi di case private in terra, apren-
I. ROSSI
146
Sessant’anni più tardi, nel 1509, gli ambienti annessi all’edificio furono destinati al primo vescovo residente di Cittaducale, i cui alloggi saranno trasferiti solo nella seconda metà del XVI secolo nell’episcopio adiacente alla cattedrale13. Questo importante
evento ebbe probabilmente delle ripercussioni sul decoro gene-rale degli interni e anche sulla chiesa. Racconta Marchesi:
fu poi alli 13 di novembre 1508 eletto Vescovo Giacomo Alfara-bio da Leonessa il quale, alli 11 di gennaro dell’anno venente, mandò don Luzio suo fratello a pigliare il possesso, e non tardò molto a comparir lui a far la residensa, che fu ricevuto con gran pompa e popular contento, che la comunità e il clero non perdo-norno a spesa nessuna per onorarlo e riceverlo solendidamente; che gli forno consegante per abitazione le case di Santa Maria della Fraternita14.
dosene molte altre; e cadè anche il cimiero del campanile di Santo Agostino» (cfr. MARCHESI 1592 [ED. 2004], p. 104). 13 Le notizie sull’ospedale sono state raccolte da Andrea Di Nicola in una
pubblicazione dedicata alla storia della cittadina dalla fondazione alla fine del Settecento. Cfr. DI NICOLA 2004, p. 73. L’autore ha affrontato lo spoglio della documentazione conservata presso l’Archivio di Stato dell’Aquila (= ASAq). Sul trasferimento si veda la Relatio ad limina del vescovo Valentino Valentini (1590). Cfr. TASSI 1990, pp. 299-300. 14 MARCHESI 1592 [ED. 2004] p. 103. L’avvenimento più importante del XVI
secolo è sicuramente il processo che portò all’istituzione della diocesi e alla conquista dell’autonomia religiosa da Rieti. Cittaducale, nemica del capolo-guogo sabino sin dalla fondazione, in lotta costante per questioni di confini e per essere l’avamposto più importante del Regno di Napoli, si trovava tutta-via soggetta alla sua autorità religiosa. Tale contraddizione fu risolta da Ales-sandro VI che, il 24 giugno del 1502, nominò Matteo Mongiani, vassallo e servitore degli Orsini, primo vescovo di Cittaducale. Le proteste del prelato reatino Giovanni Colonna, cui si unirono presto anche quelle della comunità, non rassegnata all’idea di perdere una porzione importante della propria giu-risdizione ecclesiastica e dei relativi proventi, indussero Giulio II a riunire amministrativamente le due circoscrizioni (1505). Solo nel 1508 la nuova diocesi iniziò il suo corso autonomo che terminò con la morte dell’ultimo vescovo, Pasquale Martini, durante l’occupazione napoleonica (1798). Go-vernata da un Vicario capitolare fino al Concordato del 1818 fra la Santa Se-de e i Borboni, la diocesi fu infine soppressa e annessa a quella dell’Aquila:
SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI A CITTADUCALE
Horti Hesperidum, III, 2013, 1 147
Cessata momentaneamente l’attività ospitaliera, i Raccomandati continuarono ad operare dedicandosi al seppellimento degli «uccisi»15. Nel 1569, l’antico refettorio che era stato prima della
confraternita e poi del vescovo, fu utilizzato dai funzionari du-cali di Margherita d’Austria e dalla Camera cittadina per le riu-nioni del camerlengo e dei priori; a partire da questa data, il so-dalizio riprese a svolgere le proprie funzioni negli ambienti an-nessi alla chiesa di San Girolamo (detta anche Santa Maria di Canetra intus) e solo nel 1571, con il trasferimento di ‘Madama’ all’Aquila, i locali rientrarono in suo possesso16. Nel 1588 Cola
Mazilli, ricco armentario di Lugnano, lasciò in eredità i propri averi per l’erezione di un nuovo monastero femminile benedet-tino presso la chiesa di Santa Croce, poi mutuata con quella dei Raccomandati: i confratelli cedettero così a Giovan Battista Marchesi, esecutore testamentario del defunto, la chiesa, l’orto e le abitazioni, ma il trasferimento delle monache avrebbe avuto luogo solo dopo la costruzione, in un luogo «vicino e comodo», di un altro nosocomio in cui ricevere «li povari, infermi e Pelle-grini», in sostituzione della stanza che fungeva da ospedale17. È
solo nel 1972 è tornata, dopo cinquecento anni, a far parte di quella di Rieti. Cfr. CONTE 1990A, pp. 276-279. 15 DI NICOLA 2004, p. 73.
16 Lo spostamento fu dovuto alla decisione di Margherita di prendere allog-
gio nel Palazzo della Comunità. Cfr. DI NICOLA 1984, p. 100 e DI NICOLA 2004, p. 151. L’unico nosocomio a rimanere a tutti gli effetti attivo nella cit-tadina, oltre a quello dei Raccomandati, trasformato nel 1509 in residenza vescovile, e a quello di San Girolamo (DI NICOLA 2004 pp. 41, nota 42, 107, p. 113, nota 80, 118, 169), presso la chiesa di San Francesco, fu l’ospedale di Santo Spirito (cfr. DI FLAVIO 1990B, II, pp. 75-79, DI NICOLA 2004, p. 73 e p. 92, nota 10). Sulle dinamiche organizzative degli ospedali nel Lazio, cfr. STROPPIANA 1979, pp. 79-90 e DI FLAVIO 1996. 17 DI NICOLA 2004, pp. 106-107, 166-167. Si segnala, senza aver avuto tem-
po di prenderne visione, un atto notarile conservato presso l’Archivio capi-tolare lateranense di Roma (Q.5.B.11), redatto a Cittaducale il 26 marzo 1589: Mandatum procurae ad peragenda varia negotia confratrum S. Mariae de Recom-mendatis, de Civitate Ducali. Cfr. DUVAL-ARNOULD 2010, p. 115.
I. ROSSI
148
interessante notare, in proposito, come alcune tele provenienti dalla chiesa, oggi conservate nella sagrestia della cattedrale e nel salone dell’Episcopio, rispecchino iconografie legate a santi o a episodi delle Sacre Scritture riconducibili a tematiche assisten-zialiste e caritative: è il caso dell’Incontro tra Abramo e Melchisedech (fig. 2) dove quest’ultimo è tradizionalmente raffigurato mentre offre pane e vino al patriarca ebraico, e della Cena in Emmaus (fig. 3) in cui i tre protagonisti sono rappresentati con le vesti tipiche dei pellegrini18. Dal documento del 1588 si evince anche
che i confratelli avrebbero continuato ad usufruire della chiesa con la possibilità di tenerla «sempre aperta e preparata» per le feste, le messe e le processioni organizzate durante l’anno, men-tre il monastero avrebbe corrisposto un compenso al cappella-no, obbligato a somministrare i sacramenti sia ai sodali sia agli infermi. Con un breve di Sisto V, dell’agosto dello stesso anno, ai Raccomandati fu comunque assegnata, evidentemente per of-ficiare le funzioni durante i lavori, la chiesa di San Girolamo, mentre la ristrutturazione del complesso fu affidata ad Antonio Scalabrino da Brenzone nel maggio del 1589. Il mastro si impe-gnava a
construere, resarcire et in quanto farà bisogno di novo fabricar fi-delmente come si conviene il novo Monasterio di Monache da eri-gersi a fabricarsi novamente nella chiesa de Santa Maria de Rac-comandati, secondo però il modello e forma di quello fatto, e che a lui sarà dato e consegnato dal prefato messer Gio. Battista [Mar-chesi, n.d.a.]19.
18 Le due tele sono citate in CONTE 1990B, p. 185 con alcune imprecisioni.
La prima è idenfiticata come Davide e Abiatar, la seconda è erroneamente attribuita alla scuola di Cola dell’Amatrice. Per entrambe si ipotizzava una provenienza dalla Cappella del Sacramento di Santa Maria del Popolo, per via della tematica eucaristica; in realtà, facevano parte dei beni di Santa Maria dei Raccomandati, come specificato dalle relative schede OA (1972). Le ope-re sono state recentemente pubblicate in GRUMO 2011, p. 63, n. 58 e p. 67, n. 67. 19 DI NICOLA 2004, pp. 106-107, 166-167.
SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI A CITTADUCALE
Horti Hesperidum, III, 2013, 1 149
La Relatio ad Limina del vescovo Valentino Valentini (1580-1592) del 1590 conferma, in effetti, l’esistenza di due monasteri femminili: quello di Santa Caterina e quello sub titulo Sanctae Ma-riae de Raccomandatis20. Poichè l’ospedale, un tempo gestito dalla
confraternita, aveva trasferito le sue funzioni in quello di San Girolamo già dal 1569, non è un caso che nell’elenco delle con-gregazioni di laici compaia quella di «San Girolamo dei Racco-mandati»: dato confermato anche dal testamento di Bucciarello Pagani che, nel 1592, lasciava una pianeta del valore di quindici ducati a «Santa Maria dei Raccomandati in San Girolamo»21.
Nonostante la spesa di duemila scudi, i lavori, sebbene iniziati, non trovarono attuazione e nel 1593 le benedettine di Santa Ca-terina chiesero di entrare in possesso della loro eredità22. Nel
1594 il vescovo Giovanni Francesco Zagordo (1593-1599) pre-gò invece il papa di poter utilizzare i redditi superflui dell’ospedale dei Raccomandati e della confraternita di San Gi-rolamo per l’erezione del seminario23. Alcuni anni dopo la con-
gregazione tornò in possesso dei propri beni, ma già nel gen-naio del 1619, in seguito all’iniziativa del vescovo Pietro Paolo Quintavalle (1609-1627) che aveva chiamato nella cittadina una comunità di Somaschi per l’istituzione di una scuola di «gram-matica e humanità», gli ambienti furono nuovamente ceduti: le monache si dissero ancora disponibili a rinunciare all’edificio, mentre il priore dei Raccomandati don Costanzo Manenti e altri ventuno confratelli concessero la chiesa. I religiosi ne acquisiro-no la totale proprietà nell’agosto 1620, sebbene il progetto edu-cativo non trovasse attuazione24. Fu così che nella Relatio ad li-
20 Cfr. TASSI 1990, pp. 299-300, 305, 379-390 e TOZZI 1997, pp. 148-151.
21 DI NICOLA 2004, p. 73, nota 207 e p. 92, nota 10.
22 DI NICOLA 2004, pp. 106-107 e 166-168.
23 «Sunt in Civitate tria hospitalia videlicet. Hospitale Sanctae Mariae de Re-
commendatis unitum cum Hospitali Sancti Hieronimi: quod per Confrater-nitatem Sancti Hieronimi de Recommendatis gubernatur et regitur». Cfr. TASSI 1990, p. 334. 24 DI NICOLA 2004, pp. 118-120, nota 101, p. 120.
I. ROSSI
150
mina del 1623 il vescovo Quintavalle propose di utilizzare un lascito di seicento scudi del defunto presbitero Ascanio Costan-zi, destinato alla costruzione del convento, per l’istituzione del nuovo seminario nei locali del convento stesso, il cui comple-tamento richiedeva ancora duemila scudi25. Il sodalizio conti-
nuava tuttavia a operare e doveva rivestire una certa importanza se fu, di fatto, l’unica associazione di laici proveniente da Citta-ducale ad essere menzionata in una celebre cronaca del Giubi-leo del 1650: la confraternita giunse a Roma, da Porta del Popo-lo, il 17 novembre di quell’anno, accolta ufficialmente dai rap-presentanti del Capitolo lateranse e, dopo aver pernottato pres-so le strutture della Santissima Trinità dei Pellegrini, proseguì la visita con il pellegrinaggio alle quattro principali basiliche della città:
La Compagnia della Madonna de’ Raccomandati di Civita Ducale vestita di bianco, favorita dal Capitolo di S. Giovanni Laterano, che le mandò incontro le sue Croci, Padiglioni, e Campanello, come aggregata ad esso, nell’ultimo veniva Monsignor Pomponio Dedoli [Vetuli, n.d.a] Denari Vescovo di essa Città, fu numerosa di Donne, le prime sei vestivano di rocchetti bianchi portando torcie accese in mano, che facevano honoranza ad una Croce d’ottone sopra un’hasta dipinta di turchino portata da un’altra ve-stita similmente di rocchetto, e doppo molti Fratelli in truppa sen-za sacchi, incontrata da un Mandatario di questa della Trinità, che l’alloggiò26.
Il passo è interessante dal punto di vista storico-sociale, poiché documenta una partecipazione attiva e molto numerosa alla vita del sodalizio soprattutto da parte delle donne, incaricate del ‘trasporto’ della croce d’ottone e ricordate con le fiaccole accese in mano ed il ‘rocchetto’ (la corta mantellina ancora in uso nei
25 TASSI 1990, pp. 348, 424. MORELLI 1999, p. 220, n. 885f.
26 A causa del grande afflusso di pellegrini organizzati in confraternite, il
numero di chiese da visitare per ottenere l’indulgenza plenaria fu ridotto a quattro invece che a sette. Cfr. RUGGIERI 1650 (ED. 2004), pp. 20, 263-264.
SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI A CITTADUCALE
Horti Hesperidum, III, 2013, 1 151
cortei religiosi) sulle spalle27. Da questo momento le fonti tac-
ciono fino a quando, l’8 dicembre 1660, il vescovo Giovan Car-lo Valentini (1659-1661) inaugura, nei più volte citati ambienti dell’edificio, il seminario diocesano, «arricchito per l’aggregazione della chiesa di S. Maria dei Raccomandati», con «l’obbligo di vigilare al mantenimento dell’Ospedale»28. Nella
Relatio ad limina dell’anno successivo (1661) lo stesso prelato an-notava: Adsunt etiam quatuor Laicorum Confraternitates, quae in pro-cessionibus cum saccis incedunt, atque Mons Pietatis, et Hospitale […] mentre, nel 1687, il successore Filippo Tani specificava che tale accoglienza non prevedeva alcun pasto: Hospitale ad peregrinos ex-cipiendos sub tecto, sed sine victu […]29. Quest’ultimo probabilmente,
od uno dei locali ad esso pertinente, fu riadattato nel 1726 a tea-tro cittadino su iniziativa dell’amministrazione pubblica per es-sere poi smantellato nel 1729 dal vescovo Pietro Giacomo Pichi (1718-1733), sotto la minaccia di scomunica per gli occupanti che vi si erano barricati in segno di protesta30. Nel 1795 l’abate
Francesco Sacco registrava:
Questa Città […] ha un Duomo di mediocre architettura, ufiziato da quattordici Canonici; un Seminario capace di molti Alunni, e fornito di tutte le scienze necessarie all’istruzione della gioventù; un Monastero di Monache Benedettine; un Monte di Pietà; tre Conventi di Regolari, il primo de’ Padri Agostiniani, il secondo de’
27 Sulla partecipazione femminile alle attività dei sodalizi, cfr. ESPOSITO
2001, pp. 53-78. 28 SIGNORINI 1868, II, p. 414, MACERONI 1990, p. 477. Il seminario fu in
seguito aperto nel marzo del 1662, nel giorno della festa di San Tommaso d’Aquino (7 marzo). 29 La Relatio ad limina (1661) del vescovo Giovan Carlo Valentini è trascritta
in MACERONI 1990, p. 507. Per quella di Filippo Tani (1687), cfr. MACERONI 1990, p. 517. 30 Sull’erezione del seminario, cfr. NOVELLI 1992, p. 31, DI NICOLA 2004, p.
132, nota 60, e p. 150; SAN FELICE DA CANTALICE 1990, pp. 299, 305, 334, 348, 477. Nel 1726 alcuni scenari, forse risalenti al tempo di Margherita d’Austria, furono trasportati nell’ospedale, cfr. DI NICOLA 1984, p. 108, nota 43. Su Tani cfr. MACERONI 1990, p. 477. DI FLAVIO 1990A, p. 34.
I. ROSSI
152
Conventuali, ed il terzo de’ Cappuccini; e sei Confraternite laicali sotto l’invocazione del Sagramento, del Suffragio, di Santa Maria de’ Raccomandati, della Buona Morte, di San Giuseppe, e dello Spirito Santo […]31.
Durante l’occupazione napoleonica, i vani retrostanti l’abside che, secondo alcuni saggi effettuati dalla Berti Bullo, dovevano aver ospitato gli ambienti privati del vescovo, vennero adattati a carcere32. Con la Restaurazione il collegio ecclesiastico tornò alla
diocesi aquilana; nel 1834 il Segretario Generale dell’Intendenza del Secondo Abruzzo Ulteriore, Francesco Paolo Blasioli, trat-tava per avere in affitto una parte dell’antico seminario per la costruzione di un ospedale ad uso dei detenuti infermi e, l’anno seguente, destinava una somma di 808 ducati per l’ampliamento ed il miglioramento delle prigioni. Tuttavia, a differenza di quanto accadeva nei distretti dell’Aquila e di Sulmona, lamenta-va la completa assenza di strutture assistenziali: caso ironico, se si pensa alla secolare tradizione ospitaliera della cittadina33. Nel
1870 una parte del complesso fu adibita ad asilo su iniziativa dell’arciprete Felice Gianfelice (1870-1897)34. Solo nel 1936, per
evitare la confisca del vicino convento di Santa Caterina da par-
31 SACCO 1795, p. 321.
32 ARSbap-Lazio, Santa Maria dei Raccomandati, Relazione 1971, pp. 10-11:
«L’architetto Frangipane e il dott. Recupero hanno effettuato un altro sopral-luogo il 7/2/1971. In tale occasione feci presente che avrei eseguito dei son-daggi nei locali dell’ex carcere mandamentale di Cittaducale, adiacente alla chiesa di S. Maria dei Raccomandati, nella sua parte posteriore, dietro l’abside […]. Sotto l’altare […] ho potuto aprire un varco nel muro che si è rivelato di chiusura di una galleria sotterranea […]. Chiaramente visibili e de-gni di nota sono nei locali del carcere tre archi […] a tutto sesto. Vi è una stanza, dietro all’abside della chiesa, dove è collocato un altare e nella stessa stanza, sulla parete a destra, è un vano, con stipiti di pietra, oggi armadio a muro, che forse era una finestra […]». 33 S.V. 1834, p. 121 e S.V. 1835, pp. 10-11.
34 Sulla destinazione ad asilo cfr. PALMEGIANI 1932, p. 436. Sullo stato della
collegiata e delle altre chiese di Cittaducale dopo le ‘leggi eversive’ del 1866, cfr. TASSI 2006, pp. 117-120.
SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI A CITTADUCALE
Horti Hesperidum, III, 2013, 1 153
te dello Stato, la Curia decise di permutare il vecchio seminario col monastero35. Negli antichi locali s’insediò la Scuola di selvi-
coltura per le Guardie Forestali del Regno, istituita nella cittadi-na nel 1905, oggi Scuola del Corpo Forestale dello Stato (1995). Prima della chiusura la chiesa era officiata per il servizio dei fo-restali. 3. Il monumento Santa Maria dei Raccomandati sorge nel quartiere di San Gio-vanni, uno dei quattro rioni storici compresi entro le mura, e un tempo il più ricco di chiese36: se si esclude la cattedrale di Santa
Maria del Popolo, sono oggi scomparse la chiesa di Santo Spiri-to, cui era annesso un ospedale, quella di San Francesco e quella di San Giovanni, la prima ad essere edificata e ad aver dato il proprio nome alla contrada37.
Sita all’angolo tra via Matteotti, su cui affaccia il prospetto prin-cipale, e piazza dei Forestali (già della Rete), la chiesa confina a nord-est con la Scuola forestale che ha inglobato, all’interno del
35 TASSI 2006, p. 120, nota 88.
36 Gli altri quartieri sono: Santa Maria (di Cesoni), Santa Croce e
Sant’Antimo. I rioni più recenti posti fuori le mura sono invece quello di Sant’Antonio e di San Magno. 37 I resti della trecentesca chiesa di San Francesco, soppressa nel 1866 e già
ridotta in grave stato di fatiscenza nel 1875, sono scomparsi definitivamente entro il 1981. Agli inizi del Novecento l’edificio fu ceduto al Corpo Forestale dello Stato che lo utilizzò dapprima come refettorio, poi come magazzino (AAA, Visite pastorali (1839), b. 839/2, p. 271, cfr. Appendice documenta-ria II) e infine officina meccanica, mentre l’ex convento venne adibito a Ca-serma degli Allievi Sottoufficiali. Nel 1982 le quattro tele degli altari laterali furono depositate in Sant’Agostino e poi a Roma: sono oggi in deposito temporaneo presso il Museo diocesano di Rieti. Cfr. DON ANTONIO E
CITTADUCALE 2006, p. 30 e TOZZI 2008, pp. 571-576. La chiesa di San Giovanni invece, visibile in alcune fotografie di inizio Novecento, era «semi-diruta» nel 1932, quando se ne conservava ancora un «bellissimo» portale a Roma. Cfr. PALMEGIANI 1932, p. 438. Per la descrizione, cfr. MUÑOZ 1917, pp. 43-44. Sulla cattedrale e gli altri edifici religiosi, cfr. CONTE 1996.
I. ROSSI
154
proprio cortile, l’antico chiostro quattrocentesco38. L’edificio
non è mai stato oggetto di studi approfonditi: le prime indagini sulla struttura, ad opera del Soprintendente ai monumenti del Lazio Antonio Muñoz e dall’architetto Ignazio Carlo Gavini, risalgono infatti solo all’inizio del XX secolo39.
L’edificio presenta una semplice facciata rettangolare a conci regolari di pietra grigia, al centro della quale si apre una piccola finestra circolare con mostra rientrante, il cui vano è ornato da arcatelle trilobe. Sotto una modanatura leggermente sporgente, che ne costituisce il coronamento superiore, si snoda una teoria di archetti pensili (fig. 1). La forma di questo semplice e austero prospetto e l’oculo centrale sono comuni a molti edifici dell’area abruzzese tra Trecento e Quattrocento e non aiutano pertanto a circoscrivere ulteriormente la datazione40. Il portale, invece, con
le sue linee essenziali, sembra essere già frutto di una nuova temperie culturale; inoltre, il confronto con quello della vicina chiesa di Santa Cecilia, su cui compare la data 1471, permette di definire un arco cronologico più preciso (fig. 4). I due manufatti sono sostanzialmente identici e furono con ogni probabilità scolpiti nella bottega di uno stesso tagliapietre locale41.
L’elemento plastico di maggiore rilievo è costituito dall’arco che incornicia la lunetta e che si imposta su una stretta trabeazione;
38 VERANI 1928, p. 150 e PALMEGIANI 1932, p. 436. Il chiostro è stato tra-
sformato nel tempo e adattato per i servizi della scuola forestale. Resta solo
il lato che affianca la chiesa, con colonne alternativamente cilindriche e pri-
smatiche e capitelli a foglia d'acanto semplificato con dentellatura a punta di
diamante. 39 MUÑOZ 1917, p. 41, 45, 47-48; GAVINI 1927-1928, II, p. 325. Brevi ac-
cenni si trovano invece in PALMEGIANI 1932, p. 436. 40 Basti pensare alle chiese aquilane, come San Marciano (fine XIII - inizio
XIV) o Santa Maria di Collemaggio (prima metà XIV) di cui la cattedrale di Cittaducale cita il rosone del portale sinistro. Cfr. MORETTI [1971]. Sull’arte e l’architettura in Abruzzo si vedano i recenti contributi in L’ABRUZZO IN ETÀ
ANGIOINA 2005 e in UNIVERSITATES E BARONIE 2006. 41 MUÑOZ 1917, p. 47, GAVINI 1927-1928, II, p. 324. Cfr. VALENTI 1990,
pp. 111-121.
SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI A CITTADUCALE
Horti Hesperidum, III, 2013, 1 155
lungo il profilo superiore dell’architrave, nelle mostre e nella ghiera dell’arco principale corre, invece, una decorazione a pun-te di diamante, presente anche nella porta secondaria che si apre sul fianco destro della chiesa, vicino all’angolo contiguo alla fac-ciata. Questo motivo ornamentale è caratteristico di quasi tutti gli edifici antichi di Cittaducale ed interessa sia quelli religiosi (Santa Maria del Popolo) sia civili (pilastri del palazzo Malatesta) e sembra testimoniare una «urbanizzazione rapida e omogenea» dell’abitato42. Le colonnine esagonali, incassate tra i montanti
esterni e il profilo interno del portale presentano, immediata-mente sotto la trabeazione, delle decorazioni simulanti foglie stilizzate. Sotto l’architrave, due piccole mensole a foglia ricurva incorniciano il vano dell’entrata, mentre la lunetta interna è de-corata da un dipinto murale, risalente con ogni probabilità al XIX secolo, raffigurante il monogramma mariano, lo stesso che si trovava anche sui confessionali ottocenteschi rimossi dalla chiesa durante l’ultima campagna di restauri. Sulla sinistra del prospetto svetta il campanile, dello stesso tipo di quello della cattedrale e di Sant’Agostino, ma di cui rimane solo il primo ordine. Presenta due coppie di bifore trilobate sul fronte principale, una sola sul fianco e due semplici aperture a tutto sesto sul lato posteriore. La facciata ha subito, nel corso del Novecento, due importanti restauri. Il primo risale al terre-moto del 13 gennaio 1915, di cui resta testimonianza nelle foto e nelle descrizioni pubblicate da Antonio Muñoz sul Bollettino d’Arte di quell’anno: la chiesa riportò la «caduta di parte del rive-stimento del prospetto, la rottura di una colonnina del rosone» e il «distacco di parte del rivestimento della facciata», ma già nel settembre successivo risultavano «recuperati tutti i pezzi del pa-ramento»43. Il secondo intervento risale invece alla campagna di
consolidamento della struttura, intrapresa dalla Soprintendenza
42 MARCHETTI 1990, p. 125.
43 CRONACA DELLE BELLE ARTI 1915A, p. 18, CRONACA DELLE BELLE
ARTI 1915B, p. 67, MUÑOZ 1915, p. 94, MUÑOZ 1917, p. 41. Sui danni del terremoto del 1915 in Abruzzo, cfr. GAVINI 1915 e MUÑOZ 1915.
I. ROSSI
156
negli anni Settanta, terminata nel 1988, durante la quale furono tamponate le profonde finestre rettangolari aperte con ogni probabilità durante i lavori di rifacimento del XVIII secolo44.
La chiesa è caratterizzata da una pianta longitudinale senza tran-setto, terminante in un’abside quadrata e divisa in tre navate, di cui le laterali ricoperte da volte a crociera (fig. 5). I pilastri ret-tangolari, che inglobano quelli antichi a sezione ottagonale con capitelli a foglie lisce, scandiscono lo spazio in quattro campate di cui le centrali più ampie, ed erano ingentiliti, sul lato verso la navata centrale, da lesene coronate da capitelli compositi e da stucchi settecenteschi (fig. 6). L’utilizzo del pilastro ottagono in edifici civili e religiosi gode di una particolare fortuna nell’architettura romana del XV secolo. Il modello compariva, a titolo esemplificativo, nel palazzo apostolico di Santa Maria Maggiore ricostruito da Niccolò V, oggi distrutto, dove i pila-stri, realizzati in laterizio, erano sormontati da capitelli ad angoli smussati. L’accoppiamento con capitelli a foglie lisce è attestato invece nel chiostro di Santa Francesca Romana (1450 ca.), nella chiesa dei Santi Nereo e Achilleo (1475 ca.), nella villa del car-dinale Riario alla Magliana (1485 ca.) e nel palazzo di Domenico della Rovere in Borgo (1480-1490). Dal punto di vista funziona-le questo tipo di sostegno fu adottato per ragioni di praticità e di economia, essendo formato da rocchi sovrapposti di pietra45:
per quanto ci riguarda, è interessante notare che la sua diffusio-ne si concentra proprio durante il pontificato di Niccolò V, sot-to il quale fu ratificata la concessione ai Raccomandati di Citta-ducale. Sebbene non sia corretto basarsi su pochi elementi for-mali per datare un edificio, questo dato, insieme alle considera-zioni sopra esposte sul portale, contemporaneo a quello di San-ta Cecilia (1471), avvalorerebbe l’ipotesi di una riedificazione della chiesa terminata appunto intorno all’ottavo decennio del
44 Una finestra analoga si apre sulla facciata della chiesa di Santa Cecilia. Cfr.
MARCHETTI 1990, pp. 122-127. 45 VALTIERI 1989, pp. 257-268. La prima testimonianza del suo utilizzo è
documentata da un disegno borrominiano che ritrae l’interno di San Gio-vanni in Laterano prima della ristrutturazione.
SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI A CITTADUCALE
Horti Hesperidum, III, 2013, 1 157
XV secolo. Ciò che rimane della decorazione settecentesca, ol-tre a qualche lacerto di decorazione in stucco, si limita all’affresco raffigurante Angeli turibolanti nella volta del presbite-rio. I tre altari, sebbene entro i limiti di una produzione affidata a maestranze locali, presentano un certo interesse in relazione alla diffusione delle tipologie romane tardobarocche in provin-cia46. L’altare maggiore (fig. 5) doveva essere preceduto da una
balaustra, a quanto pare scomparsa:
Tutta la navata corre fra sei pilastri […] fino all’abside, in cui al di là della balaustra un altro voluminoso altare barocco si innalza con una grande cornice dorata tra colonne di finto marmo, capitelli in gesso, angeli ver-niciati, fino a m 7,40 circa dal suolo. In alto un quadro di una Madonni-na, ad olio, chiuso in una nicchia sotto vetro, è cosa di nessun valore, a
meno che un forte ritocco non ne abbia alterato la primitiva fattura47.
4. Le visite pastorali Dati nuovi e interessanti sulla storia e sull’aspetto originario del-la chiesa sono invece forniti dalle visite pastorali conservate presso l’Archivio Arcidiocesano dell’Aquila48. Prima di iniziare
46 L’altare maggiore, il più imponente, è costituito da una mensa parallelepi-
peda dipinta a finto marmo verde, giallo e grigio. Due colonne disposte obli-quamente, con basi e capitelli compositi, reggono una trabeazione molto al-ta, sui cui angoli sporgenti si ergono due angeli inginocchiati; al centro del fastigio mistilineo si apre la piccola cornice raggiata. I due altari laterali, più piccoli, presentano la stessa struttura, fondata su lesene divergenti rispetto al piano di fondo e decorazioni a teste cherubiche. 47 ARSbap-Lazio, Santa Maria dei Raccomandati, Relazione 1971, p. 3.
Questa Vergine potrebbe identificarsi con una tela di modestissima fattura (cm 100x75), raffigurante una Mater dolorosa un tempo conservata nell’Episcopio di Cittaducale, non rintracciata nel corso della ricerca ma nota da una fotografia del 1972. Cfr. scheda OAC 1200209819 (S50). 48 Alla fine del XVIII secolo l’archivio vescovile di Cittaducale fu in parte
bruciato e disperso sulla piazza dai partigiani dei francesi invasori. Quel poco che si salvò fu trasferito all’Aquila dopo la soppressione della cattedra civite-se nel 1818 e la sua unione con quella del capoluogo abruzzese. Cfr. CAPEZZALI 1990.
I. ROSSI
158
con i sunti dei documenti, per non ingenerare confusione nella descrizione degli altari, si specifica che si è seguito lo stesso cri-terio adottato nelle ispezioni dai vescovi, cominciando dal pre-sbiterio e proseguendo verso l’uscita. Dalla più antica, del 1682, si ha la conferma che la chiesa fosse unita al seminario e che fosse la sede del sodalizio, i cui membri vestivano il sacco (adest Societas cum usu sacci). L’altare maggiore, della confraternita e officiato dai chierici Apollonio Palumbo e Luca Lambricelio, conservava l’affresco della Madonna dei Rac-comandati con i santi Francesco e Domenico (in muro pintis), collocato sulla parete dell’abside o inserito all’interno di un pala marmo-rea più antica, forse definitivamente perduto in seguito al ter-remoto del 170349. Da una fotografia del 1972, che mostra
l’altare settecentesco già privo della tela con l’Incoronazione della Vergine tra san Domenico e sant’Isidoro agricoltore (fig. 7) oggi custo-dita nella vicina chiesa di Santa Cecilia, era possibile scorgere, sulla muratura di fondo, l’ombra di un dipinto raffigurante una Vergine col Bambino, forse da identificare con la citata Madonna dei Raccomandati. Anche nella relazione della Berti Bullo, a proposi-to dell’altare maggiore, si specificava che:
Sopra al Tabernacolo viene messo in luce un affresco per ora co-perto di calce in una nicchia alquanto rovinata, interrotta dall’altare barocco. La continuazione è nello spazio riservato al ta-bernacolo, ritrovato sotto circa 20 cm di muratura di mattoni e malta. Potrebbe anche trattarsi di pittura a tempera; troppo poca è la superficie che è stata possibile liberare dalla calce, con assoluta sicurezza di non sciupare il dipinto, per potere giudicare il tipo e l’epoca della sua esecuzione50.
49 La cittadina fu, nel corso dei secoli, colpita da numerosi eventi sismici. Ol-
tre a quelli già citati, si ricordano i terremoti del 1519, 1539, 1582, 1639, 1646, 1672. Cfr. MUÑOZ 1917, p. 41. 50 ARSbap-Lazio, Santa Maria dei Raccomandati, Relazione 1971, p. 8. Cfr. Ar-
chivio fotografico della Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e del Polo Museale della Città di Roma (Rieti, Citta-ducale, Santa Maria dei Raccomandati, neg. sop. 116496).
SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI A CITTADUCALE
Horti Hesperidum, III, 2013, 1 159
Ancora, in un altro resoconto, si faceva riferimento a frammenti di affreschi antichi, ritrovati sulla stessa parete dove
era stata portata alla luce, con un piccolo saggio, una parte di au-reola, un occhio di notevoli dimensioni e parte della carnagione di un viso e di un manto, elementi tutti che potrebbero far pensare ad una Madonna a mezzo busto, bizantineggiante […]51.
Su questo altare, amministrato dal cappellano Giovanni Pisano, aveva luogo la solenne esposizione dell’eucarestia. Nella navata sinistra esistevano, poi, un altare dell’Annunciazione, sotto la cura di Gentile Innocenzo, familiare del doctor Virgilio Vetuli, e uno dedicato alla Natività52. Quest’ultimo corrisponde a quello
attualmente visibile nella forma data dalla ristrutturazione sette-centesca e deriva il suo nome dal soggetto dell’affresco ingloba-to all’interno della cornice tardobarocca o dalla tela che lo rico-priva ancora nel 1970 e poi rimossa (fig. 36). Nella navata destra (a cornu epistolae) era un altro altare con l’icona della Vergine in muro pincta. Tutte le mense si presentavano, a questa data, scar-samente curate ed erano ancora visibili, inserite nel pavimento originario di cui il vescovo dispose un parziale restauro, ben set-te lapidi sepolcrali: a queste sepolture dovevano appartenere i resti di ossa rivenuti dalla Berti Bullo nel 197053. I due rettori
51 ARSbap-Lazio, Santa Maria dei Raccomandati (Relazione della dott.ssa Ro-
salba Cantone [1981?]). 52 Sulla famiglia, che aveva dato a Cittaducale uno dei suoi più famosi vesco-
vi, Pomponio Vetuli (1632-1652), cfr. DI FLAVIO 1990A, p. 32, nota 27. 53 ARSpab-Lazio, Santa Maria dei Raccomandati, Relazione 1971, pp. 9-10:
«Lungo il muro della navata destra un rialzo del pavimento lungo tutta la pa-rete desta la mia curiosità. Infatti dopo la solita traccia del penultimo pavi-mento, in ordine di tempo, quello certamente del 1650 o 1700, sotto cm 10 di terreno di riporto, senza difficoltà si scopre un vuoto in muratura, a volta nella parte superiore, di m 1,20 x 2,00. Una parte è certamente crollata in epoca precedente alla messa in opera dell’attuale pavimento. Esaminata la cavità con una forte luce, vi si possono scorgere poche ossa umane: un baci-no, un teschio, un osso lungo […]. Dai sondaggi sul pavimento finora ese-guiti si può dedurre che sotto l’attuale pavimento in mattonelle ve ne fosse
I. ROSSI
160
della chiesa, i canonici Giovanni Paolessi ed un membro della famiglia Pagani, usufruivano per metà delle rendite provenienti da un beneficium simplex (ovvero esente dalla cura delle anime) trasferito alla chiesa dei Raccomandati da quella di San Pietro in Malvasia in contrada Portella e del relativo diritto di giuspatro-nato. Altri benefici provenivano dalle chiese di San Giuseppe, di Sancti Angeli Lauriani (attuale Lisciano), di Santa Croce in Pan-zano e di San Lorenzo a Sambuci. La chiesa era unita, come no-to, oltre che al seminario, all’oratorio di San Girolamo, retto a sua volta da un proprio cappellano, Belisario Lambricelio54.
Nel 1687 la situazione era sensibilmente mutata. Nella chiesa si celebrava regolarmente durante tutte le festività di precetto, ma solo in due occasioni era prevista una messa cantata: a Pasqua e nel giorno di san Rocco (16 agosto). L’altare maggiore era in buone condizioni e adeguatamente provvisto di tutto il necessa-rio per la celebrazione; quello dell’Annunciazione, che apparte-neva alla famiglia Vetuli, fu trovato spoglio, nonostante le rac-comandazioni della visita del 1681, con le quali si intimava di revocarne la cura a favore della chiesa e della confraternita. Il vescovo decise tuttavia di rinnovare il decreto sollecitando l’erede dei Vetuli, Vittoria Ricci, a rispettare gli accordi. L’altare della Natività fu trovato ruraliter provisum e pertanto furono di-sposti alcuni accorgimenti come la copertura della mensa sacra con una tela cerata, l’inserimento di cuspidi sui candelabri e la manutenzione generale degli arredi. Si menziona qui, per la prima volta, l’altare del Rosario, l’ultimo a sinistra che, trovato spoglio e privo di pietra consacrata su cui officiare, venne so-speso finchè non fosse stato nuovamente restaurato e dotato delle necessarie suppellettili: è probabile che vi facesse parte la
uno, fino al principio di questo secolo, in cotto, con gli elementi disposti a disegno. Più sotto ancora, a circa cm 46 di profondità, quello originario […]». 54 San Pietro in Malvasia compare nell’elenco delle chiese, risalente al 1459,
che versavano contributi al vescovo di Rieti. Cfr. MARCHESI 1592 [ED. 2004], p. 102. Archivio Arcidiocesano dell’Aquila (= AAA), Visite pastorali, b. 1125, ff. 161v, 162v-r. Cfr. Appendice documentaria II.
SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI A CITTADUCALE
Horti Hesperidum, III, 2013, 1 161
nicchia della Madonna col Bambino circondata dalle scene dei Mi-steri (figg. 6, 14-28), scoperta nel 1970. Difficile dire se a questa data gli affreschi fossero stati già scialbati: se così fosse, il do-cumento dimostra che l’altare aveva comunque mantenuto l’antica titolazione. La stessa situazione di generale abbandono fu riscontrata nella navata destra, dove erano due altari dedicati alla Vergine. Il primo fu trovato inadeguato e sprovvisto di ogni accessorio funzionale alla celebrazione. Il secondo, detto del Gonfalone, aveva come icona un antico (vetustum) stendardo raffigurante la Madonna, a detta del vescovo di buona fattura (pictura est valde pulcra), ma che aveva bisogno di essere inserito all’interno di un telaio ligneo per ornare adeguatamente lo spa-zio sacro. È interessante notare, sebbene non si abbiano ele-menti univoci per stabilire l'identità dei due oggetti, che «Uno stendardo della Madonna» compariva ancora nell’inventario dei beni della confraternita del 1910. Inoltre, non si può non ricor-dare il gonfalone un tempo nei locali dell’episcopio (fig. 8) che, alla luce di tali considerazioni, potrebbe provenire proprio dalla chiesa dei Raccomandati55. Tre elementi rendono, se non certa,
almeno plausibile questa ipotesi. La datazione al 1590 e lo stile attardato su moduli stilistici di primo Cinquecento giustifiche-rebbero l’aggettivo vetustum utilizzato dal vescovo nel 1687. La presenza di Rocco e Sebastiano, gli stessi santi che comparivano nella lunetta scoperta nel 1971 sotto la muratura di rifacimento dell’altare settecentesco e che non sappiamo se fosse stata, a quella data, già tamponata, sembrerebbe avvalorare la congettu-ra (figg. 9, 11). L’aspetto più interessante risiede nella raffigura-zione, negli angoli inferiori della tela, dei membri di una confra-ternita, gli uomini in abiti penitenziali e le donne col capo co-perto. In basso al centro sono i busti di sant’Antonio Abate, di
55 Il dipinto è stato recentemente pubblicato in GRUMO 2011, dove lo si dice
conservato in Santa Maria del Popolo. Al momento della revisione dell’articolo, dell’opera, che nel 1972 era nel salone dell’episcopio, non si è trovata traccia. Tra le altre tele un tempo nell’edificio e non rinvenute in questa occasione si segnala il modesto San Rocco (XVI secolo?). Cfr. scheda OA 1200209815 (50s).
I. ROSSI
162
un santo vescovo, forse san Magno, patrono di Cittaducale, e infine di un altro santo legato ai viandanti e ai pellegrini, Cristo-foro56. Lo stendardo è tra l’altro dipinto anche sul retro, dove
compare una più tarda Madonna in trono col Bambino tra san Giu-seppe e san Sebastiano (fig. 10). Nel caso si trattasse realmente del gonfalone dei Raccomandati, questa seconda immagine potreb-be essere messa in relazione all’intervento di rintelaiatura ordi-nato dal vescovo, mentre la presenza di san Giuseppe celerebbe un riferimento al beneficio sub titulo Sancti Josephi connesso all’altare, di giurispatronato della famiglia De Magnanti e il cui rettore era allora il reverendo Tommaso Cherubini. La relazio-ne, inoltre, precisa che la mensa fu trovata piuttosto piccola e stretta (exiguus) e che il prelato ordinò di mettere in opera una lastra di marmo più grande o, in alternativa, di riadattarvi quella del vicino altare già sospeso. Qui si ufficiava il culto solo nel giorno di Natale e nelle festività seguenti57.
Nel 1693 la situazione non sembra sostanzialmente mutata. Tutti gli altari, ad eccezione del maggiore e di quelli della Nativi-tà e del Gonfalone, furono sospesi; il vescovo dispose un nuo-vo restauro del pavimento e la predisposizione di un feretro per i confratelli defunti58.
Le visite del Settecento ci informano dell’esistenza di soli tre al-tari, identificabili con quelli visibili tuttora. Poiché la relazione del 1693 riferisce un numero superiore (sei), è più che plausibi-le, come già ipotizzato in passato, che il rifacimento in forme tardobarocche risalga a una data immediatamente successiva al 1703, anno del disastroso terremoto che causò gravi danni a tut-ti gli edifici di Cittaducale. Per alcuni di questi, come Santa Ma-ria del Popolo, sono documentati i lavori di restauro in seguito al sisma, per altri sono ipotizzabili. La prima relazione, risalente
56 Su san Magno da Trani, patrono di Cittaducale cfr. CAIONE, CALIÒ,
FALASCHI, LEGGIO, PATERA 2007, pp. 125-133. 57 AAA, Visite pastorali, b. 1293, ff. 191r-195r (nuova foliazione 99r-101v).
Cfr. Appendice documentaria II. 58 AAA, Visite pastorali, b. 1293, pp. 31-32 (nuova foliazione, p. 219r/v). Cfr.
Appendice documentaria II.
SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI A CITTADUCALE
Horti Hesperidum, III, 2013, 1 163
solo al 1745, ricorda che l’altare maggiore conservava pro Icona l’immagine della Vergine dei Raccomandati con san Francesco e san Domenico, forse la stessa menzionata nel 1682 e che il vescovo Francesco di Giangirolami (1682-1685) diceva dipinta su muro. Tra i vari onera del cappellano Giuseppe Pirotti c’era anche l’impegno di celebrare una messa cantata nella chiesa di San Gi-rolamo e di esporre il Sacramento nelle quaranta ore connesse alla festività del Natale. L’altare della Natività, sotto la cura della confraternita, era stato con ogni evidenza ritenuto decorosa-mente allestito, se il vescovo Nicola Maria Calcagnini (1750-1792) ordinava soltanto di ricoprirlo con una tela cerata: il ca-nonico Dionisio Berrettini, Iurispatronatus de Magnante, vi cele-brava la messa sei volte l’anno. Una notiza interessante riguarda l’altare opposto, nella navata destra, dedicato alla Vergine e amministrato da un’altra confraternita menzionata qui per la prima volta, la Congregationem artificum, ‘eretta’ dal «venerabile Padre Baldinucci». Il sacerdote di cui si parla è il predicatore gesuita Antonio, figlio minore del più famoso critico fiorentino Filippo59. Secondo la
testimonianza del confratello Francesco Maria Galluzzi, biogra-fo del religioso, nel 1712 Baldinucci si recò nelle diocesi di Rieti e di Cittaducale e nel 1713 era sicuramente nella cittadina: tra queste date e quella della morte (1717) deve essere stato fonda-to il nuovo sodalizio, poiché le missioni sul territorio sembrano essere state più di una60. A «Civita» il missionario, spesso affian-
59 Educato nel collegio gesuitico della città natale e poi nel noviziato della
Compagnia di Gesù a Roma, Baldinucci (Firenze 1665 - Pofi 1717) fu esone-rato dalle opere di evangelizzazione in Oriente e, a causa della salute mal-ferma, indotto a dedicarsi all’insegnamento. Dopo il 1698 si impegnò in mis-sioni popolari nelle campagne dell’Italia centrale promuovendo la diffusione degli esercizi spirituali per il clero contadino e per le congregazioni mariane nonché la pratica delle processioni penitenziali e il culto della Madonna refu-gium peccatorum. Cfr. VANNUCCI 1893 e MEROLA 1963, p. 495. 60 GALLUZZI 1720, p. 212: «faceva il Padre Baldinucci le solite sue Missioni
in Civita Ducale […]»; pp. 226-227: «Era nell’anno 1713 il signor Gio. Carlo Malatesta di Civita Ducale travagliato da un acerbo dolore di calcoli e mentre per esso gemeva, e spasimava, fu visitato dal P. Antonio […]». Si ricorda, in
I. ROSSI
164
cato dal futuro vescovo Pichi, tenne con successo un famoso quaresimale; durante il suo soggiorno, scrisse anche alcune let-tere in cui lamentava il gran lavoro dedicato alla cura delle ani-me del luogo «giacché notte e giorno non mi lasciano vivere»61.
Nel 1793 la gestione ordinaria della chiesa sembra migliorata. Il canonico Filippo Antonio Giraldi, incaricato di compiere l’ispezione al posto del vescovo Pasquale Martini (1792-1798), trovava l’altare dei santi Ignazio e Saverio, nel 1745 ancora de-dicato alla Vergine del Gonfalone, sufficientemente corredato di ornamenti sacri (fig. 11): qui doveva trovarsi la tela, oggi nella sagrestia della cattedrale, raffigurante la Vergine in gloria tra sant’Ignazio di Loyola e san Francesco Saverio (fig. 12), rimossa dalla Berti Bullo nel febbraio del 1970: «Un quadro ad olio, sistemato nella cornice interna, anch’esso molto mal ridotto, era zuppo d’acqua, quando è stato levato dalla sua sede»62. Il culto di Fran-
cesco Saverio era stato diffuso, in terra d'Abruzzo, proprio da padre Baldinucci, che lo considerava suo protettore nel ministe-ro apostolico63. Anche l’altare della Natività si mostrava biso-
gnoso di maggiori cure: il canonico ordinò, pertanto, la fornitu-ra di nuove tovaglie, corone ricoperte d’oro e un lavabo64. Il sa-
crarium fu trovato ben provvisto di suppellettili e con l’occasione
proposito, l’intervento di Adriano Ruggeri dal titolo Missioni del p. Antonio Baldinucci e visite pastorali: fonti a confronto per una quantificazione dei danni del terre-moto del 1703 nell’alta valle del Velino ed Alto Aterno, pronunciato al convegno Settecento abruzzese. Eventi sismici, mutamenti economico-sociali e ricerca storiografica (L’Aquila, 29-31 ottobre 2004), a cura di Raffaele Colapietra, Giacinto Mari-nangeli, Paolo Muzi. Purtroppo il contributo non compare negli atti pubbli-cati da Colacchi (L’Aquila) nel 2007. 61 GALLUZZI 1720, pp. 30, 32, 38, 43, 72, 88, 94-95, 203, 207, 221, 233, 235-
236, 252. 62 ARSbap-Lazio, Santa Maria dei Raccomandati, Relazione 1971, p. 2.
63 GALLUZZI 1720, p. 179. È importante ricordare, tuttavia, che nella visita
del 1687 il vescovo esortava a recitare delle messe «ut aiunt Sanctorum re-
centiorum». Cfr. Appendice documentaria II. 64 Il termine lavabo indica sia il rito dell’abluzione delle mani del sacerdote,
dopo l’offertorio, sia il servizio, costituito da una brocca e da un bacile, per l’abluzione delle mani del vescovo nella liturgia eucaristica.
SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI A CITTADUCALE
Horti Hesperidum, III, 2013, 1 165
si dispose l’inventario di tutti i beni mobili e immobili. Interes-sante, a chiusura del documento, la notizia della compresenza, all’interno della chiesa, delle due confraternite dei Raccomandati e degli Artisti, già citate nel documento del 1745, ma che risul-tano, a questa data, riunite in un unico sodalizio. Nel 1805 il vescovo Emanuele Ceciri lodava il buono stato dell’altare maggiore su cui era esposta l’Effigies Beatissimae Virgi-nis Mariae de Raccomandatis in tela depicta simul cum Icone sancti Do-minici et sancti Erasmi, forse la stessa citata nel 1745, sebbene sia difficile pensare che un vescovo potesse fraintendere l’iconografia di frate Francesco con quella del vescovo Erasmo. La già citata Incoronazione della Vergine tra san Domenico e sant’Isidoro agricoltore (fig. 7), oggi attribuita a Giuseppe Chiari (1654-1727), potrebbe essere identificata col dipinto citato nel 1805, nonostante si debba ancora presupporre un fraintendi-mento interpretativo: in quanto pastore di Antiochia, Erasmo è sempre raffigurato in abiti pastorali, mai in abiti da contadino né tantomeno con una vanga, come in questo caso, tipico attri-buto del santo spagnolo, canonizzato nel 1622 da Gregorio XV insieme a sant’Ignazio di Loyola e a san Francesco Saverio65.
L’altare della Natività veniva trovato convenientemente ornato, ma il prefetto della confraternita, Domenico Costantini, era comunque esortato a rimuoverne l’umidità, per quanto possibi-le. Questo problema era evidentemente tra le ragioni principali del deterioramento del frammento di affresco, a sua volta rico-perto da «un quadro letteralmente imbevuto d’acqua, raffiguran-te una Natività, tutto rotto, raggrinzito», rimosso dalla Berti Bullo nel febbraio del 1970 ma non rintracciato. Il dipinto è forse andato perduto poiché non se ne trova traccia neppure tra
65 La tela era stata in precedenza attribuita a Carlo Cesi (Antrodoco, 1626 –
Rieti, 1686) da Francesco Abbate in seguito al restauro diretto nel 1978. L’opera è stata successivamente riferita a un seguace di Girolamo Troppa (Rocchette di Torri in Sabina, 1637 – Roma, 1710); cfr. FERRARIS, VANNUGLI 1987, p. 34, CONTE 1990B, p. 186. Per l’attribuzione a Chiari, cfr. SCHLEIER 1990, p. 27, nota 1.
I. ROSSI
166
quelli schedati nel 1972 dalla Soprintendenza66. Anche l’altare
dedicato alla Vergine e ai due santi gesuiti fu trovato predispo-sto in maniera piuttosto mediocre. Dalla relazione del 1832, molto succinta per quanto riguarda la descrizione dell’interno, non si ricavano informazioni utili, se non l’indicazione di rifornire gli altari laterali di nuove tovaglie e di far restaurare due casule. Nel complesso, il vescovo Girola-mo Manieri si ritenne soddisfatto e concesse l’indulgenza di quaranta giorni ai presenti, procedendo in seguito alla cresima di alcuni giovani. Il documento termina con un lungo elenco di pia legata, ovvero degli obblighi di messe e di preghiere in ricor-do dei defunti, in ottemperanza ai lasciti testamentari dei mede-simi. Tra i nomi compare qui per la prima volta quello di Cola Mazilli, il ricco armentario di Lugnano che nel 1588 aveva do-nato la cospicua eredità con la quale si era dato avvio ai lavori di costruzione del monastero annesso alla chiesa: sono proprio i suoi gli oneri più numerosi da rispettare e si distinguono, rispet-to a quelli degli altri defunti, nell’ufficio di messe più solenni, lette e cantate, da celebrarsi nel lunedì di Pasqua e il 16 agosto, festa di san Rocco67.
Nel 1842 monsignor Filippo de’ Conti fornisce la prima descri-zione in italiano dell’edificio, trovato in buono stato e ben dota-to di arredi. L’altare maggiore era allora consacrato alla «Ma-donna della Purificazione» mentre gli altri corrispondono a quelli menzionati nelle visite precedenti. L’unica confraternita nominata è quella degli Artisti, dedita alla recita del rosario nelle feste di doppio precetto, mentre i gesuiti Ignazio e Francesco Saverio sono ricordati come santi protettori della chiesa. Il cambio di dedicazione dell’altare maggiore potrebbe avere un legame con il terremoto del 1703: lo sciame sismico ebbe il suo picco il 2 febbraio di quell’anno, giorno in cui si celebrava la Purificazione di Maria e la Presentazione al tempio di Gesù, fe-
66 ARSbap-Lazio, Santa Maria dei Raccomandati, Relazione 1971, p. 2.
67 Su Cola Mazzilli cfr. DI NICOLA 2004, pp. 166-167. AAA, Visite pastorali,
b. 1124, pp. 13-14 (1832). Cfr. Appendice documentaria II.
SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI A CITTADUCALE
Horti Hesperidum, III, 2013, 1 167
stività connesse al rito della Candelora. Le visite pastorali otto-centesche, peraltro, attestano messe in suffragio dei defunti e l’obbligo della partecipazione ai sacramenti della comunione e della confessione proprio in quel giorno68.
Nel 1853 il vescovo Luigi Filippi si trovava nelle condizioni di approvare unicamente l’altare maggiore; quello della Natività fu sospeso «perché grondante di acqua nelle pareti» mentre quello dedicato ai santi Ignazio e Francesco Saverio fu nuovamente interdetto per l’annosa questione della mensa di marmo, non adeguata alle sue funzioni. In occasione dell’ispezione, un qua-dro posto a sinistra della porta d’ingresso venne staccato e po-sto ai piedi della parete per «liberarlo dall’umidità»69.
Nel 1875 lo stesso vescovo, ricevuto dal cappellano Antonio Vetuli, trovò gli altari finalmente «decenti ed ornati competen-temente come comporta la piccola Chiesa che è decentissima». La confraternita degli Artisti continuava a riunirvisi durante le feste per la recita del Rosario, per la messa e per tutte le prati-che connesse ai riti, ma poteva contare su una «meschinissima rendita», integrata con l’elemosina ed il contributo volontario di una lira all’anno versata da ogni confratello. L’attenzione di Fi-lippi è rivolta in particolare alla decrizione della suppellettile:
L’Illustrissimo prelato visitò la custodia, e la sfera contenutavi coll’ostia consacrata. E trovò tutto a lodare, specialmente la ripe-tuta sfera di argento fatta lavorare di recente dal passato Prefetto della Congregazione Signor Angelo Giacomelli ed Assistenti che son venuti raccogliendo per questo le volontarie oblazioni dei fe-deli70.
68 AAA, Visite pastorali, b. 879/2, p. 167 (1842); b. 879/3, ff. 10r/v (1853); b.
1415, pp. 88-91 (1875). Risposte ai questionari del vescovo (1910). Cfr. Appendice documentaria II. 69 AAA, Visite pastorali, b. 1376, pp. 10-11 (1853). Cfr. Appendice documen-
taria II. 70 AAA, Visite pastorali, b. 1415, pp. 88-91 (1875). Cfr. Appendice documen-
taria II. Cfr. TASSI 2006, p. 109.
I. ROSSI
168
La visita del 1896 non fornisce notizie di rilievo, se non la ri-chiesta di restaurare il pavimento e di foderare la custodia dell’altare maggiore. Un’ultima osservazione, relativa a tutta la documentazione ana-lizzata, riguarda i nomi delle casate cui appartenevano molti de-gli ecclesiastici che godevano dei benefici connessi ai singoli al-tari e che risultano, quasi tutti, membri di famiglie nobili o be-nestanti della città: i Pagani, i Vetuli, i Roselli, i Falconi, i Bona-faccia da un lato e i Berrettini e i Palombi dall’altra71.
Altre informazioni, più utili, provengono dalle cosiddette Rispo-ste ai questionari del vescovo, di cui restano i documenti del 1910 e del 1919. Il primo è il più importante perché contiene un inventario degli arredi conservati dalla confraternita, detta però, con un’apparente incongruenza, «eretta nell’anno 1784 con assenso regio di Ferdinando IV». Questa precisazione permette di ipo-tizzare che questo sia l’anno in cui le due congregazioni, dei Raccomandati e degli Artisti, furono unite in nuovo organismo associativo dal vescovo Calcagnini, come indicato nella visita del 179372. L’elenco registra la presenza di cinque quadri in sa-
grestia, di «sei quadri grandi alle pareti della Chiesa», con cui possono essere identificate le tele conservate nell’Episcopio, quella nella chiesa di Santa Cecilia e altre di scarsa fattura non rintracciate, schedate nel 1972 ed allora in pessimo stato di con-servazione. Alla luce di quanto emerso dall’inventario e in as-senza di dati specifici sulla provenienza, si propone in via dubi-tativa l’identificazione delle quattordici tele della Via Crucis menzionate nel documento, di cui qui si riproduce Cristo e la Ve-
71 NOVELLI 1992, pp. 48-49.
72 Cfr. SABATINI 1995, p. 126. Negli Appunti bibliografici intorno a Statuti, Ordi-
ni, Grazie, regole, ecc. della regione Abruzzese dall’anno 1196 all’anno 1799, editi nel 1934, Sabatini ricordava le Regole delle confraternite del Santissimo Sacra-mento, dei Santi Fabiano e Sebastiano in San Giuseppe, della Madonna de’ Raccomandati, di Sant’Antonio Abate e del Suffragio, tutte approvate il 26 aprile 1784.
SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI A CITTADUCALE
Horti Hesperidum, III, 2013, 1 169
ronica (fig. 13), con le piccole tele sei-settecentesche conservate nell’ex residenza vescovile, opera di un modesto artista locale. Nel 1919 l’edificio era chiuso al culto e fu adibito a magazzino di viveri. La sagrestia, la cui porta era ostruita, conservava anco-ra dei registri, ma del tutto inaccesibili. È plausibile che la strut-tura, dopo il terremoto del 1915, non fosse stata messa in sicu-rezza: nonostante l’assenza di un cappellano, i confratelli, seb-bene scarsamente partecipi alle funzioni, erano ancora circa duecento. Le uniche visite novecentesche consultabili integrano in parte questo quadro ma sono molto scarne di notizie. Nel 1922, le confraternite di Cittaducale, tra cui quella della Madonna dei Rac-comandati, ricevettero alle porte della città il vescovo Aldolfo Turchi, ma dalla relazione non si evince alcuna ispezione alla chiesa; nel 1939 è invece elencata tra quelle che lasciavano «al-quanto a desiderare»73.
5. La storia recente: dalla chiusura ai restauri degli anni Ottanta Chiusa definitivamente al pubblico nel 197074, la chiesa si trova-
va da oltre trent’anni in uno stato di grave fatiscenza a causa del terremoto del 5 settembre 1950. Già nell’ottobre del 1949 il sindaco di Cittaducale, a capo del comitato cittadino sorto per intervenire sul monumento minacciato dal crollo del prospetto e del campanile, scriveva alla Sovrintendenza dei Monumenti e delle Arti dell’Aquila per richiedere un sussidio a causa dell’esiguità delle donazioni private, ricordando che già nel 1915 il comune aveva provveduto autonomamente al restauro della facciata, danneggiata dal terremoto.
73 AAA, Visite pastorali, b. 878/2, p. 3 (1922), b. 839/1, p. 543 (1934), b.
839/2, p. 271 (1939). Cfr. Appendice documentaria II. 74ARSpab-Lazio, Santa Maria dei Raccomandati, Ordinanza del 25/5/1970 del
sindaco Enzo Tiberti. Si ricorda che solo nel 1927 il comune di Cittaducale, allora amministrativamente compreso nel territorio dell’Aquila, fu incorpora-to nella ‘neonata’ provincia di Rieti.
I. ROSSI
170
Il sisma dell’anno seguente aggravò la situazione, colpendo principalmente la navata destra e il campanile. L’ossatura mura-ria presentava lesioni e distacchi di conci di pietra e sensibili strapiombi all’esterno e all’interno. I lavori, sollecitati dall’amministrazione comunale, dalla confraternita e da singoli cittadini, furono rimandati per molti anni a causa della cronica penuria di fondi statali. Nel 1956 fu effettuato un sopralluogo dalla Soprintendenza ai Monumenti del Lazio e contestualmente intervenne anche l’Ufficio del Genio Civile di Rieti che, in sede di verifica, propose l’abbattimento del corpo di fabbrica stra-piombato75. Da un controllo effettuato in quello stesso anno, si
accertò che la confraternita dei Raccomandati era ancora pro-prietaria dell’edificio; nel 1957 il priore Giuseppe Tiburzi e il parroco sollecitavano il rilascio del nulla osta necessario per l’abbattimento di una soffitta ricavata «lateralmente alla navata centrale», come suggerito in precedenza dal funzionario del Ge-nio Civile. Nel 1959 il priore Andrea Sarti, dopo aver ricevuto dall’amministrazione l’intimazione a provvedere alle spese, di-chiarava di non possedere né fondi né rendite per far fronte ai lavori, aprendo, pertanto, le trattative che avrebbero portato lo Stato a sostituirsi all’ente proprietario76.
Nel 1970 il Genio Civile di Rieti ribadiva al Ministero dei Lavori Pubblici, che prontamente ne informava la Soprintendenza, la necessità di un intervento di consolidamento: i dissesti riguar-davano lesioni nelle chiavi degli archi delle navate laterali, il crollo parziale della soffittatura nei pressi dell’ingresso, l’avvallamento delle falde del tetto e l’incrinatura dell’architrave
75ARSpab-Lazio, Santa Maria dei Raccomandati, prot. 2321 del 3/4/1956.
76ARSpab-Lazio, Santa Maria dei Raccomandati. Lettera del priore Andre Sarti,
16 aprile 1959 (prot. 3402 del 21/471959). Nel dicembre del 1958 il Provve-ditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Lazio trasmetteva una perizia (n. 323) per il restauro della chiesa in cui erano previsti i soli lavori atti ad assicurare la stabilità delle coperture e della facciata, essendo stati già com-piuti dall’ente proprietario le opere concernenti il ripristino statico delle fon-dazioni.
SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI A CITTADUCALE
Horti Hesperidum, III, 2013, 1 171
del portale principale77. I lavori ebbero luogo ma non furono
risolutivi e si procedette in seguito con iniezioni di cemento nel-le murature che danneggiarono seriamente gli affreschi della pa-rete destra. Sono questi gli anni in cui, a causa della cronica lati-tanza dello Stato, Anna Maria Berti Bullo prese l’iniziativa di ef-fettuare delle ricerche sulla chiesa. Secondo quanto riportato dalla stessa Berti, in seguito al crollo parziale della volta si decise di eseguire delle indagini sulle arcate divisorie: furono messi in luce, inizialmente, i pilastri ottagonali della navata centrale. No-nostante la Soprintendenza ne fosse immediatamente informa-ta, grazie ad Ilaria Bertelli Toesca, nessun funzionario effettuò il sopralluogo di routine: la signora decise pertanto di portare avan-ti le ricerche in modo autonomo mentre la chiesa veniva chiusa definitivamente con l’ordinanza comunale del 25 maggio 1970. Solo nel gennaio del 1971 l’architetto Frangipane, inviato da Roma, presa visione del lavoro fatto, richiese alla Berti di conti-nuare con i saggi: nel febbraio del 1971 venivano portati alla lu-ce diversi brani di affreschi scialbati. Nonostante l’attenzione sollevata momentaneamente dalla scoperta, nel 1977 la struttura era ancora puntellata a causa di gravi dissesti statici: il tetto ave-va ceduto e gli archi delle navatelle presentavano lesioni di chia-ve78. Nel novembre del 1980 la Soprintendenza si trovò ad af-
frontare una situazione divenuta drammatica: la volta in camera canna della navata centrale era interamente crollata. Anche la copertura aveva subito cadute parziali e le parti residue della grossa orditura risultavano fatiscenti. Si decise allora di non ri-costruire ex-novo le parti settecentesche crollate e di non pro-cedere ad un mero restauro conservativo che avrebbe, in ultima analisi, lasciato la chiesa nello stato in cui si trovava al momento dell’inizio dei lavori. Si stabilì, pertanto, la rimozione di tutti gli intonaci, il consolidamento statico e l’abbattimento del rialzo operato nel 1956 dal Genio Civile sulla navata destra per preve-nire il crollo della parete. Durante i lavori, mentre si sostituiva la
77 ARSpab-Lazio, Santa Maria dei Raccomandati, prot. 10251 del 4/7/1970.
78 ARSbap-Lazio, Santa Maria dei Raccomandati, Relazione 1971.
I. ROSSI
172
copertura a tetto della parte absidale, si verificò il distacco di una porzione di intonaco al centro che si decise di non risarci-re79. La volta della navata centrale fu totalmente sostituita da
una copertura a capriate, ma i restauri si interruppero nel 1987 per mancanza di fondi. Sebbene la facciata e le fondazioni non corressero più il rischio di improvvisi dissesti, le arcate furono puntellate. Gli affreschi non vennero interessati, invece, da al-cuna operazione, ma si rimossero ulteriori porzioni di intonaco in zone non interessate dall’intervento della Berti. Nel frattem-po le infiltrazioni d’acqua hanno causato un peggioramento del-lo stato di conservazione dei dipinti della parete destra, evidente dal confronto tra le foto del 1972 e quelle del 2007. Il lento ma graduale slittamento della platea della chiesa in direzione della Scuola Forestale ha dato il via a nuovi lavori di consolidamento non ancora conclusi80.
Nella relazione preliminare ai restauri redatta nel 1981 l’architetto Francesco De Tomasso, incaricato di dirigere i lavo-ri, formulava delle ipotesi circa l’originario assetto dell’edificio di cui si dà, qui di seguito, una breve sintesi. Il funzionario no-tava, prima di tutto, un’anomalia nell’impianto planimetrico: delle quattro campate laterali, le due centrali presentavano una dimensione maggiore di circa 50 cm rispetto a quelle poste alle estremità. Conseguentemente, i pilastri mediani che a causa del-le maggiori dimensioni delle campate più grandi risultavano maggiormente caricati, avevano un diametro maggiore (circa 70 cm contro 50 cm). A proposito delle vicende costruttive succes-
79 ARSbap-Lazio, Santa Maria dei Raccomandati, Relazione della Società Anto-
nio Triglia & C., 2/3/1981, prot. 4770, 11/4/1981 e Relazione del Soprin-tendente Giovanni di Geso, prot. 9347/13655 del 20.7.1981. 80 La notizia dello slittamento è frutto di una comunicazione orale della dot-
toressa Roselli dell’Ufficio Tecnico della Scuola Forestale di Cittaducale (an-no 2007). Ricordo, infine, che parte dei nuovi uffici dell’adiacente edificio è stata allestita sopra la navata sinistra, con conseguente pericolo di nuovi dis-sesti, danni alle volte e alle pareti dove si trovano la maggior parte degli af-freschi. Può essere utile, in proposito, consultare il sito dello studio dell’ingegner Antonio Ambrosi, incaricato dei restauri: http://www.antonioambrosi.com/index.htm.
SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI A CITTADUCALE
Horti Hesperidum, III, 2013, 1 173
sive alla fase quattrocentesca, l’architetto individuava due mo-menti principali: il primo, risalente presumibilmente alla fine del Cinquecento, con la costruzione delle volte a crociera nelle na-vate laterali e un secondo, nel XVIII secolo, più invasivo. A questo intervento doveva riferirsi la realizzazione della volta in camera canna sulla navata centrale e dei tre altari barocchi, la decorazione a stucco dipinto, l’inglobamento delle colonne ot-tagonali in nuovi pilastri compositi ed il rimaneggiamento della zona absidale, di cui ipotizzava, grazie anche alla presenza di tracce di affreschi più antichi, una radicale manomissione strut-turale precedente all’intervento quattrocentesco81.
6. Gli affreschi Riportati alla luce tra il 1970 e il 1971, in seguito alla chiusura dell’edificio al culto per problemi statici, gli affreschi di Santa Maria dei Raccomandati costituiscono la più importante testi-monianza figurativa di Cittaducale tra la fine del XV e la prima metà XVI secolo82. Schedati nel 1972 da Vincenzo Bilardello
per conto della Soprintendenza ai Beni Storici ed Artistici del Lazio, gli affreschi, scialbati prima o durante la ristrutturazione settecentesca in forme barocche, furono scoperti, come abbia-mo visto, da Anna Maria Berti Bullo83. In quell’occasione,
l’intonaco che li ricopriva non fu interamente rimosso: altre porzioni sono state liberate durante gli anni Ottanta ma senza portare ad ulteriori acquisizioni. L’operazione, anche in quel ca-
81 ARSbap-Lazio, Santa Maria dei Raccomandati, Relazione dell’architetto Fran-
cesco de Tommaso (1981?). 82 Altri affreschi, di epoche differenti e databili tra la fine del XIV e il XV
secolo, sono nell’ambiente retrostante l’abside settecentesca della chiesa di Santa Cecilia. Cfr. MUÑOZ 1917, p. 47 e CANTONE 1990B, pp. 128-139. 83 Sono gli anni, questi, della schedatura estesa della regione sabina, tra Rieti
e il confine abruzzese, in un’area che era già stata pioneristicamente censita vent’anni prima da Luisa Mortari e Italo Faldi. Cfr. MORTARI 1951, MORTARI 1960, MORTARI 1966, BILARDELLO 2004, pp. 48-49.
I. ROSSI
174
so, non fu estesa a tutta la superficie e per questo motivo non si esclude che vi siano altri brani ancora nascosti. Il quadro decorativo della chiesa non era, da quanto si può de-durre, organicamente strutturato, ma si componeva di più ri-quadri votivi giustapposti con la sola esclusione di due affreschi, entro nicchie centinate ricavate a vivo nel muro. Tutte le imma-gini riflettono, nel loro complesso, i caratteri della cultura figu-rativa umbro-laziale, sono databili tra l’ultimo quarto del XV e la prima metà del XVI secolo e confermano la progressiva omologazione del linguaggio locale, rappresentato nei suoi esiti migliori dall’amatriciano Dionisio Cappelli, sui modi di Anto-niazzo Romano prima, per approdare in seguito ad un’uniformità espressiva modellata sulla «dignitosa modestia di Iacopo Siculo e dei fratelli Lorenzo e Bartolomeo Torresani, pittori trapiantati a Rieti dalla nativa Verona»84.
La parete della chiesa che ha conservato la maggior parte di queste testimoninze figurative è quella sinistra. La più rilevante è una Madonna col Bambino (fig. 14) di scuola antoniazzesca, cir-condata da quattordici scene con i Misteri del Rosario (figg. 15-28) che forse, un tempo, costituiva la parete di fondo dell’omonimo altare citato nelle visite pastorali del 1687 e del 1693. Il vano en-
84 Cfr. Enrico Lavagnino in MORTARI 1957, pp. 3-10. Nella premessa al cata-
logo della mostra, lo studioso forniva un quadro chiaro delle influenze che potevano individuarsi sul territorio dopo la metà del Quattrocento. Indicava nell’Abruzzo il serbatoio più ricco di energie artistiche, soprattutto nella zo-na compresa tra Leonessa, Posta, Borbona, Antrodoco e il Cicolano; tra Rie-ti, Greccio e Magliano Sabina notava influenze umbre; nell’area compresa tra Palombara, Poggio Mirteto, Vescovio e la Valle del Tevere coglieva invece un linguaggio uniforme, influenzato dalle coeve esperienze artistiche «tibur-tine». Per un quadro generale sulla pittura nella zona compresa tra monti Sa-bini, Tiburtini, Cornicolani e Prenestini, cfr. BUTTAFOCO 1995, MASSAFRA
1995; sulle opere ad affresco tra Lazio ed Abruzzo a cavallo tra XV e XVI secolo cfr. NARDECCHIA 2001, TOMEI 2005; sull’Abruzzo nel primo Quat-trocento, cfr. DELL’ORSO 1992; sull’Umbria, cfr. TARCHI 1940 e TARCHI
1954, TODINI 1989, DALL’ALBORNOZ ALL’ETÀ DEI BORGIA 1990, SAPORI
1993. Si veda infine il recente ed aggiornato repertorio di Giovanna Grumo dedicato ai dipinti su tela e tavola realizzati nel reatino durante il Cinquecen-to. Cfr. GRUMO 2011.
SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI A CITTADUCALE
Horti Hesperidum, III, 2013, 1 175
tro cui si trova fu riportato alla luce nel febbraio del 1971, na-scosto da una nicchia entro cui era una statua della Vergine, identificabile forse con la terracotta otto-novecentesca raffigu-rante un’Addolorata ora nella Cattedrale85. L’opera è mutila: la
parte coincidente con i volti e i busti delle due figure è stata staccata prima di procedere all’intonacatura. La Berti Bullo sup-poneva che questa porzione fosse stata trasferita all’esterno, nell’edicola che ancora oggi si trova sul fianco destro dell’edificio. L’analisi autoptica indurrebbe ad escludere questa ipotesi sia per la frontalità del volto della Vergine, non con-gruente con la posizione del corpo nell’affresco, sia per l’assenza del viso del Bambino (fig. 29). È plausibile, tuttavia, che l’immagine sia stata manomessa, nel corso dei secoli, da pe-riodiche ridipinture fino a perdere la forma originaria86. Il dipin-
to è evidentemente ispirato ad alcuni prototipi di Antoniazzo Romano, più volte replicati e che ha tra i suoi modelli più strin-genti la Madonna degli Uditori di Rota alla Pinacoteca Vaticana (1488-1492), la Madonna col Bambino di Sant’Apollonia a Velletri e quella dell’ex-Ospedale civile di Bracciano (entro 1495), in cui si riscontrano alcuni identici particolari (fig. 30)87: la posizione
85 ARSbap-Lazio, Santa Maria dei Raccomandati, Relazione 1971, p. 7: «Sotto
pochi centimetri di intonaco, intorno alla nicchia dove trova posto una sta-tua della Madonna, nella parte della navata sinisitra resti di affreschi di due differenti periodi […]». La provenienza della statua dalla chiesa dei Racco-mandati è stata comunicata dal parroco don Mariano Pappalardo (2013). 86 Il vetro che protegge l’icona votiva non permette una corretta lettura del
dipinto la cui superficie appare accidentata e lacunosa. Solo un restauro po-trebbe accertare l’esistenza di strati d’intonaco precedenti e confermare l’ipotesi che il frammento sia ciò che resta dell’antico affresco. 87 CAVALLARO 1992, p. 202, n. 28. Nonostante la data, comparsa durante i
restauri del 1965, l’affresco è variamente datato tra il 1491-1493 e il 1497-1499. Anche l’attribuzione oscilla tra la bottega e la completa autografia del maestro. Stessa composizione, ma in controparte, si ritrova nell’opera di Le Mans e in quella del Museo civico di Viterbo, datate all’ultimo decennio del XV secolo. Cfr. CAVALLARO 1992, pp. 200, 203, 238 e CAVALLARO 2013, pp. 34-42. Tra le opere attribuite alla bottega si ricordano ancora la Madonna col Bambino nella chiesa di Santa Maria e San Biagio a Sant’Angelo Romano e l’affresco del Prado, datato entro il 1495.
I. ROSSI
176
delle gambe e dei piedi dell’infante, il risvolto del manto della Vergine che dall’avambraccio si avviluppa sulle ginocchia, la camicia che affiora dall’asola della manica destra, la posizione della mano sinistra, col mignolo leggermente piegato e indice e medio divaricati. Sebbene le campiture di colore appaiano oggi piatte a causa della perdita delle rifiniture a secco, la cromia ha mantenuto la sua fastosa vivacità. I due angeli che incoronano la Vergine sono delineati in maniera più sciolta, mentre il colore è caratterizzato dall’accostamento di tinte stridenti e da effetti cangianti. La morfologia dei nasi e delle bocche è simile a quella del San Domenico, raffigurato poco oltre sulla parete e riconduci-bile alla stessa bottega (fig. 31). La diffusione della maniera di Antoniazzo tra il Lazio settentrionale e l’Umbria meridionale risale all’ultimo ventennio del XV secolo, protraendosi in alcuni casi fin oltre la prima decade del Cinquecento, anche grazie alla «vasta disponibilità e all’ampia circolazione dei cartoni» utilizzati dagli allievi, dalla sua «posizione di artista legato al mondo con-fraternale» e ai gusti attardati della committenza locale, concen-trati principalmente su temi devozionali88. È in questo contesto
e in concomitanza con l’arrivo dei grandi protagonisti del Rina-scimento a Roma, che matura in Antoniazzo, qualche anno prima della morte (1508), la decisione di allontanarsi in provin-cia e di trasferire proprio a Rieti la bottega (1505), la cui attività rimase viva per alcuni decenni spegnendosi gradualmente in forme provinciali e di maniera, ‘forme’ di cui questo affresco sembra essere un esempio significativo. Nel duomo del capo-luogo sabino si conserva una Madonna in trono col Bambino, la Maddalena e san Balduino, eseguita da Antoniazzo e dal figlio Marcantonio, documentato in città fino al 1526, che sembre-rebbe essere, ad oggi, l’opera più vicina al dipinto civitese rin-tracciata sul territorio89. È possibile che l’esecuzione
88 CAVALLARO 1992, p. 109; SANTOLINI 1996, p. 51; CAVALLARO 2008, pp.
425-426. 89 Antoniazzo tornò successivamente a Roma, forse già a partire dal 1506, e
qui si spense nell’aprile del 1508, come recentemente accertato da Anna Esposito. Cfr. ESPOSITO 2013, p. 62 e CAVALLARO 2013, pp. 43-44. Sul pit-
SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI A CITTADUCALE
Horti Hesperidum, III, 2013, 1 177
dell’affresco vada messa in relazione con qualche evento parti-colare, come il trasferimento della residenza negli ambienti an-nessi alla chiesa dei Raccomandati nel 150990. Le scenette che
contornano la nicchia, invece, testimoniano la crescente devo-zione al salterio mariano, pratica diffusa dal XIII secolo, e poi incrementata nella seconda metà del Quattrocento dal domeni-cano bretone Alain de la Roche, cui si deve la fissazione dei quindici misteri, e dal teologo Jacob Sprenger, cui invece spetta la fondazione della confraternita del Rosario a Strasburgo nel 147591. In Italia, la prima congregazione con questa titolazione
era nata a Venezia nel 1480, seguita l’anno successivo da quella romana, istituita presso il convento domenicano di Santa Maria sopra Minerva. Sarà poi il frate veneziano Alberto da Castello a dare nuovo impulso alla devozione mariana con la pubblicazio-ne, nel 1521, di un celebre testo più volte ristampato per tutta la prima metà del XVI secolo92. La leggenda, diffusa soprattutto
da Alain de la Roche, voleva che la Vergine fosse apparsa a san Domenico e che gli avesse donato il rosario: fu così che, dopo un periodo di ‘incertezza’ iconografica in cui si continuò ad uti-
tore si veda il recentissimo catalogo della mostra ANTONIAZZO ROMANO. PICTOR URBIS 2013. Su Marcantonio Aquili cfr. COSTAMAGNA 1981, pp. 76-82; ROSSI 2008, pp. 408-413; GRUMO 2011, pp. 13-14 e GRUMO 2013, in par-ticolare pp. 154-155. La studiosa pubblica un trittico in collezione privata (fig. 40a), firmato da Marcantonio (1507), il cui pannello centrale, una Ma-donna col Bambino, mostra la classica tipologia riprodotta dalla bottega e dai seguaci di Antoniazzo, sostanzialmente coincidente con quella dell’affresco di Cittaducale, ad eccezione della posizione della mano sinistra della Vergine. 90 Non bisogna dimenticare che il primo vescovo (1502), Matteo da Mugna-
no, sebbene non si fosse mai recato nella cittadina, era vassallo degli Orsini e per gli Orsini Antoniazzo aveva decorato alcuni ambienti del castello di Bracciano, tra cui la già citata Madonna col Bambino. 91 Il culto fu confermato da Sisto IV con due bolle emanate rispettivamente
nel 1478 e nel 1479. Le confraternite del Rosario praticavano la devozione alla teoria dei misteri dolorosi, gaudiosi e gloriosi. Sui primi passi della con-fraternita, cfr. MEERSSEMAN 1977B, pp. 1144-1232. Per le più antiche con-fraternite domenicane di devozione mariana, cfr. MEERSSEMAN 1977A pp. 921-1171. 92 ROSA 1999, p. 234-235.
I. ROSSI
178
lizzate l’antico modello della Madonna della Misericordia, si giunse all’elaborazione di un nuovo prototipo, differenziatosi a sua volta in due schemi principali: il primo con Maria che, assisa su una nuvola, consegna il rosario a san Domenico, il secondo, in-vece, cui si aggiungono le figure di Gesù e di santa Caterina da Siena93. I misteri furono collocati generalmente come ‘cornice’
intorno all’immagine centrale della Vergine, soluzione questa di chiara matrice italiana, adottata soprattutto in area umbro-marchigiana, come nella pala di Giulio Vergari per la chiesa di San Michele Arcangelo a Bolognola (1519) oppure, ispirandosi a tipologie nordiche, all’interno del quadro stesso, come pannel-li o medaglioni incastrati o sospesi su un roseto, come nel caso della celebre tela di Lorenzo Lotto a Cingoli (1539)94. Rispetto a
quanto esposto è evidente che l’affresco di Cittaducale presenti incongruenze e sollevi interrogativi: prima di tutto la scena cen-trale, con la sola Vergine in trono senza i santi e, apparentemen-te, considerato lo stato di conservazione complessivo, l’assenza di cespugli di rose. Questa particolarità è forse spia di una data-zione alta dell’affresco ed è, come già detto, comune ad altre opere di area marchigiana; oppure potrebbe spiegarsi in ragione di un cambiamento in corso d’opera o verificatosi qualche anno dopo l’esecuzione del gruppo centrale, con l’aggiunta degli an-geli reggicorona, delle scene dei misteri e con la realizzazione del San Domenico nel già citato riquadro sulla stessa parete. In se-condo luogo, il numero delle scene non è quello canonico: nella cornice sono rappresentati solo quattordici episodi invece di quindici. Manca, infatti, quello che di norma apre la serie, l’Annunciazione. L’Assunzione della Vergine, invece, generalmente raffigurata mentre ascende al cielo lasciando il sepolcro vuoto,
93 MEERSSEMAN 1964B, pp. 318-325 e MEERSSEMAN 1977C, pp. 1204-1206.
94 Sull’influenza di modelli tedeschi nella pala di Lotto, cfr. LAVAGNOLI
2006, pp. 28-36. Sulla storia della confraternita e sull’iconografia del Rosario in Italia, cfr. MEERSSEMAN 1964A e MEERSSEMAN 1964B, argomenti poi ap-profonditi in MEERSSEMAN 1977C. Tra gli studi recenti, relativi a singole opere o ambiti territoriali, cfr. anche QUATTRINI 1990; VENTURA 1994; ANSELMI 2009, pp. 489-495.
SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI A CITTADUCALE
Horti Hesperidum, III, 2013, 1 179
circondato dagli apostoli agitati e confusi, è qui evocata dall’episodio della Consegna della cintola a san Tommaso (fig. 27), un’iconografia la cui liceità era stata più volte messa in dubbio nel corso del Quattrocento95. Nonostante l’opposizione degli
ambienti culturali più aggiornati, nei centri periferici e presso le clientele piccolo-borghesi, si sviluppò una costante fedeltà al soggetto, incrementata dalla devozione popolare intorno alla re-liquia conservata a Prato, con importanti eccezioni anche nella produzione artistica ufficiale96. Nel reatino, l’episodio compare
anche nello sfondo della più tarda tavola con l’Assunzione della Vergine di Jacopo Siculo per la chiesa di San Pietro a Leonessa (1542-1543)97.
Dal punto di vista stilistico le piccole scene di Cittaducale sono caratterizzate da un’espressionistica vivacità narrativa e da un
95 L’iconografia, nata nel XII secolo, ebbe tra i suoi più strenui contestatori
sant’Antonino, arcivescovo di Firenze (1446-1459), per la diretta derivazione dal Transitus della Beata Vergine Maria, un testo apocrifo attribuito allo Pseudo Giuseppe di Arimatea (VI-VII secolo), ripreso con qualche variante dalla Legenda Aurea di Jacopo da Varagine. Secondo il racconto la Vergine, prima di morire, avrebbe prodigiosamente chiamato a sè nella valle di Giosafat gli apostoli, allora impegnati nella predicazione in varie parti del mondo. Tom-maso giunse tardi: mentre si dirigeva al luogo prestabilito, vide Maria ascen-dere al cielo mentre la cintola veniva «gettata dall’alto». Nella Legenda Aurea (cap. 119) il racconto è diverso: dopo le esequie officiate dagli apostoli, Tommaso si rifiutò di credere all’accaduto. Maria allora gli apparve e, a me-moria di quanto avvenuto e per farlo ricredere, gli consegnò la cintura che aveva indosso. Cfr. FERRETTI 2002, p. 411. 96 I primi esempi si registrano in Francia alla metà del XII secolo e a Stra-
sburgo nel 1230. Un affresco nella chiesa dei Santi Giovanni e Paolo a Spo-leto sembra essere, invece, una delle più antiche raffigurazioni italiane del tema (fine del XIII secolo). Alla fine del Trecento, l’iconografia si diffuse in Toscana, soprattutto nei centri minori. Tra le opere più famose si ricordano, invece, il Tabernacolo di Orsanmichele di Andrea Orcagna (1359), la Porta della Mandorla di Nanni di Banco (1414-1421), la Madonna della cintola di Filippo Lippi e Fra’ Diamante al Museo civico di Prato (1456-1467 ca.). Cfr. FERRETTI 2002, p. 412 e sgg. Si veda anche il Dossale con i Misteri del Rosario attribuito alla bottega di Domenico Beccafumi in San Domenico a Siena (prima metà del XVI secolo). 97 GRUMO 2011, p. 42, n. 17.
I. ROSSI
180
tratto spigoloso e veloce, quasi fumettistico; gli elementi archi-tettonici, gli sfondi paesaggistici e i particolari accessori sono invece ridotti al minimo, prediligendo invece la mimica dei per-sonaggi: l’assenza totale di divagazioni descrittive è evidente nel-le scene ambientate all’aperto (Visitazione, Crocifissione, Resurrezio-ne, Consegna della cintola a san Tommaso, figg. 15, 23, 24, 27). Lad-dove è presente un interno, questo è raffigurato in modo com-pendiario; se nella Presentazione al Tempio (fig. 17) domina un im-pianto più solido, la Flagellazione (fig. 20) sembra citare, seppur goffamente, nella figura di Cristo e nella colonna sormontata dall’idolo, alcuni prototipi celeberrimi, tra cui lo stendardo di Luca Signorelli oggi a Brera, eseguito per la confraternita di Santa Maria dei Raccomandati a Fabriano (1475). Sebbene non si siano identificate corrispondenze precise, alcuni elementi lasciano supporre che a far da modello a queste imma-gini siano state stampe nordiche, probabilmente xilografie quat-trocentesche, con cui queste scenette condividono il tratto duro e alcuni caratteri tipologici, come ad esempio i lunghi capelli sciolti e la sottile fisicità di Maria nella Visitazione (fig. 15) o le esili colonne del Gesù tra i dottori (fig. 18) e dell’Incoronazione di spine (fig. 21). L’Assunzione della Vergine (fig. 32), una delle xilo-grafie a corredo delle Meditationes di Juan de Torquemada, mo-stra un’impaginazione simile a quella dell’Ascensione (fig. 25) e della Pentecoste (fig. 26) di Cittaducale, oltre ad inglobare l’episodio della consegna della cintola a san Tommaso al suo in-terno. Il testo fu il primo libro a stampa con illustrazioni edito in Italia (1467) e, come recentemente dimostrato, aveva ispirato la decorazione del chiostro di Santa Maria sopra Minerva a Ro-ma, il cui programma iconografico era stato approntato dal ce-lebre cardinale e teologo spagnolo98. Al di là di questo, le picco-
le scene costituiscono senz’altro un episodio figurativo degno di interesse e al momento ‘isolato’, sia dal punto di vista iconogra-fico sia stilistico, nella zona reatina. Per quanto riguarda la strut-
98 Meditationes J. de T. positae et depictae de ipsius mandato in ecclesiae ambitu S. M. de
Minerva, 1467. Cfr. DE SIMONE 2002.
SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI A CITTADUCALE
Horti Hesperidum, III, 2013, 1 181
tura compartimentale della nicchia, l’unico confronto possibile sembra essere l’affresco della chiesa di San Pietro nella vicina località di Torano, presso Borgorose (seconda metà del XVI se-colo), con la Madonna del Rosario tra i santi Domenico, Caterina, Agostino, Gregorio, Pietro, Ambrogio (?) e donatori e intorno, disposte in senso antiorario, quattordici scene dei Misteri (fig. 33). Il riquadro successivo, posto in corrispondenza della seconda campata dall’entrata, raffigura un San Domenico (fig. 31): una grande lacuna ne ha compromesso il volto, lasciando in vista solo una porzione del naso e della bocca. Il santo tiene nella mano sinistra un volume mentre l’indice della mano destra è al-zato. La stesura pittorica è concepita per ampie campiture di co-lore conservatosi in buono stato. Il disegno appare rigido e marcato nella veste e nel mantello, le cui superfici definiscono piani semplificati e taglienti, mentre appare più libero nel volto. Anche in questo caso si nota l’eco di prototipi antoniazzeschi: tra gli esempi più stringenti ricordiamo il Sant’Antonio da Padova del Museo civico di Rieti (1474) e il Santo Vincenzo Ferrer (fig. 34) del convento di Santa Sabina a Roma (1482-1485). La stesu-ra del colore e la tavolozza richiamano le scene dei Misteri, in particolar modo le tinte pastello dai riflessi perlati della scena della Visitazione (fig. 15) e, come già detto, il naso e le labbra presentano forti affinità con quelli degli angeli. Identiche ap-paiono anche le aureole, non sempre perfettamente centrate sulla testa dei personaggi, campite dal medesimo timbro giallo-ocra e definite in maniera sommaria da una linea spessa e scura. È interessante notare la ricorrenza di altre figure domenicane all’interno del palinsesto pittorico dell’edificio, a partire dall’espressionistico e severo volto, dipinto sulla parete di fondo della stessa navata (fig. 35); la presenza di san Domenico è te-stimoniata nel perduto affresco con la Vergine dei Raccoman-dati di cui parla il documento del 1682 e compare infine nell’Incoronazione della Vergine tra san Domenico e sant’Isidoro agricol-tore (fig. 7), un tempo sull’altare maggiore: l’antica devozione mariana/rosariana all’interno della chiesa, attestata come già vi-sto a partire dal XVIII secolo nelle visite pastorali, sembrerebbe
I. ROSSI
182
avere un’ascendenza molto più antica, di cui gli affreschi della parete sinistra costituirebbero la prima testimonianza99.
All’interno della cornice tardobarocca dell’unico altare della na-vata è invece inglobato un antico brano di affresco che, nono-stante il cattivo stato di conservazione, sembra mostrare ancora una qualità per nulla mediocre. Raffigurante in origine una Nati-vità o un’Adorazione dei pastori, l’opera fu salvata dalla scialbatura ed eletta a decoro di uno dei tre altari principali (fig. 36). La prima menzione di un altare Nativitatis, con cui deve essere iden-tificato quello in oggetto, risale al 1682, quando è così registrato nella visita pastorale del vescovo Francesco De Giangirolami (1682-1685); in seguito è l’unico, insieme a quello maggiore e all’altare della Vergine (poi dedicato ai santi Ignazio e Francesco Saverio) nella navata opposta, a sopravvivere alla ristrutturazio-ne seguita al terremoto del 1703. È probabile che il dipinto, oltre a costituire una delle memorie più antiche conservate nell’edificio e, per questo motivo, dive-nuto oggetto di particolare venerazione da parte dei fedeli, fosse stato valorizzato anche per la sua valenza artistica. L’affresco raffigura, in basso al centro, Gesù Bambino il cui corpo è taglia-to all’altezza del torace: si scorgono a fatica la testa, il nimbo crucisegnato, il braccio e la mano sinistra alzati. Alle sue spalle è collocata la mangiatoia colma di paglia, il cui prospetto frontale è costituito da rami di legno intrecciati. Il bue e l’asino rappre-sentano la parte dell’opera più chiara, mentre sullo sfondo si scorge il muro della stalla; a sinistra si intravede, tagliata, una fi-gura con le mani giunte e parte del mantello che la ricopriva. L’attitudine coincide con quella della Vergine, anche se i colori dell’abito non corrisponderebbero a prima vista con quelli ca-nonici. La manica è gialla mentre il manto ha una tonalità rossa-
99 Potrebbe rappresentare un domenicano anche il frammento di una figura,
rinvenuto sulla parete di fondo della navata destra, di cui rimane la parte in-feriore con due lembi di veste, uno scuro e l’altro bianco, verosimilmente un mantello e una tonaca. Tuttavia, la presenza di ciò che sembrebbe a prima vista un bastone, lascia aperta la possibilità di un’identificazione con sant’Antonio Abate.
SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI A CITTADUCALE
Horti Hesperidum, III, 2013, 1 183
stra: questa apparente particolarità potrebbe in realtà corrispon-dere alla base preparatoria su cui veniva stesa l’azzurrite. Se ciò che rimane dell’affresco è evidentemente un brano ridotto, le sue dimensioni, affatto esigue, lasciano immaginare una compo-sizione molto imponente e che probabilmente si sviluppava oc-cupando gran parte della parete, oltre gli attuali limiti dell’edicola barocca: sui lati le figure di san Giuseppe, della Ver-gine ed eventualmente dei pastori, in basso il Bambino raffigu-rato per intero e in alto la parte sommitale della capanna o una gloria d’angeli. Le fisionomie dei due animali, come anche la ti-pologia della mangiatoia e della parete di pietra, sono ispirate a prototipi tardo-quattrocenteschi di matrice umbra; si pensi alla Natività di Filippo Lippi nel Duomo di Spoleto (1469) e a quelle di Pinturicchio in Santa Maria del Popolo a Roma e nella Cap-pella Baglioni di Spello (1501), in cui compare il motivo dei grossi rami intrecciati della greppia. L’Adorazione dei Pastori, af-frescata nel 1516 nell’abside di Santa Maria di Arrone da Vin-cenzo Tamagni e da Giovanni da Spoleto (fig. 37), costituisce un altro termine di paragone. Sebbene nel frammento di Citta-ducale la superficie appaia molto deteriorata, le ombre che ne definiscono i volumi sembrano vicine a quelle di Arrone, per-mettendo così di datare l’affresco, in virtù di questa qualità scul-torea più risentita, entro il terzo decennio del Cinquecento100.
L’affresco di analogo soggetto di Francesco da Montereale (1520) nella chiesa di San Panfilo a Villagrande (L’Aquila) (fig. 38) costituisce un altro esempio di come potesse svilupparsi la composizione sulla parete. I problemi di umidità, documentati dalla visita del 1805, sono molto probabilmente gli stessi che hanno ridotto l’antica e venerata immagine a poco più di una
100 Il ciclo di Arrone è una precoce importazione in area umbra della pittura
romana raffaellesca. Spetta probabilmente a Tamagni tutto l’impianto archi-tettonico, l’apparato ornamentale e il paesaggio, memore di Pinturicchio e di Sodoma; a Giovanni da Spoleto, la Morte della Vergine, la maggior parte dell’Incoronazione e parte dell’Adorazione dei Pastori. Cfr. PETRALLA, SAPORI 2004, pp. 84-97.
I. ROSSI
184
larva e che, in epoca imprecisata, si decise di occultare con la tela di analogo soggetto rimossa dalla Berti Bullo nel 1970101.
In fondo alla parete della navata campeggia, su un esuberante e florido tendaggio a girali rossi, una Madonna del latte realizzata con notevole scioltezza e senso cromatico (fig. 39). Il riquadro entro cui è compresa è delimitato da una cornice rossa sul cui bordo interno si snoda una decorazione ad archetti trilobati, si-mile a quella dell’oculo in facciata, mentre un bordo più esterno a quadrilobi ingloba l’intera figurazione. La Vergine indossa una veste rossa, le cui maniche, originariamente decorate con motivi damascati, dovevano essere blu, come il manto che le copre la spalla sinistra. Il volto, sfortunatamente privo degli occhi e della fronte a causa di un’estesa lacuna, rivela ancora nei particolari della bocca e del naso un’esecuzione raffinata ed attenta risolta in sottili passaggi cromatici, evidenti nelle sfumature rosee delle guance e nel tocco bozzettistico e liquido delle labbra (fig. 40). La testa è ricoperta da un candido velo dal bordo appena sfran-giato, effetto ottenuto con rapidi tocchi a punta di pennello. La figura di Gesù appare più incerta, delineata da un ductus a tratti tremolante, come nel segno che ne definisce i pettorali. Cesare Verani propose, nel 1976, l’attribuzione dell’affresco a un se-guace dell’artista amatriciano Dionisio Cappelli102. La tipologia
del volto della Vergine, atteggiato in un’espressione seria e ari-stocratica, con le caratteristiche labbra rosse e il mento incavato sottolineato da una fossetta, trova diverse affinità soprattutto con gli affreschi votivi della chiesa di Santa Maria delle Grazie nei pressi di Amatrice, più nota come santuario dell’Icona Pas-satora: si veda, in particolare, la Madonna della Misericordia (1491) e la Vergine col Bambino in trono (1490 – fig. 41), dove il volto dell’infante ricorda quello di Cittaducale ma con un piglio più aristocratico e meno vitale. Il gesto della mano sinistra invece,
101 AAA, Visite pastorali, b. 1176, f. 3r (1805). Cfr. Appendice documentaria
II. 102 VERANI 1976A [ed. 2003], pp. 163-172; VERANI 1976B [ed. 2003], pp.
173-183.
SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI A CITTADUCALE
Horti Hesperidum, III, 2013, 1 185
con il pollice e l’indice avvicinati e il palmo aperto in evidenza, potrebbe giustificarsi con la presenza, in origine, di un velo tra-sparente tracciato a secco, oggi perduto; una posa analoga si ri-trova nella Vergine del Trittico di Fondi di Antoniazzo Romano (1476), a sua volta messa in relazione con la più antica Madonna col Bambino tra angeli e putti del pittore marchigiano Giovanni Boccati, oggi ad Ajaccio (1460). Qualche somiglianza tipologica si riscontra, infine, anche nelle opere di Bernardino Campilio (1491), conservate nella chiesa parrocchiale di Sant’Agata a Spelonga (Arquata del Tronto), sebbene queste figure mostrino una maggiore tendenza all’astrazione geometrica tanto nei volti quanto nei fondi oro con decorazioni damascate, realizzate con l’uso di mascheri-ne103. Nel nostro affresco, invece, la freschezza della rappresen-
tazione deriva anche dalla libertà e dalla naturalezza con cui so-no stati tracciati i girali vegetali, non paragobabili alla produzio-ne preziosa e convenzionale dei dipinti votivi dell’area umbro-laziale e marchigiana. L’opera è databile all’ultimo decennio del XV secolo. Sulla destra della Madonna del latte è un riquadro di grandi di-mensioni, al cui centro campeggia, entro una ghirlanda, il mo-nogramma CHO, da cui si diparte una croce (fig. 42): si tratta di un’abbreviazione equivalente del più comune Crismon (formato dalle lettere greche chi e ro - X e P). Il monogramma ricorre nei cicli di pitture devozionali del Rinascimento, ma questo si di-stingue per l’eleganza formale e compositiva delle lettere, carat-terizzate da linee dalla cadenza calligrafica e decorativa. Sulla parete di fondo della navata campeggiano due riquadri raf-figuranti un Santo domenicano (fig. 35) e una Madonna col Bambino (fig. 43). La prima figura, tagliata quasi per intero fino alle spal-le, è quella più compromessa dall’apertura della porta sottostan-
103 Sul Trittico di Fondi (Madonna col Bambino, i santi Pietro e Paolo e il commit-
tente Onorato II Caetani d’Aragona) cfr. scheda di Anna Cavallaro in ANTONIAZZO ROMANO. PICTOR URBIS 2013, n. 9, pp. 84-85. Su Bernardino di Campilio cfr. FRATINI 1996, p. 359.
I. ROSSI
186
te104: il volto, sdegnoso e aristocratico, è delineato da tratti mar-
cati, che definiscono forme affilate e volumi semplificati mentre sul lato destro si scorge ciò che rimane di un libro aperto. L’affresco fu realizzato prima della Madonna col Bambino: il lato destro della cornice è in parte ricoperto da un altro strato d’intonaco, steso per omologare l’inquadratura dell’immagine contigua con quella più antica. Si tratta di una campitura di co-lore grigio e rosso adiacente ad una banda con elementi geome-trici. Il motivo decorativo che inquadra il santo si ritrova in un altro frammento sulla stessa parete raffigurante in origine un santo vescovo o un diacono (fig. 44), e negli affreschi quattrocente-schi rinvenuti dietro l’abside della vicina chiesa di Santa Cecilia. I tratti espressionistici della figura fanno pensare all’opera di un artista influenzato dalla pittura marchigiana105. Se ne propone
una datazione all’ultimo ventennio del XV secolo. Nel riquadro successivo, la Vergine mostra lineamenti nitidi e delicati, mentre la purezza dei volumi è esaltata da una buona realizzazione a fresco, evidente soprattutto nell’incarnato che ha mantenuto una consistenza translucida. Il Bambino, fasciato in un panno giudaico, si impone fisicamente per le proporzioni piuttosto sovradimensionate e disarmoniche: la testa appare troppo grande rispetto al corpo e anche il braccio destro risulta sproporzionato. Il viso sembra quello di un uomo maturo, per nulla tenero e aggraziato, ma rigido e spaventato in un’espressione quanto meno anomala nel panorama della pittu-ra coeva di stampo devozionale. Le aureole dei due personaggi
104 ARSbap-Lazio, Santa Maria dei Raccomandati, Relazione 1971, p. 2: «In
fondo alla navata laterale sinistra, a lato dell’abside della navata centrale, una porta di costruzione relativamente recente, aperta in un muro di circa cm 95 di spessore, immette in un locale sotterraneo rispetto all’odierno pavimento, al quale si accede mediante una scala di legno e che è adibito a ripostiglio di roba vecchia e inutile […]». 105 Nell’opera del Maestro di Arnano, attivo nell’ultimo quarto del XV seco-
lo, si ritrovano personaggi dai volti, occhi e nasi allungati, ma il ductus lineare non appare così tagliente e affilato come in questo caso. Cfr. PITTORI A
CAMERINO NEL QUATTROCENTO 2002, pp. 402 e 405.
SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI A CITTADUCALE
Horti Hesperidum, III, 2013, 1 187
sono le più elaborate di tutta la chiesa e con decorazioni a rilie-vo: in quella della madre si notano ancora le punzonature circo-lari del bordo e i raggi interni divergenti mentre, in quella del figlio, i bracci svasati della croce e tracce di colore rosso. Lo strato grigio-bruno dei nimbi è forse imputabile all’ossidazione dello stagno utilizzato come base per la doratura a mecca. Nel complesso l’immagine doveva presentarsi, agli occhi dei devoti, curatissima fin nei minimi dettagli: uno strato d’oro ricopriva sicuramente anche il bordo superiore della veste rossa e la pic-cola stella ancora visibile sulla spalla destra della Vergine. Il co-lore, conservatosi discretamente su tutta la superficie a parte lo-cali abrasioni superficiali, ha mantenuto la sua brillantezza ori-ginaria. Lo spazio definito da drappi e veli, come già per la Ma-donna del latte e il Santo domenicano, ricorre spesso in riquadri voti-vi dell’Umbria meridionale106. L’affresco, databile all’ultimo ven-
tennio del XV secolo, è riconducibile ad un ambito umbro-laziale. Tra gli affreschi della navata destra, l’unico ad essersi conserva-to in maniera leggibile è la Crocifissione tra san Rocco e san Sebastia-no (figg. 9, 11), scoperta nel gennaio del 1971 riportando alla lu-ce una nicchia occultata per metà sotto l’altare dei santi Ignazio e Francesco Saverio e per il resto sotto la muratura di rifacimen-to107. Come nel caso della Madonna col Bambino e i Misteri del Ro-
sario, la superficie pittorica non è stata scialbata, poiché l’intonaco fu steso direttamente su un nuovo strato di muratura ruvida108. Una cornice dipinta, oggi perduta, correva lungo il pe-
106 Impaginazioni simili si ritrovano ad esempio in alcune opere della tarda
attività di Matteo da Gualdo, come quelle della chiesa di San Giovanni Batti-sta a Grello (1480-1499). Cfr. MATTEO DA GUALDO 2004, p. 187. 107 ARSbap-Lazio, Santa Maria dei Raccomandati, Relazione 1971, p. 7.
108 ARSbap-Lazio, Santa Maria dei Raccomandati, Relazione 1971, p. 7: la Berti
Bullo affermava di aver rimosso «40 cm circa di muratura formata da grossi massi e qualche pezzo di mattone e malta grossolana ma piuttosto resisten-te». Rispetto alle fotografie del 1972, l’affresco ha subito un processo di ulte-riore degrado. La superficie appariva nel 2007 completamente sbiancata, per effetto di efflorescenze saline causate dalle infiltrazioni d’acqua e dalla forte
I. ROSSI
188
rimetro esterno, mentre l’intradosso ha mantenuto la decora-zione a motivi vegetali bianchi, su fondo rosso e blu. Al centro del sottarco, entro un clipeo, campeggia ancora l’insegna latera-nense: due chiavi incrociate in campo scarlatto sovrastano l’iscrizione SS. Lateranensis Ecclesia. Cristo, il cui volto è delinea-to da tratti marcati e veloci, indossa un perizoma bianco, borda-to da un ricamo giudaico, visibile ancora nella foto del 1972. San Rocco è raffigurato imberbe, con lo sguardo severo e sup-plice allo stesso tempo e i lineamenti marcati; i consueti attributi del santo, il cappello a tese larghe, la borsa a tracolla e il bordo-ne, gli stessi indumenti che dovevano indossare i pellegrini che attraversavano la Salaria verso Roma, sono appena percepibili a causa delle numerose efflorescenze saline. Sulla gamba piegata doveva apparire la pustola, oggi scomparsa, mentre sul mantello smanicato poteva ancora scorgersi, nel 1972 (fig. 45), l’ombra di una croce greca109. Sebastiano, insieme all’angelo che volteggia
sopra la sua testa, è la figura più compromessa dal degrado. I tratti del volto delicati e regolari, l’espressione di abbandonata tristezza, fanno di questa figura il contraltare dell’altra. Sullo sfondo si apre un paesaggio dominato da un colle sovrastato da una cittadina cinta da mura e torri sul fronte verso la vallata, probabile allusione a Cittaducale. In basso, sulle estreme pro-paggini del pendio, è raffigurato un altro centro abitato, lambito da un fiume, forse il Velino: grazie ad un ingradimento della fo-to del 1972 è stato possibile scorgervi una chiesa e due torrioni
umidità. La differenza è ben percepibile confrontando le vecchie immagini con quelle attuali. Allora il chiaroscuro, più evidente, conferiva all’immagine un impatto visivo maggiore e la possibilità di una lettura stilistica meno compromessa. Erano già documentati, tuttavia, segni di ridipinture a tempe-ra nell’angelo, nella testa di Cristo, nel fondo, mentre ben conservato appari-va il paesaggio. La tamponatura in cemento, visibile ora come allora, sulla spalla sinistra di Cristo, si deve all’intervento del Genio Civile di Rieti, chia-mato a fronteggiare un grave dissesto statico della parete. Il colore rossastro del fondo corrisponde presumibilmente alla base, realizzata ad affresco, per la stesura dell’azzurrite, oramai perduta, ma visibile ancora a tratti in alto, vicino alla cornice. 109 Sull’iconografia del santo si veda MAGGIONI 2000, pp. 60-63.
SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI A CITTADUCALE
Horti Hesperidum, III, 2013, 1 189
e può darsi si tratti di una delle frazioni che si trovavano a valle. Per la contemporanea presenza di Rocco e Sebastiano, invocati in caso di pestilenze e associati in tal senso fin dalla metà del Quattrocento, l’affresco deve essere stato realizzato in occasio-ne di una grave recrudescenza del morbo110. Marchesi registra
tutte le epidemie dalla fondazione della città, ma ad una dedica una particolare attenzione, quella degli anni dell’invasione fran-cese in Italia: una parte dell’esercito presidiava allora i confini del Regno e se «Civita» non venne attaccata fu solo per la disa-strosa disfatta di Pavia, subita da Francesco I nel 1525. Alla riti-rata seguì la
peste che andava facendo gran danni per le terre del Regno, e par-ticolarmente in Civita nell’anno 1528, in cui ne morivano più di trenta al giorno […]. E di questi tempi tuttavia continuavano i tra-vagli di Civita Ducale di peste e de banditi li quali si erano scoverti in gran numero nella Valle di Corno, ove facevano infinite arrob-barie111.
La narrazione presenta, tuttavia, un’incongruenza. Il morbo è qui messo in relazione con la disfatta dei francesi, avvenuta tre anni prima. Si tratta evidentemente di un errore ed è probabile
110 San Sebastiano è trafitto ma non ucciso dalla freccia, emblema del morbo
fin dall’antichità pagana oltre che nella Bibbia, ed è quindi invocato come il primo uomo che sconfisse la peste senza che la sua giovinezza e bellezza fossero devastate. San Rocco, subentrato in un secondo tempo nella devo-zione popolare, subisce la peste ma, ritiratosi in una foresta per non diffon-dere la malattia, ne esce guarito, diventando così il simbolo della speranza nella guarigione. L’associazione tra i due santi sta quindi a scongiurare la pe-ste (san Sebastiano) e a guarirla (san Rocco). Cfr. HALL 1974, ad vocem. I due santi inginocchiati ai lati di una Madonna della Misericordia compaiono in un affresco devozionale quattrocentesco in San Domenico a Rieti. Il bino-mio iconografico è molto diffuso in Umbria nella seconda metà del XV se-colo. Si pensi agli stendardi di Benedetto Bonfigli (Gonfalone di san Francesco al Prato, 1464; Gonfalone di Civitella Benazzone, 1464-1465) e agli affreschi di Jacopo Zabolino nelle chiese di San Lorenzo ad Azzano (1488) e della Ma-donna delle Forche a Vallo di Nera (1494). Cfr. TODINI 1989. 111 MARCHESI 1592 [ED. 2004], p. 115.
I. ROSSI
190
che Marchesi faccia riferimento alla pestilenza portata dai Lan-zichenecchi in Italia in seguito al Sacco di Roma, iniziato nel maggio 1527 e protrattosi per dieci mesi. L’affresco potrebbe essere stato quindi realizzato proprio in questa occasione, in qualità di voto o ‘scudo sacro’ per invocare la cessazione del flagello nella sua fase più acuta, cui sicuramente allude il cospi-cuo numero di frecce conficcate nel corpo di Sebastiano. Dal punto di vista stilistico la composizione sembra influenzata dal-lo stile dei fratelli Lorenzo e Bartolomeo Torresani, attivi in Sa-bina tra la prima e la seconda metà del Cinquecento e il cui stile risultava aggiornato sui nuovi modelli romani ed umbri, dal Si-gnorelli di Orvieto al Michelangelo e al Raffaello del Vaticano. L’affresco può essere quindi riferito ad un pittore locale in-fluenzato dalla loro maniera. La composizione, aperta su di un ampio paesaggio collinare, ritorna in opere autografe o attribui-te ai due veronesi, come nella Deposizione dalla croce in San Fran-cesco a Rieti, attribuita a Lorenzo (secondo quarto del XVI se-colo) mentre negli affreschi della chiesa di San Paolo a Poggio Mirteto (1521), le tipologie dei volti, con marcate ombre intor-no agli occhi e labbra carnose messe in risalto da un chiaroscuro deciso, mostrano una certa consonanza con la figura del San Rocco112. Il motivo iconografico del Crocifisso tra una coppia o
gruppi di santi è molto diffuso in tutto il Lazio settentrionale tra il secondo e terzo quarto del XVI secolo, in forme più o meno stereotipate: si ritrova, ad esempio, sia nella vicina località di Canetra (chiesa di San Sebastiano) sia in Sant’Egidio a Corchia-
112 I Torresani sono documentati per la prima volta in Sabina a Poggio Mir-
teto (1521), cfr. VERANI 1953, VERANI 2003, pp. 253-255. Attivi a Rieti nel 1525, gli artisti lavorarono in seguito nella chiesa di Santa Maria del Popolo a Santa Rufina (Morte e Assunzione della Vergine e Sant’Antonio Abate tra san Mar-tino e san Sebastiano). Cfr. SACCHETTI SASSETTI 1932 [ed. 2003], TOZZI 1988, pp. 24-36. Nel 1548 la loro presenza è attestata a Cittaducale, dove eseguono l’affresco della lunetta del portale di Sant’Agostino. Cfr. CANTONE 1990A, pp. 102-110. La bottega dei Torresani continuò ad operare nella zona, non-ché nel Lazio settentrionale (Corchiano, Fabrica di Roma) e nell’Umbria me-ridionale (Narni), cfr. TIBERIA 1996, pp. 383-426.
SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI A CITTADUCALE
Horti Hesperidum, III, 2013, 1 191
no (1560 ca., fig. 46), nel viterbese, dove l’attribuzione oscilla tra Bartolomeo e Alessandro e Piefrancesco Torresani113.
Alcuni brani di affreschi, per le loro condizioni conservative difficilmente databili ma, con ogni probabilità, riconducibili tutti al XV secolo, concludono il panorama decorativo della chiesa. Il modesto San Francesco (fig. 47) ormai quasi completamente perduto e reso illeggibile dalle iniezioni di cemento, si trova nell’ultima campata dall’entrata, accanto ad una nicchia a sesto ribassato aperta a ridosso della semicolonna ottagonale verosi-milmente nel XVI secolo. Le decorazioni dei montanti sono ascrivibili a una fase successiva, durante la quale la figura fu ri-coperta da un ornato a girali bianchi su fondo rosso. Una netta e scura linea di contorno definisce il santo, rappresentato stante su di un pavimento grigio rozzamente scorciato in cui tratti tremolanti definiscono in modo sommario le venature del marmo. Il crocifisso e le stimmate sui piedi permettono di iden-tificarlo come Francesco. L’iscrizione che corre lungo il margine inferiore, mutila e deteriorata, recita «[A]GOSTI[…]F […]DE M. PORTO» ed è forse da mettere in relazione con il committente (fig. 48). Il frammento di una Madonna col Bambino (fig. 49), nelle mede-sime condizioni del precedente, presenta una lacuna in corri-spondenza della parte inferiore dei volti, mentre conserva la mano di Cristo alzata in segno di benedizione. Il gruppo è col-locato entro uno spazio basso e ristretto, definito da un’architettura incerta, di cui s’intravedono i riquadri geometrici del soffitto. Ciò che ne rimane è troppo esiguo per proporre se-ri raffronti che, laddove esistessero, non supererebbero comun-que i confini di un ambito popolaresco e devozionale e una da-
113 Cfr. RUSSO, SANTARELLI 1999 e ANDREA 2003, pp. 16-27. Altre affinità
si rilevano nella Crocifissione della chiesa dei Santi Martiri di Cerchiara, vicino Rieti, attribuita ad Alessandro o negli affreschi in San Silvestro papa a Falerii riferiti a Lorenzo (1556). Il tipo del Cristo è lo stesso ma le proporzioni della figura di Cittaducale sono meno slanciate mentre l’aureola, non scorciata, definisce un semplice ritaglio geometrico intorno alla testa. cfr. VERANI
1962, p. 8.
I. ROSSI
192
tazione al XV secolo. Alla stessa bottega può forse essere attri-buito, per via dell’identica decorazione a crocette grigio-verdi della cornice (sebbene questo motivo sia diffusissimo nei dipinti devozionali della zona compresa tra la Valle Reatina, l’Umbria meridionale e le Marche)114, un altro brano sulla parete di fondo
della navata destra che mostra la parte inferiore di una figura alata in movimento, parte di una perduta Annunciazione (fig. 50).
114 Nella stessa Cittaducale compare, ad esempio, in un affresco mutilo e più
volte ridipinto raffigurante San Sebastiano, nella chiesa di Santa Maria di Se-sto; nella zona, nelle già citate opere di Bernardino Campilio conservate nella parrocchiale di Sant’Agata a Spelonga (Arquata del Tronto).
SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI A CITTADUCALE
Horti Hesperidum, III, 2013, 1 193
Appendice documentaria I Si trascrive il testo in latino della Collatio del 1450, pubblicata e tradot-ta dalla Berti Bullo nel 1973.
COLLATIO HOMINIBUS FRATERNITATIS HOSPITALIS ECCLESIAE SUB VOCABULO SANCTAE MARIAE DE
RECOMMENDATIS CIVITATIS DUCATE Capitolum et Conventus Sacrosanctae Lateranensis Ecclesiae Canoni-corum Regolarium Beati Augustini Congregationis Salvatoris eiusdem Lateranensis Ecclesiae dilectis nobis in Christo hominibus fraternita-tis hospitalis et Ecclesiae sub vocabulo Sanctae Mariae de Recom-mendatis terrae Civitatis Ducate (sic) Reatinae diocesis praesentibus et futuris nobis et sacrosanctae Lateranensis Ecclesiae immediate su-biectis salutem in eo qui est omnium vera salus. Laudabilia vestrum probitatum et virtutum merita quibus apud nos fide digno commen-damini testimonio nos excitant inducunt ut personas vestras benigno favore prosequamur. Hinc est quod cum constat nobis hominibus ut Universitati dictae terrae Civitatis ducate fuisse et esse indultum per nonnulos in dicta nostra Lateranensi Ecclesia antecessores quoddam privilegium fundandi et edificandi quoddam hospitale et Ecclesiam sub vocabolo Sanctae Mariae de Recommendatis positam intus ter-ram Civitatis Ducate praedictae in quodam caseleno dictae nostrae lateranensis Ecclesiae, cuius quidam privilegii tenor de verbo ad ver-bum per omnia talis est. Capitolium et Canonici Sacrosanctae La-teranensis Ecclesiae, dilectis nobis in Cristo hominibus et Universita-ti terrae Civitatis ducatae Reatinae diocesis etc. dictoque privilegio per nos viso et coram nobis exibito et producto, Nos enim votis vestris in hac parte favorabiliter anuentes volentes igitur praemissorum merito-rum vestrorum intuitu vobis gratiam facere specialem dictam Eccle-siam et Hospitale praefatum sub vocabulo Sanctae Mariae de Re-commendatis dictae terrae et civitatis praedictae ut praefertur vobis concessae et collatae omni modo, via, iure et forma quibus melius possumus et debemus, cum omnibus et singulis indulgentiis, immuni-tatibus exentionibus, iuribus, pertinentiis, responsionibus et censu praedictis et aliis prout in eodem continetur tenore presentium accep-tamus ratificamus emologamus et de novo vobis iam dictis hominibus fraternitatis praedictae concedimus atque conferimus et de illis iam dictis hominibus fraternitatis praedictae etiam providemus dictum privilegium eorundem concessum. In quorum omnium fidem et
I. ROSSI
194
testium praemissorum has nostras presentes litteras seu privilegium vobis fieri mandavimus per infrascriptum Antonium Ludovicum no-tarium et scribam nostrum et dicti conventus ipsumque iupsimus nos-tri magni capitularis sigilli apprensione muniri. Datum Romae in loco capitulari dictae nostrae lateranensis Ecclesiae die tertio mensis aprilis tredicesima inditione sub anno Domini millesimo quadrigentesimo quinquagesimo Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris et Domini Nicolaii divina providentia Papae Quinti. Appendice documentaria II L’Aquila, Archivio Arcidiocesano Nella trascrizione dei documenti si è scelto di sciogliere le numerosis-sime abbreviazioni, relative soprattutto al testo latino. Per maggiore leggibilità si è preferito non indicare gli scioglimenti tra parentesi ton-de, utilizzate solo laddove le parole non sono state univocamente in-terpretate. Le parentesi quadre indicano, nelle visite pastorali in latino, le lacune nel testo; in quelle in italiano, le parti non trascritte. Visite pastorali 30 novembre 1682 Vescovo Francesco De Giangirolami Busta 1125, ff. 161v, 162v-r. Feria 2a die 30 mensis novembris 1682 De Ecclesia Sanctae Mariae Virginis de Raccomandatis vulgo ‘La Fra-ternita’. Illustrissimus Dominus Episcopus post vespertinas horas una mecum accessit ad dictam Ecclesiam Sanctae Mariae de Raccomandatis intus civitatem unitam Seminario, et facta oratione et absolutione mortuo-rum. Visitavit altare majus Imaginibus Beatae Mariae Virginis de Racco-mandatis, et Sancti Francisci et Dominici in muro pintis [rurali]ter provisum. Adest Societas cum usu sacci sub eodem titulo Beatae Mariae Virginis de Raccomandatis.
SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI A CITTADUCALE
Horti Hesperidum, III, 2013, 1 195
Exponitur in dicto altari Sanctissimum Sacramentum in die Sanctis-simae Nativitatis et celebra(tur) in [sin]gulis diebus dominicis et festis […] piarum personarum cuius Cappellanus est Reverendus Dominus (Johannis) Pisanus. Adest alius Cappellanus Reverendus Dominus Bellisarius Lambri-celus, qui tene(t) celebrar(i) ut supra in oratorio Sancti Hieronimi. Officiales sunt clericus Appollonius Palumbus, et Lucas Lambricelius. Visitavit altare Sanctissimae Annunciationis in navi (sinistri) peritus denudatus jussit provideri de (omnibus) necessaris expensis Gentilis Innocentii Illustris Doctoris Virgilii Vetuli. Visitavit [altare] Sanctissimae Nativitatis (ruraliter) provisum. Visitavit altare Beatae Mariae Virginis in alia navi a cornu epistolae Abs. (ma.) cum Icona Beatae Mariae Virginis in muro picta peritus denudatum quod suspensum donec provideatur de necessariis. Ecclesia ipsa est (consecrata) et habet tres navatas, media (or)nata, et picta cum pavimento (santo) ex laboribus (urbis), et mandavit reaptari ubi (coget). Habet 7 sepulchra defunctorum. Mandavit provideri de stola violacei coloris. In dicta Ecclesia adest beneficium simplex sub titulo Sancti Petri in Malvasia rurale quod fuit translatum ab Ecclesia diruta Sancti Petri in Malvasia in Turre Petrella seu Portella, quod beneficium est divisum inter duos Rectores pro medietatem. Rectores sunt admodum Re-verendus Dominus Canonicus Paganus et Reverendus Dominus Jo-seph Paulessi. Pars dimidia dicti benefici est iurispatronatus Illustris Domini de Pa-ganis, et altera medietas iurispatronatus de Paulessi her(edes) De Mi-cherris, et illorum de Spinosis. Adest in dicta Ecclesia beneficium Sancti Josephi iurispatronatus de Magnante cum onere sex missarum quolibet anno fratres sunt qua-tuor. Rector est Reverendus Dominus Thomas Cherubinus. Adest beneficius simplex Clericatus nuncupatus quod fuit translatum ab Ecclesia diruta, et rurali Sancti Angeli Lauriani, fratres sunt trium circiter cuis Rector est admodum Reverendo Domino Canonico Jo-seph Rosellus. Dictus Canonicus Paganus habet beneficium Sanctae Crucis in Pan-zano, et Beneficium Sancti Laurerentii Sambuci Ecclesiae ruralis et dirutae.
I. ROSSI
196
4 settembre 1687 Vescovo Filippo Tani Busta 1293, ff. 191r-195r (nuova foliazione 99r-101v). Feria quinta die 4 septembris 1687 Illustrissimus Dominus Episcopus de more prosequens visitiationem accessit ad Ecclesiam Sanctae Marie de Raccomandatis vulgo La Fra-ternita intus Civitatem unita seminario et facta oratione et absolutione mortuorum. Visitavit altare maius competenter provisum. Adest Societas cum usu sacci sub eodem titulo Beatae Mariae Virginis de Raccomandatis. Adsunt duo Cappellani amonibiles ut alter ipsorum inserviat et cele-bret in hac Ecclesia omnibus diebus festis de praecepto, in die tertio Paschatis Resurrectionis quo die etiam ibidem fit officium solemne ac celebratur missa cantata et etiam in die Sancti Rocchi in quo pariter celebratur missa cantata. Alter Cappellanus inservit et celebrat pariter omnibus diebus festis in Oratorio Sancti Hyeronimi quod est unitum huic Ecclesiae. Officiales dictae Ecclesiae Sanctae Marie de Raccomandatis et etiam Confraternitatis eiusdem tituli, sunt de praesenti Johannes Paulus (J)annocchius et Franciscus Germanus. Visitavit Altare Sanctissimae Annuniciationis, primum a latere Evan-gelii peritus denudatus familiae quondam de Vetulis et praecipue quondam Doctoris Virgilii Vetuli et quia in visitatione episcopi Valen-tini de anno 1681 fuit decretum ut provideretur de omnibus necessa-riis ad celebrandum et in convenientem formam dictum altarem ap-taretur expensis heredum quondam supradicti Doctoris Virgilii Vetuli alias (nisi infra annum hoc fieret) dictum altare liberum esset dictae Ecclesiae et Societatis. Idcirco Illustrissimus Dominus Episcopus renovavit et confirmavit dictum decretum et iussit intimari Victoriae Ricci heredi, et nepoti dicti Doctoris Virgilii, ut infra annum provideat ut supra, alias omne jus amittat in dictum altare et praedictum jus devolvatur in praedic-tam Ecclesiam et Sociatetem, quae tunc teneatur ipsa de praedictis necessaris providere. Visitavit Altare Nativitatis ruraliter provisum. Mandavit provideri de ultima, (lisa) inferiori tobalea, et lapidem sacrum tela cerata cooperiri, et ad faciem celebrantis (trahi) competenter, et in candelabris apponi cuspides, crucemque in medio altaris magis elevari, et fasciam ligneam pariter apponi ad pedes celebrantis in scabello suppedaneo.
SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI A CITTADUCALE
Horti Hesperidum, III, 2013, 1 197
Visitavit Altare Sanctissimi Rosarii ultimum a latere Evangelii pariter denudatum et sine lapide sacro, ubi non celebratur, quod Dominatio Sua Illustrissima etiam suspendi donec de omnibus necessaris provi-deatur. Visitavit altare Beatae Mariae Virginis primum in cornu epistolae quod fuit suspensum in praecedenti visitatione ab Episcopo de Gian-girolamis eo quod careavet omnibus necessariis ad celebrandum. Illustrissimus Dominus Episcopus confirmavit suspensionem prae-dictam donec. Visitavit altarem secundum in eodem navi in quo pro icone adest vexillum Beatae Virginis ut aiunt del Confalone. Et quia in dicto altari adest lapis sacer amonibilis valde exiguus man-davit provideri de aliquo lapide sacro maiori et in altari quod totum de petra est incastrari, vel lepidem sacrum ab alio altari in eodem late-re epistolae ut supra suspenso removeri in dicto, et hac transferri, et decenter aptari, cum altare praedictum suspensum sit totum in mar-more consecratum. Mandavit provideri etiam de duabus tobaleis, de candelabris, et tabella ultimi Evangelii et apponi fasciam ligneam ad pedes celebrantis. Asserunt Officiales in dicto altari non celebrari nisi in die Nativitatis Domini Nostri Jesu Christi et festarum sequentium. Et quia praedictum vexillum valde vetustum amplius non circum-fectur, et pictura est valde pulcra mandavit apponi diligenter in aliquo telari, ut decentius inservire possit pro icone altaris praedicti. In visitatione praedecessoris Episcopi de Giangirolamis describuntur nonnulla beneficia translata ab Ecclesis dirutis in hanc Sanctae Mariae de’ Raccomandatis. Nempe benefiucium simplex sub titulo Sancti Petri in Malvasia Ec-clesiae dirutae eiusdem Sancti Petri in Terr.o Petrellae seu portellae quod beneficium est divisum inter duos Rectores pro medietate nem-pe inter Canonicum Costantinum de Paganis et Josephus Paulesse. Item aliud beneficium sub titulo Sancti Josephi iurispatronatus De Magnantibus cum onere sex missarum quolibet anno fructus scuto-rum quatuor circiter, Rector est Reverendus Dominus Thomas Che-rubinus qui asserit propria conscientia dicto oneri missarum satisfe-cisse et satisfacere. Item aliud beneficium simplex Clericus nuncupatus quod fuit transla-tum ab ecclesia diruta et rurali Sancti Angeli Lauriani fructus scuto-rum trium circiter, cuius Rector est Reverendus Dominus Canonicus Josephus Rosellus, qui nuper idem beneficium renunciavit canonice et (sponte) datariam nepoti suo clerico Johanni Francisco Travaglino. Recognoscenda sunt Acta praedicta Visitationis, ubi alia nonnulla.
I. ROSSI
198
Quo ad corpus Ecclesiae. Mandavit lapides sepulcrales circum circa qu. (a)ptari. Quo ad supellectilem sacram. Mandavit pro planeta violacei coloris provideri de manipulo decentiori, et alias planetas reaptari ubi opus est, et etiam provideri de missis ut aiunt Sanctum recentiorum, et etiam de velo omnium colorum. Et quia, ut dictum est, in dicta Ecclesia adest Societas sub titulo Sanc-tae Mariae de Raccomandatis. Ideo Illustrissimus Dominus mandavit ut Officiales praesentes dictae Confraternitatis afferant libros introi-tus, et exitus, rationemque reddant eorum administrationis, quod etiam quia multis ab hinc annis praestituorum non fuit ab officialibus praesentis nempe ab annis quindecim circiter, ideo mandavit etiam eosdem citari ad hoc ut pariter rationem reddant administrationis eo-rum suo loco et tempore sub poenis et censuris arbitratu. 3 luglio 1693 Vescovo Filippo Tani Busta 1293, pp. 31-32 (nuova foliazione p. 219 r/v). Die 3 Julii 1693, feria sexta Illustrissimus Dominus Episcopus prosequens visitationem Civitatis convitatus et accessit ad Ecclesiam Sanctae Mariae de Raccomandatis vulgo La Fraternita intra Civitatem, et praemissis ad Deum precibus ante Altare maius, et absolutione fidelium defunctorumque, Visitavit Altare majus competenter provisum, in quo lapis sacer complectitur seu superpositus est in toto dicti altari. Debet provideri de umbello, ac de tela cerata p(rout) ex precedentibus visitationibus ad quas (…). Visitavit altare Sanctissimae Annunciationis primum a latere Evangeli peritus denudatum, in quo nullatenus celebra(tum). Stetit in decretis praecedentium suorum visitationum, quae debebunt intimari. Visitavit altare Nativitatis Domini Nostri Jesu Christi ruraliter provi-sum. Mandavit inferiores mappas diligenter mundari, fasciam ligneam poni ad pedes celebrantis et omnia sumptibus Societatis dictae Eccle-siae. Visitavit altare Sanctissimi Rosarii ultimum a latere Evangelii est de omnibus denudatus est etiam suspensum. Visitavit altare Beatae Mariae Virginis primum in cornu Epistolae quod caret omnibus necessaris ad celebrandum; et est suspensum. Visitavit altare 2 in eodem navi in quo pro Icone adest Vexillum Bea-tae Mariae Virginis ut aiunt del Confalone ruraliter provisum, facta diligentia fuit repertum lapidem dicto altari (super)impositum totum
SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI A CITTADUCALE
Horti Hesperidum, III, 2013, 1 199
esse consecratum ut pate(a)t ex operculo Sacrarum Reliquiarum, et ex crucibus lateralibus in dicto lapide incisus. Per (errorem?) autem et in adu(….)iam fuit in precedentibus visitationibus a Cappellano seu Prioribus dictae Ecclesiae (super) impositus alius lapis sacer exiguus et in quadam tabula inclusus, quem iussit ulterius super dictum altare non apponi. Mandavit mappas diligenter mundari stetique in decretis. In dicto altari (pra)eter non nulla beneficia simplicia in precedentibus visitationibus descripta sed sine expressione alicuius oneris missarum adest beneficium sub titulo Josephi cum onere seu missarum quolibet anno cuius Rector cum sit Reverendus Dominus Thomas Cherubinus nunc degens in Civitate Aquilae debet ab eo inquiri an dicto onere (spolium?) satisfecerit. Quo ad corpus Ecclesiae mandavit ubi opus est pavimentum reaptari, et provideri de feretro pro deferendis cadaveribus sumptibus dictae Societatis. Visitavit Sacristiam. Mandavit provideri de planeta, manipulo, et stola nigri coloris, vel violacei alias vero reaptari praesertim duas planetas vetustiores ambas ut aiunt vulgo di capicciola sumptibus dictae Socie-tatis. Mandavit etiam a Prioribus reddi computa introitus, et exitus infra sex menses et omnia praedicta sub penis arbitrio et recognosci debent visitationes praecedentes ad quas. 6 settembre 1745 Vescovo Nicola Maria Calcagnini Busta 1110, ff. 25r/v, 26r/v (nuova foliazione 29r/v, 30r/v). De Ecclesia Beate Mariae Virginis de Raccomandatis vulgo ‘La Fra-ternita’ Eadem die 6a 7mbris Illustrissimus et Reverendissimus Dominus as-sociatus ut supra pervenit ad dictam Ecclesiam Beatae Mariae Virginis de Raccomndatis nuncupatam ‘La Fraternita’, et facta oratione, et ab-solutione defuntctorum de more devenit ad infrascriptam visitatio-nem, et primo visitavit altare maius, quod habet pro Icona Imaginem Beatae Mariae Virginis de Raccomandatis, et Sancti Francisci et Do-minici, quod invenit competenter provisum. In dicto altari adest onus celebrandi singulis diebus festivis de prae-cepto, et dominicis et faciendi unum officium in anno, nempe canen-di primas vesperas in feria secunda post Pascha; et missam cum cantu in feria tertia Paschatis una cum quatuor missis lectis. Aliud onus habet in Festo Sancti Rocci, (videlicet) unius missae cum cantu, et quatuor missarum lectarum.
I. ROSSI
200
Aliud demum onus habet celebrari faciendi missam unam cum cantu in Ecclesia Sancti Jeronimi, quae onera satisfacienda sunt per Cappel-lanum Confraternitatis, quae reperitur erecta in dicta Ecclesia usu sac-ci cerulei coloris, eiusque Camerarius ad praesens est clericus Carolus Bonafaccia, Cappellanus eiusdem Confraternitatis ad praesens est Re-verendus Joseph Pirrotti. In dicta Ecclesia exponitur Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum spatio quadraginta horarum in die Nativitatis Domini Nostri Jesu Xri-sti. Visitavit Altare sub invocatione Nativitatis Domini Nostri Jesu Xristi ad dictam Confraternitatem spectans, et mandavit provideri de tela cerata supra lapidem sacrum. Adest in dicto altari beneficium simplex cum onere sex missarum in anno, et Rector ad praesens est Reverendus Dominus Canonicus Dionisius Berrettini Iurispatronatus de Magnante. Adest aliud beneficium simplex Clericatus nuncupatum absque ullo onere, quod possidet(us) a Reverendo Canonico Joanne Francisco Travaglini. Insuper adest aliud beneficium simplex sub titulo Sancti Petri in Mal-vasia, translatum ab ecclesia diruta Sancti Petri in Malvasia in loco ubi dicitus Pretella seu Portella iurispatronatus de Paolessi absque ullo onere, et Rector ad presens est Reverendus Dominus Carolus Paoles-si. Visitavit altare in cornu Epistolae altaris maioris sub titulo Beatae Ma-riae Virginis, quod altare spectat ad Congregationem Artificum erec-tam a Venerabile Padre Baldinucci. In dicto altari adest onus cele-brandi duas missas pro anima quondam Josephi Tiberti. Celebratus pariter in eodem altari missa singulis diebus dominiciis, et festiviis de praecepto sumptibus et elemosinis dictae Congregationis per Reve-rendum Jeronimum Travaglini Cappellanum. Visitavit paramenta sacra, et mandavit provideri de burza, et velo sive supracalice (tr)ium colorum. 13 maggio 1793 Vescovo di Cittaducale Pasquale Martini; canonico Filippo Antonio Giraldi Busta 1373, f. 9r. De Ecclesia Sanctae Mariae de Raccomandatis Eadem retroscripta die tertiadecima mensis maii 1793. Completa visi-tatione Ecclesiae Sancti Joannis Baptistae mox se contulit ad alteram
SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI A CITTADUCALE
Horti Hesperidum, III, 2013, 1 201
Sanctae Mariae noncupatae de Raccomandatis, fuitque exceptus a Re-verendo Canonico Domino Philippo Antonio Giraldi, in qua brevi oravit ac peracta de mandato per eundem Reverendum Canonicum mortuorum absolutione. Visitavit altare majus Beatissimae Virgini Mariae dicatum et laudavit. Visitavit altare Nativitatis Domini Nostri Jesu Christi et mandavit provideri de novis tabulis cum coronis auro linitis pro cartis Canonis, in principio, et lavabo. Visitavit Altare SS. Ignatio, et Francisco Xaverio, sacris quod ornati-bus sufficienter instructum inspexit. Deide accessit ad Sacrarium quod sacris suppellectibus invenit bene provisum. Iussit Magistro Priori ut conficiat inventarium omnium rerum mobi-lium, et immobilia, anuorumque reditum ad Ecclesiam spectantium. Duae institutae reperiebantur Confraternitates in hac Ecclesia, quae postea unitae fuerunt ab M. Episcopo Calcagnini; uniti quoque amba-rum reditus, et a Praefecto, et Depositario Confraternitatis, qui quot annis per secreta suffragia eliguntur, admisnistrantur. 10 maggio 1805 Vescovo di Cittaducale Emanuele Ceciri; canonico Domenico Gian-nantoni Busta 1176, f. 3r. De Ecclesia Beatissimae Virginis Mariae de Raccomandatis vulgo La Fraternita Civitatis Ducalis. Die decima mensis Maii 1805 Reverendissimus Dominus comitatus ut supra ac admodum Reverendo Domino Canonico Dominico Giannantonii, meque hora fere decima quinta ad Ecclesiam Sanctae Mariae de Raccomandatis perexit, ibique in ingressu ianuae praesto fuit admodum Reverendus Canonicus Nicolaus Giraldi Cappellanus cum Magistro Domino Domenico Costantini dictae Ecclesie Praefec-to et facta brevi oratione, de more similiter peracta mortuorum abso-lutione. Visitavit altare majus, quod bene retentum invenit et laudavit. In dicto altari adest effigies Beatissimae Virginis Mariae de Raccomandatis in tela depicta simul cum Icone Sancti Dominici et Sancti Erasmi. Visitavit pariter altare sub invocatione Nativitatis Domini Nostri Jesu Xristi, et competenter ornatum invenit, hortatus est, si potest fieri, ut umiditatem ex illo removeret dictus Prefectus.
I. ROSSI
202
Visitavit item aliud altare in cornu Epistolae sub titulo Beatissimae Virginis, S(anctorum) Ignatii, et Francisci Xaverii, quod mediocriter praeparatum invenit. Accessit ad Sacrarium, et de omnibus ad sacrificium necessariis prae-paratum invenit. His peractis: oravit parumper et ad suas (Ecclesias) redivit. 5 ottobre 1832 Vescovo Girolamo Manieri Busta 1124, pp. 13-14 (foliazione recente f. 86r/v) Pro Ecclesia Sancte Mariae de Raccomandatis. Illustrissimus et Reverendissimus Dominus Episcopus una cum suis proefatis convisitatoribus ad Ecclesiam Sanctae Mariae de Racco-mandatis die 5a dicti mensis accessit et sacro peracto ac elargita popu-lo Indulgentia 40 dierum, nec non expletis consuetis precibus pro animabus defunctorum concionem habuit, et puellos et puellas sacro linivit chrismate. Deinde visitavit altaria, et suppelletilia, et iussit pro-videri altaria lateralia de tobaleis et duas casulas designatas restaurari coetaera probavit ac laudavit. In hac Ecclesia adest erecta sodalitas sub titulo Sanctae Mariae de Raccomandatis, et singulis festis eius confratres ad preces effunden-das congregantur. Sumptibus eiusdem Sodalitatis ad implenda sunt sequentia pia legata. Pro q.m Josepho Tiberti missae duae = pro q.m Joanne Cecini missae duae = pro Laureto Senesi missae due = pro q.m Margarita Quirini missa una = pro q.m Francisco Leonardi missae sex = pro q.m Bar-tholomeo Ceciri missae tres = pro q.m carlo Costantini missae duae = pro q.m Antonio Spinelli calabrese missa una = pro q.m Antonio Anibaldi et Christina Allegri missae quatuor = pro q.m Francisco Scorretti missae duae = pro q.m Armando Felice Gioia missae qua-tuor = pro q.m Eleuterio Caroselli missa una, et rosarium unun infra annum = pro q.m Angelo Giraldi missa una in precibus 40 horarum ad honorem Purificationis Beatae Mariae Virginis, et Rosarium reci-tandum ad omnibus confratibus die 13 decembris anniversaria obitus ipsius Giraldi = pro q.m Octavio d’Antono missae duodecim quarum septem in proecipuis festivitatibus Beatae Mariae Virginis; una in fe-sto Sancti Antonii Abbatis 17 Januarii, et quatuor in supradictis preci-bus quadraginta horarum ac tandem rosarium recitandum ad omnibus fratribus = pro q.m Christina Santilli missae duae, et unum rosarium = pro q.m Mazzilli vesperas cum assistentibus in feria 2a post Pascha,
SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI A CITTADUCALE
Horti Hesperidum, III, 2013, 1 203
et in 3a sequenti missae tres lectae et una cum cantu = pro q.m eo-dem Mazzilli missa una cantata cum primis vesperis et missae duae lectae die 16 augusti = pro q.m Bernarda d’Antono missae tres quarum una die 2 augusti et aliae in precibus 40 horarum. In festo Sancti Hieronimi missa una cum cantu = missae tres lectae quarum prima in Nativitate Domini Nostri Jesu Christi; secunda in Circumcisione eiusdem, et tertia in eius Epifania. 1842 Vescovo Girolamo Manieri. Visita eseguita da monsignor Filippo de Conti Curoli Busta 879/2, pp. 166-167. Chiesa di Santa Maria dei Raccomandati Questa chiesa è a volta, ed ha tre altari; il maggiore sacro alla Madon-na della Purificazione, quello a cornu Evangeli alla Natività di Nostro Signore e l’altro a Sant’Ignazio, e a San Francesco Saverio. Vi è la congregazione degli Artisti che vi Recita il Rosario in tutte le feste di doppio precetto. Tiene un cappellano per la messa, e per la confes-sione. Ha fondi ma vi è lo stato discusso. Ha pesi di messe 40 lette, e 3 cantate, e si sodisfano dal Cappellano signor Canonico Don Ales-sandro Falconi, il quale inoltre è tenuto ad applicare pei fratelli vivi, e defonti in tutte le Feste di doppio precetto, e dei Santi Protettori, che sono Sant’Ignazio e San Francesco Saverio. Questa chiesa è provista competentemente di arredi. 22 luglio 1853 Vescovo Luigi Filippi Busta 879/3, ff. 10v-11r/v. Chiesa di Santa Maria dei Raccomandati. L’Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor Vescovo unitamente ai Convisitatori ed altri di sua compagnia dopo la visita della Chiesa di San Francesco si portò nella Chiesa di Santa Maria dei Raccomandati, ove dopo aver pregato come a solito, visitò l’Altare maggiore sacro alla Madonna della Purificazione e lo approvò. Sospese poi l’Altare sotto il titolo della Natività, perché grondante di acqua nelle pareti. Quindi dichiarò interdetto l’altare che è a lato dell’Epistola, sacro a Sant’Ignazio e San Francesco Saverio, fino a che non si apponesse novella pietra sacra. Ordinò ancora che il quadro posto a sinistra della porta d’ingresso si ponesse provvisoriamente a piedi la Chiesa appun-
I. ROSSI
204
to per liberarlo dall’umidità. Nella Chiesa di cui è parola vi è eretta la Congregazione degli artisti, la quale tutti i giorni festivi si riunisce per la recita del Santo Rosario; e per la Messa e Confessione tiene pure un Cappellano che attualmente è il Canonico Don Alessandro Falconi; il quale è tenuto ad applicare per i seguenti legati, cioè: 1° Annue messe due per fu Giuseppe Tiberti. 2° Messe due pel q.m Giovanni Ceciri. 3° Messe due per fu Lorenzo Senese. 4° Messa una per la q.m Margarita Quirini. 5° Messe due pel fu Carlo Costantini. 6° messa una per Antonio Spinetti Calabrese. 7°. Messe quattro per le anime dei q.m Antonio Anibaldi e Cristina Allegri. 8° Messe due per Francesco Scorretti, 9° Messa una per q.m Eleuterio Caroselli, 10° Messa una nel giorno del 2 febbraio pel q.m Angelo Giraldi. 11° Mes-se due per Cristina Santilli. 12° Messe tre per q.m Bernardino Danto-no, delle quali una deve applicarsi a 2 Agosto, due poi nelle 40 ore della Purificazione. I suddetti Legati poi costa essersi fedelmente adempiti fino al corrente anno 1853. Non così però e a dirsi dei Lega-ti seguenti, dei quali costa l’adempimento in parte, e però se ne ordina il ripiano non facendosi trascorrere più del mese per la totale soddi-sfazione; cioè: 1° Per il legato di Messe dieci che si celebrano per i de-funti fratelli e sorelle, come apparisce dal registro presentato, manca-no Messe 56. 2° Per il legato di messe sei pel q.m Francesco Leonar-di, a compimento del corrente anno, manca una messa. 3°. Per il lega-to di messe tre per Bartolomeo Ceciri mancano due messe nel 1847. 4° Per il legato di messe quattro per Amando Felice Gioia mancano messe tre negli anni 1844 e 1846. 5° Per il legato di messe dodici per Ottavio Dantono manca una messa nel 1852; e contemporaneamente s’impone di celebrare le suddette medesime nei giorni prescritti, e come risulta dai Registri. 6° per il legato di una messa cantata e tre lette nel Martedì di Pasqua, obbligo di Mazzilli, costa essersi adempito fino al 1841 a sole messe tre lette. Quindi si ordina celebrare tutte le messe cantate e le lette già trascurate, e riponersi in corrente nello spazio di sei mesi. 7° Per il legato di una messa Cantata nel giorno di San Girolamo che si trova adempito a tutto il 1822 e nell’anno 1836, si ordina ripianare l’atrasso dentro sei mesi. 8° Per il legato di messe tre nei giorni di Natale, primo dell’anno, ed epifania, che si trovano esattamente adempite dal 1840 al 1853, si ordina ripianare l’atrasso fino al 1839. 9° Per il legato di una messa a 25 Aprile per il q.m Pa-squale Tiberti, perché si è adempito ne’ soli anni 1833, 1851, 1852 e 1853 s’ingiunge rimettere le trascurate applicazioni nello spazio di sei mesi.
SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI A CITTADUCALE
Horti Hesperidum, III, 2013, 1 205
Finalmente per l’esatto adempimento de’ suddetti legati, non meno che degli altri, si ordina un Libro regolare di registro e bene intestato. S’ingiunge ancora alla Congrega medesima di regolarizzare il libro del-le prestazioni de’ fratelli e sorelle; di adempire subito alle messe dieci a morte de’ Congregati; e perciò si prelevi di anno in anno dalle ele-mosine raccolte una somma che dovrà rimanere in una cassa triclave a formare un monte de’ Morti. 19 luglio 1875 Vescovo Luigi Filippi Busta 1415, pp. 88-91. Senza perder via l’Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor Vescovo si recò nella chiesa di Santa Maria dei Raccomandati ove ricevuto alla porta dal Cappellano Signor Don Antonio Vetuli e fatta breve ora-zione innanzi al Santissimo Sacramento, che ivi si conserva in occa-sione della novena di Sant’Anna, incominciò a visitarla. In questa chiesa è eretta la confraternita degli Artisti dove questi si riuniscono tutti i giorni festivi per la recita del Santo Rosario, per la Messa e per pratticarvi gli atti di Religione. L’Illustrissimo prelato visitò la custo-dia, e la sfera contenutavi coll’ostia consacrata. E trovò tutto a lodare, specialmente la ripetuta sfera di argento fatta lavorare di recente dal passato Prefetto della Congregazione Signor Angelo Giacomelli ed Assistenti che son venuti raccogliendo per questo le volontarie obla-zioni dei fedeli. Visitò gli altri due Altari che trovò decenti ed ornati competentemen-te come comporta la piccola Chiesa che è decentissima. Visitò la biancheria che trovò netta, gli arredi in buono stato, quan-tunque tra essi fosse una pianeta bianca che interdisse fino a quando non fosse restaurata; i vasi sacri in buono stato; e tutto il resto che occorre al servizio del culto ebbe a lodare perché decentemente tenu-to. La congregazione ha una meschinissima rendita la quale non bastan-do a far fronte alle spese di mantenimento ed ai più legati vi sopperi-sce per via di elemosine, e colla contribuzione di Lira una che ogni fratello paga nell’anno. A carico di questa Congregazione sono i seguenti Legati:
1) N. 2 Messe lette pel q.m Giuseppe Tiberti 2) N. 2 Messe lette pel q.m Giovanni Ceciri 3) N. 2 Messe lette pel q.m Loreto Senese 4) N. una Messa letta per q.m Margherita Quirini
I. ROSSI
206
5) N. 3 Messe lette per q.m Francesco Leonardi 6) N. 3 Messe lette pel q.m Bartolomeo Ceciri 7) N. 2 Messe lette pel q.m Carlo Costantini 8) N. 1 Messa letta pel q.m Antonio Costantini 9) N. 4 Messe lette pel q.m. Antonio Annibaldi e Caterina Alle-
gri 10) N. 2 Messe lette pel q.m Francesco Scorretti 11) N. 4 Messe lette pel q.m Amando Felice Gioia 12) N. 1 Messa letta con un Rosario pel q.m Eleuterio Caroselli
13) N. 1 Messa letta annuo pel q.m Angelo Giraldi da dirsi nelle quarant’ora della Purificazione, ed un Rosario da dirsi nel 13 Dicembre di ogni anno
14) N.12 Messe lette annue da dirsi 7 nelle festività di Maria Santissima, una nel giorno di Sant’Antonio Abbate, e le altre 4 nelle quarant’ore della Purificazione ed un Rosario pel q.m Ottavio Dantono
15) N. 2 Messe lette annue per la q.m Cristina Santilli 16) N. 3 Messe ed una cantata nel Martedì di Pasqua pel q.m
Mazzilli. 17) N. una Messa cantata all’anno e parata pel q.m Giuseppe
Vallesi da dirsi nel giorno 19 Settembre Tutti questi Legati si trovano segnati nella tabella della Sagrestia, e nei registri delle Messe. Si adempiono. È a notare però che nel 1872 il Cassiere non diede l’elemosina per nessuna di queste Mes-se perché il fondo da cui si ritraggono le rendite era rimasto inondato. Pel 1874 ancora non se ne celebrò alcuna, ed altrettan-to è a dire pel 1875 già decorso per la metà. L’Illustrissimo e Re-verendissimo Monsignor Vescovo ordinò al Priore della Confra-ternita di mettersi al più presto in regola. Il Cappellano della Con-fraternita applica la Messa tutte le Domeniche, e compie tutte le funzioni religiose in questa Chiesa e la Confraternita gli paga a ti-tolo di elemosina e di compenso Lire 106.25 annue e si adempie.
29 luglio 1883 Vescovo Augusto Antonio Vicentini Busta 1291, pp. 401-403. N.d.a.: si riporta qui di seguito un breve sunto del documento. Il vescovo Augusto Antonio Vicentini visita Cittaducale ma ispeziona solo la Cattedrale di Santa Maria del Popolo e le chiese di San France-sco e di Sant’Agostino.
SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI A CITTADUCALE
Horti Hesperidum, III, 2013, 1 207
3 maggio 1896 Arcivescovo de L’Aquila Francesco Paolo Carrano Busta 1290, p. 271. Per la chiesa dei Raccomandati, in cui è eretta la Confraternita degli Artisti, e che fu visitata da lui stesso, Monsignor Arcivescovo ordina-va:
1) Ne’ confessionari si mettano le tabelle dei casi riservati e alle grate altre grate in legno.
2) Si restauri, dove occorra, il pavimento. 3) La custodia dell’altare maggiore sia foderata di seta bianca.
18-23 Agosto 1919 Monsignor Adolfo Turchi, arcivescovo de L’Aquila Busta 878/1, pp. 12-17. N.d.a.: si riporta qui di seguito un breve sunto del documento. Tra il 18 e il 23 agosto 1919, monsignor Adolfo Turchi, visita Citta-ducale, officia le funzioni, cresima duecento bambini e ispeziona le seguenti chiese, oltre a controllarne i registri parrocchiali: Santa Maria del Popolo, San Francesco e Santa Maria delle Grazie. Emana i relati-vi decreti con le indicazioni sul da farsi. Non è citata Santa Maria dei Raccomandati. 3 settembre 1922 Monsignor Adolfo Turchi, arcivescovo de L’Aquila Busta 878/2, pp. 3-9. La mattina del 3 Settembre Sua Eccellenza Monsignor Arcivescovo, in compagnia del Segretario di Visita, parte dalla sua residenza dell’Episcopio di Aquila per tempo alle ore 6 ¾ del mattino, per ini-ziare la sua seconda visita pastorale diretto a Cittaducale. Si arriva alle ore 8 alla porta Napoli, ove si trovano per il ricevimento l’Arciprete Don Pietro Dionisi, la Confraternita laicale del Sacramen-to, quella della Madonna dei Raccomandati, quella di Sant’Antonio Abbate, le Suore Missionarie Zelatrici del Sacro Cuore con i Paggi del Santissimo Sacramento e l’Oratorio femminile e un certo numero di Popolo. Le aste del baldacchino sono sorrette da 6 giovani delle mi-gliori famiglie della Città […].
I. ROSSI
208
(N.d.a.: la memoria prosegue con la descrizione della cerimonia nella cattedrale, della cresima dei fanciulli, del saggio catechistico e dell’ispezione della chiesa. Il giorno 8 settembre si procede alla visita del Monastero di Santa Caterina, della chiesa di Santa Maria delle Grazie e di quella di San Giuseppe. Si emanano i relativi decreti). 4 maggio 1934 Gaudenzio Manuelli, arcivescovo de L’Aquila Busta 839/1, p. 543 [pp. 541-543]. Monsignor Arcivescovo, accompagnato dal Prevosto di San Marciano di Aquila, Don Pietro Dionisi, è accolto solennemente fuori la porta della città con intervento di autorità, scuole, Balilla, Piccole Italiane, confraternite e musica cittadina […]. Oltre alla chiesa parrocchiale Sua Eminenza visita anche le seguenti chiese: Chiesa di Santa Cecilia […]. Chiesa di Santa Maria delle Grazie […]. Chiesa di Santa Maria dei Raccomandati:
1) Mettere ai confessionali l’immagine del Crocifisso; 2) Mettere i crismali sulle pietre sacre; sul piano terra degli altari
mettere tavole anziché mattoni. Chiesa di San Giuseppe […]. Chiesa di Sant’Agostino […]. 4 giugno 1939 Gaudenzio Manuelli arcivescovo de L’Aquila Busta 839/2, pp. 267-274. Sua Eminenza Monsignor Gaudenzio Manuelli Arcivescovo dell’Aquila, il 4 giugno 1939, festa della Santissima Trinità, si reca, ac-compagnato dal Reverendissimo Canonico Don Amilcare Torlone, in Cittaducale per compiervi la seconda Santa Visita […]. Giunto nella chiesa parrocchiale Sua Eminenza compie le cerimonie prescritte per la circostanza e inizia la celebrazione della Santa Messa. Dopo il Van-gelo parla al popolo dicendosi lieto di fare la seconda Visita in quella città che, dopo la città dell’Aquila, sede ordinaria dell’Arcivescovo, è la più cara al suo cuore per le più frequenti relazioni che ormai, dopo il restauro dell’Episcopio, Sua Eminenza tiene con quel popolo […]. La vita religiosa in questa parrocchia va lentamente risvegliandosi sia per mezzo di un po’ di movimento di Azione Cattolica, sia per la fre-quente presenza di Monsignor Arcivescovo che in questi ultimi tempi -1937- ha fatto restaurare l’Episcopio decorosamente dopo un lungo
SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI A CITTADUCALE
Horti Hesperidum, III, 2013, 1 209
periodo di abbandono e di trascuratezza che l’avevano reso quasi ca-dente e inabitabile. Fu inaugurato il 19 agosto 1937 con funzione so-lenne di San Magno nella Chiesa Parrocchiale coll’intervento di rap-presentanza del Capitolo Cattedrale di Aquila, molto clero, autorità e personaggi invitati dall’Arcivescovo. Sua Eminenza ha diviso il fab-bricato in due appartamenti riservandosi il primo piano ed assegnan-do al Parroco quello superiore a cui si accede per mezzo di una nuova scalinata. Un cancello in ferro impedisce ogni comunicazione col quartierino dell’Arcivescovo che ha l’ingresso dalla porta principale. Una imitazione della grotta di Lourdes, costruita da libera e generosa cooperazione del locale Comando della Milizia Forestale, adorna l’ingresso dalla Piazza. La facciata fu restaurata dal comune. La sala del Trono fa anche da Cappella, perché il trono può trasformarsi in Altare, sopra di cui vi è una buona tela raffigurante Sant’Agostino re-galato dalle Agostiniane di Aquila […]. La Santa Visita nella Parroc-chia di Cittaducale non è stata preceduta da predicazione come è pre-scritto nelle disposizioni dell’Ordinario. Nella Chiesa di Sant’Agostino sono in corso importanti lavori di restauro fatti per conto del Comu-ne a cui è stata però ceduta la Chiesa di San Francesco rovinata dal Terremoto e dall’incuria ed ora passata alla Milizia Forestale che ne ha fatto magazzeno. Nel giorno successivo 5 giugno Sua Eminenza l’Arcivescovo, (fu) accompagnato dall’Arciprete Don Domenico d’Angelo, da Don Alessandri, Cappellano del Monastero e da Don Moscardi Parroco di Grotti a visitare le Chiese di Santa Caterina (Monastero) Santa Maria delle Grazie, San Giuseppe e di Santa Maria dei Raccomandati. Tutte lasciarono alquanto desiderare, tranne quella delle religiose, per ordine e pulizia che Sua Eminenza ha raccomanda-to caldamente all’Arciprete. Decreti […] Risposte ai questionari del vescovo 23 luglio 1910 Risposte ai questionari del vescovo pellegrino Francesco Maria Stagni Busta 1105/12.1 (23r-25v). Confraternita di Maria Santissima dei Raccomandati di Cittaducale diretta dal priore Ursini Giovanni, Ermini Antonio, ed Angretolli Ni-cola.
I. ROSSI
210
1° La Confraternita fu eretta nell’anno 1784 con assenso regio rila-sciato e firmato dal re Ferdinando 4°. 2° Le regole della Confraternita sono distribuite secondo i voleri dello Statuto od assenso regio. Tiene il sacco bianco con rocchetto o man-tellina rossa con lo stemma di Maria, e col cingolo rosso. Conserva una parte di contabilità degli ultimi tempi. 3° I fratelli inscritti sono 247; ma non tutti pagano. Gli ufficiali sono Ursini Giovanni, priore; Ermini Antonio, 1° assistente e Angretolli Nicola, 2° assistente. 4° Buona parte dei fratelli, ricorrendo la festa della Purificazione e nelle feste Pasquali si confessano e si comunicano. 5° La Chiesa non ha né padre spirituale, né il direttore; per far dire le messe in tutte le feste dell’anno ci dobbiamo raccomandare ai Padri Cappuccini. 6° La Chiesa è propria.
Attivo 7° La rendita proveniente dal Cassiere per riscossione fondi è di £ 120.00
La riscossione dei confratelli in media ammonta a £ 160.00
Riscossione questua, in media £ 150.00 ------------ Totale dell’attivo £ 430.00
Passivo
Messe tutto l’anno in media £ 140.00 Pagamento dell’organista £ 50.00 Pagamento al sagrestano £ 50.00 Per soddisfare i confratelli morte in multa £ 100.00 Spese per la novena della Purificazione £ 30.00 Spese per le quarantore del Santo Natale, della Purificazione e del Carnevale, compresa la cera £ 50.00 Per mantenimento della biancheria £ 15.00 Per spese impreviste £ 30.00
------------ Totale del passivo £ 435.00
SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI A CITTADUCALE
Horti Hesperidum, III, 2013, 1 211
8° L’inventario dei sacri arredi conservati dalla detta confraternita è il seguente:
1) Piviali N. 3, di cui uno nero e due colorati in buono sta-to: 3
2) Parato in terzo nero in buono stato. N. uno: 1 3) Parato in terzo di tutti i colori in buono stato. N. uno: 1 4) Parato di lama, la sola pianeta mediocre. N. 1: 1 5) Bandinella di seta in buono stato. N. uno: 1 6) Numerale uno con quattro fiori in buono stato: 1 7) Camici festivi in buono stato di tela con merletti. N. tre:
3 8) Camice giornaliero in mediocre stato: 1 9) Amitti in buono stato. N. quattro: 4 10) Tovaglie con merletti festive N. tre: 3 11) Tovaglie per gli altari festive. N. due: 2 12) Tovaglie giornaliere di panno in buono stato per gli altari.
N. 3: 3 13) Sottotovaglie mediocri. N. quattro: 4 14) Asciugamani di tela. N. due: 2 15) Sparone mediocre. N. uno: 1 16) Purificatori. N. quindici: 15 17) Messale dei morti, festivo. N. uno; dei vivi, puranche fe-
stivo. N. uno. In tutto: 2 18) Messali, come sopra, giornalieri. N. due: 2 19) Una pace pei confratelli di metallo: 1 20) Corporali con palle. N. 4: 4 21) Pianete di vari colori complete. N. nove: 9 22) Reliquie N. 6, di cui due di legno e quattro metalliche: 6 23) Ostensori due, dei quali uno è d’argento 24) Calici metallici con coppe d’argento. N. due: 2 25) Campanelli N. quattro, dei quali uno al banco: 4 26) Quadri in sagrestia. N. cinque: 5 27) Crocifissi. N. due: 2 28) Elenco dei legati. N. uno. 1 29) Inginocchiatoi. N. due: 2 30) Quadri di preparazione alla messa. N. tre di cui uno sen-
za vetro: 3 31) Stendardo della Madonna. N. uno: 1 32) Scala per salire alla cucinetta. N. una: 1 33) Baldacchino per altare, completo, con crocifisso, in buo-
no stato. N. uno: 1
I. ROSSI
212
34) Sacchi. N. venti: 20 35) Tappeti di differente grandezza, il piccolo strappato. N.
tre: 3 36) Stuole per confessare. N. due: 2 37) Sedie di damasco. N. 3: tre 38) Sedie ordinarie. N. cinque: 5 39) Candelieri. N. cinquantadue, più sei di metallo, in tutto
cinquattotto: 58 40) Crocifissi agli altari. N. tre: 3 41) Lampade in buono stato. N. quattro. 4 42) Brocchetta piccola per l’olio una: 1 43) Idem grande (per l’olio). N. una: 1 44) Ampolle, paio uno: 1 45) Piattino. N. due, dei quali uno di cristallo: 2 46) Vasetto di purificazione di cristallo. N. 1: 1 47) Incensiere con navicella di ottone. N. uno:1 48) Tavolinetti due, dei quali uno con tovaglia: 2 49) Cornocopi di ferro. N. due: 2 50) Scalette per gli altari N. due, delle quali una mediocre: 2 51) Via Crucis N. quattordici: 14 52) Quadri grandi alle pareti della Chiesa. N. sei: 6 53) Lampadari. N. quindici: 15 54) Stipo o vestiario. N. uno: 1 55) Cassa per cera. N. una: 1 56) Croce per calvario. N. una: 1 57) Fiori per gli altari in buono stato. N. dieci: 10 58) Idem usati N. dieci: 10 59) Banco priorale. N. uno: 1 60) Carta gloria. N. dodici: 12 61) Misteri. N. dodici: 12 62) Catafalco per morti mediocre. N. 1: 1 63) Bandinella giornaliera rossa. N. 1: 1 64) Candelabro giornaliero. N. uno: 1 65) Banchi misti. N. dodici: 12 66) Inginocchiatoi. N. due: 2 67) Stipo piccolo mediocre. N. uno: 1 68) Vasetti per i fiori. N. dodici: 12 69) Vasetti per i fiori N. quattro: 4 70) Un Crocefisso grande per il Sepolcro: 1 71) Calice uno d’argento 72) Chiavetta d’argento. N. una:1
SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI A CITTADUCALE
Horti Hesperidum, III, 2013, 1 213
73) Pisside con coppa d’argento. N. una: 1 74) Confessionali. N. due: 2 75) Incensiere di metallo bianco con navicella nuovo. N. uno 76) Secchiello per acquasantiera con aspersorio. N. una: 1
9° Non ha sigillo proprio Città Ducale, 23 luglio 1910
Il priore G. Ursini
13 luglio 1919 Risposte ai questionari del vescovo Adolfo Turchi Parrocchia di Cittaducale. Chiesa Madonna dei Raccomandati Busta 893/ 9.1 (ff. 2r-3r) La Chiesa ha il titolo di Madonna dei Raccomandati. Attualmente è chiusa perché adibita a magazzino di viveri. Le suppellettili ed arredi sono chiusi in sagrestia. Confraternita della Madonna dei Raccomandati 71. Il titolo di Confraternita è: Madonna dei Raccomandati. Non si sa quando fu eretta. Ha l’approvazione Regia. 72. L’attuale priore non sa dare schiarimenti. Qualche registro o carta vecchia è in sagrestia dove non si può entrare perché la porta è ostrui-ta. I confratelli portano sacco bianco con mozzetta color rosa vivo, con placca. 73. I fratelli iscritti sono circa 200. Priore è Giovanni Ursini = 1° As-sistente Mancini Stefano = 2° Assistente Pietro Angelilli. Le elezioni sono fatte per votazione dai confratelli; non vengono sottoposte all’approvazione dell’Ordinario. 74. Non ha né il direttore, né cappellano. Le funzioni venivano prima celebrate dal Parroco nella Chiesa della Confraternita, attualmente sono celebrate dal Parroco stesso nella chiesa parrocchiale. 76-77. Il priore non ha uno statuto. I fratelli partecipano scarsamente alle funzioni. 78. Il Priore è d’accordo col Parroco. 79. La confraternita ha qualche rendita propria che viene riscossa dall’esattore comunale ed amministrata dal Segretario della Congrega-zione di Carità, con bilancio proprio appropriato annualmente dalla Regia Prefettura. Il Priore ha poi l’amministrazione di ciò che si esige come quota dai confratelli e delle elemosine ed ha registri con introito
I. ROSSI
214
ed esito, che, fino ad ora, non erano stati mai sottoposti all’approvazione dell’Ordinario. 80. Si fanno questue in chiesa e fuori vengono erogate per la manu-tenzione della Chiesa e per le spese di culto e feste popolari. 81. Il Priore ha un registro ove sono notati dei legati annui di N. 27 Santissime Messe che furono adempiti fino a tutte il 1915. Per tale adempimento si donino in tutto £ 32:50. Il Priore non ha altri registri di legati, né sa se (ce) n’è una tabella nella sagrestia della Chie-sa. 82. N.N. 83. Una volta all’anno per consuetudine, il 25 maggio per rinnovare le cariche. Non esiste registro di verbali. 84. N.N. Cittaducale, 13 luglio 1919 Il Parroco D. Pietro Dionisi
SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI A CITTADUCALE
Horti Hesperidum, III, 2013, 1 215
Bibliografia L’ABRUZZO IN ETÀ ANGIOINA 2005 = L’Abruzzo in età angioina. Arte
di frontiera tra Medioevo e Rinascimento, atti del convegno (Chieti 1-2 aprile 2004), a cura di D. Benati e A. Tomei, Milano 2005.
AFFRESCHI NELLE CHIESE DELLA PROVINCIA DI RIETI 2003 = Af-freschi nelle chiese della provincia di Rieti, a cura di R. Messina, Rieti 2003.
L’ALTA VALLE DEL VELINO 2006 = L’Alta Valle del Velino: ambien-te, architettura, arte, storia, atti del convegno (Antrodoco, 10-11 luglio 2004), a cura di I. Tozzi, Antrodoco 2006.
ANDREA 2003 = A. ANDREA, Analisi dei cicli pittorici di Corchiano e Fa-brica di Roma: nuovi contributi per Lorenzo e Alessandro Torresani, in «Bi-blioteca e società», 2003, 1/2, pp. 16-27.
ANSELMI 2009 = A. ANSELMI, L’iconografia della Madonna del Rosario nella Calabria spagnola, in La Calabria del viceregno spagnolo: storia, arte, ar-chitettura e urbanistica, a cura di A. Anselmi, Roma 2009.
ANTONIAZZO ROMANO. PICTOR URBIS 2013 = Antoniazzo Romano. Pictor Urbis 1435/1440-1508, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Barberini, 1 novembre 2013-2 febbraio 2014), a cura di Anna Caval-laro e Stefano Pedrocchi, Cinisello Balsamo (Milano) 2013.
ASPETTI DELL’ARTE DEL ‘400 A RIETI 1981 = Aspetti dell’arte del ‘400 a Rieti, catalogo della mostra (Rieti, Palazzo vescovile, 4 luglio-30 settembre 1981), a cura di A. Costamagna, L. Scalabroni, Roma 1981.
BAZZINI 2011 = M. BAZZINI, Parma, Arezzo, Cittaducale: zecche angioi-ne?, in La monetazione pugliese dall’età classica al Medioevo (3). Le monete della Messapia. La monetazione angioina nel Regno di Napoli, atti del 3° Congresso Nazionale di Numismatica (Bari, 12-13 novembre 2010), EOS, Collana di Studi numismatici, III, Bari 2011, pp. 533-53.
BERTI BULLO 1973 = A. BERTI BULLO, Concessione agli uomini della con-fraternita dell’Ospedale di Santa Maria dei Raccomandati di Cittaducale, in «Rieti: rivista bimestrale di studi e documentazione», 1, 1973, pp. 43-47.
BILARDELLO 2004 = V. BILARDELLO, Luisa Mortari provinciale: l’esperienza sabina, in Per la storia dell’arte in Italia e in Europa. Studi in onore di Luisa Mortari, a cura di M. Pasculli Ferrara, Roma 2004, pp. 48-49.
BUTTAFOCO 1995 = M. BUTTAFOCO, Il Quattrocento in PATRIMONIO
ARTISTICO E MONUMENTALE DEI MONTI SABINI 1995, pp. 8-19. BUTTAFOCO, MASSAFRA 1995 = M. BUTTAFOCO, M. G. MASSAFRA,
Il Seicento, in PATRIMONIO ARTISTICO E MONUMENTALE DEI MONTI
SABINI 1995, pp. 32-46.
I. ROSSI
216
CAIONE, CALIÒ, FALASCHI, LEGGIO, PATERA, 2007 = P. CAIONE, T. CALÒ, N. FALASCHI, T. LEGGIO, M. V. PATERA, Cittaducale. San Magno da Trani, scheda in I santi patroni del Lazio. III, La Provincia di Rieti, Roma 2007, I, pp. 125-133.
CANTONE 1990A = R. CANTONE, Il portale di Sant’Agostino, in Cittadu-cale: settimana dei beni culturali e ambientali, atti del convegno (Cittadu-cale, 27 settembre – 4 ottobre 1981), Rieti 1990, pp. 102-110.
CANTONE 1990B = R. CANTONE, Un ritrovamento pittorico; gli affreschi di Santa Cecilia a Cittaducale, in Cittaducale: settimana dei beni culturali e am-bientali, atti del convegno (Cittaducale, 27 settembre – 4 ottobre 1981), Rieti 1990, pp. 128-139.
CAPEZZALI 1990 = W. CAPEZZALI, Cittaducale e la Sabina nella biblio-grafia di tutti i tempi, in Cittaducale: settimana dei beni culturali e ambientali, atti del convegno (Cittaducale, 27 settembre – 4 ottobre 1981), Rieti 1990, pp. 36-43.
CAVALLARO 1992 = A. CAVALLARO, Antoniazzo Romano e gli antoniaz-zeschi. Una generazione di pittori nella Roma del Quattrocento, Udine 1992.
CAVALLARO 2008 = A. CAVALLARO, Sacralità e tradizione nell’ultimo Antoniazzo († 1508), in Metafore di un pontificato. Giulio II (1503-1513), atti del convegno (Roma, 2-4 dicembre 2008), a cura di F. Cantato-re, M. Chiabò, P. Farenga, M. Gargano, A. Morisi, A. Modigliani, F. Piperno, Roma 2010, pp. 421-444.
CAVALLARO 2013= A. CAVALLARO, Antoniazzo Romano, pittore “dei migliori che fussero allora in Roma”, in ANTONIAZZO ROMANO. PICTOR
URBIS 2013, pp. 20-47. CITTADUCALE E LA SABINA 1981 = Cittaducale e la Sabina, catalogo
della mostra bibliografica (Cittaducale, 27 settembre – 4 ottobre 1981), a cura della Biblioteca Provinciale Salvatore Tommasi dell’Aquila e di W. Capezzali, L’Aquila 1981.
CITTADUCALE: LA FONDAZIONE 1992 = Cittaducale: la fondazione di Cittaducale nella problematica di confine fra Regno di Napoli e Stato della Chiesa, atti del convegno (Cittaducale, 7-8 dicembre 1990), Rieti 1992.
CONTE 1990A = A. CONTE, La diocesi di Cittaducale dalle origini alla mor-te di S. Felice, in SAN FELICE DA CANTALICE 1990, pp. 273-289.
CONTE 1990B = A. CONTE, Il salone vescovile e gli oggetti d’arte della Catte-drale di Cittaducale, in Cittaducale: settimana dei beni culturali e ambientali, atti del convegno (Cittaducale 24 settembre – 4 ottobre 1981), Cit-taducale 1990, pp. 179-186.
CONTE 1996 = A. CONTE, La chiesa Cattedrale e gli altri edifici sacri in Il circondario di Cittaducale come territorio di confine. Storia del paesaggio, trat-
SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI A CITTADUCALE
Horti Hesperidum, III, 2013, 1 217
tazioni dotte e diari di viaggio attraverso gli occhi dei viaggianti del passato, atti della mostra-convegno (Cittaducale, 24-30 aprile 1996), s.l., stampa 1997 (Santa Rufina di Cittaducale, Arti grafiche Nobili sud), pp. 19-23.
COSTAMAGNA 1981 = A. COSTAMAGNA, «Marco Antonio pictore roma-no» a Rieti, in ASPETTI DELL’ARTE DEL ‘400 A RIETI 1981, Roma 1981, pp. 76-82.
CRONACA DELLE BELLE ARTI 1915A = Cronaca delle Belle Arti, sup-plemento in «Bollettino d’Arte», II, Febbraio-Aprile 1915, n. 2-4, p. 18.
CRONACA DELLE BELLE ARTI 1915B = Cronaca delle Belle Arti, sup-plemento in «Bollettino d’Arte», II, Settembre 1915, n. 9, pp. 66-67.
DALL’ALBORNOZ ALL’ETÀ DEI BORGIA 1990 = Dall’Albornoz all’età dei Borgia. Questioni di cultura figurativa nell'Umbria meridionale, atti del convegno (Amelia, 1-3 ottobre 1987), Todi 1990.
DELL’ORSO 1992 = S. DELL’ORSO, Un itinerario attraverso gli affreschi abruzzesi del primo Quattrocento, Teramo 1992.
DE SIMONE 2002 = G. DE SIMONE, L’ultimo Angelico: le Meditationes del cardinal Torquemada e il ciclo perduto nel chiostro di S. Maria sopra Mi-nerva, in «Ricerche di storia dell’arte», 76, 2002, pp. 41-87.
DI FLAVIO 1990A = V. DI FLAVIO 1990A, I vescovi di Cittaducale in Cit-taducale: settimana dei beni culturali e ambientali, atti del convegno (Citta-ducale, 27 settembre – 4 ottobre 1981), Rieti 1990, pp. 24-35.
DI FLAVIO 1990B = V. DI FLAVIO, L’organizzazione ospedaliera in Citta-ducale all’indomani della fondazione, in Cittaducale: settimana dei beni cultu-rali e ambientali, atti del convegno (Cittaducale, 27 settembre – 4 ot-tobre 1981), vol. II, Rieti 1990, pp. 75-79.
DI FLAVIO 1996 = V. DI FLAVIO, Spedali, lebbrosari e ospizi della Sabina, Pescara 1996.
DI NICOLA 1984 = A. DI NICOLA, Il vecchio “Palazzo della Comunità” di Città Ducale, in «Lunario Romano. Palazzi municipali del Lazio», a cura di R. Lefevre, XIV, 1985, pp. 91-112.
DI NICOLA 2004 = A. DI NICOLA, Cittàducale dagli Angioini ai Farnese, Rieti 2004.
DON ANTONIO E CITTADUCALE 2006 = Don Antonio e Cittaducale 1981-2002, a cura dell’associazione “Tota Civitas Una”, Cittaducale 2006.
DUVAL-ARNOULD 2010 = L. DUVAL-ARNOULD, Le pergamene dell’Archivio Capitolare Lateranense. Inventario della serie Q e Bollario della Chiesa Lateranense (collana Tabularium Lateranense, I), Città del Va-ticano 2010.
I. ROSSI
218
ESPOSITO 2001 = A. ESPOSITO, Donne e confraternite in STUDI
CONFRATERNALI 2011, pp. 53-78. ESPOSITO 2013= A. ESPOSITO, La Roma delle confraternite nell’età di An-
toniazzo in ANTONIAZZO ROMANO. PICTOR URBIS 2013, pp. 56-65. FERRARIS, VANNUGLI 1987 = P. FERRARIS, A. VANNUGLI, La fase
romana di Carlo Cesi, in Carlo Cesi. Pittore e incisore del Seicento tra ambien-te cortonesco e classicismo marattiano 1622-1682, Rieti 1987, pp. 21-46.
FERRETTI 2002 = I. FERRETTI, La Madonna della cintola nell’arte toscana. Sviluppi di un tema iconografico, in «Arte cristiana», 813, 2002, XC, pp. 411-422.
FIORE 1980 = F. P. FIORE, Fondazione e forma di Cittaducale, in Atti del XIX Congresso di storia dell’architettura (L’Aquila, 15-21 settembre 1975), II, 1980, pp. 475-488.
FRATINI 1996 = C. FRATINI, Per un riesame della pittura trecentesca e quat-trocentesca nell’Umbria meridionale, in Piermatteo d’Amelia. Pittura in Um-bria meridionale fra ‘300 e ‘500, Perugia 1996, pp. 285-382.
GALLUZZI 1720 = F. M. GALLUZZI, Vita del P. Antonio Baldinucci della Compagnia d Giesù missionario […], Roma 1720.
GAVINI 1915 = I. C. GAVINI, I terremoti in Abruzzo e i suoi monumenti, in «Rivista abruzzese di scienze, lettere ed arti», 30, fasc. V, maggio 1915, pp. 235-240.
GAVINI 1927-1928 = I. C. GAVINI, Storia dell’architettura in Abruzzo, 2 voll., Milano 1927-1928. GRUMO 2011 = G. GRUMO, La pittura del Cinquecento nel Reatino. Dipin-
ti su tavola e su tela, Roma 2011. GRUMO 2013 = G. GRUMO, Marcantonio Aquili, scheda n. 40 in ANTONIAZZO ROMANO. PICTOR URBIS 2013, pp. 152-155. GUIDONI 1985 = E. Guidoni, L’espansione urbanistica di Rieti nel XIII secolo e le città di nuova fondazione angioina, in La Sabina medievale, Milano 1985, pp. 156-187. HALL 1974 = J. HALL, Dizionario dei soggetti e dei simboli nell’arte, Milano 1974. LAVAGNOLI 2006 = G. LAVAGNOLI, La Madonna del Rosario di Loren-
zo Lotto a Cingoli, collana Lamusa, 1, Ascoli Piceno 2006. MACERONI 1990 = G. MACERONI, Chiesa e società civile nella diocesi di
Cittaducale dalla metà del ‘600 alla canonizzazione di S. Felice in SAN
FELICE DA CANTALICE 1990, pp. 441-619. MAGGIONI 2000 = C. MAGGIONI, La fortuna iconografica di san Rocco
nelle regioni dell'Italia centro-settentrionale: prima mappatura, in San Rocco nell’arte: un pellegrino sulla via Francigena, Milano 2000, pp. 60-63.
SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI A CITTADUCALE
Horti Hesperidum, III, 2013, 1 219
MARCHESI 1592 [ED . 2004] = S. MARCHESI, Compendio istorico di Civita Ducale. Codice Mazarino 10480 della Biblioteca Nazionale di Parigi, a cura di A. Di Nicola, Rieti 2004.
MARCHETTI 1990 = P. MARCHETTI, Consolidamento e restauro della chiesa di S. Cecilia in Città Ducale, in Cittaducale: settimana dei beni culturali e ambientali, atti del convegno (Cittaducale, 24 settembre – 4 ottobre 1981), Cittaducale 1990, pp. 122-127.
MARGOZZI 1995 = M. MARGOZZI, Il Settecento, in PATRIMONIO
ARTISTICO E MONUMENTALE DEI MONTI SABINI 1995, pp. 47-54. MARINELLI 1996 = R. MARINELLI, Note per una guida alle fonti documen-
tarie per la storia di Cittaducale e del suo territorio, in Il circondario di Citta-ducale come territorio di confine. Storia del paesaggio, trattazioni dotte e diari di viaggio attraverso gli occhi dei viaggianti del passato, atti della mostra-convegno (Cittaducale, 24-30 aprile 1996), s.l., stampa 1997 (Santa Rufina di Cittaducale, Arti grafiche Nobili sud), pp. 7-12.
MASSAFRA 1995 = M.G. MASSAFRA, Il Cinquecento, in PATRIMONIO
ARTISTICO E MONUMENTALE DEI MONTI SABINI 1995, pp. 20-33. MATTEO DA GUALDO 2004 = Matteo da Gualdo: Rinascimento eccentrico
tra Umbria e Marche, a cura di E. Bairati, P. Dragoni, Perugia 2004. MEERSSEMAN 1964A = G. G. MEERSSEMAN, Le origini della confraterni-
ta del Rosario e della sua iconografia in Italia: I. A proposito di un quadro ve-neziano di Dürer, in «Atti e Memorie dell’Accademia Patavina di Scienze lettere ed Arti», 76, 3, 1964, pp. 223- 256.
MEERSSEMAN 1964B = G. G. MEERSSEMAN, Le origini della confraterni-ta del Rosario e della sua iconografia in Italia: II. Firenze, Roma, Perugia, Chieri, Ravenna, ecc., in «Atti e Memorie dell’Accademia Patavina di Scienze lettere ed Arti», 76, 3, 1964, pp. 301-328.
MEERSSEMAN 1977A = G. G. MEESSERMAN, Le congregazioni della Vergine, in Ordo Fraternitatis. Confraternite e pietà dei laici nel Medioevo, a cura di G.G. Meersseman - G.P. Pacini, Collana Italia Sacra, vol. II, 1977, pp. 921-1171.
MEERSSEMAN 1977B = G. G. MEESSERMAN, Alano della Rupe e le ori-gini della Confraternita del Rosario, in Ordo Fraternitatis. Confraternite e pie-tà dei laici nel Medioevo, a cura di G.G. Meersseman - G.P. Pacini, Col-lana Italia Sacra, vol. III, 1977, pp. 1144-1169.
MEERSSEMAN 1977C = G. G. MEERSSEMAN, Le origini della confraterni-ta del Rosario e della sua iconografia in Italia: I. A proposito di un quadro ve-neziano di Dürer, in Ordo Fraternitatis. Confraternite e pietà dei laici nel Me-dioevo, a cura di G.G. Meersseman - G.P. Pacini, Collana Italia Sacra, vol. III, 1977, pp. 1170-1232.
I. ROSSI
220
MEROLA 1963 = A. MEROLA, ad vocem Baldincucci Antonio, in Dizio-nario Biografico degli Italiani, vol. V, Roma 1963, p. 495.
MORELLI 1999 = G. MORELLI, L’Abruzzo nei manoscritti della Biblioteca Apostolica Vaticana, in «Deputazione abruzzese di storia patria. Do-cumenti per la storia d’Abruzzo», 14, L’Aquila 1999.
MORETTI [1971] = M. MORETTI, Architettura medievale in Abruzzo (dal VI al XVI secolo), Roma s.d. [1971].
MORTARI 1951 = L. MORTARI, Opere d’arte in Sabina dall’XI al XVII secolo, Roma 1951.
MORTARI 1957 = L. MORTARI, Mostra delle opere d’arte in Sabina, Rieti 1957.
MORTARI 1960 = L. MORTARI, Il Museo Civico di Rieti dal Medioevo al XX secolo, Rieti 1960.
MORTARI 1966 = L. MORTARI, Restauri in Sabina, Rieti 1966. MUÑOZ 1915 = A. MUÑOZ, I monumenti del Lazio e degli Abruzzi dan-
neggiati dal terremoto, in «Bollettino d’Arte», XI, II-IV, 1915, pp. 61-112.
MUÑOZ 1917 = A. MUÑOZ, Monumenti d’Abruzzo. Cittaducale, in «Bol-lettino d’Arte», XI, I-II, 1917, pp. 35-48.
NARDECCHIA 2001=P. NARDECCHIA, Pittori di frontiera. L’affresco quat-tro-cinquecentesco tra Lazio e Abruzzo, Pietrasecca di Carsoli (AQ) 2001.
NOVELLI 1992 = R. NOVELLI, Materiale storico del comune di Cittaducale: lingua, comune, tradizioni della storia locale, Santa Rufina (Cittaducale) 1992.
PACINI 1977 = G.P. PACINI, Ordo Fraternitatis. Confraternite e pietà dei laici nel Medioevo, in «Italia Sacra», III, Roma 1977, pp. 1144-1169.
PALMEGIANI 1932 = F. PALMEGIANI, Rieti e la regione sabina, Roma 1932.
PAPÒ, CARROZZONI 1999 = A. PAPÒ, P. CARROZZONI, Itinerari giu-bilari nel Medio Evo attraverso la Sabina, in «Lunario Romano. I giubilei nel Lazio», a cura di L. Devoti, XXVII, Roma 1999, pp. 135-141.
PATRIMONIO ARTISTICO E MONUMENTALE DEI MONTI SABINI 1995
= Patrimonio artistico e monumentale dei Monti Sabini, Tiburtini, Cornicolani e Prenestini, a cura di M. Calvesi e M. Buttafoco, Roma 1995.
PAVAN 1978 = P. PAVAN, Gli statuti della società dei Raccomandati del Salvatore “ad Sancta Sanctorum” (1331-1496), in «Archivio della Società romana di storia patria», 101, 1978, pp. 35-96.
PAVAN 1980 = P. PAVAN, Un esempio romano: la confraternita dei Racco-mandati del Salvatore “ad Sancta Sanctorum”, in «Ricerche di storia so-ciale e religiosa», n.s., 17-18, 1980, pp. 189-193.
SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI A CITTADUCALE
Horti Hesperidum, III, 2013, 1 221
PETRALLA, SAPORI 2004 = M. PETRALLA, G. SAPORI, La chiesa parroc-chiale di Santa Maria di Arrone. Documenti e opere, Arrone 2004.
PITTORI A CAMERINO NEL QUATTROCENTO 2002 = Pittori a Camerino nel Quattrocento, a cura di A. De Marchi, Milano 2002.
QUATTRINI 1990 = C. QUATTRINI, L’iconografia della Madonna del Rosa-rio nelle Marche: origini nordiche e nascita di una tradizione locale, in «Noti-zie da Palazzo Albani. Rivista semestrale di Storia dell’Arte. Univer-sità degli Studi di Urbino», XIX, 2, 1990, pp. 5-12.
ROSA 1999= M. ROSA, Pietà mariana e devozione del Rosario nell’Italia del Cinque e Seicento, in Modelli di lettura iconografica: il panorama meridionale, a cura di M. A. Pavone, Napoli 1999, pp. 233-258.
ROSSI 2008 = S. ROSSI, Antoniazzo e Marcantonio Aquili nella Roma di Andrea Bregno, in Il senso della forma nella cultura artistica del Rinascimento, a cura di C. Crescentini e C. Strinati, Firenze 2008, pp. 401-413.
RUGGIERI 1650 (ED. 2004) = G. S. RUGGIERI, Diario dell’Anno del Santissimo Giubileo del 1650, a cura di S. Pifferi, Collana Strumenti, 5, Viterbo 2004.
RUSSO, SANTARELLI 1999 = L. RUSSO, F. SANTARELLI, La Media Valle del Tevere. Riva destra. Repertorio dei dipinti del Quattrocento e del Cinquecento, Roma 1999.
SABATINI 1995 = G. SABATINI, Scritti editi dal 1931-32 al 1962 in Scritti editi ed inediti di Gaetano Sabatini (1868-1964), a cura di E. Mattiocco, Collana di Studi e testi, Deputazione abruzzese di storia patria, III, L’Aquila 1995.
SACCHETTI SASSETTI 1932 [ed. 2003] = A. SACCHETTI SASSETTI, Lo-renzo e Bartolomeo Torresani pittori del sec. XVI in Affreschi nelle chiese della provincia di Rieti, a cura di R. Messina, Rieti 2003, pp. 113-133.
SACCO 1795 = F. SACCO, ad vocem Civitaducale, in F. Sacco, Diziona-rio geografico-istorico-fisico del Regno di Napoli composto dall'abate d. France-sco Sacco, vol I, Napoli 1795, pp. 320-321.
SAN FELICE DA CANTALICE 1990 = San Felice da Cantalice: i suoi tempi, il culto e la diocesi di Cittaducale dalle origini alla canonizzazione del santo, atti del convegno (Rieti-Cantalice-Cittaducale, 28-30 settembre 1987), a cura di G. Maceroni e A. M. Tassi, Rieti 1990.
I SANTI PATRONI DEL LAZIO 2007 = I santi patroni del Lazio. III. La Provincia di Rieti, a cura di S. Boesch Gajano e L. Erminini, I, Roma 2007, pp. 125-133.
SANTOLINI 1996 = S. SANTOLINI, Presenze antoniazzesche nell’Umbria meridionale. Da Pancrazio Jacovetti a Evangelista Aquili in Le due Rome del Quattrocento. Melozzo, Antoniazzo e la cultura artistica del Quattrocento ro-
I. ROSSI
222
mano, atti del convegno (Roma 21-24 febbraio 1996), Roma 1997, pp. 48-54.
SAPORI 1993 = G. SAPORI, La pittura nell’Umbria meridionale dal Trecento al Novecento, Terni 1993.
SAPORI 2004 = G. SAPORI, La decorazione della chiesa, in PETRALLA, SAPORI 2004, pp. 84-97.
SCHLEIER 1990 = E. SCHLEIER, Disegni di Girolamo Troppa nelle collezio-ni tedesche e altrove, in «Antichità Viva», 29, 1990, pp. 23-34.
SIGNORINI 1868 = A. SIGNORINI, La diocesi di Aquila descritta e illustra-ta, 2 voll., Aquila 1868.
STROPPIANA 1979= L. STROPPIANA, L’assistenza ospedaliera nel Lazio nel Cinquecento, in «Lunario romano», 9, 1979, pp. 79-90.
STUDI CONFRATERNALI 2011= Studi confraternali: orientamenti, problemi, testimonianze, a cura di M. Gazzini, Collana Reti Medievali E-Book, 12, Firenze 2009.
S.V. 1834 = S.V., Consiglio generale della Provincia del Secondo Abruzzo Ul-teriore, in «Annali civili del Regno delle due Sicilie», vol. IV, fasc. VII, Gennaio-Febbraio 1834, pp. 118-123.
S.V. 1835 = S.V., Consiglio generale della Provincia del Secondo Abruzzo Ul-teriore, in «Annali civili del Regno delle due Sicilie», vol. VII, fasc. XIII, Gennaio-Febbraio 1835, pp. 7-13.
TARCHI 1940 = U. TARCHI, L’arte medievale nell’Umbria e nella Sabina. Architettura religiosa, Milano 1940.
TARCHI 1954 = U. TARCHI, L’arte del Rinascimento nell’Umbria e nella Sabina, Milano 1954.
TASSI 1990 = A. M. TASSI, Aspetti religiosi, sociali e civili della diocesi di Cit-taducale dalla morte di San Felice alla metà del Seicento, in SAN FELICE
DA CANTALICE 1990, pp. 291-440. TASSI 2006 = A. M. TASSI, L’organizzazione religiosa nella seconda metà del
XIX secolo, in L’ALTA VALLE DEL VELINO 2006, pp. 89-141. TIBERIA 1996 = V. TIBERIA, Presenze antoniazzesche e dei Torresani
nell’Umbria meridionale, in Piermatteo d’Amelia. Pittura in Umbria meridio-nale fra ‘300 e ‘500, Perugia 1996, pp. 383-426.
TODINI 1989 = F. TODINI, La pittura umbra. Dal Duecento al primo Cin-quecento, Milano 1989.
TOMEI 2005 = A. TOMEI, Tra Abruzzo e Lazio: affreschi quattrocenteschi nel transetto di Santa Scolastica a Subiaco, in L’ABRUZZO IN ETÀ
ANGIOINA 2005, pp. 237-253. TOZZI 1988 = I. TOZZI, Nella chiesa parrocchiale di Santa Rufina, in «La-
zio ieri e oggi», 1988, 2, pp. 24-36.
SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI A CITTADUCALE
Horti Hesperidum, III, 2013, 1 223
TOZZI 1997 = I. TOZZI, Note critiche sulle testimonianze storico-artistiche della diocesi di Cittaducale, in «Bullettino della Deputazione Abruzzese di Storia Patria», LXXXV, 1995 (1997), pp. 143-157.
TOZZI 2008, = I. TOZZI, Le tele di San Francesco a Cittaducale, ora al Mu-seo della Diocesi di Rieti, in «Città di vita», 63, n. 6, pp. 571-576.
UNIVERSITATES E BARONIE 2006 = Universitates e baronie. Arte e archi-tettura in Abruzzo e nel Regno al tempo dei Durazzo, atti del convegno (Guardiagrele – Chieti, 9-11 novembre 2006), a cura di P.F. Pistilli, F. Manzari, G. Curzi, 2 voll., Pescara 2006.
VALENTI 1990 = M. VALENTI, L’architettura sacra: S. Agostino e S. Ceci-lia. Analisi storica di alcuni particolari architettonici, restauro conservativo e ipotesi di riuso, in Cittaducale: settimana dei beni culturali e ambientali, atti del convegno (Cittaducale, 24 settembre – 4 ottobre 1981), Cittadu-cale 1990, pp. 111-121.
VALTIERI 1989 = S. VALTIERI, L’architettura a Roma nel XV secolo: l’Antico come “imitazione” e come “interpretazione” nel suo processo formativo ed evolutivo, in Roma, centro ideale della cultura dell’Antico nel secoli XV e XVI. Da Martino V al Sacco di Roma 1417-1527, a cura di S. Danesi Squarzina, Milano 1989, pp. 257-268.
VANNUCCI 1863 = P. VANNUCCI, Vita del beato Antonio Baldinucci, Roma 1863.
VENTURA 1994 = L. VENTURA, La Madonna del Rosario di Vincenzo Tamagni nella chiesa di San Biagio in Finalborgo. Esaltazione e superbia di-nastica dei Del Carretto, Marchesi di Finale, in «Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz», 38, 1, 1994, pp. 98-117.
VERANI 1928 = C. VERANI, Note di Arte, Cittaducale, in «Terra Sabi-na», VI, nn. 4-5, 1928, pp. 145-152.
VERANI 1953 = C. VERANI, Nuove attribuzioni ai Torresani pittori del sec. XVI, Rieti 1953.
VERANI 1962 = C. VERANI, Affreschi di Lorenzo, Bartolomeo e Alessandro Torresani a Fabrica di Roma e Corchiano, Rieti 1962.
VERANI 1976A [ed. 2003] = C. VERANI, Il “Maestro della Madonna della Misericordia”, in AFFRESCHI NELLE CHIESE DELLA PROVINCIA DI
RIETI 2003, pp. 163-172. VERANI 1976B [ed. 2003]= C. VERANI, Il pittore amatriciano Dionisio
Cappelli e i minori pittori locali di immagini votive, in AFFRESCHI NELLE
CHIESE DELLA PROVINCIA DI RIETI 2003, pp. 173-183. VERANI 2003 = C. VERANI, Itinerari laziali: Poggio Mirteto, in
AFFRESCHI NELLE CHIESE DELLA PROVINCIA DI RIETI 2003, pp. 253-264.
I. ROSSI
224
Didascalie Fig. 1. Facciata di Santa Maria dei Raccomandati a Cittaducale. Fig. 2. Incontro tra Abramo e Melchisedech, episcopio, salone. Fig. 3. Cena in Emmaus, episcopio, salone. Fig. 4. Portale (2007). Fig. 5. Abside e altare maggiore (2007). Fig. 6. Veduta navata sinistra (2007). Fig. 7. Giuseppe Chiari (attr.), Incoronazione della Vergine tra san Domeni-
co e sant’Isidoro di Siviglia. Cittaducale, Santa Cecilia, presbiterio. Fig. 8. Madonna con il Bambino in trono tra san Rocco e san Sebastiano e
membri di una confraternita (Gonfalone, recto-1972). Fig. 9. Crocifissione tra San Rocco e San Sebastiano, navata destra (1972). Fig. 10. Madonna col Bambino tra san Giuseppe e san Sebastiano (Gonfalo-
ne, verso-1972). Fig. 11. Altare di sant’Ignazio di Loyola e di san Francesco Saverio
(2007). Fig. 12. Vergine in gloria tra sant’Ignazio di Loyola e san Francesco Saverio,
cattedrale, sacrestia. Fig. 13. Cristo e la Veronica, episcopio, salone. Fig. 14. Madonna col Bambino e angeli, navata sinistra (2007). Fig. 15. Visitazione (2007). Fig. 16. Natività (2007). Fig. 17. Presentazione al tempio (2007). Fig. 18. Gesù tra i dottori (2007). Fig. 19. Orazione nell’orto (2007). Fig. 20. Flagellazione (2007). Fig. 21. Incoronazione di spine (2007). Fig. 22. Andata al calvario (2007). Fig. 23. Crocifissione (2007). Fig. 24. Resurrezione (2007). Fig. 25. Ascensione (2007). Fig. 26. Pentecoste (2007). Fig. 27. Consegna della cintola a san Tommaso (2007). Fig. 28. Incoronazione della Vergine (2007). Fig. 29. Busto di Madonna, esterno, fianco destro, edicola (2007). Fig. 30. Madonna col Bambino. Bracciano, cappella dell’ex Ospedale ci-
vile. Fig. 31. San Domenico, navata sinistra (2007). Fig. 32. Assunzione della Vergine, xilografia dalle Meditationes di J. de
Torquemada (1467).
SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI A CITTADUCALE
Horti Hesperidum, III, 2013, 1 225
Fig. 33. Madonna del Rosario tra i santi Domenico, Caterina, Agostino, Grego-rio, Pietro, Ambrogio (?), santi e donatori. Loc. Torano (Borgorose), chiesa di San Pietro.
Fig. 34. San Vincenzo Ferrer. Roma, convento di Santa Sabina. Fig. 35. Santo domenicano, navata sinistra, parete di fondo (2007). Fig. 36. Natività, parete sinistra, altare (2007). Fig. 37. Adorazione dei pastori. Arrone, chiesa di Santa Maria. Fig. 38. Adorazione dei pastori. Villagrande (AQ), chiesa di San Panfilo. Fig. 39. Madonna del latte, parete sinistra (2007). Fig. 40. Madonna del latte, volto (part. - 2007). Fig. 41. Madonna col Bambino in trono. Loc. Ferrazza (Amatrice), chiesa
di Santa Maria delle Grazie. Fig. 42. Monogramma, parete sinistra (2007). Fig. 43. Madonna con il Bambino, navata sinistra, parete di fondo (2007). Fig. 44. Santo domenicano e Madonna col Bambino, navata sinistra, parete
di fondo (2007). Fig. 45. San Rocco (Crocifissione tra san Rocco e san Sebastiano, part. -
1972). Fig. 46. Crocifissione. Corchiano, chiesa di Sant’Egidio. Fig. 47. San Francesco, parete destra (2007). Fig. 48. San Francesco, iscrizione. Fig. 49. Madonna col Bambino, parete destra (2007). Fig. 50. Annunciazione, navata destra, parete di fondo (2007).