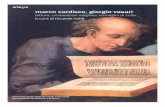L'ANAMORFOSI TRA ARTE, PERCEZIONE VISIVA E PROSPETTIVE BIZZARRE
Bibliografia storica della Liguria: ipotesi e prospettive.
Transcript of Bibliografia storica della Liguria: ipotesi e prospettive.
ORGANIZZATO D A L L A FONDAZIONE R E G I O N A L E CRISTOFORO COLOMBO IN C O L L A B O R A Z I O N E CON L'ASSOCIAZIONE 'A COMPAGNA'E CON I L PATROCINIO D E L CONSORZIO AUTONOMO D E L PORTO DI GENOVA
LA LIGURIA NEL TEMPO proposte per una bibliografia storica
Att i del Convegno di studio
Genova, B5 maggio 1990
FONDAZIONE REGIONALE C. COLOMBO ASSOCIAZIONE " A COMPAGNA"
GENOVA 1990
Si ringrazia per la collaborazione:
Ernesto Bellezza, Donatella Buongirolami, Danilo Cabona, Enrico Carbone, Laura Morando, Emanuele Oneto, Pasquale Poccia, Alberto Risso, Piero Trinca, Ingrid Van Marie
Organizzazione del Convegno: Flavia Sartore e William Piastra
Coordinamento del volume degli Atti di William Piastra
Progetto grafìco del volume degli Atti di Elena Pongiglione
In copertina: riproduzione del manifesto eseguito per H Convegno da Elena Pongiglione.
T u t t i i dir i t t i r i s e r v a t i C o p y r i g h t © 1 9 9 0 F o n d a z i o n e R e g i o n a l e C . C o l o m b o , A s s o c i a z i o n e " A C o m p a g n a "
rro|i{ruiiiiiiu (lei luvorl
K !5 maggio — Palazzo San (iiorgio. Salone delle Conipere
nini Uno
SaJMio di Cnistavo GAMALERO, A H M t M s o r v alle I»(i(iizi<>iii c A t t i v i t à C u l t u r a l i del (>)nuuic (li G e n o v a AnHc - H H o r c airiie)|)oHÌzii)iic Internazionale Spec ia l izza ta '98 V i c e l ' r c s i d c n t c F o n d a z i o n e Regionale C r i s t o f o r o C o l o m b o
Salirlo di Giuseppino ROBERTO, l ' i w s i d i M i l c (IcH'AsHociazione " A C o m p a g n a "
T I esiede Gaetano FERRO, ( ) i i l l i i u i i ( > di G e o g r a f ì a pol i t ica e d e c o n o m i c a del l 'Univers i tà . l ' i c H i d c i i l c del la S o c i e t à G e o g r a f i c a I t a l i a n a
Kelazionl
Giovanna PETTI B A L B I , I I i i i v c i s i l à di G e n o v a
IAI cultura della memoria nel mondo ligure
Romeo PAVONI , Uii ivcrs i tà di G e n o v a
Liguria storica e Liguria attuale
(Giovanni Battista VARNIER, Uiiivcrsi là di U r b i n o
Islituzioni, comunità e realtà locali
Interventi
Dino P U N C U I I , l ' r c s l d c n l c della S o c i e t à Ligure di S tor ia l 'utriu
pomerìggio
Presiede (iiuscppe D A G N I N O
Cesare MASCHIO, Direzione S I H I C I M I l i i l o n i u i l i v i A i i H i i l d o S .| ) .A . , ( ì e i i o v i i
L'ini'oniiullcu nella cutuloguzioiic bibliogrulìcu
Antonio SCOLARI, B i b l i o t e c a F a c o l t à Ingegneria U n i v e r s i t à di G e n o v a
Bibliografìa storica della Liguria: un bilancio
Alberto PETRUCCIANI, U n i v e r s i t à di B a r i
Bibliografìa storica della Liguria: ipotesi e prospettive
Interventi
Augusto C. AMBROSI , P r e s i d e n t e d e l l ' A c c a d e m i a L u n l g l a u e s e di S c i e n z e G . C a p e l l i n i , L a S p e z i a
Vito P I E R G I O V A N N I N I ,
D i r e t t o r e del l ' I s t i tu to del la S t o r i a del D i r i t t o del la F a c o l t à di G i u r i s p r u d e n z a , G e n o v a
Alberto PETRUCCIANI
Giacomina CALCAGNO,
D i r e t t o r e d e l Serv iz io B i b l i o t e c h e del C o m u n e di G e n o v a
Laura M A L F A T T O ,
Membro del Comita to E s e c u t i v a Regionale della Sezione Ligure d e l l ' A s s . I tal iana Biblioteche
Ernesto BELLEZZA,
D i r e t t o r e aggiunto del la B i b l i o t e c a U n i v e r s i t a r i a di G e n o v a
Franco B O N A T T I ,
A c c a d e m i a L u n i g i a n e s e di S c i e n z e G . C a p e l l i n i , L a S p e z i a
Alfredo REMEDI , B i b l i o t e c a r i o del la C i v i c a B i b l i o t e c a B e r i o d i G e n o v a Conclusioni Giuseppe B A G N I N O Ringraziamenti e saluti Giuseppino ROBERTO
Hii
ALBERTO PETRUCCIANI
Bibliografia storica della Liguria: ipotesi e prospettive
Vorrei cominciare riallacciandomi alla relazione che avete appena ascoltato e invitandovi a xm piccolo esperimento mentale: riprendere in mano i l Marmo, e magari soprattutto quelle parti con cui ciascuno di noi ha minore consuetudine, proiettandosi indietro di quasi un secolo, alla data, cioè, nella quale l'opera arrivava per la prima volta nelle mani dei le t tor i .
Colpirebbe subito, mi sembra, la grande ricchezza — magari disorganica, scormessa, imprevedibile, non giustificata — dell'informazione contemporanea: dai piani regolatori ai capitolati di opere pubbliche, dagli statuti di cooperative ai bilanci di enti ed aziende, dai cataloghi delle esposizioni più svariate alle più diverse manifestazioni dell'associazionismo, dai l ibretti di rappresentazioni teatrali ai programmi d i gare sportive.
A noi questo materiale, passati cento anni, appare "naturalmente" come fonte storica, e soltando calandoci in quel tempo, o trasferendolo mentalmente un secolo avanti, riusciamo a ritrovarne i l valore di in fo i -mazione attuale. Colpisce — e sarebbe interessante indagarne le ragioni , sulle piste che ci ha additato Antonio Scolari — come una cultura storica e bibliografica lontanissima dalla nostra, quella del barone Manno, possa aver condotto in parte, probabilmente in maniera incensai)e-vole, certo senza chiare scelte di metodo, a esiti che saremmo portati a collegare piuttosto al concetto attualissimo di documentazione locale.
Per doctmientazione locale si intende quel materiale, sui più diversi supporti e nelle più varie forme bibliografiche, che costituisce appunto la spina dorsale di una sezione di studi locali in una biblioteca. Anzi,
84
ra l i f i iz io i ic alla document,azk)ne locale è vsempie i)ìii ricoiiosciula, aii-c-lie nei nostro paese, come una delle responsabilità centrali per una bi -l)lioteca pubblica sul territorio (1).
Anche per l'opera datatissima del barone Manno, insomma, l 'et ichetta di bibliografìa storica, pure nel senso estremamente ampio che l'espressione "storia" poteva avere allora, risulta limitativa. Ma non è ((ucsta l'unica ragione per cui, oggi, preferirei innanzitutto parlare di una bibliografìa regionale piuttosto che di una bibliografìa storica. Quest'ul-(ima espressione, fra l 'altro, nasconde anche una certa ambiguità, fra ambito disciplinare o tematico e ambito cronologico.
M i sembra che si debba mirare, insomma, non semphcemente a imo strumento di supporto specialistico, per la ricerca storica — campo pure molto vasto e di non facile delimitazione — ma a uno strumento di documentazione e informazione regionale, che docimienti (sotto i l profì-kj bibliografico, ovviamente) la vita della Regione, tanto ieri quanto oggi, tanto nel passato quanto nel presente, in t u t t i i diversi ambiti , e per finalità e interessi differenziati, ma che riconosciamo t u t t i legitt imi 1(1 importanti.
Vediamo di chiarire brevemente, ima per una, queste clausole. Innanzitutto — e scusatemi della banalità — parliamo di doctmien-
I azione bibliografica, sia pure nel senso più ampio, e cioè deU'individua-zlonc e della descrizione dei documenti — non soltanto l ibr i — che riguardano la Regione e le singole località, e dell'organizzazione di queste informazioni per la consultazione. Questo compito può apparire banale a chi ignora le difficoltà della ricerca bibhografica, ma banale non è, perché comporta un'esplorazione a larghissimo raggio, e quindi da condurre con strategie intelligenti ed effìcienti, su i m nimiero molto alto di fonti .
Ho parlato di "docnmienti", nel senso che questo termine ha in campo bibhografìco e biblioteconomico (ed è un senso diverso, ovviamente, da (juello che ha nell'archivistica o nella diplomatica). Con questo termine infatti abbracciamo oggi t u t t i i materiali che contengono informazioni registrate e rese disponibili, in genere in più copie sostanzialmente iden-(ielle, su diversi supporti, in diverse forme, con diverse tecnologie. Do-ciiiiienti tradizionali, come i l libro e i l periodico, e i singoh scri t t i contenuti negli uni e negli altri , ma anche docxmienti d'altro tipo — quelli che con una certa sufficienza chiamiamo spesso "non l ibrar i " —, dalla slumjia alla fotografìa, alla carta geografica, al disco, al film, al videodisco, all'archivio di dati leggibile dalla macchina.
Non c'è dubbio, infatt i , che se i l libro e i l periodico mantengono
86
tuttora i rrr r rrolo lerrtrale nella documentazione e neirinroiiuazioiic, ( | 1 K -
ste hanno senipre più carattere multimediale. Non ci sono l imit i di carattere teorico, ed esistono consolidate esperienze di organizzazione bibliografica di materiale multimediale, ma naturalmente questo problema andrà affrontato su basi concrete, tenendo conto delle opportunità, delle priorità, delle disponibilità.
Uno strumento di documentazione regionale, come si è detto, non può limitare i l suo campo al passato, o a qualche ambito soltanto della vita regionale. Non ho la competenza per discutere di cosa sia la storia, di quali rapporti ci siano fra la storia, diciamo così, generale, e le storie (la storia sociale, economica, della cultura, della letteratura, dell'arte, delle idee, della filosofìa, della scienza, del l ibro, e cosi via enumerando), di fìn dove si estenda nel tempo — per dirlo alla buona — i l territorio dello storico, rispetto a quello del sociologo, dell'economista, dello studioso dell'ambiente o del clima, ecc.
Ma sono rimasto colpito in diverse occasioni dall'avvertimento degli storici — per esempio, ultimamente, nella presentazione del volume Il sistema portuale della Repubblica di Genova curato da Giorgio Doria e Paola Massa Piergiovanni — che la conoscenza del presente non p i K ) essere estranea a quella del passato (2).
Si potrebbe parlare, ancora, dell'emergere di campi di studio interdisciplinari, che non rispettano neanche le tradizionali distinzioni fra di scipline scientifiche e discipline umanistiche.
M i sembra che sia indubbio, comunque, che c'è nei campi più diversi tm'esigenza di documentazione senza fìttizi steccati né tematici uè cronologici, che la ricostruzione del passato è sentita come sempre più importante per i l presente (non solo per tm sociologo o un economista, ma anche per un geologo, i m epidemiologo o un naturalista) e, viceversa, che anche i temi di indagine attuale più specialistica si trasformano sempre più in fretta in oggetti d'interesse per le discipline storiche.
Ma questo non signifìca che si pensi a un mare magnum indistinto: al contrario, si è già cominciato, anche se in via di ipotesi, negli incontri preliminari che hanno accompagnato l'organizzazione di questo convegno, a elaborare politiche, direttive, indicazioni, che saranno ovviaincn-te da mettere a pimto (o magari anche da ribaltare) nel dialogo fra le istituzioni interessate e con gli specialisti dei diversi ambiti disci{)linari.
E arriviamo all'ultima clausola di quella provvisoria "dichiarazione di in tent i " iniziale, la destinazione, e le fìnalità, che un'impresa come questa potrebbe prefìggersi. Non solo la ricerca, che non può non costituire comunque un punto di riferimento imprescindibile, non solo lo sti i-
dio, la didattica, la divulgazione, ma anche tutte le attività di programmazione, di indirizzo e di intervento, nei più diversi campi (culturale, sociale, economico, ambientale, sanitario, formativo, ecc.), che richiedano una ricognizione sicura del sapere sul passato e sul presente della nostra Regione, tma informazione i l più possibile esauriente e affidabile per discutere, intervenire, decidere. Una bibliografìa regionale come strumento di lavoro, insomma, per t u t t i queUi che vogliono docimientarsi in maniera seria ed aggiornata su un tema o su im problema.
Una bibUografìa regionale non potrebbe non essere anche im biglietto di presentazione della Liguria, tm'opera non effìmera, non superficiale, che per serietà scientifica e carica innovativa presenti efficacemente la nostra Regione entro i suoi confmi, ai cittadini, ma anche e forse soprattutto fuori , in Italia, in Europa e nel mondo. Guardando, insomma, a quegli orizzonti a cui questa citta e questa regione per secoli hanno guardato. Anche quando usiamo, per comodità, i l termine "locale", dobbiamo spogharlo da ogni connotazione di minore, chiuso, ripiegato in se stesso.
Un progetto di questo t ipo, quindi, non può configurarsi come tm' i -niziativa separata, come un'altra piccola monade, perché sarebbe inevi-lal)ilmente condannato all'inconcludenza o al pressappochismo.
Un'impresa di questo genere non può essere patrimonio particolare (li (jualcuno, non può che realizzarsi con la più ampia collaborazione e il deciso e costante sostegno delle istituzioni.
Pensiamo, intanto, alle istituzioni poUtiche, amministrative, di governo, alle strutture tecnico-scientifiche che ad esse faimo capo (basta pensare, per esempio, a quelle che operano nel campo dei Beni culttira-l i ) , e che svolgono fimzioni di programmazione, coordinamento, tutela, promozione, e quindi a t u t t i gli enti, pubblici e privati , che producono, raccolgono, utilizzano i l materiale che ci interessa.
Questo significa coinvolgere nella mistura più ampia possibile enti, associazioni, fondazioni, aziende, che producono materiale spesso diffìcilmente reperibile, e assiciurare tma vasta partecipazione di i s t i t u t i culturali e di ricerca e di biblioteche, su tut to U territorio regionale.
Gli i s t i tu t i culturali e i centri di ricerca, a cominciare naturalmente dall'Università, ma senza dimenticare le accademie, le società storiche e scientifiche, le fondazioni, le istituzioni ecclesiastiche, le stesse grandi aziende, non solo genovesi, oltre a produrre e raccogliere materiale (li docmnentazione regionale, costituiscono anche dei necessari punti di riferimento in ambiti o aree specifiche per mettere a punto i l progetto
87
e per impostarlo secondo la massima rispondenza ai bisogni e agli interessi di coloro che ne saranno, in larga misura, i f rui tor i .
È essenziale, in particolare, la collaborazione delle biblioteche: tra biblioteche e bibliografìa, come del resto fra questi due termini e la l i -cerca, v i è tm'interdipendenza profonda.
Moltissime biblioteche della nostra Regione — starei per dire (juasi tut te — hanno fra le loro funzioni, più o meno prioritariamente, quella di documentare, su un piano generale o per specializzazioni secondo i più diversi tagli, la vita e la cultura della Regione (3). A partire dalla Biblioteca Universitaria genovese, a cui questo compito è affidato dalla legge, e che v i assolve anche tramite la raccolta e la conservazione di tu t to quanto si stampa nella provincia di Genova (secondo la normat iva sul deposito obbligatorio o dir i t to di stampa). Accanto alla Biblioteca Universitaria, alle bibhoteche pubbliche genovesi — la Berio, in primo luogo — e degli altr i centri, ricordo ancora quelle di istituzioni attive nel campo degli studi storici (la Società Ligiure di Storia Patria, quella Savonese, i l Centro Ligvue di Storia Sociale, l ' I s t i tuto Mazziniano, l ' I st i tuto Storico della Resistenza, ecc.), di associazioni legate al territorio e alle sue tradizioni (come A Compagna), di enti ecclesiastici (come la Bibhoteca Franzoniana, le cui positive iniziative sono già state ricordate), di fondazioni (per esempio, nel campo della letteratura contemporanea, quella intitolata a Mario Novaro). Anche le biblioteche dell'Università, più: nelle diverse specializzazioni, e non solo nell'ambito lunanistico o sociale, coltivano quasi sempre con particolare interesse la doctmientazione regionale, e sicuramente possono dare contributi importanti in campi speclahstici, per esempio la storia del dir i t to , quella della navigazione e delle costruzioni navali, quella delle scienze matematiche o natturali. Ed è probabile che si riveli insostituibile i l contributo magari estremamente specializzato di enti e aziende che operano nel territorio regionale e che alla storia di questo sono legate: i l Consorzio del Porto, l 'AMT, l'Ansaldo, i l Registro Navale, e anche qui si potrebbe continuare. E sono ancora molte le istituzioni che non ho ricordato in questa elencazione puramente indicativa: per esempio le biblioteche degli Archivi di Stato e delle Camere di Commercio, ancora a partire dal capoluogo. Ma vorrei citare ancora i privati , i collezionisti, gli studiosi, che spesso, soprattutto i n ambiti giudicati un po' sbrigativamente " m i nor i " , possono dare tm contributo estremamente prezioso.
La presenza qui, oggi, di responsabili e di operatori di tante delle biblioteche e delle altre istituzioni che ho o avrei dovuto ricordare, non solo da Genova, ma da tut te le altre province, mi sembra già un segno
HH
mollo importante. Non voglio leggerlo forzatamente come adesione alla l)ro[)osta che viene oggi presentata, ma m i sembra — e forse è più i m portante — che sia legittimo vedervi la consapevolezza che i l tema di (questo convegno ci riguarda t u t t i .
La più ampia cooperazione, che a mio avviso è imprescindibile, potrà concretizzarsi con gradualità, naturalmente, e a tant i l ivell i , dal supporto scientifico al contributo alla raccolta dei dati , dalla messa a disposizione di informazioni fino a ogni t ipo di facilitazione nel corso del lavoro.
È quindi i l caso di provare a definire un po' meglio i contomi di una possibile bibliografia regionale, limitandosi però, in questa sede, a toccare soltanto alcune delle questioni di maggiore portata, e sempre come semplice contributo alla discussione.
M i sembra da sottolineare, in primo luogo, l'esigenza di una struttura flessibile e modulare, nella quale intanto si distinguano la costituzione di una bibliografìa retrospettiva, che raccolga quanto è stato scritto sulla nostra Regione fino ad oggi, da ima parte, e l'avvio di una bibliografìa corrente, che documenti periodicamente, magari anno per armo, (luanto viene pubblicato, daU'altra.
Manca in entrambi i campi, e nonostante importanti e lodevoli i n i ziative nel secondo, un punto di riferimento adeguato, che risponda alle finalità che ho cercato di delineare. I metodi e le procedure, d'altra parte, sono nei due casi in buona misura gli stessi (anche se forse nell'ambito retrospettivo esigenze d i economia e di dimensionamento complessivo possono orientare verso criteri di pertinenza più stringenti).
E indispensabile, ovviamente, la disponibilità di risorse ad hòc, ma mentre per l'ambito retrospettivo solo un forte impegno "speciale" può permettere di sanare in tempi ragionevoli le lacune, per queUo corrente emerge ancor più in primo piano — e pur sempre con la necessità di una struttura centrale di servizio — l'esigenza di una cooperazione quo-tidiana delle istituzioni e delle biblioteche, da vedere non come un aggravio alle tante funzioni che già esse svolgono con mezzi inadeguati, ma come strumento di conoscenza reciproca, di condivisione di informazioni e dati , e quindi di miglioramento dei servizi.
Per quanto riguarda l'ambito retrospettivo, si può pensare, anche per arrivare a risultati concreti in un tempo ragionevole, a una ripartizione per tranches, da avviare a ritroso. Si potrebbe partire, per esem-|)i(), da una tranche relativa al dopoguerra: diciamo, per la comodità e l'efficacia che hanno in bibliografìa le date convenzionali, dal 1951 alla (lata di avvio della bibliografìa corrente. A questa tranche potrebbe se-
Hi)
guirne una seconda dedicata alla prima metà del secolo (1901-1950), arrivando perciò a ridosso del Manno. Una terza tranche, a scadenza più lontana, potrebbe recuperare le informazioni contenute nel Manno stesso e integrarlo con quanto v i manca, fìno alla data, sempre convenzionale ma comoda, dell'anno 1900.
La bibliografìa corrente potrebbe partire, naturalmente, dall'avvio dell'iniziativa (diciamo, con un po' di ottimismo, dal 1990, i l che forse potrebbe permettere di arrivare a presentare, nel corso del fatidico 1992, un primo risultato).
Parlerei di bibliografìa corrente, e non di aggiornamento, per le stesse ragioni per cui, in apertura, ho preferito parlare di una bibliografìa regionale. Non si tratta semplicemente di un problema di scadenze (quefle di un aggiornamento sono sempre più lunghe): credo che sia differente proprio i l modo di vedere.
Una bibUografìa corrente vuole documentare l'oggi (sia pure con quell'inevitabile ritardo rispetto alle pubblicazioni che è uno dei piccoH paradossi deUa bibhografìa), anche se poi le informazioni raccolte restano a disposizione per la ricerca retrospettiva, e quindi possono anche mutare di funzione, da informazione attuale per la decisione a fonte per la ricostruzione storica.
È questa prospettiva attuale che fa una bibliografìa regionale: non è solo per banali ragioni di dimensioni dell'impresa, credo, che l'imicu Regione italiana che si è cimentata nel campo deUa bibliografia regionale, quella deU'Umbria, abbia puntato — non so se come primo passo — su una bibliografia corrente, purtroppo non molto conosciuta anche se ricca e accurata, nonostante alcune scelte discutibili di strutturazione. M i riferisco alla Bibliografìa umbra, pubbUcata dal 1987 in volumi biennali ( i l primo copre gli anni 1982-1983) per iniziativa della Regione, che finanzia l'impresa, e con H contributo scientifìco e organizzativo dell'ateneo perugino, e in particolare del Centro per gli Studi Medievali e Umanistici (4).
Ma torniamo ai contomi di un possibile progetto. Per la questione dell'ambito territoriale, da affrontare con competenza storica e concretezza operativa, possiamo fare tesoro di quanto abbiamo ascoltato questa mattina dal prof. Pavoni e dal prof. Vamier.
Accanto all'ambito territoriale vanno defìniti, naturalmente, 1 criteri di selezione. Non si tratta, abbiamo detto, solo della storia e delle storie, ma di tut te le tematiche che interessino la nostra Regione e le diverse aree e località. Si tratta, insomma, di definire quella che gli esjìcrt i
<)()
(li raccolte di studi locali chiamano appunto "the locai connection", la connessione locale (o, meglio, territoriale).
Non rientrano in questo ambito, tanto per fare degli esempi, i l ibr i che siano semphcemente editi o stampati in Regione, o gli scr i t t i che siano meramente opera di autori l iguri . Ma è diffìcile anche pensare di accogliere in una bibliografìa regionale tut to quanto riguarda personaggi importanti, connessi con la Regione stessa (si potrebbe fare l'esempio di un Montale o di un Paganini), quando manca nei singoli studi xm effettivo riferimento alla Regione o alle località che ne fanno parte.
Per questa selezione si dovranno elaborare delle Uste di lavoro (di toponimi, di nomi di persone, ecc.), con appropriate direttive da precisare e quindi da verifìcare.
Al t ro problema, a cui accenno soltanto di sfuggita, è quello della selezione delle font i , dal materiale minore (effìmero, a circolazione l i m i tata od interna, comunque di forma "povera") ai diversi t i p i di periodici (pensiamo a quelli di informazione e di divulgazione, di attualità, fìno ai giornali, ai notiziari e bollett ini di enti ed associazioni, ecc.), e ancora alle diverse sezioni dei periodici stessi, con la possibilità di defìnire politiche differenziate e pit i o meno selettive (pensate, per esempio, anche nei periodici " d i studio", al problema delle rubriche, di recensioni, di segnalazioni, di cronache e notizie). È attraverso la defìnizione delle scelte più funzionali alle fìnalità poste, oltre che rispondenti alle risorse e ai tempi, che si reahzzeranno, a mio avviso, quelle esigenze di organicità che non potrebbero essere affidate a un'estemporanea selezione qualitativa, inappropriata e comimque non riducibile a criteri di imiformità e obiettività.
Definito l'ambito, sarà possibile fare una stima dell'entità dell 'impresa e mettere a punto strategie e procedure, oltre che, ovviamente, un tracciato uniforme per le registrazioni bibliografiche. È i l caso di aggiungere che i l nudo dato quantitativo dice assai poco, contrariamente a quanto spesso si crede, sulla portata di xm lavoro bibliografico. Questa dipende assai più dall'entità dei problemi bibliografici da risolvere che dalla quantità (semmai, dalla densità) del materiale che si affronta.
Sulla base dei criteri che abbiamo cominciato ad abbozzare e di alcuni sondaggi possiamo stimare del tu t to approssimativamente in circa 50.000 segnalazioni U materiale deU'ultimo quarantennio. Ma è facile capire che rintracciare decine di migliaia di aghi in un numero impreci-sato di pagliai è problema di complessità ben diversa, per esempio, dal-rim])acchettame qualche mihone all'uscita dalla fabbrica.
Soprattutto per le monografie si potrà partire, per esempio, da una
91
serie di riceichc di base sugli strumenti disponibili, generali e siìcciuli, privilegiando le basi dati accessibih su supporto informatico e dalle quah sia quindi possibile acquisire direttamente (scaricare) dati con cui costituire rma prima base di lavoro, ovviamente da verificare e convalidare oltre che da arricchire e normalizzare. Questa prima fase avrebl)c, tra l 'altro, anche xm. importante interesse come sperimentazione e defìnizione di strategie di interrogazione fìnahzzate agli studi locali e di arce. Ma bisognerà tenere conto anche delle bibliografìe tradizionali, generali e speciali, dei lavori bibliografìci già dedicati alla nostra regione, dei cataloghi delle biblioteche che hanno importanti raccolte su temi regionali o locali, di quelh delle case editrici hguri, ecc. (5)
La costituzione di ima prima base di lavoro, oltre a snellire e razionalizzare la rilevazione, potrebbe rivelarsi molto utile anche come guida per le fasi successive (per esempio, con l'individuazione di autori, {)erio-dici, collane, case editrici , ecc.). I n ogni caso le registrazioni, redatte ovviamente secondo una traccia normalizzata a cui si sta già lavorando, potrebbero confluire, tanto su carta quanto, preferibihnente, già su su])-porto magnetico (per esempio ricorrendo ai sempre più diffusi ed economici computer portati l i ) , a xm centro redazionale per l'aggiornamento dell'archivio di lavoro e la ridistribuzione dei dati stessi ai collaboratori e alle istituzioni attivamente coinvolte.
Gli esiti, quindi, potranno essere più di uno: una pubblicazione tradizionale, su carta, tramite la composizione elettronica, una messa a disposizione diretta, in forma di base dati offerta, fra gli altri servizi, dalle biblioteche e dalle ist ituzioni interessate, e soprattutto una edizione elettronica, su disco ottico (CD/ROM), mezzo ancora nuovo ma giù largamente sperimentato che sembra destinato a incidere profondamente suUa ricerca bibliografica.
I l disco ottico, infat t i , unisce ad una grande capacità di immagazzinamento xm costo di produzione molto moderato (tanto sul piano del costi fìssi iniziali quanto, ancor più, su quello dei costi di stampa delle singole copie) e xma grande comodità d'uso: può essere spedito come una lettera, letto con dispositivi di costo ormai molto modesto uniti ad un qualsiasi personal computer, e quindi impiegato con tutto l'agio che dà la consultazione locale, senza i costi e gli impacci dei collegamenti telematici, usufruendo anche di software di ricerca già in j)arte normalizzati e assai più ricchi ed amichevoli di quelli consueti nelle banche dati remote. Inoltre, i dati desiderati possono essere copiati, semplicemente premendo un tasto, in im archivio di lavoro per inserirli , i)er
98
c H c i i i i ) i ( ) , in un lesto che si sta elaborando con un qualsiasi sistema di vldeoscrittura.
Anche i l l imite di "staticità" di questo mezzo, rispetto alle banche da(i tradizionali, può essere facilmente superato. Certo un'impresa b i -l)liografìca è sempre tm work in progress. Ma anche da questo punto di vista le prospettive sono molto positive: è possibile infat t i un'integrazione tempestiva, su normali dischi magnetici, e l'aggiornamento o anche la sostituzione con un nuovo disco, con costi e disagi enormemente inferiori a quelli della sostituzione di una volmninosa opera b i bliografica su carta.
Finiamo ancora con alctmi accenni, sempre in via di ipotesi, ai cr i teri bibliografìci. L'informazione dovrà essere, ovviamente, corretta e completa, nei l i m i t i propri di una segnalazione, senza indulgere a presunte economie e piccoli vizi che quasi sempre segnano i lavori affrontati con impreparazione (per esempio, l'omissione dei nomi completi degli autori, dei dati editoriali, delle collane, ecc.).
Bisognerà, comunque, che le segnalazioni esphcitino chiaramente, anche se nella forma più breve, l'effettivo contenuto dei documenti, per fornire elementi per la scelta da parte del lettore. Ma solo in i m contesto operativo si potrà verifìcare la possibilità di coUegare aUa nuda segnalazione una annotazione dettagliata, un abstract, o eventualmente (li ricorrere — soprattutto pensando alle possibilità di ricerca offerte dalla pubblicazione elettronica — a informazioni riprese direttamente dai documenti stessi (sommari, indici), anche con tecnologie avanzate di gestione di immagini.
E bisognerà pensare anche al momento successivo della ricerca, al momento cioè in cui i l fruitore ha individuato i l materiale che lo interessa ma deve entrarne in possesso, consultarlo, riprodurlo, leggerlo. Se nella realtà italiana già l'individuazione bibliografìca è spesso problematica, l'accesso al documento costituisce da noi, quasi sempre, un vero collo di bottiglia. Naturalmente non ci si può proporre i l compito — improprio prima che irrealizzabile — di segnalare tutte le biblioteche che possiedono un certo libro o un certo periodico. Si tratterà, invece, di indicare alctme localizzazioni signifìcative, preferibilmente nelle b i blioteche che offrono un servizio più ampio e aperto a t u t t i , e nei maggiori centri del territorio.
Chi ha avuto occasione di fare ricerca in questo campo non si stupirà (juanto, a lavoro completato, risulterà con ogni probabihtà che anche le maggiori biblioteche deUa Regione possiedono solo ima modesta (luola del materiale segnalato, che tante saranno le biblioteche anche
9»
minori che |)(ilninni) daic un contributo unico, e che non i)oc() materiale risulterà reperibile soltanto fuori dai confìni regicmali.
U n lavoro di questo tipo, quindi, potrà costituire anche la base i)ei-una cooperazione bibliografìca, nel settore degli acquisti, anche retrospettivi. Quando si parla di questo tema, per le biblioteche, se ne ha spesso una visione distorta, tut ta negativa, di interferenza se non di vero e proprio divieto. La cooperazione bibliografìca fra le biblioteche è tutt 'al tra cosa, non consiste nel porre dei l i m i t i alle scelte che ogni istituzione deve responsabilmente compiere sulla base delle sue finizioni , della sua utenza e delle sue risorse.
A l contrario, la cooperazione bibhografìca è un libero e volontario impegno, da parte delle istituzioni che v i partecipano, a garantire nell'interesse di t u t t i una copertura U più possibile esauriente in un certo ambito, predeterminato e concordato, e una adeguata circolazione delle informazioni, in maniera da poter contare — tanto in ambito corrente quanto in ambito retrospettivo — su tm sistema di controllo bibliografico organico e trasparente, a cui tanto le biblioteche quanto gh studiosi e t u t t i gh utenti possano fare efficacemente riferimento.
N O T E
1. C f r . R i n o P e n s a t o , V a l e r i o M o n t a n a r i , Le fonti locali in biblioteca. M i l a n o , l ìdllclee
BibUograf lca , 1 9 8 4 ; i a memoria hmga. Le raccolte di storia locale dall'erudizione alla
documentazione. A t t i del C o n v e g n o , Ca g l ia r i 2 8 - 3 0 aprile 1 9 8 4 , a evira di P a o l a B e r t o l u c
c i e R i n o P e n s a t o . M i l a n o , E d i t r i c e Bibl iograf ìca , 1 9 8 5 .
8 . n sistema portuale della Repubblica di Genova, a c u r a d i G i o r g i o D o r i a e P a o l a M a s s a
Piergiovanni . G e n o v a , S o c i e t à L i g u r e di S t o r i a P a t r i a , 1 9 8 8 , p . 7.
3 . L e bibl ioteche del la R e g i o n e s o n o c e n s i t e e p r e s e n t a t e , c o n informazioni e s H c i i z l u l l
suUe loro r ac c o l te , n e l v o l u m e Dove e quando leggere e studiare in Liguria. Guida breve
ai servizi delle biblioteche della Regione, a c u r a di E m e s t o B e l l e z z a e P a o l a R o s s i , G e n o
v a , A s s o c i a z i o n e I t a l i a n a B i b h o t e c h e — S e z i o n e L i g m e , 1 9 8 7 ( B i b l i o t e c h e e fondi l ibriui
i n L i g u r i a , 2 ) .
4 . Bibliografìa umbra. Bollettino bibliografico, a c u r a d i C l a u d i o L e o n a r d i , E n r i c o Mene-
s t ò . 1 ( 1 9 8 2 - 1 9 8 3 ) . M i l a n o , E d i t r i c e B i b h o g r a f ì c a , 1 9 8 7 .
5 . U n a p r i m a ricognizione in a l c u n i c a m p i , c h e per i m a for t imata c o i n c i d e n z a e s c e pro
prio i n o c c a s i o n e del convegno di oggi, è offerta dal la Guida bibliografìca della Liguria.
Libri e biblioteche. Letteratura, Storia medievale. Storia moderna. Arte. Contr i ln i l i di U u i r a
Malfat to , A n n a L i s a N u t i , M a r i o F r a n c e s c h i n i , R o m e o P a v o n i , E l i s a b e K a l 'apone, A n n a
Dagnino, E l e n a Manara , G e n o v a , A s s o c i a z i o n e I ta l iana Bibl ioteche — Sezione Ligure , 1 9 9 0
( B i b h o t e c h e e fondi l ibrar i i n L i g u r i a , 4 ) .