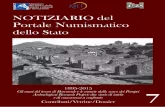I disegni di architettura e di urbanistica del fondo farnesiano nell’Archivio di Stato di Napoli.
Il portale di Sant’Aquilino nella basilica di San Lorenzo a Milano. Una nuova ipotesi...
-
Upload
beniculturali -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Il portale di Sant’Aquilino nella basilica di San Lorenzo a Milano. Una nuova ipotesi...
IL FREGIO FIGURATO DELL’ARCHITRAVE DEL PORTALE DI SANT’AQUILINO NELLA BASILICA DI SAN LORENZO IN MILANO 173
Il portale marmoreo che segna l’ingresso alla cap-pella di Sant’Aquilino nella basilica di San Loren-zo costituisce senza alcun dubbio una delle testi-monianze più significative dell’epoca romana pre-senti nella città di Milano e, per la sua originalitàe il suo stato di conservazione, nel complesso ab-bastanza buono, ricopre un ruolo di primo pianofra i non numerosi esemplari di questa tipologiamonumentale giunti a noi dall’antichità 1.Il portale (Fig. 1), realizzato in marmo lunense,misura m 4,82 di altezza e m 3,7 di larghezza, conuna luce di m 4,2×2,62. Gli stipiti, formati ciascu-no da tre blocchi giustapposti, presentano un com-plesso apparato decorativo distribuito su tre fasce:l’interna e la mediana recano una decorazione acandelabri vegetali a sviluppo verticale, variamentealternati a kantharoi, figure animate e “quadretti” asoggetto vario, mentre la fascia più esterna è ador-na di un fregio continuo di girali di acanto del tipoa tralcio ondulato. L’architrave, pure costituito datre blocchi marmorei, presenta una fascia inferio-re con motivi vegetali a festone, una mediana consuccessione di aquile reggenti ghirlande con il bec-co, intervallate da thymiateria, ed una superiore chepresenta otto personaggi alla guida di carri o mon-tanti un cavallo alternati a conchiglie a pettine
contenenti figure di delfini o di uccelli al propriointerno. Una cornice architettonica formata, dal-l’interno verso l’esterno, da un kyma ionico, un’al-ta baccellatura ed un listello liscio, corre poi lungotutto il margine esterno del portale.Il suo reimpiego in questa collocazione viene ge-neralmente considerato contemporaneo alla rea-lizzazione del complesso architettonico diSant’Aquilino – databile, secondo un’ipotesi lar-gamente invalsa, al primo quarto del V secolo d.C.2
– giudizio questo confermato anche dall’identitàdelle malte di supporto presenti nelle pareti adia-centi ad esso e presso i mosaici della cappella stes-sa, rilevata in occasione dei restauri effettuati al-l’inizio degli anni Ottanta. Il riutilizzo, inoltre, hacomportato l’asportazione di una porzione dellaparte inferiore degli stipiti che risultano, peraltro,poggiare su un piano ad un livello inferiore a quellodell’attuale basilica.
Il portale ha da sempre suscitato l’interesse deglistudiosi e dei cultori di antichità, che lo hanno spes-so ricordato e descritto nelle loro trattazioni sullastoria e sull’arte della città. Vale qui la pena diricordare, almeno, il più illustre di costoro, l’ar-chitetto Carlo Amati, professore presso l’Accade-
Alberto Bacchetta
IL FREGIO FIGURATO DELL’ARCHITRAVE DEL PORTALE DI SANT’AQUILINO NELLA
BASILICA DI SAN LORENZO IN MILANO. UNA NUOVA IPOTESI INTERPRETATIVA *
* Desidero ringraziare innanzitutto la professoressa Gemma Sena Chiesa per avermi dato l’opportunità di approfondirequesto argomento nel quadro del corso di Archeologia e Storia dell’Arte greca e romana da Lei tenuto presso la Scuola diSpecializzazione in Archeologia dell’Università degli Studi di Milano nell’Anno Accademico 1998/99 e per i consigli di cui èstata prodiga durante tutta la ricerca. Sono grato al dottor Angelo Maria Ardovino, Soprintendente Archeologo della Lombar-dia, per il permesso accordatomi allo studio del monumento e all’utilizzo del rilievo del portale. Un riconoscimento particolareva anche al dottor Fabrizio Slavazzi, che ha costantemente seguito lo svolgimento e la revisione finale di questo lavoro, semprecon grande attenzione e disponibilità, e alla professoressa Maria Teresa Grassi per i preziosi suggerimenti che mi ha fornito.Spunti di riflessione interessanti mi sono venuti dal dottor Matteo Cadario che ringrazio anche per la sua continua disponibilitàalla discussione degli argomenti di questo studio. Le fotografie del portale presentate nell’articolo sono da ascriversi al meritodella dottoressa Elisabetta Gagetti, il cui contributo si è rivelato fondamentale. Esse vengono pubblicate su concessione delMinistero per i Beni e le Attività Culturali e non sono ulteriormente riproducibili, con qualsiasi mezzo, senza espressa autorizza-zione. Infine, last but not least, una menzione particolare per il dottor Stefano Pozzi, prezioso amico “romano”.
1 Ricordiamo almeno, fra i più importanti e meglio conservati, il portale dell’Edificio di Eumachia nel Foro di Pompei,datato generalmente agli inizi del I secolo d.C., quello del cosiddetto Tempio di Romolo sulla Via Sacra a Roma, di etàseveriana, e alcuni esemplari di area mediorientale, come il portale d’ingresso del cosiddetto Tempio di Bacco a Heliopolis-Baalbek in Siria, datato agli inizi del II secolo d.C., e, sempre in Siria, quelli presenti nel frontescena, di epoca severiana, delteatro di Hierapolis.
2 Si veda da ultimo, per la complessa questione relativa alla datazione della basilica e alle diverse ipotesi in proposito:COMPLESSO LAURENZIANO 1990.
IL FREGIO FIGURATO DELL’ARCHITRAVE DEL PORTALE DI SANT’AQUILINO NELLA BASILICA DI SAN LORENZO IN MILANO 175
mia di Brera e autore di vari studi di architettura eantiquaria, che del monumento si occupò con unacerta ampiezza nella sua opera del 1821 riguar-dante le Antichità di Milano esistenti presso San Lorenzo,in cui ci fornisce anche il primo rilievo del portalee delle sue complesse decorazioni. In tempi piùrecenti l’opera è stata analizzata in modo appro-fondito soltanto da Carlo Albizzati in un articolodel 1937 che costituisce, a tutt’oggi, l’unico studiocomplessivo realizzato su di essa. I suoi giudizi e leconclusioni a cui egli giunse sono poi state di fattoripresi, senza sostanziali novità, da tutti gli studio-si successivi, che, d’altro canto, nei loro lavori han-no sempre toccato l’argomento solo incidentalmen-te, all’interno di trattazioni più generali sulla basi-lica o sull’area archeologica di San Lorenzo 3.Anche noi, d’altronde, in questa sede non affron-teremo tutte le complesse problematiche riguar-danti il portale e le sue decorazioni, cosa che ri-chiederebbe uno studio di ben più ampio respiro,ma limiteremo la nostra analisi soltanto ad unaspecifica parte di esso, vale a dire il fregio figurato(detto anche “fregio dei pianeti”) che occupa, comegià accennato, la fascia centrale dell’architrave.
IL FREGIO FIGURATO: ANALISI ICONOGRAFICA
Il fregio figurato dell’architrave costituisce l’ele-mento decorativo più importante dell’intero por-tale, l’unico ad avere uno sviluppo, per così dire,“narrativo”, pur nella ripetitività e corrisponden-za simmetrica delle figure che lo compongono,l’unico a possedere un significato specifico ed ori-ginale, che va al di là dei limiti delle rappresenta-zioni di repertorio che ritroviamo nelle altre partidel monumento. La sua stessa posizione, se da unlato rende piuttosto difficoltosa una lettura chiarae precisa dei particolari a favore di una visione d’in-sieme (possibile, peraltro, solo da una certa distan-za), rivela, d’altra parte, esplicitamente il ruolocentrale da esso svolto nell’economia dell’opera,sottolineato anche dalla maggiore spazialità, dalminore affastellamento delle figure rispetto allefasce decorative degli stipiti e allo stesso fregio sot-tostante con successione serrata di aquile reggi-
ghirlande, quasi a voler facilitare l’individuazionedelle singole componenti, facendole risaltare tra-mite il loro inserimento in ampi spazi vuoti.
Il fregio misura in lunghezza m 3,55 ed ha un’altez-za di circa cm 15. Vi sono raffigurati otto personag-gi disposti specularmente, quattro per parte, con-vergenti verso il centro: i due più esterni montanoun cavallo, mentre tutti gli altri sono alla guida diuna biga, con l’eccezione della terza figura da sini-stra che regge, invece, una quadriga. Ogni figura èseparata dalla successiva da una grande conchigliaa pettine (sette in tutto) al cui interno sono raffigu-rati, alternativamente, una coppia di uccelli in po-sizioni varie (partendo da destra, li troviamo nellaprima, terza, quinta e settima conchiglia) ed una didelfini rivolti verso il basso, in posizione divergente,con le code intrecciate (nella seconda, quarta e se-sta conchiglia). Alle due estremità del fregio si nota-no due coppie di elementi conici di forma allunga-ta, ognuno cinto, a circa tre quarti dell’altezza, dauna sorta di anello orizzontale, emergenti dalle fo-glie terminali del fregio con girali degli stipiti: laloro identificazione con mete circensi, avanzatadall’Albizzati 4, risulta del tutto convincente e costi-tuirà, come vedremo in seguito, il punto di parten-za per una possibile interpretazione dell’insieme.Lo stato di conservazione del fregio (sottoposto arestauro, insieme al resto del monumento, nei pri-mi anni Ottanta) è, nel complesso, abbastanza buo-no; non mancano, tuttavia, alcune marcate fratturedi andamento verticale e tre grosse lacune che han-no compromesso in modo significativo l’integritàdi due conchiglie (la quarta e la quinta da destra) esoprattutto di una figura su biga (la quarta da de-stra) di cui mancano buona parte del capo e lo spa-zio compreso tra il personaggio e i cavalli (una inte-grazione a stucco raffigurante uno scudo circolare,ancora presente nei rilievi effettuati dalla Soprin-tendenza Archeologica prima dei restauri, è stataasportata nel corso di questi ultimi). Inoltre, la fa-scia presso il margine superiore nella parte centraledel fregio risulta assai consumata e ribassata,cosicchè non riescono facilmente leggibili i partico-lari di alcune delle figure qui presenti.
3 Fra i lavori più recenti si ricordano: BASILICA SAN LORENZO 1951; SAN LORENZO 1985; COLONNE SAN LORENZO 1989;VIA SACRA 1991. Si vedano, inoltre: ROFFIA 1982 e COMPLESSO LAURENZIANO 1990.
4 ALBIZZATI 1937, p. 63.
A. BACCHETTA176
Come già precedentemente accennato, l’unico stu-dio complessivo sul portale di Sant’Aquilino è quel-lo, risalente ad oltre sessanta anni fa, effettuato daCarlo Albizzati, al quale si deve pure la sola ipote-si interpretativa coerente sul significato del fregio:a tale ipotesi si sono poi rifatti praticamente tuttigli studiosi successivi, di solito accettandola inte-ramente e riproponendola senza alcun approfon-dimento. Anche i pochi che ne hanno messo indubbio, in tutto o in parte, la validità non hannoperò saputo o potuto avanzare che proposte inter-pretative assai generiche e prive di validi fonda-menti documentari 5.In sostanza, Albizzati identifica i singoli personaggicome divinità celesti, personificazioni di pianeti,dando alla scena un valore simbolico in chiave co-smologica: la corsa delle divinità sui carri, pertan-to, rappresenterebbe simbolicamente il movimentodegli astri nelle loro orbite celesti. Partendo da sini-stra avremmo perciò: Mercurio, Sole, Giove, Mar-te, un personaggio alato identificabile con Vittoriao con un Genio in sostituzione di Saturno (astroinfausto e portatore di sventura la cui presenza sul-l’ingresso di un edificio, secondo l’autore, sarebbestata di cattivo augurio), Venere, Luna, Lucifero.La presenza di quelle che sono, indubbiamente, dellemete circensi alle due estremità della raffigurazio-ne viene dallo studioso spiegata in chiave astrologi-co-divinatoria, ricordando, sulla scorta di un passo
di Giovenale (Sat., VI, 582), come presso la spinadel circo fosse uso di «gettar le sortes, ossia trarreuna specie di oracolo, che si poteva considerarecome una specie di rivelazione dei numi superni» 6.Quanto alle coppie di animali, uccelli e delfini,raffigurati nelle conchiglie alternate alle divinitàplanetarie, essi starebbero ad indicare, rispettiva-mente, il Cielo e l’Oceano, che qui si accompa-gnerebbero così ai “numi del firmamento”, oltread essere, di per se stessi, animali riconducibili avarie divinità.L’ipotesi interpretativa di Albizzati, per quantocoerente e sostenuta da una logica d’insieme, pre-senta tuttavia numerosi punti deboli e passaggiforzosi. In primo luogo, la serie planetaria è, diregola, composta di sette pianeti e non di otto:Lucifero, infatti, non viene considerato come pia-neta e non compare mai nelle rappresentazionidegli dei planetari 7. Inoltre, l’assenza di Saturnodalla serie non è giustificabile semplicemente ad-ducendo il suo carattere negativo, peraltro bennoto: nelle raffigurazioni degli dei cosmici, infatti,egli compare normalmente, raffigurato come unuomo di età matura, quando non espressamentecaratterizzato dai tratti della vecchiaia, con unafolta barba scura, abbondante capigliatura, spes-so con il capo velato e lo sguardo piuttosto torvo,confacente alla sua fama nefasta 8. La sua sostitu-zione con una figura di Vittoria alata, poi, appare
5 MIRABELLA ROBERTI 1984, p. 200 vede nella scena una rappresentazione di giochi funebri, connessa alla originariadestinazione funeraria di Sant’Aquilino come mausoleo imperiale, ma non spiega i motivi della scelta dei vari personaggi, perla cui identificazione si rifà sostanzialmente ad Albizzati (anche se ne “dimentica” uno: ne cita infatti solo sette anzichè otto!).DAVID 1991, pp. 55-56 critica l’atteggiamento di quegli studiosi che si limitano a ripetere acriticamente le conclusioni diAlbizzati, rilevando la necessità di un approfondimento delle tematiche relative al portale ed in particolare al significato delfregio, ma poi, per parte sua, non avanza alcuna nuova proposta al riguardo.
6 ALBIZZATI 1937, p. 64.7 Tra le raffigurazioni più famose e complete di divinità planetarie si vedano, a titolo di esempio: il grande mosaico
pavimentale di Bir-Chana (Tunisia), conservato al Museo del Bardo e databile al tardo II secolo d.C. in cui compaiono i bustidelle sette divinità entro riquadri esagonali, circondati dai relativi animali sacri e dai segni zodiacali (DUNBABIN 1978, pp. 161e 249, tav. LXIV, nr. 162); il rilievo votivo di Wiesbaden dedicato alla triade Minerva-Vulcano-Mercurio dove, al di sopra dellefigure intere delle tre divinità oggetto del culto, compaiono gli dei planetari a mezzo busto (cfr. BAUCHHENSS, SIMON 1992, p.543, nr. 445); un’ametista di provenienza egiziana di I-II secolo d.C. conservata al British Museum dove il busto di Serapide,al centro, è circondato da due fasce concentriche occupate dai busti degli dei astrali e dai segni zodiacali; e, soprattutto, ilgrande mosaico di Orbe (Svizzera) datato al primo quarto del III secolo d.C. dove le divinità planetarie sono raffigurate, entroriquadri esagonali, in vari atteggiamenti (a cavallo, alla guida di un carro, sedute in trono), circondate da numerosi personaggidivini o mitologici e dai busti delle Stagioni (cfr. VON GONZENBACH 1961, pp. 184-194, tavv. 60-67). I busti dei quattro pianetiprotettori dei giorni fausti della settimana (Sole, Giove, Mercurio, Luna) sono raffigurati sulla facciata di una bottega pompe-iana di feltrai (IX 7, 1) aperta su Via dell’Abbondanza. Utili, per una trattazione generale dell’argomento con le sue varieimplicazioni, risultano GUNDEL 1970 e SIMON 1997.
8 Così compare nelle raffigurazioni precedentemente ricordate: in particolare, nel mosaico di Bir-Chana occupa unaposizione di assoluto rilievo, al centro del mosaico, circondato dalle altre divinità. Sul rilievo di un attingitoio in argentorinvenuto a Wettingen in Svizzera, e ora perduto, compare accanto agli altri dei vestito di una lunga tunica e con in mano unfalcetto (si veda il disegno in SIMON 1997, p. 1005, nr. 13).
IL FREGIO FIGURATO DELL’ARCHITRAVE DEL PORTALE DI SANT’AQUILINO NELLA BASILICA DI SAN LORENZO IN MILANO 177
del tutto priva di spiegazione: quale legame po-trebbe unire, infatti, i due personaggi tanto da faredi una la sostituta dell’altro? Infine (ma è, in real-tà, l’obiezione principale e costituirà il punto dipartenza per le considerazioni che svilupperemoqui di seguito) assai poco convincente appare laproposta di un collegamento tra il mondo del cir-co (indicato in modo inequivocabile dalla presen-za delle mete) e le divinità planetarie riconducibi-le semplicemente alla consuetudine di trarrevaticini presso la spina circense, vaticini che peral-tro, a ben vedere, poco o nulla hanno a che farecon l’astrologia propriamente detta, ricollegando-si, piuttosto, a pratiche divinatorie o genericamente“magiche” di sapore popolare. Tutte queste con-siderazioni critiche ci inducono a rivedere l’ipote-si interpretativa avanzata a suo tempo da Albizza-ti e a cercare una nuova possibile spiegazione perquesta originale rappresentazione.
Il primo passo verso questo obiettivo non può cheessere una puntuale indagine iconografica dei di-versi personaggi così da poterne fissare, con lamaggior sicurezza possibile, le singole identità. Edè appunto in questa prima fase che, come si vedrà,l’analisi dello studioso mantiene ancora pressochèintatta gran parte della sua validità: le identifica-zioni proposte (basate, d’altronde, su attributi ico-nografici quasi sempre assai perspicui) risultano,infatti, in larga misura pienamente accettabili, purcon alcune modifiche e precisazioni più strettamen-te dipendenti dall’interpretazione complessiva delvalore simbolico da attribuire alla scena.
Cominceremo la nostra analisi dalle figure chemontano un carro, lasciando per ultime quelle dicavalieri.
Partendo da sinistra troviamo un personaggiomaschile (Fig. 2), ritto sul carro di profilo con la
testa rivolta verso l’esterno che regge saldamentecon entrambe le mani le redini. Dietro le sue spal-le si nota l’ampio svolazzo di una clamide, che sot-tolinea efficacemente il rapido movimento del car-ro, mentre non risulta possibile esprimere un giu-dizio sicuro sulla probabile nudità della figura.Porta sulla testa, come attributo distintivo, unacorona di alti raggi che pare sorgere direttamenteda dietro il capo, più che esservi poggiata sopra.L’identificazione del personaggio con il dio Solerisulta del tutto condivisibile, anche sulla base deiconfronti adducibili 9, benchè strana appaia qui lamancanza della frusta, suo attributo consueto, esoprattutto la sostituzione della classica quadrigacon una semplice biga: la scelta deve forse spiegarsicon il desiderio, da un lato, di accomunare il Solealle altre divinità, ponendolo sul loro stesso piano e,dall’altro, di mantenere una corrispondenza ed unequilibrio simmetrico fra le figure delle due parti,per non sbilanciare troppo la composizione.
La figura seguente, anch’essa maschile (Fig. 4), mon-ta, unica fra tutte, una quadriga di cui regge le redinicon la sinistra mentre con la destra protesa all’indie-tro impugna un oggetto di forma allungata identifi-cabile, con ogni verosimiglianza, con un fulmine 10.La testa è priva di copricapo, con i capelli che for-mano una sorta di “calotta” compatta; sul viso si pos-sono intravvedere, con una certa difficoltà dato ilcattivo stato di conservazione, i resti di una cortabarba. La figura appare connotata da una marcatadinamicità, sottolineata dall’ampio gesto del bracciodestro che “apre” alla vista l’intera parte superioredel corpo (forse ricoperto da una lorica) e dallo svo-lazzo di un piccolo mantello avvolto intorno al brac-cio sinistro. Dinamica è anche la rappresentazionedei cavalli, raffigurati in una disposizione “a scalare”in modo da metterne in evidenza con chiarezza ilnumero e a suggerire la profondità spaziale, secondouna soluzione iconografica di origine ellenistica. An-
9 Numerose sono le raffigurazioni di Sol alla guida di un carro presenti su sarcofagi, come quello proveniente da Ostia aWarwick Castle (ROBERT 1897, tav. XXIV, nr. 83); belle immagini del dio troviamo anche nel già citato mosaico di Orbe, in unrilievo di III secolo a Bruxelles (ESPÉRANDIEU 1913, nr. 4134; LETTA 1988, p. 602, nr. 142) e in un tondo dell’arco di Costantino(DE MARIA 1988, tav. 98, nr. 2). Importante è la rappresentazione presente su un eliotropio della collezione Leo Metz(VOLLENWEIDER 1984, nr. 445), datato al II-III secolo d.C., in cui il dio appare alla guida di una biga, come nel nostro caso,anzichè della consueta quadriga (Fig. 3).
10 Per quanto difficoltosa risulti un’analisi di questo elemento, sembrerebbe di poter vedere nel fulmine qui raffigurato unesemplare del tipo detto “a fascio di giunchi”, una sorta di grande torcia in cui le lingue di fuoco sono raccolte in una compattastruttura fusiforme, stretta al centro da una fascia che funge da “impugnatura”. Per una descrizione più approfondita dei varitipi di fulmine che compaiono nell’iconografia greca e romana si veda FOUGÈRES 1896 (in particolare pp. 1358-1359).
A. BACCHETTA178
Fig. 3 – Eliotropio con raffigurazione del dio Sole allaguida di una biga; provenienza sconosciuta (collezioneLeo Metz).
Fig. 2 – Sole.
che in questo caso l’identificazione della figura ap-pare indubbia: si tratta, evidentemente, di Giove, ladivinità suprema, la cui posizione di dominio suglialtri dei è sottolineata dalla esclusività della quadri-ga, alla guida della quale lo troviamo sempre raffigu-rato 11. Il fulmine è il suo attributo più caratteristico,cui spesso si accompagna anche lo scettro, solitamentedi grandi dimensioni, che però, nel nostro caso, man-
ca: evidentemente si è ritenuto che non fosse neces-sario anche questo elemento per rendere immedia-tamente individuabile, senza possibilità di dubbio,l’identità della figura.
Anche il personaggio che precede, nell’ordine,Giove è sicuramente maschile (Fig. 5): esso si pre-senta con il busto di tre quarti, il braccio destroritratto a reggere una lunga asta la cui estremitàinferiore si prolunga fino ad incontrare la base dellaconchiglia e, dietro al braccio, il lembo svolazzan-te del mantello. L’asta deve probabilmente passa-re dietro il corpo dal momento che la parte supe-riore di essa non appare individuabile davanti allafigura; il torso, per quanto difficile sia esprimereun giudizio certo, sembrerebbe loricato, anche sei segni che si intravvedono su di esso potrebberopure essere interpretati come i tratti marcati dellamuscolatura del petto. La testa è andata in granparte perduta per cui mancano interamente i line-amenti del volto; ben visibile è, al contrario, il pro-filo dell’alto cimiero crestato che corona l’elmo.Come già ricordato in precedenza, il restauro haeliminato per intero le integrazioni in stucco nellospazio anteriore alla figura dove si trovava uno scu-
11 I confronti per questa figura sono, ovviamente, numerosi e molto puntuali; si veda, a puro titolo di esempio, il grandecammeo del Museo Nazionale di Napoli, datato al III-II secolo a.C., dove il dio è raffigurato, nella stessa posizione, nell’atto ditravolgere dei giganti anguipedi (NAPOLI 1994, p. 346) nonché le frequenti raffigurazioni monetali, come quella su una didrammad’argento del 225-212 a.C. (CRAWFORD 1974, p. 144, nr. 28/3, tavv. II-IV; CANCIANI 1997, p. 452, nr. 353) o su un denario diT.Annius Rufus del 144 a.C. (CRAWFORD 1974, p. 259, nr. 221/1, tav. XXXV; CANCIANI 1997, p. 452, nr. 354).
IL FREGIO FIGURATO DELL’ARCHITRAVE DEL PORTALE DI SANT’AQUILINO NELLA BASILICA DI SAN LORENZO IN MILANO 179
Figg. 4-5 – 4. Giove; 5. Marte.
do circolare sorretto dal braccio sinistro (lo stessoche, evidentemente, impugnava le redini): nulla,pertanto, possiamo dire di certo riguardo alla ef-fettiva esistenza, in origine, di tale elemento. Il per-sonaggio, per quanto sia il più seriamente com-promesso dalle fratture e dalle lacune che interes-sano l’intero architrave, risulta ugualmente iden-tificabile con certezza, come già messo in luce asuo tempo da Albizzati: ci troviamo, con ogni evi-
denza, davanti al dio guerriero per eccellenza, valea dire Marte. Tale identificazione è suffragata dauna serie di significativi confronti, soprattutto contipi monetali, che contribuiscono a chiarire l’aspet-to che la figura doveva avere nella sua interezza.Analogie stringenti si trovano con le immagini deldio appiedato, gradiente verso destra (il cosiddettoMars gradivus) presenti su un medaglione bronzeo diMarco Aurelio (177 d.C.) della zecca di Roma12 in
12 BAUCHHENSS, SIMON 1984, p. 528, nr. 217.
A. BACCHETTA180
cui il braccio destro appare sollevato a reggere untrofeo poggiato sulla spalla e la lancia impugnatadalla mano sinistra passa davanti al petto nudodella figura, su un medaglione bronzeo di Massi-miano (301-307 d.C.) da Cartagine 13, dove il dio,rivestito dalla lorica, regge con la sinistra uno scu-do ovale, nonché su un solido aureo di CostantinoII (337-340 d.C.) coniato a Treviri 14. Molto signifi-cativo è anche il confronto istituibile con l’immagi-ne presente su una corniola datata al II secolo d.C.di provenienza sconosciuta, conservata al RoyalCoin Cabinet di The Hague 15: qui il dio apparenudo, sempre gradiente a destra con il braccio sini-stro disteso e la mano aperta, che non regge nulla.Ma il particolare più importante, che illumina unasingolarità della nostra figura, è che la lancia, tenu-ta con la destra, passa dietro il corpo, secondo unadisposizione assai artificiosa e forzata, per ricompa-rire poi con l’estremità recante la punta presso laspalla sinistra. Quest’ultimo confronto chiarisce,quindi, in modo definitivo la particolare iconogra-fia di Marte presente nel rilievo, fugando ogni pos-sibile dubbio circa la sua identificazione (Fig. 6).
Riprendendo ora l’analisi delle figure da destra eprocedendo verso il centro, incontriamo per pri-mo un personaggio verosimilmente femminile(Fig. 7), avvolto per intero in una lunga veste dicui si intravvedono le pieghe e gli svolazzi dietrola schiena e, nella parte inferiore, appena sopra ilbordo del carro. Il corpo è posto di profilo e pre-senta della braccia decisamente sproporzionate inlunghezza: con la mano sinistra impugna le redinimentre il braccio destro, leggermente sollevato,appare completamente consunto all’estremità cosìche risulta impossibile individuare l’oggetto che,con ogni verosimiglianza, doveva in origine reg-gere (Albizzati ipotizza una frusta). La testa, voltadi prospetto verso lo spettatore è di forma tondeg-giante con i capelli, corti, a formare una calottacompatta; al di sopra del capo (anzi, per l’esattez-za, parzialmente dietro di esso) poggia un elemen-
to di forma vagamente semilunata che non risultain nessun modo interpretabile come un coprica-po, data la foggia del tutto inusuale e la stessa di-sposizione sulla testa. L’unica spiegazione possibi-le è di vedervi un crescente lunare sbozzato inmodo assai sommario (“una fetta di popone” se-condo il colorito giudizio di Albizzati), spiegazio-ne che comporta, come logica conseguenza, quel-la di riconoscere in questo personaggio la divinitàdella Luna, raffigurata secondo un’iconografiaampiamente attestata 16. L’identificazione trova unaconferma anche nella corrispondenza simmetricache la figura mostra con la personificazione delSole presente in posizione analoga nella parte si-nistra del fregio.
Notevoli problemi di identificazione presenta, in-vece, la figura successiva (Fig. 8): anch’essa sicura-mente femminile appare, come Luna, avvolta inuna lunga veste, cinta in vita, che la ricopre inte-ramente e di cui si individuano le estremità svo-lazzanti nella parte inferiore sopra il bordo delcarro mentre regge le redini con ambedue le mani.Il corpo è mostrato di profilo, la testa, invece, èleggermente volta verso l’esterno così da lasciareintravvedere appena l’occhio destro. I tratti delvolto sono assai rovinati così come difficilmenteleggibile appare il copricapo che la divinità sem-
13 RIC, VI, p. 430, nr. 45; BAUCHHENSS, SIMON 1984, p. 531, nr. 249.14 RIC, VIII, p. 140, nrr. 12-14, tav. 1; BAUCHHENSS, SIMON 1984, p. 528, nr. 219.15 MAASKANT, KLEIBRINK 1978, p. 117, nr. 667.16 Si vedano, ad esempio, il rilievo circolare dell’arco di Costantino (DE MARIA 1988, tav. 97, nr. 1; GURY 1994, p. 711, nr.
52), o i numerosissimi sarcofagi raffiguranti il mito di Endimione, dove Luna è sempre rappresentata avvolta in lunghe vestipanneggiate alla guida di una biga (tra gli esempi migliori cfr. ROBERT 1897, tav. XII, nr. 39; tav. XIII, nr. 47; tav. XIX, nr. 75b;tav. XXIV, nr. 83b).
Fig. 6 – Corniola con raffigurazione del dio Marteappiedato, cosiddetto Mars gradivus; provenienza sco-nosciuta. The Hague, Royal Coin Cabinet.
IL FREGIO FIGURATO DELL’ARCHITRAVE DEL PORTALE DI SANT’AQUILINO NELLA BASILICA DI SAN LORENZO IN MILANO 181
Figg. 7-8 – 7. Luna; 8. Venere (?).
bra portare: parrebbe una sorta di corona radiatadi cui sembra di poter scorgere la circonferenzainferiore con l’attacco di alcuni raggi ma il giudi-zio è assai incerto. Secondo Albizzati «è senzadubbio un nimbo radiato, che vuole indicare ilcarattere astrale della dea. E questa, in rapporto
alle figure che abbiamo fin qui riconosciute, nonpuò essere altri che Venus»17. Noi non ci sentia-mo, almeno per adesso, di poter condividere la si-curezza dello studioso circa questa identificazio-ne, dal momento che anche i confronti adducibilial riguardo non appaiono affatto risolutivi18.
17 ALBIZZATI 1937, p. 63.18 Si tratta soprattutto di tipi monetali che presentano Venere alla guida di una biga, priva di caratterizzazioni iconografiche
specifiche tali da permettere giudizi sicuri: si veda la serie di denari repubblicani di monetieri vari (Censorino, Crepusio, Limentano)datati al primo quarto del I secolo a.C. in cui la divinità è mostrata avvolta in una lunga veste e reggente una specie di cortobastone forse identificabile con uno scettro, priva di copricapo (BELLONI 1960, tav. 38, nrr. 1294-1295; tav. 39, nrr. 1368-1375) e
A. BACCHETTA182
D’altro canto, assai difficile risulta anche avanza-re proposte alternative circa l’identificazione diquesto personaggio, proprio a causa della assolutagenericità della figura e della scarsa leggibilità del-l’unico elemento caratterizzante che potrebbe ri-sultare utile a tale scopo. David19 sulla base dellaevidente corrispondenza esistente fra le figure nelledue parti del fregio propone di riconoscere in que-sta dea, speculare a Giove, la consorte del sovranodegli dei, vale a dire Giunone. Ma anche questaidentificazione, per quanto certo da non escluder-si a priori, ha come proprio fondamento questasola considerazione: nessun confronto iconografi-co, infatti, serve a suffragarla (anzi, il motivo diGiunone alla guida di un carro, al contrario diquanto accade per Venere, è del tutto ecceziona-le) senza contare che Giunone sarebbe l’unica di-vinità, almeno fra quelle fin qui considerate (ma,come si vedrà in seguito, il giudizio vale anche perle successive), a non possedere alcun carattereastrale, carattere questo che contraddistingue inmodo significativo tutti gli altri personaggi qui raf-figurati. In mancanza di ulteriori elementi, per-tanto, non possiamo che sospendere il giudizio:vedremo più avanti, quando formuleremo unaproposta interpretativa complessiva per il signifi-cato del fregio, come l’identificazione di questa fi-gura con Venere possa essere validamente soste-nuta in rapporto alle altre divinità presenti, all’in-terno di un quadro esegetico d’insieme, con unafondatezza maggiore di quanto non possa farsi orasu base esclusivamente iconografica.
L’ultima figura alla guida di un carro (Fig. 9) nonpresenta, almeno per quanto riguarda la questione
strettamente iconografica, alcun problema circa lasua identificazione. Si tratta di un personaggio fem-minile, volto di tre quarti verso lo spettatore, cheregge con la mano destra le redini mentre con lasinistra, poggiata sul parapetto della biga, impugnaun oggetto di forma circolare, cavo al proprio inter-no, interpretabile con buona sicurezza come unacorona (forse vegetale più che metallica, ma ognigiudizio al riguardo sarebbe del tutto azzardato).Dalla stessa mano sembra poi sorgere anche un al-tro elemento, di forma sottile e allungata, che si in-nalza appoggiandosi sulla spalla sinistra della divi-nità e poi proseguendo ancora fino a confondere ilproprio contorno nella parte alta del fregio, assairovinata: non può trattarsi, sulla base tanto dellaforma quanto dei confronti istituibili, che di un ramodi palma. La testa della figura è del tutto rovinata eilleggibile nei suoi tratti: si intravvedono appena duepiccoli fori, che ci danno una generica idea dellaoriginaria posizione degli occhi. Dietro la testa sivedono, se pure in modo confuso, due tratti a rilie-vo che, partendo dalle spalle, si allungano in scor-cio verso l’alto, dove risultano difficilmente leggibi-li a causa del già ricordato cattivo stato di conserva-zione del marmo: senza alcun dubbio, vista la loroforma e la posizione, si tratta di una coppia di gran-di ali e la loro presenza costituisce l’elemento defi-nitivo di conferma dell’identità del personaggio. Citroviamo, con ogni evidenza, davanti alla dea Vit-toria, raffigurata con i suoi due attributi più carat-teristici e ricorrenti nell’iconografia: la corona e lapalma, per l’appunto20. Difficile risulta, invece, giu-dicare se la divinità sia presentata nuda, come sem-brerebbe indicare la evidente presenza dell’ombe-lico chiaramente individuabile sul ventre della figu-
un’altra raffigurazione analoga su un denario di Sesto Giulio Cesare del 129 a.C. in cui la dea appare accompagnata da Eros(CRAWFORD 1974, p. 284, nr. 258/1, tav. XXXVII). Anche nelle citate rappresentazioni della serie di divinità planetarie Venerenon presenta, di solito, attributi particolari che servano a caratterizzarla e la sua identificazione deriva, quindi, soltanto dalcontesto: come eccezione a questa consuetudine possiamo ricordare un rilievo proveniente da Mainz datato al 210-220 d.C.(BAUCHHENSS 1984, pp. 40-41, nr. 32, tav. 56, 9) in cui la dea, priva, comunque, di copricapo o gioielli, reca tuttavia in mano unospecchio; tale oggetto compare associato a Venere anche nella raffigurazione della divinità presente sul già ricordato attingitoioargenteo da Wettingen. Curiosa, infine, è la raffigurazione presente su un famoso affresco pompeiano nella facciata dell’officinadi Verecundus, in cui essa appare, avvolta in un ampio mantello e diademata, con in mano un lungo bastone, alla guida di un carrotrainato da quattro elefanti (cfr. SCHEFOLD 1972, p. 64; SCHMIDT 1997, p. 219, nr. 302; POMPEI, IX, p. 776, nr. 2).
19 DAVID 1991, p. 55.20 Si vedano, tra le raffigurazioni migliori di questa divinità, un rilievo dell’Arcus Novus di Roma, conservato a Firenze,
datato al 293 d.C. (DE MARIA 1988, pp. 312-314, nr. 94, tav. 91, 1; VOLLKOMMER 1997, p. 242, nr. 24) dove la dea è presentatastante e le immagini di Vittoria su biga presenti su una corniola di I-II secolo d.C. a Copenhagen (VOLLKOMMER 1997, p. 247,nr. 94), su un denario di Ti.Claudio Nerone del 79 a.C (CRAWFORD 1974, p. 398, nr. 383/1, tav. XLIX) e su un affresco, oraperduto, a Pompei (IX 3, 5.24) casa di Marcus Lucretius (REINACH 1922, p. 144, nr. 7; POMPEI, IX, p. 208, nr. 98). In tutti questicasi la divinità reca come propri attributi la palma e la corona.
IL FREGIO FIGURATO DELL’ARCHITRAVE DEL PORTALE DI SANT’AQUILINO NELLA BASILICA DI SAN LORENZO IN MILANO 183
ra, o vestita, come si potrebbe dedurre dai segni sulpetto, interpretabili forse come pieghe di una veste,e dalla altrettanto evidente presenza di una sottilecintura che la cinge alta in vita. Per risolvere il pro-blema si potrebbe avanzare l’ipotesi di una sorta dicorsetto che veste la dea solo parzialmente, lascian-do nuda la parte inferiore del corpo, ma tale abbi-gliamento, piuttosto strano e inconsueto, non trovaalcun riscontro nell’iconografia ricorrente del per-sonaggio: in ogni caso si tratta di una questione deltutto marginale. Più importante è, invece, sottoli-neare come l’identificazione della figura con la deaVittoria se risulta, da un lato, in perfetta sintoniacon la corrispondente figura di Marte nel settoresinistro del fregio, dall’altro non trova una sua logi-ca ragion d’essere nel contesto di carattere marca-tamente “astrale” che fino a questo punto è parsodominante in questa rappresentazione. Anche inquesto caso non possiamo far altro che sospendere,per il momento, il giudizio, rimandando ad una fasesuccessiva del nostro studio la discussione appro-fondita dell’identificazione qui proposta che risul-terà, come vedremo, in parte da riconsiderare e damodificare, sulla base di considerazioni diverse daquelle puramente iconografiche qui svolte.
Come si può vedere, esiste una perfetta corrispon-denza tra le figure delle due parti del fregio: allefigure maschili del lato sinistro corrispondono al-trettanti personaggi femminili nel settore destro.Un significativo elemento, questo, che contribui-sce a quella ricerca di simmetria ed equilibrio che,come abbiamo già potuto rilevare, connota tuttala composizione.Il desiderio di realizzare una corrispondenza sim-metrica tra le parti si rileva anche dalla presenzadei due cavalieri che chiudono la composizionealle due estremità.Quello di sinistra (Fig. 10) si presenta di prospettoe monta direttamente la sua cavalcatura, senza usa-re nè sella nè redini: il braccio sinistro, infatti, èsemplicemente steso a toccare con la mano il collodell’animale, che non presenta finimenti di alcungenere. Il braccio destro, ripiegato, regge un ele-mento di forma piuttosto strana che può essereinterpretato solo come un caduceo di grandi di-mensioni, con due ali laterali assolutamente spro-porzionate, che occupano, con la loro apertura,tutto lo spazio restrostante la figura. Nonostantela stranezza della sua resa e delle dimensioni,l’identificazione dell’oggetto non pare dubbia 21.
21 Si vedano raffigurazioni di caducei del tutto analoghi, ma con ali di proporzioni più ridotte, su una cornalina diprovenienza egiziana datata all’ 80 a.C. conservata al Museo di Arte e Storia di Ginevra (VOLLENWEIDER 1979, tav. 122, nr. 4)e in un affresco di larario nell’atrio della casa I, 13, 12-14 a Pompei (POMPEI, II, p. 924, nr. 8); un altro esemplare, formatosoltanto dai due serpenti attorcigliati senza il consueto bastone centrale ma con alette laterali, si trova sul rilievo di un’ara
Fig. 9 – Vittoria.
A. BACCHETTA184
Impossibile, invece, risulta definire con sicurezzalo strano elemento che si trova davanti alla figurae che parrebbe quasi sospeso in aria: il cattivo sta-to di conservazione del marmo in questo puntonon permette di avanzare alcuna ipotesi al riguar-do. Il personaggio è, per quanto si può vedere,nudo e porta sulla testa, per il resto assai consun-ta, un copricapo recante sulla sommità due protu-beranze appuntite interpretabili come una coppiadi corna o, più verisimilmente, di piccole ali. I dueattributi della figura, caduceo e copricapo alato(petasos), non lasciano dubbi circa la sua identifica-zione con il dio Mercurio e una conferma definiti-va in tal senso viene dalle caratteristiche della suacavalcatura. Già Albizzati e poi altri autori dopodi lui 22 hanno messo in rilievo l’assoluta eccezio-nalità di Mercurio come figura equestre, spiegan-dola con l’esigenza di una concordanza rispettoalla serie delle altre divinità. In realtà, qui il dionon è presentato come figura equestre, almeno nonnel senso letterale del termine: la sua cavalcatura,infatti, non è affatto un cavallo, come si può nota-re chiaramente dalla stranezza del muso e, soprat-tutto, dalla presenza sulla testa di un elemento cir-colare spiraliforme evidentemente interpretabile
Fig. 10 – Mercurio.
Fig. 11 – Medaglione fittile per decorazione vascolarecon raffigurazione del dio Mercurio in groppa ad unariete; da Autun.
marmorea datata al I secolo d.C. conservata al Landesmuseum di Mainz (FRENZ 1992, p. 134, nr. 125, tav. 101, 3). Unamarcata sproporzione tra il caduceo e l’immagine della divinità si può, d’altronde, rilevare anche in altri casi, ad esempio inun affresco pompeiano nell’oecus della casa I, 12, 7 (POMPEI, II, p. 755, nr. 3).
22 DAVID 1991, p. 55.
come un corno e, nella fattispecie, un corno di arie-te. L’animale è, quindi, una sorta di ibrido: corpodi cavallo (anche se più tozzo e meno definito nei
IL FREGIO FIGURATO DELL’ARCHITRAVE DEL PORTALE DI SANT’AQUILINO NELLA BASILICA DI SAN LORENZO IN MILANO 185
particolari rispetto agli altri qui rappresentati, condei curiosi “alveoli”, di natura inspiegabile, neipunti di attacco delle zampe al tronco) e testa che,se non è propriamente quella di un ariete, a taleanimale certo intende alludere tramite le caratte-ristiche corna ritorte. L’artista ha, pertanto, intesoqui raggiungere, a nostro avviso, un doppio obiet-tivo: mantenere l’organicità della composizione,creando una figura di animale che non si distac-casse, nelle proporzioni e nell’aspetto generale,dalle altre cavalcature ma anche, nello stesso tem-po, richiamare, pur se solo in modo allusivo, lafigura dell’ariete, l’animale sacro a Mercurio, delquale è spesso raffigurato come destriero 23.
All’estremità destra troviamo un altro personag-gio maschile (Fig. 12), posto quasi perfettamentedi profilo, con la testa rivolta di tre quarti versol’esterno, in groppa, senza sella, ad un cavallo dicui regge le redini con ambedue le mani. La figu-ra, di cui non si riesce a giudicare con certezzal’abbigliamento, ha forme abbastanza pesanti,quasi infantili; la testa è scoperta e si riesce appe-na ad intravvedere una capigliatura a riccioli. Dallespalle spunta una protuberanza piuttosto marcatainterpretabile forse come un’ala o, meno proba-bilmente, come lo svolazzo di un mantello. Nelprimo caso, la figura troverebbe strettissimi con-fronti nelle immagini di Eroti impegnati in garecircensi assai diffusi sui sarcofagi infantili di II-IIIsecolo d.C. 24 in cui, accanto agli Amorini impe-gnati nella guida dei carri, si notano spesso figure
analoghe montate su destrieri, in funzione didesultores o iubilatores 25. Tale identificazione, oltre aessere ben fondata dal punto di vista iconografico,si adatterebbe perfettamente al contesto circensedi questa rappresentazione sottolineato, come ab-biamo già avuto modo di mettere in luce, dall’esi-stenza delle mete alle due estremità. Difficile, tut-tavia, riuscirebbe spiegare la presenza di un Erotein un contesto di divinità astrali, carattere che,come pure si è già visto, risulta essere l’altra con-notazione specifica di questo fregio.È possibile, però, avanzare anche una seconda in-terpretazione di questo personaggio, fondandolatanto su una base iconografica quanto sull’appor-to di alcune fonti scritte. Se consideriamo ancorala protuberanza della spalla del nostro fanciullocome un’aluccia non ci sarà difficile trovare deiconfronti significativi per questo personaggio, adesempio, in alcuni sarcofagi con il mito di Seleneed Endimione. Accanto alla dea si trova sempreun giovane alato, talora rappresentato con fattez-ze marcatamente infantili, nudo o, al massimo,avvolto in un manto svolazzante, reggente di soli-to una fiaccola accesa: si tratta di Hesperus, la stelladella sera. Non di rado, poi, i fanciulli alati sonodue, del tutto simili, identificabili pertanto con ledue stelle, della sera (Hesperus, appunto) e del mat-tino (Phosphorus-Lucifero) 26. La distinzione tra i dueera, in realtà, solo un artificio poetico ed artisticoin quanto già Pitagora era a conoscenza del fattoche si tratta di un unico corpo celeste, in seguitoidentificato con il pianeta Venere 27. Peraltro la loro
23 Si vedano, fra le numerose raffigurazioni di questo tipo, con Mercurio in groppa ad un ariete: l’altare funerario di Ti.Flavius Hermes dalla Via Appia, datato al 70-90 d.C. conservato al Museo Civico di Velletri (BAUCHHENSS, SIMON 1992, p. 519,nr. 232), una gemma in pasta vitrea al Kestner Museum di Hannover (BAUCHHENSS, SIMON 1992, p. 513, nr. 144), un meda-glione fittile per decorazione vascolare (Fig. 11) da Autun (WUILLEUMIER, AUDIN 1952, nr. 171), un diaspro tardoantico diprovenienza sconosciuta a Copenhagen (BAUCHHENSS, SIMON 1992, p. 513, nr. 143) e, infine, la splendida rappresentazione sulgià più volte citato mosaico dei pianeti di Orbe.
24 Per la complessa questione interpretativa circa il significato simbolico-funerario di queste rappresentazioni, problemain cui non ci addentreremo, esulando esso dall’oggetto della nostra trattazione, si vedano principalmente: CUMONT 1948, pp.346-350 e 460-467; TURCAN-DELEANI 1964; STUVERAS 1969, p. 57.
25 Tra gli esemplari migliori di questa serie ricordiamo quelli conservati a Firenze (cfr. MANSUELLI 1958, tav. 239) e aRoma nei Musei Vaticani (cfr. LIPPOLD 1956, tavv. 32, 35, 40, 43, 47, 48). Vale la pena qui sottolineare brevemente la differen-za fondamentale tra equi (o equites) desultores e iubilatores, spesso usati da molti autori come se avessero lo stesso significato: i primisono quei cavalieri che, nell’intervallo tra le corse, si cimentavano in esibizioni acrobatiche e gare di destrezza di vario tipo perintrattenere il pubblico; gli altri, invece, sono cavalieri che durante le gare avevano il compito di stimolare ed incitare allacorsa i cavalli della propria squadra, seguendo da vicino i carri e, con ogni probabilità, anche sostituendosi al volo all’aurigaeventualmente gettato a terra.
26 Si vedano vari esempi di sarcofagi di provenienza urbana (ad esempio: ROBERT 1897, tav. XII, nrr. 39-40; tav. XX, nr.77; tav. XXII, nr. 79) dove i giovinetti alati possono ben essere paragonati al nostro, anche se recano talora in mano una grossafiaccola.
27 Si veda, in proposito MARTIN 1875, in particolare p. 478.
A. BACCHETTA186
sicura identificazione è talvolta complicata dallacircostanza che essi presentano caratteristiche deltutto analoghe tali da portare non di rado ad unaloro assimilazione. In un sarcofago con il mito dellacaduta di Fetonte proveniente da Ostia e datatoalla seconda metà del II secolo d.C. 28, Phosphorus
ed Hesperus sono raffigurati come due cavalieri,privi di ali e di fiaccola, del tutto identici, posti ailati del carro del Sole. Anche alcune fonti lettera-rie contribuiscono a chiarire le caratteristiche diquesta divinità celeste: Ovidio ci presenta Lucife-ro come cavaliere splendente di luce montato suun veloce destriero in due passi delle sue opere 29,mentre Stazio 30 e Marziale 31 in altri due branimettono in rilievo il legame stretto che univa ledue divinità astrali ai Dioscuri e, in modo partico-lare, Lucifero e Castore, tanto che tutt’altro cherari sono i casi di assimilazione: nelle stesse rap-presentazioni funebri prima ricordate del mito diEndimione e di quello di Fetonte i due giovinettisono da taluni interpretati come Dioscuri.L’identificazione del nostro personaggio con Lu-cifero-Castore (arrivando quindi ad accettare, siapur con altri presupposti, quanto già era stato pro-
posto da Albizzati) ci sembra, pertanto, la più va-lida, anche considerandola nel contesto della sce-na raffigurata: vedremo in seguito quali significa-tivi legami si possano individuare tra tale figura ela dimensione circense del fregio.
Dopo aver, quindi, analizzato le singole figure e avercercato di fondare, per quanto possibile, su basi ico-nografiche sufficientemente valide le varie propo-ste di una loro identificazione, prima di tentare unainterpretazione dell’insieme vogliamo porre breve-mente l’attenzione ancora su alcuni elementi, forsesecondari ma non per questo trascurabili, del no-stro rilievo, vale a dire sulle raffigurazioni dei carrie sui particolari degli attacchi dei cavalli.I carri, tutti molto simili fra di loro, presentano unparapetto completamente chiuso, dal bordo mar-catamente rilevato, più alto nella parte anteriore eche si abbassa poi progressivamente verso la parteposteriore, con profilo ondulato, ed una predellamolto allungata che arriva alla propria estremitàquasi a toccare terra; la ruota è a sei raggi. In tuttii carri si nota distintamente l’attacco del timone,così come ben evidente è il giogo posto sulla grop-
28 Conservato alla Ny Carlsberg Glyptotek di Copenhagen (ROBERT 1919, tav. CVIII, nr. 336).29 Ov., Am., II, 2, 55-56: «haec mihi quam primum caelo nitidissimus alto / Lucifer admisso tempora portet equo»; Tr., III, 5, 55-56:
«hos utinam nitidi solis praenuntius ortus / afferat admisso Lucifer albus equo».30 Stat., Silv., IV, 6, 15-16: «donec ab Elysiis prospexit sedibus alter / Castor et hesternas risit Tithonia mensas».31 Mart., VIII, 21, 6: «ipse suo cedet nunc tibi (Phosphoro) Castor equo».
Fig. 12 – Lucifero.
IL FREGIO FIGURATO DELL’ARCHITRAVE DEL PORTALE DI SANT’AQUILINO NELLA BASILICA DI SAN LORENZO IN MILANO 187
pa degli animali e il punto centrale, leggerementerialzato, dove il timone si innesta sul carro di Ve-nere questo rialzo è assai rilevato e ha una formaparticolare che ricorda una testa elmata. Su quasitutti i cavalli delle bighe (l’unica eccezione è costi-tuita da quella di Marte) sono ben evidenti anchele corregge di cuoio passanti sotto il petto tramitele quali le bestie erano unite al timone: le bighe,infatti, non venivano tirate direttamente ma solo permezzo di quest’ultimo, dal momento che i cavalli nonerano legati in alcun modo al carro ma esclusiva-mente al timone. Il giogo è fissato tramite una sortadi collare (sub iugum) che passa sotto il collo degli ani-mali e che risulta particolarmente evidente sui ca-valli di Luna, Venere e Vittoria. Il carro del Sole,invece, mostra in modo abbastanza chiaro il colle-gamento diretto, attraverso degli anelli fissati sulgiogo, tra le redini, impugnate dal guidatore, e lebriglie collegate ai morsi nelle bocche dei cavalli.Il tipo di bardatura è, in sostanza, quello che siriscontra di solito nelle rappresentazioni circensi:si vedano, in proposito, i sarcofagi con corse diAmorini sopra citati e, in particolare, le raffigura-zioni di carri da corsa poste sui coperchi di duesarcofagi dei Musei Vaticani 32: essi appaiono del
tutto analoghi ai nostri, con la sola differenza del-le ruote (che negli esemplari portati a confrontosono o piene o a quattro raggi).Diversa, invece, appare la legatura di una quadriga,quale è quella di Giove: qui soltanto i due cavallicentrali, detti eques jugales o introjugi, sono fissati diret-tamente al timone tramite un giogo (che nella nostraraffigurazione, peraltro, non risulta visibile), mentrei due esterni, eques funales o funarii, sono attaccati di-rettamente al carro tramite una corda o una cate-na: a tale tipo di legatura, quindi, si deve verosimil-mente riconnettere la fascia che si vede alla base delcollo del cavallo in primo piano, che pare proseguireal di sopra della sua schiena fino a raggiungere ilcarro e che non può confondersi con le redini, indi-viduabili chiaramente nella parte superiore 33.
Le figure delle divinità sono intervallate, come giàaccennato all’inizio, da sette conchiglie a pettinedi grandi dimensioni al cui interno si alternanocoppie di delfini e uccelli. I primi si presentanosempre secondo lo stesso schema, in posizione ver-ticale, con la testa in basso e le code intrecciate inalto (Fig. 13): confronti puntuali per queste figuresi trovano su urne funerarie di età imperiale, spe-
32 Cfr. LIPPOLD 1956, tavv. 32 e 40.33 Per un’ampia ed approfondita trattazione di tutti i problemi “tecnici” relativi ai carri e alle caratteristiche dei finimenti
si vedano: SAGLIO 1887; BAUDRILLART 1900, pp. 664-665 e, da ultimi, CIRQUE ROMAIN 1990 e MOLIN 1990. Utile può risultareanche la consultazione delle voci relative a questi argomenti in IOPPOLO, PISANI SARTORIO 1999, pp. 307-329.
Fig. 13 – Conchiglia a pettine con coppia di delfini.
A. BACCHETTA188
cie di produzione urbana, dove frequente è anchel’associazione con la conchiglia 34, su stele funera-rie 35, mosaici pavimentali 36, decorazioni architet-toniche37 o su opere di altro tipo, ad esempio scul-ture per fontana 38 (Fig. 14). Risulta evidente, dagliesempi citati, che il motivo della conchiglia e deidelfini intrecciati costituisce un elemento decora-tivo assai diffuso nel corso della prima e media etàimperiale, presente in diversi contesti e utilizzatoin differenti ambiti artistici.Discorso analogo può essere fatto anche per le im-magini delle coppie di uccelli, che però mostranouna maggiore problematicità. Essi, infatti, si pre-sentano con una varietà di disposizione assai ac-centuata rispetto ai delfini: in due casi gli uccelliappaiono disposti in una posizione divergente, conle code decisamente sollevate e ravvicinate (Fig.15), secondo uno schema per il quale non siamoriusciti a trovare confronti; in un caso, al contra-rio, essi si trovano in una posizione, per così dire,“convergente” vale a dire affrontati con le testesollevate e i becchi accostati 39 (Fig. 16), mentrenell’ultima raffigurazione, che risulta, per quantoci consta, del tutto eccezionale, i due animali sonoraffigurati nell’atto di accoppiarsi (Fig. 18). I moti-vi di questa varietà, che contrasta con la ripetitivi-tà delle raffigurazioni dei delfini, appaiono diffici-
34 Si vedano, fra gli esempi migliori, le urne funerarie di Aurelius Crispinus Caepio, di età flavia, al Museo NazionaleRomano (SINN 1987, tav. 34, nr. 164), di Claudia Prepusa, di fine I-inizi II secolo d.C., al Museo Gregoriano Profano (SINN
1987, nr. 416), di M.Ulpio Fortunato, al Fitzwilliam Museum di Cambridge (SINN 1987, tav. 81, nr. 541), di T. Flavio Onesimo(SINN 1987, tav. 72, nr. 461) e di L.Cocceius Clymenus, di epoca tardo-claudia, al British Museum (SINN 1987, tav. 31, nr. 121).
35 Come quella di Wiesbaden, di età imprecisata (ESPÈRANDIEU 1931, p. 24, nr. 30), o altri esemplari di provenienzaumbra datati tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C. (DIEBNER 1986, tavv. 15-16), o, ancora, un’edicola funeraria con conchigliee delfini dei Musei Capitolini (STUART JONES 1912, tav. 16-II-8).
36 Molto significativo è l’esempio del mosaico con teste di Oceano della casa di Isgunto a Hippo Regius in Algeria, datatoal 210-260 d.C., dove la fascia decorativa esterna è costituita da una successione di coppie di delfini intrecciati intorno a unaconchiglia a tortiglione, alternate a conchiglie a pettine (DUNBABIN 1978, tav. LVI, nr. 142). Due delfini affrontati in posizioneverticale, con un tridente al centro, si trovano su un pavimento, databile al II secolo d.C., proveniente dalla villa marittima diMonfalcone, località Collina della Punta, conservato al Museo Archeologico di Aquileia (DE FRANCESCHINI 1998, p. 369, fig.88). Una coppia di delfini con le code intrecciate, in un riquadro della cornice esterna, è presente nel mosaico di epocaaugustea dell’atrio della casa di Paquius Proculus (I, 7, 1) a Pompei (POMPEI, I, p. 490, nr. 12).
37 Ad esempio, a Pompei, le cornici in stucco presenti nell’oecus della casa di M.Epidius Sabinus (IX, 1, 22.29) con delfiniaffrontati che descrivono un semicerchio intorno alla valva di una conchiglia a pettine (POMPEI, VIII, p. 984, nr. 49), in unambiente della casa dei Pigmei (IX, 5, 9) dove una raffigurazione analoga, con delfini, però, divergenti, si alterna a piccolepalmette stilizzate (POMPEI, IX, p. 527, nr. 78) e nel caldarium delle terme della casa del Centenario (IX, 8, 3.7) con coppie didelfini accostati ad un’ancora centrale (POMPEI, IX, p. 1092, nr. 355).
38 Una scultura a forma di alto trono con la statua del dio Nilo disteso, di provenienza sconosciuta, ascrivibile all’età adrianeao antonina, conservata a Villa Albani, presenta sulle due facce laterali una coppia di delfini con le code intrecciate intorno ad untridente (evidente richiamo al dio del mare Nettuno) posti sopra una conchiglia a pettine (VILLA ALBANI 1992, tav. 126, nr. 320).
39 Anche per questo schema, come per i delfini intrecciati, si possono trovare numerosi confronti puntuali nella decora-zione delle urne funerarie: ad esempio su quella di C.Voltilius Domesticus, di età adrianea, conservata al Museo GregorianoProfano, dove due uccelli si trovano, sulla sommità dell’urna, ai lati di una conchiglia contenente il ritratto del defunto (SINN
1987, nr. 549) analogamente a quanto avviene su un’altra urna anonima di epoca imprecisabile, a Sfax (SINN 1987, tav. 60, nr.378); su quella di L.Postumius Iulianus, di età tardo-claudia, dove gli animali stanno in posizione, per così dire, araldica ai lati di
Fig. 14 – Scultura per fontana raffigurante il dio Nilodisteso su un alto trono a gradini decorato sui lati concoppie di delfini; provenienza sconosciuta. Roma, Vil-la Albani.
IL FREGIO FIGURATO DELL’ARCHITRAVE DEL PORTALE DI SANT’AQUILINO NELLA BASILICA DI SAN LORENZO IN MILANO 189
Figg. 15-16 – 15. Conchiglia a pettine con coppia di uccelli in posizione divergente; 16. Conchiglia a pettine concoppia di uccelli affrontati.
li da definire, così come difficile da spiegare in unachiave semplicemente decorativa risulta l’ultimadi tali immagini. D’altro canto, anche vedere inessa, come fa Albizzati, un’allusione ai cicli vitalidella natura, per quanto certo possibile, risulta for-
zato e non giustificabile nel quadro generale delfregio. Assai suggestiva ed ingegnosa, ma anch’es-sa, in definitiva, poco convincente, è la propostadi David 40 che vede nelle sette figure un riferimentodiretto ai sette giri di cui si componeva ogni gara
un tripode; di Claudia Prepusa, già ricordata, di Cacia Daphne, tardo-flavia (Fig. 17), al Gregoriano Profano (SINN 1987, tav.65, nr. 412) e di Cornelia Epitychia, di età flavia, a Kassel (SINN 1987, tav. 39, nr. 196) dove le coppie di uccelli sono raffiguratein una posizione del tutto simile a quella del nostro fregio, affrontati con i becchi accostati.
40 DAVID 1991, p. 60, n. 38.
A. BACCHETTA190
Fig. 17 – Urna funeraria di Cacia Daphne; provenien-za sconosciuta. Roma, Museo Gregoriano Profano.
circense e che venivano conteggiati tramite il pro-gressivo capovolgimento di piccole statue di delfi-ni e l’asportazione di grosse uova di pietra, entram-bi posti su piedistalli monumentali alle due estre-mità della spina 41: se il richiamo ai delfini, anima-li sacri a Nettuno, nume tutelare di corse e corri-dori 42, è, però, del tutto evidente, assai più mac-chinoso risulta, invece, quello alle uova realizzatotramite gli uccelli.Se si prova tuttavia a cercare, per questi animali,un significato simbolico che trascenda il loro valo-re meramente decorativo si vedrà che in essi la di-mensione funebre è quella più decisamente mar-
cata 43: il delfino, oltre a simboleggiare, evidente-mente, l’elemento acquatico, svolge una funzionedi guida delle anime dei defunti nell’aldilà 44, men-tre l’uccello, simbolo dell’aria, viene visto comeun’incarnazione dell’anima del defunto, specie nelsuo carattere di immortalità 45. La stessa conchi-glia, rappresentativa dell’acqua, simbolo di fertili-tà, legata strettamente al culto di Afrodite, possie-de anche una marcata valenza funeraria, che silega strettamente alla dimensione funebre di que-sta dea 46, ma che non le impedirà, comunque, didivenire, al di là di tali significati simbolici, unodegli elementi decorativi di più largo utilizzo neipiù disparati contesti monumentali, grazie alla“funzionalità” della sua forma e del gran numerodi impieghi a cui si presta.Riescono pertanto facilmente comprensibili, sullabase di queste credenze, i motivi che hanno con-dotto alla scelta di uccelli, delfini e conchiglie per ladecorazione di urne e stele funerarie. Da un utiliz-zo esclusivo in tali contesti, poi, si può ragionevol-mente pensare che queste immagini, persi a poco apoco il primitivo significato religioso e la profondavalenza simbolica e finendo, viceversa, per prevale-re il loro valore puramente decorativo ed estetico,siano passate ad un uso più ampio e generalizzato,in una più vasta serie di ambiti artistici, dove il loroimpiego risulta ormai del tutto slegato da qualun-que significato trascendente e connesso soltanto adun semplice intento ornamentale 47. E questo è quan-to siamo portati a credere che sia successo nel casodel nostro fregio, dove l’impiego di tali immagini ascopo puramente artistico-decorativo (potremmodire addirittura “riempitivo”, se a tale definizionenon venisse automaticamente attribuita una sfuma-
41 Per questa pratica di computo dei giri si vedano: BALIL 1966; QUINN SCHOFIELD 1966 e, da ultimo, IOPPOLO 1999, pp.130-132, figg. 26-27.
42 Plin., H.N., IX, 8; Lact., Inst., VI, 20. Cfr. anche IOPPOLO 1999, p. 130.43 Cfr. MACCHIORO 1911, pp. 47-54 e pp. 64-65. Si vedano, a questo proposito, anche le voci relative in DE VRIES 1974.44 TOYNBEE 1973, pp. 207-208.45 MACCHIORO 1911, pp. 47-50 riconduce la concezione romana dell’uccello come anima del defunto alla tradizione
mitologica greca, di cui riporta numerosi esempi. Inoltre, lo stesso autore (pp. 52-54) sottolinea come nella tradizione religiosaromana gli uccelli-anima relativi ad ogni estinto fossero diversi, non solo uno, arrivando a spiegare in tal modo il fatto che suimonumenti funerari (are, cippi, stele) compaiono di preferenza, come abbiamo visto negli esempi succitati, coppie di uccelli,di preferenza affrontati.
46 Si veda, al riguardo, FLORESCU 1957.47 Lo stesso Macchioro (p. 54) riconosce come le figure di uccelli siano utilizzate, con valore puramente decorativo, anche
al di fuori del contesto funerario, in varie associazioni con altre figure ed elementi «perché un motivo prettamente simbolicopuò anche esser usato per ornamento, ma l’origine di tanta profusione, specifica dell’arte sepolcrale, doveva esser simbolica».Analoghe considerazioni valgono pure per le figure di delfini utilizzate anche solo per scopi puramente ornamentali in conte-sti non sepolcrali (p. 65).
IL FREGIO FIGURATO DELL’ARCHITRAVE DEL PORTALE DI SANT’AQUILINO NELLA BASILICA DI SAN LORENZO IN MILANO 191
48 Se ne veda la specifica ed approfondita trattazione in ANDREI 1984, pp. 48-60.49 Si rimanda anche alle analisi in questo senso svolte da CASTORINA 1961, pp. LXXXIII-CXI; ANDREI 1984, pp. 49-50
e 53-56; LYLE 1984; SABLAYROLLES 1990, pp. 127-133 (in particolare pp. 128-129).
tura negativa), comunque con un marcato intentodi “scansione” regolare della scena, di “intervallo”tra le figure principali ci sembra essere la spiegazio-ne più semplice ed accettabile da proporre, nonpotendo in alcun modo ravvisare in questo conte-sto un qualche esplicito carattere funerario che possaindurci a spiegazioni di altro tenore.
IL FREGIO FIGURATO: ANALISI ICONOLOGICA ED
INTERPRETAZIONE
Arriviamo ora al punto centrale della nostra trat-tazione, di cui quanto argomentato fino a questomomento rappresenta, in certo senso, la necessa-ria premessa, vale a dire alla possibile interpreta-zione del significato di questo fregio. Tale inter-pretazione parte dalla considerazione del fatto –fino ad oggi sempre ritenuto, in qualche modo,secondario ed accessorio e che invece, a parer no-stro, costituisce la chiave di volta per comprende-re questa raffigurazione – che l’ambito di svolgi-mento della scena è “dichiaratamente” circense eche, appunto, dalla complessa simbologia del Cir-co si deve pertanto prendere le mosse per arrivaread una conclusione accettabile e fondata.
Il Circo, infatti, ha sempre posseduto un profondo earticolato simbolismo religioso ed astrologico che civiene testimoniato da una ricca serie di fonti antiche:le più importanti, che qui illustreremo con una certaampiezza in modo da fornire una preliminare visio-ne d’insieme della questione, sono costituite dai notipassi di Cassiodoro (Var., III, 51, 3-13) e di Tertul-liano (Spect., VIII, 1-7), e da un epigrammadell’Anthologia Latina (I, 197), nonché da un pococonosciuto frammento (F 34) dello storico perga-meno A.Claudio Carace, vissuto in epoca antoni-na, ripreso dal bizantino Giovanni Malalas (Chronogr.,VII, 176) 48. Da tali fonti appare chiaramente comenessun elemento, nessuna struttura, nessun aspettodel Circo e delle gare che in esso si svolgevano fosseprivo di legami con l’ambito astrale e cosmologico49.La serie dei riferimenti è talmente ampia da risulta-re, almeno per noi moderni, frutto di un’attenzionee di una volontà interpretativa che potrebbero sem-brare quasi esasperate. Il senso generale di questadottrina è, d’altronde, sintetizzato in maniera effica-ce dall’emistichio iniziale del citato epigramma cherecita significativamente: «Circus imago poli», il Circoè la raffigurazione del cielo e dei suoi elementi.Così, riassumendo in breve la ricca serie di corri-spondenze astrali, troviamo che:
Fig. 18 – Conchiglia a pettine con coppia di uccelli nell’atto di accoppiarsi.
A. BACCHETTA192
50 Durante tutta l’epoca imperiale le gare del circo si svolgevano tra quattro fazioni, ognuna contrassegnata da un colorediverso: azzurro, bianco, rosso e verde. La bianca e la rossa esistevano già in età repubblicana, mentre le altre due furonoistituite agli inizi del I secolo d.C. Di breve durata fu la riforma voluta da Domiziano (Suet., Dom., 7, 1; D.C., LXVII, 4) chene introdusse altre due, oro e porpora, eliminate subito dopo la sua morte. In età tarda (IV secolo d.C.) la blu e la verde (taloragiudicate alla stregua di veri e propri partiti politici rappresentanti rispettivamente il patriziato e la plebe) finiranno conl’assimilare le altre due, che quindi scompariranno definitivamente dalla scena. Si vedano, in proposito: GOOSSENS 1939;CAMERON 1976, pp. 45 e 53-56; ANDREI 1984, pp. 48-49; IOPPOLO, PISANI-SARTORIO 1999, p. 315, s.v. Factio, factiones.
51 TORELLI 1984, p. 199; TORELLI 1992, p. 208. Per una trattazione d’insieme delle complesse questioni riguardanti leorigini del Circo e delle gare circensi a Roma si veda THUILLIER 1990.
52 Un’interpretazione eziologica di questo tipo, con un più stretto collegamento tra Enomao e Romolo quali “fondatori”delle gare circensi, si trova anche nell’opera del cronachista bizantino Giovanni Malalas (Chronographia, VII, 171-176) che, comegià ricordato, riprenderebbe, adattandolo alla situazione storica della Costantinopoli del suo tempo, un passo (F 34) delle perduteStorie scritte, in età antonina, dal pergameno A.Claudio Carace: si veda, a tal proposito, ANDREI 1984, pp. 48-51 e 59-60.
– i dodici cancelli (carceres) da cui escono i cavalliall’inizio della corsa rappresentano i mesi dell’an-no e le costellazioni dello Zodiaco;– le quattro fazioni in gara 50, contrassegnate cia-scuna da un diverso colore, rimandano alle sta-gioni e agli elementi naturali (la fazione verde rap-presenta la Primavera e la Terra, la rossa l’Estatee il Fuoco, l’azzurra l’Autunno e l’Acqua, la bian-ca l’Inverno e l’Aria);– la pista del Circo rappresenta la Terra e l’Euripo(lo specchio d’acqua che circondava la pista)l’Oceano;– i due obelischi posti sulla spina al centro dellapista richiamano il Sole (quello più alto) e la Luna;– le mete alle due estremità della spina indicanol’Oriente e l’Occidente e l’auriga, come Febo allaguida del suo carro, oltrepassando ora l’una oral’altra richiama simbolicamente il moto quotidia-no del Sole;– i sette giri di pista, di cui si compone ogni corsa,alludono ai giorni della settimana e alle orbite deipianeti e vengono contati, come già ricordato, conl’ausilio di statue di delfini e di uova (ovaria o falae)che, rispettivamente, costituiscono un richiamo aNettuno e alla nascita dei Dioscuri;– la biga è simbolo della Luna, la quadriga delSole e i semplici cavalli (i già ricordati desultores eiubilatores) dei Dioscuri;– i ventiquattro missus (le corse successive di cui sicomponeva ciascuna gara) alludono alle ore di cuisi compone il giorno.
Questa complessa dottrina deve, evidentemente,aver conosciuto un periodo di elaborazione piut-tosto lungo, le cui radici, secondo alcuni autori,sarebbero rintracciabili addirittura nella culturalatina di epoca arcaica e nelle gare campestri, già
connotate di significati religiosi, che si svolgevanolungo le rive del Tevere, diretti antecedenti dellegare circensi 51. In ogni caso, diversi autori antichici forniscono suggestive, quanto fantasiose, ipotesicirca l’origine delle gare circensi, il loro primo isti-tutore e la stessa etimologia del termine, facendosempre riferimento ad un passato tanto remoto dasconfinare nel mito. Giovanni Lido (Mens., I, 12) eCorippo (Laud.Just., I, 334-344) ne ricollegano l’ori-gine, in Grecia, alla mitica gara di Enomao ePelope per la giovane Ippodamia (e un accenno intal senso si trova pure all’inizio del già citato passodi Cassiodoro che fa, invece, di Romolo il primoistitutore di gare “circensi” campestri sul suolo ita-lico, in occasione del ratto delle Sabine 52), mentrein Italia il circo sarebbe una creazione della magaCirce (da cui avrebbe poi preso il nome) in onoredel suo ospite Odisseo. Analoga interpretazione civiene fornita anche da Tertulliano (Spect., VIII, 2)e da Isidoro di Siviglia (Etym., XVIII, 28) il qualeperò afferma che sono i Greci a ritenere la magafondatrice delle gare in onore del Sole, proprio ge-nitore, mentre i Romani, più razionalmente, avreb-bero derivato il termine «a circuito equorum, eo quod
ibi circum metas equi currant». L’autore prosegue poiper diversi capitoli a trattare del Circo, delle sueparti e delle relative valenze simboliche, ripeten-do, in larga misura, i concetti già esposti.
Tutte le fonti citate, come si può vedere, traccianoun quadro molto articolato e complesso delle va-lenze simboliche ed astrali del Circo, sia per quantoriguarda la sua struttura architettonica che rispet-to alle sue componenti più strettamente agonisti-che: si tratta sempre, però, di fonti tarde (ad ecce-zione dell’epigramma dell’Anthologia Latina, di etàadrianea e, anzi, da taluni attribuito nientemeno
IL FREGIO FIGURATO DELL’ARCHITRAVE DEL PORTALE DI SANT’AQUILINO NELLA BASILICA DI SAN LORENZO IN MILANO 193
53 WUILLEUMIER 1927, p. 190.54 Cfr. WUILLEUMIER 1927, p. 194.55 CUMONT 1929, pp. 196-199.56 WUILLEUMIER 1927, pp. 186-197.57 WUILLEUMIER 1927, pp. 190-195.58 Cfr. TORELLI 1992, p. 208; DAGRON 1991, pp. 335-338 spiega le valenze cosmologiche dell’Ippodromo di Costantino-
poli in un quadro programmatico di continuità politico-culturale tra la nuova capitale e Roma che passa, tra l’altro, ancheattraverso il recupero di una ideologia circense che aveva improntato di sè la mentalità romana imperiale: «(…) si risale aRoma per spiegare storicamente Costantinopoli, e si ricorre agli artifici di un simbolismo nato nei primi anni dell’impero per foggiareun rituale politico nel quale trovano espressione i problemi della società bizantina» (p. 336).
59 «Oƒ palaioˆ kaˆ t¦ perˆ toà ƒppodrom…ou kataskey£menoi dišneiman kaˆ t¦ crèmata prÒj tinaj tîn¢stšrwn: kaˆ tù men `ErmÍ dedèkasi tÕ bšneton, tÍ de ’Afrod…tV tÕ leukÒn, tÕ ·oÚsion tù ”Arei, tÕ pr£sinon tÍSel»nV, tù Diˆ t¾n n…khn kaˆ t¾n Âttan tù KrÒnJ, ½goun tÕn blšponta ¢pÕ toÚtwn ¢stšra tù Diˆ nikht¾n¢pofa…nontej, tÕn de blšponta tù KrÒnJ ¹ttèmenon: tÕn de `/HliÒn tinej mšn bohqe‹n tù ·ous…J ¢pef»nanto di¦ tÕpurîdej, oƒ ple…ouj de kaloàsi mes…thn, pepoi»kasi <de> æj mšson kaˆ koinÕn ¢stšra: (…)».
che allo stesso Svetonio, grande appassionato del-le corse dell’ippodromo 53), databili a partire dalIV secolo d.C. (Tertulliano) fino ad arrivare addi-rittura al VII secolo d.C. (Isidoro). Tuttavia è deltutto verosimile pensare che esse costituiscano solola codificazione per iscritto di un complesso di cre-denze risalente ad epoca ben più antica, con tuttaprobabilità almeno alla prima età imperiale, se giànella prima metà del II secolo d.C. esse potevanovenir esposte organicamente in una composizionepoetica. Se poi proviamo a risalire fino alla tardaetà repubblicana, troviamo un significativo passodi Cicerone (Div., I, 132) in cui l’autore afferma dinon tenere in alcuna considerazione, accomunan-doli in un comune disprezzo, gli indovini, i veg-genti, gli interpreti dei sogni e i “de circo astrologos”,quegli astrologi cioè che, evidentemente, esercita-vano la propria professione di premonitori conparticolare riguardo alle gare del Circo: una testi-monianza, certo indiretta ma comunque non tra-scurabile, del fatto che già nella prima metà del Isecolo a.C. la dottrina astrologica del circo dove-va essere ben sviluppata e diffusa anche a livellopopolare 54.Tutte le argomentazioni svolte fino a questo mo-mento, se da un lato ci forniscono un quadro ab-bastanza articolato delle credenze antiche sullecomplesse valenze celesti del Circo, dall’altro, però,nulla ancora ci dicono di concreto riguardo allaraffigurazione circense presente sul fregio del no-stro portale.Per tentare di chiarire il suo significato specifico cidobbiamo ancora rivolgere ad altre fonti scritte e,in particolare, ad un illuminante passo di “astro-logia circense” contenuto nel Codice medievaleParisinus Graecus 2423, databile al 1132, pubblica-
to da F. Cumont 55 e approfonditamente analizza-to da P. Wuilleumier in un suo fondamentale arti-colo 56. Questo testo di età medievale, come ha ef-ficacemente dimostrato Wuilleumier 57, seguito poida altri autori 58, costituisce soltanto il punto di ar-rivo finale di una lunghissima elaborazione inizia-ta, secondo lo studioso, già in piena epoca repub-blicana e che ha, probabilmente, conosciuto variesuccessive codificazioni scritte di cui noi oggi nul-la possediamo. La datazione così tarda di questodocumento, pertanto, non ne inficerebbe affattola validità storica e documentaria e non costitui-sce un ostacolo, per noi, a proiettare indietro neisecoli, almeno fino alla prima età imperiale, il qua-dro di credenze da esso tracciato. Fatta questa do-verosa premessa conviene riportare integralmenteil testo nella sua parte iniziale, che è quella che piùdirettamente ci interessa:«Gli antichi, avendo preso in esame anche la que-stione dell’ippodromo, suddivisero i colori (delle
fazioni circensi) tra alcuni astri: a Mercurio attribui-rono l’azzurro, a Venere il bianco, il rosso a Mar-te, il verde alla Luna, a Giove la vittoria e la scon-fitta a Saturno; vale a dire che quell’astro, fra diessi, che guardava verso Giove (cioè si trovava in con-
giunzione astrale con esso) costoro consideravano comevincitore, quello che, invece, si rivolgeva a Satur-no, come sconfitto. Il Sole, poi, taluni hanno so-stenuto che aiutasse il rosso, a causa della sua es-senza ignea, i più, invece, giudicarono che dispen-sasse in egual misura il bene, considerandolo comeun astro mediano e comune» 59. Il testo, poi, pro-segue a lungo discettando sui diversi metodi perpredire, tramite l’analisi delle posizioni degli astri,le vittorie delle varie fazioni nelle corse del Circo.Ma ciò che ci riguarda da vicino è contenuto in
A. BACCHETTA194
60 «(…) ¨noqen mšn tÁj puram…doj ™pˆ toà EÙr…pou bwmoˆ †druntai tre‹j: KrÒnou, DiÒj, ”Areoj: k£twqen dep£lin bwmoˆ tre‹j: ’Afrod…thj, `Ermoà kaˆ Sel»nhj: tr…podej dÚo, `Hl…ou kaˆ Sel»nhj».
61 «Equi desultorii, per quos circensium ministri missus denuntiant exituros, luciferi praecursorias velocitates imitantur».
queste righe iniziali: qui, infatti, si fa menzionediretta dei sette pianeti che compongono la serieconosciuta nell’antichità o perchè alla protezionedi alcuni di essi sono affidate le singole fazioni operchè la loro influenza condiziona in modo de-terminante, nel bene e nel male, i risultati dellegare.Questo non è l’unico testo astrologico riportatodal Wuilleumier in cui si stabiliscono rapporti di-retti fra alcuni pianeti e le fazioni del Circo, e daaltri scritti emergono attribuzioni in parte diversea testimoniare come questa materia fosse tutt’al-tro che fissata in modo definitivo e unanimementeaccettato: ma, per ammissione dello stesso studio-so, questo è il testo più completo e organico, dovepiù compiutamente sono fissati i dettami e i prin-cipi di questa singolare dottrina. Non ci pare, per-tanto, arbitraria la scelta di questa fonte comepunto di riferimento e possibile chiave di letturadel significato simbolico racchiuso nella rappre-sentazione di cui ci stiamo occupando. Appare,infatti, del tutto evidente come si abbia una corri-spondenza quasi perfetta (i punti discordanti ver-ranno chiariti fra breve) tra le divinità planetariepresenti nella corsa del fregio e i pianeti citati neltesto come variamente connessi all’attività circen-se. Riassumendo, in via ancora preliminare, loschema della rappresentazione si avrebbe, quindi,partendo dall’estremità sinistra: Mercurio, patro-no della fazione azzurra, Sole, generosodispensatore di favori universali, Giove, diretto re-sponsabile delle vittorie, Marte, patrono della fa-zione rossa, “Vittoria”, il cui significato rimaneancora da chiarire, Venere (la cui identificazione,seppure non sicura dal punto di vista iconografi-co, date le difficoltà che abbiamo sopra illustrato,risulterebbe ora fondata in modo verosimile sullabase dell’associazione con le altre figure),protrettrice della fazione bianca, Luna, patronadella squadra verde e, infine, Lucifero, sul qualeancora dovremo soffermare la nostra attenzione.Un altro passo letterario del già citato GiovanniLido (Mens., I, 12) viene a fornire un ulteriore con-tributo, seppur certo molto meno determinante,alla definizione del ruolo delle divinità planetarie
nell’ambito circense. Descrivendo l’aspetto delprimo leggendario edificio circense fondato dallamaga Circe, aspetto che, per quanto alterato dacomponenti frutto di fantasia, deve, evidentemen-te, rispecchiare in qualche misura una realtà og-gettiva conosciuta, l’autore cita una serie di mo-numenti collocati sulla spina e dedicati alle variedivinità: «(…) da una parte della piramide (l’obelisco
del Sole) presso l’Euripo si trovano tre altari: di Sa-turno, di Giove e di Marte; dall’altro lato, ancoratre altari: di Venere, di Mercurio e della Luna; duetripodi, del Sole e della Luna (…)» 60. Si tratta, an-che in questo caso, delle sette divinità planetarie,citate come titolari di monumenti votivi nella zonacentrale della pista, a sottolinearne ancora, pursenza specificare alcuna loro eventuale funzione o“patronato”, l’importante presenza nel Circo.Nè in questo testo di Giovanni Lido nè in quelloprecedente viene mai citato, invece, Lucifero, lacui immagine, al contrario, abbiamo ritenuto dipoter individuare nel nostro fregio: la sua presen-za e il ruolo da lui svolto potrebbero, quindi, ap-parire difficili da spiegare. In realtà anche se, comericordato, egli non fa parte della serie delle divini-tà planetarie così come è stata fissata dagli antichi,rivestendo solo un ruolo secondario, di “accom-pagnatore” del Sole o della Luna, ben definita èperò la sua posizione nel quadro della “astrologiacircense”. Varie sono, infatti, le fonti che ne parla-no e sempre in termini che si adattano perfetta-mente alla rappresentazione che ci troviamo da-vanti sul nostro fregio, vale a dire di cavaliere aventefunzione di desultor: non, quindi, direttamente im-pegnato nell’agone o in stretto rapporto con unadeterminata fazione, ma svolgente il compito di“annunciatore” delle corse, di “preparatore”, percosì dire, delle gare. Cassiodoro (Var., III, 51, 6) celo descrive esplicitamente in questi termini: «Gliequi desultorii, tramite i quali gli arbitri delle garecircensi annunciano la prossima uscita dei corri-dori, imitano le velocità precorritrici di Lucifero» 61, ilquale, come si sa, con il proprio sorgere annunciaper primo la venuta del giorno. Brevi allusioni aquesta condizione troviamo anche nel più volte ci-tato epigramma dell’Anthologia Latina (v. 18): «(…) ai
IL FREGIO FIGURATO DELL’ARCHITRAVE DEL PORTALE DI SANT’AQUILINO NELLA BASILICA DI SAN LORENZO IN MILANO 195
Castori sono attribuiti ritualmente singoli cavalli» 62
e in Isidoro di Siviglia (Etym., XVIII, 36): «(…) aLucifero ed Espero consacrarono i desultores» 63; lostesso autore, più avanti (Etym., XVIII, 39), entranello specifico: «Desultores sono chiamati poichè untempo, prima che ciascuno fosse giunto alla finedella corsa, discendeva e correva; oppure perchèpassavano saltando di cavallo in cavallo» 64.La presenza qui di Lucifero, pertanto, risulta per-fettamente giustificata dal ruolo di desultor svoltonel contesto circense e ben si integra con quelladelle altre divinità planetarie cui era affidata unamansione più specifica ed “attiva”, completandoquel quadro di “astrologia circense” che abbiamotentato di delineare. La sua collocazione all’estre-mità del fregio poi, proprio dietro a Luna, di cui èinsieme ad Espero fedele accompagnatore, può ri-chiamare alla mente la tradizionale collocazioneangolare delle figure dei Dioscuri presente in al-cuni rilievi, in particolare di sarcofagi (e si è giàaccennato a come, sovente, le due coppie sianosoggette a scambi e confusioni). Qui tale effetto èdeterminato, soprattutto, dall’esatta corrisponden-za che la figura trova, all’estremo opposto, con l’im-magine speculare di Mercurio, quasi che quest’ul-timo, pur indicato chiaramente nella sua identitàtramite i consueti ed inconfondibili attributi, siastato, però, volutamente lasciato in una posizione,in certo modo, ambigua, come a svolgere contem-poraneamente un doppio ruolo nell’economiadella composizione, facendo appunto, nella posi-zione in cui è collocato, da “contraltare” alla figu-ra di Lucifero, così da rafforzare l’equilibrio del-l’insieme.
Ci rimane ora da chiarire, per concludere, unodei punti più controversi e complessi di tutta lascena, vale a dire il ruolo e il significato della fi-gura che abbiamo precedentemente identificatocome “Vittoria”.
Come ricordato all’inizio, Albizzati pensava chesi fosse operata sul fregio la sostituzione dell’im-magine di Saturno, funesto e malaugurante, conquella, certo più positiva, della dea Vittoria: nonchiariva però i motivi di questa scelta e, soprat-tutto, quale legame potesse sussistere tra i duepersonaggi che potesse indurre ad associarli alpunto da utilizzarne uno in sostituzione dell’al-tro. Una possibile risposta ci può venire da un’at-tenta riconsiderazione dell’iconografia di questafigura e dalla lettura di alcune fonti antiche. Gliattributi che abbiamo visto caratterizzare questaimmagine (le grandi ali, la corona e la palma)sono, senza dubbio, quelli che incontriamo piùdi frequente nelle rappresentazioni di Vittoria,ma non sono di essa esclusive. Le ritroviamo, in-fatti, pressochè identiche in non poche raffigura-zioni di un’altra divinità che con Vittoria è stret-tamente correlata e alla quale fu spesso assimila-ta: Nemesi.Il culto di questa dea, di origine orientale, giun-ge a Roma nel periodo tardo-repubblicano in-contrando un notevole ed immediato favore so-prattutto nel mondo militare e presso i ceti po-polari. Dal punto di vista della rappresentazioneartistica Nemesi manifesta una costante e signifi-cativa tendenza all’assimilazione dei caratteri edegli attributi iconografici di altre divinità come,ad esempio, Tyche, da cui prende la ruota, Themis,dalla quale deriva la bilancia e, in modo partico-lare, per l’appunto Nike, da cui deriva le ali e lapalma 65. L’assimilazione a quest’ultima risultaparticolarmente attestata nel periodo compresofra l’età tardo-repubblicana e l’inizio del II seco-lo d.C., pur presentando ancora alcune testimo-nianze nel periodo successivo: a partire dall’etàadrianea, tuttavia, comincia a diffondersi nuova-mente il tipo della Nemesi aptera 66. Ora, questacuriosa tendenza all’assimilazione iconograficacon Vittoria non è casuale e non trova la propria
62 «(…) Castoribus simpli rite dicantur equi».63 «(…) desultores Lucifero et Hespero sacraverunt».64 «Desultores nominati quod olim, prout quisque ad finem cursus venerat, desiliebat et currebat; sive quod de equo in equum transiliebat».65 CHAPOUTHIER 1924, p. 295. A questo proposito, Pausania ricorda come le statue alate di Nemesi fossero creazioni di
epoca “tarda”: si veda il passo della sua opera relativo alla Nemesi di Ramnunte (Paus., I, 33, 7): «(…) pter¦ d’ œcon oÜtetoàto tÕ ¥galma Nemšsewj (la statua della Nemesi di Ramnunte) oÜte ¥llo pepo…htai tîn ¢rca…wn». Cfr. CHAPOUTHIER
1924, p. 297.66 Per una analisi particolareggiata delle problematiche riguardanti la complessa iconografia di Nemesi si rimanda a
PARIBENI 1963 e KARANASTASSI, RAUSA 1992, in particolare pp. 768-770.
A. BACCHETTA196
spiegazione in una semplice questione di gusti odi mode artistiche: essa è, invece, strettamenteconnessa a quello che, sin dai primi tempi delsuo arrivo a Roma (e già, in modi differenti, eraprobabilmente anche nel mondo greco-ellenisti-co 67), è sempre stato considerato il “contesto diazione” di questa divinità, il suo ambito specifi-co, vale a dire il mondo dei giochi e degli spetta-coli pubblici, del circo e dell’anfiteatro (e, in mi-sura minore, del teatro), con le loro gare, i giochie le cacce, di cui Nemesi era considerata una sor-ta di patrona 68. Nemesi era infatti invocata dagliatleti come protettrice dai pericoli delle gare eperchè intervenisse a propiziarne il successo: daciò si sarebbe presto sviluppato un processo gra-duale di avvicinamento progressivo tra le due di-vinità 69. Prima Nemesi avrebbe ricevuto l’appel-lativo di Victrix o Nikaia 70, poi sarebbe stata af-fiancata fisicamente a Vittoria, per arrivare, infi-ne, ad essere identificata completamente conessa 71. Le testimonianze in questo senso sono as-sai numerose. In un suo inno musicale a lei dedi-cato, il poeta Mesomede, vissuto in età adrianea,celebra la dea in questi termini: «(…) cantiamoNemesi, dea immortale/Vittoria dalle ali spiega-te» 72. Una moneta bronzea di Marco Aurelio daStobi (Macedonia) ci mostra la dea stante con tuttigli attributi derivati da Vittoria (ali, corona, pal-ma) e reggente in mano, insieme alla corona, an-che un “braccio”, unità di misura, verosimilmenteimpiegato qui con un marcato valore simbolico73;
identica la ritroviamo anche su una corniola, da-tabile al III secolo d.C. conservata a Monaco 74.Molto significativa è la raffigurazione presentesu una stele votiva marmorea, datata al II-III se-colo d.C., proveniente dal Nemeseum situato nei
67 VON PREMERSTEIN 1894, pp. 404, 407; SCHWEITZER 1931, p. 212. Contro questa opinione si esprime, invece, HORNUM
1993, pp. 44-50, per il quale l’associazione tra Nemesi e le attività agonistiche è comprovata con sicurezza soltanto a partiredalla prima età imperiale romana.
68 Si veda, per una trattazione specifica a questo riguardo: PREMERSTEIN 1894, PERDRIZET 1914, pp. 94-100 e, soprattut-to, HORNUM 1993.
69 PERDRIZET 1914, p. 96 afferma che la palma e la corona di Nemesi sono i simboli delle vittorie agonistiche; BOULEY
1990, p. 244, sottolinea il fatto che Nemesi, prendendo su di sé gli attributi della dea Vittoria, finisce con il rappresentare nonil concetto astratto di vittoria, ma la vittoria reale ottenuta dagli atleti nelle gare e nelle lotte dell’anfiteatro e del circo.CHAPOUTHIER 1924, pp. 298-303 mette in rilievo la dimensione “popolare” di questa divinità affermando che è a questoambito che, verosimilmente, bisogna ricondurre il processo di assimilazione tra Nemesi e Vittoria.
70 PERDRIZET 1914, pp. 95-96 e pp. 98-99; CHAPOUTHIER 1924, p. 295; HORNUM 1993, pp. 69-70. Cfr. CIL, III, 1592:«[Ne]m[e]si Vi(ctrici) / Iul(ius) Candid(us) / Evocat(us) / V L S» e CIL, VI, 531: «Virgini Vic / trici Sanctae / Deae Nemesi / M Aurelius/ Romanus / optio karc / chor XII urb / Gordianae / D P ».
71 CHAPOUTHIER 1924, pp. 297 e 301-302 ricorda la rappresentazione presente su alcune gemme (cfr. POSNANSKY 1890,figg. 35, 36, 41) di Nemesi alata e reggente in mano una palma che viene coronata da Vittoria, giudicandola una sorta di “fasetransitoria” prima della completa identificazione fra le due dee. Analoga raffigurazione è presente su un rilievo pubblicato daPOSNANSKY 1890, p. 161.
72 Mesom., Nem., «(…) Nšmesin qeÕn °domen ¢fq…tan / N…khn tanus…pteron»; il testo integrale dell’inno è riportatoin HORNUM 1993, pp. 115-116.
73 CHAPOUTHIER 1924, p. 297, fig. 5; KARANASTASSI, RAUSA 1992, p. 751, nr. 194.74 KARANASTASSI, RAUSA 1992, p. 764, nr. 242.
Fig. 19 – Stele votiva marmorea; dal Nemeseum dell’an-fiteatro di Flavia Solva. Graz, Museo Archeologico.
IL FREGIO FIGURATO DELL’ARCHITRAVE DEL PORTALE DI SANT’AQUILINO NELLA BASILICA DI SAN LORENZO IN MILANO 197
pressi dell’anfiteatro di Flavia Solva, nel Norico 75
(Fig. 19): in essa vediamo la dea, caratterizzatadai consueti attributi, nell’atto di incoronare ungladiatore, evidentemente il vincitore di una garache ha inteso, con quest’opera, ringraziareNemesi per il favore accordatogli. Quello di Fla-via Solva, d’altronde, non è certo l’unico esem-pio di luogo di culto dedicato a questa divinitàpresso un edificio di spettacolo: lo storico bizan-tino Giovanni Malalas, infatti, ricorda che l’im-peratore Diocleziano consacrò a Nemesi un sa-cello presso la curva del circo di Daphne vicinoad Antiochia 76, e altari o edicole a lei dedicatistanno all’ingresso degli anfiteatri di Aquincum eCarnuntum in Pannonia e di Sarmisegetusa in Dacia77. Sacelli dedicati alla divinità si trovano purenegli anfiteatri di Pola e Salona (datati al II seco-lo d.C.) 78, nonché in numerosi teatri della Mace-donia 79. Un rilievo marmoreo raffiguranteNemesi alata associata ad un grifo e alla ruota(tipici dell’iconografia di Tyche) e reggente nellamano destra un gladio al posto della consuetacorona (mentre nella sinistra si trova il ricorrenteramo di palma) proviene dall’arena di Susa, inPiemonte 80. Significativa è, poi, la serie di rilievivotivi in marmo con dediche a Nemesi provenien-te dal teatro di Thasos 81, probabilmente colloca-ti, in origine, sullo stesso proscenio dell’edificio.E gli esempi potrebbero ancora continuare 82.Frequenti sono anche le dediche epigrafiche alladea provenienti da edifici di spettacolo 83: del tutto
particolare è, ad esempio, quella funeraria delventitreenne gladiatore Glauco di Modena, mor-to a Verona 84, in cui il defunto ammonisce tutti anon riporre alcuna fiducia nella dea che lo ha in-gannato, evidentemente non assistendolo nelloscontro e permettendo così la sua morte. Questaepigrafe, oltre ad attestare ulteriormente lo strettolegame esistente tra Nemesi e il mondo dei giochipubblici, risulta utile anche per introdurre la spie-gazione specifica del motivo per cui l’immagine diquesta divinità si trova, a nostro parere, sul fregioin un punto in cui, secondo ogni evidenza e sullabase delle considerazioni che abbiamo sopra svol-te, dovremmo trovare Saturno. Il gladiatore Glauco,oltre all’ammonizione circa l’«inaffidabilità» diNemesi, consiglia ai lettori del proprio epitaffio diprocurare planetam suum ossia di «scongiurare il suopianeta», volgendo quindi verso quest’ultimo leproprie preghiere e dall’analisi del testo dell’iscri-zione parrebbe indubbio che l’aggettivo possessi-vo suum vada riferito, per l’appunto, alla stessaNemesi. Ma qual era dunque questo pianeta di
Nemesi? Se proviamo a leggere alcuni testi di astro-logia antica la risposta apparirà del tutto evidente.Vezio Valente, astrologo ed erudito del II secolod.C. autore degli Anthologiarum Libri, afferma che«(…) quello di Saturno (…) è l’astro di Nemesi(…)»85; secondo Achille Tazio, commentatore diArato del III secolo d.C., «(…) l’astro di Saturno èdetto (…) dagli Egizi astro di Nemesi» 86; Eliodoro,commentatore di Paolo Alessandrino del VI seco-
75 Conservata a Graz: HUDECZEK 1977, p. 445, tav. 114; KARANASTASSI, RAUSA 1992, p. 764, nr. 243; HORNUM 1993, p.67, tav. XXVII. Per un’analisi approfondita del pezzo si veda DIEZ 1946.
76 Malalas, Chronographia, XII, 307; VON PREMERSTEIN 1894, p. 400 e HORNUM 1993, pp. 53-54; 57.77 PERDRIZET 1914, p. 98; HORNUM 1993, pp. 48-49.78 BOULEY 1990, p. 241. L’autore ricorda anche il rinvenimento nel sacello dell’anfiteatro di Salona di un piccolo altare
votivo con dedica alla dea: «Dia… [ex iu]sso deae [N]emesi / s(olvit) l(ibens) m(erito)». Si veda anche HORNUM 1993, pp. 59-60.79 BOULEY 1990, pp. 242-243.80 MERCANDO 1993, p. 295.81 BERNARD, SALVIAT 1962, pp. 596-603, figg. 17-21.82 Si rimanda agli altri casi significativi citati e discussi in DELPLACE 1980, pp. 408-413 e, soprattutto, all’ampia rassegna
di HORNUM 1993, pp. 56-62.83 Se ne vedano vari esempi in: BENDALA GALAN 1986, pp. 402-404; BIRLEY 1986, p. 33; KENNER 1989, pp. 902-905; per
l’area balcanico-danubiana si rimanda a BOULEY 1990, pp. 242-243. Una raccolta sistematica delle attestazione epigraficherelative a Nemesi è in HORNUM 1993, pp. 153-317.
84 CIL, V, 3466: «(…) planetam / suum / procurare / vos moneo in / Nemese ne fidem / habeatis / sic sum deceptus». Cfr. HORNUM
1993, p. 241, nr. 155.85 Vett.Val., I, 1: «(…) Ð toà KrÒnou (…) ™stˆ Nemšsewj ¢st»r (…)».86 Ach.Tat., Intr.Arat., 17: «(…)toà KronÒu Ð ¢st¾r lšgetai (…) par¦ de A„gupt…oij Nemšsewj ¢st»r» (in MAAS
1958, p. 43). Secondo PERDRIZET 1912, pp. 259-260, qui con il termine “Egizi” non si intenderebbero i sacerdoti egiziani bensìi Greci d’Egitto e gli Egizi di cultura ellenizzata: anche questa testimonianza, pertanto, si riferirebbe ad una tradizionericonducibile all’ambito greco-romano. Si veda anche, a questo proposito, BOUCHÉ LECLERCQ 1899, p. 66, n.1; p. 94, n.1.
A. BACCHETTA198
lo, dice che secondo l’insegnamento di ErmeteTrismegisto «(…) la sorte di Saturno è Nemesi» 87;Efestione di Tebe, poi, sostiene che le statue diNemesi devono essere consacrate «sotto il segnodi Saturno (ossia quando si è nel segno zodiacale del Ca-
pricorno) e nel momento della sua massima altezzanel cielo» 88. Un’ulteriore conferma, sia pure indi-retta, del legame tra Saturno e Nemesi, ci vieneanche da Macrobio che, in un passo dei Saturnalia,ricollega entrambi al sole, facendo esplicito riferi-mento alla potenza dell’astro 89. Curioso è, infine,il passo di Tolomeo (Tetr., III, 11) in cui si affermache Saturno presiede, tra l’altro, all’orecchio de-stro dell’uomo (mentre al sinistro è preposto Mar-te), in quanto «orientale e diurno» e perché assi-milato a Nemesi, la quale ha sede, per l’appunto,dietro questo orecchio in un posto che si solevatoccare con il dito mignolo per chiedere perdonoagli dei di parole oltraggiose 90.
Da queste fonti risulterebbe, quindi, del tutto evi-dente un’associazione assai stretta fra la deaNemesi e il pianeta Saturno, probabilmente spie-gabile con il carattere sostanzialmente negativoattribuito ad entrambi: l’astro dagli influssi sinistriunito alla personificazione della vendetta divina 91.Quindi, se il nostro ragionamento è giusto, la figu-ra alata del fregio non sarebbe Vittoria bensì
Nemesi e la sua presenza si spiegherebbe in baseallo stretto legame che l’associava a Saturno: ri-mane, tuttavia, privo di una spiegazione specifica(al di là del generico timore per eventuali influssinegativi, già chiamato in causa da Albizzati) il mo-tivo per cui si sia qui preferito non raffigurare di-rettamente la divinità planetaria (che, lo ricordia-mo, nel quadro interpretativo da noi propostoimpersonerebbe la sconfitta nelle gare circensi) masolo alludere indirettamente ad essa, a meno disupporre (come siamo assai propensi a fare) che sisia voluto, con questa sostituzione, realizzare unulteriore velato riferimento, una sorta di raffinatae sottile allusione al mondo degli spettacoli pub-blici (e quindi, nello specifico, anche del circo, temadominante del fregio), mondo al quale, come di-mostrato poc’anzi, Nemesi risulta essere stretta-mente legata. Inoltre, si può pensare che con talesostituzione si sia voluto anche raggiungere unperfetto equilibrio speculare tra le due parti delfregio, facendo corrispondere alle divinità maschilidella parte sinistra altrettante divinità femminiliin quella destra 92. D’altronde, proprio questa ri-cerca di equilibrio avrebbe, come già visto, addi-rittura determinato la trasformazione in cavallodell’ariete di Mercurio, al fine di non creare disso-nanze troppo marcate nella composizione figura-tiva dell’opera.
87 Commentarium in Pauli Alexandrini E„sagwg¾n: «(…) tÕn de (klÁron) toà KrÒnou Nšmesin» (in CUMONT 1929, Excerpta
dal codice 4, fol.11). Per la complessa questione delle “sorti” (klÁroi) attribuite dalla dottrina ermetica ai vari pianeti sirimanda a BOUCHÉ LECLERCQ 1899, pp. 307-308.
88 Heph. Astr., Excerpta (Codice Parisinus Graecus 2417): «(…) ™n to‹j (zJd…oij kaˆ Øyèmati) toà KrÒnou» (in CUMONT
1929, p. 151, 12).89 Macr., Sat., I, 22: «(…) Nemesis, quae contra superbiam colitur, quid aliud est, quam Solis potestas? cuius ista natura est, ut fulgentia
obscuret et conspectui auferat, quaeque sunt in obscuro illuminet offeratque conspectui. (…) Saturnus ipse, qui auctor est temporum, (…) quid aliudnisi Sol intelligendus est ? ».
90 Si veda il passo di Plinio il Vecchio (H.N., XI, 251): «Est post aurem aeque dexteram Nemeseos [locus] (…) quo referimus tactumore proximum a minimo digito veniam sermonis a dis ibi recondentes». Cfr. BOUCHE LECLERCQ 1899, p. 321.
91 Si vedano le considerazioni in questo senso di CUMONT 1935, p. 17 e, soprattutto, di PERDRIZET 1912, pp. 259-260:«L’astrologia antica attribuiva le morti violente all’influenza di Saturno e, d’altra parte, davanti ad una morte violenta la fedepopolare pensava anche a Nemesi: se tale morte pareva meritata vi si vedeva la mano di Nemesi, se pareva immeritata se neinvocava vendetta a Nemesi giustiziera». Illuminanti sono anche, a questo riguardo, le parole di BOUCHÉ LECLERCQ 1899, p.94, n.1: «Nemesi è la legge di natura, la ripartizione che attribuisce a ciascuno il suo dovuto, è la distruzione che colpiscenecessariamente – e giustamente – tutte le opere umane. Al pari di Nemesi, Saturno non è forse in astrologia l’autore di mortiviolente (Ptol., Tetr., IV, 8), quelle, appunto, che non sono opera del tempo? Nemesi, simbolo solare per Macrobio (Sat., I, 22,1), si connette al carattere solare di Saturno (…)». Significativi, a proposito del carattere negativo e “vendicativo” attribuitoalla dea, sono anche i versi di Catullo (50, 18-21): «Nunc audax cave sis, precesque nostras / oramus, cave despuas, ocelle, / ne poenasNemesis reposcat a te. / Est vemens dea: laedere hanc caveto».
92 Vale pure la pena ricordare l’attestazione epigrafica – presente nella dedica di un altare di provenienza urbana, datatoalla metà del III secolo d.C. – di una stretta associazione della dea, oltre che a Giove, a Vittoria e al Sole, anche a Marte, incorrispondenza del quale la troviamo, appunto, raffigurata nel nostro fregio: CIL, VI, 2821: «I(ovi) O(ptimo) M(aximo) et Marti et
Nemesi et Soli et Victoriae et omnibus Diis Patriensibus». Cfr. POSNANSKY 1890, p. 123, nr. 3; DELPLACE 1980, p. 407.
IL FREGIO FIGURATO DELL’ARCHITRAVE DEL PORTALE DI SANT’AQUILINO NELLA BASILICA DI SAN LORENZO IN MILANO 199
CONCLUSIONI
Alla fine di questo nostro tentativo di spiegarne ilvalore ed il significato, il fregio del portale diSant’Aquilino lascia in realtà ancora aperti diver-si interrogativi, primo fra tutti quello riguardantela sua presunta unicità: non ci è, infatti, riuscito ditrovare raffigurazioni di alcun tipo che possanoanche solo in maniera indiretta richiamare, nel suocomplesso, quest’opera o comunque ricollegarsi,in qualunque modo, a quell’ambito di tradizioni ecredenze astrologico-circensi in cui abbiamo cre-duto di trovare la possibile chiave di lettura dellascena. Tale situazione non ci permette, evidente-mente, di avanzare alcuna ipotesi circa l’inquadra-mento cronologico di una simile rappresentazio-ne e di conseguenza, dell’intero portale. I testi cheabbiamo utilizzato nella nostra trattazione, infat-ti, si datano sì, per la maggior parte, ad epoca tar-da, in alcuni casi addirittura medievale (pur conla significativa eccezione del passo riferibile aCarace di Pergamo, di età antonina, che costitui-rebbe la più antica attestazione scritta, ad oggiconosciuta, di un rapporto simbolico tra il Circo el’ordinamento cosmico 93), ma sembrano semprerichiamare e presentare, nella sostanza, tradizionie credenze di ben più antica origine. E, d’altro can-to, l’assoluta impossibilità di una qualsiasi analisistilistica, unita ai limiti intrinseci dello studio icono-grafico che generalmente, per quanto condotto conla massima ampiezza possibile, non può, per suastessa natura, fornire indicazioni temporali di unaprecisione tale da risultare in qualche modo utile,ci impediscono di formulare ipotesi fondate circaun inquadramento cronologico, sia pure di ampiomargine, di quest’opera. La datazione tradizionale,formulata da Albizzati, che la vuole ascrivibile al-l’epoca flavia non può venire, a priori, consideratadel tutto incompatibile con il quadro interpretativoche abbiamo formulato, ma, certo, suscita non po-che perplessità nel momento in cui si ponga menteal fatto che, in base ad essa, la raffigurazione pre-sente nel fregio verrebbe a costituire una delle più
antiche rappresentazioni di carattere circense (siapure nel senso del tutto particolare dell’interpreta-zione astrologica del Circo e, anzi, proprio per que-sto ancor più problematica a causa delle implica-zioni di natura culturale e sociale che essa compor-terebbe) a noi pervenute dall’epoca romana.D’altro canto, ad una datazione più tarda ostanodecisamente le considerazioni di carattere stilisti-co (riguardanti, soprattutto, le decorazioni deglistipiti con girali e candelabri) svolte da Albizzati erecentemente ribadite 94 che, nel loro insieme, nonpermettono in alcun modo di abbassare la crono-logia del portale oltre il I secolo d.C. Anche l’ipo-tesi di una rilavorazione, parziale o totale, del fre-gio stesso, per quanto suggestiva e, teoricamente,non impossibile, non risulta tuttavia suffragata daprove concrete (lo stesso restauro non ha indivi-duato alcuna traccia di un eventuale intervento diquesto tipo) e se, da un lato, servirebbe a risolverealcuni problemi ne aprirebbe, dall’altro, di nuovi,forse ancora più complessi, relativi al momento eai motivi di una tale operazione.Alle problematiche riguardanti la cronologia si le-gano strettamente quelle relative alla collocazioneoriginaria del portale: infatti, l’ipotesi più semplicee suggestiva, perfettamente in linea con la raffigu-razione del fregio, che lo vorrebbe proveniente dalCirco della città si scontra inevitabilmente con ladatazione tarda di quest’ultimo, all’epoca tetrarchi-ca, nel momento in cui Milano ricoprì il ruolo dicapitale e di sede dell’imperatore Massimiano epertanto ebbe, unica città della Cisalpina insiemead Aquileia, il cui circo è più o meno contempora-neo, l’onore di possedere un edificio circense 95.Se pertanto la provenienza dal Circo risulta, permotivi cronologici, improponibile, piuttosto proble-matica appare anche la proposta, autorevolmentesostenuta, di ricollegare il portale ad un edificio tem-plare non meglio identificato 96: difficile infatti cisembra, al momento, individuare un possibile lega-me specifico tra il carattere circense del fregio, cheinevitabilmente finisce con il caratterizzare l’interaopera, e la dimensione religiosa di un edificio sacro.
93 ANDREI 1984, p. 56.94 Nel quadro delle ricerche sul portale svolte durante il già ricordato corso di Archeologia e Storia dell’Arte greca e
romana tenuto dalla professoressa Gemma Sena Chiesa presso la Scuola di Specializzazione in Archeologia dell’Universitàdegli Studi di Milano nell’Anno Accademico 1998/99.
95 Per il Circo di Milano si vedano, da ultimi: HUMPHREY 1986, pp. 613-620 e FROVA 1990.96 ALBIZZATI 1937, p. 65; FROVA 1982, p. 174.
A. BACCHETTA200
Le altre possibili soluzioni (edificio pubblico, edifi-cio di spettacolo o, addirittura, monumento fune-rario) risultano, d’altro canto, ancor meno soddi-sfacenti. Piuttosto improbabile ci pare anche la tesidi una provenienza esterna del portale, che pure hatrovato recentemente qualche sostenitore 97.In mancanza di elementi certi su cui fondare lenostre ipotesi preferiamo, pertanto, sospendere ilgiudizio, in attesa di una revisione complessivadella questione e, magari, di future auspicabilinovità della ricerca che possano contribuire a ri-solvere almeno alcuni dei numerosi problemi po-sti da uno dei più interessanti e controversi monu-menti dell’antichità conservati a Milano.
Abbreviazioni bibliografiche
ALBIZZATI C. 1937, Un portale di età romana a Milano, in “LaCritica d’Arte”, II, 1937, pp. 55-65.
ANDREI O. 1984, A.Claudius Charax di Pergamo. Interessi antiqua-
ri e antichità cittadine nell’età degli Antonini, Opuscola Philologa,5, Bologna.
BALIL A. 1966, Ova, Delphini, Roman Circus…and all that, in“Latomus”, 25, 4, pp. 867-870.
BASILICA SAN LORENZO 1951, A. Calderini, G. Chierici,C. Cecchelli, La basilica di San Lorenzo Maggiore in Milano,Milano.
BAUCHHENSS G. 1984, Denkmäler des Iuppiterkultes aus Mainz und
Umgebung, CSIR Deutschland, II, 3, Germania Superior,Mainz am Rhein.
BAUCHHENSS G., SIMON E. 1984, Mars, in LIMC, II, 1, pp.505-580.
BAUCHHENSS G., SIMON E. 1992, Mercurius, in LIMC, VI, 1,pp. 500-554.
BAUDRILLART A. 1900, Jugum, in DAGR, III, 1, pp. 663-668.
BELLONI G.G. 1960, Le monete romane di età repubblicana, Milano.
BENDALA GALAN M. 1986, Die Orientalischen Religionen Hispani-
ens, in ANRW, II, 18-1, pp. 345-408.
BERNARD P., SALVIAT F. 1962, Inscriptions de Thasos, in “BCH”,86, 1962, pp. 578-611.
BIRLEY E. 1986, The deities of Roman Britain, in ANRW, II, 18-1, pp. 3-112.
BOUCHÉ LECLERCQ A. 1899, L’astrologie grecque, Paris.
BOULEY E. 1990, Le culte di Némésis et les jeux de l’amphithéatre
dans les provinces balkaniques et danubiennes, in Spectacula I. Gla-
diateurs et amphithéatres (Atti Toulouse-Lattes 1987), Lattes,pp. 241-251.
CAMERON A. 1976, Circus factions. Blues and Greens at Rome and
Byzantium, Oxford.
CANCIANI F. 1997, Iuppiter, in LIMC, VIII, 1, pp. 421-470.
CASTORINA E. 1961, Tertulliani de spectaculis, Firenze.
CHAPOUTHIER F. 1924, Némésis et Nike, in “BCH”, 48, 1924,pp. 287-303.
CIRQUE ROMAIN 1990, Le cirque romain (Saint-Raymond 1990),Saint-Raymond.
COLONNE SAN LORENZO 1989, Le colonne di San Lorenzo: storia e
restauro di un monumento romano, Modena.
COMPLESSO LAURENZIANO 1990, M.P. Rossignani, S. Bocchio,C. Bertelli, S. Lusuardi Siena, Il complesso laurenziano, inMilano Capitale dell’Impero Romano 286-402 d.C. (Milano1990), Milano, pp. 137-144.
CRAWFORD M.H. 1974, Roman Republican Coinage, Cambridge.
CUMONT F. 1929, Catalogus codicum astrologorum graecorum. VIII-
1 Codices parisini, Bruxelles.
CUMONT F. 1935, Les noms des planetes et l’astrolatrie chez les Grecs,in “AntCl”, 4, 1935, pp. 5-43.
CUMONT F. 1948, Recherches sur le symbolisme funeraire des Romains,Paris.
DAGRON G. 1991, Costantinopoli. Nascita di una capitale, Torino.
DAVID M. 1991, De aurea ecclesia Genesii, in VIA SACRA 1991,pp. 49-61.
DE FRANCESCHINI M. 1998, Le ville romane della X Regio, Roma.
DELPLACE C. 1980, Le griffon de l’archaisme à l’époque impériale,Bruxelles-Roma.
DE MARIA S. 1988, Gli archi onorari di Roma e dell’Italia romana,Roma.
DE VRIES A. 1974, Dictionary of Symbols and Imagery, Amsterdam.
DIEBNER S. 1986, Reperti funerari in Umbria, Roma.
DIEZ E. 1946, Ein Nemesis Relief aus Flavia Solva, in “OJh”,36, pp. 5-14.
DUNBABIN K. 1978, The mosaics of roman North Africa, Oxford.
ESPÉRANDIEU É. 1913, Recueil général des bas-reliefs, statues et bustes
de la Gaule romaine, V (Belgique), Paris.
ESPÉRANDIEU É. 1931, Bas-reliefs, statues et bustes de la Germanie
romaine, Paris-Bruxelles.
FLORESCU G. 1957, Contribution à l’éclaircissement du problème du
médaillon dans l’art gréco-romain, in Hommages a Waldemar
Deonna, Collection Latomus, 28, Bruxelles, pp. 220-225.
FOUGERES G. 1896, Fulmen, in DAGR, II, 2, pp. 1352-1360.
FRENZ H.G. 1992, Denkmäler Romischen Gotterkultes aus Mainz
und Umgebung, CSIR Deutschland, II, 4, Germania Superi-or, Mainz.
FROVA A. 1982, La produzione artistica di età romana, in Archeolo-
gia in Lombardia, Milano, pp. 139-178.
97 DAVID 1991 ipotizza la sua provenienza addirittura dal Circo di Caligola al Vaticano, ristrutturato da Nerone in unperiodo pressappoco corrispondente alla possibile cronologia del nostro monumento e poi occupato da mausolei imperiali trail IV e il V secolo d.C. dopo un lungo periodo di abbandono.
IL FREGIO FIGURATO DELL’ARCHITRAVE DEL PORTALE DI SANT’AQUILINO NELLA BASILICA DI SAN LORENZO IN MILANO 201
FROVA A. 1990, Il Circo di Milano e i circhi di età tetrarchica, inMilano capitale dell’Impero romano 286-402 d.C. (Milano 1990),Milano, pp. 423-431.
GOOSSENS R. 1939, Note sur les factiones du cirque à Rome, in “Byzantion”, 14, pp. 205-209.
GUNDEL H.G. 1970, Pianeti, in EAA Suppl. 1970, pp. 614-623.
GURY F. 1994, Selene, Luna, in LIMC, VII, 1, pp. 706-715.
HORNUM M.B. 1993, Nemesis, the Roman State and the Games,Religions in the Graeco-Roman World, 117, Leiden-NewYork-Köln.
HUDECZEK E. 1977, Flavia Solva, in ANRW, II, 6, pp. 414-471.
HUMPHREY J.H. 1986, Roman Circuses. Arenas for chariot racing,London.
KARANASTASSI P., RAUSA F., Nemesis, in LIMC, VI, 1, pp. 733-770.
KENNER H. 1989, Die Gotterwelt der Austria romana, in ANRW,II, 18-2, pp. 875-974.
IOPPOLO G. 1999, La struttura architettonica, in G. Ioppolo, G. Pi-sani Sartorio (edd.), Circo di Massenzio, Roma, pp. 103-196.
IOPPOLO G., PISANI SARTORIO G. 1999, Glossario latino dei ter-
mini tecnici circensi, in G. Ioppolo, G. Pisani Sartorio (edd.),Circo di Massenzio, Roma, pp. 307-329.
LETTA C. 1988, Sol, in LIMC, IV, 1, pp. 592-625.
LIPPOLD G. 1956, Die Skulpturen des Vaticanischen Museums, III,2, Berlin.
LYLE E.B. 1984, The Circus as Cosmos, in “Latomus”, 43, 4,1984, pp. 827-841.
MAAS E. 1958, Commentariorum in Aratum Reliquiae, Berlin.
MAASKANT-KLEIBRINK M. 1978, Catalogue of the engraved gems
in the Royal Coin Cabinet the Hague, The Hague.
MACCHIORO V. 1911, Il simbolismo nelle figurazioni sepolcrali roma-
ne. Studi di ermeneutica, in “MemNap”, 1, 1911, pp. 3-135.
MANSUELLI G.A. 1958, Galleria degli Uffizi. Le sculture, I, Roma.
MARTIN Th.-H. 1875, Astronomia, in DAGR, I, 1, pp. 476-504.
MERCANDO L. 1993, Alcune considerazioni su un rilievo con divini-
tà alata da Susa, in L. Mercando (ed.), La Porta del Paradiso.
Un restauro a Susa, Torino, pp. 291-298.
MIRABELLA ROBERTI M. 1984, Milano romana, Milano.
MOLIN M. 1990, Les chars de course romains, in Le cirque et les courses
de chars. Rome-Byzance (Lattes 1990), Lattes, pp. 149-153.
NAPOLI 1994, Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Napoli.
PARIBENI E. 1963, Nemesi, in EAA, V, pp. 404-406.
PERDRIZET P. 1912, Némésis, in “BCH”, 36, pp. 248-274.
PERDRIZET P. 1914, Némésis, in “BCH”, 38, pp. 89-100.
POMPEI, Pompei. Pitture e mosaici, 1990-1999, Roma.
POSNANSKY F. 1890, Nemesis und Adrasteia, Breslau.
PREMERSTEIN A. 1894, Nemesis und ihre Bedeutung fur die Agone,in “Philologus”, 53, pp. 400-415.
QUINN SCHOFIELD P. 1966, Ova and Delphini of the Roman Circus,in “Latomus”, 25, 1, pp. 99-100.
REINACH S. 1922, Répertoire de peintures grecques et romaines, Paris.
RIC, Roman Imperial Coinage, London.
ROFFIA E. 1982, I restauri di San Lorenzo, in Restauri archeologici
in Lombardia. Attività della Soprintendenza 1977-1981, Como,pp. 77-90.
ROBERT C. 1897, Die Antiken Sarkophag-reliefs, III-1, Berlin.
ROBERT C. 1919, Die Antiken Sarkophag-reliefs, III-3, Berlin.
SABLAYROLLES R. 1990, La passion du cirque sous le Haut Empire,in Le cirque et les courses de chars. Rome-Byzance (Lattes 1990),Lattes, pp. 127-133.
SAGLIO E. 1887, Currus, in DAGR, I, 2, pp. 1633-1643.
SAN LORENZO 1985, La basilica di San Lorenzo in Milano, Milano.
SCHEFOLD K. 1972, La peinture pompéienne. Essai sur l’évolution
de la signification, Collection Latomus, 108, Bruxelles.
SCHMIDT E. 1997, Venus, in LIMC, VIII, 1, pp. 192-230.
SCHWEITZER B. 1931, Dea Nemesis Regina, in “JdI”, 46, 1931,pp. 175-246.
SIMON E. 1997, Planetae, in LIMC, VIII, 1, pp. 1003-1009.
SINN F. 1987, Stadtrömische Marmorurnen, Mainz.
STUART JONES H. 1912, The sculptures of the Museo Capitolino,Oxford.
STUVERAS R. 1969, Le putto dans l’art romain, Bruxelles.
THUILLIER J.P. 1990, L’origine du Cirque, in Le cirque et les courses
de chars. Rome-Byzance (Lattes 1990), Lattes, pp. 33-37.
TORELLI M. 1984, Lavinio e Roma, Roma.
TORELLI M. 1992, Le basiliche circiformi di Roma. Iconografia,
funzione, simbolo, in G. Sena Chiesa, E.A. Arslan (edd.), Felix
Temporis Reparatio (Atti Milano 1990), Milano, pp. 203-217.
TOYNBEE J.M.C. 1973, Animals in roman Life and Art, London.
TURCN-DELEANI M. 1964, Contribution à l’étude des Amours dans
l’art funeraire romain: les sarcophages à courses de chars, in“MEFRA”, 76, 1, pp. 43-49.
VIA SACRA 1991, M.L. Gatti Perer (ed.), Milano Ritrovata. La via
sacra da San Lorenzo al Duomo (Milano 1991-1992), Milano.
VILLA ALBANI 1992, Forschungen zur Villa Albani. Katalog der
antiken Bildwerke, III, Berlin.
VOLLENWEIDER M.L. 1979, Musée d’art et d’histoire de Geneve.
Catalogue raisonné des sceaux, cylindres, intailles et camées, II,Mainz am Rhein.
VOLLENWEIDER M.L. 1984, Deliciae Leonis. Antike geschnittene
Steine und Ringe aus einer Privatsammlung, Mainz am Rhein.
VOLLKOMMER R. 1997, Victoria, in LIMC, VIII, 1, pp. 237-269.
VON GONZENBACH V. 1961, Die Römischen Mosaiken der Schweiz,Basel.
WUILLEUMIER P. 1927, Cirque et astrologie, in “MEFRA”, 44,pp. 184-209.
WUILLEUMIER P., AUDIN A. 1952, Les médaillons d’applique gal-
lo-romains de la vallée du Rhône, Paris.