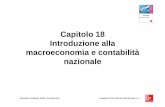La sepoltura dipinta del monastero di Cairate. Origine e sviluppi di una tipologia tombale.
Concetti base materialismo storico non-Marxiano. Prospettive e sviluppi
Transcript of Concetti base materialismo storico non-Marxiano. Prospettive e sviluppi
Krzysztof Brzechczyn, Concetti base materialismo storico nonMarxiano. Prospettive e sviluppi
in:Scienza, marxismo e metafisica. Leszek Nowak e la scuola
metodologica di Poznan, pp. 244-285 a cura di Giacomo Borbone,
Villasanta: Limina Mentis Editore 2012,ISBN-10: 8895881834, ISBN-13: 978-8895881836
storico non-:storico elaborata da Les a scienza e metafisico p̂ do abbastanza semplifi< >uramente politica, pur; hica (come anche due r po economico-politico) ibile nelle seguenti ope
KrzysztofBrzechczyn
St r u t t u r a d i c l a s s e d e l l a v i t a s o c i a l e
Il materialismo storico non-marxiano venne formulato da Nowak nell’ambiente scientifico della cosiddetta Scuola Metodologica di Poznan. Le sue sorgenti intellettuali sono rappresentate, rispettivamente, dalla teoria idealizzazionale della scienza4, dall’interpretazione categoriale della dialettica5 e dall’interpretazione adattiva del materialismo storico6.
Il materialismo storico non-marxiano non è altro che una generalizzazione della teoria sociale di Marx, secondo il quale le divisioni di classe emergevano solamente nella sfera economica. Leszek Nowak, che in questo caso radicalizza il punto di vista marxiano, sostiene invece che la struttura classista della vita economica non è altro che un aspetto particolare della più generale struttura classista della vita sociale nel suo complesso. Le divisioni di classe emergono a causa di un iniquo accesso ai mezzi materiali della società, le quali non emergono solamente nella sfera economica: esse emergono spontaneamente anche nelle altre sfere delle attività umane, come nella politica e nella cultura.
4 Cfr. Id ., U podstaw Marksowskiej metodologii nauki, PWN, Varsavia. 1971; Id ., La scienza come idealizzazione: i fondamenti della metodologia Marxiana, Il Mulino, Bologna, 1977; Id ., The Structure o f Ideali- zation. Towards a Systematic Interpretation o f the Marxian Idea o f Science, Reidel, Dordrecht, 1980 e L. No w a k -I. No w a k o w a , Idealization X: The Richness o f Idealization (Poznan Studies in the Philosophy o f the Sciences and the Humanities, t. 69), Rodopi Amsterdam-Atlanta, 2000.
5 Cfr. L. No w a k , U podstaw dialektyki Marksowskiej. Pròba interpretacji kategorialnej, PWN, Varsavia, 1977.
6 Cfr. Id ., (ed.) Social Classes, Action andHistoricalMaterialism (PoznanStudies in the Philosophy o f the Sciences and the Humanities, vol. 6). Rodopi, Amsterdam, 1982; Id . (ed.) Dimensions o f the Historical Pro- cess (Poznan Studies in the Philosophy o f the Sciences and the Humanities, vol. 13), Rodopi, Amsterdam, 1989 e Id ., The Adaptive Interpretation o f Historical Materialism: A Survey. On a Contribution to Polish AnalyticalMarxism, in L. No w a k , R. Pa n a s i u k (eds.) M arx’s Theories Today (Poznan Studies in the Philosophy o f the Sciences and the Humanities, vol. 38), Rodopi, Amsterdam-Atlanta, 1998, pp. 201-236.
245
Concetti base del materialismo storico non-marxiano: prospettive e futuro
Ognuno di questi momenti sociali (economia, politica e cultura), presenta un’analoga struttura intema; è così possibile distinguere il livello materiale, il livello istituzionale ed il livello della coscienza sociale. Iniziamo dal momento politico. Al livello materiale della vita politica possiamo distinguere i mezzi di coercizione. I rapporti di questi mezzi determinano la divisione della società nella classe dei dominanti (i quali dispongono dei mezzi di coercizione), e nella classe dei cittadini (deprivati di tali possibilità). Questi due vasti gruppi sociali organizzano se stessi tramite stati, partiti politici, organizzazioni civili, associazioni, ecc. (che vanno a formare il livello politico-istituzionale, ossia quella piattaforma all’interno della quale le attività sociali trovano applicazione). A sua volta, la coscienza politica delle classi, cioè le dottrine ideologiche e i programmi politici, dà vita alla dimensione spirituale della vita politica.
Anche la vita economica è dotata di una tale struttura interna. Anche qui, difatti, il livello materiale è costituito dai mezzi di produzione, i quali determinano una divisione in classe dei proprietari e classe dei produttori diretti. La dimensione istituzionale dell’economia abbraccia i sindacati, le associazioni dei lavoratori, i consumatori, ecc. Il livello di coscienza del dominio economico include le dottrine e le concezioni economiche, le quali forniscono ai gruppi sociali la base razionale per le azioni che essi intraprendono.
Nel dominio culturale, il livello materiale è costituito dai mezzi di produzione spirituale - ad esempio, la carta stampata, la radio, la televisione, ecc. I rapporti tra i mezzi di produzione spirituale determinano la seguente divisione di classe: la classe dei preti, i quali dispongono dell’uso dei mezzi di produzione spirituale, e la classe degli indottrinati, privi invece di tale possibilità. Il livello istituzionale della vita spirituale include le organizzazioni delle caste dei preti: chiese, organizzazioni di scrittori, gruppi di artisti, ecc. Dall’altro lato, il livello meta-cognitivo della vita culturale è caratterizzato da frammenti di queste dottrine disseminate, le quali forniscono
246
KrzysztofBrzechczyn
la base razionale per le azioni che tali particolari caste di preti intendono intraprendere.
Grazie a tale cornice concettuale della vita sociale, è possibile distinguere tre autonomi e separati tipi di divisione di classe. Nel dominio politico, la classe che ha a sua disposizione i mezzi di coercizione incrementa il suo ambito di influenza limitando l ’autonomia dei cittadini. Nel dominio economico, la classe che detiene i mezzi di produzione incrementa i suoi profitti a scapito dei salari dei produttori diretti. Nel dominio culturale, coloro che dispongono, invece, dei mezzi di produzione spirituale, aumentano il loro dominio spirituale sugli indottrinati, limitando in tal fatta l’autonomia di questi ultimi. Gli antagonismi sociali che scaturiscono da questo iniquo accesso ai mezzi materiali della società (mezzi di coercizione, di produzione e di indottrinamento), hanno pertanto, in ciascuno di questi tre domini della vita sociale, un carattere autonomo. Le divisioni di classe presenti in altri domini della vita sociale possono rafforzare gli antagonismi in un dato dominio o, all’opposto, indebolirli. Le divisioni di classe possono anche accumularsi quando una classe sociale, ad esempio, se desidera incrementare l’ambito della sua influenza sociale, prende il controllo sia dei mezzi di coercizione che di produzione o sia i mezzi di coercizione che di produzione spirituale.
Il livello di controllo dei mezzi materiali costituisce, pertanto, la base delle divisioni delle società. Utilizzando tale criterio, Leszek Nowak7 distingue le società a tre momenti (laddove le classi esistenti sono separate) ed i sistemi sociali (laddove le divisioni di classe si sovrappongono: società a due momenti e società ad un momento). Nowak delinea inoltre alcune varianti della società a tre momenti, la quale dipende dalle tre classi di oppressori: i governanti, i proprietari ed i preti. In ogni caso, si possono anche delineare le varianti economiche, politiche e gerarchiche della società a tre momenti. Difatti, all’interno della società a due momenti, si possono distinguere tre varianti: quella economico-politica, quella
7 Cfr. Id ., Property and Power, cit., pp. 179-185.
247
Concetti base del materialismo storico non-marxiano: prospettive e futuro
economico-gerarchica e quella politico-gerarchica. Nella società ad un momento, la stessa categoria del popolo gioca sia il ruolo di governante, sia di produttore che di prete; questa è la cosiddetta classe dei triplici signori (governanti-produttori-preti). In questo tipo di società le divisioni di classe raggiungono il punto più alto, poiché una sola classe detiene non solo il monopolio di tutti e tre i mezzi materiali della società (mezzi di coercizione, mezzi di produzione e mezzi di indottrinamento), bensì anche quello di tutti e tre i domini della vita sociale (politica, economia e cultura). Accanto a tutto ciò, vi sta la classe del popolo.
Mo d e l l o d i s o c i e t à e c o n o m i c a
La categoria-chiave nella teoria della società economica è quella della alienazione del lavoro. Vi è una differenza tra i bisogni economici dei produttori diretti e il capitale variabile che essi utilizzano per soddisfare tali bisogni. L’intensità della lotta di classe economica dipende dall’alienazione del lavoro; ovvero quando
• il livello dell’alienazione del lavoro è basso e la maggior parte dei bisogni dei produttori diretti viene soddisfatta (pertanto, anche l’intensità della lotta economica è bassa);
• il livello dell’alienazione del lavoro è alto al punto che la maggior parte dei bisogni dei produttori diretti non viene soddisfatta (anche in questo caso l ’intensità della lotta economica è bassa, poiché la povertà atomizza il popolo rendendolo così incapace di qualsiasi protesta);
• le rivoluzioni irrompono a causa del livello moderatamente alto dell’alienazione del lavoro (pertanto, lo sfruttamento del lavoro diventa alquanto doloroso per la maggior parte dei produttori diretti).
248
KrzysztofBrzechczyn
Queste dipendenze consentono la descrizione della nozione di equilibrio sociale, la quale si presenta come una condizione necessaria per la riproduzione di un dato sistema di rapporti di proprietà. In una società economica isolata, vi sono tre situazioni pure: la pace di classe, la rivoluzione e la declassazione. È ovvio che lo stato di rivoluzione non lo si può considerare come uno stato di equilibrio sociale, poiché il processo di produzione, e quindi la massimizzazione dei profitti dei proprietari, non è possibile durante le perturbazioni rivoluzionarie. Per la struttura economica, l ’equilibrio sociale viene raggiunto nello stato della pace di classe. Nello stato di declassazione, i proprietari possono ottenere la pace sociale, ma al costo della bassa produttività dei loro impiegati. Pertanto, una struttura di classe economica isolata tende naturalmente allo stato di pace di classe, così come allo stato di equilibrio sociale.
Il primo modello di società economica si basa pertanto sulle seguenti assunzioni idealizzanti:
A/ la società S è composta da due classi: i proprietari delle forze produttive e i produttori diretti;
B/ la società S è isolata dal resto delle altre società;C/ il ruolo di coloro che dispongono dei mezzi di coerci
zione e dei mezzi di indottrinamento viene trascurato;D/ il ruolo delle istituzioni economiche viene trascurato;E/ l ’influenza della coscienza economica viene trascurata;F/ il livello delle forze produttive è costante;G/ il numero delle branche della produzione nella società
S non cresce;H/ il fondo di accumulazione nella società S è uguale a
zero.
Consideriamo adesso lo sviluppo, nel tempo, della nostra società idealizzata. Assumiamo che, nel suo momento iniziale, vi sia lo stato della pace di classe tra proprietari e produttori diretti. In tal caso, la competizione tra i proprietari li
249
Concetti base del materialismo storico non-marxiano: prospettive e futuro
forza ad incrementare il plus-prodotto. Nelle condizioni di un livello costante di tecnologia, il solo modo di massimizzare i profitti consiste nel diminuire il capitale variabile dei produttori diretti. Se un proprietario dovesse ritardare nel far ciò. finirebbe coll’essere tagliato fuori dalla classe dei proprietari, a meno che non impari a fare il contrario. Globalmente, la diminuzione del capitale variabile genera l ’alienazione del lavoro, la quale - secondo le assunzioni statiche di questo modello - intensifica la lotta di classe economica. Nelle sue fasi iniziali essa porta ad una diminuzione della produttività dei lavoratori, all’abbandono del lavoro, a scioperi isolati, ecc. Nelle sue fasi finali, invece, l ’alienazione del lavoro genera infine le rivoluzioni economiche di massa: si arriva così alla fase delle rivoluzioni economiche.
Di fronte alle proteste di massa, i proprietari che si trovano nelle condizioni del modello I sono assolutamente senza potere. Per limitare il malcontento generale, alcuni proprietari si vedono costretti ad aumentare le entrate dei produttori diretti. Tuttavia, la situazione non cambia di molto poiché, dopo aver restaurato la pace di classe, i meccanismi della competizione economica forzano un proprietario tipico ad abbassare le entrate dei produttori diretti (e ciò porta di nuovo all’intensificazione della lotta di classe). A lungo andare, l’unica e stabile soluzione al conflitto sociale consiste nel mutare i rapporti di proprietà, rafforzando il legame tra un proprietario tipico e i suoi produttori diretti. Per via dei malcontenti rivoluzionari, alcuni proprietari cedono parte dei loro diritti di proprietà, garantendo così ai produttori diretti una maggiore autonomia di produzione, la quale stimola la loro attività ad un livello maggiore. I proprietari che agiscono in tal modo, cioè che mutano i rapporti di proprietà all’interno delle loro unità produttive, raggiungono la pace sociale. Inoltre, i loro lavoratori saranno più motivati nel lavoro perché - in condizioni di alta produttività - le loro entrate saranno più alte (così come i profitti dei produttori). In tal modo, i proprietari evitano sempre più le perturbazioni rivoluzionarie, modificando profondamente i
250
KrzysztofBrzechczyn
rapporti di proprietà con i loro produttori diretti. Passo dopo passo, emerge così un nuovo sistema economico basato su rapporti di proprietà più appetibili alle masse ed una omogenea classe di proprietari finisce così per dividersi in parti progressive e tradizionali. Quando la maggior parte della produzione globale viene attuata all’interno dei nuovi e progressivi rapporti di proprietà, l’evoluzione della società dà vita ad una nuova formazione socio-economica.
Questo modello è in effetti stato concretizzato ulteriormente da Leszek Nowak. Rimuovendo l’assunzione H (il fondo di accumulazione è uguale a zero), si pone il problema della realizzazione del plus-prodotto. Lo sviluppo economico nel modello II di società economica viene spinto dai consumi dei proprietari8.
Nelle due successive concretizzazioni9, Nowak rimuove l ’assunzione F, la quale postula che il livello delle forze produttive è costante, come anche l’assunzione G , la quale afferma che il numero delle branche della produzione non cresce. Nel modello III, invece, viene rimossa l ’assunzione F supponendo che le forze produttive crescano periodicamente. In questo modello, la crescita delle forze produttive stabilizza i rapporti di proprietà, poiché un produttore tipico si ritrova di fronte alla seguente scelta: cambiare i rapporti di proprietà o incrementare il capitale variabile coperto dalla crescita della produzione (a sua volta stimolata dal progresso tecnologico). Tra le due opzioni egli sceglierà l ’ultima. In questo modo il progresso tecnologico diventa un mezzo per ridurre la lotta di classe - il solo fattore, nel modello, in grado di mutare i rapporti di proprietà. Comunque sia, il modello III non è una buona approssimazione della società feudale, poiché ignora la divisione dell’economia in settore agricolo e settore urbano.
Tuttavia, Nowak nel modello IV rimuove l ’assunzione secondo la quale il numero delle branche della produzione è stabile. Egli assume che nelle fasi finali della crescita delle
8 Cfr. Ib id , pp. 63-77.9 Cfr. Ib id , pp. 78-100.
251
Concetti base del materialismo storico non-marxiano: prospettive e futuro
forze produttive, emerge una nuova branca della produzione: l ’artigianato. Quest’ultima risulta decisiva circa il diverso modo di realizzazione del plus-prodotto se messo a confronto con la precedente formazione. Nel modello IV di società socio-economica, il settore dell’economia agricola creava la domanda per i prodotti realizzati nel settore urbano e viceversa; cioè il settore dell’economia urbana creava la domanda per i prodotti realizzati nel settore agricolo. Un’altra caratteristica di questo modello è il doppio ciclo della lotta di classe, poiché i rapporti sociali presenti in entrambi i settori dell’economia passano attraverso le fasi della crescita dell’alienazione del lavoro, delle perturbazioni rivoluzionarie e attraverso l ’evoluzione dei rapporti di proprietà che si concludono, infine, con la nascita dell’economia unificata.
Nella successiva concretizzazione, Nowak rimuove l’assunzione F supponendo che le forze produttive crescano continuamente (Modello V di società socio-economica). Grazie a tale concretizzazione - ad un livello di micro-scala sociale - i proprietari possono uscire dalle perturbazioni rivoluzionarie non attraverso la revisione dei rapporti di proprietà, bensì attraverso la crescita del capitale variabile. In tal guisa - ad un livello di macro-scala sociale - la classe dei proprietari inconsciamente risolve il problema della realizzazione del plus-prodotto, poiché i laboriosi lavoratori hanno generato la domanda per i prodotti realizzati nell’economia.
La tendenza stabile dello sviluppo socio-economico presente nei modelli I-V, era caratterizzata dalla graduale liberalizzazione del lavoro. La progressiva classe di proprietari di una data formazione è la classe dominante di quella successiva. Il produttore diretto di una formazione successiva è più liberalizzato rispetto a quello di una precedente formazione sociale, proprio perché egli possiede, rispetto a colui che lo ha preceduto, una più grande autonomia produttiva.
252
Il m o d e l l o d i s o c i e t à p o l i t i c a
In questo modello assumiamo che ogni cittadino ha il suo insieme di preferenze, le quali orientano le sue azioni. Tra le varie azioni attuate dai cittadini, possiamo distinguere quelle che sono autonome e regolamentate. Le azioni regolamentate sono quelle gestite dalla repressione dei governanti, mentre quelle autonome non vengono gestite da simili sanzioni inflitte con tali mezzi repressivi. Il rapporto tra l ’ammontare delle azioni regolamentate e il numero delle azioni intraprese dai cittadini (universo delle azioni) corrisponde alla alienazione civile.
Vi sono due metodi per subordinare la vita sociale: la burocratizzazione ed il terrore. Con la burocratizzazione il potere permea gradualmente l ’intera struttura della vita sociale, impedendo in tal modo ai cittadini di compiere, liberamente, azioni sociali. Con il terrore, invece, i governanti “eliminano” fisicamente dalla vita sociale (tramite la morte, lunghi periodi di prigionia, isolamento, ecc.) tutti quei cittadini che fungono da centro di rapporti sociali indipendenti. In ogni caso, lo stato di declassazione non dura in eterno. Infatti, assumiamo che quando la burocratizzazione della vita sociale supera una certa soglia, allora appare una tendenza alla rivitalizzazione degli autonomi legami sociali vigenti tra i cittadini. Ciò significa che gli strati sociali statizzati vengono rimpiazzati da quelli autonomi, di modo che i rapporti sociali controllati dalle autorità svaniscano per far posto ad una più allargata sfera della vita sociale autonoma.
Assumendo che l ’intensità della resistenza civile dipenda dal livello di alienazione civile, possiamo rappresentare il tutto come segue:
• quando il numero delle azioni regolamentate è basso (e quando anche l ’alienazione civile lo è), allora prevale la pace di classe;
• quando il livello dell’alienazione civile è alto, il
KrzysztofBrzechczyn
253
Concetti base del materialismo storico non-marxiano: prospettive e futuro
livello di resistenza è basso poiché i cittadini (declassati ed atomizzati), sono incapaci di reagire;
• una rivoluzione politica del primo tipo irrompe quando l ’alienazione civile è moderatamente alta: essa è dolorosa abbastanza da poter provocare reazioni politiche, ma è anche incapace di prevenire le comuni proteste dei cittadini;
• quando l’alienazione civile cresce al punto da generare l’eliminazione dei rimanenti legami sociali indipendenti, allora si verifica una rivoluzione politica del secondo tipo.
Consideriamo adesso lo stato di equilibrio sociale in una società politica. In un sistema politico di classe isolato - diversamente da quello economico - l ’equilibrio sociale viene raggiunto attraverso la declassazione dei cittadini, poiché la crescita del potere è possibile solo nelle condizioni di schiavitù dei cittadini. Sebbene la pace di classe permetta il mantenimento della dominazione politica, tuttavia essa ostacola la massimizzazione della regolamentazione del potere. Pertanto, una struttura di classe politica isolata tende naturalmente allo stato di declassazione, quando invece l ’interesse della classe dei governanti può essere massimizzato senza impedimenti.
Il primo modello della società politica si basa sulle seguenti assunzioni idealizzanti:
A/ la società S è composta da due sole classi - i cittadini e i governanti;
B/ la società S è isolata da tutte le altre società;C/ il ruolo di coloro che dispongono dei mezzi di produ
zione e di coloro che dispongono invece dei mezzi di indottrinamento, viene trascurato.
D/ il ruolo delle istituzioni politiche viene trascurato;E/ il ruolo della coscienza politica viene trascurato;F/ il livello dei mezzi di coercizione è costante;G/ i governanti applicano direttamente i mezzi di coerci
254
KrzysztofBrzechczyn
zione.Consideriamo adesso lo sviluppo, nel tempo, della nostra
società politica idealizzata. In questo caso supponiamo che, nella fase iniziale dei rapporti dinamici tra governanti e cittadini, prevalga la pace di classe. Per via dei meccanismi di competizione politica tra coloro che dispongono dei mezzi di coercizione, un governante, mediamente, è costretto ad allargare la sua sfera di regolamentazione. Coloro i quali non competono vengono eliminati dalla struttura politica del potere oppure, attraverso processi per tentativi ed errori, imparano ad allargare la loro sfera di controllo. Di conseguenza, l’autonomia sociale svanisce e la sfera del potere di regolamentazione si allarga. La crescita della regolamentazione del potere intensifica le resistenze dei cittadini, la quale si trasforma, gradualmente, in rivoluzione civile di massa. La possibile vittoria o fallimento di una rivoluzione civile apre la strada alla biforcazione dello sviluppo politico. Supponiamo che siano i cittadini a vincere. Allora, da un punto di vista puramente materialistico, nulla cambia, poiché all’interno della classe dei cittadini si ricostituisce una divisione tra coloro che dispongono dei mezzi di coercizione e coloro che invece sono privi di una tale influenza. Pertanto, una élite rivoluzionaria struttura il cuore stesso della nuova classe di governanti. Il meccanismo della competizione politica vigente fra di essi, porta ancora una volta alla crescita del potere di regolamentazione. Ciò, a sua volta, porta ad una crescita della resistenza civile e quindi allo scoppio di una successiva rivoluzione politica. Quando è la rivoluzione a vincere di nuovo, allora il meccanismo della competizione tra l’élite rivoluzionaria conduce alla crescita del potere di regolamentazione. Essa provoca lo scoppio della successiva rivoluzione e tale sviluppo si ripete ancora una volta: rivoluzione vittoriosa - crescita del potere di regolamentazione come risultato della competizione tra l ’élite rivoluzionaria - crescita della resistenza civile
255
Concetti base del materialismo storico non-marxiano: prospettive e futuro
- scoppio della prossima rivoluzione10. La fase della crescita post-rivoluzionaria del potere di regolamentazione, tuttavia, non si ripete all’infinito e qualche rivoluzione andrà persa. La sconfitta della rivoluzione dei cittadini consente ai governanti (sia quelli nuovi che quelli vecchi) di utilizzare il terrore post-rivoluzionario. Quest’ultimo affligge coloro i quali provengono dalla classe dei cittadini appartenenti ai legami sociali indipendenti. L’atomizzazione della classe dei cittadini rende possibile il controllo di un numero sempre crescente di campi sociali. Quando tutti i domini della vita sociale vengono subordinati, il sistema raggiunge allora lo stato di totale schiavitù. In tali circostanze, gli unici mezzi per fermare il potere svaniscono. Sotto tali condizioni sociali, non vi sono sfere sociali da regolamentare, in quanto il meccanismo della competizione politica forza i governanti tipici ad allargare la loro sfera di regolamentazione; in tal fatta, la competizione procede ulteriormente a scapito delle sfere sociali già sottoposte al controllo degli altri governanti. Le purghe periodiche, le quali fanno piazza pulita di tutti gli altri eventuali candidati, risolvono così il problema della sovra- competitività. In tal modo, la schiavitù dei cittadini trasforma se stessa in auto-schiavitù dei governanti i quali, al culmine del loro apparato di potere, conquistano gradualmente il centro del potere. Comunque sia, sulla base delle assunzioni accettate nel modello di società politica, vi è una tendenza verso la graduale rivitalizzazione dei legami sociali indipendenti, la quale fa accrescere l ’abilità dei cittadini a resistere. Ciò porta ad una rivoluzione del secondo tipo, la quale dà inizio ad una graduale riduzione del potere di regolamentazione. Questa rivoluzione viene soppressa dai governanti, al fine di evitarne altre riducendo, in tal modo, anche lo scopo del loro controllo.
10 Questa sequenza evolutiva viene da Nowak definita pgtla obywatelska. Tradotto letteralmente, tale termine significa “cappio civile” (in inglese “civil loop”), ed indica lo scoppio di una successiva rivoluzione condotta contro le autorità rivoluzionarie. Nota del traduttore.
256
KrzysztofBrzechczyn
Tuttavia, i meccanismi della competizione politica generano ancora una volta la crescita del potere della regolamentazione, innescando lo scoppio della rivoluzione successiva su larga scala. Questa obbliga i governanti a fare concessioni più larghe e ciò, in tal caso, rende più difficile ai governanti reprimere i ribelli. Pertanto una società politica si evolve secondo lo schema seguente: rivoluzione civile-repressione-conces- sioni-crescita della regolamentazione politica-prossima rivoluzione politica su una base sociale più ampia.
In questa fase, irrompono le proteste di massa e la loro scala è così ampia che le autorità, invece di bloccare tutto con le repressioni, non hanno altra scelta se non quella di elargire concessioni, le quali riducono il controllo dei governanti ad un livello abbastanza sopportabile per i cittadini.
Il presente modello di società politica si basa su una teoria multi-modellata del potere politico. Nowak11 rimuove gradualmente le assunzioni idealizzanti B, Non-C e D-G costruendo, pertanto, una sequenza di modelli all’interno dei quali egli prende in considerazione il ruolo politico delle istituzioni, la coscienza sociale delle classi politiche, l ’efficace aggressività dei rapporti interni che portano alla costruzione di un impero politico, la crescita tecnologica dei mezzi di coercizione, i rapporti di forza tra l ’esercito e le autorità politiche e le lotte competitive all’interno delle autorità nel corso dello sviluppo della società politica.
11 Cfr. Id ., Power and Civil Society, cit.
257
Il m o d e l l o d i s o c i e t à g e r a r c h i c a
Iniziamo col distinguere la nozione spirituale di autorità con quella di dominazione spirituale. Una persona B è un’autorità spirituale per A, relativamente ad un a classe di credenze Z, se condizione necessaria e sufficiente affinché A accetti ciascuna di esse è solamente la consapevolezza che tali credenze appartengono a B.
Una persona B domina spiritualmente la persona A, relativamente ad un a classe di credenze Z , se condizione necessaria e sufficiente affinché A accetti ciascuna di esse è solamente la consapevolezza che tali credenze appartengono a B. In altre parole, possiamo dire che la persona B dogmatizza (in un senso ben definito) la coscienza della persona A12.
Il meccanismo della competizione spirituale forza un prete tipico (religioso o secolare) ad allargare la sua sfera di regolamentazione. Quei preti che non allargano effettivamente la loro sfera di regolamentazione verranno allontanati dalla gerarchia dei preti, a meno che non imparino a fare tutto ciò. L’interesse della classe dei preti consiste nell’allargamento dell’ambito di regolamentazione spirituale, mentre quello della classe dei credenti si basa invece sull’allargamento della loro sfera di autonomia spirituale. La resistenza spirituale dei credenti è caratterizzata dal rifiuto delle visioni del mondo imposte dai preti, i quali impongono le loro norme di condotta sia nella sfera pubblica che privata. Questa resistenza può assumere diverse forme: decrescita della partecipazione dei credenti nelle cerimonie organizzate dai preti, con un conseguente aumento del divario tra le preferenze dichiarate (sotto l ’influenza dei preti) e quelle realizzate, riconoscimento dei preti come cattivi interpreti di una determinata dottrina, conversione in diverse concezioni del mondo religiose o secolarizzate. Una resistenza così concepita può dar vita ad una
Concetti base del materialismo storico non-marxiano: prospettive e futuro
12 Cfr. P. Bu c z K o w s K i-A. K l a w i t e r -L. N o w a k , Religia jako struktura kla- sowa. Przyczynek do nie-Marksowskiego materializmu historycznego, in «Studia Religiologia», vol. 20, 1987, pp. 79-128.
258
KrzysztofBrzechczyn
rivoluzione spirituale senza l ’utilizzo della violenza.L’intensità della lotta di classe dipende dall’alienazione
spirituale, la quale costituisce il rapporto tra i giudizi dogmatizzati e l ’universo dei giudizi accettati dai credenti. In questo caso, la contraddizione tra i preti ed i credenti non porta ad una crescita della resistenza spirituale, visto che anche la regolamentazione spirituale dei preti è in crescita. Visto che ogni individuo possiede una sua concezione del mondo, possiamo ben dire che un debole intervento nelle concezioni del mondo genera una rivoluzione spirituale. Il basso livello della regolamentazione spirituale causa la rivoluzione (esterna) del primo tipo. Il secondo campo della rivoluzione (interna), invece, si verifica quando tutte le coscienze dei credenti vengono dogmatizzate, e sono quindi prive di ogni autonomia spirituale rispetto ai preti. Lo stato della pace spirituale avviene ad un livello moderatamente alto di regolamentazione spirituale. Possiamo riassumere le lotte di classe delle classi spirituali nel seguente modo:
• quando il livello di alienazione spirituale è basso, allora si verifica una rivoluzione del tipo I;
• la pace di classe prevale quando il livello di alienazione spirituale è moderatamente alto;
• quando il livello di alienazione spirituale è alto, allora si verifica una rivoluzione del tipo II.
Prendiamo adesso in considerazione le condizioni di equilibrio sociale presenti in questo tipo di società. È ovvio che lo stato della rivoluzione spirituale esclude la realizzazione dell’interesse di classe dei preti. L’equilibrio sociale lo si può ottenere sia in uno stato di pace di classe sia in uno stato di declassazione. Visto che la classe dei preti, priva dei mezzi di coercizione, non è in grado di proteggere se stessa dalla resistenza spirituale degli indottrinati, allora lo stato di equilibrio sociale corrisponde alla pace di classe. La struttura isolata della classe spirituale tende naturalmente alla pace di classe,
259
Concetti base del materialismo storico non-marxiano: prospettive e futuro
la quale corrisponde al suo stato di equilibrio.Il modello della società puramente spirituale si basa sulle
seguenti assunzioni idealizzanti:
A/ la società S è composta da due sole classi: i preti e gli indottrinati;
B/ la società S è isolata da tutte le altre società;C/ il ruolo di coloro che dispongono dei mezzi di coerci
zione e dei mezzi di produzione viene trascurato;D/ il ruolo delle istituzioni spirituali viene trascurato;E/ il ruolo della meta-coscienza viene trascurato;F/ il livello dei mezzi di indottrinamento è costante;G/ i preti applicano direttamente i mezzi di indottrinamen
to.
L’evoluzione di questa società spirituale idealizzata consta di sei fasi: la fase del primo rifiuto, la fase dell’assorbimento delle alternative, la fase degli scismi, la fase dell’ecumenismo, la fase dell’assimilazione ed infine la fase della paga- nizzazione.
Durante la fase iniziale dell’evoluzione, vi è un pluralismo generale in una data società e le concezioni dei credenti non sottostanno ad uno schema comune. L’intervento dei preti nelle concezioni dei credenti genera la loro resistenza. Ad un tale livello di idealizzazione non è possibile stabilire se una data fede incrocia la fase dello sviluppo sociale o meno. Sebbene attraverso questo modello non sia possibile rendere conto delle condizioni sufficienti della perdita di una data fede attraverso lo stadio del rifiuto, tuttavia si possono fornire le condizioni della sua ulteriore espansione. Tale condizione è costituita dalla accettazione di tutto ciò che non contraddice le assunzioni di una nuova fede. In questa fase di sviluppo, si manifesta l’assorbimento delle concezioni esistenti e la riconciliazione dei suoi dogmi con la fede dominante.
Dopo la conquista spirituale della società, la classe dei preti inizia ad eliminare dalla coscienza dei credenti tutti quei
260
KrzysztofBrzechczyn
motivi che stanno alla base delle loro concezioni e che, pertanto, non sono in accordo con la fede dominante. Ciò genera la dogmatizzazione della coscienza dei credenti la quale - secondo le assunzioni del modello - stimola la loro resistenza spirituale. Per via delle rivoluzioni spirituali, fanno la loro comparsa le fedi riformate FfriI, Ffri2, ecc., con dogmi meno numerosi e con un basso livello di alienazione spirituale. Inoltre, il crescente pluralismo presente nelle questioni di coscienza incrementa la probabilità di conversione - ossia, l ’apparenza di una fede F con un insieme differente di assunzioni concernenti tale concezione.
Il numero crescente degli scismi e delle conversioni indebolisce la posizione della fede iniziale. L’indebolimento della competizione spirituale e la fusione con altre fedi permettono di bloccare il flusso dei credenti. Tale situazione dipende dalla proporzione delle forze tra le fedi calcolate in base al numero dei credenti. I candidati più probabili per una tale fusione sono proprio le fedi riformate più vecchie, poiché queste ultime si evolvono sempre attraverso fasi di rifiuto, assorbimento di alternative e scismi. Meno probabile è invece la fusione con le fedi più recenti, poiché siamo nel periodo di espansione spirituale. Poiché la fusione finale dipende dalle aspettative di crescita dei credenti, vi è anche la possibilità di fusione con fedi provenienti da differenti visioni del mondo. In quest’ultimo caso, questa nuova fede assumerà un carattere sincretico.
La fusione spirituale, in ogni caso, non deve avvenire necessariamente, poiché tale processo dipende dalle proporzione delle forze tra fedi diverse. A seguito dell’assimilazione spirituale di nuove fedi da parte di una fede iniziale F , i preti della vecchia fede si uniranno a quest’ultima. Ciò significa che la fine della fede iniziale durerà per un certo periodo di tempo, ma senza i suoi preti.
261
Un m o d e l l o d i s o c i e t à p o l i t i c a c o n u n ’e c o n o m i a
s t a z i o n a r i a
Nei modelli finora presentati, i rapporti tra la classe dei proprietari, dei produttori diretti, dei governanti, dei cittadini, dei preti e dei credenti, li abbiamo considerati isolatamente ed abbiamo anche trascurato l ’impatto di altre divisioni di classe. Nowak, in tal caso, costruisce un modello di società politico-economica priva dell’assunzione A (la società consiste di due sole classi: proprietari e produttori diretti), che Nowak rimpiazza con la più debole assunzione A+: la società S è composta da tre classi: proprietari, governanti e popolo. Le rimanenti assunzioni idealizzanti rimangono le stesse.
In una tale società vi sono tre tipi di conflitti: la lotta di classe politica tra governanti e cittadini, la lotta di classe economica tra proprietari e produttori diretti e la competizione sopra-classista tra governanti e proprietari. Entrambe le classi hanno interessi materiali differenti: i proprietari cercano di massimizzare il plus-prodotto, mentre i governanti la regolamentazione del potere. L’ostacolo nella massimizzazione del plus-prodotto è caratterizzato dalla resistenza dei produttori diretti, i quali possono essere neutralizzati con l ’ausilio di coloro che dispongono dei mezzi di coercizione (ciò corrisponde ad una situazione di alleanza sociale tra la classe dei governanti e quella dei proprietari). L’ostacolo nella massimizzazione della regolamentazione del potere politico è caratterizzata, invece, dalla resistenza civile portata avanti dai cittadini più potenti, cioè i proprietari. Tuttavia, la strategia più ottimale per i governanti consiste nella divisione della classe dei cittadini grazie ad un’alleanza con la classe dei proprietari. Entrambe le classi sociali possono avere interessi parzialmente coincidenti oppure parzialmente divergenti, i quali determinano le condizioni per poter instaurare un’alleanza sopra-classista oppure rivaleggiare. Presentiamo adesso le condizione dell’alleanza sopra-classista dal punto di vista dei proprietari. La base per tali analisi sarà lo sviluppo del
Concetti base del materialismo storico non-marxiano: prospettive e futuro
262
KrzysztofBrzechczyn
la società economica isolata. Durante la fase della crescente alienazione del lavoro prevarrà la tendenza alla competizione sopra-classista. In ogni caso, quando la crescita dell’alienazione del lavoro è troppo alta al punto da intensificare al lotta di classe economica, allora tale tendenza diminuisce gradualmente per rimanere ancorata alla fase dell’evoluzione dei rapporti di proprietà.
Veniamo adesso alle condizione dell’alleanza sopra-classista dal punto di vista dei governanti. La base per tali analisi sarà lo sviluppo della società politica isolata. Durante la fase della crescente alienazione civile, prevarrà la tendenza all’alleanza sopra-classista. Ciò perché in questo stadio dello sviluppo sociale il raggio d ’azione della regolamentazione politica è limitato; si assiste pertanto ad un’alleanza con i proprietari la quale consente ai governanti di dividere la popolazione in proprietari e lavoratori. La tendenza all’alleanza viene rafforzata nelle condizioni in cui vige l’intensificazione della lotta di classe civile, e ciò avviene sino allo scoppio di una rivoluzione civile. Dopo la disfatta dei disordini civili, nella fase della schiavitù, la tendenza all’alleanza sopra-classista diminuisce per poi venir rimpiazzata dalla tendenza alla competizione sopra-classista. In tal caso, la classe dei proprietari diventa così l ’ostacolo più grande alla statizzazione della vita sociale (specialmente nell’economia). Presentiamo adesso, in maniera estremamente semplificata, l ’evoluzione di una tale società.
All’inizio di questa fase (ossia la fase della crescita dell’alienazione del lavoro e della diffusione del potere), la classe dei proprietari domina sulla classe dei governanti. A causa del meccanismo della competizione economica, il capitale variabile posseduto dai produttori diretti si riduce progressivamente. Lo sfruttamento crescente dei produttori diretti genera una crescita graduale della lotta di classe. Al fine di controbilanciare le proteste rivoluzionarie dei produttori diretti, i proprietari colgono alcune prerogative delle autorità. A lungo andare, la tendenza ad abbracciare la funzione dello stato, porterà
263
Concetti base del materialismo storico non-marxiano: prospettive e futuro
alla società totalitaria E ed alla trasformazione della classe dei proprietari nella doppia classe dei governanti-proprietari. Comunque sia, secondo le assunzioni del modello della società economica isolata, la crescita dell’alienazione del lavoro intensifica la lotta di classe economica, la quale conduce allo scoppio della rivoluzione.
In una società economica isolata, le rivoluzioni di popolo possono concludersi o con l’evoluzione dei rapporti di proprietà o con dei mutamenti negli scontri sociali. Nella società politico-economica, le rivoluzioni di popolo si trasformano in scontri sociali a causa dell’alleanza tra governanti e proprietari. Se nel corso di tale scontro dovesse vincere la rivoluzione di popolo, allora l’élite rivoluzionaria soggetta al meccanismo della competizione politica si appropria dei mezzi di produzione e di coercizione, al punto da trasformare la società in una società totalitaria P. Comunque sia, la vittoria della rivoluzione di popolo di fronte alla mobilizzazione delle due classi di oppressori sembra un’ipotesi poco probabile. I proprietari abbattono le rivoluzioni con l ’ausilio delle autorità. Esse permettono ai governanti di reprimere le proteste e di applicare un terrore selettivo ed a breve termine, anche se non condividono la declassazione a lungo termine dei produttori diretti; ciò perché una eccessiva regolamentazione delle autorità all’interno dei rapporti economici divergerebbe dagli interessi economici dei proprietari. Comunque sia, il freno imposto dalle masse ed il terrore duraturo fanno sì che l’alienazione civile decresca e che i produttori diretti riguadagnino l ’abilità nel fare rivolte. Tuttavia, questa nuova rivoluzione presenta due possibilità: o la vittoria del popolo conduce ad una totalitarizzazione oppure la disfatta genera repressioni selettive ma di breve durata. In tal fatta, la società si evolve seguendo tale schema: rivoluzione-pace politica e repressioni a breve termine-crescita dell’alienazione civile-scoppio della prossima rivoluzione. La sequenza delle rivoluzioni porta i proprietari alla convinzione secondo la quale il potere politico non sia poi un alleato così efficiente - esso è capace di soppri
264
KrzysztofBrzechczyn
mere le proteste, ma incapace di prevenire quelle successive. A lungo andare, la base per la pace sociale stabile può essere solo la modifica dei rapporti di proprietà.
L’evoluzione dei rapporti di proprietà provoca la divisione dell’omogenea classe dei proprietari in due strati: tradizionali e progressivi. Comunque sia, la divisione della classe dei proprietari in due sotto-classi facilita la liberazione dei governanti dai limiti imposti dalla classe dei proprietari, e consente inoltre la crescita del loro ambito di regolamentazione. A ll’inizio di tale processo, l ’alleato delle autorità è la debole sotto-classe dei proprietari (quella progressiva), la quale viene supportata dai governanti contro i proprietari tradizionali. Quando la maggior parte della produzione globale viene realizzata all’interno dei nuovi rapporti di proprietà, i governanti si alleano col partner più debole, cioè con la sotto-classe tradizionale dei proprietari. La crescita graduale dell’ambito di applicazione della regolamentazione, viene realizzata al prezzo della soggiogazione del popolo; inoltre essa limita anche l ’autonomia dei proprietari progressivi, i quali si alleano con la classe dei cittadini. Infine, la crescita dell’alienazione civile, secondo le assunzioni di questo modello, genera lo scoppio della rivoluzione civile.
Per quel che concerne la fase della rivoluzione civile, va detto che il suo esito dipende dalla statizzazione della vita sociale. Se la rivoluzione scoppia troppo presto (quando ad esempio un nuovo settore dell’economia non emerge pienamente e una nuova classe di proprietari è ancora socialmente debole), allora essa si conclude con una disfatta e le autorità che conquistano il controllo dei mezzi di produzione realizzano la società totalitaria P. Se la rivoluzione avviene invece quando la maggior parte della produzione globale viene realizzata all’interno dei nuovi rapporti di produzione, allora essa ha più probabilità di vittoria. Nel caso della vittoria civile, i rapporti tra i proprietari progressivi e i nuovi governanti rivoluzionari si capovolgono, poiché le nuove autorità rivoluzionarie sono soggiogate dai proprietari progressivi. Lo stato,
265
Concetti base del materialismo storico non-marxiano: prospettive e futuro
in questo caso, diventa uno strumento nelle mani di questa sotto-classe. Ecco perché le principali barriere ed ostacoli che limitano lo sviluppo di un nuovo settore dell’economia, nel periodo post-rivoluzionario, spariscono mentre al contempo generano una decrescita dell’alienazione civile. Questo modello detiene le caratteristiche di sviluppo della formazione schiavistica e feudale. Comunque sia, lo sviluppo del capitalismo non rientra nel modello che abbiamo appena delineato, poiché abbiamo ignorato un importante fattore materiale, cioè il continuo progresso tecnologico.
Il m o d e l l o d i s o c i e t à p o l i t i c o -e c o n o m i c a c o n
u n ’e c o n o m i a d i n a m i c a
In questo modello rimpiazziamo l’assunzione idealizzante F (il livello delle forze produttive è costante) con quella affermante che le forze produttive crescono continuamente; mentre le altre assunzioni rimangono immutate.
L’utilizzo delle nuove tecnologie da un lato favorisce una certa crescita della produzione (chiameremo tutto ciò il surplus tecnologico), dall’altro genera una maggiore efficienza del lavoro. Nelle condizioni di pace di classe, l’intero surplus tecnologico viene posseduto dalla classe dei proprietari i quali, in questo modo, massimizzano il loro profitto. Quando invece sorge un conflitto di classe, allora il surplus tecnologico diventa un mezzo di pacificazione delle proteste dei lavoratori, poiché esso favorisce una crescita delle loro entrate.
Veniamo adesso alla fase della crescente alienazione del lavoro e del collasso del potere. Al suo stadio evolutivo iniziale, la classe dei proprietari domina su quella dei governanti. Per via della competizione economica, un proprietario tipico è costretto a massimizzare i suoi profitti. Il modo più semplice per realizzare tutto ciò consiste nel ridurre il capitale variabile dei produttori diretti. La crescita dell’alienazione del lavoro
266
KrzysztofBrzechczyn
intensifica la lotta di classe economica, la quale si conclude con una rivoluzione di massa.
Nelle condizioni del modello I della società economica, un proprietario tipico, il quale deve fronteggiare le proteste di massa, non muta i suoi rapporti di proprietà. Invece, nel modello di società economico-politica con un’economia stazionaria, un produttore tipico ha due possibilità per risolvere il conflitto con i suoi impiegati: (1) invocare le forze militari oppure (2) mutare i rapporti di proprietà. Nelle condizioni di tale modello un produttore tipico ha una possibilità in più: (3) far aumentare le entrate degli impiegati, le quali possono essere coperte con il surplus tecnologico.
Supponiamo che in caso di proteste sociali i proprietari facciano ricorso alle forze armate per sedare eventuali rivolte da parte dei lavoratori. In questo caso, l ’intervento delle forze armate si rivelerebbe una pessima soluzione, poiché finirebbe con lo sconvolgere il processo di produzione. Tuttavia, un metodo ottimale per risolvere il conflitto di classe consiste nell’incrementare le entrate degli impiegati, i quali possono ricevere finanziamenti dalle aspettative di crescita della produzione stimolata dal progresso tecnologico. Sempre più proprietari, attraverso il metodo per tentativi ed errori, sono convinti che il metodo migliore consista nel prevenire la domanda di entrate piuttosto che aspettare le proteste dei lavoratori. La conciliazione delle richieste degli impiegati viene coperta dal progresso tecnologico previsto. In tal fatta, i proprietari assicurano una pace sociale stabile all’interno delle unità economiche e la classe dei lavoratori resta compatta. La peculiarità di questa fase di sviluppo consiste nella graduale diminuzione dell’alienazione del lavoro; in tal modo la lotta di classe economica scompare senza che vi siano particolari modifiche nei rapporti di proprietà.
Veniamo adesso alla fase del collasso economico. La pace sociale a lungo termine fa sì che la classe dei produttori diretti sia sempre meno propensa a rischiare con delle proteste di massa. La smobilizzazione dei produttori diretti fa sì che i
267
Concetti base del materialismo storico non-marxiano: prospettive e futuro
proprietari siano sempre meno ansiosi di accrescere il capitale variabile. Di conseguenza, appaiono nuovamente il problema della sovrapproduzione e la realizzazione del surplus. L’economia va in crisi e le masse, a lungo smobilizzate dalla pace sociale, non sono in grado di organizzare al più presto una protesta grazie alla quale ripristinare, attraverso una crescita delle entrate, l’equilibrio economico tra domanda ed offerta.
Si arriva così alla fase della statizzazione della vita sociale. In questa situazione la classe dei governanti entra nella scena sociale. La crescita dell’intervento statale nell’economia soddisfa due scopi in uno: la liquidazione della sovrapproduzione e l ’allargamento della sfera di regolamentazione. Il crescente intervento statale nell’economia assume la forma o del welfare state o dello stato militare. In ogni caso, il suo significato sociale rimane lo stesso - statizzazione dell’economia, la quale è l ’unico aspetto della statizzazione generale della vita sociale.
Arriviamo adesso alla fase delle rivoluzioni civili. Secondo le nostre assunzioni, la crescita dell’alienazione civile genera la resistenza civile. Inizialmente, strati marginali di cittadini vengono coinvolti nella protesta. Ciò perché la classe dei proprietari, per via del processo di burocratizzazione, è priva di ogni significato sociale, laddove la classe dei produttori diretti non ha alcun motivo per ribellarsi, visto che il livello delle loro entrate è più che soddisfacente. In questo modo, le rivoluzioni civili sconfitte non sono in grado di prevenire il processo di totalitarizzazione di una società - concentrazione della disposizione della proprietà e del potere nelle mani di una sola classe sociale. Le rivoluzioni civili vittoriose - sotto il meccanismo della competizione politica il quale genera la crescita del potere di regolamentazione - accelerano solo la futura totalitarizzazione di questo sistema sociale.
268
In t e r p r e t a z i o n e s t o r i c a d e i m o d e l l i n e l
m a t e r i a l i s m o s t o r i c o n o n -m a r x i a n o
I modelli che abbiamo appena delineato forniscono un’interpretazione della storia delle società appartenente alla linea di sviluppo europea che va dall’antichità alla storia moderna.La controparte della nascita dell’alienazione del lavoro e della diffusione della formazione dello stato di schiavitù è costituita dalla schiavitù patriarcale, la quale trasformò se stessa in un tipo classico di schiavitù. In quel periodo, le forme istituzionali di controllo del potere attraverso la proprietà erano gli antichi sistemi democratici. La crescita dello sfruttamento schiavistico causò una serie di rivoluzioni. Essere furono abbattute dalle autorità politiche ma la lotta incessante degli schiavi attuò l ’evoluzione dei rapporti di proprietà. Nel quadro della formazione della schiavitù emerse l’istituzione dei coloni (colonatus) - prototipo dei rapporti di proprietà feudali. I proprietari di grandi terreni sistemarono le persone libere come affittuari (colonus) delle loro terre arabili. Dopo il pagamento dell’affitto, i coloni avrebbero potuto tenere il resto delle entrate per se stessi. Nel periodo del tardo-impero prese posto la crescente burocratizzazione della vita sociale. La parte occidentale dell’Impero romano collassò sotto l’attacco delle tribù barbare - il fattore che abbiamo trascurato nel modello - mentre la sua parte orientale resistette sino al 1453.
Un ciclo di sviluppo simile si verificò nella formazione feudale. La controparte della nascita dell’alienazione del lavoro e della diffusione dello stato era il periodo del primo feudalesimo. Inizialmente, la classe feudale soggiogò i contadini e il signore feudale era il legittimo proprietario della terra utilizzata dai contadini, ragion per cui quest’ultimo avanzava nei loro confronti pretese personali e giuridiche. Il progresso tecnologico presente tra X e XI secolo generò la nascita dell’economia urbana. Le migliori condizioni lavorative in questo nuovo settore dell’economia spinse i cittadini a migrare nelle città, con lo scopo di migliorare le proprie condizioni
KrzysztofBrzechczyn
269
Concetti base del materialismo storico non-marxiano: prospettive e futuro
di vita. Tuttavia, il meccanismo dello sfruttamento presente nei settori dell’economia stimolò lo sfruttamento crescente della plebe e dei contadini. Dal XIV al XVI secolo disordini plebei e contadini si verificarono nell’Europa occidentale. Queste proteste imposero alcuni mutamenti ai rapporti di proprietà, i quali favorirono l ’apparizione dei diritti di proprietà nel sistema capitalistico.
La fioritura dell’economia urbana provocò la divisione della classe omogenea dei proprietari in due sotto-classi: l’aristocrazia terriera e artigiani e mercanti (cioè la futura borghesia). Questa divisione consentì alle autorità politiche di emanciparsi dall’influenza di queste due sotto-classi dei proprietari. La forma istituzionale di questi processi era costituita dallo stato assolutista. La crescente burocratizzazione della vita sociale causò una serie di rivoluzioni civili che rovesciarono il potere dello stato in Olanda, Gran Bretagna e Francia.
La tendenza presente nello sviluppo delle società occidentali - dalla schiavitù attraverso il feudalesimo ed il capitalismo - era la crescente liberazione del lavoro. Infatti, un servo era più libero di uno schiavo, ed un lavoratore in regime capitalista è più libero di un servo; ma questo processo si arrestò proprio con il capitalismo. La forma istituzionale del dominio della proprietà sulle autorità statali presente in questo sistema era la cosiddetta democrazia borghese, la quale riduceva la sfera del potere di regolamentazione alla funzione di un “portiere notturno”. Ad ogni modo, lo sfruttamento crescente dei lavoratori portò ad una serie di proteste: il movimento cartista in Gran Bretagna, la primavera dei popoli presente in tutta l ’Europa tra il 1848-1849, la comune di Parigi del 1870, ecc. Grazie al costante progresso tecnologico, i capitalisti furono tra i primi proprietari a “corrompere” i loro stessi lavoratori grazie all’incremento del capitale variabile e a risolvere il problema della realizzazione del plus-prodotto poiché i lavoratori più ricchi creavano la domanda per i prodotti. Venne anche risolto il problema della sovrapproduzione, sia attraverso il crescente intervento statale sia attraverso contratti governativi.
270
KrzysztofBrzechczyn
La funzione economica del nuovo stato crebbe dopo la grande crisi degli anni ’30. La forma istituzionale della crescita della statizzazione della vita sociale era caratterizzata, nell’Europa occidentale, dalla costruzione del welfare state. I gruppi sociali che ricevevano sovvenzioni statali dipendevano sempre più dalla burocrazia di stato. Le proteste contro la nascita delle regolamentazioni statali venivano guidate da gruppi marginali della classe dei cittadini. In questo senso si potrebbero interpretare le rivolte studentesche della primavera del ’68 o i movimenti pacifisti degli anni ’70. L’accumulazione della proprietà e del potere venne bloccata dall’ondata neoliberista degli anni ’80. Tuttavia, tale tendenza - secondo le assunzioni del materialismo storico non-marxiano - non fermò il processo di accumulazione di proprietà e potere, al cui interno era proprio la burocrazia statale, piuttosto che i proprietari reali, a prendere le decisioni in materia di economia.
La caratteristica essenziale delle società occidentali era la separazione e l’equilibrio fra tre classi sociali: governanti, proprietari e preti i quali, a loro volta, controllavano la politica, l’economia e la cultura. Questo equilibrio venne scosso dalla storia della Russia, laddove lo stato divenne il più grande proprietario terriero. Esso generò due tentativi di totali- tarizzazione della società: il primo avvenne durante il regno di Ivan Il Terribile, laddove i pomeshchiki - ossia la doppia classe dei governanti-proprietari - erano in competizione con l ’aristocrazia russa - la singola classe dei proprietari, mentre il secondo tentativo si verificò durante il regno di Pietro Il Grande. In questo caso le autorità cercarono di dar vita a delle attività manifatturiere creando in tal fatta la classe dei mercanti. Tale anomalia totalitaria causò un feudalesimo statale che, privo dello stadio della libera competizione, finì col trasformare se stesso in un capitalismo di stato, laddove il livello della regolamentazione statale alla fine del XIX secolo era uguale a quello presente nelle società europee occidentali.
Lo sviluppo della società sovietica dopo il 1917 lo si può interpretare sulla base del modello della società puramente
271
Concetti base del materialismo storico non-marxiano: prospettive e futuro
politica. Il rovesciamento del regime zarista nel febbraio del 1917 non era altro che una rivoluzione civile la quale condusse ad una crescita post-rivoluzionaria del potere di regolamentazione. Il governo provvisorio cercò di regolare la vita sociale concentrando nelle sue mani sempre più potere. Ciò, comunque sia, scatenò i malesseri sociali, culminati poi con la rivoluzione d ’ottobre comandata dai bolscevichi e diretta contro il governo provvisorio. Molto presto, comunque, i bolscevichi cominciarono ad acquisire sempre più potere. Difatti, la nazionalizzazione delle banche, l ’introduzione della “guerra comunista” o la formazione della polizia segreta, ecc., sono una conferma di tutto questo. Ciò generò una nuova ondata di malesseri sociali, caratterizzati dall’opposizione esercitata dai contadini. Infine i disturbi sociali si spostarono verso le città: i marinai ed i contadini di Kronstadt - i più vicini sostenitori dei bolscevichi - si ribellarono contro di essi. La pacificazione di questi malesseri diretti contro la nuova classe di governanti post-rivoluzionaria condusse, verso la fine degli anni ’20, all’imposizione totale del controllo politico sul popolo. Il periodo stalinista (dal 1929 al 1953), lo si può percepire come una fase di schiavitù. Le purghe staliniane, durante gli anni ’30, erano la controparte di una sotto-fase di auto-schiavitù del potere. I prigionieri dei gulag, i quali trasformarono se stessi da individui atomizzati a masse autoorganizzate, diedero vita ad una serie di rivolte carcerarie. La prima rivolta scoppiò nel campo di lavoro vicino Vorkuta. La prima metà del 1953 registrò un altissimo numero di sommosse nei gulag, le quali ebbero come risultato una certa liberalizzazione dell’oppressivo sistema politico manifestato, tra le altre cose, dalla condanna da parte di Khrushchev del culto di Stalin in occasione del XX congresso del Partito Comunista. Questi eventi possono essere interpretati come una transizione dell’intero sistema alla fase delle rivoluzioni cicliche del secondo tipo. Le ricorrenti rivoluzioni civili includono: gli scioperi dei lavoratori di Novocherkassk e delle quattordici città della Russia centrale nel corso degli anni ’60, i rigurgi
272
KrzysztofBrzechczyn
ti nazionalistici dei paesi baltici negli anni ’70 e gli scioperi all’inizio degli anni ’80. Essi portarono, da un lato a misure repressive verso i cittadini ribelli ma, dall’altro lato, forzò gli alti vertici del Partito Comunista a fare delle concessioni politiche in modo da evitare lo scoppio di altre rivoluzioni. Le riforme di Gorbachev costituirono il più serio tentativo di evitare rivoluzioni sociali simili al movimento di Solidarnosc in Polonia. Comunque, questa politica riformista, sebbene accrebbe l ’autonomia sociale delle persone, stimolò, nei fatti, la rivitalizzazione dei legami sociali e portò ad una crescita dei disordini civili, provocando il declino del triplice governante.
Questo modello di società politica è stato applicato anche alla storia post-bellica della Polonia. Il sistema della triplice classe della prima metà degli anni ’40 venne imposto dall’Unione Sovietica alla Polonia attraverso la nazionalizzazione delle industrie principali, l ’introduzione del monopolio spirituale del marxismo, l ’abolizione delle libertà individuali come anche attraverso il terrore e la soppressione delle voci dissidenti. Il periodo stalinista (1948-1956), durante il quale il potere del partito comunista nella società polacca raggiunse il suo apice, lo possiamo interpretare come una fase dello schiavismo. L’apparato politico controllava l ’intera vita politica così come l ’economia e la cultura.
Dopo la rivolta di Poznan nel giugno del 1956, il sistema della triplice classe entrò in una fase di rivoluzioni cicliche del secondo tipo; pertanto il partito comunista si vide costretto a riconoscere sia l ’esistenza di aziende agricole private come anche l ’influenza spirituale della Chiesa cattolica. Dopo le rivolte a Szczecin, Gdansk, e Gdynia nel dicembre del 1970, le autorità riconobbero le aspirazioni economiche della società: il programma di costruzione della “Seconda Polonia” (secondo la definizione della propaganda ufficiale) era. in un certo senso, un opaco tentativo di soddisfare i bisogni economici della società polacca. Dopo le proteste di Radum e Ursus nel giugno del 1976, le autorità comuniste riconobbero l ’attività dell’opposizione politica in Polonia. I fonda
273
Concetti base del materialismo storico non-marxiano: prospettive e futuro
menti di questo sistema, tuttavia, vennero scalzati dal grande movimento di Solidarnosc del 1980. La circolazione di massa dell’informazione cominciò a diventare indipendente dal controllo delle autorità, la vita politica indipendente cominciò a prendere forma ed inoltre vennero attuati alcuni tentativi di liberalizzazione dell’economia. Il processo di costituzione di una società democratica venne rallentato dall’imposizione della Legge marziale nel 1981. Otto anni più tardi (1989), gli Accordi della Tavola Rotonda (che si tennero a Varsavia dal 6 febbraio al 4 aprile del 1989), preceduti da due ondate di scioperi nel maggio e nell’agosto del 1988, iniziarono, grazie alle imposizioni delle forze sociali indipendenti, a trasformare il sistema, il quale era più profondo di tutte le altre precedenti concessioni fatte dalle autorità comuniste.
274
Il m a t e r i a l i s m o s t o r i c o n o n -m a r x i a n o c o m e
PROGRAMMA DI RICERCA
I modelli che abbiamo presentato forniscono un’interpretazione teoretica della storia delle società di classe nel corso degli ultimi 2.500 anni (dall’antica Grecia e Roma al moderno sistema capitalista occidentale e al sistema del socialismo reale dell’Europa orientale). Comunque sia, uno dei più importanti svantaggi del materialismo storico non-marxiano consiste nel trascurare le differenze evolutive presenti società europee13 e lo sviluppo delle società non-europee14. La filosofia della storia, tradizionalmente, tende a dividere le società del mondo come appartenenti o alla linea di sviluppo occidentale o a quella orientale. Possiamo parafrasare tale divisione sulla base dell’apparato nozionistico del materialismo storico non-marxiano. Vale a dire, la principale caratteristica delle società appartenenti alla linea di sviluppo occidentale (civiltà europea) era la separazione delle divisioni di classe.
KrzysztofBrzechczyn
13 Su questi aspetti cfr. K. Br z e c h c z y n , Odrgbnosc historyczna Euro- py Srodkowej. Studium metodologiczne, Humaniora, Poznan, 2004; Id ., L ’effetto a cascata nel processo storico. Un tentativo di chiarire le peculiarità di sviluppo dell’Europa centrale, in F. Co n i g l i o n e -R. Po l i (eds.), La Realtà modellata. L ’approccio idealizzazionale e le sue applicazioni nelle scienze umane, Franco Angeli, Milano, 2004, pp. 179-239 e Id ., The Distinctiveness o f Central Europe in Light o f the Cascadeness o f the Historical Process, in Id . (ed.), Idealization XIII: Modeling in History (Poznan Studies in the Philosophy o f the Sciences and the Humanities, vol. 97), Rodopi, Amsterdam-New York, 2009, pp. 231-269.
14 Cfr. L. No w a k -K. Pa p r z y c k a , On the Social Nature o f Colonization, in L. N o w a k (ed.), Dimensions o f the Historical Process (Poznan Studies in the Philosophy o f the Sciences and the Humanities, vol. 13), Rodopi, Amsterdam, 1989, pp. 299-312 e K. Br z e c h c z y n , O wielosci linii roz- wojowych w procesie historycznym. Pròba interpretacji ewolucji spole- czenstwa meksykanskiego, UAM Press, Poznan, 2004.
275
Concetti base del materialismo storico non-marxiano: prospettive e futuro
La sua fusione, se mai è avvenuta, sui fondamenti della civiltà europea si è dimostrata instabile15. Le società appartenenti alla linea di sviluppo orientale sono invece caratterizzate dalla categoria della cumulazione della divisione di classe (la fusione di proprietà e potere è una caratteristica fondamentale del modo di produzione asiatico o dei sistemi dispotici orientali16). Tuttavia, vorrei precisare che tale divisione, al fine di comprendere la diversità evolutiva delle società noneuropee, si dimostra fin troppo approssimativa. Sebbene la cumulazione delle divisioni di classe fosse una caratteristica stabile delle società non-europee, tuttavia tale cumulazione assunse configurazioni differenti e i diversi tipi di interesse sociale vennero massimizzati dalla classe dominante. Al fine di spiegare più precisamente la diversità evolutiva delle civiltà non-europee, è necessario costruire, nel materialismo storico non-marxiano, una tipologia completa delle società ed impostare in maniera più chiara i suoi criteri. La tipologia che proporrò si basa sui seguenti criteri:
1. quale tipo di interesse domina in una data società;2. qual è il livello di cumulazione delle divisioni di
classe, ovvero se la classe dominante è una singola, duplice o triplice classe;
3. qual è la relazione tra le classi dominate ed i potentati sociali.
Introduciamo tali criteri dettagliatamente. Nel caso delle società classiste (a tre momenti) e di quelle sopra-classiste (ad uno e a due momenti), l’applicazione del criterio (1) conduce alla classe dominante caratterizzata da coloro che dispongono dei mezzi materiali della società. Tale classe può essere
15 Cfr. K. B r z e c h c z y n , The State o f Teutonic order as a Socialist Society, in L. No w a k -M. Pa p r z y c k i (eds.), Social System, Rationality and Revolution (Poznan Studies in the Philosophy o f the Sciences and the Humanities, vol. 33), Rodopi, Amsterdam, 1993, pp. 397-417.16 Cfr. K. A. W i t t f o g e l , Oriental Despotism: a Comparative Study o f To
tal Power, University Press Yale, 1957.
276
KrzysztofBrzechczyn
quella dei governanti (che mirano a massimizzare il potere di regolamentazione), quella dei proprietari (che tendono a massimizzare il profitto) oppure quella dei preti (che tendono a massimizzare la dominazione spirituale). Nel caso delle società all’interno delle quali una sola classe dominante controlla i mezzi di coercizione, di produzione e di indottrinamento, allora tale criterio ci porta all’interesse di classe prioritario per questa stessa classe.
Il dominio di una società A sulla classe B significa che in caso di conflitto, a lungo andare, l’interesse della classe A verrà massimizzato. Una classe sociale che domina in questo modo sul resto della società, si chiama la classe principale.
La priorità dell’interesse di classe del tipo A sull’interesse di classe del tipo B significa che, nella situazione in cui la massimizzazione dell’interesse di B esclude la massimizzazione dell’interesse di A, a lungo andare l ’interesse di A viene massimizzato. In altre parole, l’interesse di classe B viene subordinato strumentalmente alla massimizzazione dell’interesse di A . A seconda del tipo di interesse (massimizzazione del potere, del profitto o della dominazione spirituale) è possibile distinguere una linea di sviluppo in politica, economica o gerarchica.
Veniamo adesso al criterio (2) della nostra tipologia. Una stessa classe può controllare i mezzi materiali della società o ad un duplice livello (mezzi di produzione e mezzi di coercizione) o ad un triplice livello (mezzi di produzione, mezzi di coercizione e mezzi di indottrinamento). A tal proposito possiamo distinguere le classi nel modo seguente: singola classe (ad esempio i governanti), duplice classe (ad esempio i proprietari-governanti) e triplice classe (i proprietari-governanti- preti). Sulla base del livello di accumulazione delle divisioni di classe, è possibile distinguere le varianti presenti all’interno di ogni singola linea di sviluppo: variante ad uno, due o tre momenti. Ad esempio, la linea di sviluppo di tipo politico la possiamo interpretare come una variante a tre momenti (la classe dei governanti è una singola classe), a due momenti (la
277
Concetti base del materialismo storico non-marxiano: prospettive e futuro
classe dei governanti si impossessa dei mezzi di produzione0 di comunicazione di massa) o ad un momento (la classe dei governanti si impossessa dei mezzi di produzione e dei mezzi comunicazione di massa).
L’applicazione del criterio (3), in riferimento alle classi sociali, determina la caratterizzazione del rapporto tra classi sociali subordinate rispetto alla classe principale; in riferimento ad una classe ad un momento, esso determina la caratterizzazione dei rapporti tra interessi di classe realizzati dalla triplice classe; in riferimento alla classe a due momenti, determina invece il rapporto tra la massimizzazione dell’interesse di classe della società a due momenti e la massimizzazione dell’interesse di classe della società ad un momento. Nel caso delle società classiste, il dominio della classe B sulla classe C significa che in caso di conflitto, a lungo andare, l ’interesse di B verrà massimizzato. Comunque sia, la classe principale di questa società continua a subordinare entrambe queste classi. Nelle società ad un momento, l’interesse di B sull’interesse di C significa che in caso di conflitto, a lungo andare, l ’interesse di B verrà massimizzato. In altre parole, l ’interesse di classe di C è strumentalmente subordinato alla massimizzazione dell’interesse di classe di B - ed allo stesso tempo, sia B che C sono strumentalmente subordinati all’interesse della triplice classe. Nel caso di società a due momenti, la priorità dell’interesse della classe a due momenti sugli interessi sociali della classe ad un momento, significa che in caso di conflitto, a lungo andare, la prospettiva dell’interesse della classe a due momenti viene massimizzato. A seconda del rapporto esistente tra le classi subordinate (o interessi di classe), è possibile distinguere diverse versioni (politica, gerarchica ed economica) di ogni singola variante presente all’interno di ogni tipo di linea di sviluppo. Ad esempio, la versione gerarchica a tre momenti caratterizza il rapporto tra le classi subordinate di governanti e proprietari. Nel caso della versione politica.1 governanti dominano i proprietari, laddove nella versione economica sono questi ultimi a dominare i governanti. Vale
278
KrzysztofBrzechczyn
la pena ricordare che entrambe queste classi sono subordinate alla classe dei preti.
Per riassumere, a seconda dell’interesse di classe, sia esso la massimizzazione della regolamentazione del potere, il plusvalore o la dominazione spirituale, possiamo distinguere le varie tipologie di linee di sviluppo in politica, economica e gerarchica. A seconda del livello di accumulazione delle divisioni di classe, ogni tipo di linea di sviluppo può manifestarsi sulla base di queste tre varianti: ad un momento, a due momenti o a tre momenti. A seconda, invece, dei rapporti tra gli interessi di classe (o classi subordinate), possiamo distinguere diverse versioni (politica, gerarchica ed economica) di ogni singola variante presente all’interno di ogni tipo di linea di sviluppo. Incrociando questi criteri, è possibile distinguere 18 tipi di società, ciascuna delle quali inizia sempre con linee separate di sviluppo17:
1. Tipo gerarchico 2. Tipo economico1.1 Variante a tre momenti1.1.1. Società gerarchica
a tre momenti di tipo politico (preti + governanti + proprietari)
1.1.2. Società gerarchica a tre momenti di tipo economico (preti + proprietari + governan
t i )
2.1 Variante a tre momenti2.1.1. Società economica a tre mo
menti di tipo politico (proprietari + governanti + preti)
2.1.2. Società economica a tre momenti di tipo gerarchico (proprietari + preti + governanti)
17 Cfr. K. Br z e c h c z y n , On the Application o f non-Marxian Historical Materialism to Development o f non-European Societies, in J. Br z e z i n s k i -A. K l a w i t e r -T.A.F. Ku i p e r s -K. La s t o w s k i -K. Pa p r z y c k a - P. Pr z y b y s z (eds.), The Courage o f Doing Philosophy: Essays Dedi- cated to Leszek Nowak, Rodopi, Amsterdam-New York, 2007, pp. 235254.
279
Concetti base del materialismo storico non-marxiano: prospettive e futuro
1.2 Variante a due momenti
1.2.1. Società gerarchica a due momenti di tipo politico(preti-governanti + proprietari)
1.2.2. Società gerarchica adue momenti di tipo economico(preti-proprietari + governanti)
2.2 Variante a due momenti2.2.1. Società economica a due
momenti di tipo politico (proprietarigovernanti + preti).
2.2.2. Società economica a due momenti di tipo gerarchico (proprietari- preti + governanti)
1.3 Variante ad un momento
1.3.1. Società gerarchica ad un momento di tipo politico(preti-governanti-proprietari)
1.3.2. Società gerarchica adun momento di tipo economico(preti-proprietari-governanti)
2.3 Variante ad un momento2.3.1. Società economica ad un mo
mento di tipo gerarchico (proprietari- preti-governanti)
2.3.2. Società economica ad un momento di tipo politico (proprietari- governanti-preti)
3. 'lino politico3.1 Variante a tre momenti3.1.1. Società politica a tre momen
ti di tipo economico (governanti + proprietari + preti)
3.1.2. Società politica a tre momenti di tipo gerarchico (governanti + preti +proprietari) . — ------------------------- ------------------
3.2 Variante a due momenti3.2.1. Società politica a due mo
menti di tipo economico (governanti- proprietari + preti)
3.2.2. Società politica a due momenti di tipo gerarchico (governanti-preti + governanti) ________________
3.3 Variante ad un momento3.3.1. Società politica ad un mo
mento di tipo economico (governanti- proprietari-preti)
3.3.2. Società politica ad un momento di tipo gerarchico (governanti- preti- proprietari)___________________
280
KrzysztofBrzechczyn
Fig. n. 1. Tipologia delle società nel materialismo storico nonmarxiano, - cumulazione delle divisioni di classe, + separazione delle divisioni di classe.
Ovviamente, la diversità evolutiva delle civiltà non-euro- pee la si può interpretare con l ’ausilio delle tipologie presenti nella figura 1. Descriviamole brevemente. Le società che appartengono a differenti tipi di linee evolutive o di sviluppo, si evolvono secondo diversi meccanismi. Pertanto, le società che appartengono alla linea di sviluppo di tipo politico si evolvono secondo le regolarità del momento politico, mentre quelle di tipo economico secondo le regolarità del momento economico. Le società che appartengono invece al tipo gerarchico si evolvono secondo le regolarità del momento spirituale della società. Tali regolarità mutano essenzialmente all’interno di ogni singola variante della società. Nelle società ad un momento, una data classe di potentati sociali dispone anche di altri mezzi materiali utili per massimizzare l ’interesse principale di tale classe. In tale tipo di società, la tendenza principale dello sviluppo sociale è costituita dal meccanismo della resistenza civile. Le cose vanno diversamente nelle società a due momenti. L’esistenza di singole classi di potentati sociali fa sorgere una nuova tendenza sociale all’interno dello sviluppo sociale - il meccanismo della competizione sopraclassista e l ’alleanza sopra-classista. Tale tendenza diventa sempre più importante nelle società a tre momenti. In un tale sistema sociale, la barriera principale alla massimizzazione dell’interesse di classe da parte della classe dominante non è costituito solamente dalla resistenza civile, ma anche dalle obiezioni delle altre classi di potentati. In alcune fasi di sviluppo di tali tipi di società, la competizione sopra-classista e l ’alleanza sopra-classista diventano il meccanismo di sviluppo principale.
La tipologia delle linee di sviluppo che abbiamo delineato più sopra, funge da “mappa” nel cosiddetto materialismo storico non-marxiano, la cui teoria è costituita dalla seguente serie di modelli:
281
Concetti base del materialismo storico non-marxiano: prospettive e futuro
• la società puramente gerarchica, la quale costituisce il punto di partenza nella costruzione della teoria delle società che appartengono alla linea di sviluppo di tipo gerarchico;
• la società puramente economica e le sue ulteriori concretizzazioni, la quale costituisce il punto di partenza nella costruzione della teoria delle società che appartengono alla linea di sviluppo di tipo economico;
• la società puramente politica e le sue ulteriori concretizzazioni, la quale costituisce il punto di partenza nella costruzione della teoria delle società che appartengono alla linea di sviluppo di tipo politico;
• la società a tre momenti di tipo economico (2.1.1.) trasformata in società a tre momenti di tipo politico (3.1.1.). Tuttavia, tale modello non è completo poiché al suo interno viene trascurata l’influenza della classe dei preti.
Il materialismo storico non-marxiano risulta ancora sprovvisto:
• di una completa teoria delle società ad un momento di tipo gerarchico (1.3.1.; 1.3.2.), economico (2.3.1.; 2.3.2.), e politico (3.3.1.; 3.3.2.)18;
• di una completa teoria della società a due momenti di tipo gerarchico (1.2.1; 1.2.2.), economico (2.2.1; 2.2.2) e politico (3.2.1. 3.2.2);
18 Il controllo dell’economia da parte dei governanti presente nella teoria di quest’ultimo tipo di società è stato analizzato in L. No w a k , Power and Civil Society, cit. e A. Si e g e l , Entdifferenzierung, Desintegration, Re-differenzierung. Zur Modellierung des politisch-okonomischen Krisenzyklus in der Volksrepublik Polen, in K. S. Re h b e r g (ed.), Dif- ferenz und Integration. Die Zukunft moderner Gesellschaften, West- deutscher, Wiesbaden, 1997, pp. 363-69.
282
KrzysztofBrzechczyn
• di una completa teoria delle società a tre momenti di tipo gerarchico nella versione politica (1.1.1) ed economica (1.1.2), e di una teoria a tre momenti di tipo economico nella sua variante gerarchica (2.1.2) e politica (3.1.2);
• di una completa teoria delle società a tre momenti di tipo economico nella sua variante politica (2.1.1.) e di una società politica a tre momenti nella sua variante economica (3.1.1).
In breve, possiamo utilizzare tali gap presenti nelle linee di sviluppo dei modelli del materialismo storico non-marxia- no per impostare un vero e proprio programma di ricerca, ed in questo senso ancora molto deve essere fatto. Una volta riempiti questi gap sarà possibile trasformare il materialismo storico non-marxiano in una teoria del processo storico estendibile anche al campo cronologico e geografico, paragonabile alla storiografia di Arnold Toynbee19 o a quella, tanto per rimanere sul fronte polacco, di Feliks Koneczny20.
19 A. To y n b e e , A Study o f History, Vol. I-II (Abridgement of Vol. IX by D.C. Somervell), Oxford University Press, New York-London, 19471957.
20 F. Ko n e c z n y , On the Plurality o f Civilizations, Polonica Publications London, 1962.
283
Concetti base del materialismo storico non-marxiano: prospettive e futuro
Bi b l i o g r a f i a
K. Br z e c h c z y n , L ’effetto a cascata nel processo storico. Un tentativo di chiarire le peculiarità di sviluppo d e ll’Europa centrale, in F. Co n i g l i o n e -R. Po l i (eds.), La Realtà modellata. L ’approccio idealizzazionale e le sue applicazioni nelle scienze umane, Franco Angeli, Milano, 2004, pp. 179-239. Id ., Odrqbnosc historyczna Europy Srodkowej. Studium meto- dologiczne, Humaniora, Poznan, 2004.Id ., O wielosci linii rozwojowych w procesie historycznym. Pròba interpretacji ewolucji spoieczenstwa meksykanskiego, UAM Press, Poznan, 2004.Id , On the Application o f non-Marxian Historical Mate- rialism to Development o f non-European Societies, in J. Br z e z i n s k i -A. Kl a w i t e r -T.A.F. Ku i p e r s -K. F a s t o w s k i -K. Pa p r z y c k a -P. Pr z y b y s z (eds.), The Courage o f Doing Phi- losophy: Essays Dedicated to Leszek Nowak, Rodopi, Am- sterdam-New York, 2007, pp. 235-254.Id ., The Distinctiveness o f Central Europe in Light o f the Cas- cadeness o f the Historical Process, in Id . (ed.), Idealization XIII: Modeling in History (Poznan Studies in the Philosophy o f the Sciences and the Humanities, vol. 97), Rodopi, Amster- dam-New York, 2009, pp. 231-269.Id ., The State o f Teutonic order as a Socialist Society, in L. N o w a k -M. Pa p r z y c k i (eds.), Social System, Rationality and Revolution (Poznan Studies in the Philosophy o f the Sciences and the Humanities, vol. 33), Rodopi, Amsterdam, 1993, pp. 397-417.P. Bu c z k o w s k i-A. Kl a w it e r -L. N o w a k , Religia jako struttura klasowa. Przyczynek do nie-Marksowskiego materializmu historycznego, in «Studia Religiologia», vol. 20, 1987, pp. 79-128.F. Ko n e c z n y , On the Plurality o f Civilizations, Polonica Pub-
284
KrzysztofBrzechczyn
Westdeutscher, Wiesbaden, 1997, pp. 363-69.A. To y n b e e , A Study o f History, Vol. I-II (Abridgement of Vol. IX by D.C. Somervell), Oxford University Press, New York-London, 1947-1957.K. A. w i t t f o g e l , Oriental Despotism: a Comparative Study o f Total Power, University Press Yale, 1957.
285