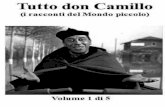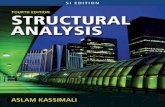Niente si crea, niente si distrugge, tutto si ricicla, in Sara Marini e Vincenza Santangelo (a cura...
Transcript of Niente si crea, niente si distrugge, tutto si ricicla, in Sara Marini e Vincenza Santangelo (a cura...
2/208
Università Iuav di Venezia - Dipartimento di Culture del ProgettoQuaderni della ricerca
Copyright ©MMXIVARACNE editrice S.r.l.
via Raffaele Garofalo, 133/A-B00173 Roma[06]93781065
ISBN 978-88-548-7176-2
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasimezzo, sono riservati per tutti i Paesi.
Non sono consentite le fotocopiesenza il permesso scritto dell’Editore.
Progetto grafico di Luciano Comacchio - MeLa Media LabI edizione: giugno 2014
2/208
Università Iuav di Venezia - Dipartimento di Culture del ProgettoQuaderni della ricerca
Copyright ©MMXIVARACNE editrice S.r.l.
via Raffaele Garofalo, 133/A-B00173 Roma[06]93781065
ISBN 978-88-548-7176-2
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasimezzo, sono riservati per tutti i Paesi.
Non sono consentite le fotocopiesenza il permesso scritto dell’Editore.
Progetto grafico di Luciano Comacchio - MeLa Media LabI edizione: giugno 2014
3/208
Ricicli. Teorie da concettinomadi e di ritornoA cura diSara Marini e Vincenza Santangelo
Unità di ricercaRe-cycle. Strategie di riciclaggio per l’architettura e la città
Indice
DECLARATORIA
Rileggendo e riflettendoValerio Paolo Mosco
TEORIE DA CONCETTI NOMADI E DI RITORNO
Riciclare il capital-nichilismo? Frammento realisticoNicola Emery
Cicli e ri-cicli dei territori contemporaneiRenato Bocchi
Niente si crea, niente si distrugge, tutto si riciclaGiovanni Corbellini
Altre VenezieSara Marini
NELLA CITTà E NEL TERRITORIO
Architettura e città: un principio di solidarietàMaria Isabel Villac
Fabrica de Creación Fabra i CoatsManuel Ruisánchez
Comunicare il re-cycleEnrico Fontanari
1 kilometro senza confiniMarina Caneve
Tetris metropolitanoAldo Aymonino
Avamposti metropolitani. Forte MargheraAntonella Gallo
8
16
24
32
40
66
78
88
92
108
172
5/208
33/208
Riciclo è un termine ambiguamente sospeso fra la promessa (o minaccia...) di eterno ritorno e l’aspirazione a nuovi inizi. Come tale, la sua recente importazione all’interno del dibattito architettonico ha determinato un ventaglio di posizioni estremamente variegato a seconda dei campi di applicazione, delle inclinazioni ideologiche, delle problematiche coinvolte. Una varietà che emerge anche dalle riflessioni che hanno accompagnato le prime fasi della ricerca nazionale Re-cycle Italy 1. Pippo Ciorra, curatore della mostra del MAXXI2 ispiratrice di questo programma di ricerca, riconosce il carattere inclusivo del riciclo, la sua capacità di applicazione alle diverse scale e di proporsi come possibile ponte «tra due lati opposti del pensiero architettonico, quello progressivo/progressista e concettuale e quello pragmatico (ecologico)»3. I programmi di ricerca proposti e le dichiarazioni di intenti che li sostengono fanno prevalere in buona parte questo secondo approccio, «più responsabile, di impegno sociale e civile»4, senza apparentemente mettere in discussione metodologie disciplinari consolidate: con il rischio di riproporre modalità operative che, se non sono state complici nel determinare la situazione che vorrebbero fronteggiare, poco sono riuscite a influirvi in maniera significativa.Personalmente credo che inquadrare il progetto architettonico attraverso la prospettiva del riciclo comporti un radicale ripensamento di procedure e strumenti5. Non avrebbe altrimenti senso inventarsi un nuovo termine per ridefinire abituali pratiche re/ri-progettuali, come il riuso, il restauro, la ristrutturazione, la riqualificazione. Né sarebbe un gran passo avanti limitarsi a sottolineare nuovamente la partecipazione a una ormai quarantennale condizione postmoderna di superamento della tabula rasa e di confronto serrato con l’esistente, sia pure aggiornata a una idea di sostenibilità complessiva... Perché il riciclo è molto diverso dalla ripetizione, è un processo fondamentalmente basato sullo scarto, sia nel senso di giu-dizio, selezione, rifiuto che in quello di deviazione dello sguardo, repentino spostamento di prospettiva. L’interpretazione della realtà si lega qui alla organizzazione critica dei dispositi-vi concettuali e operativi chiamati a trasformarla. Diventa quindi strategico interrogarsi sui “trattamenti” che, in analogia con i processi industriali dai quali abbiamo preso in prestito
1. Questioni introduttive, programmi nazionali e locali, singoli argomenti di ricerca e questioni teoriche sono raccolti in tre volumi, Nuovi cicli di vita per architetture e infrastrutture della città e del paesaggio; Viaggio in Italia; Recycland. Tutti a cura di S. Marini e V. Santangelo, editi da Aracne, Roma 2013.2. Re-cycle. Strategie per l’architettura, la città e il pianeta, a cura di P. Ciorra con S. Marini, M. Ricci e P. Viganò, MAXXI, Roma, 01.12.2011-20.05.2012.3. P. Ciorra, Afterwor[l]d, in Nuovi cicli di vita per architetture e infrastrutture della città e del paesaggio, cit., p. 80.4. A. Rocca, recensione ai volumi citati alla nota 1, in «Op. cit.», n. 149, 2014, pp. 72-77.5. Vedi G. Corbellini, Progettare l’amnesia, in Recycland, cit.
34/208
il concetto di riciclo, rendono utilizzabili gli oggetti scartati, materiali o immateriali, per il loro reinserimento nel processo produttivo. E questo riguarda sia le condizioni generali nelle quali l’azione di progetto è chiamata a operare che le questioni più interne alla disciplina, i suoi strumenti e le sue teorie.Cosa scartiamo nei contesti di trasformazione? Come ne selezioniamo i materiali fisici e soprattutto concettuali da reimpiegare? Quali “lavorazioni” utilizziamo nel portarli a uno stato più generico, disponibile a operazioni progettuali a largo raggio? Questo processo di “raccolta differenziata” ed “estrazione di materie prime” pone l’architettura di fronte a una profonda revisione del suo rapporto con la memoria, almeno per come si è consolidato negli ultimi cinque secoli. L’architetto moderno, figlio disciplinare della rivoluzione umanistica, è intrinsecamente portato a valutare i contesti di intervento in termini specificamente architettonici, riconoscendo la qualità delle singole parti e, soprattutto, la coerenza delle relazioni tra loro in termini di unità compositiva, di finitio albertiana. Di conseguenza, la trasformazione procede attraverso decisioni basate su giudizi di valore storico-estetici che portano, alle diverse scale, a decisioni tendenzialmente polarizzate tra conservazione e demolizione, museificazione e tabula rasa. Un atteggiamento esemplificato dal Plan Voisin di Le Corbusier che, nel radere al suolo la gran parte del centro di Parigi per poter realizzare le sue torri “cartesiane”, lasciava testimonianze dei monumenti passati (il Louvre, Place Vendôme...) e presente anche nei diffusi interventi in cui si tengono su facciate più o meno antiche a garantire continuità ai tessuti urbani, mentre si rifanno dalle fondamenta gli interni. Il riciclo architettonico coinvolge viceversa una maggiore ambiguità, si situa nella scala di grigi tra memoria e amnesia, guarda avanti liberamente a quello che si può fare con i materiali a disposizione, qui e ora, pur nutrendosi del valore di riconoscibilità degli stessi. Così, più grande e inaspettato il distacco dalla condizione precedente e maggiore l’efficacia dell’operazione. Ma, allo stesso tempo, maggiormente identificabile la vita passata di oggetti e spazi scartati e più radicale l’adesione, in termini fattuali e di rappresentazione, a una procedura di riciclo.Altrove ho paragonato questa condizione dello sguardo e gli esiti che ne possono scaturire a una sorta di medioevo di ritorno6. Il palazzo di Diocleziano di Spalato, il castello Franco di Paros, il duomo di Siracusa e molteplici altri esempi, con le loro inversioni spaziali (l’interno diventa esterno, i vuoti si riempiono e viceversa), le apparecchiature scoordi-nate di particolari architettonici (capitelli rovesciati, colonne a fare da travi, murature di
6. G. Corbellini, Progettare l’amnesia, in Recycland, cit.
35/208
spoglio...), le continue ibridazioni, sovrapposizioni e giustapposizioni “elencali”, illustrano quasi didascalicamente le caratteristiche dell’architettura di riciclo e le sue potenzialità: l’indeterminazione nello spazio e nel tempo, la disponibilità a connettersi dinamicamente al flusso della trasformazione a seconda di possibilità e necessità contingenti, la riduzione della standardizzazione e l’automatica produzione di differenziazione marginale. Per ricon-quistare una attitudine analoga, alcuni progetti contemporanei si appoggiano a macchine concettuali specificamente dirette a disconnettere l’approccio dell’architetto dalle sue consuetudini culturali e produrre quello scarto così decisivo nel fornire alternative tanto praticabili quanto inaspettate, non direttamente determinate dagli assetti compositivi, spaziali, normativi, funzionali, tettonici, tipologici, distributivi e tecnologici consolidati nei contesti in trasformazione.Vediamone alcune.
FrammentazioneUn primo dispositivo, analogo ai processi di lavorazione industriale dei rifiuti, è la fram-mentazione. Da qualche tempo si stanno diffondendo servizi di raccolta di serramenti, parti strutturali, rivestimenti e altri elementi edilizi provenienti da siti di demolizione. Piattaforme come opalis.be, promossa dal collettivo rotor, da cui è possibile accedere a informazioni su ubicazione e assortimento dei depositi di materiali recuperati in Belgio7, o l’organizzazione non profit newyorkese Build it Green!8 forniscono un apporto quantitativo che si traduce in evidenti conseguenze qualitative. Questi elementi, privati delle relazioni che li coordinavano in una composizione di insieme, si offrono a una libera riconsiderazione del loro ruolo, anche indipendentemente dalla loro funzione specifica e originale. Emblema-tico a questo riguardo (oltre a varie installazioni più o meno temporanee di rotor) il progetto Van Alen Books di Lot-Ek, al cui interno viene realizzata una gradonata montando insieme una serie di porte vecchie9.La rottura dell’unità relazionale tra le parti (della “composizione”...) produce effetti analoghi anche a scale differenti. Kengo Kuma, ad esempio, dissemina nel suo progetto Eco Particle10 per l’isola giapponese di Miyakojima le singole stanze di un vasto intervento residenziale in un bosco, con l’obiettivo di facilitare un processo di diluizione dell’architettura nell’ambiente.
7. Opalis.be è una piattaforma informatica organizzata per luoghi (i depositi) e materiali (legno, minerali e altri semilavorati). Un'ampia pagina di consigli aiuta l’utente a orientarsi. Vi sono poi collegamenti a iniziative analoghe in altri paesi.8. Oltre ai servizi di raccolta, stoccaggio e vendita dei materiali recuperati, l’iniziativa newyorkese agisce come impresa di “decostruzione”. Vedi http://bignyc.org/.9. http://www.lot-ek.com/filter/cultural/VAN-ALEN-BOOKS, consultato il 08.02.2014.10. K. Kuma, Eco Particle, in «Lotus International», n. 97, 1998.
36/208
CatalogoLa raccolta degli elementi edilizi per tipologia è premessa per realizzazioni che fanno del monotematismo uno dei motori del riciclo e della sua espressività. L’accostamento per genere di parti simili ma estremamente variabili per forme, dimensioni, finiture, materiali e stato di conservazione, produce una interessante tensione tra ripetizione e differenza. Si tratta di un approccio che vede sempre più spesso l’uso di vecchie finestre: assemblate nei poetici Vodka Pavilion di Alexander Brodsky11, nelle molteplici installazioni di Jason van der Woude12, o in edifici come lo showroom Rake13, realizzato da un gruppo di studenti a Tron-dheim sotto la supervisione di August Schmidt.
Chilometro zeroStudi come 2012 architekten, oggi Superuse-Studios, basano il loro lavoro sull’intercet-tazione di flussi locali di materiali, siano essi legati alla dismissione di edifici (vedi il bar interno alla scuola di architettura di Delft, realizzato assemblando serramenti in alluminio di recupero) che di attività di altro genere. La struttura metallica di villa Welpeloo è ricavata da una macchina tessile, mentre il rivestimento utilizza le assicelle di legno dei rocchi sui quali si avvolgevano grandi cavi elettrici, entrambi materiali recuperati da vicine attività industriali in disuso. Ancora il gruppo olandese realizza un parco giochi con pale eoliche a fine vita e parti di caccia F-1614. Come si può intuire, la “correttezza ambientale” alla base dell’efficacia estetico-narrativa di queste proposte tende a intersecarsi con intenzioni ed esiti meno rassicuranti. Il reimpiego in loco di materiali di spoglio fa spesso pensare a una sorta di cannibalismo rituale, teso a nutrirsi delle qualità precedenti e a riprodurne in qualche modo l’aura. Le tegole impilate da Arturo Franco a formare divisori semitrasparenti nell’edificio 8b al Matadero di Madrid15 così come i coppi di vario genere e colore provenienti dalla incessante sostituzione edilizia cinese e accatastati da Wang Shu sull’involucro del Ningbo Museum16 abitano sì il territorio della nostalgia per un passato ideale ma, fondan-dosi sul ritorno del rimosso, ne esplorano sottilmente anche le inquietudini. Queste ultime sono al centro della ricerca di R&Sie in cui la paura e il disgusto provocati dalle materie
11. A. Brodsky, Pavilion for Vodka Ceremonies. Art-Kliazma, Moskow, 2003, in «Lotus International», n. 130, 2007.12. Alcune delle opere di Jason van der Woude sono ubicate presso la Verbeke Foundation, in Belgio. Vedi http://www.ver-bekefoundation.com/ e http://www.telosproductions.eu/New_website/Jason.html.13. Vedi http://www.archdaily.com/172839/rake-showroom-rake-visningsrom/, consultato il 05.02.2014.14. Opere e approccio dello studio olandese sono disponibili in http://www.superuse-studios.com/.15. Vedi http://www.dezeen.com/2011/07/10/warehouse-8b-by-arturo-franco-office-for-architecture/, consultato il 08.02.2014.16. Vedi http://www.architectural-review.com/ningbo-museum-by-pritzker-prize-winner-wang-shu/5218020.article, consul-tato il 23.12.2013.
37/208
rifiutate (tanto più perturbanti quanto più vicine a noi) diventano parte di una sorta di subli-mazione vicina ad analoghe esperienze dell’arte contemporanea: l’acqua fetida della laguna di Venezia viene risucchiata tra le pareti trasparenti del progetto per la nuova sede Iuav; le polveri sottili sospese nell’aria inquinata di Bangkok sono attirate dalla rete elettrostatica che avvolge come un sudario la proposta per il museo di arte contemporanea; al MiPi Bar17 servono a ogni avventore bevande ricavate dalla sua orina...
DislocazioneOggetti scartati appartenenti ai più diversi ambiti produttivi entrano, come si è visto, nell’immaginario dell’architettura. Nei progetti del Rural Studio, Basurama, Elasticospa, Thilo Folkerts, David Hertz, ancora Lot-Ek e Superuse Studios, insieme a tanti altri, libri, lattine, targhe, bottiglie, balle di carta da riciclo, pneumatici, finestrini di automobile, su fino a serbatoi industriali, autobotti, container o parti di aeroplano aiutano a contenere i costi e aggiungono un valore specificamente legato alla brillantezza delle soluzioni. L’in-congruenza di questi elementi funziona da MacGuffin progettuale, sfidando l’architettura a inclusioni tanto stridenti quanto dotate di una loro emergente necessità. Lo straniamento che ne deriva accompagna il processo di ideazione e riaffiora inalterato nell’impressione dell’osservatore.La decontestualizzazione oggettuale si intensifica poi attraverso operazioni di manipolazione che, come nei ready-made dadaisti, mettono in moto interessanti cortocircuiti tra forma, funzione e rappresentazione. L’inversione dell'orinatoio di Duchamp che, coricato, diventa Fontana opera nell’architettura analoghe dislocazioni concettuali, sia che coinvolgano ricicli materiali o puramente tipologici. NL Architetcts propongono ad esempio di rovesciare sottosopra la casa tipica (quella con il tetto a due falde e il camino che tutti i bambini disegnano) per un progetto di ludoteca De Wilde Plek18 in cui si entra dal timpano, infisso nel terreno, e si sale al giardino pensile, intensificando in questo modo la dimensione tra-sgressiva del gioco.
DerivaTutti questi approcci comportano “trattamenti” che, in un modo o nell’altro, agiscono sull’integrità fisica dei materiali sottoposti a riciclo, disconnettendoli di fatto dai loro con-testi. Si tratta di operazioni difficilmente estensibili alla grande scala che, proprio per le sue
17. Sull’approccio di R&Sie vedi G. Corbellini, Bioreboot. The Architecture of R&Sie(n), Princeton Architectural Press, 2009.18. Vedi http://www.nlarchitects.nl/project/146/slideshow, consultato il 08.02.2014.
38/208
misure, è caratterizzata da una maggiore inerzia, da una stratificazione consolidata di con-nessioni funzionali e spaziali, da una estesa rete di vincoli territoriali ed extra architettonici. I tempi lunghissimi che hanno reso possibili i ricicli medievali di vasti comparti urbani (oltre alla colonizzazione parassitaria del palazzo di Spalato si possono ricordare le arene romane inglobate nei tessuti di Lucca o Firenze...) non sono logicamente comprimibili nelle odierne necessità di risposta quasi istantanea, né sono riproducibili – e probabilmente auspicabili – i complessivi rivolgimenti economici, sociali e culturali che hanno consentito quelle lente metabolizzazioni. La odierna, sovrabbondante produzione di junkspace intrinsecamente legata alle dinamiche di mercato e ulteriormente evidenziata dalla crisi sfida il progetto contemporaneo ad approntare tecniche di digestione accelerata che riguardano prima di tutto gli aspetti immateriali, la capacità di vedere in questi contesti incerti un paesaggio disponibile, svincolato dalle ragioni che lo hanno prodotto e che ne hanno determinato gli assetti fisici. È quanto emerge da alcuni esperimenti degli ultimi trent’anni, tutti più o meno riferibili alla pratica situazionista della deriva. Questo vagare privo di scopo, attraversando spazi e ambienti senza una meta, indipendentemente dalle loro caratteristiche funzionali o spaziali e, allo stesso tempo, facendosene influenzare in modo del tutto contingente e casuale, è il motore paradossale di alcune applicazioni superefficienti. Un esempio mi-litare e uno cinematografico possono aiutare a chiarire. L’attacco dell’esercito israeliano alla città palestinese di Nablus nel 2002 è stato condotto senza tenere conto di «streets, roads, alleys, or coutyards that constitute the syntax of the city, and none of the external doors, internal stairwells, and windows that constitute the order of buildings, but rather moved horizontally through party walls, and vertically through holes blasted in ceilings and floors»19. Per visualizzare questo modo di vedere e usare lo spazio, sia pure in una misura meno radicale, si può richiamare alla mente il terzo episodio della saga di Jason Bourne20, in cui Matt Damon attraversa il tessuto edilizio di Tangeri, senza curarsi di cosa sia privato e pubblico, saltando da un edificio all’altro attraverso finestre e terrazzi, fino a sorprendere il suo antagonista (che aveva seguito percorsi più tradizionali). Il Bunker 599, massiccia forti-ficazione di calcestruzzo tagliata a metà dall’intervento di Raaaf e Atelier De Lyon21, esprime
19. E. Weizman, Letal Theory, in «Log», n. 7, 2006, p. 53. L’articolo è basato in parte su una intervista a Aviv Kokhavi, gene-rale israeliano, che fa esplicitamente riferimento a Guy Debord e alle teorie situazioniste. Interessante, dal punto di vista del riciclo architettonico, il fatto che le vie aperte durante i combattimenti sono state in parte mantenute: «In fact, after serbing their original purpose, the openings forced through the walls become part of the syntax of the city and are not reused for military purposes», nota 1, ibid.20. P. Greengrass, The Bourne Utimatum, 2007.21. Vedi http://www.raaaf.nl/en/projects/7_bunker_599, consultato il 16.01.2014.
39/208
una attitudine analoga ad affrontare vuoti e pieni come variabili liberamente manipolabili, e qualcosa di altrettanto spiazzante emerge nello spettacolare intervento di Herzog & De Meuron per il Caixa Forum di Madrid, in cui l’edificio preesistente viene completamente svuotato al piano terra e fatto levitare, le finestre si aprono senza alcuna connessione al partito del vecchio involucro di mattoni, ulteriormente gravato in alto da una massa di ferro arrugginito. In una simile direzione si erano mossi alcuni progetti urbani “site-specific” a cavallo degli anni Ottanta. L’estensione della griglia dell’ospedale lecorbusieriano sul sestiere veneziano di Cannaregio, proposta nel 1978 da Peter Eisenman22, anticipa analoghe strategie di stratificazione condotte pochi anni dopo da Bernard Tschumi e Rem Koolhaas nei loro progetti per il parco della Villette a Parigi. La sostanziale indifferenza delle geome-trie sovrapposte tra loro e/o ai tessuti esistenti, la loro virtuale indeterminazione funzionale e spaziale, la componente stocastica che riduce fortemente il controllo del progettista sulle sue stesse azioni, le frizioni che si producono tendono a rompere i tradizionali rapporti architettonici tra figura e sfondo e a liberare un potenziale inatteso.Il progetto del riciclo sembra dunque richiedere il riciclo del progetto. Quest’ultimo, fram-mentato nelle sue componenti fondamentali e privato delle relazioni che le legavano in una sequenza abituale di gesti e operazioni, è sfidato dalle condizioni contemporanee a ripro-gettarsi ogni volta, a trovare nella realtà gli strumenti tecnici e narrativi che ne sostengono l’efficacia operativa.
22. Al progetto per Cannaregio K. M. Hays ha dedicato una recente e interessante analisi critica nel suo Architecture’s Desire. Reading the Late Avant-Garde, MIT Press 2010, cap. Repetition, p. 51 e sg.