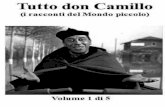Redalyc.El materialismo de Georges Bataille. Una lectura ...
Diderot e Spinoza: Materialismo, idea del tutto, storia della natura
Transcript of Diderot e Spinoza: Materialismo, idea del tutto, storia della natura
raffaele carbone
DIDEROT E SPINOZA: MATERIALISMO,IDEA DEL TUTTO, STORIA DELLA NATURA
Non è facile discutere dei rapporti tra Diderot e Spinoza, e a mag-gior ragione alla luce delle problematiche discusse in questo Conve-gno. Le difficoltà di questa indagine, che inevitabilmente richiede di confrontarsi con il denso tessuto culturale del Settecento francese, nel quale il pensiero di Spinoza è filtrato attraverso una particola-re griglia ermeneutica, sono generate dalla penuria di riferimenti espliciti al filosofo olandese nei testi di Diderot, dalle mediazioni che si frappongono tra i due pensatori (tra i quali Bayle certamente, Toland, Shaftesbury1), dagli sviluppi magmatici e vertiginosi della stessa riflessione di Diderot2. Nel singolare, burrascoso e vorticoso percorso filosofico del pensatore francese, in un movimento che «lo trascinò dall’ateismo al panteismo, dal materialismo al panpsichi-smo e viceversa da questi a quelli»3, la presenza di Spinoza, almeno in parte mediata dall’interpretazione dominante dello spinozismo come ateismo – del resto lo schema di lettura più incisivo era for-nito in quel tempo dai contestatori dello spinozismo – , costituisce un vettore decisivo nel (ri)orientamento e nelle dinamiche di questo
1 Paolo Casini ritiene che il preteso spinozismo di Diderot è di maniera, avulso dal contesto speculativo dell’Ethica e ricalca la particolare ricezione o rielaborazione illuministica che del pensiero di Spinoza avevano dato Boulainvillier, Bayle e Shaf-tesbury (P. Casini, Diderot ‘philosophe’, Bari, Laterza, 1962, p. 133). Più recente-mente Frank Burbage e Nathalie Chouchan – per i quali la lettura di Spinoza da parte di Diderot è fortemente ipotetica – argomentano che tra i due autori ci sono come intermediari Berkeley (in particolare l’Alciphrone), forse Shaftesbury, ma so-prattutto Bayle – l’articolo Spinoza del suo Dizionario – e le opere apologetiche (F. Burbage, N. Chouchan, «A propos du rapport Diderot-Spinoza. Spinozisme et matérialisme chez Diderot», in O. Cloche e H. Politis (éd. Par), Spinoza aux XVIIIe siècle, Atti delle Giornate di studi del 6 e 13 dicembre 1987 organizzate alla Sorbona, Paris, Méridiens Klincksieck, 1990, pp. 169-182, in part. 171).2 Scriveva infatti Ernst Cassirer: «Il pensiero di Diderot non aspira […] a un’espressione fissa, a chiudersi in formule stabili e definitive. Esso è e rimane un elemento fluido e fuggevole; ma appunto in questa sua volubilità crede di potersi avvicinare alla realtà» (E. Cassirer, Die philosophie des Aufklärung, Tübingen, J. C. B. Mohor, 1932, tr. it. di E. Pocar, Firenze, La Nuova Italia, 1936, 1964, p. 133).3 Ivi, p. 109.
196 Ontologia e temporalitàSpinoza e i suoi lettori moderni
stesso itinerario. Peraltro, nella misura in cui ci avviciniamo ai te-sti del pensatore di Langres, rileviamo che egli si allontana da quei detrattori di Spinoza che pure costituirono un canale d’accesso al filosofo olandese.
Alla luce delle tematiche del Convegno, ho tralasciato di esami-nare le Pensées philosophiques (1745), in cui Diderot confuta l’an-tropomorfismo divino e i punti chiave dell’apologetica classica (la prova dei miracoli e l’integrità delle Scritture) e si fa partigiano del-la supremazia del potere civile sulla religione quando essa rischia di turbare l’ordine pubblico. Tra l’altro, di questo testo Vernière ha proposto una interessante lettura sinottica con il Trattato teologico-politico4.
È comunque a partire da La Promenade du Sceptique (1747) che Diderot comincia a trasformare la nozione di spinozismo liberando-la dalle incrostazioni dell’apologetica. In questo testo, e in particola-re nella sezione L’Allée des marroniers, Diderot mette in scena una discussione sul rapporto tra Dio e mondo attraverso le voci di pir-roniani, deisti, atei, spinozisti e scettici. I due spinozisti del dialogo sono Alcméon e Oribaze: il primo, confutando il deismo, critica l’idea di un’intelligenza divina creatrice, di un Dio trascendente il cosmo; il secondo, prendendo le distanze dall’ateismo, riconosce l’esistenza di un Dio che è tuttavia immanente: un Dio da cercare in noi stessi, ovvero un Dio di cui noi facciamo parte. In questo contesto lo spino-zismo si rivela come quella filosofia che riesce a conciliare la critica del finalismo, il riconoscimento di un nesso deterministico tra gli elementi del mondo e l’esistenza di Dio5.
Prendo dunque in esame alcuni passi di questo testo. Annun-ciando l’argomentazione di Oribaze, Alcméon così si rivolge ai suoi interlocutori: «Voi siete parte del suo essere; egli è in voi, voi siete in lui. La sua sostanza è unica, immensa, universale; essa sola è: il resto non sono che modi»6. Qualche pagina più avanti interviene Oribaze, che replica agli argomenti del deista Philoxène, per il qua-le la meravigliosa organizzazione del cosmo, e, tra le altre cose, la
4 P. Vernière, Spinoza et la pensée française avant la révolution, 2 voll., Paris, PUF, 1954, vol. II, pp. 564-567.5 F. Burbage, N. Chouchan, A propos du rapport Diderot-Spinoza… cit., p. 173.6 «Vous faites partie de son être; il est en vous, vous êtes en lui. Sa substance est unique, immense, universelle; elle seule est: le reste n’en est que des modes» (D. Diderot, La Promenade du sceptique ou Les Allées, in Id., Œuvres, I, Philosophie, edizione a cura di L. Versini, Paris, Robert Laffont, 1994, § 37, p. 115. Le traduzioni dei passi di Diderot sono mie. Tra le edizioni italiane dei testi filosofici di Diderot, ho consultato le Opere flosofiche, a cura di P. Rossi, Milano, Feltrinelli, 1963).
197Ontologia e temporalitàSpinoza e i suoi lettori moderni
perfetta struttura e funzionalità di esseri minuscoli come gli insetti, non possono essere prodotto di qualche oscuro movimento fortuito della materia7. Riassumo l’argomentazione di Oribaze. (1) Se non ci fosse mai stato qualche essere, mai ce ne sarebbero, perché per darsi l’esistenza occorre agire, e per agire occorre essere. (2) Se ci fossero sempre stati soltanto gli esseri materiali, non sarebbero mai esistiti esseri pensanti, e questo perché o gli esseri intelligenti si sa-rebbero dati l’esistenza o l’avrebbero ricevuta dagli esseri materiali: nel primo caso, se si fossero essi stessi autogenerati, avrebbero agito prima di essere; nel secondo caso, se il pensiero è un prodotto della materia, allora esso non è che un effetto della materia, cosicché il pensiero e gli esseri intelligenti verrebbero ridotti allo stato di modi (modes), cosa che i deisti stessi non potrebbero riconoscere. (3) Ar-gomentazione simile per la materia. Se fossero esistiti solo esseri pensanti, non ci sarebbero mai stati esseri materiali: poiché tutte le facoltà della mente si riconducono al pensiero e alla volontà, e non riuscendo noi a concepire che queste facoltà possano agire sugli es-seri creati, e tanto meno sul niente, possiamo supporre che dall’in-telligenza non si produce la materia. (4) L’essere intelligente non è pertanto una modalità dell’essere corporeo (tesi sostenuta dal deista Philoxène e sottoscritta da Oribaze). D’altro canto, non abbiamo ra-gioni per credere che l’essere corporeo sia effetto dell’essere pensan-te. (5) «Ne consegue, da quanto egli [Philoxène] ammette e dal mio ragionamento, che l’essere intelligente e l’essere corporeo sono eter-ni, che queste due sostanze costituiscono l’universo, e che l’universo è Dio»8. Non si tratta, prosegue Oribaze, di divinizzare in tal modo
7 Ivi, § 47, p. 118.8 Ivi, §§ 49-52, p. 119. Riporto il testo originale del § 52: «L’être intelligent, selon lui, n’est point un mode de l’être corporel. Selon moi, il n’y a aucune raison de croire que l’être corporel soit un effet de l’être intelligent. Il s’ensuit donc de son aveu et de mon raisonnement, que l’être intelligent et l’être corporel sont éternels, que ces deux substances composent l’univers, et que l’univers est Dieu». La tesi secondo cui l’universo è Dio costituisce, a parere di Bayle, il nucleo del pensiero di Spinoza, anche se questa dottrina non è una novità assoluta: «Io credo che egli [Spinoza] sia stato il primo che ha ridotto a sistema l’ateismo, facendone una dottrina coerente e concate-nata alla maniera dei matematici; d’altra parte le sue opinioni non sono affatto nuo-ve. Già in tempi lontani si è creduto che l’universo è una sola sostanza, e che Dio e il mondo sono un unico essere» (P. Bayle, Dizionario storico e critico. Spinoza, tr. it. di P. Bertolucci, Torino, Boringhieri, 1958, p. 25). La versione della filosofia spinoziana proposta da Bayle mette in rilievo i seguenti punti-chiave: la sostanza unica è dotata di un’infinità di attributi; corpi e menti sono modificazioni degli attributi estensione e pensiero; la sostanza o natura produce in se stessa e mediante causalità immanente tutto ciò che noi chiamiamo creature» (Ivi, pp. 77-78). Bayle prova a confutare punto per punto i pilastri dello spinozismo, in particolare mette in discussione il concetto di
198 Ontologia e temporalitàSpinoza e i suoi lettori moderni
le mosche, le gocce d’acqua e tutti i granelli di sabbia, come obietta Philoxène: questa visione dell’universo tende piuttosto a bandire la presunzione, la menzogna, gli dei9. Nella battaglia filosofica messa in scena da Diderot lo spinozismo ha l’ultima parola: da un lato con-cilia il determinismo e l’onnipresenza di Dio, dall’altro fornisce una spiegazione logica dell’universo e dell’ordine che lo struttura10.
È interessante confrontare questi paragrafi con la lettera a Vol-taire dell’11 giugno 1749, in cui Diderot rifiuta negli stessi termini il dualismo spiritualista. Sviluppando le argomentazioni di un perso-naggio, Saunderson, protagonista di un’altro suo scritto, la Lettre sur les aveugles11, egli riprende il ragionamento che ne La Promenade du sceptique è esposto da Oribaze. Anche in questa lettera l’autore spie-ga che gli esseri spirituali non possono esistere in virtù degli esseri materiali, altrimenti ne sarebbero dei modi o almeno degli effetti (tesi questa che Voltaire respinge energicamente). La stessa conclusione si trae quando si indaga l’origine della materia. La buona filosofia ci in-vita a supporre nelle cose solo ciò che vi cogliamo distintamente: ora, scrive Diderot, io non vedo distintamente altre facoltà nella mente ol-tre il volere e il pensare; e non immagino nemmeno che il pensiero e la volontà possano agire sugli esseri materiali o sul niente, come non
modificazione (le singole cose intese non come parti ma come modificazioni di un de-terminato attributo dell’unica sostanza). A riguardo egli pensa che «[…] l’estensione è composta di tante sostanze quante sono le sue modificazioni» (Ivi, p. 82). D’altro canto è assurdo concepire Dio esteso perché in tal modo si nega la sua semplicità e lo si rende composto di un numero infinito di parti. Affermare che l’estensione è in Dio significa inoltre ridurre Dio alla condizione della materia, «il più vile di tutti gli es-seri» (Ibidem). Poiché la materia esiste sotto molteplici forme attraverso successive modificazioni, ne risulta «[…] che il dio degli spinozisti è una natura attualmente can-giante, che passa continuamente per diversi stadi, i quali differiscono interiormente e realmente gli uni dagli altri» (Ivi, pp. 84-85). 9 D. Diderot, La Promenade… cit., § 54, p. 119. 10 A riguardo Cfr. P. Vernière, Spinoza et la pensée française… cit., p. 670 e P. Quintili, La pensée critique de Diderot. Matérialisme, science et poésie à l’âge de l’Encyclopédie. 1742-1782, Paris, Honoré Champion, 2001, pp. 164-166.11 Il matematico Saunderson, cieco nato, espone una metafisica che si costru-isce sull’idea di un’evoluzione continua dalla materia bruta alla materia pensante passando per la materia animata e senziente. Pensando la materia in modo più astratto rispetto ai vedenti, i ciechi nati sono più facilmente inclini a credere che essa possa pensare. «Qu’est-ce que ce monde, monsieur Holmes? Un composé sujet à des révolutions qui toutes indiquent une tendance continuelle à la destruction; une succession rapide d’êtres qui s’entre-suivent, se poussent et disparaissent; une symétrie passagère; un ordre momentané. Je vous reprochais tout à l’heure d’esti-mer la perfection des choses par votre capacité; et je pourrais vous accuser ici d’en mesurer la durée sur celle de vos jours» (Id., Lettre sur les aveugles, in Id., Œuvres cit., I, p. 169).
199Ontologia e temporalitàSpinoza e i suoi lettori moderni
mi capacito di come il niente o gli esseri materiali possano agire sugli esseri spirituali. In breve, poiché non è possibile concepire la possi-bilità di queste azioni (quella del niente o della materia sugli esseri spirituali e quella di questi ultimi sui corpi) né se ne ha percezione, si deve convenire che l’essere spirituale e l’essere corporeo sono l’uno indipendente dall’altro, «[…] che essi costituiscono insieme l’univer-so, e che l’universo è Dio»12. In questa lettera, dove Diderot traccia le linee di un’ontologia minima, c’è qualche traccia dei principi base del pensiero di Spinoza. In particolare penso al primo libro dell’Etica, Proposizione III: «Delle cose che non hanno nulla di comune tra di loro, l’una non può essere causa dell’altra». Dimostrazione: «Se non hanno nulla di comune tra di loro, esse dunque (per l’Assioma 5) non possono neanche essere conosciute l’una mediante l’altra, e perciò (per l’Assioma 4) l’una non può essere causa dell’altra. C.D.D.»13. Da tener presente anche, nel terzo libro dell’Etica, la Prop. II (e il relativo scolio): «Né il Corpo può determinare la Mente a pensare, né la Men-te può determinare il Corpo al moto o alla quiete o a qualche altra maniera d’essere (se ce ne è qualche altra)»14.
D’altro canto, nel costruire la sua argomentazione a sostegno della reciproca indipendenza di pensiero e materia, Diderot sembra evocare anche delle posizioni fatte valere da Malebranche: (1) l’esse-re precede l’agire e il pensare15; (2) il niente non ha proprietà – tesi che deve precedere, secondo l’Oratoriano, il je pense donc je suis; (3) sussiste una differenza essenziale tra l’anima pensante, senzien-te, desiderante e il corpo esteso (i modi d’essere dell’estensione in lunghezza, larghezza e profondità non sono altro che rapporti di distanza)16. Se per Malebranche il primo principio di tutte le nostre
12 D. Diderot, Lettre à Voltaire, 11 juin 1749, in Id., Œuvres, V, Correspondance, edizione a cura di L. Versini, Paris, Robert Laffont, 1997, p. 14.13 Eth I, pr. 3, dem., tr. it. di G. Durante, note di G. Gentile e G. Radetti, Milano, Bompiani, 2007, I, pp. 8-11.14 Eth III, pr. II, pp. 240-241; Scolio, pp. 242-251.15 «Que M. Descartes raisonnoit donc mal de commencer sa Métaphysique par ce vicieux raisonnement. Je pense donc je suis. Car, comme dit M. Arnauld, on ne sçaurait penser sans être» (N. Malebranche, Réponse à la troisième lettre de M. Ar-nauld, 19 mars 1699, in Id., Œuvres complètes, a cura di A. Robinet, voll. 23, Paris, Vrin-C.N.R.S., 1958-1990, Vol. IX, p. 948).16 Id., Entretiens sur la métaphysique et sur la religion, I, § III, in Id., Œuvres complètes cit., Vol. XII, p. 35; Œuvres, a cura di G. Rodis-Lewis, Paris, Gallimard, coll. «La Pléiade», 2 voll., 1979, 1992, Vol. II, p. 672. Si veda la lunga aggiunta del 1700 al libro IV, capitolo XI de La recherche de la vérité (Id., Œuvres, ed. Rodis-Lewis cit., Vol. I, p. 432): «Or il suit de ce que le néant n’est pas visible, que tout ce qu’on voit clairement, distinctement, immédiatement existe nécessairement».
200 Ontologia e temporalitàSpinoza e i suoi lettori moderni
conoscenze è la negatività del niente17, Diderot – più palesemente nella lettera a Voltaire ma anche ne La Promenade du sceptique – pure fa leva su questa premessa per articolare la sua tesi18. In tal modo, per quanto riguarda gli anni 1747-1749, egli individua i fon-damenti logici di quella che si potrebbe definire un’ontologia mini-ma, ovvero un tracciato stringato ed essenziale dei pilastri e delle linee di un’archittetura dell’essere: (1) il nulla non ha proprietà, ciò che non è non agisce e non può dunque produrre qualcosa; (2) men-ti e corpi sono entità di natura profondamente diversa – niente con-sente di ricondurre la mente che pensa e che vuole ai corpi estesi e viceversa – cosicché le prime non sono né modificazioni né prodotto dei secondi né questi lo sono di quelle; (3) pensiero e materia sono eterni, (4) essi costituiscono l’universo, (5) l’universo è Dio.
Tuttavia, come si è detto, il pensiero di Diderot è in continuo mo-vimento. Così, negli anni successivi a La Promenade e alla lettera a Voltaire, l’incidenza di Spinoza sul suo percorso intellettuale assu-me un’altra curvatura.
Le voci ‘naturalista’ e ‘spinozista’ dell’Enciclopedia19 possono orientarci nel tentativo di valutare il peso della filosofia di Spinoza
17 Per Descartes questo principio costituisce semplicemente una delle nozioni comuni: «[…] sed facilè ipsam agnoscimus ex ׀ quolibet ejus attributo, per com-munem illam notionem, quòd nihili nulla fint attributa, nullæve proprietates aut qualitates» (R. Descartes, Principia philosophiæ, in Œuvres de Descartes, a cura di Ch. Adam e P. Tannery, voll. 12, Paris, Cerf, 1897-1913; Paris, CNRS-Vrin, 1964-1974, Vol. VIII, Prima parte, § 52, p. 25).18 «S’il n’y avait jamais eu d’êtres […] il n’y en aurait jamais eu; car pour se don-«S’il n’y avait jamais eu d’êtres […] il n’y en aurait jamais eu; car pour se don-ner l’existence il faut agir, et pour agir il faut être» (D. Diderot, Lettre à Voltaire, 11 juin 1749 cit., p. 14).19 Qualche anno prima di pubblicare Spinoza et la pensée française avant la révolution Vernière aveva ricostruito l’immagine di Spinoza – e il giudizio sulla sua filosofia – in alcuni articoli dell’Enciclopedia: P. Vernière, Le spinozisme et l’En-cyclopédie, «Revue d’histoire littéraire de la France» juillet-septembre 1951, ripreso in Id., Lumières ou clair-obscur ?, Paris, PUF, 1987, p. 275-286. In questo lavoro Vernière riconosce che lo spinozismo, a causa della sua logica serrata, mal si con-ciliava con l’empirismo di Diderot, il quale in nessun caso poteva abbracciarne la teoria della conoscenza e il disprezzo costante dell’esperienza. Tuttavia, Diderot sembra smarrirsi, o vuol farci confondere, quando attacca nello spinozismo le tesi che egli stesso difende e con cui già si è esposto nella Lettre sur les aveugles e nelle Pensées sur l’interprétation de la nature. In realtà, nell’Enciclopedia, Diderot non intende oltrepassare «l’intelligence de son temps». Così Vernière può concludere che l’autentico Diderot non si trova in quelle pagine: non resta che dispiacersi del fatto che l’esercizio della libertà intellettuale sia stato così difficile nel XVIII secolo e la pratica dell’ipocrisia così frequente (Ivi, p. 286). Sostanzialmente d’accordo con la lettura di Vernière è France Marchal nel suo lavoro La culture de Diderot, Paris, Honoré Champion, 1999, pp. 362-366.
201Ontologia e temporalitàSpinoza e i suoi lettori moderni
negli sviluppi delle riflessioni di Diderot. Per quanto riguarda la pri-ma, dopo aver spiegato il significato più generale di questo termine (una persona che ha studiato la natura e che è versata nella cono-scenza delle cose naturali), Diderot mette in luce un’ulteriore va-lenza semantica della parola: «Si dà ancora il nome di naturalisti a coloro che non ammettono affatto Dio, ma credono che c’è soltanto una sostanza materiale, rivestita di diverse qualità che le sono tanto essenziali quanto la lunghezza, la larghezza, la profondità, e in con-seguenza delle quali nella natura tutto si realizza necessariamente come noi vediamo; in questo senso naturalista è sinonimo di ateo, spinozista, materialista, etc.»20. Nel lemma ‘spinozista’ Diderot di-stingue gli spinozisti antichi da quelli moderni.
Il principio generale degli spinozisti moderni pone che la materia è sensibile. Essi dimostrano questo principio facendo leva sullo svi-luppo dell’uovo, corpo inerte, che in virtù del solo tramite del calore graduale passa allo stato di essere senziente e vivente, e sulla crescita di ogni animale, che all’inizio non è che un punto, e che attraverso l’assimilazione nutritiva delle piante, in poche parole, di tutte le so-stanze che servono alla nutrizione, diventa un corpo senziente e vi-vente in un grande spazio. Da ciò essi concludono che esiste soltanto la materia, e che essa basta per spiegare tutto; del resto essi seguono l’antico spinozismo in tutte le sue conseguenze21.
Il nuovo spinozismo cerca di conciliare l’idea di una materia ete-rogenea e il tema dell’unità della sostanza alla luce della sensibilità della materia stessa. Quest’ultima ipotesi, che trova sostegno nelle indagini empiriche, e con cui gli spinozisti moderni ricongiungono il pensiero e l’estensione, può esser messa in rapporto con quan-to Spinoza scrive nello scolio della Prop. XIII22 del secondo libro dell’Etica:
Da ciò comprendiamo non solo che la Mente umana è unita al Cor-po, ma anche che cosa si deve intendere per unione della Mente e del Corpo. Nessuno però la potrà comprendere adeguatamente, os-sia distintamente, se prima non conosce adeguatamente la natura del nostro Corpo. Tutto ciò, infatti (Nam ea), che abbiamo mostrato
20 D. Diderot, Encyclopédie, Article: Naturaliste, in Id., Œuvres cit., I, pp. 480-481.21 D. Diderot, Encyclopédie, Article: Spinoziste cit., p. 484.22 La pr. XIII afferma: «L’oggetto dell’idea costituente la Mente umana è il Cor-po, ossia un certo modo, esistente in atto, dell’Estensione, e niente altro» (Eth II, pr. 13, tr.it. cit., pp. 130-131).
202 Ontologia e temporalitàSpinoza e i suoi lettori moderni
sinora è cosa comunissima (admodum communia sunt) e vale (per-tinet) ugualmente per gli uomini e per gli altri Individui (ab reliquia Individua), i quali, benché in gradi diversi, sono tutti animati (quae omnia, quamvis diversis gradibus, animata tamen sunt), Di qua-lunque cosa, infatti, è data necessariamente in Dio un’idea, la cui causa è Dio allo stesso modo che è causa dell’idea del Corpo umano, e quindi tutto ciò che abbiamo detto dell’idea del Corpo umano si deve dire necessariamente dell’idea di qualunque cosa23.
La distinzione tra spinozisti antichi e moderni rivela la ricchezza ermeneutica della filosofia di Spinoza: in essa devono esser rintrac-ciabili aperture e modulazioni grazie a cui lo spinozismo può modifi-carsi alimentandosi dei progressi della ricerca filosofica e scientifica. Diderot sembra qui riconoscere l’attualità teorica dello spinozismo, anche se il neospinozismo del XVIII secolo, riducendo la sostanza alla materia e dotandola di un dinamismo immanente che, come nota Roger, non è stato supposto da Spinoza, finisce con l’allonta-narsi dal pensiero del filosofo di Amsterdam24.
Alla luce di questa voce dell’Enciclopedia ciò che caratterizza lo spinozismo moderno è sul piano ontologico il materialismo e sul piano epistemologico una particolare attenzione alla sfera biologi-ca: la sensibilità della materia è dimostrata non soltanto da rigorose argomentazioni logiche ma in primo luogo dalle indagini sulle tra-sformazioni che avvengono in natura, dall’osservazione del prodursi della vita e della sensazione a partire dall’(apparentemente) inerte e inanimato. Ora, come ha ben spiegato Vernière, se Diderot palesa la parentela ideologica tra lo spinozismo e il nuovo materialismo, e nella misura in cui abbraccia egli stesso questa posizione mate-rialistica, egli riconosce implicitamente il ruolo svolto da Spinoza nell’elaborazione della sua filosofia25. A riguardo sono emblematiche alcune considerazioni della lettera di Diderot a Duclos del 10 ottobre 1765. In essa egli sostiene che il pensiero è il prodotto della sensibi-
23 Eth II, 13 schol., tr. it. cit., pp. 132-133.24 Cfr. J. Roger, Les Sciences de ma vie dans la pensée française du XVIIIe siècle, Paris, Albin Michel, 1993, pp. 462-463; H. Ida, Genèse d’une morale matérialiste. Les passions et le contrôle de soi chez Diderot, Paris, Honoré Champion Éditeur, 2001, pp. 300-301.25 P. Vernière, Spinoza et la pensée française… cit., p. 597. Da tener presente anche la lettura di Marx W. Wartofsky, per il quale Diderot trasforma l’unità della sostanza spinoziana in unità materiale, il che rende Dio inutile e – poiché conoscen-te e conosciuto sono della stessa natura – fa della materialità la condizione della conoscenza della natura (M. W. Wartofsky, Diderot and the Development of Mate-rialist Monism, «Diderot Studies» 2 (1952), pp. 279-329, in part. 285-287).
203Ontologia e temporalitàSpinoza e i suoi lettori moderni
lità e che la sensibilità è una caratteristica universale della materia: questa proprietà è inerte nei corpi bruti, come lo è il movimento nei corpi pesanti fermati da un ostacolo, ma diventa attiva negli stessi corpi nella misura in cui assimilano una sostanza animale vivente26. La concezione della sensibilità della materia, accennata peraltro an-che in una lettera dell’ottobre 1759, in cui Diderot nega l’opposizio-ne tra materia vivente e materia morta27, si riscontra nelle Pensées sur l’interprétation de la nature28 e nell’Entretien entre d’Alembert et Diderot, testo capitale della sua produzione: in opere e occasioni diverse Diderot afferma e sviluppa l’idea che ogni particella della materia costituente l’universo è dotata di sensibilità – inerte o in atto – e di vita29; negli Éléments de physiologie, poi, mette l’accento sul fatto che la sensibilità non è tanto una proprietà intrinseca della materia quanto il risultato della sua organizzazione30.
26 «[…] la pensée est le résultat de la sensibilité, et […] selon moi, la sensibilité est une propriété universelle de la matière; propriété inerte dans les corps bruts, comme le mouvement dans les corps pesants arrêtés par un obstacle; propriété ren-due active dans les mêmes corps par leur assimilation avec une substance animale vivante» (D. Diderot, Lettre à M. Duclos, à Châlons-sur-Marne, 10 octobre 1765, in Id., Œuvres, V cit., p. 541). 27 «Le sentiment et la vie sont éternels. Ce qui vit a toujours vécu, et vivra sans fin. La seule différence que je connaisse entre la mort et la vie, c’est qu’à présent vous vivez en masse, et que dissous, épars en molécules, dans vingt ans d’ici vous vivrez en détail» (Id., Lettre à Sophie Volland, Au Grandval, 15 octobre 1759, in Id., Correspondance cit., p. 171).28 D. Diderot, Pensées sur l’interprétation de la nature, § 58 (Questions) in Id., Œuvres, I cit., p. 597-598. Si veda anche l’edizione a cura di Vernière: D. Diderot, De l’interprétation de la nature, in Id., Œuvres philosophiques, a cura di P. Vernière, Paris, Garnier, 1964, 1980, pp. 241-242.29 Su questa tematica si veda C. Lannoy, La sensibilité épistémologique de Di-derot: Expression matérialiste d’un désir d’éternité, «Recherches sur Diderot et l’Encyclopédie» 27 (1999), pp. 59-88, in part. 71-72.30 Sulla differenza tra il Rêve de d’Alembert e gli Éléments de physiologie cfr. Y. Belaval, Le philosophe Diderot, «Critique» 58 (1952), pp. 230-253, ora in Id., Étu-des sur Diderot, Paris, PUF, 2003, pp. 279-303, in part. 294-297. Negli Éléments de physiologie, contestando la teoria dualista delle due sostanze (anima e corpo), che, alla luce delle definizioni che ne vengono date, appaiono essenzialmente incom-patibili [«Quelle liaison peut-il donc y avoir entre elles? Y a-t-il quelque chose de plus absurde que le contact de deux êtres, dont l’un n’a point de parties, et n’occupe point d’espace? Y a-t-il quelque chose de plus absurde que l’action d’un être sur un autre sans contact ?»], Diderot valorizza ancora la posizione abbracciata prece-dentemente: «Pourquoi ne pas regarder la sensibilité, la vie, le mouvement comme autant de propriétés de la matière: puisqu’on trouve ces qualités dans chaque por-tion, chaque particule de chair?». Tuttavia, egli ricorre con maggior vigore ad una nuova idea-chiave: l’organizzazione. «La différence d’une âme sensitive à une âme rationnelle n’est qu’une affaire d’organisation» (D. Diderot, Éléments de physiolo-
204 Ontologia e temporalitàSpinoza e i suoi lettori moderni
Nelle Pensées sur l’interprétation de la nature (1753) Diderot sottolinea la centralità dell’idea del tutto, di cui la filosofia non può fare a meno. A dissipare lo stupore di fronte ai fenomeni che ci sono ignoti o che ci sorprendono interviene appunto l’attitudine filoso-fica: la meraviglia in realtà nasce spesso dal fatto che supponiamo parecchi prodigi là dove non se ne dà che uno solo, dal fatto che immaginiamo tante azioni particolari nella natura quanti sono i fe-nomeni censiti, mentre è plausibile che essa non abbia mai prodotto che un solo atto. I ragionamenti che fanno leva sullo stupore di fron-te a singoli fenomeni della natura ci conducono a isolare i differenti prodotti delle molteplici azioni che supponiamo darsi in natura e a pensare collezioni di fenomeni indipendenti le une dalle altre. In tal modo quella catena generale di cui la filosofia suppone la continuità viene a spezzarsi in diversi punti. Invece, «l’indipendenza assoluta di un solo fatto è incompatibile con l’idea del tutto; e senza l’idea del tutto, niente più filosofia»31.
Il tutto si presenta nondimeno infinitamente differenziato e arti-colato, ma la differenza non toglie la continuità e la similitudine tra le parti.
Sembra che la natura si sia compiaciuta a variare lo stesso mecca-nismo in un’infinità di maniere differenti. Essa non abbandona un tipo di produzioni che dopo averne moltiplicato gli individui sotto tutti gli aspetti possibili. Quando si considera il regno animale e ci si accorge che tra i quadrupedi non ve n’è alcuno che non abbia le funzioni e le parti, soprattutto quelle interne, perfettamente simili a quelle di un altro quadrupede, non si crede volentieri che c’è stato un primo animale prototipo di tutti gli animali, al quale la natura non ha fatto altro che allungare, accorciare, trasformare, moltiplica-re, distruggere certi organi? […] Ma che questa congettura filosofica sia ammessa come vera con il dottor Baumann, o respinta come fal-sa con M. de Buffon, non si negherà che occorra abbracciarla come un’ipotesi essenziale al progresso della fisica sperimentale, a quello della filosofia razionale, alla scoperta e alla spiegazione dei fenomeni
gie, dans Id., Œuvres cit., I, Prima parte, Cap. III, pp. 1281, 1282, 1283). Sul ruolo dell’organizzazione nella formazione del vivente e della sensibilità si veda, tra gli altri, questo passo: «A mesure que l’animal s’organise, il y a des parties qui se dur-cissent et prennent de la continuité: il s’établit une sensibilité générale et commune que les organes partagent diversement; entre ces organes les uns la conservent plus ou moins longtemps que d’autres» (Ivi, Prima parte, Cap. II, p. 1269). 31 «L’indépendance absolue d’un seul fait est incompatible avec l’idée de tout; et sans l’idée de tout, plus de philosophie» (D. Diderot, Pensées sur l’interprétation de la nature, § 11 cit., p. 564; ed. Vernière, p. 186).
205Ontologia e temporalitàSpinoza e i suoi lettori moderni
che dipendono dall’organizzazione. Infatti è evidente che la natura non ha potuto conservare tanta somiglianza nelle parti e presentare tanta varietà nelle sue forme, senza aver spesso reso sensibile in un essere organizzato ciò che ha nascosto in un altro32.
Come in matematica, esaminando tutte le proprietà di una curva, si trova che si tratta della stessa proprietà presentata sotto aspetti di-versi, così nella natura si riconoscerà, quando la fisica sperimentale sarà più avanzata, che tutti i fenomeni, o della gravità o dell’elasticità o dell’attrazione o del magnetismo o dell’elettricità, non sono che aspetti differenti della stessa modificazione33.
Se l’idea del tutto – che si ripresenta in più punti delle Pensées sur l’interprétation de la nature34 – intende cogliere la natura come un’entità rigorosamente unitaria, di cui noi percepiamo soltanto al-cuni elementi particolari, il tutto non appare come qualcosa di sta-tico. È bensì un tutto intimamente strutturato, una realtà mobile e dinamica, e il differenziarsi delle sue forme avviene nel tempo. Quest’ultimo assurge allora a categoria chiave della concezione di-derotiana della natura. «Se gli esseri si modificano successivamente passando attraverso le sfumature più impercettibili, il tempo, che
32 Ivi, § 12 cit., pp. 564-565; ed. Vernière, pp. 186-188. L’ipotesi del dottor Bau-Ivi, § 12 cit., pp. 564-565; ed. Vernière, pp. 186-188. L’ipotesi del dottor Bau-L’ipotesi del dottor Bau-mann – pseudonimo sotto il quale Maupertuis pubblica la Dissertazione d’Erlan-gen nel 1751 – sul passaggio dalla sensibilità particolare alla sensibilità generale è sviluppata in un paragrafo successivo. Uno dei punti decisivi dell’esposizione che assume sino in fondo tale ipotesi è il seguente passo: «Chi impedirà che delle parti elementari intelligenti e sensibili si allontanino all’infinito dall’ordine che costituisce la specie? Da qui un’infinità di specie di animali venuti fuori da un primo animale; un’infinità di esseri emanati da un primo essere; un solo atto nella natura» (Ivi, § 50, p. 589; ed. Vernière, p. 227). Quali sono le conseguenze di questa teoria che afferma una sensibilità generalmente diffusa nell’universo e attribuisce alle mole-cole organiche il desiderio, l’avversione, il sentimento e il pensiero, sino a suggerire l’idea della differenziazione progressiva degli esseri a partire da un primo essere? Questo universo così concepito forma un tutto, o no? Se esso non costituisce una totalità, si introduce il disordine nella natura e si rompe la catena che lega tutti gli esseri – e si mette in discussione la stessa esistenza di Dio. Se l’universo è un tutto in cui gli elementi non sono meno ordinati delle parti, occorrerà riconoscere che in conseguenza della copulazione universale il mondo, simile a un grande animale, ha un’anima; inoltre, potendo il mondo essere infinito, quest’anima del mondo può essere un sistema infinito di percezioni, e pertanto il mondo può essere Dio (Ivi, § 50, p. 590; ed. Vernière, p. 229).33 Ivi, § 45, pp. 584-585; ed. Vernière, p. 220.34 «Qui empêchera des parties élémentaires intelligentes et sensibles de s’écarter à l’infini de l’ordre qui constitue l’espèce? de là, une infinité d’espèces d’animaux sortis d’un premier animal; une infinité d’êtres émanés d’un premier être; un seul acte dans la nature» (Ivi, § 50, p. 589; ed. Vernière, p. 228).
206 Ontologia e temporalitàSpinoza e i suoi lettori moderni
non si arresta affatto, deve porre la più grande differenza tra le forme che sono esistite in epoche molto remote, quelle che esistono oggi, quelle che esisteranno nei secoli lontani; e il nil sub sole novum non è altro che un pregiudizio fondato sulla debolezza dei nostri organi, l’imperfezione dei nostri strumenti e la brevità della nostra vita»35.
L’idea di successione temporale appare nella stessa definizione che Diderot dà della natura nelle ultime pagine della Pensées sur l’interprétation de la nature: «Chiamerò dunque elementi le diffe-renti materie eterogenee necessarie per la produzione generale dei fenomeni della natura; e chiamerò la natura il risultato generale attuale, o i risultati generali successivi della combinazione degli ele-menti. Gli elementi devono esser caratterizzati da differenze essen-ziali; altrimenti tutto sarebbe potuto nascere dall’omogeneità, poi-ché tutto potrebbe ritornarvi»36.
Sedici anni separano il Rêve de d’Alembert (1769), considerato il vertice della produzione filosofica di Diderot, dalle Pensées sur l’interprétation de la nature (1753): anni febbrili, laboriosi e disper-sivi. Le Rêve de d’Alembert, riallacciandosi alle questioni poste al termine del testo del 1753, che sviluppa in un discorso di più ampio respiro, accoglie gran parte della cultura cosmologica e biologica del XVIII secolo, assimilata però in una sintesi di grande forza innova-tiva37. Quest’opera è costituita da tre entretiens. Il primo, l’Entetien entre d’Alembert et Diderot, è un dialogo di stampo socratico, dove Diderot – che sin dall’inizio fa riconoscere a d’Alembert non soltan-to le oscurità della teologia tradizionale, ma le stesse contraddizio-ni del deismo38 – conduce d’Alembert, attraverso la sua maieutica, alla comprensione della tesi del monismo materialista – posizione implicita nella Lettres sur les aveugles – proposta in luogo del dua-lismo tradizionale: una sola sostanza, la materia, consente di risalire la catena continua degli esseri postulando la sensibilità universale39;
35 Ivi, § 57 (De quelques préjugés), p. 595; ed. Vernière, pp. 238-239.36 Ivi, § 58 (Questions), p. 596; ed. Vernière, p. 239.37 Per le questioni relative alla genesi di quest’opera si veda P. Casini, Diderot ‘philosophe’ cit., pp. 262-267.38 «J’avoue qu’un être qui existe quelque part et qui ne correspond à aucun point de l’espace; un être qui est inétendu et qui n’occupe de l’étendue; qui est tout entier sous chaque partie de cette étendue; qui diffère essentiellement de la matière et qui lui est uni; qui la suit et qui la meut sans se mouvoir; qui agit sur elle et qui en subit toutes les vicissitudes; un être dont je n’ai pas la moindre idée; un être d’une nature aussi contradictoire est difficile à admettre» (D. Diderot, Entretien entre d’Alembert et Diderot, in Id., Œuvres cit., I, p. 609; ed. Vernière, p. 257).39 «D’Alembert – Vrai ou faux, j’aime bien ce passage du marbre à l’humus, de l’humus au règne végétal, et du règne végétal au règne animal, à la chair» (Ivi, p.
207Ontologia e temporalitàSpinoza e i suoi lettori moderni
nella materia più bruta, ad esempio nella pietra o nel marmo, è pre-sente una sensibilità inerte che può essere attivata: in tal modo è possibile passare via via dal sensibile all’animato, dall’animato al co-sciente40. Diderot personaggio spiega a d’Alembert che è preferibile postulare la sensibilità come proprietà della materia piuttosto che introdurre un elemento impercettibile che si inserisce nella mate-ria per determinare il passaggio dalla materia inerte, dalla machine, alla sensibilità, alla vita: «[…] per non ammettere una supposizione semplice che spiega tutto, la sensibilità, proprietà generale della ma-teria o prodotto dell’organizzazione, lei rinuncia al senso comune e precipita in un abisso di misteri, di contraddizioni e di assurdità»41. «Non si dà che una sola sostanza nell’universo, nell’uomo, nell’ani-male. L’organino con cui si insegna a cantare a un uccello è fatto di legno, l’uomo di carne. Il canarino è di carne, il musicista è fat-to di una carne diversamente organizzata; ma l’uno e l’altro hanno una stessa origine, una medesima formazione, le stesse funzioni e la stessa fine»42.
Ne Le Rêve de d’Alembert, secondo entretien di quest’opera, Ma-demoiselle de Lespinasse, uno dei personaggi, riporta al dottor Bor-deau le tesi che D’Alembert ha formulato in sogno:
613; ed. Vernière, p. 264). «Cette idée de ‘la chaîne des êtres’ est une des idées-forces du XVIIe siècle. Depuis Leibniz, qui ne voyait point de ‘saut’ dans la nature, beaucoup de naturalistes admettaient une loi générale de continuité: selon Buffon, ‘la nature descend par degrés et par nuances imperceptibles’ (Histoire des animaux, édit. Furne, Paris, 1837, t. III, p. 3)» (P. Vernière, Notes a l’Entretien entre d’Alem-bert et Diderot cit., p. 264, n. 1). 40 D. Diderot, Entretien entre d’Alembert et Diderot cit., pp. 611 ss.; ed. Vernière, pp. 260 ss.41 «[…] pour ne pas admettre une supposition simple qui explique tout, la sensi-«[…] pour ne pas admettre une supposition simple qui explique tout, la sensi-bilité, propriété générale de la matière ou produit de l’organisation, vous renoncez au sens commun et vous précipitez dans un abîme de mystères, de contradictions, d’absurdités» (Ivi, p. 619; ed. Vernière, pp. 276-277).42 «Il n’y a plus qu’une seule substance dans l’univers, dans l’homme, dans l’ani-«Il n’y a plus qu’une seule substance dans l’univers, dans l’homme, dans l’ani-mal. La serinette est de bois, l’homme est de chair. Le serin est de chair, le musicien est d’une chair diversement organisée; mais l’un et l’autre ont une même origine, une même formation, les mêmes fonctions et la même fin» (Ivi, p. 620; ed. Vernière, p. 278). Qualche riga più avanti Diderot mette in luce la connessione universale dei fenomeni e la loro necessità, che tuttavia in certi ambiti (etica, politica, ecc.) può sfuggirci. Chiede d’Alembert: «Est-ce que la liaison des phénomènes est moins nécessaire dans un cas que dans l’autre?» (si tratta della morale e della politica, «scienze congetturali» rispetto alle scienze «rigorose»). Diderot risponde : «Non; mais la cause subit trop de vicissitudes particulières qui nous échappent, pour que nous puissions compter infailliblement sur l’effet qui s’ensuivra» (Ivi, pp. 620-621; ed. Vernière, p. 280).
208 Ontologia e temporalitàSpinoza e i suoi lettori moderni
Chi conosce le specie di animali che ci hanno preceduto? Chi cono-sce quelle che succederanno alle nostre? Tutto cambia, tutto passa, soltanto il tutto resta. Il mondo comincia e finisce incessantemente; esso è ad ogni istante al suo inizio e alla sua fine; non ce ne sono mai stati altri, e mai ce ne saranno. In questo immenso oceano di mate-ria, non una molecola che somigli a un’altra molecola, non una mo-lecola che sia identica a se stessa un istante: Rerum novus nascitur ordo, ecco la sua iscrizione eterna43.
Ben traspare in questo passo la propensione di Diderot per l’ete-rogeneità della materia, che nondimeno si combina con la conce-zione dell’unità completa dell’universo: entrambi i presupposti – eterogeneità della materia, unità del tutto – sono già presenti nelle Pensées sur l’interprétation de la nature44. Da segnalare ancora, in continuità con le Pensées, la particolare percezione che Diderot ha della temporalità dell’universo e della temporaneità di ogni essere: all’interno del tutto, che solo perdura, vige la legge del mutamento incessante, della successione, che fa di ogni essere una produzione particolare e momentanea di una certa porzione del tutto45. A riguar-do non è superfluo ricordare che nell’Entretien entre d’Alembert et Diderot Diderot personaggio contesta al suo interlocutore la suppo-
43 Id., Le Rêve de d’Alembert, in Id., Œuvres cit., I, p. 631; ed. Vernière, pp. 299-300. 44 «Il n’y a qu’une manière possible d’être homogène. Il y a une infi nité de ma-«Il n’y a qu’une manière possible d’être homogène. Il y a une infinité de ma-nières différentes possibles d’être hétérogène. Il me parait aussi impossible que tous les êtres de la nature aient été produits avec une matière parfaitement homogène, qu’il serait de les représenter avec une seule et même couleur… Quelles sont les différences essentielles des matières que nous regardons comme essentiellement hétérogènes ou élémentaires? Nous l’ignorons» (Id., Pensées sur l’interprétation de la nature cit., § 58, p. 596; ed. Vernière, p. 239).»Mais comment se peut-il faire que la matière ne soit pas une, ou toute vivante, ou toute morte? La matière vivante est-elle toujours vivante? Et la matière morte est-elle toujours morte? La matière vivante ne meurt-elle point? La matière morte ne commence jamais à vivre?» (Ivi, p. 598; ed. Vernière, p. 242).45 «L’existence et l’unité de la nature sont déterminées matériellement: elle est constituée d’éléments matériels hétérogènes, doués d’une énergie éternelle (la sensibilité), qui par combinaison produisent les formes régulières des choses. Les formes, provisoires, ne sont que l’indice d’une conformité passagère et imparfaite avec l’ordre général, lequel n’est, dans chaque instant et dans sa totalité, qu’un état ponctuel, aléatoirement réalisé de la matière, sans qu’il soit possible de lui assigner un terme, en quelque sens qu’on l’entend. Si Diderot a été constamment l’homme d’une idée fondamentale, c’est celle d’un monde sans fin, sans origine, sans principe créateur ou transcendant, sans hypostase possible d’un sens ou d’un autre, soumis à une universelle transformation» (J.-C. Bourdin, Diderot: Le matérialisme, Paris, PUF, 1998 p. 113). Questo agile testo di Bordin chiarisce bene anche il nesso tra il materialismo e l’idea del tutto: Ivi, pp. 56-79).
209Ontologia e temporalitàSpinoza e i suoi lettori moderni
sizione che gli animali siano stati originariamente ciò che essi sono nel loro presente: «Quale follia! Non sappiamo nemmeno ciò che sono stati come non sappiamo ciò che diverranno. Il vermicello mi-nuscolo che si agita nel fango si avvia forse verso lo stato di animale superiore; l’animale enorme che ci spaventa per le sue proporzioni s’incammina forse verso lo stato del vermicello, è forse una produ-zione particolare, e momentanea, di questo pianeta»46.
Ne Le Rêve de d’Alembert d’Alembert personaggio, combinando diverse tesi – l’intimo legame tra il tutto e le parti, la necessità di tutto ciò che accade, il divenire universale, la continuità tra tutti gli esseri – , pronuncia le asserzioni trascritte di seguito, in cui tra l’al-tro si può leggere una sorta di “democratizzazione” della natura47:
Io sono dunque tale perché è occorso che fossi tale. Cambiate il tutto, voi mi modificate necessariamente; ma il tutto cambia incessante-mente… L’uomo non è che un effetto comune, il mostro un effetto raro; entrambi ugualmente naturali, ugualmente necessari, ugual-mente nell’ordine universale e generale… Cosa c’è di sorprendente in questo? … Tutti gli esseri circolano gli uni negli altri, conseguen-temente tutte le specie… tutto è in un flusso perpetuo… Ogni ani-male è più o meno uomo; ogni minerale è più o meno pianta; ogni pianta è più o meno animale. Non c’è nulla di preciso nella natura… […] Non siete d’accordo sul fatto che tutto si tiene in natura e che è impossibile che ci sia un vuoto nella catena? Cosa intendete dire con i vostri individui? Non ce ne sono affatto, no, non ce ne sono affat-to… Non c’è che un solo grande individuo, è il tutto. In questo tutto, come in una macchina, in un animale qualsiasi, c’è una parte che voi chiamate in tal modo o in talaltro: ma quando denominate individuo
46 «Si la question de la priorité de l’œuf sur la poule ou de la poule sur l’œuf vous embarrasse, c’est que vous supposez que les animaux ont été originairement ce qu’ils sont à présent. Quelle folie! On se sait non plus ce qu’ils ont été qu’on ne sait qu’ils deviendront. Le vermisseau imperceptible qui s’agite dans la fange s’achemine peut-être à l’état de grand animal; l’animal énorme qui nous épouvante par sa gran-deur s’achemine peut-être à l’état de vermisseau, est peut-être une production par-ticulière, et momentanée, de cette planète» (D. Diderot, Entretien entre d’Alembert et Diderot cit., p. 615; ed. Vernière, pp. 267-268). Si vedano inoltre gli Éléments de physiologie: «Il ne faut pas croire que les animaux ont toujours été et qu’ils reste-ront toujours tels que nous les voyons. C’est l’effet d’un laps éternel de temps, après lequel leur couleur, leur forme semble garder un état stationnaire; mais cet état n’est qu’apparent. L’ordre général de la nature change sans cesse: au milieu de cette vicis-situde la durée de l’espèce peut-elle rester la même? non: il n’y a que la molécule qui demeure éternelle, et inaltérable» (Id., Éléments de physiologie cit., Prima parte, Cap. II, p. 1275). 47 A. Vartanian, The Rêve de D’Alembert: A Bio-Political View, «Diderot Stud-ies» 17 (1973), pp. 41-64, in part. 61.
210 Ontologia e temporalitàSpinoza e i suoi lettori moderni
questa parte del tutto, questo avviene in virtù di un concetto così falso come nel caso in cui, a proposito di un uccello, voi attribuiste il nome di individuo all’ala, a una piuma dell’ala… E voi parlate di essenze, poveri filosofi! Lasciatele perdere le vostre essenze. […] Che cos’è un essere?... La somma di un certo numero di tendenze … E posso io essere altra cosa che una tendenza?... No, io vado verso un termine… E le specie? … Le specie non sono che disposizioni ten-denti a un termine comune che è loro proprio… E la vita? … La vita, una susseguirsi di azioni e di reazioni… Da vivo, agisco e reagisco in quanto aggregato… morto, agisco e reagisco in quanto molecole… Io non muoio dunque?... No, senza dubbio, in questo senso non muoio affatto, né io né qualsiasi altra cosa… Nascere, vivere e trapassare, è un mutare di forme…48.
48 «Je suis donc tel, parce qu’il a fallu que je fusse tel. Changez le tout, vous me changez nécessairement; mais le tout change sans cesse… L’homme n’est qu’un effet commun, le monstre qu’un effet rare; tous les deux également naturels, également nécessaires, également dans l’ordre universel et général. Et qu’est-ce qu’il y a d’éton-nant à cela? … Tous les êtres circulent les uns dans les autres, par conséquent toutes les espèces… tout est en un flux perpétuel… Tout animal est plus ou moins homme; tout minéral est plus ou moins plante; toute plante est plus ou moins animal. Il n’y a rien de précis en nature… Ne convenez-vous pas que tout tient en nature et qu’il est impossible qu’il y ait un vide dans la chaîne? Que voulez-vous donc dire avec vos individus? Il n’y en a point, non, il n’y en a point… Il n’y a qu’un seul grand individu, c’est le tout. Dans ce tout, comme dans une machine, dans un animal quelconque, il y a une partie que vous appellerez telle ou telle: ainsi quand vous donnerez le nom d’individu à cette partie du tout, c’est par un concept aussi faux que si, dans un oiseau, vous donniez le nom d’individu a l’aile, à une plume de l’aile… Et vous parlez d’essences, pauvres philosophes! laissez là vos essences. […] Qu’est-ce qu’un être?... La somme d’un certain nombre de tendances… Est-ce que je puis être autre chose qu’une tendance?... non, je vais à un terme… Et les espèces?… Les espèces ne sont que des tendances à un terme commun qui leur est propre… Et la vie?... La vie, une suite d’actions et réactions… Vivant, j’agis et je réagis en masse… mort, j’agis et je réagis en molécules… Je ne meurs donc point?... Non sans doute, je ne meurs point en ce sens, ni moi, ni quoi que ce soit… Naître, vivre et passer, c’est changer des formes…» (D. Diderot, Le Rêve de d’Alembert cit., pp. 636-637; ed. Vernière, pp. 310-312). Sulla questione della necessità universale, evocata all’inizio da d’Alembert sognante, è da tener presente che, come Bordeu chiarisce a Mademoiselle de Lespi-nasse, le decisioni e le azioni umane non sfuggono a questa legge: «La volonté naît toujours de quelque motif intérieur ou extérieur, de quelque impression présente, de quelque réminiscence du passé, de quelque passion, de quelque projet dans l’avenir. Après cela je ne vous dirai de la liberté qu’un mot, c’est que la dernière de nos actions est l’effet nécessaire d’une cause une: nous, très compliquée, mais une» (Ivi, p. 664; ed. Vernière, p. 363). Cfr. anche Id., Éléments de physiologie cit., Terza parte, Cap. VI, pp. 1298-1299). Sulla necessità in Spinoza rinviamo a due luoghi del primo libro dell’Etica. «Proposizione XXXII. La volontà non può essere chiamata causa libera, ma solo causa necessaria. Dimostrazione. La volontà, allo stesso modo dell’intellet-to, è soltanto un certo modo del pensare; e perciò (per la Prop. 28) ciascuna volizio-ne non può esistere né essere determinata ad operare se non determinata da un’altra
211Ontologia e temporalitàSpinoza e i suoi lettori moderni
L’idea del tutto, l’idea del cosmo come un solo individuo sem-bra riallacciarsi al materialismo vitalistico di origine stoica. Que-sta filiazione è stata sostenuta con forza, recentemente, da Marian Skrzypek (che su tale concezione del cosmo richiama anche Seno-fane e Parmenide)49, ma era già stata ipotizzata da Vernière nella sua edizione delle opere filosofiche di Diderot. Tuttavia, Vernière non esclude la possibilità che sulla genesi di questa idea incida una certa interpretazione dell’Etica di Spinoza, diffusa ai tempi di Di-derot ma certamente oppugnabile, che ravvisa un ateismo nasco-sto nell’assimilazione di Dio e natura e confonde i ‘modi’ spinoziani con le parti di un tutto50. A mio parere, la provenienza spinoziana di questa concezione è più che plausibile, e trova riscontro negli stes-si testi del filosofo olandese. Penso in particolare al secondo libro dell’Etica, Lemma VII, scolio: «[…] tutta la natura [tota Natura] è un solo Individuo, le cui parti, cioè tutti i corpi, variano in infiniti modi senz’alcun cangiamento dell’Individuo totale»51. D’altra par-te, la concezione dell’universo come un unico individuo – eterno e immutabile nel mutare delle parti – non si declina unicamente nella versione del materialismo vitalistico degli stoici antichi; basti pen-sare che Radetti, nelle sue note alla traduzione dell’Etica di Duran-te, fa risalire questa concezione attestata negli scritti di Spinoza alla tradizione platonica rinascimentale (ad esempio Leone Ebreo) e a Gassendi52.
causa, e questa alla sua volta da un’altra, e così via all’infinito» (Eth. II, pr. 32, dem, tr. it. cit., pp. 72-73). «Dalla necessità della natura divina devono seguire infinite cose, in infiniti modi (cioè tutto quello che può cadere sotto un intelletto infinito)» (Eth I, pr. 16, tr. it. cit., pp. 42-43).49 M. Skrzypek, Les catégories centrales de la philosophie de Diderot, «Recher-ches sur Diderot et l’Encyclopédie» 26 (1999), pp. 27-36, in part. 28-29.50 P. Vernière, Notes a D. Diderot, Œuvres philosophiques cit., p. 312, n. 1. È nota d’altro canto la posizione di Vernière sui rapporti tra Diderot e Spinoza. «Nous retrouverons une exacte conjonction entre les grandes thèses spinozistes et la doc-trine propre de Diderot; il serait vain de rapporter ce matérialisme expérimental à l’atomisme antique, à Lucrèce et Épicure, quand Diderot lui-même insistera sur l’ascendance réelle trop méconnue» (P. Vernière, Spinoza et la pensée française… cit., p. 603).51 Eth II, lem. 7, schol., tr. it. cit., pp. 146-147.52 G. Gentile-G. Radetti, Note a B. Spinoza, Etica cit., pp. 744-745, n. 64. Radetti fa notare inoltre che l’uso del sintagma «tota Natura» per indicare la totalità dei modi corporei è in contrasto con la nota formula «Deus sive natura» e con le esplicite dichirazioni di Spinoza. Radetti cita come esempio il Trattato teologio-politico, cap. VI: «NB. Me hic per Naturam non intelligere solam materiam, ejusque affectiones, sed praeter materiam, alia infinita» [TTP VI, ed. Cura di A. Dini, Milano, Bompiani, 20042, p. 240] (Ivi, p. 745).
212 Ontologia e temporalitàSpinoza e i suoi lettori moderni
Al di là dell’ascendenza della tesi di Diderot, occorre segnalare, alla luce di quanto considerato, la distinzione ontologica tra il piano della totalità (il solo grande individuo) e il piano delle parti, che non possono a rigore essere considerate individui proprio nella misura in cui sono parti che esistono in funzione del tutto e non autonoma-mente da esso. D’altronde, Diderot suggerisce che le singole parti del tutto sono a loro volta costituite da parti – l’ala è parte rispetto all’uccello, la piuma rispetto all’ala – , ma resta chiaro che tutt’altra cosa è il piano della totalità, dell’unico grande individuo.
Analizzando il Rêve de d’Alembert, Vernière riconosce in un passo importante del testo la presenza dell’argomento elaborato da Bayle53 e Fénélon contro il Dio spinoziano: «[…] poiché egli [il Deus sive Natura] sarebbe materia dell’universo, porzione dell’universo, soggetto a vicissitudini, egli invecchierebbe, morirebbe»54. Questo argomento, diffuso nella libellistica antispinoziana, è ripreso da Di-derot nella voce ‘Spinoza’ dell’Enciclopedia, la cui sincerità è però tutt’altro che indubbia, a parere di Vernière55. Il ricorso a questo giu-dizio critico del Dio di Spinoza – ovvero di una certa versione volga-rizzata dell’ontologia spinoziana – resta nondimeno problematico, a mio avviso, per due ragioni. In primo luogo, chi esprime questa confutazione del Dio spinoziano, semplificando e snaturando il pen-siero di Spinoza, è il dottor Bordeu, che non è sempre e comunque portavoce o personaggio dietro cui si cela Diderot56. In secondo luo-
53 Concepire Dio come esteso significa – sostiene Bayle – toglierli la sua sempli-cità, renderlo composto di un numero infinito di parti e ridurlo alla condizione della materia. «Chi dice materia, dice teatro di ogni genere di cambiamento, campo di battaglia di cause contrarie, soggetto di tutte le corruzioni e di tutti i nascimenti, in una parola, l’essere la cui natura è la più incompatibile con la immutabilità di Dio». «[…] il Dio degli spinozisti è una natura attualmente cangiante, che passa continua-mente per diversi stadi, i quali differiscono interiormente e realmente gli uni dagli altri» (P. Bayle, Dizionario storico e critico. Spinoza cit., pp. 82-83, 84).54 «[…] mais puisqu’il [le Dieu sive Natura] serait matière dans l’univers, portion de l’univers, sujet à vicissitudes, il vieillirait, il mourrait» (D. Diderot, Le Rêve de d’Alembert cit., p. 639; ed. Vernière, p. 317).55 P. Vernière, Notes a D. Diderot, Œuvres philosophiques cit., p. 317, n. 2. Quanto alla presenza dell’argomento ne Le Rêve de d’Alembert, Vernière scrive : «Sans inquiétude, Diderot reprend la critique baylienne du Dieu de Spinoza, mais pour trouver dans la science de son temps et dans le rêve métaphysique de quoi confirmer la logique géométrique de l’Éthique» (Id., Spinoza et la pensée fran-çaise… cit., II, p. 599).56 «Comme, d’ailleurs, Diderot n’intervient pas en personnage dans les deux derniers dialogues de la trilogie, et que, pourtant, il veut se faire entendre, il ne lui reste plus, après avoir fait de d’Alembert le porte-parole de son Rêve – théorie sur l’origine des êtres –, qu’à se substituer parfois à Bordeu» (Y. Belaval, Études sur Di-
213Ontologia e temporalitàSpinoza e i suoi lettori moderni
go, l’argomento per cui Dio – essendo identico alla materia, alla na-tura – si modifica, invecchia, muore, si scontra con una precedente tesi espressa da d’Alembert sognante (è a lui che Diderot, come si legge in una lettera a Sophie Volland, affida il suo pensiero57): se tutto cambia, il tutto resta58. Quest’ultima affermazione suggerisce, sul piano ontologico, una duplicazione di livelli: il tutto che non pe-risce/le parti che cambiano incessantemente. Se la natura-tutto non è intaccata dalle modificazioni che subiscono le sue parti, non c’è il rischio di introdurre l’invecchiamento e il perire sul piano della totalità.
Vernière richiama poi la lettera di Spinoza ad Oldenburg del 20 novembre 1665: «Le Rêve de d’Alembert demeure un rêve, mais il faut bien reconnaître chez Diderot une conception vitaliste de l’univers que certaines lettres de Spinoza justifiaient, même si son acceptation intellectuelle du panthéisme et son image baroque de l’immense araignée étreignant l’univers ne sont que jeux d’esprit»59. Nondimeno, se consideriamo attentamente la lettera chiamata in causa da Vernière, possiamo cogliere negli sviluppi dell’argomen-tazione spinoziana non tanto (o non soltanto) possibili spunti per sostenere l’idea di un vitalismo universale, quanto le affermazioni sull’intima connessione delle parti al tutto, sulla diversità dei modi con cui le parti dell’universo sono governate60, sulle variazioni infi-nite che subiscono le parti. Si tratta di tesi che rivelano grande inte-resse nell’elaborazione che, come si è visto, ne ha fatto Diderot. Ma leggiamo Spinoza:
derot cit., p. 195). «Mais tandis que Platon respecte l’unité de personnage, Diderot, lui, ne reste pas longtemps seul à seul avec un interlocuteur réinventé: le décousu de la conversation semble entraîner le décousu du personnage. C’est Bordeu; non, c’est Diderot. C’est Julie de Lespinasse, non, c’est Sophie Volland. C’est d’Alembert; non, c’est encore Diderot qui réplique à soi-même» (Ivi, p. 201).57 «Il y a quelque adresse à avoir mis mes idées dans la bouche d’un homme qui rêve. Il faut souvent donner à la sagesse l’air de la folie afin de lui procurer ses entrées» (D. Diderot, Lettre à Sophie Volland, 31 août 1769, in Id., Œuvres, V cit., p. 969).58 «Tout change, tout passe, il n’y a que le tout qui reste. Le monde commence et finit sana cesse; il est à chaque instant à son commencement et à sa fin; il n’en a jamais eu d’autre, et n’en aura jamais d’autre» (D. Diderot, Le Rêve de d’Alembert cit., p. 631; ed. Vernière, pp. 299-300).59 P. Vernière, Spinoza et la pensée française… cit., p. 599.60 Non è arbitrario richiamare a riguardo la tesi degli Éléments de physiologie, precedentemente citata, secondo cui l’ordine generale della natura muta incessan-temente: c’è dunque eterogeneità nel governo delle parti dell’universo e nei loro rapporti reciproci.
214 Ontologia e temporalitàSpinoza e i suoi lettori moderni
Ora, siccome tutti i corpi della natura si possono e si debbono con-cepire a quel modo in cui abbiamo concepito qui il sangue, altri reci-procamente determinati a esistere e a operare secondo una certa de-terminata maniera, da tutti insieme costantemente osservata in ogni circostanza, di qui segue che ogni corpo, in quanto esiste modificato in un certo modo, deve essere considerato come parte dell’intero universo, convenire col suo tutto e connettersi con tutti gli altri. E poiché la natura dell’universo non è, come quella del sangue, limita-ta, ma assolutamente infinita, le sue parti sono governate in infiniti modi da questa natura di infinita potenza e sono costrette a subire variazioni infinite. Ma in ordine alla sostanza io penso che ciascuna parte abbia col suo tutto una più stretta unione. Infatti, nella prima lettera ch’io vi ho scritto quando abitavo ancora a Rheinburg, ho ac-cettato di dimostrare che, essendo della natura della sostanza di es-sere infinita, per conseguenza ciascuna parte appartiene alla natura della sostanza corporea, senza la quale non può né essere né essere concepita61.
Questa lettera è da mettere in rapporto con quella inviata a Schul-ler dieci anni dopo (1675)62 e con lo scolio del lemma VII del secondo libro dell’Etica, già ricordato, dove Spinoza, a conclusione della sua argomentazione, scrive che tutta la natura è un solo individuo, le cui parti, ovvero i corpi, si modificano in infiniti modi senza che l’insie-me, il tutto, subisca alcuna alterazione63.
Nell’ampio brano della Lettera XXXII a Oldenburg, oltre a ricor-dare l’intima connessione delle parti al tutto – il che significa, dal lato dei corpi, che ogni corpo è parte dell’universo, conviene con il suo tutto ed è inscindibile da tutti gli altri corpi64 – , Spinoza mette
61 Ep. 32, Spinoza a Oldenburg, Voorburg 20 novembre 1665, tr. it. in B. Spinoza, Epistolario, a cura di A. Droetto, Torino, Einaudi, 1951, 1974, p. 170.62 Quando Spinoza scrive che le parti della natura dell’universo sono governate in infiniti modi da questa natura di infinita potenza e sono costrette a subire variazioni infinite, è possibile che si stia pensando alla Facies totius Universi, modo infinito mediato dell’attributo estensione a cui accennerà nella lettera a Schuller: «Infine, gli esempi che chiedete del primo genere sono: nel pensiero l’intelletto assolutamente infinito; nell’estensione il movimento e la quiete. Del secondo genere, invece, la fac-cia di tutto l’universo la quale, benché varii in infiniti modi, rimane tuttavia sempre la medesima» (Ep. 65, Spinoza a Schuller, L’Aja, 29 luglio 1675, tr. it. cit., p. 260).63 Eth II, lem. 7, schol., tr. it. cit., pp. 146-147.64 Nel caso della mente, il rapporto con il tutto è così spiegato: «E in quanto alla mente umana, anch’essa io la considero parte della natura, in quanto affermo che in natura si dà anche una potenza infinita di pensiero, la quale in quanto infinita, contiene in sé obiettivamente tutta la natura e i suoi pensieri procedono allo stesso modo della natura, che è il suo ideato. Affermo poi che la mente umana è questa stessa potenza, non in quanto infinita e comprensiva di tutta la natura, ma in quanto
215Ontologia e temporalitàSpinoza e i suoi lettori moderni
in luce la varietà dell’universo sia dal punto di vista delle leggi che regolano le sue parti sia dalla prospettiva delle modificazioni che queste parti subiscono. Qui troviamo qualche punto di incontro con il pensatore francese. Diderot, infatti, da un lato, fa emergere una natura-tutto che sola permane; dall’altro, coglie, all’interno della stessa totalità, un flusso perpetuo, un’infinità di modificazioni. Dal-la prospettiva del philosophe, tuttavia, il pensiero non è rappresen-tazione di una dimensione parallela o potenza che contiene in sé obiettivamente – cioè rappresentativamente – tutta la natura, ma una modificazione della materia stessa, una delle sue infinite varia-zioni che si producono successivamente, nel tempo, ovvero, come indicano gli Éléments de physiologie65, un prodotto dell’organiz-zazione della materia. E se per Spinoza ciascuna parte appartiene alla Sostanza, senza la quale non può essere né essere concepita, Diderot – lo si è ricordato – ammonisce che senza tutto non c’è fi-
finita ossia in quanto comprende soltanto il corpo umano, e in questo senso dico che la mente umana è parte di un intelletto infinito» (Ep. 32, tr. it. cit., p. 170).65 Negli Éléments de physiologie – opera dalla genesi complessa e di lunga du-rata, a cui l’autore comincia a dedicarsi nel 1774 – Diderot riprende la tesi fonda-mentale della catena continua delle specie e dei regni, sviluppata a partire dagli anni 1749-1750. C’è però una seconda idea portante in quest’opera da mettere in luce: la vita appartiene alla materia, la vita molecolare è eterna. La terza tesi di questo mate-rialismo biologico stabilisce la dipendenza stretta dello psichico e del fisico provata dagli esempi dei traumi cranici che modificano la vita intellettuale e affettiva o delle malattie psicosomatiche. Si riscontra, poi, che l’autore – con termini quasi identici a quelli del giugno 1756 («Regardez-y de près, et vous verrez que le mot liberté est un mot vide de sens; qu’il n’y a point, et qu’il ne peut y avoir d’êtres libres; que nous ne sommes que ce qui convient à l’ordre général, à l’organisation, à l’éducation, et à la chaîne des événements. […] Il n’y a qu’une sorte de causes à proprement parler: ce sont les causes physiques. Il n’y a qu’une sorte de nécessité, c’est la même pour tous les êtres, quelque distinction qu’il nous plaise d’établir entre eux, ou qui y soit réellement» (D. Diderot, Lettre à Paul Landois, 29 juin 1756, in Id., Œuvres cit., V, pp. 56-57) – propende per il determinismo universale e per l’assenza di una volontà libertà. Tra le novità, invece, va segnalata la propensione per l’organicismo – inco-Tra le novità, invece, va segnalata la propensione per l’organicismo – inco-raggiata da Bordeu – che arriva fino a considerare ogni organo come un animale indipendente (si veda l’introduzione di Versini agli Éléments de physiologie nelle Œuvres cit., I, pp. 1257-1258). Tuttavia, anche in questo testo Diderot guarda ancora la natura come una rete di nessi necessari: «Il y a dans la nature des liasions entre les objets et entre les parties d’un objet. Cette liaison est nécessaire» (D. Diderot, Éléments de physiologie cit., Terza parte, Cap. II, p. 1285). Questa connessione deve essere rispecchaiata dalla concatenazione delle nostre idee – fermo restando che il pensiero, il giudizio nasce dall’azione dei sensi (sui quali a loro volta hanno agito gli oggetti) sul cervello, là dove le sensazioni non sono né semplici né momentanee, ma costituiscono piuttosto un «faisceau» (Ivi, p. 1284): «On ne sépare pas sans con-séquence pour le jugement, les objets dont l’enchaînement existe en nature. On ne les conjoint pas sans bizarrerie» (Ivi, p. 1285).
216 Ontologia e temporalitàSpinoza e i suoi lettori moderni
losofia, non c’è, in altri termini, possibilità di pensare quella parti che esistono modificandosi incessantemente, l’una legata all’altra da nessi necessari, all’interno della totalità. Il tutto, se da un lato sembra tradurre nel linguaggio dell’autore di Jaques le fataliste la Sostanza spinoziana interpretata in chiave materialistica, dall’altro assume la funzione logica di idea-guida e idea-limite che permette di pensare le modificazioni della natura come fatti non isolabili da un orizzonte più esteso (e di volta in volta ulteriormente estendibi-le) e necessariamente connessi l’un l’altro, là dove la connessione si rivela tanto logica (nesso causa-effetto, nesso parte-tutto) quanto temporale (successione dei fenomeni, passaggio dalla materia inerte alla vita, alla memoria, alla coscienza, all’intelletto). Coniugandosi con l’ipotesi della sensibilità66 come proprietà strutturale della ma-teria e con l’idea che la natura ha una storia di cui buona parte delle tappe non sono a nostra disposizione, l’idea del tutto accoglie dun-que l’esigenza di pensare l’unitarietà della natura senza sacrificarne l’eterogeneità e la processualità.
66 Nella Réfutation d’Helvétius Diderot riconosce che la sensibilità generale delle molecole della materia è una supposizione: «[…] la sensibilité générale des molécu-les de la matière n’est qu’une supposition, qui tire toute sa force des difficultés dont elle débarrasse, ce qui ne suffit pas en bonne philosophie» (D. Diderot, Réfutation d’Helvétius, in Œuvres cit., I, p. 798).