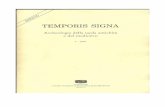Alvaro Siza: la ricostruzione del quartiere Chiado a Lisbona / The reconstruction of Chiado, Lisbon
La ricostruzione paleoambientale e dei manufatti archeologici
-
Upload
unisalento -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of La ricostruzione paleoambientale e dei manufatti archeologici
isbn 9788890334603 prima di Carpignano. Documentazione e interpretazione di una sepoltura neolitica 103
LA RICOSTRUZIONE PALEOAMBIENTALE E DEI MANUFATTI ARCHEOLOGICI
INTRODUZIONE La Paleoecologia è una disciplina di formazione più o meno recente, fondata sulla
collaborazione tra le “scienze della Terra” (geologia, geomorfologia, mineralogia, pedologia, paleobotanica, paleontologia dei vertebrati, etc.) e le discipline bio-archeologiche, paletnologiche ed etno-archeologiche. Le innovazioni metodologiche degli ultimi decenni (New Archaeology, archeologia contestuale e “post-processuale”) hanno infatti dimostrato che il quadro di interazioni entro cui gli organismi biologici, l’uomo in particolare, e l’ambiente fisico si sono sviluppati nel corso del tempo può essere coerentemente ricostruito solo attraverso una complessa “combinazione” tra aspetti “fisici” (cicli climatici, biogeografia del pianeta, etc.) e aspetti tendenzialmente più “immateriali” (assetti etno-culturali delle civiltà antiche, elaborazione e trasmissione di prototipi ideologici e tecnologici, etc.).
Gli studi paleoambientali sono ostacolati sia dai limiti documentari dei singoli campi d’indagine interessati, sia dalle difficoltà “strutturali” di convivenza tra saperi più o meno ben differenziati dal punto di vista degli obiettivi e degli strumenti di ricerca.
La definizione dell’Etnoarcheologia come approccio autonomo all’analisi dell’articolazione socio-economica e della sfera spirituale delle società del passato (BINFORD 1962, 1978, 1989) è connessa a vari livelli all’affermazione dell’Archeologia Sperimentale (SEMENOV 1964; COLES 1973). La prima interpreta specifiche realtà preistoriche o protostoriche sulla base di modelli “comparativi” di matrice etnoantropologica, mentre la seconda è più “empiricamente” finalizzata alla riproduzione di processi lavorativi e di sistemi costruttivi desunti dalle evidenze archeologiche e dall’eventuale analogia tra queste e la cultura materiale degli attuali “popoli primitivi” (per un’ampia rassegna bibliografica, CAZZELLA 1999).
La frequente inadeguatezza quantitativa e qualitativa dei dati disponibili limita notevolmente anche le potenzialità delle tecniche di rappresentazione grafica degli habitat antichi. Tuttavia, anche nei casi in cui non si disponga di fonti archeologiche o storico-letterarie sufficienti per delineare le peculiarità ecologiche e culturali di un determinato contesto spazio-temporale, la ricostruzione ambientale dello stesso dovrà essere condotta entro limiti di attendibilità, bilanciando le scarne e frammentarie nozioni acquisite e le capacità pratiche e intuitive del disegnatore (FERRI, MORA 1996).
Mentre in ambito divulgativo e museale sono ormai ampiamente diffuse svariate e non sempre plausibili tipologie di rappresentazione bidimensionale o tridimensionale (realtà virtuale) degli antichi ecosistemi, il ricorso sistematico all’indagine paleoambientale risulta ancora scarsamente attestato nella prassi delle ricerche archeologiche.
Il perseguimento di una resa grafica chiara e “ottimale” (capacità di comunicazione) e l’adozione di uno stile “appropriato” (impatto) sono, comunque, elementi fondamentali e imprescindibili sia per le ricostruzioni di carattere “scientifico” che per quelle di indirizzo più propriamente “divulgativo”. Tra le tecniche grafiche maggiormente utilizzate, si possono distinguere lo stile antiquario di tradizione ottocentesca, quello realistico e quello vignettistico, raramente applicato ma di particolare efficacia espressiva (per una sintesi sull’argomento cfr., in particolare, MEDRI 2003).
Le attività di scavo, studio e musealizzazione della sepoltura tardo-preistorica di Carpignano hanno previsto anche la riproduzione grafica in chiave “realistica” del contesto paleoambientale di riferimento e la creazione sperimentale di repliche funzionanti di alcuni manufatti recuperati.
LUIGI COLUCCIA La ricostruzione paleoambientale e dei manufatti archeologici
104 prima di Carpignano. Documentazione e interpretazione di una sepoltura neolitica isbn 9788890334603
La proposta di ricostruzione del “paesaggio neolitico” di Carpignano è realizzata con tecnica “a carboncino” su carta da disegno per ornato (formato 50x70 cm). I vantaggi di questa scelta grafica sono sintetizzabili nella necessità di contenimento dei costi, nella relativa rapidità dei tempi di esecuzione e nell’ottimizzazione degli spazi espositivi. L’elaborato definitivo, infatti, è costituito da un ingrandimento a stampa in scala 3:1 del disegno originale, applicato su un supporto verticale poco ingombrante (pannello di m 1x2). LA RICOSTRUZIONE DEL PALEOAMBIENTE: IL CASO SPECIFICO
L’attuale centro urbano di Carpignano Salentino (quota s.l.m. 90-75 m) occupa una posizione leggermente elevata rispetto al territorio circostante e controlla verso S-E un’ampia bassura con livello medio di 65-60 m s.l.m. La sepoltura indagata nel 2001 è collocata su una bassa scarpata in posizione intermedia tra questi dettagli del paesaggio.
L’analisi geomorfologica dell’area suggerisce l’esistenza in antico (Pliocene medio-superiore) di un ambiente peripalustre o, comunque, a microclima di tipo umido (MARGIOTTA, MARTANO, WALSH 1987; SANSÒ, SELLERI, in questo volume). Le variazioni climatiche registrate per le epoche successive possono aver creato condizioni microambientali favorevoli allo sfruttamento agricolo dei suoli.
Le ricerche archeobotaniche relative all’indagine della tomba neolitica di Carpignano (FIORENTINO, PRIMAVERA, in questo volume) documentano la presenza di scarsi resti di cariossidi (Triticum, Hordeum) e di specie xerofile tipiche della macchia mediterranea (olivastro, lentisco). I dati acquisiti sembrano confermare le ipotesi avanzate in merito alla transizione da un regime caldo-umido, tipico del Neolitico Medio, a uno tendenzialmente più arido, che perdurerà sino all’età del Bronzo rivelandosi più adatto del precedente alla diffusione della cerealicoltura (CALDARA, PENNETTA 2002). I siti neolitici meridionali evidenziano una grande varietà nelle produzioni cerealicole, testimoniando l’attenzione delle comunità di agricoltori nel verificare la compatibilità tra le diverse specie vegetali e le caratteristiche pedologiche dei nuovi territori assoggettati alla coltivazione (FIORENTINO 2002).
Occorre tuttavia considerare anche alcuni limiti interpretativi di carattere generale, riconducibili alla “specificità” delle evidenze funerarie: infatti, la frequenza percentuale di determinati esemplari faunistici e botanici all’interno di questi contesti può non riflettere l’effettivo quadro ambientale antico, risultando almeno in parte condizionata da particolari implicazioni ideologiche o rituali.
La sepoltura di Carpignano costituisce al momento l’unico esempio salentino di tomba “a grotticella” attribuibile al V millenno a.C. In realtà, resti di una sepoltura simile, ubicata a pochi metri dalla prima, sono stati messi in luce durante lavori d’emergenza condotti nel 2003 (v. brevi note preliminari in INGRAVALLO, TIBERI 2008). Questi importanti rinvenimenti consentono di retrodatare l’insorgenza di questa tradizione funeraria, precedentemente riferita ai momenti finali della cultura di Diana sulla base del ritrovamento di un analogo contesto sepolcrale ad Arnesano (LO PORTO 1972).
Nonostante l’estrema frammentarietà dei dati disponibili in merito agli orizzonti medio e finale del Neolitico nella Puglia meridionale, è ipotizzabile un progressivo aumento demografico e una parziale accentuazione della complessità socio-economica e culturale dei gruppi stanziati nell’ambito geografico e cronologico considerato (CREMONESI 1986). Tali processi si riflettono non soltanto nel coinvolgimento di queste genti nei principali circuiti internazionali di prestiti e scambi, ma anche nell’affermazione di monumentali manifestazioni funerarie e cultuali di tipo megalitico o ipogeico (per una sintesi e un’aggiornata rassegna bibliografica sulle tematiche trattate: MANFREDINI 2001; INGRAVALLO 2004; INGRAVALLO, TIBERI 2008).
Analizzando nel dettaglio la ricostruzione proposta, si può notare che la prima scelta operata è stata individuare un punto di vista prospettico del paesaggio da rappresentare. L’osservatore è più o meno al centro dell’ampia bassura sopra descritta, con lo sguardo rivolto in direzione della piccola altura a S-W (fig. 1). Pur in assenza di informazioni relative all’insediamento coevo al contesto funerario indagato, si è optato per l’ubicazione di un piccolo nucleo di capanne in corrispondenza del rilievo occupato dal centro storico, considerandone la posizione dominante e strategicamente valida.
LUIGI COLUCCIA La ricostruzione paleoambientale e dei manufatti archeologici
isbn 9788890334603 prima di Carpignano. Documentazione e interpretazione di una sepoltura neolitica 105
1. Ricostruzione paleoambientale del sito e del territorio di Carpignano Salentino (L. Coluccia 2003).
LUIGI COLUCCIA La ricostruzione paleoambientale e dei manufatti archeologici
106 prima di Carpignano. Documentazione e interpretazione di una sepoltura neolitica isbn 9788890334603
In tutto il Salento non esistono siti del Neolitico che siano stati scavati estensivamente e che abbiano permesso, ad esempio, di definire modelli e tipologie di organizzazione territoriale o di cogliere il rapporto spaziale tra necropoli e villaggi. Allo stato delle ricerche, le uniche tracce di strutture abitative edite per quanto concerne l’area considerata provengono da Sant’Anna (Oria) nel Brindisino (INGRAVALLO 1996; ORLANDO 1996; INGRAVALLO 1997; cfr., inoltre, TIBERI 2007 e, in particolare, il tentativo di ricostruzione virtuale delle stesse evidenze, GABELLONE 2007).
Il quadro documentario risulta meno lacunoso in relazione alla Puglia centrale, dove sono state individuate sepolture in grotta o di altra tipologia all’interno di fossati difensivi in disuso, riferibili a fasi insediative più antiche. Nello stessa zona, inoltre, sono noti diversi ipogei funerari a carattere monumentale, databili a partire dal Neolitico Medio. Si segnala, ad esempio, l’ipogeo Manfredi (Polignano a Mare, Bari), realizzato in questo orizzonte cronologico lungo il perimetro occidentale del sito di Santa Barbara. I livelli più tardi riferibili a questo contesto sembrano documentarne la “ri-frequentazione” a scopo cultuale nel corso del Neolitico Finale (facies Diana-Bellavista). Altri casi simili sono: Grotta Pacelli (Castellana Grotte, Bari), Cala Scizzo e Cala Colombo (Torre a Mare, Bari), etc. (GENIOLA 1987).
Di notevole interesse sono anche le evidenze funerarie recentemente indagate a Serra Cicora (Nardò, Lecce). Il sito, esteso su un pianoro paralitorale collocato ad una quota media di 45 m s.l.m., domina un ampio tratto del litorale ionico salentino. La frequentazione dell’area copre un arco cronologico che, senza soluzione di continuità, abbraccia le fasi neolitiche dal momento iniziale a ceramica impressa fino agli aspetti centrali e finali di Serra d’Alto e Diana. Le fasi più antiche sono mal conservate e difficilmente interpretabili. A partire dal V millennio a.C. si registra, invece, un’esclusiva destinazione a pratiche di carattere sepolcrale e rituale (INGRAVALLO
2004; INGRAVALLO, TIBERI 2008). I pochi dati disponibili in merito alle consuetudini funerarie delle comunità neolitiche dell’Italia
sud-orientale possono avallare l’ipotesi che gli spazi riservati alle attività di seppellimento fossero in qualche maniera distinti rispetto al centro abitato; non è tuttavia chiaro se ciò determinasse una vera e propria separazione “fisica” tra i due settori. L’ubicazione delle necropoli era, inoltre, plausibilmente condizionata da fattori di natura socio-politica e ideologica: alle manifestazioni funerarie, espressioni simboliche di autoidentificazione e di appartenenza culturale, era affidato il compito di affermare e giustificare il possesso e la gestione di un determinato territorio (MANFREDINI 2001).
Nella ricostruzione del paesaggio antico di Carpignano, la necropoli è stata ipoteticamente inserita ai margini del villaggio. Gli ingressi delle tombe “a grotticella” si aprono su un leggero salto di quota morfologicamente adatto a isolare e proteggere l’altura soprastante. È utile segnalare che nel Salento non sono attestate strutture di difesa simili ai fossati dei villaggi neolitici della Puglia settentrionale e centrale; la collocazione degli insediamenti in corrispondenza di luoghi naturalmente “eminenti” potrebbe essere la strategia più comunemente adottata. Indizi in tal senso ricavabili, ad esempio, da alcuni siti baresi del Neolitico finale: Bellaveduta (Mariotto) e Selva di Città (Terlizzi-Bitonto) nell’interno, Titolo (Palese) e Torre S. Agostino (Giovinazzo) in prossimità della costa adriatica (SICOLO 2002).
Per la Puglia meridionale sono da ricordare le scarne evidenze di Cardigliano (Specchia, Lecce), individuate in seguito a ricognizioni non sistematiche (ORLANDO 1997), e quelle già menzionate di Sant’Anna (Oria, Brindisi).
Le capanne e le sepolture ipogeiche di Carpignano occupano volutamente una posizione di secondo piano nel disegno, spiegabile con l’impossibilità di approfondire ulteriormente il dettaglio a causa della scarsità di dati.
Per le stesse ragioni, anche altri importanti elementi del paesaggio sono rappresentati come temi di fondo: si pensi alle raffigurazioni di essenze arboree come le querce caducifogli, la cui presenza nel contesto ambientale indagato è priva di riscontro oggettivo ma ipotizzabile in base al confronto con habitat analoghi.
Un piano di maggior rilievo è assegnato alla riproduzione grafica delle pratiche agricolo-pastorali tipiche dell’economia produttiva neolitica. Queste attività, infatti, sono testimoniate anche dai reperti botanici e faunistici provenienti dalla sepoltura di Via Pasca. In particolare, si segnala la presenza di cariossidi di Hordeum e di Triticum e di resti osteologici riferibili a ovicaprini e, in percentuale minore, a suini.
LUIGI COLUCCIA La ricostruzione paleoambientale e dei manufatti archeologici
isbn 9788890334603 prima di Carpignano. Documentazione e interpretazione di una sepoltura neolitica 107
La scena proposta è incentrata sulle attività di mietitura. Lo strumento utilizzato per queste operazioni è una falce, la cui tecnologia costruttiva verrà esaminata e descritta in seguito. La scelta di assegnare il compito della raccolta a una donna può ritenersi del tutto casuale. Alla luce di più o meno recenti ricerche etnografiche su società “primitive” di agricoltori contemporanei, è ipotizzabile una compartecipazione unanime del gruppo alle principali mansioni lavorative.
Meno fortuita è la rappresentazione del trasporto del bambino sulla schiena della madre. Sempre in ambito etnografico, infatti, sono segnalati esempi simili in quasi tutte le regioni calde del globo. Oltre alla tipologia raffigurata, è piuttosto diffusa anche la modalità di “trasporto sull’anca” (LEROI GOURHAN 1943).
Nella ricostruzione compaiono anche alcuni elementi ascrivibili alla sfera della lavorazione delle fibre vegetali. Il riferimento è al capo tessuto indossato dalla donna e al canestro ai suoi piedi, utilizzato per contenere il raccolto. La tessitura e l’intreccio sono da considerare come due aspetti parzialmente distinti di un medesimo ambito artigianale. Le principali differenze riguardano il diametro delle fibre adoperate per la creazione dell’ordito e la diversa rigidità del prodotto che ne deriva.
La tessitura è nota fin dall’VIII millennio a.C. per le società neolitiche dell’area medio-orientale. Le più antiche materie prime impiegate sono, molto probabilmente, fibre liberiane, ottenute mediante macerazione del libro di alcune essenze arboree quali la quercia, il tiglio, il salice e l’olmo; successivamente si passa all’uso del lino domestico (Linum usitatissimum), che dopo una articolata fase di preparazione (macerazione, separazione tramite gramolatura, battitura e pettinatura) si presta ad essere filato.
Dal IV millennio a.C., le testimonianze relative alla pratica della tessitura del lino nel territorio italiano sono numerose e provengono, per la maggior parte, dai siti lacustri circumalpini. A queste si possono aggiungere le evidenze del primo Neolitico dal sito di La Marmotta, sul lago di Bracciano (FUGAZZOLA DELPINO 1999). I dati acquisiti non consentono ancora di stabilire con chiarezza il livello tecnologico di queste produzioni. Ad esempio, per il Neolitico mancano prove chiare del confezionamento di abiti tessuti. I frammenti rinvenuti, a causa delle loro ridotte dimensioni, non si prestano a valutazioni di questo genere e potrebbero far pensare semplicemente alla realizzazione di tele destinate, forse, ad altri usi. Al contrario, attraverso l’analisi di “veneri” e idoletti fittili rinvenuti in diverse località della penisola è possibile risalire ad alcuni modelli adottati nell’artigianato tessile. Ritenendo plausibile l’esistenza di capi d’abbigliamento tessuti, c’è da ricordare che questi non erano in grado di garantire una protezione adeguata per tutte le stagioni. I rigori dell’inverno, infatti, richiedevano la sostituzione dei tessuti, troppo leggeri, con indumenti più pesanti realizzati probabilmente in pelle (BAZZANELLA
1999). Accanto alla tessitura fioriva anche l’industria del vimine, per la quale venivano utilizzate
graminacee, giunchi o ramoscelli di viburno. L’arte dell’intreccio, antica almeno quanto la tessitura, è sopravvissuta in numerosi contesti artigianali moderni senza significativi cambiamenti nel processo tecnologico, evidenziando in questo il carattere fortemente “conservativo” di una produzione che trova nella manualità e nella semplicità dei materiali adoperati le sue principali prerogative. Il sito di Grotta Santa Croce nel Barese (Neolitico Antico) ha restituito una rara e preziosa testimonianza relativa alla pratica dell’intreccio delle fibre vegetali. Si tratta di un manufatto di forma ovoidale lavorato a spirale (probabile stuoia), che trova precisi confronti nella documentazione etnografica relativa alle regioni dell’Africa equatoriale (BOSCATO, GAMBASSINI, RONCHITELLI 2002). Altri esempi analoghi, di più recente edizione, provengono dal sito lacustre di La Draga, in Catalogna (BOSCH et alii 2006a).
Non compare ancora in questo periodo la lavorazione della lana, che avrà il suo sviluppo a partire dalla prima età dei metalli. Per il Neolitico, tuttavia, è lecito ipotizzare forme di sfruttamento del pelo animale, visto che le specie di ovini esistenti non presentavano il caratteristico vello che è frutto di una lunga selezione realizzatasi nel corso del III millennio a.C. La pecora e la capra sono state importate allo stato domestico nei nostri territori, dove il corrispettivo selvatico non è attestato. Queste specie costituivano essenzialmente una riserva alimentare. Lo testimoniano, in particolare, gli indici di età di morte relativi all’attività di
LUIGI COLUCCIA La ricostruzione paleoambientale e dei manufatti archeologici
108 prima di Carpignano. Documentazione e interpretazione di una sepoltura neolitica isbn 9788890334603
macellazione: l’esame dei resti ossei evidenzia, infatti, la consuetudine di macellare i capi in età adulta, ossia in coincidenza del raggiungimento della taglia definitiva.
Nella scena sono messe in evidenza le caratteristiche anatomiche di alcuni esemplari di pecora, in cui è possibile cogliere una relativa somiglianza con specie attuali come il muflone sardo e corso, rappresentanti di un probabile ritorno alla vita selvatica a partire da forme neolitiche domesticate.
Figura strettamente legata al mondo pastorale e al compito di custodia del bestiame e dei beni è quella del cane domestico: le fattezze fisiche evidenziate dal disegno lo connotano come anatomicamente distinguibile dal corrispondente selvatico, che è il lupo. Il Canis familiaris non rappresenta una riserva alimentare primaria all’interno dei contesti neolitici ed è rappresentato da pochi reperti ossei, alcuni dei quali con tracce di macellazione. Le caratteristiche della specie (piccola taglia, muso accorciato) indiziano un processo di domesticazione di lunga durata (WILKENS 2002). LA RICOSTRUZIONE DEI MANUFATTI
L’ascia a corredo della sepoltura di Carpignano, di tonalità verde scuro tendente al nero è probabilmente foggiata da un ciottolo di ofite, denominazione generica di rocce metamorfiche, basiche o ultrabasiche, come gabbri, serpentini, peridotiti, etc. Si tratta di una materia prima non disponibile in loco, come anche il cinabro utilizzato per trattare alcune ossa e l’ossidiana impiegata per realizzare supporti laminari. Questi dati confermano la molteplicità dei prodotti di scambio in circolazione tra V e IV millennio a.C. nel Salento.
L’industria litica proveniente dal deposito in oggetto ha offerto la possibilità di proporre una ricostruzione sperimentale di alcuni strumenti da lavoro adoperati durante il Neolitico, in particolare una falce e un’ascia. La descrizione dei processi lavorativi e la terminologia adottata per inquadrare le varie categorie funzionali degli utensili sono in gran parte mutuate da LEROI
GOURHAN 1943.
LA FALCE Dai terreni di riempimento della grotticella provengono diverse schegge e lame in selce e
ossidiana. Alcune di queste presentano tipiche tracce di usura traslucida (lustro) compatibili con le attività di taglio degli steli vegetali: è probabile, pertanto, che si tratti di elementi di falcetto. Le tracce suddette, determinabili in alcuni casi ad occhio nudo, sono riconoscibili grazie all’impiego di elementari microscopi, anche di modesta potenza (sull’argomento cfr. CALANI 1997; CALANI 1999; MARTINELLI 2002; GIBAJA, PALOMO 2006).
In ambito preistorico sono documentati diversi tipi di falci. Uno dei più antichi (a guisa di coltello), attestato anteriormente alla domesticazione dei cereali, è costituito da una lunga e robusta lama, all’estremità della quale è ricavata l’impugnatura, mediante l’avvolgimento di legacci in fibra vegetale o animale (GUILAINE, COURTIN, MOHEN 1976). Questa, in alcuni casi, poteva essere realizzata con materie dure animali, legno o ceramica appositamente modellata. Altri esemplari a lama singola, invece, sono caratterizzati da un inserimento obliquo all’interno dei manici a formare un angolo funzionale compreso tra i 110 e i 135 gradi circa. Anche un semplice arco in legno, lavorato fino ad ottenere un margine tagliente, poteva essere sufficiente a soddisfare le esigenze lavorative (per una panoramica sulle varie tipologie presenti nei contesti neolitici cfr. BOSCH et alii 2006a).
Per il Neolitico Antico e Medio sono note alcune falci costruite mediante l’inserimento obliquo di più tratti di lama all’interno del manico, con la conseguente determinazione di un profilo funzionale scalariforme (lustro obliquo rispetto al margine). Se, al contrario, l’usura degli elementi di falcetto è distribuita in senso longitudinale, avremo un bordo rettilineo (lustro parallelo rispetto al margine). Queste forme di immanicatura necessitavano di un definitivo fissaggio per mezzo di un mastice a base di resina vegetale (cfr. ad esempio ACANFORA 1970). Opportunamente sciolto a caldo, veniva applicato semi liquido per la comentatura tra lame e fenditura del legno. Gli stessi accorgimenti sono stati adottati nella costruzione sperimentale della falce: si è utilizzato un ramo incurvato di Quercus calliprinos (quercia spinosa), che per lunghezza e diametro meglio rispondeva all’impiego richiesto. Dopo una preventiva fase di scortecciamento, si è praticata, nella porzione opposta al manico, una scanalatura longitudinale
LUIGI COLUCCIA La ricostruzione paleoambientale e dei manufatti archeologici
isbn 9788890334603 prima di Carpignano. Documentazione e interpretazione di una sepoltura neolitica 109
utile all’inserimento degli elementi litici. Questi, opportunamente ricavati da un nucleo di selce, sono stati ritoccati e volutamente troncati al fine di ottenere dei tratti di lama più facilmente alloggiabili all’interno del taglio sopra descritto. Il margine prescelto è di tipo rettilineo (fig. 2).
La preparazione dei tratti di lama in selce ha richiesto circa 2 ore di lavoro, alle quali si aggiungono 4-5 ore per la costruzione del manico e circa 1 ora per le operazioni di fissaggio dei pezzi e per la finitura dello strumento con pietra abrasiva tipo grès.
2. Replica della falce neolitica prodotta sperimentalmente (L. Coluccia 2003).
L’ASCIA L’ipotesi di ricostruzione proposta per l’ascia si basa sull’osservazione dei tratti distintivi del
manufatto in pietra levigata rinvenuto tra i rari oggetti di corredo della tomba di Carpignano (fig. 3).
Il vocabolo “ascia” definisce un utensile per smussare e abbozzare il legname con margine tagliente (filo) perpendicolare all’asse del manico. Nella letteratura archeologica corrente lo stesso termine include anche l’“accetta”. Questa erronea sovrapposizione determina una certa approssimazione nella classificazione morfologica dei diversi manufatti. L’“accetta”, infatti, è un utensile adoperato per sgrossare, togliere i rami, fendere rapidamente i pezzi di taglia media; presenta un margine tagliente parallelo all’asse del manico e in vista frontale, una lama con due tagli obliqui simmetrici.
Sia l’“ascia” che l’“accetta” rientrano, comunque, nell’ambito delle cosiddette “percussioni lanciate”, ulteriormente distinguibili in perpendicolari e oblique.
L’esame morfologico e tipologico del reperto di Carpignano offre lo spunto per ulteriori osservazioni. Il margine tagliente, determinato dall’incontro delle due facce, superiore ed inferiore, presenta in vista frontale un andamento curvilineo. La distinzione terminologica tra faccia “superiore” e “inferiore” deriva dalla posizione assunta dall’ascia in fase di lavoro (“percussione lanciata obliqua”).
La faccia superiore ha un profilo convesso in vista laterale, con una più marcata curvatura sull’estremità distale coincidente con il margine funzionale. In questo tratto si concentrano e si identificano anche ad occhio nudo dei leggeri e sottili solchi, lunghi dai 4 ai 5 mm, con andamento parallelo all’asse longitudinale dello strumento (tracce d’uso). Anche sul piano normale il carattere convesso risulta essere più accentuato rispetto alla faccia inferiore. Quest’ultima, invece, è caratterizza da un profilo laterale e frontale subrettilineo, ad eccezione
LUIGI COLUCCIA La ricostruzione paleoambientale e dei manufatti archeologici
110 prima di Carpignano. Documentazione e interpretazione di una sepoltura neolitica isbn 9788890334603
delle porzioni prossimale (tallone) e distale (filo), attraverso cui si realizza il raccordo con la superficie superiore.
Le modeste dimensioni della lama (lunghezza cm 5,6; larghezza massima cm 4,5) possono indiziare la presenza di un manico particolarmente sviluppato, probabilmente “a gomito”. Bisogna ricordare che nella tipologia di strumenti in esame la lama è per circa 2/3 della sua lunghezza incastrata all’interno dell’immanicatura. Nello strumento finito, infatti, è visibile esclusivamente la piccola porzione di questa coincidente col tratto funzionale.
Disponiamo di numerose informazioni circa l’ampio ricorso a diverse materie organiche (legno, legacci in fibra vegetale etc.) nella realizzazione di questo tipo di attrezzi da lavoro. I dati provengono, nella stragrande maggioranza dei casi, da contesti palustri o da ambienti caratterizzati da fenomeni di conservazione estrema, come i ghiacciai.
Il caso più eclatante, anche se cronologicamente distante dal contesto analizzato, è rappresentato dalla cosiddetta “mummia del Similaun”, scoperta nel 1991 in alta Val Senales, località Giogo di Tisa (Bolzano). Il rinvenimento costituisce una fonte documentaria eccezionale sugli aspetti della vita materiale delle genti neolitiche ed eneolitiche del Nord-Est italiano (DE
MARINIS, BRILLANTE 1998; SPINDLER 1998). Nel corredo mobiliare di questo individuo rientra anche un’ascia. Il manico ligneo è ricavato da un tronco piuttosto lungo (impugnatura), da cui si diparte, quasi ad angolo retto, un ramo robusto coincidente con l’immanicatura della lama. Il legame naturale tra il ramo e il tronco garantisce una resistenza ottimale al manico dell’ascia. Intagliando longitudinalmente l’estremità del legno corrispondente all’immanicatura, si ottiene un profilo biforcuto (forcella) adatto ad ospitare la lama. Proprio l’orientamento di quest’ultimo, perpendicolare o parallelo all’asse del manico, determina la distinzione tra incastro per ascia e incastro per accetta (CLARK 1969).
3. Replica dell’ascia neolitica prodotta sperimentalmente (L. Coluccia 2003).
La tecnologia costruttiva dell’ascia appartenuta all’uomo dei ghiacci è fortemente
condizionata dall’impiego di una lama in rame ben più pesante dell’ascia litica di cui si presenta la ricostruzione. Le lame in metallo prodotte nell’Eneolitico e nella successiva Età del Bronzo (asce piatte e ad alette) si prestano meglio (per forma, peso e articolazione strutturale) a essere immanicate col sistema appena sintetizzato (CARANCINI 1984). L’impugnatura, infatti, è realizzata con il pezzo più consistente del legno adoperato (tronco), delegando al ramo, più esile e leggero, il compito di contenere la lama.
Nel caso di una lama in pietra, poco pesante e di dimensioni ridotte rispetto agli esemplari metallici, bisognerà invertire la disposizione dei pesi e delle parti del legno da impiegare (ramo
LUIGI COLUCCIA La ricostruzione paleoambientale e dei manufatti archeologici
isbn 9788890334603 prima di Carpignano. Documentazione e interpretazione di una sepoltura neolitica 111
per l’impugnatura, tronco per l’immanicatura). Questo secondo tipo di manico è largamente attestato in contesti neolitici, dove di solito a questo scopo venivano utilizzate essenze arboree come il tasso, il frassino o la quercia.
La particolarità di questi reperti è la presenza di un incastro che non è “a forcella”, ma “a 1/2”. Infatti, quando si dispone di una lama adeguatamente lunga, è sufficiente praticare un piano d’appoggio, opportunamente interrotto da un gradino contro cui far scontrare il tallone della stessa, per garantire la necessaria stabilità all’immanicatura. Ne sono un esempio eloquente i manici integri provenienti dal già citato sito neolitico di La Draga (BOSCH et alii 2006b), sebbene quasi sempre privi delle corrispettive lame e dei legacci per il fissaggio. Il modello completo proposto prima (ascia del Similaun) può ovviare, in parte, a questa carenza di dati. In quel caso, strisce di pelle animale non lavorata garantiscono una tenuta ottimale per mezzo di una salda legatura sviluppata tra la lama e un lieve solco intenzionalmente praticato alla base della testa del manico. La pelle impiegata presenta il vantaggio, rispetto al cordame in fibra vegetale, di praticare una forza stringente e progressiva sull’immanicatura durante l’essiccatura. Lo stesso collagene presente nella pelle, inoltre, conferisce nel tempo caratteristiche adesive alla legatura.
Da numerosi contesti transalpini del III millennio a.C. (facies occidentale Seine-Oise-Marne, facies orientale Saône-Rhône) provengono esempi di immanicatura con articolazione del gomito composita (BAILLOUD 1974). La peculiarità di questi reperti, oltre allo straordinario stato di conservazione, è la presenza di un elemento allungato in legno o in materia dura animale, che si frappone tra lama e manico in posizione ortogonale a quest’ultimo.
Nella porzione distale, coincidente con il margine funzionale, viene alloggiata mediante incastro la lama; nella porzione prossimale si realizza l’articolazione con il manico. Solitamente è lo stesso manico (“maschio”) ad occupare il foro (“femmina”) praticato in quella che potremmo definire la “testa” dello strumento. Una variante è rappresentata dall’impiego di una guaina realizzata in palco di cervo, che ospita da un lato la lama e dall’altro si inserisce all’interno del manico. In entrambi i casi, le sollecitazioni impartite in fase di lavorazione all’ascia vengono distribuite e ammortizzate nei vari distretti dello strumento, impedendo che il manico si fenda come invece può accadere quando una lama viene incastrata direttamente al suo interno.
I tipi descritti ricorrono ad un elemento d’interposizione solitamente predisposto all’inserimento di lame a sezione ellittica, evidentemente non adatte per un incastro a faccia piana come quello necessario per la ricostruzione dell’ascia di Carpignano. Seguendo le indicazioni scaturite dai dati sopra esposti, si è proceduto alla costruzione sperimentale del manufatto, previa selezione dei materiali da adoperare, primo tra tutti la pietra. È stato scelto un ciottolo di breccia calcarea metamorfica, raccolto allo stato erratico. Si tratta, infatti, di un supporto analogo all’originale per caratteristiche strutturali.
La prima operazione da compiere è la scheggiatura (diretta e indiretta) della pietra selezionata. Segue la fase di martellinatura, eseguita a mezzo di un ciottolo della stessa materia e funzionale alla preparazione del supporto per la levigatura.
Quest’ultima agisce in “percussione obliqua puntiforme” sulla superficie scabra del supporto e può essere attuata per mezzo di una levigatrice a base fissa o mobile piuttosto tenera (grès o legno). Per una migliore riuscita del processo, risulta utile frapporre uno strato di sabbia inumidita a granelli duri tra la base della levigatrice e le superfici litiche, favorendo il meccanismo di abrasione per attrito nelle zone di contatto.
La riproduzione della pietra levigata, conforme il più possibile all’originale e potenzialmente funzionante, ha richiesto circa 2 ore per la fase di scheggiatura, 1 per la martellinatura e più di 15 per la levigatura e la lucidatura finale.
Il manico, ricavato da un esemplare di Juniperus communis (ginepro), è stato appositamente selezionato per soddisfare le esigenze strutturali dell’immanicatura “a gomito”. Occorre considerare, infatti, che l’angolo naturale tra ramo e tronco deve essere compreso tra i 65 e gli 85 gradi per garantire un corretto funzionamento dell’utensile.
Dopo la fase di preventiva scortecciatura e la realizzazione di un apposito incastro, l’oggetto è stato sgrossato e rifinito su tutta la superficie con l’ausilio di pietre abrasive di grana differente, per un totale di 6 ore lavorative circa. A causa delle ridotte dimensioni della lama, si è optato per un intaglio “a forcella”, più stabile del tipo “a 1/2”.
LUIGI COLUCCIA La ricostruzione paleoambientale e dei manufatti archeologici
112 prima di Carpignano. Documentazione e interpretazione di una sepoltura neolitica isbn 9788890334603
In seguito al posizionamento della lama nell’apposita fenditura, si è provveduto all’esecuzione di una legatura con l’impiego di cordame in fibra vegetale. Il tempo complessivo necessario per costruire lo strumento è stimabile, quindi, in circa 25 ore lavorative.
LUIGI COLUCCIA
Laboratorio di scienze applicate all’archeologia, Università del Salento via Dalmazio Birago 64, 73100 Lecce email: [email protected]
BIBLIOGRAFIA ACANFORA 1970 M.O. Acanfora, Manufatti in legno da Polada e Barche di Solferino, in
“Bullettino di Paletnologia Italiana”, XXI, 79, II, 1970, pp. 157-239. BAILLOUD 1974 G. Bailloud, Le Néolithique dans le Bassin Parisien, Paris 1974. BAZZANELLA 1999 M. Bazzanella, La tessitura nel Neolitico, in A. PESSINNA, G. MUSCIO (a
cura di), Settemila anni fa il primo pane, Udine 1999, pp. 192-204. BINFORD 1962 L.R. Binford, Archaeology as Anthropology, “American Antiquity”, 28,
1962. BINFORD 1978 L.R. Binford, Nunamiut Ethnoarchaeology, New York 1978. BINFORD 1989 L.R. Binford, Debating Archaeology, San Diego 1989. BOSCATO, GAMBASSINI, RONCHITELLI 2002 P. Boscato, P. Gambassini, A. Ronchitelli, Una stuoia in
fibre vegetali del Neolitico antico nella Grotta Santa Croce, in F. RADINA (a cura di), La Preistoria della Puglia. Paesaggi, uomini e tradizioni di 8000 anni fa, Bari 2002, pp. 71-76.
BOSCH et alii 2006° A. Bosch, J. Chinchilla, J. Tarrús, R. Piqué, Els objectes de fusta i fibres vegetals, in A. BOSCH, J. CHINCHILLA, J. TARRÚS (a cura di), Els objectes de fusta del poblat neolític de la Draga. Excavacions 1995-2005, Girona 2006, pp. 27-126.
BOSCH et alii 2006b A. Bosch, A. Palomo, R. Piqué, J. Tarrús, Les fulles de pedra polida de les aixes, in A. BOSCH, J. CHINCHILLA, J. TARRÚS (a cura di), Els objectes de fusta del poblat neolític de la Draga. Excavacions 1995-2005, Girona 2006, pp. 133-138.
CALANI 1997 L. Calani, Grotta delle Veneri. Industrie litiche dei livelli a ceramiche. Studio sulle tracce di usura, in E. INGRAVALLO (a cura di), La passione dell’origine. Giuliano Cremonesi e la ricerca preistorica nel Salento, Lecce 1997, pp. 221-231.
CALANI 1999 L. Calani, Interpretazione dell’industria litica attraverso lo studio funzionale. Il Neolitico di Sammardenchia, in A. PESSINNA, G. MUSCIO (a cura di), Settemila anni fa il primo pane, Udine 1999, pp. 158-164.
CALDARA, PENNETTA 2002 M. Caldara, L. Pennetta, L'ambiente fisico delle Murge durante il Neolitico, in F. RADINA (a cura di), La Preistoria della Puglia. Paesaggi, uomini e tradizioni di 8000 anni fa, Bari 2002, pp. 21-26.
CARANCINI 1984 G. Carancini, Le asce nell’Italia continentale, II, in “Prähistorische Bronzefunde”, IX, 12, 1984, pp. 236-237.
CAZZELLA 1999 A. Cazzella, Etnoarcheologia e Archeologia sperimentale, in E. INGRAVALLO (a cura di), Fonti di informazione e contesto archeologico, Lecce 1999, pp. 63-73.
CLARK 1969 J.G.D. Clark, Europa preistorica. Gli aspetti della vita materiale, Torino 1969 (trad. it., ed. or. 1952).
COLES 1973 J. Coles, Archaeology by Experiment, Londra 1973. CREMONESI 1986 G. Cremonesi, Il Neolitico e la prima età dei Metalli, in Atti del
Colloquio Salento porta d’Italia (Lecce 1986), pp. 33-45.
LUIGI COLUCCIA La ricostruzione paleoambientale e dei manufatti archeologici
isbn 9788890334603 prima di Carpignano. Documentazione e interpretazione di una sepoltura neolitica 113
DE MARINIS, BRILLANTE 1998 R.C. De Marinis, G. Brillante, La mummia del Similaun. Ötzi. L’uomo venuto dal ghiaccio, Venezia 1998.
FERRI, MORA 1996 W. Ferri, A. Mora, Il disegno e la paleoantropologia: omaggio a Carlo Ranzi, in Atti del XIII Congresso UISPP, II (Forlì 1996), pp. 55-59.
FIORENTINO 2002 G. Fiorentino, I più antichi agricoltori ed i processi di sfruttamento delle risorse vegetali, in F. RADINA (a cura di), La Preistoria della Puglia. Paesaggi, uomini e tradizioni di 8000 anni fa, Bari 2002, pp. 221-225.
FUGAZZOLA DELPINO 1999 M.A. Fugazzola Delpino, La vita quotidiana del Neolitico. Il sito della Marmotta sul lago di Bracciano, in A. PESSINNA, G. MUSCIO (a cura di), Settemila anni fa il primo pane, Udine 1999, pp. 184-191.
GABELLONE 2007 F. Gabellone, La capanna di Sant’Anna e la sua ricostruzione virtuale, in TIBERI 2007, pp. 165-169 e tavv. XVII – XIX.
GENIOLA 1987 A. Geniola, La cultura di Serra d’Alto nella Puglia centrale, in Atti della XXV Riunione Scientifica IIPP (Monopoli 1987), pp. 55-86.
GIBAJA, PALOMO 2006 J.F. GIBAJA, A. PALOMO, Les puntes de sageta i làmines de falç de sílex, in A. BOSCH, J. CHINCHILLA, J. TARRÚS (a cura di), Els objectes de fusta del poblat neolític de la Draga. Excavacions 1995-2005, Girona 2006, pp. 139-143.
GUILAINE, COURTIN, MOHEN 1976 J. Guilaine, J. Courtin, J.P. Mohen, L’agriculture, in J. GUILAINE (a cura di), La Préhistoire française, II. La civilisations nèolithiques et protohistorique de la France, Parigi 1976, pp. 172-174.
INGRAVALLO 1996 E. Ingravallo, Oria. L’insediamento neolitico di Sant’Anna, Mostra Documentaria (Oria 1996).
INGRAVALLO 1997 E. Ingravallo, Sant’Anna (Oria), in E. INGRAVALLO (a cura di), La Passione dell’origine. Giuliano Cremonesi e la ricerca preistorica nel Salento, Lecce 1997, pp.135-156.
INGRAVALLO 2004 E. Ingravallo, Il sito neolitico di Serra Cicoria (Nardò-Le): note preliminari, in “Origini”, XXVI, 2004, pp. 87-119.
INGRAVALLO, TIBERI 2008 E. Ingravallo, I. Tiberi, Il Neolitico salentino nel circuito internazionale di prestiti e scambi, in “Studi di Antichità”, 12, 2008, pp. 71-95.
LEROI GOURHAN 1943 A. Leroi Gourhan, L’uomo e la materia, Milano 1993 (trad. it., ed. or. 1943).
LO PORTO 1972 F.G. Lo Porto, La tomba neolitica con idolo in pietra da Arnesano, (Lecce), in “Rivista di Scienze Preistoriche”, XXVII, pp. 357-372.
MANFREDINI 2001 A. Manfredini, Rituali funerari e organizzazione sociale: una rilettura di alcuni dati della facies Diana in Italia meridionale, in M.C. MARTINELLI, U. SPIGO (a cura di), Studi di Preistoria e Protostoria in onore di Luigi Bernabò Brea, Messina 2001, pp. 71-87.
MARGIOTTA, MARTANO, WALSH 1987 B. Margiotta, M. Martano, N. Walsh, Carta geolitologica del territorio amministrativo di Carpignano Salentino (Lecce), in “Quaderni di ricerche del Centro Studi Geotecnici e d’Ingegneria – Lecce”, 11, 1987.
MARTINELLI 2002 M.C. Martinelli, La strumentazione in pietra nelle fasi più antiche del Neolitico nella Puglia centrale, in F. RADINA (a cura di), La Preistoria della Puglia. Paesaggi, uomini e tradizioni di 8000 anni fa, , Bari 2002, pp. 195-208.
MEDRI 2003 M. Medri, Manuale di rilievo archeologico, Bari 2003. ORLANDO 1996 A.M. Orlando, S. Anna: le strutture, in INGRAVALLO 1996, pp. 49-51. ORLANDO 1997 A.M. Orlando, Cardigliano (Specchia), in E. INGRAVALLO (a cura di) La
passione dell’origine. Giuliano Cremonesi e la ricerca preistorica nel Salento, Lecce 1997, pp. 290-293.
SEMENOV 1964 S.A. Semenov, Prehistoric Technology, Londra 1964. SICOLO 2002 M. Sicolo, Il popolamento neolitico a NO di Bari, in F. RADINA (a cura
di), La Preistoria della Puglia. Paesaggi, uomini e tradizioni di 8000 anni fa, Bari 2002, pp. 177-183.
LUIGI COLUCCIA La ricostruzione paleoambientale e dei manufatti archeologici
114 prima di Carpignano. Documentazione e interpretazione di una sepoltura neolitica isbn 9788890334603
SPINDLER 1998 K. Spindler, L’uomo dei ghiacci, Milano 1998 (trad. it., ed. or. 1993). TIBERI 2007 I. Tiberi, Sant’Anna (Oria - Br). Un sito specializzato del VI millennio
a.C., Galatina 2007. WILKENS 2002 B. Wilkens, Gli animali del Neolitico Antico nella Puglia centrale, in F.
RADINA (a cura di), La Preistoria della Puglia. Paesaggi, uomini e tradizioni di 8000 anni fa, Bari 2002, pp. 215-220.