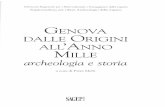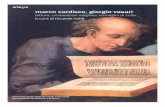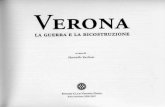Ricostruzione postbellica nell'Illirico giustinianeo
Transcript of Ricostruzione postbellica nell'Illirico giustinianeo
Dipartimento di StoriaUniversità della Calabria
Miscellaneadi
studi storici
Rubbettino
Finito di stampare nel mese di maggio 2011dalla Rubbettino Industrie Grafiche ed Editoriali
per conto di Rubbettino Editore Srl88049 Soveria Mannelli (Catanzaro)
Estrattodal n. XVI, 2009-2010
C. TorreRicostruzione post-bellica nell’Illirico giustinianeo
151
AbstractProcopio di Cesarea descrive nel De Aedificiis l’attività edilizia promossa da Giu-stiniano (527-565) nell’Impero bizantino (Italia esclusa). Il libro IV di quest’ope-ra è in parte dedicato alle costruzioni realizzate nell’Illirico, devastato dalle inva-sioni barbariche. Qui l’imperatore provvede al restauro o alla realizzazione ex no-vo di strutture difensive, ovvero al trasferimento di antichi centri in località più si-cure e alla fondazione di nuove città. A tal proposito la testimonianza di Procopiosi configura quale fonte di notevole interesse per lo studio dell’evoluzione dell’ha-bitat nella Prefettura dell’Illirico nella fase di transizione dal mondo antico a quel-lo medioevale.
Procopius of Caesarea describes the building activity promoted by EmperorJustinian (527-565) in the Byzantine Empire (with the exception of Italy) in hisDe Aedificiis. The 4th book of this work is in part dedicated to constructions re-alized in the Illyrian territories, devastated by barbarian invasions. Here theEmperor provided for the restoration or the construction from the beginningof defensive structures, or rather for the transfer of ancient towns to safer lo-cations and the foundation of new cities. Procopius testimony about this topictakes shape as a source of relevant interest for habitat evolution studies in theIllyrian Prefecture in the transition phase from the Ancient to the MedievalWorld.
Parole chiave: Ricostruzione; transizione; polis; kastron.
Key words: Rebuilding; transition; polis; kastron.
CRISTINA TORRE
Ricostruzione post-bellica nell’Illirico giustinianeo
Un aspetto interessante della dominazione bizantina in qualsivoglia re-gione dell’Impero e in ogni momento della sua lunga storia è rappresentatodall’impegno profuso nella fondazione o rifondazione di città, nell’edifica-zione di centri fortificati nonché nel restauro e/o nell’innalzamento di strut-ture difensive di diverso genere, selezionate in base alle esigenze dei siti sucui sarebbero state realizzate1. Tale attenzione si riflette, tra l’altro, nellospazio riservato agli aspetti tecnici, ma non solo, relativi alla costruzione dipoleis e phrouria nella trattatistica militare bizantina, rappresentata ad esem-pio dal manuale noto con il titolo Perˆ Strathg…ac o De re strategica e at-tribuito ad un anonimo autore vissuto al tempo di Giustiniano (527-565)2.
Si trattava di interventi in alcuni casi funzionali a “salvare dall’abban-dono molte città antiche, favorendone la persistenza nel loro sito tradizio-nale o trasferendole altrove”3. In altri casi essi erano legati alla necessariaordinaria manutenzione, ma anche e soprattutto al ripristino e al rafforza-mento di strutture danneggiate da situazioni di conflittualità, sia che si trat-tasse di vere e proprie guerre – come nel caso dell’Italia durante e dopo laguerra greco-gotica – oppure di periodiche invasioni, non meno rovinosedella guerra tout-court per i territori e le popolazioni che le subivano.
Proprio nell’attività di fondazione e rifondazione di città, come anchein quella di ripristino di preesistenti strutture difensive condotta dai Bi-zantini è possibile cogliere i due aspetti della continuità e del mutamentonel passaggio dal conflitto alla ricostruzione. Il primo si concretizza difat-ti nell’impegno a salvaguardare, come si è detto, la sopravvivenza di centriantichi, come accade in Italia ad esempio a Taranto dove una parte dell’a-rea urbana viene fortificata dal generale giustinianeo Giovanni il Sangui-nario4. È invece possibile parlare di mutamento – con gli opportuni di-stinguo – quando si verifichi l’edificazione di un nuovo centro. È il caso,ancora per quanto concerne l’Italia e più precisamente l’odierna Calabria,delle città di Rossano, Squillace e Catanzaro. Ognuna di queste, come evi-denziato da Filippo Burgarella, costituisce un esempio delle tre modalitàattraverso cui potevano essere realizzate nuove fondazioni ossia, rispetti-vamente, per ampliamento o rafforzamento di un phrourion preesistente(Rossano); per traslazione del sito dalla località originaria ad un’altra(Squillace); per formazione ex novo, generalmente in altura (Catanzaro)5. Ta-le cura per il territorio dimostra tra l’altro come vada quantomeno ridi-
152
1 Cfr. CONCINA 2009, p. 48.2 ANON. Strat.3 BURGARELLA 2006, p. 193.4 Ibid., pp. 196, 199.5 Ibid., p. 198.
153
mensionato il luogo comune secondo cui i Bizantini sarebbero stati dei do-minatori per lo più assenti e incuranti delle necessità – soprattutto in ma-teria di difesa e sicurezza – delle province, mostrandosi al contrario preoc-cupati solo della riscossione di tasse ed imposte6.
In questa sede verranno presi in considerazione – a partire dalla testi-monianza del De Aedificiis di Procopio di Cesarea – alcuni centri edificatio riedificati da Giustiniano nella Prefettura del Pretorio dell’Illirico alloscopo di evidenziare, in relazione ad essi, gli aspetti della continuità e delmutamento intesi nella maniera poc’anzi esposta. Le informazioni riporta-te da Procopio, opportunamente contestualizzate ed integrate con i dati of-ferti da altre fonti permetteranno in particolare di chiarire cosa, nella fasedella ricostruzione, questi centri – e le popolazioni che li abitavano – ab-biano conservato della loro fisionomia originaria e in che misura invece es-si siano cambiati.
Al tempo di Giustiniano7 ciò che resta della Prefettura dell’Illirico, arti-colata nelle due diocesi di Macedonia e di Dacia, risulta suddiviso nelle pro-vince di Macedonia I e II, Tessaglia, Acaia, Epirus Nova, Epirus Vetus e Cre-ta per ciò che concerne la diocesi macedone. La diocesi di Dacia compren-deva invece le due Dacie (Ripense e Mediterranea), la Dardania, la Prevali-tana, la Mesia I e la Pannonia, residuo dell’antica Pannonia II, con le città diSirmio e Bassiana8. Le testimonianze del tempo riflettono tuttavia una certaambiguità nella percezione della Prefettura9: gli atti del concilio di Calcedo-nia (451), ad esempio, fanno dell’Illirico una diocesi, così come quelli del Vconcilio ecumenico, tenutosi a Costantinopoli sotto l’egida di Giustinianonel 553, restituiscono un’immagine tutt’altro che chiara della sua fisiono-mia10. Le discordanze che emergono dalle fonti sono verosimilmente indiziodi un cambiamento in atto, di una lenta evoluzione che procede nel sensodella disgregazione e quindi della scomparsa della Prefettura dell’Illirico11.
La ricostruzione giustinianea nella regione è trattata nel IV libro del DeAedificiis o, meglio, del De Aedificiis Justiniani di Procopio di Cesarea12.
6 Ibid., p. 193.7 Tra i numerosi lavori sull’età di Giustiniano si vedano in particolare RUBIN 1960-
1995; STEIN 1968; MARAVAL 1999; TATE 2004; MEIER 2007.8 LEMERLE 1954, pp. 265 ss.; POPOVIČ 1975, pp. 445 ss.; MARAVAL 1999, p. 9; CROKE
2001, pp. 48-54.9 DAGRON 1984, pp. 1-6. Ma già LEMERLE 1954, p. 266, n. 1: “Il faut prendre garde
qu’Illyricum, dans les sources, peut désigner tantôt une région géographique assez vague,tantôt une division administrative précise”.
10 DAGRON 1984, pp. 2 s.11 Cfr. LEMERLE 1954, pp. 269-273.12 CESARETTI 2008, p. 154 e n.
Questo testo costituisce, come è noto, la fonte principale di informazionisull’attività di ricostruzione promossa dal sovrano in tutto l’Impero, ecce-zion fatta per l’Italia. Tale dato, insieme ad altri, rivela un aspetto dell’o-pera – la sua incompiutezza13 – da cui non è possibile prescindere e che èopportuno anche in questa sede sottolineare. Eventuali imprecisioni, svi-ste, errori più o meno grossolani sicuramente riscontrabili nel testo non de-vono infatti indurre a formulare avventati quanto scorretti giudizi di valo-re14. Allo stesso tempo il fatto che Procopio non abbia terminato il De Ae-dificiis deve mettere in guardia dal considerare il suo resoconto alla streguadi una trattazione esaustiva15. Un esempio in tal senso riguarda proprio uncentro della Prefettura dell’Illirico, Byllis, in Epirus Nova. Ecco, Procopionon riporta alcuna informazione a proposito di questa città, eppure testi-monianze epigrafiche dimostrano che anch’essa fu interessata dal pro-gramma imperiale di ricostruzione16.
È inoltre opportuno tenere presente che l’attività edilizia promossa daGiustiniano, per quanto ampia e capillare, non è certamente qualcosa distraordinario. Già agli inizi del V secolo – per limitarci ad un periodo pros-simo a quello in esame – probabilmente in conseguenza della discesa di Ala-rico e di alcuni eventi sismici, erano state effettuate nel territorio oggetto delnostro interesse delle ricostruzioni che adombrano un vero e proprio pro-gramma imperiale17. Questo riguardava la penisola Balcanica in generale, lecittà della Grecia in particolare, come è emerso dagli scavi archeologici con-dotti a Corinto e nell’area dell’Istmo. Qui i sistemi murari risultano appun-to contemporanei, anche se strutturalmente differenti, rispetto alle mura in-nalzate a Costantinopoli da Teodosio II (408-450). Mura invece del tutto si-mili a quelle di Corinto – e quindi, presumibilmente, coeve – sono venutealla luce a Sparta, Epidauro, Korone e Hermione18. Anche l’imperatore
154
13 Cfr. DOWNEY 1947, pp. 172, 176.14 A tal proposito non è possibile, a mio avviso, condividere quanto scritto da Denis
Roques in riferimento agli errori e alle imprecisioni dell’opera: ROQUES 2000, pp. 36 ss. Se-condo DOWNEY 1939, pp. 373 ss. è difficile accettare un difetto di informazione da parte diProcopio, per cui “A more natural approach would be to inquire whether the form and con-tents of the account may not have been influenced by the purpose of the work and by exi-gencies of its form” (parole citate da p. 374).
15 Cfr. al riguardo ROQUES 2000, pp. 38 s.16 SEG 38, 530-533. FEISSEL 1988; ID. 2000, p. 92. È possibile cogliere una situazione
analoga ad esempio in relazione all’Epiro Vetus (CHRYSOS 1997, p. 165), alle regioni basso-danubiane (PATOURA-HATZOPOULOS 1980, pp. 104-106) come anche all’Africa (RAVEGNA-NI 1983, p. 121).
17 Cfr. Codex Theodos. XV.1.49 (9 aprile 412). GREGORY 1979, pp. 270 s.; CROW 1995,p. 120.
18 GREGORY 1979, pp. 270 s.
155
Anastasio (491-518) aveva mostrato attenzione per le questioni edilizie con-nesse alla sicurezza del territorio, come dimostra ad esempio la costruzionedel cosiddetto “Lungo Muro” – tÕ makrÕn kaloÚmenon te‹coc19 – in Tra-cia20. Sempre a proposito di Anastasio lo storico Giovanni Malala (sec. VI)ricorda come (325,30-31) ”Ekticen d�, Ð aÙtÕc bacileÚc... kat6 pÒlin tÁc`Rwman…ac di£fora kt…cmata, «Codesto sovrano realizzò… in ogni cittàdella Romània diverse costruzioni». Questo motivo viene ripreso e amplia-to più avanti (335,60-63): œkticen d� kaˆ e„c ˜k£cthn pÒlin tÁc `Rwman…acdi£fora kt…cmata kaˆ te…ch kaˆ ¢gwgoÚc, kaˆ lim2nac ¢nakaq£rackaˆ dhmÒcia loutr6 ™k qemel…wn o„kodom1cac, kaˆ ¥lla poll6 ™n˜k£ctV paršcce pÒlei, «In ogni città della Romània realizzò diverse co-struzioni, mura, acquedotti, bonificò aree portuali, edificò dalle fondamen-ta bagni pubblici e molto altro fece in ogni città».
È chiaro dunque come gli interventi in campo edilizio promossi daGiustiniano e descritti da Procopio si configurino in effetti come atti di po-litica ordinaria21. Essi si pongono non di rado in assoluta continuità ri-spetto alla politica dei predecessori, in particolare di Anastasio22. Ciò cheli distingue da quanto realizzato da qualsiasi altro imperatore è il fatto diessere stati oggetto di una trattazione specifica all’interno di un’opera uni-ca nel suo genere quale è appunto il De Aedificiis23.
Tornando alla costruzione e/o ricostruzione di città e fortezze nell’Illi-rico, esse si erano rese necessarie all’epoca di Giustiniano per motivi qualilo stato di incuria in cui versavano alcune strutture nonché il crollo di altrein conseguenza di terremoti o di attacchi nemici. In relazione a questi ulti-mi e per limitarci al VI secolo giova ricordare come nel 517 Bulgari e Antisi fossero spinti sino alle Termopili dopo avere devastato la Tracia e la Ma-
19 EVAGR., HE III 38.20 La realizzazione da parte di Anastasio della struttura originaria delle Lunghe mura
è tuttavia discussa: CROW 1995, p. 118.21 Cfr. DOWNEY 1939, p. 361.22 Cfr. PATOURA-HATZOPOULOS 1980, pp. 103 (Tomi), 104 (Dinogetia); GREGORY 2000,
pp. 110, 112.23 L’attività edilizia, intesa quale manifestazione della philanthropia del sovrano, aveva
rappresentato sino a Procopio solo uno degli elementi costitutivi del Basilikòs Lògos (cfr.WHITBY 2000, pp. 54 ss.). Ne è un esempio il Panegirico per l’imperatore Anastasio di Pro-copio di Gaza in cui troviamo sia riferimenti generici alle opere realizzate, sia descrizioni disingoli interventi quali l’acquedotto di Ierapoli, il porto di Cesarea, il faro di Alessandria, ilcosiddetto “Lungo Muro” a difesa di Costantinopoli (PROCOP. GAZ. Pan., cc. 18-21). La no-vità e insieme l’unicità del De Aedificiis consistono invece nella centralità assoluta assuntadall’argomento. La natura dell’opera di Procopio, se cioè essa sia un panegirico o un’ope-ra storiografica è tuttora un problema discusso: WHITBY 2000, pp. 46, 56 s.; CESARETTI
2008, p. 163.
cedonia, mentre nel 529 ancora i Bulgari, insieme questa volta agli Sclave-ni, venivano respinti da Mundo, magister militum per Illyricum24. Nel 536Sirmio e molti centri della Dacia Ripense furono occupati dai Gepidi25. Ne-gli anni compresi tra il 540 ed il 551 la popolazione bulgara dei Kutriguriè protagonista di una serie di incursioni che la portano a colpire Tessalo-nica e ancora la Grecia sino all’Istmo di Corinto. Nel 548 gli Sclaveni sispingono fino a Durazzo26. Nel 559 Kutriguri e Sclaveni giungono ancorauna volta alle Termopili continuando a devastare la penisola balcanica an-che negli anni successivi, mentre sul finire del regno di Giustiniano si af-facciano ai confini dell’Impero gli Avari27.
Siffatto continuo stato di guerra determinò da una parte, nell’Illiricocome altrove, un consistente calo demografico, indubbiamente aggravatodalla peste che nel 542/543 toccò anche i Balcani28; dall’altra accelerò ilprocesso di militarizzazione del territorio. La diminuzione della popola-zione ebbe tra le sue conseguenze la scomparsa di molti centri insieme al-la contrazione degli insediamenti superstiti29. Denotano invece l’evoluzio-ne in senso militare delle strutture insediative sia l’alta percentuale diphrouria costruiti e ricostruiti (come emerge anche dal De Aedificiis), sia laprogressiva trasformazione della polis in kastron o, meglio, la graduale ac-quisizione (de jure o de facto) da parte dei kastra – fossero essi preesistentio di nuova fondazione – dello status di polis30, laddove nelle poleis le esi-genze difensive, vieppiù “preminenti su ogni altra forma di vita sociale”31,
156
24 PLRE III, pp. 903-905.25 RAVEGNANI 2009, p. 103.26 LEMERLE 1954, pp. 283 ss.; MARAVAL 1999, p. 81.27 MARAVAL 1999, pp. 78-84; TATE 2004, pp. 721-733. Un’ampia panoramica circa le
condizioni economiche dell’Illirico, nonché sul ruolo giocato a Costantinopoli da numero-si individui originari di questa regione (dall’imperatore Anastasio allo stesso Giustiniano) ètracciata in CROKE 2001, pp. 54-56; 88-101.
28 STATHAKOPOULOS 2007, p. 102; SARRIS 2007, p. 120. Per una mappa della diffusio-ne della peste nell’Impero bizantino al tempo di Giustiniano v. HORDEN 2005, pp. 136-137.
29 Cfr. MUÇAI 2008, p. 381.30 In virtù del possesso di requisiti quali un’alta percentuale di popolazione civile, una
certa monumentalità data dalla presenza di strutture non necessariamente legate a funzio-ni difensive e insieme di edifici destinati ad accogliere le autorità, anche ecclesiastiche qua-li soprattutto i vescovi: RAVEGNANI 1983, pp. 12 s., n. 26. Malala (372,25-28) ci informa aproposito della concessione da parte di Giustiniano dei d…kaia pÒlewc ai kastra di Ana-sarthon/Theodoriade e Sousai/Joustinianoupoli: RAVEGNANI 1982, p. 277 e n. 36.
31 Ibid., p. 16. “L’ottica militare e in generale i problemi della sicurezza mostrano diprevalere anche nella vasta attività edificatoria svolta nelle regioni balcaniche – lungo il Da-nubio, in Epiro, in Macedonia, in Tracia – secondo una casistica operativa assai articolata”:CONCINA 2009, p. 52.
157
modificavano l’antico assetto urbano rendendo le città sempre più simili adelle fortezze.
La questione della transizione dalla polis al kastron è tuttavia molto piùcomplessa. Un interessante modello teorico entro cui inquadrarla è statoelaborato da Archibald Dunn il quale in primo luogo ha proposto di clas-sificare i livelli superiori del sistema di insediamento in “civic urban”,“non-civic urban”, “non-civic non-urban”, categoria, quest’ultima, in cuiviene inserita la realtà del kastron32. Lo studioso ha quindi sottolineato lanecessità di un approccio al problema che fosse di ampio respiro, che te-nesse conto, cioè, delle ricerche archeologiche e topografiche, le quali co-stituirebbero a suo avviso l’unica fonte di nuovi elementi utili per l’indagi-ne, soprattutto in relazione ai Balcani33. L’esito più significativo delle argo-mentazioni di Dunn risiede nell’individuazione di una nuova cronologiadella transizione dalla polis al kastron nel contesto balcanico: “it would bearguable that the transition had already occurred in the Balkans duringLate Antiquity in many if not most respects”, accolta quindi, in unaprospettiva più generale, da John Haldon: “the evidence suggests that oneshould avoid overemphasising the contrast between the late ancient polisand the middle Byzantine kastron: … a large number [di insediamenti]were cheracterised already in the fourth and fifth century, and especially inthe sixth century, by features normally associated archeologically and topo-graphically with the later Byzantine kastron…”34.
D’altra parte, nella storiografia erudita di VI/VII secolo in generale35
e nelle parole di Procopio in particolare è possibile scorgere a mio pare-re un aspetto dell’evoluzione – da polis a kastron – del centro cittadino,il quale nel VI secolo è forse già cambiato nelle sue strutture materiali manon ancora, evidentemente, nella denominazione36. Nello storico di Ce-sarea difatti non compare mai il termine kastron37 che di lì a breve si af-fermerà per designare la realtà tipica dell’habitat bizantino38. In luogo dikastron credo che egli ricorra non tanto (o comunque non solo) a phrou-
32 DUNN 1994, pp. 60, 66 s.33 Ibid., pp. 60-63, 71.34 HALDON 1999, p. 12.35 RAVEGNANI 1983, p. 10.36 “… many historians of the sixth century refer almost exclusively to urban centres as
poleis, and it is difficult to know whether this is a general application of the term based onsize, importance and so on, as well as juridical-constitutional status, or whether the tecni-chal meaning of the word alone is being observed”: HALDON 1999, p. 11. Cfr. VEIKOU 2010,pp. 184 ss.
37 Il K£ctra M£rtic menzionato in Aed. IV 6.33 è un toponimo (traslitterazione diCastra Martis, nella Dacia Ripense).
38 CONCINA 2009, pp. 57 ss.
rion39, quanto, perlomeno in alcuni casi, a polis. Lo storico difatti associachiaramente il phrourion al kàstellos (Aed. II 5.9) e così facendo distin-gue a mio parere entrambi sia dalla polis che dal kastron. Invece l’uso pro-copiano di polis in luogo di kastron potrebbe essere talora letto alla lucee in conseguenza della progressiva reciproca assimilazione delle forme diabitato che essi rispettivamente designano40 oltre che, ovviamente, comericorso ad un lessico “classico” che comprendeva anche il termine polis,laddove kastron rappresentava “day-to-day values and realities”41. Saràutile fare qualche esempio: nel libro II del De Aedificiis Procopio parladel phrourion di Circesio, in Mesopotamia, che Giustiniano fortificò fa-cendone una polis42. Ecco, Giovanni Malala si riferisce al medesimo cen-tro con il termine kastron43. Ancora, Procopio definisce polis Cassiope,cittadina portuale sita nella parte Nord-orientale di Corcira44, corrispon-dente al castrum Cassiopi di alcune lettere di papa Gregorio Magno45.
Anche nel contemporaneo manuale De re strategica, precedentementemenzionato, è possibile del resto constatare “l’identificazione della poliscol kastron, giacché quest’ultimo termine non vi figura46, ma i suoi requi-siti sono perfettamente ascrivibili alla polis: requisiti che consistono in mu-ra di cinta e fortificazioni. Di lì a poco, nel cosiddetto Strategikòn dellopseudo-Maurizio kastron e polis risultano affini e distinti da phrourion”47.
Il suddetto fenomeno di assimilazione spiega probabilmente anchel’ambiguità nell’uso di polis e phrourion in altri autori: la “confusione” traquesti termini osservata in Agazia e in maggior misura in Teofilatto Simo-catta48 è a mio avviso indicativa della trasformazione che vede da un lato lacontrazione del centro abitato, dall’altro la sua evoluzione in senso milita-re. Ancora, appare significativo il confronto istituito da John Haldon, peri secoli VII-IX e per i territori bizantini in Asia Minore, tra la letteraturaagiografica bizantina e le opere di geografi arabi: tutti quei centri per i qua-li la prima utilizza la parola polis vengono descritti dalla seconda come for-tezze, “and since Arab technical terminology had a very precise usage in
158
39 Così RAVEGNANI 1983, p. 10.40 Cfr. d’altronde ibid., pp. 14 s., n. 30.41 HALDON 1999, p. 18.42 PROCOP. Aed. II 6.1-3.43 IO. MAL. 252.52; 253.56-57.44 PROCOP. Bell. VIII 22.26.45 Gregorii Magni registrum epistularum, epp. XIV 7; 8; 13.46 Così come si è detto per Procopio.47 BURGARELLA 2006, p. 194.48 RAVEGNANI 1982, p. 273; cfr. HALDON 1999, p. 11.
159
respect of the differences between cities, towns and villages, this is not in-significant, suggesting that, in appearance at least, most Byzantine cities,however they were referred to by the Byzantines themselves, were little mo-re than fortresses to Arab observers”49.
Fatte queste precisazioni, che torneranno utili nel prosieguo del dis-corso, è possibile adesso analizzare alcuni casi specifici di ricostruzione nel-l’Illirico giustinianeo. Come già accennato il punto di partenza per la no-stra analisi sarà il IV libro del De Aedificiis50.
Inquadrato lo spazio geografico del libro, sostanzialmente la penisola bal-canica, l’Autore inizia il suo itinerario ¢pÕ tÁc toà bacilšwc... patr…doc51:
(17) Nel territorio dei Dardani europei, stanziati oltre le montagne degli Epidamni, vi-cino la fortezza [phrourion] chiamata Bederiana, si trovava un villaggio [chōrion] chiamatoTauresio da cui proviene l’imperatore Giustiniano, l’ecista del mondo. (18) Ecco, in questovillaggio in breve tempo egli realizzò una cinta muraria di forma quadrangolare innalzandouna torre ad ogni angolo, ragione per cui ora esso viene chiamato Tetrapyrgia52. (19) Assaivicino a questo villaggio edificò poi una splendida città [polis] cui diede il nome di Justi-niana Prima (in latino Prima significa “prima”), sdebitandosi in questo modo con la terrache lo aveva cresciuto. (20) Ed era certo necessario che tutti i Romani condividessero que-sto debito, visto che quella terra aveva cresciuto il comune salvatore di tutti. (21) Qui co-struì poi un acquedotto, facendo sì che la città fosse adeguatamente rifornita di acqua cor-rente. (22) Il fondatore della città pose grande cura nel realizzare molte altre cose straordi-narie e degne di grande considerazione. (23) Chiese difficilmente enumerabili, indescrivi-bili dimore per le autorità, grandi portici, belle piazze, fontane, strade, bagni, botteghe. (24)Una città semplicemente grande, popolosa, insomma prospera e tale da essere la metropo-li [mētropolis] dell’intera regione. Giunse infatti a tanto grande dignità. (25) Venne sceltacome sede dell’arcivescovo degli Illiri, avendo tutte le altre città ceduto il posto a lei in quan-to prima per grandezza53.
Sulla base della casistica individuata da Filippo Burgarella54 potremmocollocare Justiniana Prima tra le nuove fondazioni giustinianee realizzateex novo.
49 HALDON 1999, p. 14. Invece, a partire dalla metà del X secolo il termine kastron rap-presenterà “the dominant descriptive term for Byzantine urban settlements”: ibid., p. 16.L’uso pressoché esclusivo di kastron per designare il centro abitato si registra inoltre, sem-pre a partire dal X secolo, nei documenti bizantini, anche in quelli dell’Italia meridionale(la cui prassi contrasta al riguardo con le fonti agiografiche locali): VON FALKENHAUSEN
1978, pp. 145 s.50 Sui problemi posti dal IV libro del De Aedificiis e in particolare sulla lista di topo-
nimi in esso contenuta v. PERRIN-HENRY 1981.51 PROCOP. Aed. IV 1,15.52 Cfr. RAVEGNANI 1983, p. 60.53 PROCOP. Aed. IV 1.17-26. La traduzione è mia.54 Cfr. supra, p. 152.
La città, situata nella Dacia Mediterranea55, è stata identificata, nonsenza incertezze, con l’attuale Caričin Grad, in Serbia56. Qui in effetti le in-dagini archeologiche hanno portato alla luce una struttura urbanistica chesembra corrispondere a quanto descritto da Procopio.
La città è stata per lo più costruita rispettando il tradizionale modelloellenistico-romano57. Gli elementi di differenziazione sono rappresentatida una parte, ovviamente, dagli edifici di culto cristiani e dal complessoepiscopale58; dall’altra dall’assenza di strutture adibite all’intrattenimentodella popolazione, come i teatri59.
Con i suoi sontuosi edifici, gli acquedotti, i portici, le fontane, le gran-di strade, Justiniana Prima sembra essere sorta sulla base di criteri diffor-mi rispetto a quanto prescritto dall’anonimo autore del De re strategica60
secondo il quale, nel momento in cui si costruisce una città, specialmentein zone di confine, bisogna prestare maggiore attenzione alle questioni disicurezza piuttosto che all’estetica:
“Non mi sfugge del resto il fatto che molti, in considerazione dell’attuale benessere(che credono eterno), quando si accingono a costruire grandi città prestano attenzione,piuttosto che alla sicurezza, alle belle apparenze e per questo spesso le costruiscono in zo-ne pianeggianti, adorne di giardini, parchi e prati. Noi invece, tenendo conto dell’incertez-za del futuro e giudicando più importante la sicurezza dell’apparenza, vogliamo costruirecittà circondate da mura là dove risulti impossibile assediarle con macchine da guerra”61.
160
55 Procopio riferisce che la città si trova in Dardania, provincia situata tra l’Epirus No-va (capoluogo della quale è appunto Dyrrachium/Epidamno), e la Dacia Mediterranea. Tut-tavia la Novella 11 de privilegiis archiepiscopi Primae Justinianae, datata 14 aprile 535, col-loca inequivocabilmente la città nella Dacia Mediterranea (ll. 6-7): cfr. HONIGMANN 1939-1944, pp. 142 s. Justiniana Prima figura d’altra parte in un contesto in cui sono trattati cen-tri appartenenti tutti alla Dacia Mediterranea: Sardica, Naisso, Pantalia, Remesiana (Aed.IV 1.31-32): ibid., pp. 144 s. Unica eccezione Ulpiana/Justiniana Secunda (città della Dar-dania), la quale viene qui nominata (Aed. IV 1.28-30) forse per associazione a Justiniana Pri-ma. Le parole di Procopio suscitano qualche perplessità, specie ove si consideri che lo sto-rico aveva indubbiamente accesso a documenti ufficiali. L’aporia può forse dipendere dalfatto che la città fosse sorta in prossimità del confine tra le due province, ma può anche dar-si che ci troviamo dinanzi ad una delle imprecisioni più volte evidenziate nell’opera di Pro-copio su cui v. supra, p. 154. Sul carattere fluttuante del confine tra le due province v. PO-POVIČ 1975, p. 474, n. 2.
56 Sui problemi inerenti l’individuazione del sito v. HONIGMANN 1939-1944, pp. 142ss. e, da ultimo, BAVANT 2007. Lo identifica con Skopje ancora AUBERT 2003, col. 675.
57 BAVANT 2007, p. 345 parla di “curious mixture of classical traditions and new earlyByzantine innovations”.
58 Ibid., p. 287. Cfr. DUVAL 1984.59 CONCINA 2009, pp. 53, 103.60 ANON. Strat. 11.25-32.61 La traduzione è mia.
161
Certamente la monumentalità di Justiniana Prima doveva essere legataall’intento celebrativo in base al quale, come narra Procopio, essa era sor-ta62. Non credo però si possa escludere che nella costruzione le esigenze le-gate alla sicurezza fossero state tenute nella dovuta considerazione, no-nostante il silenzio dello storico al riguardo. In relazione a questo aspetto idubbi relativi all’identificazione non consentono di utilizzare con assolutasicurezza i risultati degli scavi condotti a Caričin Grad, dove in effetti è ve-nuto alla luce un insediamento fortificato e realizzato su di un’altura, quin-di in posizione protetta63. Degno di nota appare invece per noi il fatto chela città dovesse ospitare l’“arcivescovo degli Illiri”: perché una città fossesede vescovile doveva infatti essere dotata delle strutture difensive idoneea garantire la sicurezza dell’autorità ecclesiastica, come sarebbe stato sot-tolineato alcuni anni dopo da papa Gregorio Magno64.
A tal riguardo giova richiamare l’attenzione sul phrourion di Meridio,il quale in questi stessi anni risulta essere sede vescovile. Che si trattasse diun phrourion lo ricaviamo dal De Aedificiis che lo elenca insieme ad altriphrouria ricostruiti da Giustiniano ™n cèrv 9Akuenis…J, «nel territorio diAquae», nella Dacia Ripense65. La Novella 11 de privilegiis archiepiscopiPrimae Justinianae del 535 ci informa invece circa l’esistenza del vescova-do (ll. 29-31)66. Ora, è con ogni probabilità proprio il possesso di fortifica-zioni, tipico del phrourion, a rendere il centro di Meridio, altrimenti sco-nosciuto, atto ad ospitare un vescovo.
Ma ancora più significativo è forse l’esempio del phrourion di Mociso,nella Cappadocia II, a proposito del quale Procopio narra67:
“In Cappadocia sorgeva un castello [phrourion] di nome Mociso, sito in pianura e incosì cattive condizioni che era parzialmente crollato o sul punto di crollare. Giustiniano lofece abbattere e costruì una grande cinta muraria a occidente dell’antico castello [phrou-riou] su un colle erto e di difficile praticabilità. Qui fece poi edificare molte chiese, alber-ghi, bagni pubblici, nulla trascurando di ciò che distingue una città fortunata. Perciò salì al-la dignità di metropoli [mhtropÒlewc ¢x…wma Ãlqen], termine con il quale i Romani indi-cano le città più importanti di un distretto”68.
62 Cfr. ELSNER 2007, p. 47.63 BAVANT 2007, pp. 342-344; CONCINA 2009, p. 103.64 BURGARELLA 2006, pp. 196 s.65 Secondo HONIGMANN 1939-1944, p. 145, l’espressione di Procopio rappresente-
rebbe “an awkward combination of the Latin in agro Aquensi with the Greek suffix -»cioc= Latin -ensis”.
66 Cfr. ibid., pp. 147 ss.67 PROCOP. Aed. V 4.15-18.68 Trad. Ravegnani (in RAVEGNANI 1982, pp. 276 s.). Il testo tra parentesi quadre è ag-
giunto da chi scrive. Riguardo Circesio, che Ravegnani (ibid., p. 276) definisce castro, oc-
Mociso era dunque un phrourion posto in pianura, quindi in posizionestrategicamente sfavorevole, e in stato di rovina. Verificata evidentementel’assenza delle condizioni idonee ad una ricostruzione in loco, si è deciso diprocedere con la traslazione del centro in un’area dotata in primo luogo deirequisiti naturali atti a soddisfare le esigenze connesse alla sicurezza. Il si-to viene quindi munito di un sistema difensivo, la cinta muraria, nonché ditutta una serie di costruzioni che ™nde…knutai pÒlin eÙda…mona, che de-signano una città, una polis prospera. In virtù delle caratteristiche così ac-quisite Mociso può dunque assurgere al rango di metropoli, esattamente lostesso termine utilizzato per Justiniana Prima e del quale Procopio illustral’accezione, di natura indubbiamente civile. Quello che invece lo storiconon specifica è che Mociso diviene altresì metropolia ecclesiastica, così co-me rivelano le Notitiae episcopatuum, che le assegnano quattro sedi vesco-vili suffraganee, fra cui Nazianzo69.
Dunque, da quanto osservato sinora si desume che se non tutti i kastrao phrouria sono sede di un vescovo, è vero invece il contrario: un sito chesia sede vescovile è senz’altro un centro fortificato70. Questo principio sa-rà sempre rispettato dai Bizantini come dimostra, per un’epoca posteriore,l’esempio della cittadina calabrese di Nicastro, la bizantina Neokastron ap-punto. Il “Nuovo-kastron”, fondato all’indomani della riaffermazione del-l’Impero d’Oriente in Italia meridionale grazie alle campagne del generaleNiceforo Foca il Vecchio (885/886), è difatti sede vescovile, suffraganeadella metropolia di Reggio71.
Alla luce di quanto sinora esposto è chiaro che anche Justiniana Prima,sede dell’“arcivescovo degli Illiri” non poteva non essere dotata di un si-stema difensivo atto a garantire la sicurezza del presule e certamente, al-l’occorrenza, anche della popolazione dislocata nel territorio circostante72.
Tornando adesso alla fondazione della città, altre fonti potrebbero sug-gerire una lettura alternativa delle modalità di edificazione seguite: Agazia,
162
corre precisare che Procopio in realtà parla di phrourion (cfr. supra, p. 140): trattasi per-tanto di un ulteriore esempio di fondazione di città per ampliamento di una fortezza pree-sistente.
69 Cfr. DARROUZÈS 1981, passim.70 Cfr. DUNN 1994, p. 78: “… in practice episcopal status was itself becoming another
way of distinguishing a kastron from a mere fortification”. Diversa sembrerebbe la situa-zione per taluni centri dell’Epiro Vetus: VEIKOU 2010, pp. 186 ss. (praesertim p. 189).
71 BURGARELLA 2001, pp. 67 s.72 E in effetti a Caričin Grad (ammesso che sia corretta l’identificazione con Justinia-
na Prima) sono emerse tracce di una profonda ruralizzazione dell’insediamento durantel’ultima fase della sua esistenza, segno che la città divenne «un refuge de la population ro-maine s’abritant derrière les puissants remparts de Justinien»: POPOVIČ 1975, p. 501.
163
storico continuatore di Procopio, in riferimento a Giustiniano ad un certopunto afferma che73
patrˆc d� Ãn aÙtù pÒlic 9Illurik1, Bederian¦ m�n ™k palaioà Ñnomazomšnh, Ûc-teron d� Prèth 'Iouctinian7 metakleqe‹ca: 'IouctinianÕc g6r Ð bacileÚc, ¤te d7 ka-t'aÙt7n e„c fîc prohgmšnoc, ™kÒcmhcš te e„kÒtwc t¾n patr…da œrgoic poik…loic kaˆ ™x¢fanoàc eÙda…mona ™xeirg£cato kaˆ tÁc o„ke…ac aÙtÍ metad2dwke prochgor…ac.
“La sua patria era la città illirica chiamata fin dall’antichità Bederiana, in seguito Justi-niana Prima. Infatti l’imperatore Giustiniano, per il fatto di esservi venuto alla luce, abbel-lì, come si conviene, la sua patria con diverse opere, la rese, da sconosciuta quale era, pro-spera, e le diede il proprio nome”.
Agazia dunque identifica la patria di Giustiniano con Bederiana, la qualedel resto aveva già dato i natali a Giustino, come ricordato dallo stesso Pro-copio74. I due autori tuttavia classificano il sito in maniera differente. Agazia,difatti, utilizza il termine polis laddove Procopio definisce Bederiana phrou-rion. Non credo si debba dubitare delle parole di Procopio, laddove per Aga-zia è stata messa in evidenza l’ambiguità nell’uso di polis e phrourion75.
Ammettendo l’identificazione Bederiana/Justiniana Prima potremmoa questo punto ipotizzare che la nuova fondazione sia in realtà sorta perampliamento del preesistente phrourion. Non osta ad una simile interpre-tazione quanto riferito da Procopio in Aed. IV 1,28, quindi subito dopo lamenzione di Justiniana Prima: ”Eti mšntoi kaˆ Beder…ana tÕ froÚrion¢noikodomhc£meoc Ólon pollù Ñcurèteron katect»cato, «E, ancora,riedificò il phrourion di Bederiana rendendolo molto più forte». Oltre al-l’edificazione del nuovo centro si sarebbe verosimilmente provveduto alrafforzamento della fortezza originaria. Justiniana Prima potrebbe pertan-to rappresentare un esempio o di fondazione del tutto nuova, oppure difondazione avvenuta per ampliamento di un phrourion preesistente.
Le intenzioni di Giustiniano in relazione alla nuova città andavano pe-rò ben oltre il generale piano di ricostruzione nei Balcani e l’intento cele-brativo connessi all’edificazione materiale del sito. Sembra infatti che il so-vrano volesse trasferire da Tessalonica a Justiniana Prima la capitale dellaPrefettura dell’Illirico76. Ciò almeno è quanto lascia intendere il testo del-la Novella con la quale vengono sanciti i diritti e la giurisdizione dell’arci-
73 AGATH. 190.25-30.74 PROCOP. An. 6.2.4. Anche Giovanni Malala parla del medesimo centro come luogo
d’origine sia di Giustino (336.5), sia di Giustiniano (354.11).75 RAVEGNANI 1983, p. 16, n. 34. Cfr. supra, p. 158.76 PIETRI 1984, pp. 48 ss.; DAGRON 1984, p. 4, n. 13.
vescovo della città, vale a dire la già menzionata Novella 11 de privilegiisarchiepiscopi Primae Justinianae, datata 14 aprile 53577. Qui (ll. 8-18) vieneesplicitamente affermato che, in séguito al trasferimento della sede del Pre-fetto da Sirmio a Tessalonica Attilanis temporibus, la dignità episcopaletenne dietro alla Prefettura e “il vescovo di Tessalonica, non per sua auto-rità ma perché posto all’ombra della Prefettura meritò una certa premi-nenza”78. Dal momento però che l’Impero Romano è tornato ad occuparela riva sinistra del Danubio
“[…] abbiamo ritenuto necessario collocare la sede della stessa gloriosissima Prefettu-ra, che in Pannonia era stata istituita, vicino la Pannonia, nella nostra felicissima patria, dalmomento che la Pannonia Seconda non è per nulla distante dalla Dacia Mediterranea lad-dove una grande distanza separa dalla Pannonia Seconda la Macedonia Prima. E dal mo-mento che non era utile per lo Stato che uomini costantemente impegnati nello sforzo bel-lico giungessero in Macedonia Prima dopo avere attraversato ampi spazi e grandi difficol-tà, abbiamo ritenuto necessario trasferire la Prefettura stessa nelle regioni superiori, perchéle province vicine ne ricevano più agevolmente sollievo”79.
Dunque l’edificazione di Justiniana Prima rientrava all’interno di un piùampio programma di riorganizzazione civile ed ecclesiastica delle provincesettentrionali dell’Illirico, ma non solo. Questo programma prevedeva da unaparte il trasferimento del capoluogo della Prefettura del Pretorio nel nuovocentro, decisione che nella Novella viene presentata, si tenga presente, comeuna restaurazione dei diritti di Sirmio, ma che è rimasta evidentemente sullacarta80 (ne ignoriamo i motivi) se Tessalonica è sede del Prefetto ancora nel60481. Dall’altra parte venne invece realizzato il punto cardine della riorga-
164
77 Nov. Just., p. 94.78 “[…] Et Thessalonicensis episcopus non sua auctoritate, sed sub umbra praefecturae
meruit aliquam praerogativam”.79 “[…] necessarium duximus ipsam gloriosissimam praefecturam, quae in Pannonia fue-
rat constituta, iuxta Pannoniam in nostra felicissima patria collocare, cum nihil quidem magnidistat a Dacia mediterranea secunda Pannonia, multis autem spatiis separatur prima Macedoniaa Pannonia secunda. Et quia homines semper bellicis sudoribus inhaerentes non erat utile rei-publicae ad primam Macedoniam per tot spatia tantasque difficultates venire, ideo necessariumnobis visum est ipsam praefecturam ad superiores partes trahere, et iuxta eam provinciae consti-tutae facilius sentiant illius medicinam” (ll. 15-21). Secondo HONIGMANN 1939-1944, p. 141,n. 1 il testo presenterebbe una lacuna alla l. 20, lacuna che lo studioso propone di integrarecome segue: “… ideo necessarium nobis visum est ipsam prafecturam ad superiores partes tra-here et iuxta eam <sedem archiepiscopi orthodoxae fidei addicti creare, ut quae sub eo sunt> pro-vinciae constitutae facilus sentiant illius medicinam”, aggiungendo “But perhaps there is stillmore missing”. Nulla tuttavia al riguardo è segnalato in apparato critico.
80 Cfr. MARKUS 1979, p. 290. LEMERLE 1954, pp. 267 ss.81 DAGRON 1984, p. 2.
165
nizzazione ecclesiastica, ovvero la creazione dell’arcivescovado al quale ven-gono assoggettate le Chiese di Dacia Mediterranea, Dacia Ripense, Mesia I,Dardania, Prevalitana, Pannonia e, in un primo momento, anche MacedoniaII82. Il legame arcivescovado-prefettura è chiaramente affermato nella No-vella 11 che pone la «preminenza» del titolare di Tessalonica sub umbra prae-fecturae. L’accomodamento dell’organizzazione ecclesiastica alla geografiaamministrativa rappresenta del resto un principio tipico dell’ordinamento bi-zantino83. Esso era stato espressamente formulato nel concilio di Calcedoniadel 451 (can. 17)84; verrà ribadito dal concilio cosiddetto Quinisesto del 692(can. 38)85 e sarà alla base del trasferimento della giurisdizione ecclesiasticasull’Illirico (oltre che sull’Italia meridionale) da Roma a Costantinopoli nell’-VIII secolo, al tempo di Leone III l’Isaurico (717-741)86:
e„ d2 tic ™k bacilikÁc ™xouc…ac ™kain…cqh pÒlic, À aâqic kainicqe…h, to‹c politi-ko‹c kaˆ dhmoc…oic tÚpoic kaˆ tîn ™kklhciactikîn paroikiîn ¹ t£xic ¢kolouqe…tw.
“Se per volere imperiale una città viene edificata o ricostruita l’ordinamento ecclesia-stico si adegui all’organizzazione civile”.
La politica di Giustiniano nei riguardi della sua città natale andrebbeperò inquadrata in un contesto più ampio ove si consideri: a) che Giusti-niano aveva forse già conferito la dignità di arcivescovo – del tutto partico-lare nella sua novità e ambiguità87 – al titolare della sede di Cartagine, capi-tale della Prefettura del Pretorio d’Africa appena ricostituita88; b) cheavrebbe accordato, pare, il medesimo grado al vescovo di Ravenna, capi-tale della Prefettura del Pretorio d’Italia, forse intorno al 548/549 con Mas-simiano, primo presule di Ravenna per il quale risulti attestato il titolo diarcivescovo89.
82 La Novella 131 de ecclesiasticis canonibus et privilegiis (a. 545), c. 3, elenca nuova-mente le province soggette all’arcivescovado di Justiniana Prima, escludendo questa voltala Macedonia II. Cfr. PIETRI 1984, p. 49.
83 PIETRI 1984, p. 49.84 ACO 2,1,2, p. 161.85 NEDUNGATT-FEATHERSTONE 1995, pp. 116 s.86 ANASTOS 1957; BURGARELLA 1989, pp. 444 s.87 MARKUS 1979, pp. 277-279.88 La questione è però assai incerta, dal momento che nella Novella 131, a fronte del-
l’uso di ¢rciep…ckopoc per il titolare di Justiniana Prima, il presule di Cartagine è definito™p…ckopoc: ibid., pp. 285 ss.
89 Massimiano viene identificato con l’archiepiscopus ravennate menzionato in un do-cumento del 4 aprile 553 con il quale vengono donati dei beni alla Chiesa di Ravenna:PCHBE2, s. v. Maximianus 2, p. 1149; PILARA 2008, p. 781. Cfr. MARKUS 1979, pp. 293 ss.
L’attribuzione della dignità arcivescovile a Justiniana Prima (che scal-zava tra l’altro la sede di Sardica in quanto metropoli della Dacia Mediter-ranea) si inscrive dunque verosimilmente all’interno di un progetto di ri-organizzazione complessiva, politica ed ecclesiastica, della pars Occidentisdell’Impero, progetto che prevedeva la ricostituzione delle tre Prefetturedi Italia, Africa e Illirico, ognuna facente capo ad un capoluogo – Roma,Cartagine, Justiniana Prima – che ospitasse, oltre al Prefetto, anche un ar-civescovo, verosimilmente allo scopo di equiparare il rango ecclesiastico aquello civile90.
Tuttavia un simile progetto – ammesso che la nostra ipotesi sia corretta– non fu pienamente realizzato. Si è detto che Justiniana Prima non diven-ne mai la sede del Prefetto. Essa conservò invece il suo rango di arcivesco-vado, come attestano pochi anni dopo alcune lettere di papa Gregorio Ma-gno91. La città in ogni caso non sembra avere resistito all’ondata avaro-sla-va che si riversò sulla penisola balcanica nel VII secolo92 e la menzione del-l’arcivescovado in una assai più tarda Notitia episcopatuum93 è legata a com-plesse questioni politico-ecclesiastiche che esulano dal presente lavoro94.Ciò che qui preme invece evidenziare è come Justiniana Prima costituiscaun esempio emblematico della volontà di mascherare sotto l’apparenza del-la continuità – il ripristino dei diritti di Sirmio in quanto capitale della Pre-fettura – quello che nella realtà dei fatti avrebbe rappresentato, se portato atermine, un profondo cambiamento, un tentativo di ridisegnare la geogra-fia amministrativa ed ecclesiastica di un’intera regione.
Tornando adesso al resoconto di Procopio sulla ricostruzione giustinia-nea nell’Illirico, altri casi interessanti sono Evria nell’Epirus Vetus e Diocle-zianoupoli/Kastoria, che lo storico colloca in Tessaglia95, due esempi di ri-costruzione operata per traslazione dalla località originaria ad un’altra.
166
(praesertim pp. 298 s.); PIB, II, s.v. Maximianus 3, pp. 369-371. Sull’attività erudita, più pre-cisamente ecdotica, di san Massimiano v. BURGARELLA 2005, pp. 125 s.
90 Cfr. VON FALKENHAUSEN 1992, pp. 257 s.91 Gregori Magni registrum epistularum, epp. III 6; 7; V 8; VIII 10; IX 157; XI 29; XII 11.92 “La città rimarrà nell’abbandono all’incirca dopo il primo quindicennio del VII se-
colo, a seguito di un grave incendio, probabilmente collegabile con l’avanzata avaro-slavanei Balcani”: CONCINA 2009, p. 104. Sull’ultima fase della vita del sito di Caričin Grad v.POPOVIČ 1975, pp. 497 ss.
93 DARROUZÈS 1981, nr. 13, pp. 371 s. (cfr. ibid., pp. 152 s.).94 Cfr. HONIGMANN 1939-1944, p. 141, n. 1: “It is well known that since the 12th cen-
tury the archibishops of Achrida (Ochrid, the ancient Lychnidus) have pretended thattheir see is identical with Justiniana Prima, in order to justify their claim to autocephalousrights”.
95 GREGORY 2000, p. 107 ritiene erronea questa informazione di Procopio, rinviandoa KERAMOPOULLOS 1930-1932 (in realtà 1932), pp. 55-63. Tuttavia nel lavoro di Keramopoul-
167
Dopo essersi inoltrato nell’interno della penisola balcanica il nostroAutore era ritornato sulla costa, tracciando un nuovo percorso descrittivoa partire da Nicopoli, appunto nell’Epirus Vetus96:
“(39) In questa regione si trovava poi un’antica città ricca di acque, il cui nome corri-sponde perfettamente a tale caratteristica: (40) fin dalle sue origini infatti fu chiamata Eu-roia. Non molto distante da questa si trova un lago in mezzo al quale giace un’isola su cuisorge un’altura. (41) Il lago presenta un passaggio tale da consentire l’accesso ad una partedell’isola (42) e lì l’imperatore, dopo avere costruito una città fortificata e assai sicura, tra-sferì gli abitanti di Euroia”.
Più avanti, nel terzo capitolo del IV libro, la descrizione di Procopioprocede dalle Termopili verso Nord97:
“(1) In Tessaglia esisteva una città, Dioclezianoupoli, un tempo prospera, oggi distruttadalle invasioni dei barbari e da moltissimo tempo abbandonata. Nelle sue vicinanze si trovaun lago chiamato Castoria, al cui centro sorge, circondata dalle sue acque, un’isola, (2) l’ac-cesso alla quale è consentito da una stretta lingua di terra larga non più di quindici piedi. (3)Sull’isola si innalza una montagna molto alta, per metà nascosta dal lago, mentre l’altra metàsi erge al disopra di esso. (4) L’imperatore lasciò perdere il territorio di Dioclezianoupoli poi-ché chiaramente di facile accesso e ormai da lungo tempo in rovina, come abbiamo già detto,e fece costruire sull’isola una città sicura cui, come è giusto, assegnò il nome”.
La traslazione dei due siti di Euroia e Dioclezianoupoli presenta evi-denti analogie. In entrambi i casi difatti la popolazione è stata trasferita inun nuovo centro edificato su una propaggine di terra protesa su di unospecchio d’acqua. È vero che Procopio parla di isole, ma queste in effettisono collegate alla terraferma da un istmo.
Sia per Euroia che per Dioclezianoupoli/Kastoria Procopio utilizza iltermine polis. Tuttavia le scelte effettuate in fase di ricostruzione in rap-porto al sito e alle caratteristiche strutturali rivelano chiaramente, a miosommesso avviso, come anche questi centri abbiano oramai acquisito la fi-
los a p. 56 leggiamo (traduco dal greco moderno): “Sicché Dioclezianoupoli, collocata inquella che per Procopio è la Tessaglia, deve essere ricercata in quella che per noi è la Ma-cedonia occidentale, nei pressi del lago di Kastoria”. È evidente come nulla sia detto a pro-posito di un errore dello storico bizantino, tantoppiù che Dioclezianoupoli viene annove-rata fra le città tessale anche dal Synekdemos di Ierocle, un testo datato 527/8 ma che foto-grafa una situazione di epoca precedente: PAPAZOTOS 1988, p. 198; CROKE 2001, p. 51, n.6. Non è da escludere dunque, analogamente a quanto osservato a proposito della colloca-zione di Justiniana Prima (v. supra, p. 160, n. 55), che anche in questo caso abbiamo a chefare con un problema di fluttuazione dei confini delle singole province.
96 PROCOP. Aed. IV 1.39-42.97 Ibid. IV 3.1-4.
sionomia del kastron. Ciò risulta evidente innanzitutto dalla selezione delnuovo sito, del tutto in linea con quanto prescritto dal trattato De re stra-tegica98 dove, ricordiamo, vengono ascritti alla polis quelli che sono in ef-fetti i requisiti propri del kastron99:
“Risultano idonee per la fondazione di una città […] le zone poste nei pressi di alture(Óca kat6 lÒfwn ke‹tai), con dirupi che chiudano tutt’intorno l’accesso, come anchequelle che sono circondate da grandi fiumi […] e ancora quelle situate su lingue di terraprotese sul mare o su grandi fiumi, collegate alla terraferma da passaggi assai stretti”.
Appaiono inoltre significative alcune espressioni riferite ad Euroia: ilnuovo centro (odierna Kastri100) sorge su di un’altura, indicata con il ter-mine lÒfoc – lo stesso utilizzato nel passo del De re strategica testé ripor-tato; esso è poi dotato di una cinta muraria (™teic…cato). La nuova Euroiapresenta dunque non solo la collocazione, ma anche gli elementi struttura-li tipici del kastron.
In relazione a questo centro è interessante notare come il cambia-mento non abbia comportato un mutamento del nome, cosa che invecesembra essersi verificata, come vedremo, nel caso di Dioclezianoupoli. Iltrasferimento si è quindi svolto, per gli abitanti di Euroia, nel rispetto del-l’identità della comunità cittadina, anche per ciò che riguarda l’aspetto re-ligioso. Quando infatti, alla fine del VI secolo, il vescovo di Euroia insie-me al clero e, verosimilmente, a parte della popolazione101 si rifugiò pres-so il castrum Cassiopi, sull’isola di Corcira, egli recava con sé le reliquie disan Donato102 le quali evidentemente erano state traslate anche in occa-sione del primo trasferimento. Ma per i cittadini di Euroia la conserva-zione del proprio nome e delle proprie tradizioni andò con ogni probabi-lità ben oltre i confini dell’Epiro Vetus se consideriamo che il toponimo bi-zantino Evriatikon, corrispondente alla cittadina calabrese di Umbriatico(il cui patrono è, appunto, san Donato) potrebbe costituire un indizio deltrasferimento dall’Epiro in Calabria di individui appartenenti a quella co-munità, in fuga dalle invasioni avaro-slave del VI/VII secolo103.
168
98 ANONYM. Strat. 11,1-9.99 Cfr. supra, p. 158.
100 Identificata un tempo con Ioannina, sulla base di una seconda ipotesi, ritenuta piùplausibile, la nuova Euroia corrisponderebbe all’odierna località di Kastri, più vicina al vil-laggio di Glyky o Glyke, dove sembra sorgesse la città antica: CHRYSOS 1997a, pp. 155 s.
101 Cfr. STRANO 2011.102 Gregorii Magni registrum epistularum, ep. XIV 7. Cfr. FORESI 1995-1997, pp. 106-
109; STRANO 2011.103 BURGARELLA 1996, p. 70; ID. 2009b, pp. 28 s.; STRANO 2011.
169
Per ciò che concerne invece Dioclezianoupoli/Kastoria, oltre a quantoosservato per l’esempio precedente in relazione alla collocazione del sito,anche in questo caso del tutto coerente rispetto alla realtà propria di un ka-stron, è possibile menzionare la seriore testimonianza dell’Alessiade di An-na Comnena (sec. XII), la quale in effetti si riferisce al centro in questionecon il termine kastron104:
Toà mšntoi Bruenn…ou katšcontoc t¾n Kactor…an, kaq£per ¥nwqen e‡rhtai, toà-ton ™ke‹qen ™xel£cai kaˆ t¾n Kactor…an katacce‹n Ð aÙtokr£twr cpoud£zwn tÕ Ðpli-tikÕn aâqic ¢nekale‹to kaˆ Óploic ¤pantac katafr£xac prÕc teicomac…an kaˆ t¦ckat¦ toÝc œxwqen polšmouc cumplok6c tÁc prÕc tÕ k£ctron feroÚchc e‡ceto. œcti d�¹ qšcic toà tÒpou toiaÚth: l…mnh t…c ™ctin ¹ tÁc Kactor…ac, ™n Î tr£chloc ¢pÕ tÁccšrcou e„c2rcetai kaˆ perˆ tÕ ¥kron eÙrÚnetai e„c petrèdeic bounoÝc ¢poteleutîn.perˆ d� tÕn tr£chlon kaˆ pÚrgoi kaˆ mecopÚrgia òkodÒmhntai k£ctrou d…khn, Óperkaˆ Kactor…a Ñnom£zetai.
“Mentre, come si è già detto, Briennio si trovava a Castoria, l’imperatore, impazientedi cacciarlo da lì e di occupare il sito, richiamò l’esercito e, dopo avere procurato a tutti l’ar-mamento adatto per gli attacchi alle mura e per gli scontri esterni con i nemici, si diresse al-la fortezza. Queste le caratteristiche del sito: Castoria è un lago in cui si protende, a partiredalla terraferma, una lingua di terra che si allarga all’estremità terminando con alture roc-ciose. Su questa lingua di terra sono state costruite torri e mura che le congiungono a gui-sa di fortezza, che appunto è chiamata Castoria”105.
La denominazione del nuovo sito costituisce un aspetto problematico,complicato dalle incertezze relative alla identificazione dell’antica Diocle-zianoupoli “tessala”. La questione, nello specifico, è sollevata dalle paroledi Procopio tÕ Ônoma, æc tÕ e„kÕc, ¢fÁke tÍ pÒlei, “assegnò, come ègiusto, il nome alla città”. Codesta espressione è stata interpretata in tre dif-ferenti maniere: a) Giustiniano assegnò alla città il nome del centro origi-nario, Dioclezianoupoli; b) Giustiniano assegnò alla città il nome del nuo-vo sito su cui era sorta, Kastoria; c) Giustiniano diede alla città il proprionome, Justinianoupolis/Justiniana106.
Lo status quaestionis tracciato da Thanasis Papazotos nel 1988 è rima-sto a lungo sostanzialmente invariato107, ma di recente Olga Karagiorgouha riproposto l’ipotesi che il nome dato alla nuova fondazione fosse quel-
104 ANN. COMN. VI 1.1. Si tenga comunque presente quanto osservato a proposito del-l’uso seguìto dalle fonti letterarie bizantine a partire dalla metà del X secolo: v. supra, p. 159,n. 49.
105 La traduzione è mia.106 PAPAZOTOS 1988, p. 196.107 Ibid.
lo del sovrano108. In effetti una simile interpretazione non è, a mio som-messo avviso, da scartare, ma per una ragione diversa rispetto a quella chia-mata in causa dalla studiosa. Questa pone l’accento sulla «imperial menta-lity» in virtù della quale alcuni centri (Justiniana Prima e Secunda, due Ju-stinianoupolis e tre Justinianê), restaurati o del tutto ricostruiti da Giusti-niano, avrebbero preso il nome del sovrano in segno di gratitudine per lasua benevolenza. Senonché in tal caso dovremmo avere un numero di granlunga superiore di città chiamate con il nome dell’imperatore. Anche l’e-sempio di Euroia, sopra esaminato, contraddice una simile lettura. Si è vi-sto difatti come le modalità di traslazione del sito siano del tutto analoghea quelle relative a Dioclezianoupoli/Kastoria, eppure non risulta che Eu-roia abbia mutato il proprio nome.
L’ipotesi che la città abbia preso il nome di Giustiniano potrebbe inveceessere avvalorata dal confronto con un altro passo di Procopio. In Aed. II8,8-9 leggiamo: Zhnob…a pot� 'Odon£qou gun7... pÒlin õkic2 pou ™ntaàq£tina ™n to‹c ¥nw crÒnoic brace‹an, kaˆ tÕ Ônoma ¢fÁke tÍ pÒlei.Zhnob…an g6r aÙt»n, æc tÕ e„kÒc, ™pwnÒmacen109, “un tempo Zenobia,moglie di Odenato … eresse all’incirca da queste parti una città nei tempi an-tichi piccola, e le assegnò il nome. Infatti, come è giusto, la chiamò Zenobia”.È evidente come le parole dello storico siano assolutamente identiche nel ca-so di Dioclezianoupoli e in quello di Zenobia. Dunque è abbastanza verosi-mile che, come Zenobia diede il proprio nome alla città da lei fondata, ancheGiustiniano abbia fatto la stessa cosa con Dioclezianoupoli.
La nuova denominazione non sembra però avere avuto fortuna dal mo-mento che non troviamo alcuna attestazione, nelle fonti attualmente a nostradisposizione, di una Justinianoupolis o Justiniana di Tessaglia. In questo ca-so ha evidentemente avuto la meglio il nome del luogo che aveva ospitato lariedificazione, Kastoria, nome che del resto pare avesse già soppiantato ilprecedente. Kastoria infatti sorgeva sull’antica K»lhtron, ossia l’oppidum diCeletrum di cui parla lo storico latino Tito Livio (31,40)110: inde impetum inOrestidem fecit et oppidum Celetrum est aggressus, in peninsula situm. Lacusmoenia cingit; angustiis faucibus unum ex continenti iter est. Questo dato ciconsente tra l’altro di ipotizzare che la ricostruzione dell’antica Dioclezia-noupoli sia stata realizzata combinando traslazione del sito e riedificazionedi una preesistente fortezza, o almeno di ciò che ne rimaneva.
Appare chiaro dunque da quanto detto come, nel quadro della politicagiustinianea di ricostruzione attuata nella Prefettura del Pretorio dell’Illiri-
170
108 KARAGIORGOU 2001, I, pp. 159 s.109 Il corsivo è mio.110 KERAMOPOULLOS 1932, p. 60.
171
co sia possibile riconoscere sotto forme diverse il realizzarsi dei due aspettidella continuità e del mutamento. L’analisi proposta dimostra inoltre, in ri-ferimento all’Illirico, la validità di quanto è stato osservato per l’odierna Ca-labria111 circa l’opportunità di superare la communis opinio che ritrae i Bi-zantini come dominatori interessati esclusivamente allo sfruttamento fisca-le dei territori loro assoggettati. Nell’Illirico, come in Italia e certamente inaltre regioni dell’Impero la dominazione bizantina si accompagnò ad unacura pressoché costante del territorio e dei sudditi, la cui incolumità venivaricercata e garantita anche attraverso una accorta politica di ricostruzione.Le differenti modalità attraverso cui questa veniva condotta contribuivanoinoltre a modificare sensibilmente i connotati insediativi delle aree interes-sate: l’attenzione per la salvaguardia degli antichi abitati da una parte, la ri-cerca di nuove, più sicure dislocazioni dall’altra hanno prodotto, a Bisanziocome altrove, un lento quanto inesorabile cambiamento112.
111 BURGARELLA 2006.112 Per ragioni di spazio non è stato possibile discutere in questa sede un ulteriore
aspetto interessante, inerente i costi della ricostruzione: in che percentuale, cioè, essi fosse-ro sostenuti dalle casse dello Stato e quanto invece gravassero sulle spalle delle popolazio-ni locali. L’assenza di sistematicità osservata in riferimento alla ricostruzione giustinianeanell’Illirico (WOZNIAK 1982, p. 204) potrebbe in effetti essere interpretata alla luce dellamancanza di un vero e proprio “programma” nonché del fatto che l’iniziativa della rico-struzione fosse per lo più affidata alle autorità cittadine. Queste, dal canto loro, verosimil-mente incalzate dalla necessità di ridurre i costi, potrebbero essere state indotte a privile-giare ad esempio il restauro piuttosto che l’edificazione ex novo di determinate strutture.Ciò spiegherebbe altresì per quale ragione nel De Aedificiis il numero delle fortezze re-staurate risulti di gran lunga superiore rispetto a quello delle nuove costruzioni, così comeosservato da WOZNIAK 1982, p. 199.
172
Bibliografia
ACOActa Conciliorum Oecumenicorum, ed. E. SCHWARTZ, t. II, vol. I, 2,Berolini et Lipsiae 1933.
AGATH.Agathiae Myrinaei Historiarum libri quinque, rec. R. KEYDELL, Be-rolini 1967 (CFHB, 2).
ANASTOS 1957M.V. ANASTOS, The Transfer of Illyricum, Calabria and Sicily tothe Jurisdiction of the Patriarchate of Constantinople in 732-33, in“Silloge Bizantina” in onore di Silvio Giuseppe Mercati (= Studi Bi-zantini e Neoellenici, 9), Roma 1957, pp. 14-31, rist. in ID. 1979,IX.
ANASTOS 1979M.V. ANASTOS, Studies in Byzantine Intellectual History, London1979.
ANN. COMN.Annae Comnenae Alexias, recc. D. R. REINSCH-A. KAMBYLIS, Beroli-ni et Novi Eboraci 2001 (CFHB, 40).
ANON. Strat.Anonymus De re strategica, in Three Byzantine Military Treatises,ediz. a cura di G.T. DENNIS, Washington, D.C., 1985 [CFHB, XXV= Dumbarton Oaks Texts, IX], pp. 1-136.
AUBERT 2003R. AUBERT, Justiniana Prima, in Dictionnaire d’histoire et de géographieecclésiastiques, sous la direction de R. AUBERT, vol. XXVIII, Paris2003, coll. 675-676.
BAVANT 1984B. BAVANT, La ville dans le Nord de l’Illyricum (Pannonie, Mésie I, Da-cie et Dardanie), in Villes et peuplement, pp. 245-288.
BAVANT 2007B. BAVANT, Caričin Grad and the Changes in the Nature of Urbanismin the Central Balkans in the Sixth Century, in POULTER 2007, pp.337-374.
BROGIOLO-WARD-PERKINS 1999G. P. BROGIOLO-B. WARD-PERKINS, The idea and ideal of the Townbetween Late-Antiquity and the Early Middle Ages, Leiden 1999.
BURGARELLA 1989F. BURGARELLA, Le terre bizantine (Calabria, Basilicata e Puglia), inGALASSO-ROMEO 1989, pp. 413-517.
173
BURGARELLA 1996F. BURGARELLA, Calabria bizantina e cultura greca, in La Calabria clas-sica e bizantina, pp. 63-95.
BURGARELLA 2001F. BURGARELLA, Il Medioevo, in MAZZA 2001, pp. 61-71.
BURGARELLA 2005F. BURGARELLA, Ravenna e l’Italia meridionale e insulare, in Raven-na, pp. 101-133.
BURGARELLA 2006F. BURGARELLA, Fondazione di città e costruzione di kastra: aspetti tec-nici, in BURGARELLA-IERACI BIO 2006, pp. 193-205.
BURGARELLA 2009aF. BURGARELLA (a cura di), San Nilo di Rossano e l’abbazia greca diGrottaferrata. Storia e immagini, Roma 2009.
BURGARELLA 2009bF. BURGARELLA, La Calabria bizantina (VI-XI secolo), in BURGAREL-LA 2009a, pp. 19-38.
BURGARELLA-IERACI BIO 2006F. BURGARELLA-A. M. IERACI BIO (a cura di), La cultura scientificae tecnica nell’Italia meridionale bizantina, Atti della sesta Giornatadi studi bizantini (Arcavacata di Rende, 8-9 febbraio 2000), Sove-ria Mannelli 2006.
La Calabria classica e bizantinaLa Calabria classica e bizantina. Atti del Convegno Nazionale di Stu-di, Castrovillari, 11-12 Novembre 1995, Castrovillari 1996.
CAVALLO 1992G. CAVALLO (a cura di), L’uomo bizantino, Roma-Bari 1992.
CESARETTI 2008P. CESARETTI, All’ombra di una preterizione: Proc. Aed. I 1,1, “RSBN”n.s. 45, 2008, pp. 153-178.
CHRYSOS 1997aE. CHRYSOS, Roads, cities and fortresses of Epirus, in SAKELLARIOU
1997, pp. 151-156.CHRYSOS 1997b
E. CHRYSOS, Barbarian invasions, in SAKELLARIOU 1997, pp. 161-165.Codex Theodosianus
Theodosiani libri XVI cum constitutionibus sirmondianis et legesnovellae ad theodosianum pertinentes, vol. I, t. 2, ed. TH. MOMMSEN,rist. anast., Weidmann 1971.
CONCINA 2009E. CONCINA, La città bizantina, Roma-Bari 20092.
CROKE 2001B. CROKE, Count Marcellinus and his Chronicle, Oxford 2001.
CROW 1995J. G. CROW, The Long Walls of Thrace, in MANGO-DAGRON-GREATREX
1995, pp. 109-124.DAGRON 1984
G. DAGRON, Les villes dans l’Illyricum protobyzantin, in Villes et pe-uplement, pp. 1-20.
DARROUZÈS 1981Notitiae Episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae, Texte critique,introduction et notes par J. DARROUZÈS, Paris 1981.
De Aedificiis. Le texte de Procope et les réalités, “AnTard” 8, 2000.Destinées de l’Illyricum méridional
Les destinées de l’Illyricum méridional pendant le haut Moyen Âge,“MEFRM” 120/2, 2008.
DOWNEY 1939G. DOWNEY, Procopius on Antioch: a study of method in the «De Aed-ificiis», “Byzantion” 14, 1939, pp. 361-378.
DOWNEY 1947G. DOWNEY, The composition of Procopius’ De aedificiis, “TAPhA”78, 1947, pp. 171-183.
DUNN 1994A. DUNN, The transition from polis to kastron in the Balkans (III-VIIcc.): general and regional perspectives, “BMGS” 18, 1994, pp. 60-80.
DUVAL 1984N. DUVAL, L’architectur religieuse de Tsaritchin Grad dans le cadre del’Illyricum oriental au VIe siècle, in Villes et peuplement, pp. 399-481.
ELSNER 2007J. ELSNER, The rhetoric of Buildings in the De Aedificiis of Procopius,in JAMES 2007, pp. 33-57.
EVAG. HEEVAGRIUS, Ecclesiastical History, edd. J. Bidez-L. Parmentier, Lon-don 1898, rist. anast. Amsterdam 1964.
VON FALKENHAUSEN 1978V. VON FALKENHAUSEN, La dominazione bizantina nell’Italia meri-dionale dal IX all’XI secolo, trad. ital., Bari 1978.
VON FALKENHAUSEN 1992V. VON FALKENHAUSEN, Il vescovo, in CAVALLO 1992, pp. 253-290.
FEISSEL 1988D. FEISSEL, L’architecte Viktôrinos et les fortifications de Justiniendans les provinces balkaniques, “BSNAF” 1988, pp. 136-146.
174
175
FEISSEL 2000D. FEISSEL, Les édifices de Justinien au témoignage de Procope et del’épigraphie, in De Aedificiis. Le texte de Procope et les réalités, pp.81-104.
FORESI 1995-1997A. FORESI, Calabria e penisola balcanica tra VI e VII secolo. La dia-spora dei vescovi balcanici, “Miscellanea di Studi Storici” X, 1995-1997, pp. 99-111.
GALASSO-ROMEO 1989G. GALASSO-R. ROMEO (a cura di), Storia del Mezzogiorno, vol. II, t.II, Il Medioevo, Napoli 1989.
Gregorii Magni registrum epistularumGregorii Magni registrum epistularum, voll. I-IV, ediz. a cura di D.NORBERG con trad. ital. di V. RECCHIA, Roma 1996-1999.
GREGORY 1979T.E. GREGORY, The Late Roman Wall at Corinth, “Hesperia” 48,1979, pp. 264-280.
HALDON 1999J. HALDON, The idea of the Town in the Byzantine Empire, in BRO-GIOLO-WARD-PERKINS 1999, pp. 1-23.
HOHLFELDER 1982R. L. HOHLFELDER (a cura di), City, Town and Countryside in theEarly Byzantine Era, New York 1982.
HONIGMANN 1939-1944E. HONIGMANN, Meridianus episcopus, “AIPhO” 7, 1939-1944, pp.141-154.
HORDEN 2005P. HORDEN, Mediterranean Plague in the Age of Justinian, in MAAS
2005, pp. 134-160.IO. MAL.
Ioannis Malalae Chronographia, recensuit I. THURN, Berolini et NoviEboraci 2000 (CFHB, 35).
JAMES 2007L. JAMES, Art and Text in Byzantine culture, New York 2007.
KARAGIORGOU 2001O. KARAGIORGOU, Urbanism and Economy in Late Antique Thessaly(3rd-7th century A.D.). The Archaeological Evidence, A thesis in threevolumes (vol. 1: Text, vol. 2: Appendices and tables, vol. 3: Illustra-tions) submitted for the degree of Doctor of Philosophy, Trinity2001.
KERAMOPOULLOS 1932A.D. KERAMOPOULLOS, 9OrectikÕn ”Argoc-DioklhtianoÚpolic-Kac-tor…a, “Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher” 9, 1932, pp. 55-63.
LEMERLE 1954P. LEMERLE, Invasions et migrations dans les Balkans depuis la fin del’époque romaine jusqu’au VIIIe siècle, “RH” 211, 1954, pp. 265-308,rist. in LEMERLE 1980, I.
LEMERLE 1980P. LEMERLE, Essais sur le monde byzantin, London 1980.
LITTLE 2007L.K. LITTLE (a cura di), Plague and the end of the Antiquity. The Pan-demic of 541-750, Cambridge 2007.
MAAS 2005M. MAAS (a cura di), The Cambridge Companion to the Age of Jus-tinian, Cambridge 2005.
MANGO-DAGRON-GREATREX 1995Constantinople and its Hinterland, Papers from the Twenty-seventhSpring Symposium of Byzantine Studies, Oxford, April 1993, Edit-ed by C. MANGO and G. DAGRON with the assistance of G.GREATREX, Aldershot 1995.
MARAVAL 1999P. MARAVAL, L’empereur Justinien, Paris 1999.
MARKUS 1979R.A. MARKUS, Carthage-Prima Justiniana-Ravenna. An Aspect of Jus-tinian’s Kirchenpolitik, “Byzantion” 49, 1979, pp. 277-302, rist. inID. 1983, XIII.
MARKUS 1983R.A. MARKUS, From Augustine to Gregory the Great. History andChristianity in Late Antiquity, London 1983.
MAZZA 2001F. MAZZA (a cura di), Lamezia Terme. Storia cultura economia, Sove-ria Mannelli 2001.
MEIER 2007M. MEIER, Giustiniano, trad. ital., Bologna 2007.
MUÇAI 2008S. MUÇAI, Aperçu des données archéologiques dans le territoire alba-nais (IVe-VIIe siècles), in Destinées de l’Illyricum méridional, pp. 377-384.
NEDUNGATT-FEATHERSTONE 1995G. NEDUNGATT-M. FEATHERSTONE (edd.), The Council in Trullo re-visited, Roma 1995 (Kanonika, 6).
176
177
Nov. Just.Corpus Juris Civilis, III, Novellae Justiniani, edd. R. SCHOELL-D. KROLL,Berolini 1895.
PATOURA-HATZOPOULOS 1980S. PATOURA-HATZOPOULOS, L’oeuvre de reconstitution du limes danu-bien à l’époque de l’empereur Justinien Ier, “RESE” 18, 1980, pp. 95-109.
PAPAZOTOS 1988TH. PAPAZOTOS, Anackaf1 DioklhtianoupÒlewc. Oi prètec ek-tim1ceic, “AD” 43, 1988 [1995], A, pp. 195-218.
PCHBE2CH. PIETRI (†)-L. PIETRI, Prosopographie Chrétienne du Bas Empire,2, Prosopographie de l’Italie Chrétienne, 2 voll., Rome 2000.
PERRIN-HENRY 1981M. PERRIN-HENRY, La place des listes toponymiques dans l’organisa-tion du livre IV des edifices de Procope, “Geographica Byzantina”1981, pp. 93-106.
PIBS. COSENTINO, Prosopografia dell’Italia Bizantina (493-804), vol. I(A-F), Bologna 1996; vol. II (G-O), Bologna 2000.
PIETRI 1984CH. PIETRI, La géographie de l’Illyricum ecclésiastique et ses relationsavec l’Église de Rome (Ve-VIe siècles), in Villes et peuplement, pp. 21-62.
PILARA 2008G. PILARA, Massimiano, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol.71, Roma 2008, pp. 780-782.
PLRE IIIJ.R. MARTINDALE, The Prosopography of the Later Roman Empire,III, Cambridge 1992.
POPOVIČ 1975V. POPOVIČ, Les témoins archéologiques des invasions avaro-slavesdans l’Illyricum byzantin, “MEFRA” 87/1, 1975, pp. 445-504.
POULTER 2007A.G. POULTER (ed.), The transition to Late Antiquity on the Danubeand beyond, Oxford 2007 (Proceedings of the British Academy, 141).
PROCOP. Aed.Procopii Caesarensis opera omnia, ediz. a cura di J. HAURY, rivedutada G. WIRTH, vol. IV, De Aedificiis, Lipsiae 1964.
PROCOP. Bell.Procopii Caesarensis opera omnia, ediz. a cura di J. HAURY, rive-duta da G. WIRTH, voll. I-II, De Bellis, Lipsiae 1963.
PROCOP. An.Procopii Caesarensis opera omnia, ediz. a cura di J. HAURY, rivedutada G. WIRTH, vol. III, Historia quae dicuntur arcana, Lipsiae 1963.
PROCOP. GAZ. Pan.Procopius Gazaeus Opuscula rhetorica et oratoria, ed. E. AMATO, Be-rolini et Novi Eboraci 2009, pp. 80-104.
PROCOPIO, Storie segrete, Introduzione, revisione critica del testo e note diF. CONCA, Versione italiana di P. CESARETTI, Milano 19992.
Procopius, with an english translation by H.B. DEWING, VII, Buildings,London-Cambridge Massachusetts 1971.
RAVEGNANI 1982G. RAVEGNANI, Kastron e Polis: ricerche sull’organizzazione territo-riale nel VI secolo, “Rivista di Studi Bizantini e Slavi” 2, 1982, pp.271-282.
RAVEGNANI 1983G. RAVEGNANI, Castelli e città fortificate nel VI secolo, Ravenna 1983.
RAVEGNANI 2009G. RAVEGNANI, Soldati e guerre a Bisanzio. Il secolo di Giustiniano,Bologna 2009.
RavennaRavenna da capitale imperiale a capitale esarcale, Atti del XVII Con-gresso internazionale di studio sull’alto medioevo (Ravenna, 6-12giugno 2004), Spoleto 2005.
ROQUES 2000D. ROQUES, Les Constructions de Justinien de Procope de Césarée, inDe Aedificiis. Le texte de Procope et les réalités, pp. 31-43.
RUBIN 1960-1995B. RUBIN, Das Zeitalter Justinians, 2 voll., Berlin-New York 1960-1995.
SAKELLARIOU 1997M. B. SAKELLARIOU (a cura di), Epirus. 4000 years of greek historyand civilization, Athens 1997.
SARRIS 2007P. SARRIS, Bubonic Plague in Byzantium. The Evidence of Non-Liter-ary Sources, in LITTLE 2007, pp. 119-132.
STATHAKOPOULOS 2007D. STATHAKOPOULOS, Crime and Punishment. The Plague in theByzantine Empire 541-749, in LITTLE 2007, pp. 99-118.
STEIN 1968E. STEIN, Histoire du Bas-Empire, II, De la disparition de l’Empired’Occident à la mort de Justinien (476-565), Paris 1949.
178
179
STRANO 2011G. STRANO, Corcyra in età bizantina: crocevia di culture e di popoli (incorso di stampa).
SYM. MAG.Symeonis Magistri et Logothetae Chronicon, recensuit S. WAHLGREN,Berolini et Novi Eboraci 2006 (CFHB, 44).
TATE 2004G. TATE, Justinien. L’épopée de l’Empire d’Orient (527-565), Paris 2004.
VEIKOU 2010M. VEIKOU, Urban or rural? Theoretical remarks on the Settlement Pat-terns in Byzantine Epirus (7th-11th centuries), “ByzZ” 103/1, 2010, pp.171-193.
Villes et peuplement = Villes et peuplement dans l’Illyricum protobyzantin,Actes du colloque organisé par l’École française de Rome (Rome,12-14 mai 1982), Rome 1984 (Collection de l’École française de Ro-me, 77).
WHITBY 2000M. WHITBY, Procopius’ Buildings, book I: a panegirical perspective, inDe Aedificiis. Le texte de Procope et les réalités, pp. 45-57.
WOZNIAK 1982F.E. WOZNIAK, The Justinian Fortification of Interior Illyricum, inHOHLFELDER 1982, pp. 199-209.