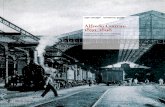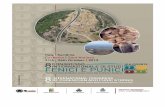Alfredo Cottrau 1839_1898 L'architettura del ferro nell'Italia delle grandi trasformazioni
Il Piano INA-Casa. Un programma di ricostruzione fisica, economica e sociale nell'Italia degli anni...
Transcript of Il Piano INA-Casa. Un programma di ricostruzione fisica, economica e sociale nell'Italia degli anni...
Politecnico di MilanoFacoltà di Architettura e Società
Corso di Laurea in Urbanistica
Corso Integrato
Storia della città e del territorioprof. Alessandro De Magistris
Matteo VerdelliMatricola: 732517
Il Piano Ina – Casa
Un programma di ricostruzione fisica, economica e sociale nell'Italia degli anni '50.
Approfondimento sul casostudio della Falchera di Torino.
Indice
Parte prima. Inquadramento generale
I. La condizione storico-politico-economica dell'Europa e dell'Italia dopo la seconda guerramondiale.
Parte seconda. Il piano Ina-Casa
I. Il piano Ina-Casa: i protagonisti, le scelte, i luoghi, i tempi e i mezzi.
II. Genealogie del piano Ina-Casa: le proposte italiane al problema casa dal 1939 al 1950.
III.Il piano alla scala urbana: i modelli da seguire, i manuali come strategia normativa e leaspirazioni degli urbanisti italiani.
IV. Il piano alla scala dell'architettura: le tecniche edilizie e le scelte architettoniche etecnologiche e il rilancio della figura dell'architetto.
V. Gli esiti: un bilancio critico del piano osservato ai nostri giorni.
Parte terza. Approfondimento: Torino, La Falchera (1950/1956) di Giovanni Astengo.
I. Il progetto: i modelli, i protagonisti, le risorse, l'evoluzione e l'esito attuale del processocon approfondimenti su alcuni blocchi di edifici.
1.ILa condizione storico-politico-economica
dell'Europa e dell'Italia dopo la seconda guerra mondiale.
Prima della seconda guerra mondiale, in seguito alla crisi economica del 1929, in Europa si era ampiamentediffuso il modello economico keynesiano secondo il quale lo Stato deve investire in programmi di diversanatura creando inflazione nelle sue casse ,a offrendo allo stesso tempo lavoro e reinserendo i lavoratori nelmercato dell'economia di consumo. Questo modello fu per primo adottato nel New Deal Roosveltiano ma verràpoi reinterpretato e preso a modello anche nella risoluzioni di diversi problemi di natura economica e socialecome vedremo in seguito anche in Italia. Nel frattempo il dibattito urbanistico è più vivo che mai sia in ambitointernazionale dove si discute tra la visione monumentale adottata nel piano di Mosca del 1933 e la visionerazionale del Movimento Moderno ormai diffusa ediscussa sia in Europa che in America grazie ai Ciam.In Italia il fascismo si configura come un'esperienza dimodernizzazione con specificità e affinità rispetto adaltre esperienze totalitarie. Negli anni venti è stato creatoil primo insegnamento universitario di architettura el'architetto viene per la prima volta visto come una figuracentrale che deve unire sapere tecnico e teorico. In pochianni la figura dell'architetto si ritaglia un ruolodeterminante nella storia del paese: raccolti nelSindacato Fascista Architetti essi avevano messo adisposizione del regime impegnato a raggiungere e aconsolidare il consenso, le loro abilità e conoscentetecniche e teoriche attraverso la costruzione di cittànuove (Sabaudia ad esempio), di piani regolatori, discuole, di asili e di case del fascio (solo per l'Operanazionale balilla si fanno 900 centri per giovani, 1500palestre,2500 campi sportivi). Le scelte dell'architetto elo stile architettonico tuttavia non sono mai obbligate dalregime ma è sempre più diffuso un clima di liberasperimentazione e diffusione delle idee del dibattitointernazionale.La Seconda Guerra Mondiale sconvolge completamentequesto sistema consolidato: porta sconvolgimenti edistruzioni fisiche che consentono l'applicazionedell'ideologia moderna della tabula rasa e di ricostruirepoggiandosi sul dibattito e gli orientamenti architettonicidiscussi prima della guerra; è cambiato completamente ilpiano politico in quanto sono scomparse le grandipotenze degli anni 30 (Germania e l'Impero colonialeInglese su tutti) ed il mondo sta per essere spartito tradue nuove potenze con modelli economici, politici esociali completamente differenti: il modello statunitense dell'economia fortemente capitalista e di consumo chelascia libera iniziativa all'autoregolamentarsi del mercato nell'Europa Occidentale completamente diverso dalmodello sovietico fondato sulla pianificazione dell'economia e la centralità dello stato negli interventi ditrasformazione delle città. La politica urbanistica si rivela sin da subito inscindibile dalla nuova dimensioneeconomica e politica che l'Europa ha assunto in questi anni e che influenzerà la ricostruzione del dopoguerra.In Italia la legge del fascista in materia urbanistica del 1942 ha introdotto una pianificazione gerarchica acascata che vuole coinvolgere tutto il territorio nella pianificazione e che presuppone un apparato autoritarioche controlli ed incentivi l'uso del piano in integrazione con le forze e le iniziative del libero mercato. Tuttaviaquesto modello di pianificazione passa dopo la guerra ad uno stato democratico liberistico di ispirazionestatunitense completamente differente ideologicamente dal regime, in cui i piani vengono si elaborati ma contempi lunghissimi mentre le forze del libero mercato imprimono in brevissimo tempo un'impronta dispeculazione alla ricostruzione italiana senza alcun legame con il territorio e con strategie generali ma solo
Illustrazione 1: Fotografia della distruzione di Romanel dopoguerra
Illustrazione 2: Fotografia di un intervento diricostruzione nel dopoguerra
come interventi parziali e distaccati tra loro. A ciò si aggiunge il fatto che il crollo del regime ha travolto laposizione di prestigio degli architetti raggiunta alla fine del ventennio in quanto la condanna politica contro ilfascismo viene rivolta anche contro le opere di regime e i progettisti compromessi con il fascismo.In questo confuso contesto di politiche urbanistiche e di profili professionali incerti si inserisce il Piano Ina-Casa come atto pianificatorio di carattere economico e keynesiano che si pone l'obiettivo di modernizzare ilpaese dando nuovo opportunità di lavoro e assorbendo la disoccupazione.
2.IIl piano Ina-Casa:
i protagonisti, le scelte, i luoghi, i tempi e i mezzi.
“La concezione del piano è partita dalla visione del disagio di tanti milioni di disoccupati italiani, non solo nelfisico per la mancanza del pane quotidiano, ma anche nello spirito perché privati del lavoro come componentedella propria personalità.”
Filiberto Guala, presidente Comitato d'attuazione Ina-Casa
“Il piano per la costruzione di case per lavoratori è nato per la preoccupazione, in me vivissima fin dai primimesi dopo l'assunzione del ministero, di recare un contributo al riassorbimento dei troppi disoccupati italiani.Reputai utile rivolgere il mio sguardo alle costruzioni edilizie visto che esse sono le più capaci a fungere davolano nel sistema economico.”
Amintore Fanfani, ministro del Lavoro e ideatore del piano Ina-Casa
Le parole di queste due personalità di spicco della ricostruzione italiana nel dopoguerra sono già abbastanzachiare per capire quali fossero gli obiettivi e le scelte del piano di ricostruzione che sto per presentare.Nonostante studi recenti (si veda 2.III Genealogie del piano Ina-Casa) dimostrano come il problema delladisoccupazione e della casa operaia abbiagenealogie e intrecci più articolati, il pianoesposto da Fanfani può essere consideratocome il primo piano generale italiano dicostruzione della città pubblica, diintervento statale per indirizzare econtrollare la ricostruzione fino a quelmomento, ma anche oltre questo pianocome vedremo, in prevalenza orientataverso l'azione privata e parziale e in molticasi la speculazione edilizia.
Nella seduta del Consiglio dei ministri del6 luglio 1948 Fanfani presenta il disegno dilegge “per incrementare l'occupazioneoperaia, agevolando la costruzione di caseper lavoratori”. Il 12 luglio la propostaviene illustrata alla Camera che la approva appena un mese dopo, il 4 agosto. Dopo alcune modifiche vieneapprovata dal Senato e nuovamente dalla Camera il 24 febbraio 1949 e quattro giorni dopo viene firmata dalPresidente della Repubblica Luigi Enaudi la legge n.43 Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia,agevolando la costruzione di case per lavoratori dando avvio il 1 aprile dello stesso anno al primo settennio diattività del piano Ina-Casa. La legge prevede che il piano sia finanziato da un sistema misto al quale dovranno partecipare lo Stato, i datoridi lavoro e i lavoratori stessi attraverso la trattenuta di un salario mensile. Tra differenze e timori verso unacomplessa, lenta e costosa macchina di burocrati, il funzionamento è affidato ad un organismo centralizzato esnello. L' Ente assume una struttura diarchica: da un lato il Comitato di attuazione che emana norme,distribuisce i fondi e vigila il piano, dall'altra la Gestione Ina-Casa che si occupa degli aspetti architettonici eurbanistici del piano, oltre a quelli amministrativi e di controllo dell'operato degli enti gerarchicamentesottostanti. Gli organi centrali del piano si appoggiano localmente sulle stazioni appaltanti alle quali sonoassegnate compiti relativi all'attività di costruzione degli edifici e amministrazione degli alloggi.A presiedere il Comitato di attuazione viene chiamato Filiberto Guala manager capace e legato al gruppo dicattolici di sinistra che guiderà il gruppo fino al 1960 prima di ritirarsi per entrare nell'Ordine dei frati trappisti.A capo della Gestione viene chiamato Arnaldo Foschini, uomo politico capace e abile stratega con amicizie eaccordi con la maggioranza delle istituzioni coinvolte nel piano, nonché uomo di fiducia della categoriaprofessionale degli architetti. Proprio questa sua ultima caratteristica lo indurrà a volere un massiccio
Illustrazione 3: Amintore Fanfani a Milano nel 1948
coinvolgimento degli architetti nel piano tanto da renderli i veri protagonisti di questa fase della ricostruzioneitaliana (si veda dopo 2.IV il piano alla scala architettonica). Foschini incarica Adalberto Libera di dirigerel'ufficio architettura della Gestione; costui pur restando solo fino al 1952 avrà un ruolo importantenell'impostazione del piano per la correzione e il vaglio dei progetti e per la redazione della prima manualisticadell'Ina-Casa.L'avvio del piano è caratterizzato da grande rapidità: già nel luglio 1949 si inaugura il primo cantiere e vengonorealizzati settimanalmente 2800 alloggi; nell'ottobre del 1949 la Gestione bandisce il primo dei numerosiconcorsi per la formazione di un albo di progettisti con la volontà di istituire uno stato maggiore di architetti dadesignare come progettisti abili a costruire case in relazione al piano Fanfani. Migliaia di architetti sarannocoinvolti e gli incarichi dell'Ina-Casa saranno la prima occasione di una certa importanza offerta nel dopoguerrae per molti giovani addirittura la prima occasione professionale, creando un nuovo rapporto tra gli architetti euna nuova clientela di massa che verrà apprezzato anche dal rappresentante degli urbanisti italiani AdrianoOlivetti.All'esaurimento del secondo settennio nel 1963 (avviato nel 1956) alcuni dati dimostrano l'efficacia del piano: èstata garantita un'occupazione stabile di 40000 lavoratori edili all'anno con un totale di oltre 5000 cantieri apertisu un totale di 8000 comuni; sono stati costruiti 355000 alloggi, corrispondenti al 10% del totale dellaabitazioni costruite nel periodo. Questi ultimi non sono dati eccezionali se confrontati al fabbisogno abitativodel dopoguerra e se confrontati ai dati diintervento statale europeo, ma diventanosignificativi se li consideriamo come ilsegnale di un cambiamento di rotta e diaffidamento allo Stato della ricostruzionefino a quel momento affidata come suddettoall'iniziativa privata. Grazie all'Ina-Casa migliaia di famiglieitaliane poterono migliorare le propriecondizioni abitative e gli fu garantito unaccesso alla proprietà della casa.
Illustrazione 4: Fanfani inaugura a Padova le prime case Ina
2.IIGenealogie del piano Ina-Casa:
le proposte italiane al problema casa dal 1939 al 1950.
Come precisato nell'inquadramento generale le politiche sul problema casa sono un continuum cheaccompagnano la storia dell'urbanistica e della città sin dalla rivoluzione industriale di fine '800 e che siripropongono sulla scena del dibattito ogni qualvolta un evento catastrofico e decisivo ne impongono lanecessità. Come in tutto il resto d'Europa, anche in Italia già durante la guerra intellettuali, studiosi e lo stessoregime fascista si interrogano su quale sia la soluzione migliore per migliorare le condizioni generali della casauna volta finita la guerra; è proprio a partire da queste riflessioni formulate da profili professionali diversi cheFanfani prenderà spunti e modelli per elaborare quello che sarà il suo piano per assorbire la disoccupazione erisolvere il problema casa.
Il piano Ina-Casa di Puggioni.La cronaca ci riporta che Fanfani nel giugno del 1948 ha già illustrato le sue proposte al Consiglio dei Ministriche le approverà pochi giorni dopo. Tuttavia qualcosa di importante in questa direzione è già avvenuto neigiorni precedenti quando Fanfani ha convocato presso il proprio ministero alcune personalità di spicco delmondo economico tra le quali spunta il direttore dell'Istituto nazionale di assicurazioni (Ina) Annetto Puggioni.In quella riunione il ministro espone la necessità di un provvedimento urgente per dare lavoro ai disoccupati einsieme all'Ina elaborerà la prima bozza di quello che sarà poi il decreto del ministro. Ma chi è Puggioni e per quale ragione ha un ruolo di primissimo piano nel provvedimento? Puggioni oltre adessere un esperto matematico ed il direttore generale dell'Ina, è l'autore di un progetto simile a quello presentatoda Fanfani ideato nel 1946. La sua idea prevedeva che l'Ina avrebbe emesso delle obbligazioni e che l'importoricavato da tali obbligazioni verrebbe destinato alla costruzione di case per lavoratori, l'assegnatario avrebbepagato la casa attraverso un polizza assicurativa entro venticinque anni e lo Stato avrebbe concorso in parte alpagamento rateale. La proposta di Puggioni è presa in considerazione e accettata dalla Cgil e presentata IIIgoverno De Gasperi nel marzo 1947; tuttavia sono giorni cruciali della scena politica che vedono il durodiscorso del presidente Truman sul pericolo dell'avanzata comunista e la conseguente estromissione dellesinistre da parte di De Gasperi. La proposta di Puggioni è sospesa e non può essere ripresa nella propagandaelettorale delle elezioni del 1948 poiché pare completamente inadeguato proporre nel clima di ferocecontrapposizione tra la Dc e il Fronte Popolare una proposta che aveva avuto il sostegno dei comunisti. Sidecide quindi che se ne riparlerà dopo l'esito delle elezioni, cosa che avviene prontamente nell'incontro suddettograzie all'iniziativa del nuovo Ministro del Lavoro Fanfani. Non è errato dire sulla base di queste prove che ilprogetto di Puggioni anticipa e prefigura di qualche anno il disegno di legge di Fanfani.
La casa a chi lavora di Bottoni.Nei giorni in cui Fanfani presenta alla Camera il suo piano, Piero Bottoni èall'estero dove sta tenendo una serie di importanti conferenzesull'esperienza del quartiere milanese del QT8; al suo ritorno in Italiaindividua e sottolinea ai relatori della Camera una somiglianza tra laproposta di Fanfani ed una proposta simile pubblicata da lui nel febbraiodel 1945 dal titolo La casa a chi lavora.Bottoni è sia un uomo politico di sinistra iscritto al Pci, sia uno dei piùstimati architetti italiani da sempre antifascista e rappresentante dellacategoria professionale degli ingegneri e degli architetti. La proposta diBottoni rispecchia in pieno un articolo dello stesso autore pubblicata nel1941 dalla rivista “Domus” diretta da Giuseppe Pagano, una delle voci piùincisive attorno al tema dell'abitazione popolare che denuncia con forza lapessima condizione abitativa della maggior parte degli italiani e mette indiscussione l'intera politica edilizia in Italia ma che non avrà la possibilitàdi imporsi nel dibattito del dopoguerra a causa della sua deportazione emorte nel campo di Mathausen nel 1945.Bottoni riprende il pensiero di Pagano e formula la sua proposta in basa allaquale le case avrebbero dovuto realizzarsi attraverso un istituto assicurativocreato ad hoc: il capitale di tale istituto verrebbe costituito attraverso la
Illustrazione 5: Un'immagine diPiero Bottoni in compagnia dellafamiglia
stipula di un'assicurazione obbligatoria per tutti i lavoratori che darebbe diritto al godimento dell'alloggio anchese la casa assegnata sarebbe rimasta in affitto e non in proprietà. Lo Stato e gli imprenditori avrebbe contribuitocon una parte del 75% nella creazione del capitale.Quest'idea suscita vivo interesse a diversi colleghi architetti e Bottoni cerca di far conoscere la sua propostaanche alle gerarchie del partito fascista e la invia a Mussolini stesso. Il partito invita l'architetto a far parte di uncostituendo comitato tecnico per lo studio del problema della casa operaia ma la cosa non va in porto e a causadella situazione bellica la proposta di Bottoni non verrà presa in esame né in questo momento né nellasuccessiva pubblicazione del 1945.
L'ente per la casa popolare di Miniati.A queste due proposte finora analizzate occorre aggiungerne una terza precedente di alcuni anni. Nel 1939,durante il regime fascista, nel Ministero delle Corporazioni è all'ordine del giorno il problema della casapopolare. La proposta più interessante uscita da quel dibattito è quella di Gino Miniati che prevede la creazionedi un ente apposito per la costruzione di case operaie, finanziato da vari istituti assicurativi (su tutti Ina e Inps) eche si avarrebbe dei contributi degli industriali sotto forma di anticipazioni; le case sarebbero quindi cedute inriscatto agli operai ed attraverso un piano di ammortamento l'ente recupererebbe anno per anno le anticipazioniricevute. Questa proposte viene osteggiata dalle gerarchie del partito in quanto entrerebbe in contrasto conl'attività del Consorzio degli Istituti fascisti case popolari (Ifcp) anche se la proposta di Miniati fu comunquediscussa e variamente riadattata nelle proposte del ministro dei Lavori pubblici Giuseppe Gorla nel 1941sull'onda di un programma di ricostruzione per il dopoguerra e influenzerà anche alcuni incontri-dibattito sulmedesimo tema dell'abitazione popolare tra il regime fascista e quello nazista. La proposta di Bottoni prima esposta viene elaborata mentre negli ambienti ministeriali si sta appuntodiscutendo la proposta originaria di Miniati e il gruppo a cui Bottoni viene invitato a far parte proprio perportare avanti questa discussione partecipano alcune personalità che come vedremo saranno fondamentali nelsuccessivo piano Fanfani: su tutti Gino Cipriani e Arnaldo Foschini.
L'iter parlamentare e le opposizioni al Piano Fanfani.Come già descritto in precedenza la proposta originaria di Fanfani viene approvata dal Consiglio dei ministri epresentata alla Camera nel luglio del 1948. Prevede la partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti, deidatori di lavoro e dello Stato: ai lavoratori si chiede un accantonamento obbligatorio sulla tredicesima mensilitàche verrebbe compensato con l'emissione dei buoni casa; i datori di lavoro partecipano con un contributo afondo perduto; lo Stato interviene pagando gli interessi sul “risparmio” dei lavoratori e concorre perventicinque anni ad un piano di ammortamento. L'assegnazione degli alloggi avviene attraverso un sorteggio ela struttura verrebbe gestita da un Comitato di attuazione per la costruzione degli alloggi e dall'Ina per laraccolta e la gestione dei fondi. Rispetto a Puggioni, Fanfani ha introdotto il carico ai lavoratori e l'assegnazionevia sorteggio, riprendendo l'articolato e complesso sistema di finanziamento assicurativo, rispetto a Bottoni ladifferenza riguarda l'assegnazione delle case che vengono date in proprietà mentre riprende l'idea diobbligatorietà della partecipazione operaia seppur all'interno di una visione corporativa dei finanziamenti(lavoratori, datori e Stato) e della società.Alla Camera le opposizioni principali riguardano il prestito forzoso ai danni dei lavoratori e durante ladiscussione subentrano alcune modifiche che prevedono di riequilibrare il sistema di prelievo ai danni deilavoratori attraverso delle rate mensili e non attraverso l'accantonamento obbligatorio. Allo stesso tempoFanfani è deciso a mantenere salda la sua idea originaria, mentre l'Ina riesce a ritagliarsi un maggiore spazio dipotere riuscendo a farsi affidare dalla Camera l'affidamento della gestione del piano e dotandosi di una propriapersonalità giuridica dal momento che ha la possibilità di creare un proprio consiglio direttivo in opposizione aquello del Comitato d'attuazione inizialmente previsto da Fanfani.Il Senato prende atto delle modifiche e ne aggiunge delle proprie tra le quali un ulteriore riduzione dellapercentuale a carico dei lavoratori , l'eliminazione del sistema del sorteggio e l'adozione di graduatorie sullabase di criteri di necessità e l'assegnazione in affitto di metà degli alloggi. Con queste modifiche il testo vienerispedito alla Camera che lo approverà in via definitiva, con il voto contrario dell'opposizione nel febbraio del1949.Il voto contrario deriva verte principalmente sul troppo potere attribuito all'organo Gestione Ina-Casa e per ilcontributo forzoso chiesto ai lavoratori visto però da Fanfani come contributo irrinunciabile.Ulteriori opposizioni arrivano anche dagli alleati americani. Nel novembre del 1949 Fanfani incontra DavidZellerbach, responsabile dell'amministrazione degli aiuti economici del piano Marshall. Questi chiede che ilpiano venga esteso non solo agli operai ma anche ai contadini e di incoraggiare la costruzione delle case da
parte dei privati insistendo ripetutamente di non volere eccessivi oneri sugli imprenditori. Alla base di questadivergenza di vedute c'è una diversa idea di economia, profondamente liberista quella statunitense eprofondamente legata all'intervento statale a sostegno dell'economia quella di Fanfani. Da questa fratturascaturirà il fatto che gli Stati Uniti pur sostenendo il piano Fanfani concentreranno gli aiuto in modo daagevolare l'iniziativa privata nel settore edilizio.
L'ideologia economica e sociale nella mente di Fanfani.Rispetto alle proposte di Bottoni e Puggioni quella di Fanfani ad un obiettivo in più che consiste nell'interventodi lotta alla disoccupazione. Fanfani, riconoscendo che creare posti di lavoro non sia il sistema migliore percostruire case di qualità, non si scosta dalla sua idea originaria in quanto la vede come l'unico modo perrisolvere, anche se non completamente, due problemi con un solo provvedimento. Fanfani è uno studioso deimodelli corporativi già portati avanti nel regime fascista ed ora ancora presenti ma divenuti democratici. Questo suo sostegno al corporativismo trova origine nell'idea che l'economia debba essere sostenuta e regolatadallo Stato e dalla politica; si tratta di convinzioni che si radicano nelle teorie di Keynes sull'utilizzo della spesapubblica per realizzare una politica di piena occupazione e che rispecchiano il modello americano del New Dealdi Franklin Delano Roosevelt. Convinto che il sistema della libera concorrenza e del libero mercato nonpermetta di raggiungere il massimo della produzione, Fanfani è fautore della necessità di realizzare forme dicontrollo sociale nella vita economica.L'idea di fondo di Fanfani non si esaurisce nel solo concetto economico, ma sopratutto nell'idea che l'economiadebba essere ispirata all'etica cristiana ed il piano Fanfani risponde appunto a questa istanza. La lotta alladisoccupazione è riconducibile ad una visione cristiana di soccorso ai poveri in cui lo strumento di controlloeconomico assume un fine religioso. Il piano si configura come un dispositivo di carità istituzionalizzata a scalanazionale, di partecipazione solidaristica di tutte le componenti sociali verso i più bisognosi come dimostral'iniziativa di Fanfani di assegnare gli alloggi tirando a sorte tra i lavoratori come se, per chi crede, la casaricevuta per sorte fosse un segno della provvidenza divina.
La casa esatta e per tutti di Ponti.Nel 1948 mentre il disegno di legge Fanfani è in discussione al Senato, esce sul Corriere della Sera una nuovoproposta di edilizia a basso costo promossa da Gio Ponti, architetto famosissimo nell'ambiente nazionale sin daitempi del fascismo ed interessato alla questione casa sin dagli annitrenta. Costui prevede che i 1.250.000 alloggi previsti dal pianoFanfani in sette anni sono difficili da realizzare con gli attuali sistemi diproduzione edilizia ed è perciò necessario introdurre anche in Italia laproduzione in serie grazie alla quale, secondo i calcoli di Ponti, siarriverebbe a risparmiare in tutto 4 miliardi e mezzo di lire. Con questamossa intende presentare la sua candidatura alla gestione del piano inquanto uomo esperto nel dibattito della ricostruzione e sullarazionalizzazione del sistema edilizio grazie alla quale non si avrebberocase tutte uguali ma si produrrebbe un miglioramento nella qualitàdell'architettura. La proposta di Ponti richiede una forte presenzadell'industria e della tecnologia nella ricostruzione con l'obiettivo dicreare la “casa esatta” anche se non si limita al solo studioarchitettonico. L'aderenza al piano Fanfani si basa sul fatto che anchelui come il ministro del Lavoro parla di una ricostruzione da avverarsisotto il segno di una “civiltà cattolica” in cui è obbligatorio nonsprecare nulla con l'obiettivo di essere d'aiuto al maggior numero dipoveri possibile. Tuttavia il fatto che sia stato ampiamentecompromesso con il fascismo gli impedisce di partecipare al dibattitosulla ricostruzione portato avanti dagli ambienti antifascisti (quelli incui Bottoni presenta la sua proposta) e la figura di Ponti perde mano amano prestigio e valenza. Fanfani infine opterà per Arnaldo Foschinialla guida della Gestione Ina-Casa preferendo un uomo politico e dalleelevate capacità strategiche e decisionali ad un architetto molto piùinteressato alla casa che all'economia e all'occupazione cioè il vero obiettivo del piano.
Le figure di Arnaldo Foschini e Filiberto Guala nel piano Fanfani.
Illustrazione 6: Foto di Gio Ponti allavoro sulla sperimentazione per lacasa operaia
Abbiamo visto come durante l'iter parlamentare il disegno di legge subisca alcune importanti modifiche, primafra tutte il maggior peso assunto dalla Gestione Ina-Casa che si dota di un consiglio direttivo e di unapersonalità giuridica. Il piano Fanfani è dunque affidato ad una diarchia: da una parte il Comitato di attuazioneche fa capo a Fanfani e al Ministero del Lavoro, dall'altra la Gestione Ina-Casa che fa capo all'Ina e a Puggioni.A dirigere la Gestione viene chiamato Arnaldo Foschini. Questi è un incarico più politico che professionale inquanto Foschini non è un progettista ma un uomo politico poco compromesso con il fascismo e associato allamaggior parte delle istituzioni interessate al piano (si veda l'approfondimento nella sezione dedicata al rilanciodella figura dell'architetto). A capo del Comitato di attuazione viene nominato Filiberto Guala con l'obiettivo di contrastare il poteredell'Ina. Guala appartiene all'ala più socialista della Dc che fa capo a Dossetti, ed è un uomo da sempreimpegnato contro le ingiustizie sociali e profondamente cattolico ma allo stesso tempo dotato di elevatissimecapacità menageriali e grazie a lui Fanfani è convinto di rilanciare lo spirito di assistenza e rinnovamentosociale alla base del piano.Il contrasto tra Guala e Foschini è aperto e palese a partire dall'impostazione architettonica (Guala punta suprogetti tipo mentre Foschini punta sulle capacità e sulla qualificazione dei progettisti) e nessuno dei due è unabile costruttore e progettista esperto nel campo dell'edilizia. Per ovviare a ciò Foschini chiama a capo dellasezione architettonica Adalberto Libera che opta per una ricostruzione non improntata sull'industria ma sulletradizionali tecniche costruttive.
Il piano nazionale di Diotallevi e Marescotti.A un anno di distanza dall'adozione del piano Fanfani nel 1950 si tiene a Roma la Conferenza economicanazionale promossa dalla Cgil. L'intervento pubblico è programmato verso tre grandi progetti: lanazionalizzazione dell'energia elettrica, la bonifica e l'irrigazione di zone improduttive e un piano nel settoreedilizio.Il piano sulla casa viene presentato da Diotallevi e Marescotti, autori di una serie di articoli sulla casa giàapparsi a partire dal 1941 nella quale invocano un deciso intervento dello Stato per combattere la speculazioneedilizia e per dare una casa a chi ne ha bisogno e prevedono che i fondi siano raccolti attraverso un prestitoforzato a basso interesse da imporsi su tutte le proprietà matrimoniali all'interno di una critica complessivaall'economia capitalista.Nel 1948 Diotallevi e Marescotti pubblicano un libro che si configura come punto di arrivo di una pazientericerca perseguita negli ultimi sette anni, ricca di esempi con occhio particolare all'esperienza tedesca tra la finedegli anni venti e i primi anni trenta. Nel 1950 la proposta dei due studiosi si configura come risposta della sinistra e della Cgil al piano Fanfani dapoco entrato in vigore; vengono sottolineati i limiti del decreto governativo (tassazione dei lavoratori,esclusione di vari strati di poveri fiscalmente non reperibili) e viene definito come un buon piano, ma parzialeda inglobare in una prospettiva più ampia prevedendo la creazione di un ente nazionale e regionale dicoordinamento e lasciando la parte esecutiva ai comuni e agli istituti case popolari, preferendo un massicciointervento dell'industria nell'edilizia e una raccolta di fondi attraverso l'emissione di cartelle al portatore acondizioni vantaggiose e raccolta di azioni sui redditi di agrarie in modo da includere nuove fasce di destinatari.
Per riassumere il piano di Puggioni, quello di Bottoni e la proposta di Miniati e di Ponti sono piani per la casacircoscritti al settore edilizio. Il piano Diotallevi è una parte di un disegno di sviluppo generale e complessivomentre il piano Fanfani si propone principalmente di combattere la disoccupazione e la costruzione di case èsubordinata all'obiettivo primo.
2.IIIIl piano alla scala urbana:
i modelli da seguire, i manuali come strategia normativa e le aspirazioni degli urbanisti italiani.
Le aspirazioni degli urbanisti italiani.“L'epilogo del conflitto schiudeva alle speranze l'animo di coloro che, durante i lunghi anni di guerra, eranovenuti maturando meditati propositi di un'organica preparazione della ricostruzione del paese”
Giovanni Astengo, Attualità dell'urbanistica 1949
Le speranze delle quali parla Astengo sono quelle degli urbanisti italiani i quali avevano visto nellaricostruzione un vera opportunità per avviare una nuova ed efficace politica di pianificazione nel paese.Astengo non perde tempo a denunciare la delusione per un susseguirsi di occasioni perdute, per denunciare glierrori compiuti nel ricostruire l'Italia con interventi e soluzioni contingenti e frammentarie con ladisseminazione di politiche, finanziamenti ed interventi con cui nei primi anni della ricostruzione vennefavorito l'intervento privato e non quello pubblico.Così il piano Ina-Casa si configura fin da subito come un'opportunità per riscattare la banale ricostruzione evede nel piano la vera occasione per una grande ricostruzione capace non solo di risolvere due grandi questioninazionali, casa e lavoro, ma di avviare un complesso programma di sperimentazione e realizzazione di quartieriin grado di incidere in futuri e di porsi come guida sui modi dello sviluppo urbano.Le visioni di Astengo sembrano essere supportate in quegli anni dallo stesso Adalberto Libera, responsabiledella sezione architettonica della Gestione, che riconosce al piano Fanfani un vero contenuto urbanistico che sipone come obiettivo l'inizio di una concreta ed importante attività urbanistica consistente in numerosi emoderni quartieri residenziali.
Si intuisce sin da subito quale valore diano gli urbanisti italiani all'unità quartiere illusoriamente visti comeparti utili a contrastare un incontrollato e informe processo di crescita urbana; il quartiere con le sue case, i suoiservizi, spazi aperti è visto come più che una parte di città in espansione ma come una vera unità sociale,ambito di integrazione, formazione e vita della comunità.Tuttavia per gli urbanisti del tempo il quartiere arriva ad essere visto come un'isola utopica, rifugio dellasperimentazione e del progetto in cui la lontananza e la periferia rispetto alla città non sono un problema ma unconfine grazie al quale è possibile distaccarsi e sperimentare. È l'idea della “città-satellite”, in posizioneambigua e contraddittoria rispetto alla città esistente, che finalmente trova terreno fertile di sperimentazioneanche nel nostro paese.
Ma quale idea di quartiere è sottesa in questa volontà di sperimentazione?La Gestione Ina-Casa tenta fin da subito di indirizzare la diffusione di un certo standard qualitativo elevato atutti gli interventi attraverso la selezione dei progettisti (rifiutando la banale adozione di progetti-tipo) e laredazione di piccoli manuali con l'intento di guidare la progettazione di alloggi, edifici e quartiere.Questi manuali non vogliono codificare regole ma proporre suggerimenti per evitare un'eccessiva omogeneità estandardizzazione alle realizzazioni del piano con l'obiettivo di porsi come punto di partenza per poi aprirsi adinterpretazioni diverse da parte dei progettisti.Nei primi due fascicoli (1949 – Suggerimenti, norme e schemi per la elaborazione e presentazione deiprogetto; 1950 – Suggerimenti, esempi e norme per la progettazione urbanistica. Progetti tipo) la volontà èquella di sviluppare un'idea di spazio abitabile articolata dal particolare al generale come avvenne nei primicongressi Ciam. 21 punti elencano altrettante regole per la buona progettazione del quartiere e numerosiprogetti e realizzazioni sono indicati come esempi da seguire (su tutti quelli dei paesi scandinavi) o da evitare(quelli del razionalismo del movimento moderno).L'idea di spazio abitabile che ne consegue può essere riassunta attraverso alcune parole chiave:Bassa densità e diradamento: nasce la volontà di costruire allontanandosi dalla tradizione ottocentesca(formata da isolati chiusi a corto, addensati ed allineati sul filo stradale) per aprirsi a modelli insediativi a bassadensità, con la presenza di vegetazione a garantire il sole, la luce, e le visuali libere; composizioni urbanistichetali da creare ambienti accoglienti e riposanti.
Organicismo opposto al razionalismomoderno: la volontà è quella di nonassumere a modello un'idea di modernitàastratta come quella espressa dairazionalisti ma di aprirsi ai bisognispirituali e materiali dell'uomo reale chenon ama e non comprende le ripetizioniinfinite ma dove è il paesaggio el'esistente ad influenzare la progettazionee a suggerire la composizioneplanimetrica; l'urbanista sarà così ingrado di creare ambienti spontanei,genuini, fusi con il luogo con tipi ediliziarticolati con alloggi e numero di pianivari e differenziati senza composizionirigidamente geometriche. Ladiversificazione viene ricercata sia tra idiversi quartieri sia all'interno delquartiere stesso che deve essere policentrico e si deve differenziare in settori in modo tale che tra la casa e ilquartiere esista una nuova realtà cioè l'unità di abitazione o l'unità di vicinato, tanto discussa nel dibattitointernazionale ed europeo ma quasi mai realizzata con successo in Italia.Un moderno tradizionale: uno degli obiettivi del piano Ina-Casa è quello di porsi come veicolo per lamodernizzazione del paese. Ma i suggerimenti all'attenzione alla tradizione mostrano un'idea di modernità chedeve necessariamente integrarsi e radicarsi nella tradizione. Ciò nella pratica avviene nel continuo confrontocon l'ambiente, con i nuclei storici, con il paesaggio da salvaguardare e nella scelta dei tipi edilizi, dei colori edei materiali. Il progettista ha una chiara responsabilità in tutto ciò in quanto lo Stato non ha capacità dicontrollo e di salvaguardia di tutti gli interventi.Spazio costruito integrato allo spazio aperto: nei manuali si consigliano i progettisti di rivolgere le propriepreoccupazioni in primo luogo alle caratteristiche spaziali delle vie e delle piazze e secondariamente agli aspettiarchitettonici. Questo perché lo spazio costruito (studiato nei minimi particolari dell'alloggio) devenecessariamente relazionarsi in modo inscindibile con lo spazio aperto in modo che l'uno attribuisca senso evalore all'altro per formare uno spazio abitabile al centro per cento.
La forma dei manuali e delle norme.L'insieme dei fascicoli prodotti dalla Gestione Ina-Casa (i due suddetti nel1949 e 1950 per il primo settennio e due nel 1956 per il secondo)siconfigurano quindi come la grammatica e la sintassi necessarie al formarsi diun savoir faire che riuscisse allo stesso tempo a confermare i suggerimenti emostrasse la fertilità di pensiero e le abilità degli architetti. Questo grazieanche alla scrittura dei testi in forma in forma dismessa sequenziale e ripetitivain modo da non conferire mai loro l'aspetto rifinito del manuale vero e proprio.
Nei fascicoli vengono utilizzate una gamma diversificata di norme che èpossibile schematizzare con i nomi di idealtipo, esempio, regola prestazionalee standard. Le prime due forme prediligono il linguaggio visivo, la regolaprestazionale quello verbale e lo standard il linguaggio numerico. Il linguaggioè in molti versi decisivo in quando conferisce significati diversi alla regolapresa in esame.Idealtipi: nel primo fascicolo del 1949 la regola tecnica per la progettazionedegli alloggi viene espressa attraverso una casistica figurativa di schemiplanimetrici. Vi sono 4 tipi edilizi ammessi con riferimento alla diversacapacità abitativa e alle abitudini di vita per un totale di 81 idealtipi differentisulla base del quale viene posta la responsabilità del progettistanell'adattamento dello schema alla situazione specifica fatta salva la presenzadi alcuni aspetti indispensabili che non devono essere trascurati come l'esposizione,la presenza del disimpegnoe l'allacciamento idraulico. Sulla base di questi aspetti la didascalia distingue e giudica i vari idealtipi tra
Illustrazione 8: Copertina del IIfascicolo-guida allasperimentazione
Illustrazione 7: un esempio di buona progettazione in prospettiva
positivi e negativi. Da ciò si evince che lo studio tipologico e la forma del Movimento Moderno riguardanti ladistribuzione interna dell'alloggio non sono messe in discussione; il rifiuto del razionalismo e l'adozione delproblema locale risulta più evidente sulla gamma tipologica (si escludono edifici alti) sulle tecniche e i materiali(si esclude la prefabbricazione) e sull'impianto urbanistico (si rifiuta la regola geometrica).Esempi e regole prestazionali: risulta più difficile trattare normativamente il tema del quartiere. Come suddetto
la strategia si basa su una serie di immagini non schematiche e nonunificate come erano quelle degli alloggi ancor più debitrici delladidascalia che interviene per fissare l'attenzione e renderli comprensibili.In tutto sono una quarantina di esempi disomogenei accompagnati da 21regole prestazionali ciascuna dedicata a un requisito dell'urbanisticaorganica: attenzione per i caratteri dei centri; la creazione di scorciprospettici gradevoli; la cura del verde; la varietà della composizionedegli edifici.Questi esempi voglio ovviare alla vaghezza delle regole e attendono dalprogettista uno sforzo induttivo di interpretazione che gli consenta ditrovare la soluzione adatta. Questo processo costituisce un allenamentoed un elemento di formazione per il professionista. Ciò dimostra cheesempi e regole prestazionali sono forme normative difficile chepresuppongono una tradizione urbanistica e una cultura attenta econdivisa e che non sempre garantiscono un buon prodotto se questamanca nel progettista.Standard: dopo il primo settennio la Gestione promuove un referendumpresso gli assegnatari delle abitazioni per accertarne la godibilità dei tipie delle caratteristiche delle abitazioni, poi analizza i reclami e predisponeun terzo fascicolo che, da una parte costituisce un bilancio dei precedentiin cui sono esplicitati i punti forti delle raccomandazioni precedenti esono indicati quelli problematici portando ad una limitazione ulterioredei tipi edilizi ammessi, dall'altra parte si impone all'attenzionesopratutto per l'introduzione in maniera sistematica degli standardurbanistici connessi al dimensionamento del quartiere ed in particolare alproporzionamento dei centri sociali. La tabella ha in primo luogo loscopo di facilitare il controllo dei progetti ma per garantire il correttoutilizzo fornisce alcuni esempi e spiegazioni per la comprensione.
Illustrazione 9: Immagini tratte daifascicoli dell'Ina che mostranoalloggi, aggregazioni, prospetti eveduti di esempi tipo
2.IVIl piano alla scala dell'architettura:
le tecniche edilizie, le scelte architettoniche e il rilancio della figura dell'architetto.
Gli architetti: il rilancio di una professione.Gli obiettivi primari ed espliciti del piano sono già stati ampliamentidiscussi. Occorre ora soffermarsi su un terzo obiettivo, non scrittodalla legge e già implicitamente nominato in precedenza, ma fruttodel processo di costruzione del piano: il rilancio della figuradell'architetto. Gli architetti durante il fascismo avevano avuto un ruolodeterminante (si veda 1.I inquadramento generale) ma dopo la cadutadel regime nel 1943 si trovano in difficoltà. La scomparsa di unreferente politico forte e sicuro provoca un momento didisorientamento sia tra i professionisti sia nelle scuole. Tuttavia èproprio a partire da questo sconcertante scenario di incertezzaprofessionale che tra il 1944 e il 1949 si realizzano in ambienteromano le condizioni che condurranno nuovamente gli architetti aessere protagonisti del paese con il piano Fanfani. A capo della Gestione Ina-Casa infatti sarà Arnaldo Foschini: la suanomina non è un fatto casuale ma è stata attentamente voluta e siinquadra perfettamente nel rilancio della figura professionale da luirappresentata. Gli obiettivi che Foschini si pone sin da subitosottolineano questa volontà: una difesa della libertà di professioneattraverso la non adozione di schemi e modelli vincolanti ed unaricostruzione che non passi attraverso la prefabbricazione conl'obiettivo di offrire più lavoro possibile in unione all'attenzione per le valenze locali.Per capire la scelta di Foschini e il perché di questi suoi obiettivi occorre fare un passo indietro.Nel 1944 sono sciolte le organizzazioni sindacali fasciste tra cui il Sindacato fascista architetti che raccoglie il78% degli architetti italiani. Nello stesso anno Foschini è l'unico che ha contribuito fondare le scuole diarchitettura e a formare la prima figura dell'architetto ad essere ancora in attività: Piacentini è troppocompromesso con il fascismo per essere tenuto in considerazione, Giovannoni è anziano e troppo lontano daigiovani mentre Calza Bini è ancora imprigionato dagli alleati.Foschini ha attraversato indenne il crollo del regime fascista grazie alle sue amicizie negli ambienti vaticani edessendo riuscito a nascondere i suoi frequenti coinvolgimenti con il regime. Per questo diverrà dapprimapreside della scuola di architettura di Roma e accumulerà a partire dal 1944 un numero di cariche che non hauguali con nessun'altra personalità di quegli anni che dimostrano la centralità della sua figura nei rapporti con leistituzioni.Nel 1944 anticipando lo scioglimento del sindacato fascista si tiene a Roma la prima riunione dell'Associazioneromana architetti che prenderà sin da subito le distanze dal fascismo escludendo coloro che sono consideratitroppo compromessi con il regime. L'Associazione mostra una netta diffidenze verso i tempi recenti, adifferenza di quello che avviene negli ambienti sociali e politici della rinascita italiana, e non attira un grannumero di architetti importanti (nel 1945 sono solo 121). Foschini viene eletto come primo presidentedell'Associazione ma rimarrà poco alla presidenza poiché si dimetterà alla fine del 1945 con l'esplicito obiettivodi dedicarsi interamente alle trattative con gli ingegneri e nella difesa della categoria dell'architetto presso iMinisteri. Perciò entra in contatto con l'Aniai, l'associazione degli ingegneri e degli architetti italiani, e questaalleanza avrà un ruolo decisivo anche nelle vicende dell'Ina-Casa come vedremo. Foschini interviene contro il rischio paventato di di una ricostruzione affidata agli uffici tecnici dei variministeri e fa opera di convincimento verso i colleghi più scettici sulle possibilità occupazionali nel dopoguerra.Uno dei settori in cui si prospetta la possibilità di incarichi è quello delle chiese in quanto Foschini intrattieneottimi rapporti con gli ambienti del Vaticano ed ottiene che la ricostruzione delle chiese sia affidata ad architettiliberi professionisti offrendo ricche opportunità di lavoro per i suoi colleghi. Nel 1945 Foschini prefigura quindiun rilancio legato all'architettura religiosa e non a quella sociale come avverà con il piano Fanfani. Anche nel campo della prefabbricazione Foschini assume un ruolo di primo piano ma pur essendo presidente
Illustrazione 10: Casa del quartiereTiburtino a Roma di Mario Ridolfi
della Commissione di studio della casa prefabbricata, si discosta dalle posizioni estremiste ed assume unaposizione intermedia in cui non esclude lo studio del tipo completamente prefabbricato ma sottolineal'importanza di tenere conto delle tradizioni locali conscio del fatto che soluzioni completamente prefabbricateporterebbero lavoro a pochi architetti. Foschini si sta muovendo con grande abilità in vari ambienti (Vaticano, prefabbricati, ingegneri) dirigendo gliarchitetti e promuovendo alleanze per cercare occupazione invece che isolare e cercare autonomia per gliarchitetti.Come si inserisce il piano Ina-Casa in tutto ciò?Quando Foschini viene eletto presidente della Gestione Ina-Casa queste sue alleanze coltivate giocano un ruolodecisivo. Egli infatti si trova in buonissimi rapporti anche con Gino Cipriani, il direttore generale dell'Ina, con ilquale si era creato un forte sodalizio fin dai tempi del regime. L'Ina infatti negli anni del fascismo aveva messoa disposizione il capitale finanziario per i numerosi interventi nei centri storici ed aveva affidato agli architettila progettazione. Nel dopoguerra Foschini propone che questa collaudata collaborazione venga riconfermata ediventi un modello da estendere ad altri enti statali e non solo nei centri storici ma anche nel campo dell'ediliziasociale.Nel primo disegno di legge Fanfani però non sono contemplati ruoli ad architetti ed ingegneri. Il forte pesoassunto durante l'iter parlamentare dall'Ina-Casa in generale e dalla Gestione in particolare consentono aFoschini di far valere le sue alleanze e di garantire occupazione ancheagli architetti ora finalmente interessati dal piano Fanfani. La scelta diFoschini come presidente della Gestione Ina-Casa su scelta dell'Ina siinquadra proprio in questo contesto e la nomina di un uomo più politicoe organizzativo che tecnico è proprio uno di quegli elementi checonsente di mettere in moto quella grandiosa macchina dell'abitazioneche è il piano Ina-Casa. Inoltre quasi a voler supplire alla mancanza dicompetenza in tema abitazione che era stata attribuita a Foschini, questichiama un suo ex allievo Adalberto Libera e gli affida la direzionedell'ufficio progetti.Il piano inizia nell'aprile del 1949 e nei primi dieci mesi circa Foschiniopera con una struttura essenziale con Libera che sovraintende il lavorodi un gruppo di giovani architetti tutti ex allievi del professore romanoaddetti a esaminare ed accettare i progetti che da tutte le parti d'Italiaarrivano a Roma. Poi man mano che il piano decolla vengono createdelle mini commissioni tecniche composte da un professionista esperto,uno più giovane e una segretaria. In tutto nel 1952 lavorano allaGestione 189 persone con una cinquantina di architetti e ingegneri, unaventina di geometri e una cinquantina di collaboratori esterni.Abituati alla compromissione politica degli architetti fascisti, gliarchitetti italiani del dopoguerra rimangono stupiti dell'imparzialitàdimostrata da Foschini: seleziona i progettisti con concorsi ad hoc inmodo da far emergere la qualità e stimolare la professione. Crea inquesto modo il più partecipato concorso della storia italiana a cuiparteciperanno 203 architetti e 137 ingegneri equivalenti ad unarchitetto su 10 tra quelli che esercitano la professione. Lo stesso Ponti,componente della commissione per la scelta dei progettisti, sottolinea come gli architetti siano stati scelti diogni tendenza e colore anche se è altrettanto vero che il 48% dei selezionati sono stati allievi di Foschini eprovengono dall'ambiente romano.Il rilancio della figura non avviene solo sul piano occupazionale ma attraverso l'esperienza Ina-Casa gliarchitetti assumeranno nuovamente un ruolo centrale anche dal punto di vista politico, il cui successo è dovutoa condizioni particolari, a politiche statali di forte intervento a sostegno del settore edilizio.Un dato emerge da questa storia. La disinvoltura con cui gli architetti aggiornano la loro offerta dicollaborazione rispetto a istanze provenienti da sistemi politici diversi, una dittatura prima e una democrazia inmodo che la figura dell'architetto non sia fine a sé stesso ma sottende alla funzione di “pubblico servizio” primaaderendo alle politiche del consenso del regime ora abbracciando le ideologie sociali della repubblica.
Le tecniche edilizie per la ricostruzione.Il piano Fanfani interviene a imprimere una secca inversione di rotta alle strategie che polarizzano il dibattito
Illustrazione 11: Fronti e sezioni diuna casa tipo a Cesate di MarioGardella
sulla ricostruzione in Italia. Negli anni precedenti il 1949 infatti nel dibattito architettonico il fabbisogno diabitazioni aveva portato tutti a condividere l'esigenza di aumentare la produttività imprimendo una forteaccelerazione al progresso delle tecniche di costruzione ed individuando nella prefabbricazione lo strumentoadatto per tale scopo. Il piano Ina-Casa propone una direzione opposta all'innovazione individuando nella costruzione di case ilmezzo per incrementare l'occupazione operaia imponendo perciò una bassa meccanizzazione ed un altoimpiego di manodopera inibendo l'innovazione tecnologica orientando la ricostruzione vero l'ediliziatradizionale.Ma qual è il tipo di costruzione indicatoall'epoca del piano Ina-Casa conl'aggettivo tradizionale? Si tratta di unmodello costruttivo molto bendeterminato delineato nei suggerimentiemessi dagli opuscoli della Gestione Ina-Casa: un sistema composto daun'equilibrata combinazione di elementimurari ed elementi in cemento armatotutti realizzati prevalentemente in opera. Nonostante differenze vistose tra ambitigeografici differenti, la costruzione Ina-Casa tende ad assumere un caratteresostanzialmente omogeneoprofondamente diverso sia dal modellointernazionale dell'edificio modernobasato sullo scheletro portante e sullasmaterializzazione della parete sia dalmodello ottocentesco perché l'impiegodel cemento armato modifica il comportamento strutturale delle murature. Quello applicato è il modo dicostruire disponibile in Italia all'indomani della guerra e risponde al singolare processo di modernizzazione chesi è sviluppato in Italia negli anni venti e trenta in cui la corrente più ruralista e vernacolare ha prevalso neglianni immediatamente precedenti la guerra.Non c'è dubbio che superiori ragioni di politica sociale ed economica impongano l'arresto del progresso tecnicoed accentuino il divario tecnologico ed industriale dell'edilizia italiana rispetto ad altri paesi e determinerannonegli anni sessanta il precipitoso ricorso ai sistemi prefabbricati già largamente impiegati nei paesi esteri. Ma ciò non è sufficiente a definire l'esperienza Ina-Casa come un modello di passività tecnologica e unariproposizione di un modello già dato. Il modello costruttivo assunto è infatti sottoposto ad un'avvincente esofisticata opera di revisione sperimentale che non potendo mirare a definire un nuovo modello più avanzato,diviene un lavoro di perfezionamento e messa a punto di quel modo di costruire che si vuole conservare conun'incessante richiamo da parte del Comitato di attuazione alla definizione dei particolari costruttivi e portano imaggiori esponenti a ridisegnare minuziosamente il repertorio degli elementi artigianali dell'edilizia corrente.In questo modo, concentrato sul particolare costruttivo, l'architetto continua a svolgere il ruolo che ha svolto inItalia negli anni venti e trenta: produce espressioni figurative e linguaggi, instaurando un nesso di continuitàcon l'anteguerra.
Illustrazione 12: Studio sui manufatti in cemento grigliato diFederico Gorcio
2.VGli esiti:
un bilancio critico del piano osservato ai nostri giorni.
Il piano Fanfani si configura ancora oggi come il più consistente programma di edilizia pubblica coordinatodalla stato centrale che l'Italia abbia mai conosciuto. Le case e i quartieri costruiti col piano Ina-Casa sonoandati ad aggiungersi, diventandone una parte rilevante, aquella che potremmo chiamare la città pubblica che trovaorigine in quelle parti urbane programmate e realizzate findall'Ottocento da diverse istituzioni ed enti con lo scopo disoddisfare il fabbisogno abitativo di quei gruppi sociali aiquali il libero mercato rende difficoltoso l'accesso al benecasa. Queste parti di città pubblica formate da residenze,attrezzature collettive e spazi aperti, hanno tentato di dareforma a diversi percorsi di ricerca orientati alla modernità emostrano ancora oggi le tracce degli studi sulle forme e sugliusi dello spazio abitabile non solo interno ma anche di quelloesterno non costruito. Grazie ad interventi come questo oggi gran parte dello spaziourbano oltre che materialmente costruito risulta strutturatodalla disposizione sul territorio di beni pubblici, non solodalla costruzione singola, ma sopratutto dalle relazioni che litengono insieme. L'intervento pubblico non solo hacontribuito a costruire l'urbanistica moderna ma ha assunto unruolo importante nella costruzione della città in opposizioneal formarsi delle periferie che andavano costruendosiattraverso giustapposizioni di interventi dispersi e banali neltentativo di indicare nuove direttrici di crescita e di proporreesempi di spazio abitabile che potessero eventualmente ancheessere riferimento per l'intervento dei privati.L'importanza di interventi di questo tipo ci portano aconstatare, insieme al degrado, l'interesse diquelle architetture e di quegli spazi come un“bene che costituisce testimonianzamateriale avente valore di civiltà” in quantoesito materiale di storie diverse. Questiquartieri documentano le tracce della storiadi comunità di cittadini, dei differenti modid'uso degli spazi individuali e collettivi checi conducono a parlare di queste parti di cittàcome di patrimoni, dotati di specifici valori ea definirli documento/monumento dellamodernità. Un valore di questo tipo sollecita per iquartieri progetti e azioni non solo diriqualificazione ma anche di conoscenza etutela. Si tratta di interrogarsi su quali siano imodi migliori di intervento che si adattino adintere parti di città e ad una nuova societàfatta di abitanti con nuove e diverse abitudinirispetto a quelli originari. L'interventopubblico allora è forse il caso che siconcentri, dopo un lungo periodo nel qualeha immesso nello spazio urbano quantità rilevanti di nuove idee sull'abitare, col grande tema del senso e delridisegno di questi interventi con l'obiettivo di dare l'avvio ad un processo di riqualificazione che si espanda e
Illustrazione 13: Scorcio degradato in uno spazioaperto del quartiere Ina-Casa di Cesate
Illustrazione 14: Degrado della pavimentazione in uno spaziopubblico a Cesate
più complessivamente coinvolga lo spazio periferico.
Oltre a questi buoni bilanci generali occorre sottolineare come l'Ina-Casa non si sia realmente posta alla fine delsuo processo come un ciclo virtuoso di riflessione e guida nella progettazione della città. Una volta avviatoinfatti il processo di crescita urbana ha rapidamente assunto connotati propri facendo in modo che i successiviprogrammi di crescita urbana rimanessero indirizzati verso processi debolmente inseriti in disegni urbanisticiaccennati e privi di ogni ambizione. A partire dalla fine del piano Ina-Casa è iniziata una lunga stagione diaccumulazione senza qualità e l'idea stessa di progetto complesso e riconoscibile è diventato un episodiomarginale.In tutto questo vi è però anche una eco del modo di porsi dello stesso programma Ina-Casa rispetto alla cittàesistente. I progetti infatti si sviluppano quasi sempre come isole felici e autosufficienti ben lontanidall'integrazione con la città esistente e con la fusione con essa.
3.IIl progetto:
i modelli, i protagonisti, l'evoluzione del progettoe l'esito attuale del processo con approfondimenti su alcuni edifici.
Perché proprio la Falchera come caso studio?Sulle pagine di “Urbanistica”, Giovanni astengo nel 1951 tenta il primo bilancio sistematico dell'esperienza Ina-Casa. L'ultimo tra i casi esemplari proposti è l'unitaresidenziale Falchera, costruita a Torino secondo unprogetto da lui stesso coordinato ed illustrato sullarivista stessa. Nel volgere della fine del primo settennioFalchera diventa uno dei luoghi emblematici dellaricostruzione pubblica e della vicenda Ina-Casa insiemeai quartieri romani del Tuscolano e del Tiburtino e alquartiere San Marco a Mestre: Falchera e le unitàresidenziali diventano la testimonianza essenziale di unprocesso di modernizzazione del patrimonio edilizio,efficace e rapido nelle strategie progettuali come nellepratiche costruttive.Ciò non significa che il quartiere sia privo di difetticome sottolineato nel numero monografico che larivista “Metron” dedica all'intervento nel 1954: vienecriticata innanzitutto l'ubicazione dell'interventorispetto alla città storica, quasi a volersi qualificarecome un embrione isolato sconnesso dal sistema per la quale è stato immaginato. Tuttavia le ragioni chepresiedono la scelta di tale ubicazione sono da ricercarsi nella frammentazione del mercato fondiario imperfettoche condiziona l'Ina-Casa nell'acquisto delle aree grandi in periferia e piccole nei centri.
Falchera tuttavia costituisce un caso unico dal punto di vista dei professionisti e degli incarichi con la presenzadi Astengo a capogruppo del progetto urbanistico e di alcuni architetti ed ingegneri sia piuttosto conosciuti chegià nel primo dopoguerra erano emersi con progetti e realizzazioni importanti, sia giovani che trovano nellecase di Falchera la prima grande opportunità professionale. L'Ina-Casa diventa così il luogo dellasperimentazione per molti dei nuovi maestri e l'occasione per tentare una via della modernità lontana daiclamori dell'anteguerra ma pure lontana dalle ipotesi rigeneratrici di città dell'immediato dopoguerra.Nel complesso l'intervento della Falchera consente di rileggere l'intera vicenda del piano Ina-Casa attraversoalcuni dei suoi risultati più brillanti ma anche attraverso le sue incertezze, ambiguità e difficoltà strutturali: sisono ottenuti in totale 915 alloggi per 4000 vani per un totale di 3800 abitanti in origine.
I modelli per il progetto.Sin dalla prima proposta di piani si evince che i modelli tratti daiprogettisti derivano da esempi nordeuropei per quanto riguarda lescelte distributive degli alloggi sia per il gusto degli spazi verdiprivati, pubblici e condominiali influenzati dalle idee della cittàgiardino. Talune ricercatezze invece derivano da ispirazioni legate alMovimento Moderno come ad esempio la dimensione molto ridottadei cornicioni e nelle coperture a debole tendenza. Queste ricercatezzee sperimentazioni di modelli stranieri sono puntualmente inseritiall'interno dell'architettura piemontese caratterizzata da una fortetradizione manifatturiera che ha prodotto un'assestata cultura nell'usodel mattone; ciò è evidente nel largo uso della muratura in mattoni avista sapientemente lavorato che si pone come comune denominatoredell'intervento ma è allo stesso tempo trattato da ogni progettista inmodo personale e mai identico e ripetuto. Illustrazione 16: Planimetria generale,
"primo progetto" 1954
Illustrazione 15: Fotografia aerea della zona centraledel quartiere
L'evoluzione del progetto.L'avvio della politica del “quartiere residenzialeautosufficiente” della Falchera inizia quando il 14 giugno1950 gli organi direttivi del Piano in modo autonomo daglienti locali deliberano l'acquisto dei terreni occorrenti per larealizzazione di un “complesso edilizio unitario” cheavrebbe raggruppato le abitazioni destinate alla città diTorino dalla programmazione del secondo anno. L'obiettivonell'ambiente torinese è sia quello di far fronte ai danniprovocati dalla guerra sia quello di dare l'avvio ad unapolitica di quartieri operai di buona qualità per far fronte alproblema immigrazione.Ubicato a circa 7 km a Nord di Torino, oltre l'areaindustriale della Stura, la Falchera si articola in quattronuclei residenziali realizzati in tre lotti distinti distribuitiattorno ad un centro comunitario e raccordati mediante unasse stradale di penetrazione della strada provinciale. Su unasuperficie di poco superiore ai 300.000 mq il gruppo Astengo elabora un piano urbanistico nel quale insedia ben6000 abitanti stando ben al di sotto del limite massimo di abitanti per ettaro previsti dal piano (200 contro i 500del piano.) La viabilità interna si sviluppa in modo da lambire i lati esterni dei blocchi edilizi su cui siaffacciano le scale e i servizi. Nel mese di dicembre del 1950 viene affidato l'incarico perla redazione del piano urbanistico che si articola attraversopiù tappe intermedie prima di arrivare ad un progettodefinitivo.La planimetria del “primo progetto” è ricca diinformazioni: prevede l'ubicazione dei servizi per lamaggior parte nell'area centrale (scuola,asili,chiesa,bar,uffici,mercato,centro assistenza) e inpiccola parte tra le corti (asili, botteghe commerciali,garage, ristorante); la sagoma planimetrica dei blocchiresidenziali (proposta nell'impianto morfologicocaratteristico a “tre ali divaricate”) è dettagliata fino acontenere la tipologia edilizia adottata: per quattordiciblocchi è adottata la casa multipla continua con due
alloggi per piano mentreper il quindicesimo bloccosi prevede la casa alta dinove piani e tipologia che si pone in stretta relazione con il ristorante adiacente;è previsto un unico tipo di scala a due rampe consigliato negli schemiplanimetrici diffusi dall'ente; la viabilità è distinta su tre livelli e l'asse dipenetrazione principale si conclude a nord laddove incontra la casa alta.Una versione successiva è datata 21 dicembre 1951. Rispetto alla versioneprecedente non tutti i servizi sono concentrati nell'area centrale ma si collocanosu alcune aree contigue ad essa. La planimetria generale del “progetto definitivo” presenta indicazioni menodettagliate del primo progetto ma vengono allo stesso tempo precisati elementicome l'uso delle coperture del tetto a falda semplice; il nucleo centrale deiservizi muta sostanzialmente in quanto le aree da destinare alla chiesa subisconoun significativo incremento e una parte dei servizi di quartiere viene spostata piùa nord e cambia l'ubicazione di un asilo e del mercato spostati verso est; tutte lesagome dei blocchi residenziali vengono ridefinite ed alcune tipologie cambiateo integrate con altre: significativa è l'eliminazione del blocco a nove piani e delristorante annesso che cambia anche la configurazione planimetrica dei blocchilimitrofi; la viabilità viene ridisegnata e l'asse di penetrazione principale si
conclude con una rotatoria.
Illustrazione 17: Planimetria Generale dellaversione successiva al primo progetto, 1951
Illustrazione 18: Planimetria generale del progettodefinitivo, 1954
Illustrazione 19: Pianta delcentro del quartiere
Nell'ultima planimetria generale rielaborata dall'Ufficio tecnico dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Torinoviene rappresentata una situazione ancora diversa: per quanto riguarda i servizi centrali hanno subitoun'ulteriore revisione in quanto si presentano con un impianto planimetrico variato che tende a privilegiare unamaggiore integrazione tra gli edifici a carattere pubblico; i blocchi residenziali rimangono pressoché invariatirispetto alla versione del 1951.
Tutti i blocchi edilizi sono conformati sul modello “a tre ali divaricate” messo a punto dai progettisti e vienescelta la tipologia residenziale in linea sviluppata su tre livelli. La loro ripetizione differente determina ampispazi sistemati a verde pubblico che complessivamente rappresentano il 70% della superficie di intervento.Alla scala del blocco edilizio le norme generali del piano urbanistico fissano la conformazione degli edifici e iltaglio degli alloggi conferendo unitarietà e uniformità al quartiere.Alla scala dell'alloggio le norme del piano urbanistico fissano alcuni elementi dimensionali fondamentalirispettosi delle indicazioni progettuali fornite dall'ente. Infatti all'unicità del tipo edilizio corrisponde lavariabilità dell'organizzazione spazio-funzionale degli alloggi affidata all'abilità dei progettisti nel quale risultachiara sia l'aderenza a modelli nordeuropei sia l'attenzione ai suggerimenti della Gestione.Alla redazione del piano urbanistico seguono quelli per la redazione dei progetti. Il primo lotto consiste in sette blocchi residenziali e viene affidato sia ai singoli autori del piano sia a Sottsassche a Becker e Romano. I progettisti hanno anche l'incarico di dirigere i lavori dei blocchi appaltatidall'amministrazione comunale. I lavori dei 518 alloggi vengono tutti consegnati nell'agosto del 1952 edultimati nel 1954.Il secondo lotto è interamente affidato all'IACP (Istituto autonomo case popolari di Torino) in qualità distazione appaltante che provvede ad espletare le gare nel 1953. I progetti per complessivi 222 alloggi sonosemplice ripetizione dei precedenti, vengono tutti consegnati nel giugno del 1953 e risultano ultimati nelmaggio del 1955.La realizzazione dei 175 alloggi del terzo lotto nella parte nord viene ritardata per diverse cause relativeall'impossibilità di acquistare i terreni e alle modifiche sulle dimensioni dei servizi. Tutto ciò impone unridimensionamento dei tre blocchi edilizi la cui progettazione viene nuovamente affidata ad Astengo.Nonostante tutto i lavori vengono consegnati nel 1956 ed ultimati nel giugno del 1958.
Come si presenta oggi il quartiere?A cinquant'anni dalla realizzazione Falchera è un aggregato urbano vivo, vissuto e amato dagli abitanti. Èpresente ed immediatamente avvertibile un forte interesse alla riqualificazione da parte della PubblicaAmministrazione (a dimostrazione di ciò è in atto un nuovo assetto della piazza e l'ubicazione di nuove strutturedi servizio). Gli spazi verdi e gli edifici stesso sono oggetto di un'attenta manutenzione con pochissimi casi diinterventi e alterazioni, anche se di evidenti dimensioni. Grazie a queste considerazioni è possibile riconoscereanche oggi l'unitarietà dell'intervento ed il quartiere si conferma come un ambiente architettonico di improntapiemontese rurale con una propria significativa personalità, nonostante sia le vicende del processo sia laframmentarietà dei singoli progetti di edifici affidati a progettisti diversi possano suggerire un esito differente.
Approfondimenti su alcuni blocchi di edifici.Blocco 21 (primo lotto) di Nello Renacco: fu tra i primi ad essere progettato e adessere edificato alla Falchera. I quattro edifici si snodano a partire dall'imbocco asud dell'asse viario di penetrazione del quartiere e delimitano il grande spazioverde aperto verso sud-est. L'impianto distributivo interno degli edifici èarticolato intorno ai vani scala disposti sui fronti nord ed est. Lo sviluppo del fronte è tale da comprendere tre scale che servonocomplessivamente sei appartamenti; fa eccezione il lungo edificio orientato indirezione nord-sud che si articola su cinque scale e si affaccia sull'asse viarioprincipale. La distribuzione interna degli appartamenti segue le indicazioni e glistandard del piano generale e comprende un totale di 341 vani mentre al pianointerrato sono distribuite le cantine. L'aspetto architettonico rafforza le immaginidi sobrietà ed eleganza anche grazie al diffuso impiego di muratura in mattoni avista che ha lasciato il posto al rivestimento intonacato soltanto negli sfondatidelle logge.
Illustrazione 20:Planimetria del blocco 21tratta da un elaborato diprogetto
Le trasformazioni di manutenzione recenti ci mostrano come sia stata interamente sostituita la copertura degliedifici che non ha saputo rispettare il carattere architettonico originario innalzando i fronti di circa otto corsi dimattoni. Un forte segno di trasformazione è la chiusura pressochè totale delle logge trasformate abusivamentecon infissi in lega d'alluminio. Di segno opposto è lamanutenzione del giardino che risulta molto curato eapprezzato.Blocco 31 (secondo lotto) di Mario Passanti: fu edificatonel 1953 nell'ambito del secondo lotto e vide come stazioneappaltante l'IACP. Gli edifici che compongono il blocco sielevano per tre piani fuori terra e prevedono 42 alloggi perun totale di 270 vani. L'involucro degli edifici è in mattonia faccia vista per conferire all'intero complesso unaricercata connotazione rurale. La soluzione distributivadegli alloggi è tale da conferire un opportunodimensionamento dei locali che garantiscono una buonailluminazione naturale degli spazi interni e facilitano la disposizione degli arredi conferendo agli alloggi unbuon livello di qualità abitativa.Le trasformazioni subite dal blocco risultano di modesta entità e sono prevalentemente legate ad interventi dimanutenzione straordinaria grazie ad unabuona qualità dei materiali e ad unaproprietà condominiale meno interventista.Una delle principali alterazioni apportateriguarda l'aggiunta di verande nella corteinterna con serramenti in alluminio diaspetto non omogeneo.Blocco 40 (terzo lotto) di GiovanniAstengo e Guido Gigli: come suddetto ilterzo lotto fu il più articolato in quanto subìalcune operazioni di riconfigurazione peradeguarsi alla nuova sistemazionedell'ampliata area adibita alla chiesa e aiservizi ad essa connessi. La continuità della regia di Astengo nella progettazione dei blocchi rende questaporzione del quartiere più facilmente ascrivibile ad un disegno espressivo e linguistico unitario. Il suoposizionamento limitrofo rispetto al nucleo centrale e di servizio generale gli faceva assumere nelle intenzionidei progettisti un ruolo strategico di cerniera col paesaggio, ovvero di simbolo del limite tra l'originalecommistione di costruito e verde del quartiere e l'aperta campagna a quei tempi sgombra dell'anello della
tangenziale. Lo stato di conservazione e di manutenzione diqueste aree si dimostra eccellente vista la selezione delleessenze arboree e la dimensione ottimale in altezzaraggiunta col tempo dalla piantumazione. Essa creaun'efficace cortina filtrante rispetto ai prospetti concavi deiblocchi e sottolinea l'armonia dimensionale dell'impianto.Come in altri casi sopra esposti per aumentare la superficieutile degli alloggi si riscontra l'occupazione delle logge e deibalconi con le verande in alluminio caratterizzate da unapovertà compositiva in netto contrasto con l'attenzione deiparticolari nel progetto. La volontà di mantenere il liberoaccesso alla corte comune senza ostacoli o siepi contribuisceal mantenimento della proporzione armonica fra il disegnodel verde e il disegno del costruito.
Illustrazione 21: Blocco 31, schema distributivo
Illustrazione 23: Blocco 40, piante del primo e del secondo piano
Illustrazione 22: La trasformazione spontanea enon controllata delle logge in verande
Bibliografia
Paola Di Biagi, La grande ricostruzione: il piano Ina-Casa e l'Italia degli anni '50, Roma 2001
Rinaldo Capomolla; Rosalia Vittorini, L'architettura INA Casa (1949-1963):aspetti e problemi diconservazione e recupero, Roma 2003
Luigi Beretta Anguissola, I 14 anni del piano Ina-Casa, Roma 1963
Leonardo Benevolo, L'architettura dell'Ina-Casa (in “Centro Sociale”), Roma 1960
Ina-Casa, Piano di incremento dell'occupazione operaia. Case per i lavoratori. Suggerimenti norme e schemiper l'elaborazione e la selezione dei progetti – Bandi di Concorso (fascicolo I), Roma 1949
Ina-Casa, Piano di incremento dell'occupazione operaia. Case per i lavoratori. Suggerimenti, esempi e normeper la progettazione urbanistica – Progetti tipo (fascicolo II), Roma 1950
Ina-Casa, Piano di incremento dell'occupazione operaia. Case per i lavoratori. Guida per l'esame dei progettidelle costruzioni Ina-Casa da realizzare nel secondo-settennio (fascicolo III), Roma 1956
Ina-Casa, Piano di incremento dell'occupazione operaia. Case per i lavoratori. Norme per le costruzioni nelsecondo-settennio (fascicolo IV), Roma 1957
Giovanni Astengo, Nuovi quartieri in Italia (in “Urbanistica” n.7), Roma 1951
Adalberto Libera, Ina-Casa. La scala del quartiere residenziale (in “Esperienze urbanistiche in Italia”),Roma 1952
Gestione Ina-Casa, L'Ina-Casa al IV Congresso Nazionale di Urbanistica, Roma 1953
Benedetto Gravagnuolo, La progettazione urbana in Europa: 1750-1960: storia e teorie, Roma 1991
Autori Vari, Attività urbanistica dell'Ina-Casa (in “Urbanistica” n.17), Roma 1955