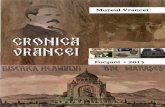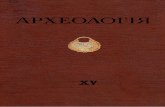I diritti sociali come diritti fondamentali _ Diritto Pubblico 1.2013
Aspetti dell'assistenza ospedaliera a Firenze nel XV secolo in Città e servizi sociali nell'Italia...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Aspetti dell'assistenza ospedaliera a Firenze nel XV secolo in Città e servizi sociali nell'Italia...
CENTRO ITALIANO DI STUDI DI STORIA E D'ARTE,
PISTOIA
-A,\INIINISTR{ZIONEPRO\INCIALECAMEMDICOMMERCIOINIDUSTRIAAGRICOLTUMCOMUNE ENTE PROVINCL{LE PER IL TURISMO
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOL{ E PESCL{
DODICESIMO CONVEGNO DI STUDI
CITTA E, SE,RVIZI SOCIALINELL'ITALIA DE,I SE,COLI XII-XV
Pistoia, 9-12 ortobre 1987
presso la sede del Centro1990
Pistoia,
INDICE GENEMLE
Enti promotori
Comitato scientifico
Relatori
Emilio Cristiani, Presentazione
Henri Bresc, Ecole et seruice sociaux dans les cités et les <rter'
res» siciliennes (XIll"-XV" siècles)
Giovanna Petti Balbi, lstituzioni cittadine e seruizi scolasticinell'ltalia Centro-Settentrionale tra XIll e XV secolo
Anna Maria Patrone Nada, «Super prouidendo bonurn et suffi-ci e n t e m m a gi s t rum s ch o larurn ». L' o r ga nizzazio n e s co las t ica
delle città del tardo Medio Euo
Francesca Lozzatr Laganà, LJn rnaestro di scuola toscano delDuecento: Mino da Colle di Valdelsa
Giuliana Albini, L'assistenza all'infanzia delle città dell'ltaliaPadana (secoli Xll'XV)
Gian Maria Varanini - Giuseppina De Sandre Gaspami, Gliospedali dei «malsani>» nella società ueneta del XII Xlllsicolo. Tra assistenza e disciplinamento urbano. I. L'inizia-tiua pubblica e Priaata
Gian Maria Varanini - Giuseppina De Sandre Gasparini, 11.
Organizzazione, uontini e società. Due casi a confronto
Mauro Ronzani, Nascita e afferruazione di un grande «Hospita'le» cittadino: lo Spedale Nuouo di Pisa dal 1257 alla metà
del Trecento
pag. V
VI
VII
x
1
21
» 115
>> 201
569
>> t4l
>> 166
49
83
Lucia Sandri, Aspetti dell'assistenza ospedaliera a Firenze nelXV secolo
Enrico Coturri, Spedali della città e del contado a Pistoia nelMedio Euo
Irma Naso, L'assistenza sanitaria negli ultimi secoli del MedioEuo. I rnedici «corudotti» delle comunità piemontesi
Gabriella Piccinni, L'ospedale di S. Maria della Scala di Siena.Note sulle origini dell'assistenza sanitaria in Toscana(ruV-XV secolo)
Anna Benvenuti Papi, «In domo bighittarum seu uiduaruntr>.Pubblica assistenza e marginalità fernminile nella Firenzenzedieaale
Pierre Racine, ll sistema ospedaliero lornbardo (secoli Xil-XV)
Silvana Collodo, ll sistema annonario delle città uenete: dapubblica utilità a seruizio sociale (secoli Xlil-XVI)
Duccio Balestracci, La lotta contro il fuoco (XIll-XVl secolo)
Roberto Greci, f/ problema dello smaltinaento dei rifiuti neicentri urbani dell'Italia medieuale
Maria Serena Mazzi, «Un dilettoso luogor: l'organizzazionedella prostituzione nel tardo Medio Euo
Halina Manikowska, ll controllo sulle città. Le istituzionidell'ordine pubblico nelle città italiane dei secoli XIV e
XV
lndice dei nomi e delle cose noteuoli (a cura di Enrica Salvatori)
lndice degli autori (a cura di Enrica Salvatori)
Indice generale
>> 2)J
>> 259
>> 2JJ
>> 2gJ
325
355
»> 439
>> 465
» 481
5t5
551
569
)83
417
570
Sabato 10 ottobre, mattinaPalauo dei Vescoui
Presidente Prof. PrenRE RecrNB
Lucra SeNonr
ASPETTI DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA A FIRENZENEL XV SECOLO
Note introduttiue: città e suiluppo ospedaliero (XIV-XV secolo)
La storia ospedaliera fiorentina non ha beneficiato molto sino
ad oggi dell'atteÀzione degli storici. Se si esclude l'opera, famosa,
di Luigi Passerini della metà dell'Ottocento, sorta di censimento
storicJdegli ospedali cittadini e alcune monografie in genere di
vecchia dit^, dittute per 1o più da interessi artistici o religiosi, la
situazione degli studi in matetia, è in area cittadina, p^t-
ticolarmente per il periodo medievale, a dir poco, deludente (1).
Ma è tutta É storiografia ospedaliera a risentire, nonostante gli
studi che si sono intensificati in quest'ultimi anni, di notevoli ritar-
di rispetto ag[.ùtrirami della storia sociale(2).La ragione di ciò
(1) L'opem di L. PessunrNr, storia degli stabilimenti di beneficenza e.di..isttuzione
,rutu'iia dellà ciuà di Firenze, Firenze 1851iè basilare per Ia conoscenza dell'assistenza
:t*ffir;;;il;" a"l *,o..ii"o ^lle
soppies.ioni leopotdine. Tuttavia notizie storiche
."UG.àAi?a fiorentina possono esserè trrtt. da opere di carattere storico-artistico-
;.lrgi;il, q;rti p., .r.-pio quella di G. Rrcnn,.Norizie storiche delle chiese fiorentine.
""Ul-io,'fir."rè fiSq-ieq. Èer indicazioni bibliogra{iche di questo tipo, relative cioè
;d ;;. ,on-ro..ifi.l. ma utili per ricomporrà il quadro assistenziale fiorentino,
o.o.àr[.ro in òarticolare, rimandiamo alle precise indicazioni di A. D'ADDARI9,
i{p"rui ;;ihz';;;;;;fr;;; a Firenze,Roma r§72, pp. 58-5e in nota, che se ne awale
;rrr'i.*. , q".ffa già iominata di Luigi P-asserini p-ù illusffare la carità cittadina che
arriva a ,,-ro uorrisò senza cedimenti dàla fioritura àel primo medioevo al.XVI secolo.*-' ?rl §t.a" t"tl*g.merto E. BnesseN, L'obosplmle» .e.i poyery: la stotiografia
,uU,ìilrt*ri. i,ttotn ilt caso «lombardo,>, Milano t98t e del medesimo a,ttoreProb-
237
sta forse nell'intimo e perenne contlasto dalle istituzioni ospedalie-
fe nei secoli, vie di mezzo cioè 6a luoghi religiosi e profani, di cura
e di carità, in una dualità durata sino ai giorni nos6i, che investe le
pefsone ,t"rr. .h. in vario modo hanno a che fare con tali strut-
tufe.È l, pen.*azione di questa percezione dell'assistenza ospeda-
liera che pir: a tutto ci ha interessato, urr assillo, che accompagna
mohe delle riflessioni che seguiranno.
Le notizie ffatte dalle fonti letterarie del XlV e del XV secolo,
come è noto agli studiosi, parlano di una città altamefite org nizza-
ta sotto il proÉlo dell'assistenzai ttefita, tfentacinque ospedali sec-
ondo le tesìimonianze del cronista Giovanni Villani e dell'umanista
Cristoforo Landino (3).
IJna fitta rete ospedaliera non è tuttavia, in questi secoli, pre-
rogativa solo fiorentina ed è comune ad altre città, seppure sia da
considerarsi una caratteristica dell'atea del Centro-nord, la più ur-
banizzata della penisola, Le città toscane da parte loro, sembtano
godere di una pàsizione di privilegio. Pisa, con forse 40.000 abitan
Ii ulu firr. del;200, vede sorgere tra XI e XfV secolo ben cinquan-
tacinque ospedali, dei quali, però, non è dato sapere quanti ne
funziJnassert ,[,epoc, del suo massimo sviluppo demografico (4).
Siena, 15.000-40.0ò0 abitanti ai primi del 'J00, si awale al tempo,
leni d.i stoiografia dell'assistenza in ltalia,'nwelfate_state - problemi e alternatiue, a
cuta di G. R6sir, . P. DoNerr, Milano 1982, pp' 221'248'-*-Ol -f. .f,i.t. .h'..rto illoru n Firenze'é ne' borghi, co.ntando le badie e Ìe
.hi... d.,frati religiosi, troviamo che sono centodieci, tra_1e quali sono cinquantasette
;;rr*Ài.-;;; pàfiolo, .irqu. badie con due priori con da onanta monaci, ventiquat-
il';;t;;i'.i-;;.h.'.o, d, cinquecerito donne, dieci-regole di frati' trenta
,p"iJ^..i prtii*U" i.tt, ad lllogare ipoveri einfermi, e da dugentocinquanta in
;L;;;"-;;p;.lluoi . pr.ti,. {ò. Vi'Ji*,, fronica,!!, Roma 1e80' pp 183-185):, Nella
.,^rt" dedicaìa ai Flientini eicellenti in'dottrina delJa Apologia, ne-lla quale si difend-e
'iàiU"rlf"ii'*-1):'fiiti colonniatoi Cristoforo Landmò, parla, tra l'altro, della
;;;;fi.*r" deflà chieie, dei monasteri e degli ospedali fiorentini: <<Sono preterea
;i;.? ;il[ tt .h*; di ;;r-..hi. .i'qr^.,tut.à. Sono hosp itali trentacinque,tra' quali
ardirò oorre santa Maria Nuova ei primo tra' christiani. In questo si curano I'un mese
,.ì"r ,i"" pirìii; ì;;;;;;.; ulaii, (Co*edia det druino poeta .Dante Alishieri con la
1olto ,t legyiadro spositione di Christoforo Landino, Vinegia i5l6)'-""""
(;1 ÈffE;#;à"L pir*l ,i,r.d^, A' Parrtta, Gtibspedzli a.P-isa-nel Medioeao'
tastiu'tture sinitaie a Pia'. Contributi alla stoia di *na citià sec. Xlil-XlX, Pisa 1986,
nn-- lSi-.15, oer i dati demoerafici cfr. D. HtnrrHv, Pisa in the eaily Renaissance' A
iirdy of urÈan growth. New Haven 1958, pp.35-fi'
238
-1e-
ta:leut-
1a-'rl4
1o,
aa-
:L-
tta
dau-rlo
I-n-ne
{),o,
di una diecina di ospedali (5). Lucca, per limitarci ad alcuni esem-
pi, con non più di 15.000-20.000 abitanti, vanta all'epo-ca in que-
stione, tredici, istituzioni ospedaliere (6).
i)l'organizzazione più che il numero degli ospedali della To-scana tardomedievale ad attirarcl'ammftazione delle altre città del-1a penisola e persino europee. Per non parlare dell'esemplaritàdell'ospedale fiorentino di Santa Maria Nuova, di cui ci occupere-mo, basti pensare a quello di Santa Maria della Scala di Siena, notagià ai contemporanei per la salda amministrazione è la qualità deiservizio ospedaliero (7).
rJna valutazione dello sviluppo raggiunto dall'assistenza ospe-
daliera nelle varie città sulla base della sola componente numericanon può dare, infatti, un'esatta visione del1a realtà poiché, comesappiamo, in epoca medievale si indicavano come ospedali anchesemplici ospizi con appena qualche letto a disposizione. A Perugia,per esempio, per la quale è attestata la presenza in arcaurbana, ftaTrecento e Quatffocento, di ben ventiquattro ospedali al servizio diuna popolazione di circa J0.000 abitanti, sappiamo, da un resocon-to sia pure un po' tardo, le visite pastorali del X\{[ secolo, che si
poteva contare su meno di un totale di cento posti letto (8). Per la
.a
1e
!LÉ
et-ìtain
11a
de1la
a\,:5e
lo
,,6,
A
(5) Per gli ospedali di Siena cfr. A. Genos4 Siena nella storia della medicina(1240-1555), Firenze 1958, pp. 287-288; per i dati demografici, si veda L. Bontorot-rt, Siena, Batr 1982, pp. 19-20.
(6) Per gli ospedali di Lucca, si veda L. Scutvrucct, Lucca e il pellegrinaggioruedieaale,'rn Lucca, il aolto Santo e la ciuiltà medieuale,Lucca L984, pp. 157-176;
(7) Sulla fama degli ospedali toscani, di Santa Maria Nuova di Firenze e di SantaMaria della Scala di Siena, specie nel Nord d'Italn, si veda il lavoro di F. Lrvrnotrl,Ricerche sulle origini dell'ospedale Maggiore di Milano, «Archivio storico Lombardo»,C\trI (1981), pp.77-773. Sul progresso del servizio medico all'interno degli ospedalitoscani e di quello di Siena in particolare, cfr. M.D. Gnurr, Le médecin au seruice deI'hopital rnédiéoal en Europe occidentale, in L'etnergenza storica delle attiuità teniarie(secc. Xll-XWil), relazione tenuta presso l'Istituto Internazionale di Storia economica<<Francesco Datini>:, XIV settimana di studio, Prato,27 aprle 1982. Del resto il mede-simo Cristoforo Landino, tiferendosi all'ospedale di Santa Maria Nuova, traccia unquadro eloquente: <(In questo si curano più che tecento amalati. Sono del continuo,6enché molto difficil sia e letti candidi et sempre chi guardi l'amalato et a ogni hora a'suoi bisogni pro!'vegga. Né è comune o el vitto o 1a medicina ma singulare a ciascunosecondo el morbo. Sempre sono parati e medici et phisici, e quali particularmente a
tutti ordinano» (Cornedia del diuino poeta Dante Alighieri con la dotta et leggiadraspositione di Christoforo Landino, cit.,).
(8) Pet Perugia, sia per dati demografici che per quelli ospedalieri, cfr. A. Gno-HMANN, Città e territorio tra Med.ioeoo ed Età rnoderna (Perugia secc. XILL-XVI), voil,.2,Perugia 1981, i, La città pp.381-401 eIo.,Perugia Bari, 1981, pp.20-21 e64-65.La
239
Milano della fine del '200 (100.000 abitanti circa) si intuisce, al
contrario, che l'esiguità numerica delle istituzioni ospedaliere, dieciin tutto, rispetto all'alto valore demografico, è forse blanciata da
una rilevante capacità ricettiva, visto che uno solo dei suoi ospeda-
li, stando alle notizie delle cronache, il più antico, detto <<del Bro-1o,>, poteva accogliere, benché in tempi di crisi, sino a cinquecentoinfermi (9). Non va dimenticato che un letto poteva ospitare due,
tre infermi aTTavolta, secondo l'uso del tempo, favorito dalf'utrlizzodi «letti grandi>> come ci documentano spesso le fonti, ragion per
cui varrebbe la pena di specificare ogni volta se ci si riferisce al
numero dei letti disponibili o a quello degli infermi accolti.
La Firenze quattrocentesca (40.000 - 50.000 abitanti) dis-
poneva forse di non più di 500-600 letti, divisi ta i diversi entiospedalieri, dei quali più di un terzo era assorbito da quello diSanta Maria Nuova, là dove il XW secolo of{riva, ad una popola-
zione oltre le 100.000 persone, stando alla soLita testrmonianza diGiovanni Villani, «più di mille letta, (10). Da qui 1a supposizione,
capacità ricettiva degli ospedali petugini è tatta da G. )vhcrrozzr, Antichi ospe_dali diPirugia, «Vita ospedìlieràr, XLII, ) (marzo 1987), pp -16--17, dove i.l numero dei lettid.i ùri ospedali^è contato in occasione di visite pastorali operate nel corso del XVIsecolo.
(9) Pet gli ospedali milanesi, è da vedere G. C.rsrtru. Gli antichi ospedali e launificazione o\pediliera rnilanese del XV secolo, Milano 1918, dove sapp.iamo dall'auto-re che nel 1448 furono riuniti all'ospedale Maggiore sedici ospedali urbani e quindicidel.contado. Dieci ospedali sono invece indicati da1 cronista Bonr.esin Da 1a Riva alla
finé del XIII secolo: .iVi sono inoltre in città e nei sobborghi, che sono sempre sottin-tesi quando si parla de11a città, dieci ospedali per i malati_poveri e quasi tutti adeguata-
mente dotati di beni temporali. Tra essi primeggia l'ospedale del Brolo, ricchissimo per
cospicui possedimenti, fondato nel 114i da Goffredo da Bussero.-In questo ospedale,
cosi attes-tarono i suoi frati e decani, si trovano ta1volta, e specialmente nei giorni dicarestia come quando se ne fece il conto, più di 500 malati poveri a letto e un numeroancora maggioie di malati non costretti a ietto, tuttl maltenuti a-spese-dell'ospedale,inoltre alle iue cure sono affidati nientemeno che più di 350 bambini, di cui sin dallanascita si occupano altrettante balie...» (BoNvrsrN Dr r.r. Rrv.t, De magnalibus Medio-lani, con introduzione di Maria Corti, trad. It., Milano 1974, pp.55'56'
(10) Tale computo nasce dalla considerazione che alla fine del'400 Santa MariaNuova contava, s.còndo il calcolo del Passerini che ci pare il più conveniente, intornoar23Oletti; l'ospedale di Bonifazio nel corso del medesimo ne disponeva 94, quello diSan Matteo 60è)5 San Paolo per iI quale sappiamo però che non furono mantenutiper turto i'arto del '400. La dis§onibilità di letti infatti variava co1 mutare delle condiiioni economiche degli ospedali-. I maggiori ospedali contavano intorno ai 200-100 letti(si badi bene non iicoveJati). Per gli altri ospedali - ospizi si può calcolare nelmigliore dei casi dai 10 ai 12 letti èiascuno (in genere erano almeno tanti quanti i1
,ut.to degli apostoli) quello del Vespucci ne contava ai primi del secolo, I'epoca
240
se si vogliono considerare attendibili i dati del Villani, riferiti al
1118, che il notevole calo demografico, seguito alle crisi epidemi-
che, soprar,wenute a partire dal 1348, avesse causato la scomparsa
di molte piccole istituzioni, dando al panorama assistenziale cittadi-no l'assetto quale ci appare nell'epoca di cui ci occupiamo, tenden-
te cioè al mantenimento, come vedremo meglio in seguito, di po-
che istituzioni, tra cui un grande ospedale. Tale mutamento è del
resto già presente nel medesimo Cristoforo Landino che, alla fine
del XV secolo, pur riportando i medesimi dati del Villani riguardo
al numero degli ospedali, si sofferma con ricchezza di particolarisull'ospedale di Santa Maria Nuova, la maggiore istituzione cittadi-na (11).
(Jbicazione dell'istituzione ospedaliera e assetto urbanistico a Firenze
tra XI e XV secolo
Ospedali, ospizi di vario genere
nello spazio cittadino. I più antichi,ormai scomparsi e decaduti e quasi
si disribuivano variamentela maggior parte dei qualiinattivi nell'epoca di cui ci
misliore, diciotto. Supponendo che Firenze disponesse di a16i diecidodici piccoliori.duli, si ottengonoitri 150 letti pari ad un totrl" di 550, circa posti_disponibili_perpoìeri e'infermi,ésclusi gli ospedali che si occupavano dell'assistenza all'infanzia, doveSanta Maria della Scala-per tutto iI XV secolo e San Gallo sino al 1436,- pate, però
accogliessero ancora poveri e infermi specie in concomitanza delle crisi epidemiche- Intutto] .o-pr".a dt,nqi. anche 1a .^puCità assistenziale dei due ospedali per ttovatelli sipossono calcolare ciica 600 posti lÀrro. Vero è che i poveri erano accolti anche daLle
varie confraternite. che armìntrno in città nel corso del secolo. alcune delle qualt
offriva forse qualche letto o giaciglio per i poveri ma non certo pef gli infermi. Infine,anche considérando il calcolò di-600 letti, la situazione cittadina riguardo al numero
dei ricoveri offerti a poveri e ammalati dagli ospedali era molto variata rispetto alla
prima metà del XlV-seco1o. U! comp-enso però, llPpure-limitato ai soli-indigentipoteva provenlre, come sr è già detto dall'aumento delle confraternile,-b9n 75 aipnmià.1 S..à1o sedicesimo cfr. G.M. MoNrr, Le confraternite medieuali dell'alta e media
Italia, Fnenze 1927, vol. I, pp.; 149 e segg. Per il numero dei letti a- disposizione nei
vari ospedali, si veda, L. PeissnrNr, Stor/i degli Stabilirneilti di beneficenza, cit. Per il,,,rln.rò degli abitanti in città all'epoca considerata cfr. D. HBnrrnv-CH. KrAprcH-Zuspx, Les Toscans et leurs familles, une étude catasto florentin de 1427, Patigi 1978,pp. 173 e segg.
(11) Cfr:-G. Vr*aNr, Cronica cit. Tale vaiazione de1 panorama assistenziale
cittaiino è già percepita da Cnrstorono LaNorNo, ghe pon_e in evidenza 1a presenza diun grande òrpÉdrl.,-.he assorbe un numelo straordinario di ammalati e che primeggia
sui iimanenti, vedi a questo proposito la nota n. )-
241
occupiamo, il XV secolo, sorgevano in prossimità delle porte, sulle
vie principali, al loro imbocco in città e quasi sempre collegati a
chiese e monasteri.Tali antiche istituzioni, risalenti all'XI secolo, assolvevano, in
origine, principalmente, al ricovero dei viandanti e dei pellegrini.Almeno due ospedali pare sorgessero sul Ponte Vecchio, fuori PorSanta Maria, uno dei quali retto dai cavalieri dell'ordine di San
Giovanni di Gerusalemme; un altro era congiunto alla basilica diSan Lorenzo, fuori della porta del Vescovo; sempre fuori dalle
mura, quelle ar,cora della cerchia «Matildina>r, dal7a parte di PortaSan Piero, un ospizio era gestito dal monastero di San Pier Maggio-re e molto vicini alle mura, si trovavano in-fine due ricoveri: unosottoposto allaBadia tra Porta San Piero e la postierla del Garbo,l'altro, detto di San Giovanni evangelista, sorgeva alf interno presso
il duomo e la Porta del Vescovo (12).
È alla fine del XII e ancor più aI XIII secolo che dobbiamo la
comparsa di istituzioni ospedaliete ad ovest e a sud de1la città,nuovamente lungo la linea delle mura, seppure di quelle ampliate
della «prima cerchia comunale»> (13). L'origine laica di alcuni e
1'attività assistenziale di tutti, rivolta ad un'utenza più vasta di tipourbano, catattetizzano gli ospedali sorti in quest'epoca' Fuori della
Porta San Lorenzo,là dove partivano le strade per Bologna e lzRomagna, sorge alla fine del XII secolo, l'ospedale di San Gallo,destinato a divenire popalare nell'ambito della beneficienza fioren-tina nel corso dei due secoli successivi e, particolarmente, per l'as-
sistenza ai trovatelli (14). Ai primi de1 '200La zona ovest della città
(i2) Le notizie degli ospedali qui come altove in quesro paragrafo, sono tatteoltre che da L. PessptrNr, Storia degli stabilimenti di beneficenza, cit., da R. Devr-DSoHN, Storia di Firenze, cit. \{I, pp.84 e segg. Per laloqz1i,7a7i6ne degli ospedali cisiamo valsi dell'opera Le strade di Firenze, a cura di P. Bencr'lrrNr e E. Gu.rnNrrnr,Firenze 1977, pp. l-5 e di quella M. Loopps PecNa, Firenze dtlle origini al Medioeuo,Firenze, 197 4, pp. 313-341.
(13) Si taiia delle mura della prima cerchia comunile del tt72. Nel quartiered'Olffarno non vennero costruite vere e proprie mura ma fu i-l dosso delle case ad
assicurare 1a difesa della città, cfr., P. BancnruNI, Le strade di Firenze, cit., Le seticerchia murarie, pp. 1-6. e M. Lopss PocNe, Fircnze dalle origini, crt., _pag. 33_8.
(i4) Per |'knportanza raggiunta dall'ospedale di San Gal1o nei secoli siveda oltea L. PessrnrNr, Storia degli stabilirnenti di beneficenza, cìt., pp. 659-667 F. Cea»rNr,IJna licenza di Niccolò IV all'ospedale di San Gallo, «Archivio Storico Italiano>>,
CXXVIII (1970) pp. 469-474; Sulla vita e l'attività dell'ospedale rimandiamo in par-ticolare a G. PrNiò, Personale, balie e salariati dell'ospedale di S. Gallo, estratto da
242
ospita almeno quattro, cinque ospedali, tutti situati all'esterno diPorta San Paolo. tra questi, uno era stato promosso dalla predica-zione di Pietro da Verona e alti due istituti e sorretti dall'opera deiterziari francescani, esercitanti la loro attività a due passi dallachiesa domenicana di Santa Maria Novella (15). Fondato da unlaico, come del resto anche quello già nominato di San Gallo, allafine del XIII secolo, compare tra le istituzioni assistenziali cittaàinequello di Santa Maria Nuova, che sorge fuori delle mura tra laporta di Balla e la postierla degli Albertinelli, poco prima dell'ulte-riore ampliamento della cerchia muraria (16). Ma è specialmentel'Oltarno che vede l'articolarsi, nel corso del )OII secolo, di unarete di ospizi nei pressi delle chiese omonime dei popoli di San
Giorgio, di Santa Lucia de' Magnoli, di Santa Felicita e di San PierGattolino, guadagnati da poco al perimetro urbano.
I XIV secolo è ancora caratterizzato da un incremento delleistituzioni ospedaliere. Se l'ampiezza del7e mura, quelle della sec-
onda cerchia comunale, consente ormai largamente la fondazionedi ospedali alf interno del tessuto urbano, tuttavia quelli sorti nellaprima metà del secolo, vengono ancora istituiti in vicinanza delleporte e comunque sempre su strade intensamente frequentate. InOlmarno si intensificano i ricoveri intorno e lungo la strada chereca ail.a Porta San Pier Gattolini, che si apriva sulla stada direttaa Siena e a Roma. Nelle vicinanze di Porta a Prato è fondatol'ospedale di Santa Maria della Scala, che si awierà presto all'assi-stenza specifica dei tovatelli e alla Porta a Faenza trova luogol'istituzione di Sant'Antonio per il ricovero dei malati di ergotismo,
<<Ricerche storiche)),2 (1974), Firenze 1974 eL. SaNonr, Modalità dell'abbandono dei
fanciulli in area urbana: gli esposti dell'ospedale di San Gallo di Firenze nella pima metàdel XV secolo, in Infanzia e società in Europa, XIV-XX secolo, Roma )0-31 gennaio1987.
(15) Per gli ospedali della Compagnia Maggiore, fondati da Pietro da Verona e
per quelJi dei terziari francescani, specie per quello di San Paolo in Santa MariaNovella, si veda R. DavrosouN, Storia di Firenze, cit., \{I, pp. 163-188 e sulle vicendedei terziari francescani di Santa Maria Novella e sul1e compagniefondate da Pietro daVerona, si confronti, G.G. MennssrutN, Dossier de l'ordre de la pénitence au XIIIsiècle, Fribowg 1961; pp. 10 e segg.
(16) Sulla questione del luogo ove sorse Santa Maria Nuova <<Érzi r;auros ciuitatisFlorentie et prope ecclesiam Sancti Egidii>> e non alf interno delle mura neli'odierna viaFolco Portinari, si veda, Lo spedale di S. Maria Nuooa e la costruzione del loggiato diBernardo Buontalenti, a cura di G. PelrparoNr, con introduzione di Ugo Procacci,Firenze 1961, pp. 15 e segg.
243
secondo gline (17).
È lu r.o.rrrolgente esperienza dell'epidemia del 1348, che porta
alla fondazione di nuove istituzioni, che sembrano non tenere piùin alcun conto il precedente utitzzo dell'ospedale come luogo adi-
bito principalmente al ricovero dei viandanti e dei pellegrini e che
paiono orientate, già dal1a scelta del luogo in cui sorgono, alla
ricerca di un più diretto contatto con la popolazione cittadina.L'ospedale di Bonifazio, della fine del secolo, sorge nuovamente
sulla via di San Gallo, incorporando però beni e locali di istituzionipreesistenti, probabilmente in declino, come pensiamo fosse per lagran parte dei piccoli ospedali dopo la grave crisi di peste (18).
Quello di San Matteo trova posto, alf incirca alla medesima epoca,
poco distante del già affermato ospedale di Santa Maria Nuova,che certo aveva dovuto sostenere durante l'epidemia un ritmosconvolgente, cui persino le sue strutture dovevano essere risultateinadeguate (19). In Borgognissanti, sempre alla fine del XIV seco-
1o, eta nato l'ospedale di Simone Vespucci, in un'area, che aveva
alle spalle quella già ben servita di Santa Maria Novella ma che
aveva di fronte a sé, dall'altra parte del fiume, I'Oltarno, dotato dinumerose ma piccole e povere istituzioni (20).
(17) Pet I'ospedale di Santa Maria della Scala oltte a G PesssnrN4 Storia deglistabiiimenti di beÀeficenza, cit. pp. 675 e segg., si legga anche S. Martino in oia dellaScala. Ricordo storiòo di Gurno Canoccr, Firenze 1898. Per l'ordine degli ospitalieri diS. Antonio di Vienne in generale rimandiamo a Przzrtr, I santi nella stoia della
medicina,Roma L947, pag. 37 e per l'ospedale fiorentino di S. Antoruo a L. PassrnrNr,Stoia degli stabilimenti di beneficenza, cit., pp. 135 e segg.
(18)-Su1 luogo ove fu fondato l'ospedale di Bonifazio e l'utilizzo di locali diistituzioni preesistènti, si veda G. Brzz.r.nnrNr, Glì ospedali fiorentìni (dal_1200 al 1.937),
<<Firenze Rassegna Mensile del Comune» W4 (l1f.7), pp. 116-119; Per Ia storia dell'o-spedale, L. PessrnrNr, Storia degli stabilimenti di beneficenza, cr|., PP. 2.16 e segg.- (19) Per San Matteo, oltre à L. PasstnrNr, Storia degli stabilimenti di beneficenza,
cit., pp. 149 e segg., si veda specie per l'ubicazione e l'edificio che g1i fu destinato,L'Aicàdenia di belle arti di Firànze - 1784-1984, Firenze 1984, pp. 17-21. Durante leepidemie gli ammalati di peste venivano ricoverati nei vari ospedali cittadini. Unalàpide nel museo di San Marco ricorda il ricovero di appestati anche nell'o-spedale diSanta Maria del1a Scala, destinato più che altro a1 ricovero dei bambini abbandonati,durante l'epidemia del 1479. La noiizia è 6atta da G. Brzzennrxr , Gli ospedali fiorenti-ni, cit., W2 (l%7), pp. 42-43.
(20) Per l'ospedalè di Simone Vespucci, detto poi di Santa Maria de11'Umiltà e
infine di San Giovanni di Dio, rimandiamo a V. Pascr, Notizie relatiae alla fondazione e
amministrazione dello spedale denorzinato San Giooanni di Dio, Ftenze 1988 e a L.PassnnrNr, Storia degli stabilimenti di beneficenza, cit., pp' )95 e segg.;
244
La <<specializzazione>> ospedaliera del XV secolo è anch'essa ilfrutto di un'ottica assistenziale tutta cittadina. Fioriscono in que-
sr'epoca luoghi di cura per i soci delle arti minori, mentre le mag-
giori già da tempo si erano viste affidare il paronato di ospedali
dediti ad un'attività di tipo pubblico, quali quello di Santa Mariadel1a Scala, di San Gallo, di Bonifazio e di San Matteo. Nel 1435 è
fondato dai manesalchi in via San Gallo, l'ospedale di Sant'Eligio esul finire del secolo alle spalle della medesknavia, quello dei Batti-
lani, nell'area compresatravia delle Ruote, via San Zanobi e Santa
Reparata (21). Sottoposto all'Arte della Seta, alla metà del Quatuo-cento, era nato quello degli Innocenti sulla piazza della Santissima
Annunziata, creato per il solo ausilio dei bambini abbandonati'È in q.resto clima di intensificazione della tete assistenziale
urbana che si inserisce, alla fine del secolo, la fondazione fuoridelle mura e per di più in vrra zona, quella a est, quasi del tuttodisservita di enti ospedalieri, di San Sebastiano degli Ammorbati,nei pressi della Porta della Giustizia, che ci propone per l'eccezio-
nalità, data l'epoca, della sua posizione e della sua destinazione (gli
ammalti di peste) una chiara volontà di prevenzione della salute
pubblica.La varrazrone operatasi nel tempo nell'ubicazione delf istitu-
zione ospedaliera nel contesto urbano cittadino è dunque rivelari-ce di mutati intenti assistenziali.
Orientati un tempo verso un'assistenza sporadica e casuale,
infittitasi con la ripresa della proclamazione degli anni giubilari a
partire dal «grande giubileo» del 1300, gli ospedali avevano poipian piano spostato la loro attenzione,legata alla strada e ai vian-dantr, ai bisogni della città (22).Il notevole aumento demografico,che dall'Xl al XIII secolo aveva costretto per ben due volte alf in-grandimento delle mura, era stato accompagnato da una int-ensificazione della rete ospedaliera. Nuove istituzioni, ormai auto-
(21) Sugli ospedali promossi dalla solidarietà degli artigiani nominati, si vedasempre L. PÀssnnrNr, Stoia degli stabil!ryen1i di beneficenza-, cit., pp. 106.e segg. e inparticolare, F. Arr,o»r, Cenni sull'ospedale dei battilani e sulla assistenza alle temopatieiegli anticbe spedali delle corporazioni, Firenze 1957 e n generale, A. ConsrNr, L'a$z-stinza ospitaliera e le antiche corporazioni di arte e mestiei, Pruto 1922.
(22)' Per la cadenza degti aniri giubilari dal 1100 in poi, cfr. G. Cesrnrrr, Gli annt
santi,Rocca San Casciano 1949.
245
nome dall'abbinamento con chiese e monasteri, erano sorte, quasi a
corredo delle nuove mura, a fronteggiare però, già ai primi del'200, zone <<nuove»> della città, quali l'Oltrarno a sud e, a nord-ovest, l'area intorno alla chiesa di Santa Maria Novella. Alla finedel '200 e ai primi del 'J00, la necessità di ospedali <<urbani>> si
riassume nella fondazione di Santa Maria Nuova e nella coperturadi vuoti assistenziali nelle zone più densamente popolate e oggetto
di una crescente immigrazione. Alla fine del XlV e nel XV secolo,
la fine dell'espansione demografica segna, infine, una riorganizza'zione della città al suo interno anche sotto il profilo assistenziale.
Con la definitiva affermazione di una destinazione universale deglienti ospedalieri, sorgono, infatti, nel cuore stesso della città nuoveistituzioni, catattetizzate, tta l'altro, da insigni strutture architetto-niche (21).
Alla fine del '400 la mappa assistenziale fiorentina delinea lezone più povere della città, caratterizzate dalla presenza, lì più che
alffove, del proletariato urbano: l'Olrarno, 1o spazio urbano a sud ead ovest della chiesa di Santa Maria Novella, fronteggiante in partei popoli di San Ftediano e di Santa Felicita, sul1a riva sinistadell'Arno e tutta la sriscia a nord e ad ovest della basilica di San
Lotenzo, parallela alla via San Gallo. Qualche sacca si apriva forse
anche a nord-est, intorno alla chiesa della Santissima Annunziata,non oltre il popolo di San Pier Maggiore e più giù in quello diSant'Ambrogio.
La Fienze del '400 dunque disperde i suoi poveri in aree
periferiche o li accalca in Oltrarno dal7'a\tra parte del fiume.
(23) Fienze nel XV secolo vede sorgere il complesso dell'ospedale degli In-nocenti su progetto del Brunelleschi e aricchisce gli ospedali già esistenti con impor-tanti opere architettoniche: l'arte dei giudici e dei notai, sempre su progetto, comepare brunelleschiano, abbellisce con un portico l'ospedale di San Paolo in Santa MariaNovella. Anche gli ospedali di Bonifazio e di San Matteo sono coredati da enrambida una opeta di Romolo di Bandino e Sandro dei Vinta sul finire del )(IV secolo. Sullefabbrichè ospedaliere quattrocentesche e la loro monumentalità si veda, in genetale, A.Scottr, Malati e strutture ospedaliere dall'età dei luni all'Unità, tn Storia d'ltalia,Malattia e medicina (Annali 7 pp. 238-D9. In particolare per gli interventi architettonici nei vari ospedali, rimandiamo per quelli di Bonifazio e di San Matteo, a L'Accad.emiadi belle arti di Firenze 1784 1984 cit., pp. 20-21; per quello di San Paolo, cfr. M.A.MaNNr,rrr, L'ospedale di S. Paolo dei conoalescenti in Firenze, «Ospedali d'Italia-Chirurgia>>, XII (febbraio 1965), pp.24); per quello degli Innocenti, L. PassrmNr, ,llorzadegli stabilimenti di beneficenza, cit., pp. 685 e segg.
246
a
tEuoluzione dell'istituzione ospedaliera nella Firenze del Xlil'XV se-
rclo
Dal punto di vista istituzionale, l'ospedale della Firenze del
X\I secolò aveva portato a termine, come si è già accennato, la sua
Iaicizzaziorte, di luogo cioè fondato da laici, ricchi benefattori, mer-
canti per 1o più e coesisteva sempre meno come ricovero annesso a
chiese e monasteri'Il Trecento, in particolate, eta stato caratteflzzato dal sorgere
di ospedali la cui attività e amministrazione era stata posta, talvolta
p., uìI.r. dei fondatori, sovente membri essi stessi, sotto il paffo-
nato di un'arte o dall'estensione di questa vigtlanza e protezione ad
istituzione già esistenti. Soluzione, quest'ultima, riservata, in gene-
re, ad istituzioni da tempo male amministrare, nelle quali si erano
verificate gravi irregolarità nella gestione paffimoniale. Già alla fine
del XI11 i.co1o, per esempio, l'ospedale di San Gallo era stato
sottoposto per questa ragione, a17a vigtlanza alternata di varie arti,
qruli q,-,.11, def Cambio, della Lana, di Calknala, dei Medici e
Speziali, dei Pellicciai, e, infine, della Seta(24). La stessa cosa
dtrr"tt" verificarsi per l'ospedale di santa Maria della scala, eserci-
tante la medesima attività di San Gallo, diretta all'aiuto dell'infan-
zia abbandonata, messo nel XV secolo anch'esso sotto iI patronato
dell,arte della Seta (25). Non a caso, ma forse per una particolare
predilezione di quest'arte verso i ffovatelli, anche l'ospedale di'santa
Maria degli Innocenti, softo alla metà del xv secolo, avrà ilpatrocinio dei Àercanti della seta (26). Per l'ospedale di S_an Paolo^i1
Srtt, Ma1,a Novella, fu nuovamente l'autorità comunale a deci-
dere nel 1403, per via del grave disordine seguito all'amminis6azio-
ne dei pinzocheri, la sua dipendenza dell'arte dei Giudici e dei
Notai (27). Sin dall'origine, invece, e per volontà dei fondatori,
turono messi sotro il controll0 delle arti del Cambio e di calimala,
e
;ia
f,
),
ri
t-
e
e
a
n
[,
tr
l.-
r-
re
la
rile
t.1,
i-td
t.1-
ta
Q4) ctr. R. DavrosonN, storia di Firenze, nuova edizione, Firenze 1977, vot.
\n' ;;' 9l-95, cn non parla però della sua sottomissione all'Arte della seta di cui
.i=.f'.i informa L. PassrnrNr,-.!toria degli stabilimenti di beneficenza, cit., pp' 659 e
segg." 25) Cfr. L. PessenrNr, Storia degli stabiltmenti di beneficenza,-cit' pp'-675 e segg'
126) Cft. U. CHr,nrcr,'L'assistenia all'infanzia e il regio spedale degli Innocenti dt
Frexie, Firenze l%2' PP. 2l-22.,iil Cfr. L. pessrnin,, Stoia degli stabilimenti di benefìcenza, cit.,pp.163 e segg.
247
gli ospedali di San Matteo e di Bonifazio, entrambi della fine delXIV secolo (28).
I patronati erano esercitati dunque da quelle arti che, comequella di Calimala, del Cambio e della Seta, avevano, insieme aquella della Lana, la maggiore influenza in seno al governo cittadi-no (29). Tuttavia, tale inserimento delle arti nell'assistenza pubblicadella Firenze bassomedievale è forse più che testimonianza, propa-ganda di impegno politico e di potere economico, olre che ii..r.udi un equilibrio interno al venir meno, come è stato notato, giàdaila tine del XIII secolo, della loro tradizionale murua assisten-za (30). Il riemergere di tale solidarietà che a Firen ze (ma il feno-meno è comune ad altre città) si esprime tra i norcini, i calzolai, imanescalchi, i tintori e i battilani per tutto l'arco del Trecenro especialmente del Quattocento, dando vita ad istituzioni assisten-ziali a carattere ospedaliero, destinate ai soli soci, è stato inter-pretato, infine, non a caso, come connesso alla «crisi della strutturacofporativa>> in quest'epoca e, in generale, alle difficoltà economi-che del XV secolo (11).
Accanto alle istituzioni riservate ai lavoratori delle arti, sorgo-no in città, ra XIV e XV secolo, non pochi luoghi destinati allacura delle vedove, delle <<convertite», dei trovatelli in un'otticaassistenziale che, se in gran parte ripete il passato nella scelta dellepersone da aiutare, se ne discosta nell'optare per una divisionespaziale delle diverse attività caritative. La cura dei malati continuainvece ad essere affidata ad organismi che assicurano anche l'assi-stenza ai pellegrini, ai viandanti poveri, agli emarginati in genere,che non beneficiano di istituzioni loro specificamente destinate.
Da questa appena abbozzata caratteizzazione dell'ospedale,
(28) Cfr. L. Pessrnrrur, Stoia degli stabilimenti di bene/icenza, cit., pp. 149 e segg.e pp. 216 e segg.
(!9) A questo_proposito si veda, A. SprccreNr, Solidaietà, prelidenza e assistenzaper. gli artigiani-ne.ll'Italia medieuale Gemlo XII-XV), n Art;gioii e salaiati. Il nondodel laaoro nell'Italia dei secoli_Xil-XV, Pistoia 1984, pp. 29;3$, alla pag. 324.
(10) Cfr. A. SuccraNr, Solidaietà, prexidenzt, cit., pp. j2O-321. ' "(11) Cfr. A. SerccreNr, Solidaietà, preuidenza, cit., pa§. fiZ e A. Grohmann, C/rà
e territoio-cit.,p^C. 10l, che !,ota,per Perugia "a partire dalla metà del secolo XV»>,
ouna.prolifl. erazione deg,li ospedali dille corpòrazionir, quali quelli relativi alle arti deicalzolai, dei fabbri, del Macello, dei Maestri di pGtra- e legname, dei notai e deglispeziali mentre per l'avanti comparivano solo queili delle artì del cambio, della Me"r-canzia e della Lana.
248
:r;c\.-ero. se non ancora luogo di cura per infermi, sono però da
.sciudersi quelle istituzioni cittadine che, come I'ospedale di San-
t Arrronio. vicrno a17a Porta a Faenza, del più volte nominato San
Sebastiano degli Ammorbati, sul <<Prato della giustizia>> e, infine,
ma siamo già ormai ai primi del X\{ secolo, della SS.ma Trinità,verso la porta a San Gallo, funzionavano semplicemente come luo"go di raicolta di infermi affetti da malattie repellenti o/e per lequali si temeva un'origine contagiosa come il <<fuoco di Sant'Anto-,ror, lu peste e, più iardi, la sifilide (32). È, in questa volontà diriunione e di separazione insieme dei malati dai sani, specie degli
eppestati e dei sifilitici (le due ultime malattie pre le quali, inoidirr. di tempo, si era assunta una coscienza collettiva) che viene
consratata la prima affermazione di un sisterna sanitario pubblico,;he si svilupperà più concretamente nel secolo successivo (J-l)'
Diversamente, la segregazione e l'allontanamento dei lebbrosi,
dapprima nellazzarctto di Sant'Eusebio, sorto nel 1186, sulla viachè-andava aPrato, e poi con l'ingrandirsi della città, rasferito dilà dal Mugnone al «Campoluccio>>, risponde a complesse motiva-
zioni storiche e psicologiche che, scomparsa quali la lebbra, già nel
X\r, X\T secolo, riaffioreranno a carico di altre malattie(34).
(?2) Per le malattie nominate, peste, sifilide, lebbra, ofuoco dì Sant'Antonio»,come volgarmente si chiamava l'ergotismo si veda IVLS. Mtzzt, _Salute e società nellledioeuol Firenze 1978, pp. 41-78. Per gli ospedali nominati oltre a L. PassrmNr,
Stona degli stabilirnenti di beneficenza, cit', Pp. 133 e segg., Pp.203 e segg. eyP.296 e
,.gs. ,r,àh. G. BrzzannrNr, Gli ospedali di Firenze crt., YI/2 (l%7) pp. 39-46, che
loZldr,jr^ quello di San Sebastiano-degli ammorbati nella sede dell'ex convento ora
,.o-p^rro d.[e monache di MontedoÀini e quello de]la ss.ma Trinità verso la fine di.ra Sàn Gallo nei locali degli ospedali di San Rocco e di S. Caterina dei Talani, M.S.
\L,zzt, La peste a Firenze iet'sbl, cit., pag. 1i1, riporta alla nota n.74la notizia del
passaggio àel'edificio dell'ospedale di San Sebastiano che- sorgeva. fuori della porta
àel1a"éiustizia alle medesime-monache di Montedomini e Monticelli che ne fecero illoro convento.
)1r SulJ'argomento in generale si veda, CÀ4. Crpone, Conlto an nemico in-
ttstbile. Epidemle e struttureianitarie nell'ltalia del Rinascimento, Bo_logna 1986, spe-
cìalmente-alle pagne7,27 e per Firenze in particolare, M.S.,Mezzr, La peste a Firenze
'tei '4A0, n Stiutiure familiaii, epidemie, migrazioni, a cura di R Cor'raa, G. PrccrNNr,
G. hrro, Napoli 1984, pP. 91-115.(14) Per Ll^rr^r.tto iiorentino e le sue vicende storiche, si veda-E. Gnosso, 1/
ieobrosario medieuale fiorentino di S. Eusebio, Firenze 1979. Pet la malattia della leb-
bra. oltre a1le indicaziàni di M.S. Mazzr , Salute e società, cit., pp. 52'59, si veda anche
T. Acrumr - C. Cuscrau\ Malato, medico e ruedicine nel Medioeuo, Torino 1981, pp.
1.{-1g. Per la fo11ia che va a sostiruire la r,paura secolare,, del1a lebbra, che si esprime in,reazioni tendenti alla separazione, all'esclusione, alla purificazione>>, si legga M. Fo-ctct-r, Storia della follìa, Milano 1980, pp. 29'31.
249
Parallelamente all'assistenza osped altera, ci pare opportunonotare, in ultimo, molto brevemente, come la città offrisse ai suoipoveri l'aiuto di compagnie laiche, alcune delle quali nate da unaprofonda ispirazione religiosa, come era il caso di quella dei capi-tani del Bigallo e di quella della Misericordia, entrambe della primametà del XIII secolo. Declinata ormai dalla fine del '100 la tene-merita attività di un'alta antica e illusrre compagnia, quella deicapitani di orsamichele, era sorta in città nei primi deienni del'400,|a Compagnia dei Buonomini di San Martino, rivolta singolar-mente ai <<poveri vergognosi>> (35). Tuttavia, ad eccezione di quelladel Bigallo, che sovrintendeva anche ad alcuni ospedali della città edel contado, le altre compagnie nominate, le più importanti manon le uniche in ambito urbano, si limitavano, ohre a quella eserci-tata nell'a sede della compagnia, ad un'assist enza a domicilio deimalati poveri sotto forma di aiuti in denaro e in natura.
L'assistenza al malato in senso terapeutico, nei limiti consentitidal progresso della scienza medica è dunque già all'epoca unacaratteristica essenzialmente ospedaliera.
In conclusione, nel bassomedioevo Firenze opera gradatamen-te una specializzazione assistenziale, che si concrerizza nell'allegge-rimento dell'attività caitativa dei suoi ospedali, creando nuoveistituzioni, dedicate unicamente al recupero sociale dei suoi assisti-ti, una volta gravanti sui medesimi enti ospedalieri. Rientrano nelnuovo quadro assistenziale olue ai luoghi dedicati alle vedove e aiffovatelli, come si è già notato, anche come ci pare, le nuove com-pagnie laiche il cui numero cresce singolarmente nel corso delmedesimo XV secolo. Agli ospedali rimane ruttavia affidata ancora
(15) Per le con{raternite_in generale e per quelle fiorentine qui nominate in par-ticolare, rimandiamo a G.M. Moùrr, Le confratemite medieaali artrotto
" iiiio tàt*,
voll. 2, Firenze 1927, r, pp. 149 e segg. Firenze avrebbe contato u à.r,, d.iiu,rro..circa 75. confraternite ai primi del XVI secolo. singolarmente rimandiamo alle mono-gratie di P.. L-aNorNr, Istoria dell'oratorio di s. Maria det Bigallo e della uenerabilecortpagnia della Miserrcordia della città di Firenze, Firen2e tlig, ai s. La Sonsa, lagonpagnia d'or san Mìchele oouero ufla pagina delia beneficenza toscana,Trari 1902, allavoro di A. Snrccraur, The «poue.ri ueigoinosi, in fifteenth-cinturl itiriii. ii" iirrtyear's actioity of the Buonomini di s. Martitto, n Aspects of pouirty in early *o1rruEurope, Firenze 1981, pp. 119-lB2 e a La Misericordia di'Firenze'attrauers'o i secoli,note stoiche a cura di c. Tonnrcr[r, M. Lorrs prcNe, M. DaNrr, o. cHrccHuccr,Fienze 1975,
250
'-:ra larga fetta dell'emarginazione cittadina difficilmente penemabi-
.c ar medesimj contemPoranei.
t';rietà degli iruteruenti assistenziali di tipo ospedaliero rtella Firenze
irittrocentesca
Deile varie istituzioni di origine più o meno antica, che siamo
r-enuti srn qui enumerando, solo poche avevano raggiunto o conser-
ra\ aro nel Quattrocento una personalità, per così dire, «ospedalie-
ra,. legata se non ancota totalmente a1la cura degli ammalati, certa-
rnenre ai mezzi economici, ai locali, al numero dei letti a dis-
ros:zione, ^17a
prcstazione, talvolta saltuatia, dell'opera dei medici
--,:re a quella di un personale fisso laico o religioso'
-l,d una vasta proliferazione di organismi paraospedalieri, la
Firenze del XV secolo opponeva, infatti, non più di quattto impor-:alli istituzioni, che si diversificavano nuovamente tra loro per laqu'alità e i mezzi profusi nell'attività assistenziale. Dopo quello di§anta Nlaria Nuova, che occupava una posizione di notevole premi-
:renza. seguivano nell'ordine I'ospedale di Bonifazio, alla pari quel-
lo di San Matteo e, infine, quello di San Paolo. Gli ospedali diSanta Maria della Scala e di San Gallo, ormai prossimi, tral'altro,alia riunione con quello di Santa Maria degli Innocenti, portavano
ar-anri, tnfattt, un'attività ormai quasi unicamente diretta alTa cuta
dei bambini abbandonari 06).
,.16r Tale situazione di un ridotto numero di istituzioni con intenti terapeutici,
rì:Eosro ad una cospicua plesenza di ricoveri di diverso tipo appare atrche.nella rap-
:iesenrazione che di FireÀze fa I ftate Monteolivetano Stefano Bonsignori nel 1584
;re scrive nell,a legenda della cana da lui compilata: <<oltre li soprascritti luoghi notati si
::Lara demro alla"citta ventidue spedali de'quali cinque ne sono deputati alli infermi,-::ie a putti e putte abbandonati e dodici per li poveri et peregrini» I cinque
=.iC"I desrinati àgI.i infermi compaiono tutti tfa i «luoghi notabili» nume_rati e de-
=----:-.i dove però SÀta Maria Nuova e San Matteo, sedi anche di conveqti femminfi,
-r=trarono. ìe1la scelta della dizione che ne fa il frate come monasteri. E importante:c:re ruÉavia come si 6atti proprio dei medesimi quat6o ospedali da noi notati comej orientao nel XV secolo
-verìo Ia cura degli infermi, cui il frate aggiunge, data
- .=o.r. quello degli incurabili, destinato ai sifilitici, verso la fine del1a via San Gallo
=.::,.. nàn .ornpà'r. quello di San Sebastiano degli ammorbati g_ià spostaro nei pressi
:.-': Dona della Giustizia a17a zona di San Marco Vecchio. A11o stesso modo non
..:-:aie piti neppure 1'ospedale di san Gallo già abbattuto dai tempi dell'assedio e
*..'lo d.ilu Sciu (già uri..ro agli Innocenti dal 1536) è ormai il monastero di S.
25t
Tra le istituzioni, che abbiamo definito a carattere <<ospedalie-ro>>, quella di San Paolo, sulTa piazza di Santa Maria Novella eracerto la più screditata, trovandosi dai primi del XV secolo in unasituazione di grave disordine (37). Da rempo si era determinara,infatti, un'involuzione delle sue funzioni assistenziali, regredite alpunto da farc di quello che era stato uno dei più illusmi ospedalicittadini, precedente come origine a quello di Santa Maria Nrro,o",il ricettacolo di mendicanti, che paiono affollare particolarmentequesta parte della città. Rifugio di derelitti, che compensano conparte del loro <<acatto>> l'ospitalità ricevuta, l'ospedale trae qualcherisorsa dall'affitto di case di sua proprietà, date a pigione , porr.."gente, tra cui molte vedove e forestieri, per lo scarso valore degliimmobili, come dimostrano le poche lire annuali p^gate per l,affit-to ma, probabilmente, anche per la regola, propria alle istituzionirette da religiosi, renure a soddisfare le richieste di alloggio deimeno abbienti. Singolare anche lo smercio di vino, a mezzi banliper volta effettuato dai pinzocheri di san Paolo ai poveri abitantinel <<Garofano>>, ossia la stada immediatamente al.le spalle dell,o-spedale, dove abitano molti dei pigionali deil'istituzione, acquirentiessi stessi (38). Nonostante la tutela dell'Arte dei Giudici e deiNotai, esercitata sull'ospedale a partire dal 1403, nel secolo succes-
Martino. Nella carta della catena del 1470 san Gallo (già riunito agli Innocenti dal1463) e Santa Maria della. scala compaiono ancora. per-rutto questo"si veda, Firenzen.elle t,edute e piante- studio storico topografico cartografico di a. Moo . G. Éo".rro,ristampa anastatica, Roma 197), pp. l2-ir e 40-46. §uf'ospedale di san Gallo, sul suo«declino economico>> e la
"perdiia di identità» che lo portiranno ^1t"
rir"iàì_É .o" lliInnocenti cfr. -G. PrNro, La Toscana nel Tardo Mediieuo, tOS2, pp. 24i1.
. (37). Per_l'ospedale di san Paolo e le notizie storiche che l.o^àncernono, riman-diamo oltre che a L. PassrnrNr, stoia degli stabilinenti di beneficenza,.ri"li. rel .s_egg. a_q.q.MEenssruaN, Dossier de l'ordre de h penitence, cit., a M.A. Mi**urrr,Lbspedale di san Paolo dei conualescenti, cit., e a R. DavrosonN,'stora di Finze cit.,\fII, pp. 85-86.
. (34;, !e1 gu.an1o riguarda I'attività di san Paolo e le sue risorse economiche, cisiamo valsi dei dati scaturiti da _un'indagine wolta sui manoscritti presenti nel fondoa-ttinente all'ospedale. In particolare sonò stati esaminati n. 8 libri
-di Entrata e (Jscita
del 1409 al 1413, depositati presso l'fuchivio di Stato di Firenze, nel fondo denomina-to dell ospedale di san Paòlo dei convalescenti. per le vendite di vino "i por.ri,rimandiamo in pa.rticolare.al Bastardello (1412) 4, c. 17, dove per esempio leggiamo«dalia Giovanna del Garofzno, che- crolla il capo, soldi diciasseti. p.. -à- u7il. aivino>> e ancora a c. 19. «Da uno fiammingo àel Garofano, soldi quindici per mezzobarile di vino».
252
sr-o verrà ridotto a convalesc enzaflo per i malati dimessi da santa
\Iana Nuor.a.un,insolita vivacità nell'attività svolta a favorc dei malati e
degli indigenti è invece, in quest'epoc9,la peculiarità- dell'ospedale
Jbo,rifuTioOg). Tale convinzioÀe la si deduce oltre che dalla
consratazione di un considerevole movimento degli addetti alla
.*, a.u, casa e degli infermi, più che altro dalla presenza nei ruoli
d.1 p.rrorule di alàeno due medici, un <<cerusico)> e un <<fisico>>,
.h" ,i alternano nel1a cura dei malati. Senza contare che in tempo
di crisi epidemica, l'ospedale ardva a stipendiare anche quattro
medici tra .,cerusici»>, <<fisici>> e specialisti, di cui uno sempre pre-
sente (40). Neppure I'ospedale di Bonifazio saprà evitare, tuttavia,
,r* piogr"tri#d..rd"nza, che 1o porterà nei secoli successivi' ad
,.rotu.rJ funzioni di semplice ricovero per invalidi, e, infine, di
reclusorio Per malati di mente.
L,abbàndanza e la qualità delle fonti molti ci documentano.anche sull,attività svolta nel XV secolo dall'ospedale di san Matteo,
che se, come pare, non si discosta molto dal punto di vista terapeu-
ir.o du qrr.[, di Éonrfazio, è però, al pari e diversamente da quella
d-i San Pìolo, segnata da carattetstiche tali da dlffercnziarla netta-
mente nell,ambiio assistenziale ospedaliero cittadino. Tra i suoi
meriti, anzitttto,la sistemazione degli infermi in letti separad. sin-
golare la sua opera a favore dei forestieri e degli sffanieri, dimoran-
Ii o ai prrrrggio in città e il sollievo diretto a categorie di ematgina-
ri che, .o-!"i servi e gli schiavi, paiono più di altre escluse dal
consorzio caritativo cittàdino (41). San Matteo, tra l'altro, sarà 1'u-
(lg) Per 1e vicende storiche dell'ospedale di Bonifazio, si vedaancora L' Pessr'm-
sr. S,iorio-arsii ttrbit*rnti-ii iri,fl,,iza, cit', pp' 2L6 e segs' e G' BrzzenmNi' G/i.,spedali di FTrenze cir.' W2 (l%lt. pag' 116 . . ."-'
i+ol Tali notizie p.or.ngorro Julo ipog[o-dei dati ffatti dai manoscritti dell'ospe-
aA. a.oorirmi presso I'Arcliivio di Staio -di Fir.nr.. ln
-particolare,,sono stati visti
,t"- tjUri di Ricordanze ma più che altro di Debitori e Creditori nell'arco dl temPo
-',"'Dr.*',."-a tctl " t 1470 citca. Dal libro di Debitoti e creditoti \1416'1417) 190'
.. S§ ,.r" prgaii gli stipendi a quattro. medici, due fisici, un cerusico e a <<maestro
it.hnto d.ù'oIru, iredicì:o", più 1o x al barbiere.""',jìr p.t r.;";;;;;1"rir;-alIosp.dul" di San Matteo rimandiamo ai già più volte
cr:a,i. i. Éoirrnr*r, Storia àegli stabilimenti di beneficenza, cit'' pp -!f e-segg a G'
ii;;;r;;-eToipiaoti di Fi,,nz, cit.,Yr/2-r.1e37-\'.pp'-.)e a6 e M4 MANNELLI'
: "oiart, 'di
San 'Matteo in iirriz,, ot)spedali..d'Ita[ì-Chirurgia"' XV6 (dicembre
:;^-r'-"" jlO-,llZ. Per le notizie rull'"niuità su.ll'ospedale. cfr. L. SeNonr, Sttan-ieri e
:.)-.,,iri"rrrtii É;rrnriarl-goourocento attrauerso i tibri di Ricordi e di Entrata e Usata
253
nica delle istituzioni considerate, a patte quella di Santa MariaNuova, a mantenere nel tempo, seppure notevolmente ridotta, lasua funzione di assistenza agh, infermi e a non assumere quellaesclusiva di ricovero per i poveri. La vasta proprietà immobiliàre incittà e nel contado tova ragione di continua prosperità nella bene-volenza ecclesiastica, pontificia in particolare, che lo distingue, négli manca, alpaù di Santa Maria Nuova e di Bonifazio, l,appoggiodell'autorità laica sino alla sua soppressione awenuta .r.i XVt[secolo.
Del tutto straordinaria, se confrontata a quella degli ospedaliesaminati, appare l'ascesa di Santa Maria Nuova. Sorto sul finiredel XIII secolo, con appena diciassette letti a disposizione, necontava circa un centinaio già nella prima metà del Trecento e,forse, oltre duecento alla fine del Quattrocento (42). La fortunadell'ospedale, tuttavia, sta probabilmenre nelle vicende del medesi-mo patronato, Attibuito alla famiglia fondatrice dei Portinari sinoa turto I 1617 , allorché fu definitivamenre affidato al governo gran-ducale, il suo esercizio era stato già esautorato a partire dal t352,dal privilegio dell'elezione dello spedalingo, a{tidata dapprima alvescovo e poi, con l'awento del governo mediceo, al medesimoCosimo I (43). Il credito riscosso da Santa Maria Nuova in campoassistenziale, ci sembra dunque dovuto in gran parte a questo auto-revole conmollo finanziaio esercitato nei secoli, sia dal lato eccle-
degli ospedali attadini tn stranieri e forestiei teÌle attà basso-medieoali, "euaderni distoria urbana e rurale", Firenze 1988.
(42) Per santa Maria Nuova, si veda L. PassrmNr, stabilinenti di benef,icenza,git., pp 2.84 e segg. e G. PauparoNr, Lo sped-ale di s. Maria Nuoua e la costruzione d.e'l
beeiatg di Bernardo Buontalenti, cit., La questione del numero di letti a disposizione diSanta Maria Nuova è controversa p_er via àella confusione fatta dagli stoticitra numeroeffettivo dei letti e. quantità_ di infermi che potevano prenderci'posto. Lo stesso L.PessrnrNr, stonla degli stabrlimenti di bene/ìienza, cit., ip 301-302 accenna al prob-Iema della inrerpretazione delle fonti che danno per la fine del '400 ora 600, o.à 100ricoverati a seconda che si stesse attraversando uÀ periodo di crisi epidemica o meno.Nel 1147 in tempo di carestia pare accogliesse già à1lora circa220 malati. Nel 1524, il,Passerini dà per certo che esistessero 150 letti destinati agli uomini e g0 per le donne,opinando che per via deÌl'usanza- di pore due ammalati per letto, L'ospedal. potesseaccogliere allora, come alla fine del XV secolo, intorno ail50 assistiti. Sur'argàmentosi veda anche G. PerraparoNr, Lo spedale di s. Maria Nuoua e la costruzione dei loggiatodi Bernardo Buontalenti, cit., pag. iz, . G.B. RavBNNr, I libri dei morti delr'ospeille diSanta Mart)a Nuoua di Firenzà còme fonti per lo studio d.ella nobilt)tà durante ie ursi disussistenza, in La popolazione italiana nel Settecento, Bologna 19g0, pp. 51I-527.
(43) C[t. G. Peuperoxr, Lo spedale di Santa MariaNuoua,.it., pag. pp. 7-g.
254
'14
\a
lain
ré
.o
II
1i
a
t-
:)
1
))
siastico che da quello laico. Furono senz'altro queste le premesse di'::a solida base patimoniale che certo ebbe una parte di primo:iano nello svolgimento stesso della sua funzione assistenziale che,se non poté esentarsi da quella sovrapposizione di ruoli, cui abbia-rxìo spesso accennato) sicuramente si orientò prima e con maggiorgaranzie verso l'attività terapeutica(44). Grazie a questa prosperasiruazione economica, Santa Maria Nuova poté sempre assicurarsil'opera dei migliori medici e impiantare ben presro scuole medicheal suo interno a partire già dal7a fine del XV secolo (45).
Diversamente dalle città del Centro-nord, che ricorsero, per lopiù a partire dalla seconda metà del '400, alla formazione di <<ospe-
dalt magni>>, mediante la riunione in un unico organismo, talvoltatbndato ex nouo, dei beni dei piccoli ospedali ormai decaduti,Firenze assiste al naturale perpetuarsi ed ingrandirsi di Santa Maria\uova. Le riunioni, operate, in genere, per o'uwiare alle mal-rersazioni degli amministratori, non hanno dunque nessuna partenell'evoluzione del grande ospedale fiorentino e, tranne quelle vo-lute dal duca Cosimo I, a partire dal1537 e relative agli ospedali diPistoia, Pisa e Livorno, si dovrà attendere il XVIII secolo e lesoppressioni leopoldine per veder aggregare a Santa Maria Nuovaalcuni degli ospedali della città (46).
La caratteristica dell'assistenza ospedaliera fiorentina nel XVsecolo è dunque quella di un «ospedale grande>>, definito da uncospicuo numero di letti, due, forse tre centinaia, da gtandi corsieseparate a letti fronteggianti per gli uomini e per le donne, da unaampia disponibilità di locali, che in Santa Maria Nuova awiene persuccessivi ingrandimenti, sino al,a reakzzazione dell'impianto a cro-ciera ne1I'ultimo quarto del XVI secolo ma, principalmente dalla
rl.1) SulÌa modesta attività terapeutica degli ospedali deltempo silegga, I. Neso,),ltiiri e stluttilrc sanitarie nella società tardo-medieoale. Il Piemonte dei secoli XIV e
-,,-,'. -\Iilano 1.982, pp. I7-D.,i5r A ptoposito dei medici illusri al servizio di Santa Maria Nuova, G. Parrrpa-
:c,rr. lo speddle di Santa Maria Nuoaa, cit., pag. 1 e M.A. MenNrrLr, Tommaso:.;i:lsi. litotomo nella sarcla di chiruryia dell'osped.ale di S. Maria Nuooa in Firenze,
"Ospedali d'Italia Chirurgia», XII 5-6 (maggio-giugno 1965), pp. 64I-645, oltre al più
=9. 16 Clr. per le annessioni a Santa Maria Nuova, L. PasspnrNr, Storia degli stabili--:t:: ;i beneft)cenza, cit., pp. 304 e segg.
255
compresenza in area urbana di altre irnportanti, seppure minori,istituzioni (47). A quest'ultime è affidata un'attività di affiancamen-to a quella preminente di Santa Maria Nuova.
In breve, I'idea è che i fiorentini avessero operato nel corsodel XV secolo, una sorta di specializzazione assistenziale nell'ambi-to di un quadro istituzionale di tipo uadizionale (48). Se tutte leistituzioni ospedaliere, infatti, sono impegnate nelle varie forme diassistenza ai poveri è senz'alro agli ospedali minori che la cittàrimette maggiormente il sollievo dei diseredati. Senza la messa a
punto di un preciso programma assistenziale, tale aiuto si articolainfine, per le diverse possibfità economiche degli enti in questionee per il differente ambito urbano in cui è esercitato, in modo quasicomplementare. Se Santa Maria Nuova, infatti, come scaturisce dauna nostra precedente ricerca, svolta sui Libri dei morti dell'ospe-dale della fine del XV secolo, dà sollievo alla folla dei comitatini, lealtre istituzioni sono tndirizzate in rnodo più manifesto alla curadella composita povertà cittadina. Mentre l'ospedale di San Paolorivolge la sua attenzione al ricovero dei mendicanti, come permette,forse, la precarietà del suo patrimonio, quello di San Matteo real-izza, oltre al non facile aiuto agli stranieri, il ricovero dei servi edegli schiavi.
(47) Per la pianta ospedaliera, accresciuta e modificata nei secoli, rimandiamooltre che a G. Peuperom, Lo spedale di S. Maia Naoua, cit., A. Scorrr, Malati estrutture ospedaliere, cit., pag. 238.
(48) Col XVI secolo la situazione, quale abbiamo descritta per il XV secolo,vaderà notevolmente, awiandosi in modo deciso ad una nuova <<sistemazione»> deipoveri. Rifacendoci alla solita didascalia compilata dal Bonsignori per la carta da luiredatta alla fine del XVI secolo (supra, n. 16) non si può fare a meno di notare infatti,come tra i ventidue ospedali da lui indicati, oltre ai cinque destinati agli infermi, cui siè già accennato, cinque siano aperti ai fanciulli e fanciulle abbandonati e ben dodici ai«poveri et peregrini»>. Se il cresciuto numero (rispetto al XV secolo) degli ospedaliriservati «a' putti e putte)>, è il risultato di una ulteriore special)zzazione dell'assistenzaalla rnfanzia, che è attenta, ora, al sesso, la dichiarazione delÌa destinazione degli altridodici ospedali ai soli «poveri et peregrini», oltre a farci intendere l'espansione senzaprecedenti della mendicità e dell'emarginazione in genere, ci paria dell'awenuto cam-biamento della mentalità in materia assistenziale. Ora, infatti esistono ospedali (sepp-ure nella pratica tale distinzione tarderà a divenire netta) per infermi e per i poveri. Sieta dunque arrivati a quel primo stadio di <<speciallrzazione assistenziale la cui neces-sità era stata aweftita dalle menti più illuminate già nel Quatuocento, primo fra tutti ilvescovo fiotentino Antonio Pierczzi, cfr. a questo proposito, B. Grneurr, ll paaperi-smo nell'età preindustriale (secoli XIV-XW), n Storia d'ltalia, Documenti 5, Torinot973, pp. 670-698. Per la cana del Bonsignori, cfr. G. Borrrto A. Monr, Piante euedute di Firenze, cit..pp. 40-46.
256
)r1)
:n-
:SO
bi-1e
dirrà
a
>7a
oe
isila
1e
ra1o
J-
e
o)
eiui:i,
siaiI:a
ri'a
I-)-
;ii-
11
;_
J
e
toe
-\ia l'anenzione, attraverso le fonti ospedaliere, all'emargina--:::: rissuta dai fiorentini del'400, ci rivela anche la poco appari-:;.:::i ma oltremodo pesante miseria femminile. Poco comprese:-="e loro necessità materiali, le donne soffrono infatti un abbando-- r .re ci sorprende. Nei loro confronti l'assistenza ospedaliera si:--.'.rsitica ulteriormente. L'ospedale di Santa Maria Nuova, avvia-
: - . come sembra, alfa cura di mali tipicamente femminili si dedica:- - Gi 'a-ltri alle donne maritate, alle vedove, alle nubili, a coloro le;:rl'cioè non offendono con la loro presenza il.,decoro>> del--.io Schiave e serve competono maggiormente, come si è visto,,"' :.!edale di San Matteo. L'emarginazione maschile, da partes-'-. =e:o pressante di quella femminile, include tuttavia categorie
':'i «luove» allo spettacolo della miseria cittadina: dai lavoratori:=".ec ljzia, agli atigiani del ramo ressile, che con la loro maggiore::=:--.rza aggiungono nuovamente dignità all'ospedale di Santa,*"1::..-: -\uova.
I a realtà assistenziale della Firenze quattrocentesca esprime,-:::.. im notevole disagio economico e psicologico, che si riflette-.- :::ocio della distinzione degli interventi ospedalieri, separati sec-::ic i diversi gradi dell'emarginazione degli utenti. È in quest,epo-:r . Der questo motivo che nasce e si alimenta la connotazione;e.-'ospedale, quale luogo malfamato, aperto ad ogni corruzione ad3--rlenrare la vergogna di chi è costretto a rivolgersi alle sue .,rr". È::r quesro clima che maturerà Ia necessità di una separazione del-,'a:tiutà propriamente terapeutica da quella di semplice ricovero,sr:lo a dare all'ospedale la configurazione di luogo di cura dei soli::;ermi.
251