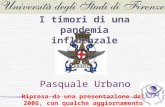Una Crocifissione con il ritratto di Napoleone Orsini per una confraternita di Assisi
26 giugno '44. Archeologia di una ricostruzione, in Entità di una distruzione, Identità di una...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of 26 giugno '44. Archeologia di una ricostruzione, in Entità di una distruzione, Identità di una...
Collana “Conoscere Palestrina”XI
ENTITÀ DI UNA DISTRUZIONEIDENTITÀ DI UNA RICOSTRUZIONE
LA PARROCCHIADELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA
NEL RIONE DEGLI SCACCIATI
Atti del Convegno di StudiPalestrina
Chiesa della Santissima Annunziata25 Aprile 2012
A cura di ANDREA FIASCO - ROBERTA IACONO
26 GIUGNO ’44ARCHEOLOGIA DI UNA RICOSTRUZIONE
Andrea Fiasco
Museo Diocesano Prenestino di Arte Sacra
Andrea Fiasco
106
Il 4 giugno del 1944 le prime formazioni militari alleate feceroingresso in città, sancendo così, per Palestrina, la fine dell’occupa-zione nazifascista. Con quel giorno si chiuse uno dei capitoli più tra-gici della storia contemporanea del paese e prese avvio,ufficialmente, una fase di transizione postbellica, nella quale gettaresolide basi per la ricostruzione del paese.
La città era stata colpita, a partire dal gennaio del 1944 (vedi ilsaggio di Albino Lucarelli), da un intenso e continuo bombarda-mento aereo1, che aveva danneggiato enormemente l’area urbana,costringendo la popolazione a trovare rifugio nelle zone periferichedi campagna, dove la maggior parte delle famiglie prenestine posse-deva un casolare o un appezzamento di terra.
L’area urbana2 risultò profondamente colpita (Tav. I). Tuttol’abitato impostato lungo l’asse via Anicia-corso Pierluigi risultòestremamente compromesso, con danni irreparabili al ComplessoConventuale di Santa Maria degli Angeli e al Palazzetto Baronale alCorso della famiglia Barberini. I danni interessarono anche la fac-ciata della Cattedrale, con lesioni alla Loggia delle Benedizioni, allazona retrostante la chiesa e al vicino Seminario Vescovile3. Il quar-tiere del Borgo e il quartiere dello Sprecato furono praticamente rasial suolo. I danni coinvolsero anche la residenza cittadina più presti-giosa, l’antico Palazzo Colonna-Barberini. Raso al suolo il PalazzoVeccia Scavalli Borgia, di cui oggi resta solo il portone d’ingresso difronte la chiesa di Santa Rosalia. Anche il quartiere degli Scacciatinon fu risparmiato dalle bombe aeree.
Fu atterrato tutto il quadrante occidentale del rione, gravitanteintorno alla chiesa della SS.ma Annunziata, già colpita il 22 gennaio4
e andata distrutta irreparabilmente il primo giugno 1944. La detta-gliata relazione preparata nel marzo del 19455, insieme con la tavolagrafica allegata, mostrano l’entità dei danni su tutta l’area urbana.Centosessantamila metri cubi di edifici andati completamente di-strutti, circa centoventimila quelli compromessi, tali da dover essereabbattuti, senza contare orti, cortili e le altre aree all’aperto rimastedanneggiate. Risultò quindi, in termini abitativi, un danno com-plessivo pari a circa duemilacinquecento vani distrutti. Circa l’80-85% della superficie urbanizzata della città era rimastaprofondamente lesionata, la maggior parte addirittura irreparabil-mente6.
In questa situazione di enorme distruzione fu avviata tempesti-vamente una procedura di intervento da parte degli organi statali.
1 Questo argomento è stato trattato daA. LUCARELLI nel suo volume Architet-tura della rinascita: l’UNRRA. Il caso Pa-lestrina (Palestrina, 2007, pp. 105-112). 2 Per area urbana si intende tuttol’abitato compreso all’interno delperimetro tracciato dalle fortificazioniantiche, che nell’antichità avevano ilcompito di circoscrivere anche lo spaziodell’urbs cittadina, l’area sottoposta aristretti vincoli di natura giuridico-sacrale. 3 Venne completamente distrutto ilvano posto alle spalle della cappella delSantissimo Sacramento, che a queltempo era occupato dal locale museodall’Associazione Archeologica Prene-stina. Proprio per timore che fosse cen-trato dalle bombe alleate questoambiente era stato sgomberato dai ma-teriali archeologici che vi erano espostialla fine del ’43 dal Prof. Gullini. S. AU-RIGEMMA, F. FASOLO, G. GULLINI, Pale-strina - Scoperte e restauri nel complessotemplare della Fortuna Primigenia, inBollettino d’arte, IV, Ottobre - Dicem-bre, 1948, pp. 348-349; E. FERRACCI,Diario inedito. Cronaca di Palestrina dal25 luglio 1943 al 27 gennaio 1944, Co-mune di Palestrina, Assessorato allaCultura, Biblioteca Comunale “Fanto-niana”, Fondazione “Cesira Fiori”, Pa-lestrina, 1994, pp. 8-9.4 ANONIMO, Dalla cronaca del Conventodi San Francesco di Palestrina dei FratiMinori, Comune di Palestrina, Assesso-rato alla Cultura, Biblioteca Comunale“Fantoniana”, Fondazione “CesiraFiori”, Palestrina, 1994, p. 10. 5 La relazione e la tavola in allegato fu-rono redatte dagli architetti Vincenzo eFurio Fasolo, con la collaborazione del-l’arch. Corrado Quoiani. 6 LUCARELLI, 2007, pp. 105-112.
107
26 giugno ’44. Archeologia di una ricostruzione
Tav
. I -
Vinc
enzo
e Fu
rio F
asol
o. P
ales
trina
. Sch
izzo
pla
nim
etric
o (1
:100
0) d
ell’a
rea u
rban
a al t
erm
ine d
el co
nflit
to.
In n
ero
gli e
dific
i com
plet
amen
te d
istru
tti. I
n tra
ttegg
io q
uelli
dan
negg
iati.
Andrea Fiasco
108
Nel diario degli eventi di quei drammatici giorni è registrata unadata di estrema importanza: un lunedì di fine giugno, il 26, del 19447.
Quel giorno giunseroin città due giovani fun-zionari dell’allora RegiaSoprintendenza alle Anti-chità. Furio Fasolo (1915-1987) e Giorgio Gullini(1923-2004) quel giornocondussero il primo so-pralluogo ufficiale a quelloche restava ancora in piedidell’area urbana dellacittà. Erano stati inviati a
Palestrina dal loro superiore, il Soprintendente Salvatore Auri-gemma (Fig. 1). La ricognizione dell’area sortì subito, agli occhi deidue funzionari, un notevole impatto, non solo per lo stato di distru-zione in cui versava la città, ma anche per la nuova configurazioneche sembrava mostrare la zona alta, dominata oramai da un massic-cio prospetto di forma triangolare (Fig. 2), che dopo la rimozionedelle macerie si rivelò essere il sommo delle due monumentali rampeascendentali dell’antico complesso templare della dea Fortuna, ap-pena riscoperto: «[...] Quando il 26 giugno del 1944 compimmo ilprimo sopralluogo a Palestrina dopo il passaggio della guerra - scrisseFurio Fasolo - la parte superiore della fronte triangolare di quelle che siriveleranno poi come due monumentali rampe ascendenti, elemento com-pletamente nuovo, ancora incertamente affiorante dalle macerie, domi-nava il panorama dal basso di Palestrina e si imponeva ormaiall’attenzione [...]»8.
Fin da quel giorno e poi nei ripetuti sopralluoghi compiuti du-rante tutta l’estate i due studiosi si aggirarono per il paese, nel ten-tativo di capire l’entità delle distruzioni. Fasolo, che ricorda la città
colma di un mare di macerie, registrò, già fin dal primo giorno, attra-verso una serie di scatti fotografici (Figg. 3-8), il paesaggio spettraleche caratterizzava le aree più interne dell’abitato9.
Fig. 1 - Il Soprintendente alle Antichità dell’epoca Salvatore Aurigemma (1885-1964).
Fig. 2 - Grafico compositivo dei resti delle strutture del tempio affioranti dalle macerie messo a confronto con una fotografia dell’area.
7 Il giorno prima, il 25 giugno, si erasvolta una visita in forma privata allacittà da parte del Vescovo della DiocesiPrenestina, il Cardinal Carlo Salotti.ANONIMO, 1994, p. 21. 8 F. FASOLO, G. GULLINI, Il Santuariodella Fortuna Primigenia a Palestrina,Roma, 1953, p. 4. 9 F. FASOLO, Album Prenestino 1944-1956, Roma, 1956, p. 1 e tavole I-IV.
109
26 giugno ’44. Archeologia di una ricostruzione
Fig. 3 - Piazza della Cortina vista da nord. Fig. 4 - Via del Borgo vista da nord.
Fig. 5 - Piazza della Cortina vista dalla cavea del santuario. Fig. 6 - Piazza della Cortina vista dal basso.
Fig. 7 - Via del Borgo vista da ovest. Fig. 8 - Via del Borgo.
Andrea Fiasco
110
Questa forte presa di coscienza da parte dei due funzionari dellagrave situazione in cui versava la città risultò decisiva per le sorti delpaese, per la sua rinascita. La loro attività di ricognizione, di rilevamentoe di pronto intervento ful’inizio del recupero dell’areaurbana.
Furono loro a capirecon celerità l’importanzadelle strutture rimesse inluce dalle bombe nella zonadel Borgo e dello Sprecato.Gli edifici dei due quartieriinfatti erano stati completa-mente atterrati, facendoriaffiorare, quasi intatte, im-ponenti costruzioni, identificate subito dai due studiosi con il san-tuario della dea Fortuna. Venne così alla luce una straordinaria areaarcheologica a cielo aperto, coronata in cima dal Palazzo ColonnaBarberini, un cantiere di studio e di lavoro su cui Fasolo e Gullinisaranno attivi almeno fino al ’56, anno della solenne inaugurazione
dell’area alla presenza del Presi-dente della Repubblica Gronchi,legando così per sempre i loronomi alla storia delle scoperte ar-cheologiche della città10.
L’attività che Fasolo e Gulliniavviarono in quei mesi estivi del’44 fu richiedere un intervento ur-gente del Corpo Reale del GenioCivile per intraprendere la rimo-zione delle macerie (50.000 risul-teranno i metri cubi di detritirimossi nel solo perimetro del-l’area archeologica)11. Con i lorocontatti e grazie alla grande sensi-bilità del prof. Aurigemma, che ac-colse subito le richieste dei duefunzionari, si diede immediato ini-
zio, già sul finire del ’44, ad alcuni interventi di ripristino e consoli-damento statico12. A partire poi dalla primavera del 194513 si avviòlo scavo archeologico nella zona del Borgo e dello Sprecato, a partiredall’area oggi occupata dalla rampa sinistra del tempio, dove fin dasubito vennero alla luce i famosi capitelli dalle sagome inclinate (Fig.9)14. L’intervento in quei mesi fu sostenuto con grande sforzo eco-nomico e con l’impegno appassionato di Ranuccio Bianchi Bandi-nelli (Fig. 10), allora Direttore Generale del Ministero della PubblicaIstruzione, e attraverso l’opera politica del Sottosegretario alle BelleArti, Carlo Ludovico Ragghianti15 (Fig. 11). Il nuovo e inaspettatoscenario velocizzò il recupero e la ricostruzione di altri settori della
10 Si segnalano qui, per brevità, esclusi-vamente le pubblicazioni redatte du-rante il corso dei lavori. AURIGEMMA,FASOLO, GULLINI, 1948, pp. 346-354;FASOLO, GULLINI, 1953; FASOLO, 1956;F. FASOLO, Il Palazzo Colonna-Barberinied alcune note sul suo restauro, in Bollet-tino d’arte, XLI, I, Gennaio-Marzo,1956, pp. 73-80. 11 Le macerie su piazza della Cortinaammontavano a circa ottomila metricubi, nella zona di via del Borgo eranocirca diecimila. ADA-PA, Pratiche di tu-tela, 282/9, Doc. 09-06-1947. 12 Effettuati sul Seminario Vescovile. AU-RIGEMMA, FASOLO, GULLINI, 1948, p. 347.13 FASOLO, GULLINI, 1953, p. 5. 14 ADA-PA, Pratiche di tutela, 282/9,Doc. 09-06-1947.15 I due furono fondatori nel 1935 dellarivista La Critica d’Arte. Per una tratta-zione esauriente della figura di BianchiBandinelli e del suo operato si vedano isaggi di M. BARBANERA (Ranuccio Bian-chi Bandinelli. Biografia ed epistolario diun grande archeologo, Milano, 2003 eRanuccio Bianchi Bandinelli e il suomondo, Bari, 2000). Allo stesso modo su Carlo LudovicoRagghianti si veda la sintesi con ampiorepertorio bibliografico a cura di R.BRUNO (Ragghianti critico e politico, Mi-lano, 2004). Si veda anche il volumemonografico Studi su Carlo LudovicoRagghianti, edito in formato elettronico(Predella, rivista semestrale di arti vi-sive, n. 28, predella.arte.unipi.it).
Fig. 9 - I famosi capitelli dalle sagome inclinaterinvenuti nello scavo della rampa sinistra del
santuario.
Fig. 10 - Il Direttore Generale del Mi-nistero della Pubblica Amministra-zione Ranuccio Bianchi Bandinelli
(1900-1975).
111
26 giugno ’44. Archeologia di una ricostruzione
città. A tal proposito, contestual-mente, fu avvertita con urgenza lanecessità di dotare il Comune diun Piano Regolatore, tanto che il5 febbraio del 1945 vennero inca-ricati di redigerlo l’arch. VincenzoFasolo e l’ing. Luigi Piccinato16.La sfida che i due professionistiebbero il compito di portare a ter-mine, considerate anche le ina-spettate straordinarie scopertearcheologiche, fu quella di otte-nere dalla nuova pianificazioneurbanistica un’integrazione so-stenibile fra il vecchio nucleo abi-tato dell’area urbana, così come
era venuto a costituirsi a partire dal XV-XVI secolo, e le aree di in-teresse archeologico e monumentale, come ad esempio la neonatazona archeologica, i cui limiti, con lo scavo in corso, erano in con-tinua evoluzione. La scelta di affidare questo delicato intervento diriorganizzazione urbanistica alla mente e all’ingegno dell’arch. Vin-cenzo Fasolo (Fig. 12) non dovette risultare casuale: l’architetto17,
originario di Spalato, allievo diGustavo Giovannoni, era uno deimassimi esperti nel recupero enella riqualificazione urbanistica,esponente di primo piano di unalinea di pensiero che perseguival’obiettivo di trarre dagli “stili sto-rici” modelli adatti alla città con-temporanea, nel tentativo diaccendere un dialogo tra vecchioe nuovo, tra la trasformazione delcorpo storico della città e l’ediliziadelle nuove costruzioni e deinuovi quartieri18.
Docente di architettura al-l’Università La Sapienza di Romafin dal 1925, prima della guerracollaborò con l’Ufficio V del Co-
mune di Roma, che in quegli anni assumeva il nome di Governato-rato, attraverso un intensa attività di progettazione e realizzazione diedifici ad uso civile. Vincenzo Fasolo, negli anni in cui era impegnatosul fronte prenestino, ricevette anche l’incarico di architetto capodella Reverenda Fabbrica di San Pietro in Vaticano, ruolo che rico-prì dal 1948 al 1969. L’arrivo a Palestrina anche di Vincenzo Fasoloquindi permise a Furio, suo figlio, di operare a stretto giro con ilpadre, dando vita ad un connubio professionale che avrà nel voltodell’odierna città uno dei loro più importanti interventi congiunti. La
Fig. 11 - Il Sottosegretario alle BelleArti Carlo Ludovico Ragghianti
(1910-1987).
Fig. 12 - Vincenzo Fasolo (1885-1969).
16 B. CIALDEA, U. LULLI, Palestrina 1945.Ricostruzione, una difficile partenza, Co-mune di Palestrina, Assessorato allaCultura, Biblioteca Comunale “Fanto-niana”, Fondazione “Cesira Fiori”, Pa-lestrina, 1995, pp. 8-9.17 Su Vincenzo Fasolo si veda in gene-rale B. CREVATO-SELVAGGI, Vincenzo Fa-solo dalla Dalmazia a Roma. Vita e operedell’architetto spalatino, Catalogo dellamostra, Roma Musei di Villa Torlonia -Casina delle Civette, 7 Dicembre 2011 -26 Febbraio 2012, Roma, Venezia,2011; V. FASOLO, L’attività di VincenzoFasolo, ingegnere e architetto, in La Capi-tale a Roma. Città e arredo urbano.1870-1945, Catalogo della mostra (Car-dilli L., Cambedda Napoletano A. a curadi), Roma 2 Ottobre - 28 Novembre1991, Roma, 1991, pp. 96-99. 18 Per un inquadramento del linguaggioteorico e pratico dell’attività professio-nale di Fasolo si veda F. GIOVANNETTI,F. R. STABILE, Disegnare, osservare, pen-sare: il “primato del disegno”, in CRE-VATO-SELVAGGI, 2011, pp. 15-29; F.GIOVANNETTI, F. R. STABILE, VincenzoFasolo. Primato del disegno e dell’am-bientismo, in Bollettino dei Musei co-munali di Roma, 18, 2004, pp. 129-155;P. MARCONI, Torniamo a riconsiderare ladidattica della storia dell’architettura: Fa-solo, Benevolo e Zander la facevano megliodi noi, in Il restauro e l’architetto: teoriae pratica in due secoli di dibattito (Mar-coni P. a cura di), Venezia, 2002, pp.194-197.
Andrea Fiasco
112
prima redazione del nuovo Piano Regolatore venne approvata condelibera di consiglio nel dicembre del 194619, un anno dopo l’affi-damento dell’incarico.
Fasolo intervenne in questa prima fase (Tav. II) innanzitutto di-sciplinando le zone edificabili nell’area suburbana e stabilendo glispazi riservati a zone di ampliamento residenziale (tutto il settore
19 ASCP, RGN/1-6, Delibere di ConsiglioComunale 1946-1949, Verbale seduta del28-12-1946.
TAV. II - Vincenzo Fasolo, Luigi Piccinato. La redazione del primoPiano Regolatore della Città di Palestrina nel 1946.
Tav. III - Vincenzo Fasolo, Luigi Piccinato.L’aggiornamento del Piano Regolatore nel 1949.
113
26 giugno ’44. Archeologia di una ricostruzione
occidentale), una delle priorità visto che buona parte dell’area ur-bana era in procinto di essere espropriata a favore delle straordina-rie scoperte archeologiche che nel frattempo venivano alla luce. Sututto il settore occidentale, come visibile dalla tavola, Fasolo e Pic-cinato previdero il decentramento dell’attività edilizia, la qualeavrebbe potuto investire l’intera Valle Zampea, i declivi compresifra Colle Martino e l’antico tracciato della Prenestina-Pedemontanae tutta l’area a ridosso di Porta San Francesco. L’obiettivo era quellodi salvaguardare dalla cementificazione il cosiddetto Quadrilatero -la zona compresa fra l’attuale via degli Arcioni, viale Pio XII, via Pre-nestina Nuova e via della Martuccia - il cui notevole interesse ar-cheologico era assolutamente da preservare, come era già statoampiamente riconosciuto prima del conflitto20. A tal fine quindi siappose su tutta quest’area un vincolo indiretto con notifica, il qualesebbene giuridicamente non corrispondesse ad un divieto assolutodi inedificabilità, nelle intenzioni dei redattori avrebbe poi di fattocostituito questo indirizzo, visto che il rilascio ai privati di nullaostadi edificabilità sull’area veniva demandato esclusivamente alla So-printendenza alle Antichità e ai Monumenti21. Con una situazione incontinua e non prevedibile evoluzione risultò inevitabile un aggior-namento del Piano, che nel 1949 servì a disciplinare invece propriol’area urbana, all’interno della quale, come è visibile nella tavola (Tav.III), fu definito il perimetro dell’area archeologica sottoposta a vin-colo, le aree verdi o destinate a parco pubblico, l’apertura di nuovispazi ad uso della comunità e la nuova viabilità interna alle mura.
Il nuovo Piano Regolatore permise di organizzare la macchina diricostruzione, destinando ad un controllo mirato tutti gli interventieffettuati nell’area urbana, sia pubblici che privati, monitorati con-tinuamente dalla Soprintendenza alle Antichità e ai Monumenti.Questo avvenne principalmente inserendo in ruoli chiave alcunedelle personalità più competenti in tema di tutela e integrazione ur-banistica che all’epoca operavano sul territorio. Sedettero quindi,nella Commissione Edilizia Comunale, sia Furio Fasolo che GiorgioGullini, nonché l’ingegner Piccinato e il geometra Andreatta, rap-presentanti sul territorio del Corpo Reale del Genio Civile22.
Un ruolo di primissimo piano fu assolto in questo periodo pro-prio dal Corpo Reale del Genio Civile, che arrogò a sé il diritto diistruire e coordinare tutti gli interventi di sgombero delle macerie,demolizione, riparazione e ripristino di qualsiasi fabbricato andatodistrutto o danneggiato con il bombardamento, come sancì la cir-colare del 18 settembre del 1945: «[…] si ricorda che tutti i lavori re-lativi ai danni di guerra dovranno esclusivamente essere eseguiti daquesto Ufficio. Non è ammesso che il Comune realizzi i lavori, faccia ledovute perizie e poi chieda il rimborso a questo Ufficio. Il Comune puòsegnalare a questo Ufficio i danni di guerra da riparare, i quali sarannopoi presi in carica da questo Ufficio che si occuperà anche di affidare conle gare l’esecuzione […]»23. Per ottenere questo il Genio Civile isti-tuì nel marzo del 1947 il Comitato Riparazioni Edilizie24, a cui spet-tava il compito di stabilire le modalità e il programma generale di
20 L. QUILICI, Palestrina. Cronaca delladistruzione di una città antica, in La Pa-rola al Passato, CLXXXVI, 1979, pp.223-224.21 «[…] Sull’area vi è vietata qualsiasi co-struzione: può tuttavia permettersi la co-struzione di qualche eventuale edificio chenon turbi l’ambiente, sentito il parere dellaSoprintendenza alle Antichità e ai Monu-menti […]». Nel quadriennio 1954-1958 la Soprintendenza alle Antichità,guidata allora da Pietro Romanelli,strinse ancor di più le maglie del prov-vedimento, avviando l’apposizione diun piano di vincoli specifici nell’area, talida renderla per larghi tratti completa-mente inedificabile. Nonostante questo,a partire dagli anni ’60 e poi di seguitofino alla fine degli anni ’70 il connubiofra privati, Comune e Soprintendenzastessa condusse ugualmente ad unasconsiderata attività edilizia su quasitutta l’area, annullando così i tentativiintrapresi fino agli anni ’50 di proteg-gere tutto questo territorio a ridossodell’area urbana, così densamente riccadi testimonianze storico-archeologiche(QUILICI, 1979, p. 224 e ss.). Nel 1981,con il nuovo aggiornamento del PianoRegolatore, fu nuovamente ribadito ilnotevole interesse archeologico di que-st’area, assegnandole una destinazioned’uso addirittura a parco archeologico eauspicandone una generale ristruttura-zione e un intervento di valorizzazione,sebbene negli anni precedenti il paesag-gio storico dell’area fosse stato già enor-memente compromesso dall’attivitàedilizia dei privati, in larga parte di na-tura abusiva. 22 ASCP, RGN/1-6. Delibere di ConsiglioComunale 1946-1949, Verbale seduta del06-07-1946.23 ASCP, RGN/32-6. Corpo Reale GenioCivile, Doc. n. 1809/18-09-1945. 24 ASCP, RGN/32-6. Corpo Reale GenioCivile, Doc. n. 7919/20-03-1947.
Andrea Fiasco
114
ricostruzione. Il Comitato era coordinato dal comm. Umberto PieroButi, Capo zona del Genio Civile, dall’architetto Ferrero e dal geo-metra Andreatta. Il Ministero dei Lavori Pubblici con una circolare25
aveva sollecitato l’utilizzo delle imprese locali per effettuare i lavoridi riparazione, sgombero e ricostruzione.
Bisognava quindi che le imprese edili del luogo si iscrivessero esi accreditassero presso l’Elenco Regionale del Provveditorato alleOpere Pubbliche per il Lazio, in modo tale da poter partecipare allegare d’appalto pubblicate dal Genio Civile.
Il contributo del quartiere degli Scacciati al programma diricostruzione
Nella concitazione che caratterizzò il primo biennio dopo la finedel conflitto, nella dialettica che si instaurò fra i rappresentanti sulposto dei vari organi dello Stato e gli enti locali il ripristino dellepiene funzioni dell’autorità comunale segnò un momento di snodo.Il 25 aprile del 1946, ad un anno dalla fine ufficiale della guerra sulterritorio italiano, alle ore 17, nella casa comunale ancora ospitata al-l’interno dei locali del palazzo Fiorentini-Mencacci in piazza Gre-gorio Pantanelli, si riunì il primo consiglio comunale dalla fine delleostilità, composto da membri elettiliberamente e democraticamentedal popolo. Dopo alcuni governitransitori che videro l’avvicenda-mento di varie personalità locali co-ordinate dai commissari prefettizi -spiccano i nomi di Raffaele Galeassi,Basilio Cialdea, Umberto Lulli - lanuova giunta, eletta dalla popola-zione prenestina, a partire da questadata fu presieduta dal nuovo Sin-daco Licinio Bernardini.
Nella seduta del 25 aprile emersel’importanza detenuta in termini po-litici e di rappresentanza popolare daparte del rione degli Scacciati. Benquattro furono i consiglieri eletti re-sidenti in quel quartiere della città:Colanicchia Enrico, TagliacozzoAgapito, Consoli Orlando e Carpi-neta Francesco. Il verbale della se-duta, conservato presso l’ArchivioStorico del Comune di Palestrina26,ancora oggi manifesta l’impegno con-sistente da loro svolto per portare subito all’attenzione dell’assembleale urgenze che incombevano sul rione. Nell’agenda che l’assemblea esa-minò di primaria importanza risultò la proposta di istituire due scuoleelementari per supplire alle necessità della popolazione scolastica delquartiere e di edificare un lavatoio al servizio delle famiglie.
25 ASCP, RGN/32-6. Ministero dei La-vori Pubblici, Doc. n. 7861/23-08-1946.26 ASCP, RGN/1-6. Delibere di Consiglio1946-1949, Verbale seduta del 25-04-1946.
Fig. 13 - Il Consigliere ComunaleEnrico Colanicchia (1889-1953).
115
26 giugno ’44. Archeologia di una ricostruzione
Se queste iniziative furono orientate a offrire un’immediata ri-sposta alle problematiche quotidiane del rione le parole del consi-gliere Enrico Colanicchia (Fig. 13) invece mostrano con decisioneancora oggi quale fosse il pensiero politico della corrente “scaccia-tana”. L’intervento di Colanicchia risulta essere, ad un’analisiodierna, un vero e proprio manifesto politico della ricostruzione pre-nestina, ancora più interessante se si pensa alla storia personale delconsigliere, quello di un semplice ed umile agricoltore. Dopo unaparte iniziale del discorso che toccò gli aspetti più disastrosi che il re-gime fascista aveva provocato alla Nazione Colanicchia ricordò al-l’assemblea «[...] che si sono predisposti per Palestrina un PianoRegolatore ed un nuovo regolamento edilizio. È stata un’ottima cosa per-ché se dalla disgrazia che ci è toccata con la distruzione di mezzo paesesi potrà trarre il vantaggio di vederlo poco a poco risorgere più bello diprima e con migliori costruzioni e più razionalmente disposte questo saràtanto di guadagnato per tutti. Ora quello che ci sta dinanzi sarà senzadubbio un periodo di intense ricostruzioni, e da parte dei privati e daparte di enti pubblici. Quindi se non vogliamo immortalarci nella storiadel paese come un branco di somari è nostro strettissimo dovere vigilaresul modo su cui si ricostruisce. È necessario che il Piano Regolatore e il re-golamento siano rispettati ad ogni costo, e che le nuove costruzioni o lericostruzioni o i restauri siano fatti con un certo gusto e salvaguardandoil carattere della nostra città. Una brutta costruzione o una costruzionefuori dal suo posto deturpano tutta una strada o un panorama. E que-sto lo è poi per sempre [...]»
«[...] Sarà poi sommo interesse per Palestrina prendere e mantenerecontatti con il Ministero e con la Soprintendenza delle antichità, i qualistanno eseguendo, proprio nel cuore del paese, grandiose opere di scavo.Dobbiamo fare quanto è in noi perché questi lavori abbiano il massimosviluppo possibile. Monumenti archeologici di eccezionale importanzasono venuti alla luce e altri certamente ne saranno scoperti. Ciò potràfare di Palestrina un centro turistico di notevole importanza con van-taggio di ogni categoria di cittadini. È questa un’altra ottima ragioneperché il problema edilizio venga affrontato con discernimento e con in-telligenza, seguendo le direttive di tecnici sperimentati. Occorrerà ancheche il Comune si ponga in grado di fornire nel suburbio delle aree edifi-catorie a coloro che non potranno ricostruire la loro casa ove si trovavaprima. Vorrei inoltre che il Consiglio Comunale fosse chiamato a pre-stare quel massimo di attività che può essere consentita da un regolaresvolgersi del lavoro amministrativo. Così facendo si otterranno non soloi vantaggi che sono frutto di ogni ampia e libera discussione, ma si daràaggio ai nostri colleghi della minoranza di portarci il loro contributo che,più che utile e gradito, risulta indispensabile. Più cose quindi il Consi-glio discuterà e più i nostri concittadini si convinceranno che l’Ammini-strazione del loro Comune non è l’affare di un partito, né di un gruppettodi persone (la Giunta) per quanto rette ed esperte, ma è cosa di tutto ilpopolo, nella quale tutti, senza distinzione di idee politiche, possono guar-dare a fondo ed intervenire [...]» .
Lo sforzo corale evocato da Colanicchia, l’impegno massimo per
Andrea Fiasco
116
realizzare una ricostruzione della città veloce e in accordo con inuovi regolamenti, con le richieste della Soprintendenza e con ilbuon senso dei cittadini, furono i pilastri su cui poggiare la riorga-nizzazione urbanistica del paese. Il discorso di Colanicchia testimo-nia come il rione degli Scacciati con i suoi rappresentanti compreseimmediatamente la rilevanza delle sfide che il paese era chiamato adaffrontare, mostrando tutto l’alto senso civico e l’interesse per unabuona riuscita dei lavori di ricostruzione, volgendo lo sguardo al fu-turo, nel quale già vedevano per la città uno sviluppo ed una voca-zione rivolta verso un turismo culturale di massa.
La ricostruzione della chiesa della Santissima AnnunziataAnche il quartiere degli Scacciati con il bombardamento aereo
della città a più riprese aveva subìto ingenti danni. La chiesa dellaSantissima Annunziata, che il 22 gennaio del 1944 era stata già dan-neggiata, il primo giugno venne ridotta ad un cumulo di macerie,centrata in pieno da una bomba (Fig.14).
Il quartiere quindi si trovava a dover fare i conti, al termine dellaguerra, con la perdita del suo edificio più importante dal punto divista cultuale e sociale. Con la fine della guerra e l’avvio della rico-struzione lo Stato italiano decise però di sostenere, con il DecretoLegislativo Presidenziale del 27 giugno del 194627, lo stanziamentodi risorse finanziarie per la riparazione e la ricostruzione degli edificidi culto danneggiati o distrutti dalle offese belliche. Fu predisposta,nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, la spesa di due mi-liardi di lire destinata a finanziare la ricostruzione o la riparazionedelle chiese danneggiate dalla guerra. L’intervento doveva suppor-tare le diocesi nella ricostruzione degli edifici di culto andati distruttio danneggiati. Lo Stato si faceva totale carico delle spese di rico-struzione o riparazione, escludendo tassativamente il finanziamentodi qualsiasi opera di ampliamento o abbellimento28.
Fig. 14 - Lo stato di distruzione della chiesa della Santissima Annunziatadopo il bombardamento del primo giugno 1944.
27 App. documentaria n. 1.28 Il finanziamento poteva contemplarel’acquisto del mobilio, limitatamentealle indispensabili esigenze di carattereliturgico, ma escludeva la copertura fi-nanziaria di qualsiasi altra forma di ar-redamento quale opere d’arte,suppellettile sacra, libri sacri, paramenti,vasellame, ecc. ecc.
117
26 giugno ’44. Archeologia di una ricostruzione
Tecnicamente il decreto legislativo prevedeva che lo Stato si sa-rebbe fatto carico completamente della ricostruzione del luogo diculto o, in alternativa, come disciplinava l’articolo 6 del decreto,avrebbe potuto affidare in concessione all’ordinario diocesano (ilvescovo) la progettazione e l’esecuzione dei lavori.
È in questo quadro storico che maturò l’idea di ricostruire lachiesa della Santissima Annunziata di Palestrina. Il 10 ottobre del1947 la Diocesi di Palestrina pertanto, nella persona del suo vescovo,il cardinal Carlo Salotti (1939-1947), avanzò la richiesta ufficiale diricevere in concessione la ricostruzione della parrocchia29. A tal pro-posito nell’aprile del ’46 era stata nel frattempo affidata alla figuradell’arch. Vincenzo Fasolo la cura di redigere il progetto di rico-struzione30. Il progetto di Fasolo fu ritenuto meritevole di approva-zione dalla Pontificia Commissione Centrale per l’Arte Sacra31. Il 21aprile del 194832 il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici accolsela richiesta di concessione avanzata dall’Ordinario Diocesano, ascol-tato anche il parere dell’ufficio competente del Genio Civile e delProvveditorato Regionale alle Opere Pubbliche. Il 26 luglio dellostesso anno il Ministro approvò definitivamente il progetto con De-creto Ministeriale33. Il Consiglio decise di finanziare interamentel’opera di ricostruzione della chiesa e della canonica per un importodi ₤. 14.191.283, comprese le spese di progettazione e di sorve-glianza, a fronte di un preventivo di spesa di ₤. 15.887.622 previstadal progetto preliminare di Fasolo. Termine ultimo di consegna deilavori fu stimato in dodici mesi, a partire dalla registrazione del de-creto presso la Corte dei Conti (09-12-1948/09-12-1949). Era pre-vista nel progetto la costruzione anche della canonica, nonostante ildecreto legislativo vietasse anche il finanziamento delle opere di am-pliamento, in quanto la Curia rinunziava alle spese di riparazionedella vecchia casa del parroco, sita, prima del conflitto, in piazza dellaCortina.
Nel frattempo nell’estate del 1948 era stato nominato vescovodella Diocesi, dopo la morte del card. Salotti avvenuta nell’ottobredell’anno precedente, il cardinal Benedetto Aloisi Masella (1948-1970). Il 2 febbraio del 1949 Mons. Pietro Severi, nominato vescovosuffraganeo della Diocesi Prenestina, confermò la fiducia a VincenzoFasolo, affidandogli anche l’incarico di direttore dei lavori di rico-struzione della chiesa34.
In quel tempo l’arch. Fasolo aveva appena ricevuto anche il pre-stigioso incarico di architetto capo della Reverenda Fabbrica di SanPietro. La costruzione della nuova chiesa della Santissima Annun-ziata prendeva inizio quindi sotto i buoni auspici, sotto l’egida delnuovo architetto della Reverenda Fabbrica, la cui figura e il cui im-pegno sul cantiere dell’Annunziata contribuivano a rendere presti-gio e lustro alla nuova edificazione.
Dal settembre del ‘48 al gennaio ’49 venne istruito, formalizzatoe bandito il capitolato d’appalto per le manifestazioni d’interesse allarealizzazione dei lavori di ricostruzione35. Alla gara d’appalto furonoinvitate a partecipare sette imprese: la Ditta Tomassi Alessandro,
29 ASDP, Ufficio Amministrativo, Pale-strina, SS.ma Annunziata, Ministero deiLavori Pubblici, D.M. 2692/2246 del 26-07-1948.L’istanza fu inoltrata dalla Curia Vesco-vile con prot. n. 558/1946. Inoltre nel’47 don Emilio Evangelisti, il parrocodella chiesa della SantissimaAnnunziata, aveva scritto direttamenteal Ministro dei Lavori Pubblici,segnalando lo stato di distruzione dellachiesa e la necessità di ricostruirla al piùpresto. Il Ministro, l’OnorevoleUmberto Tupini, aveva rispostonell’agosto dello stesso annodirettamente a Mons. Giuseppe Puliti,Vicario Generale della Diocesi,assicurando che avrebbe tenuto inconsiderazione la vicenda. ASDP, Uffi-cio Amministrativo, Palestrina, SS.maAnnunziata, Ministero dei Lavori Pub-blici, Doc. del 22-08-1947.30 App. documentaria n. 2. Fasolo ac-cettò l’incarico di redigere il progettodella nuova fabbrica alle condizioniposte da Salotti - che non prevedevano,qualora il progetto non fosse stato ap-provato dal Ministero, il rimborso dellespese di progettazione - con lettera di ri-sposta conservata all’interno dellostesso fondo archivistico. 31 ASDP, Ufficio Amministrativo, Pale-strina, SS.ma Annunziata, Ministero deiLavori Pubblici, D.M. 2692/2246 del 26-07-1948.32 ASDP, Ufficio Amministrativo, Pale-strina, SS.ma Annunziata, Ministero deiLavori Pubblici, Consiglio Superiore deiLavori Pubblici, Doc. n. 1143/21-04-1948.33 App. documentaria n. 3. Registratoalla Corte dei Conti il 9 dicembre 1948(reg. 25, fog. 309), il Decreto fu ratifi-cato con prot. n. 6838 dalla DirezioneGenerale dei Servizi Speciali il 26 di-cembre 1948.34 App. documentaria n. 4.35 ASDP,Ufficio Amministrativo, Pale-strina, SS.ma Annunziata, Curia Vesco-vile, prot. n. 654/20-09-1948.
Andrea Fiasco
118
quella di Tomassi Enrico, la Ditta Rossi Pergentino, la Ditta Cec-coni Aldo, la ditta dell’ingegner Grutter Adolfo, quella di SebastiPietro e quella di Belcecchi Umberto. Quasi tutte le ditte erano diRoma - la Grutter era in quegli anni impegnata sul cantiere dell’areaarcheologica del santuario36 - tranne le imprese Cecconi e Tomassi.Queste formularono un’offerta congiunta, che risultò poi la migliore,la quale prevedeva un ri-basso del 6.25% rispetto alcapitolato d’appalto ini-ziale. Le tre ditte avevanopresentato un’offerta cu-mulativa dando vita ad unasorta di cordata, che giuri-dicamente però non corri-spondeva a nessuna formasocietaria legalmente previ-sta. Come spiega bene unanota37 riservata redatta daVincenzo Fasolo e indiriz-zata a Mons. Severi l’offertacumulativa presentata dalletre imprese aveva l’obiet-tivo di superare la man-canza di requisiti richiestidal bando iniziale di cuierano sprovviste le DitteTomassi (iscrizione alProvveditorato per le OO.PP. del Lazio) e che solo laditta Cecconi Aldo a quel tempo possedeva. La delicata situazionecomportò quindi ulteriore allungamento dei tempi di inizio lavori.Finalmente il 3 febbraio 1949 fu comunicato alle ditte associate To-massi & Cecconi di aver vinto l’appalto per la realizzazione dei la-vori38. Il 18 marzo fu comunicato al Ministero dei Lavori Pubblici eal Genio Civile che l’inizio dei lavori di ricostruzione aveva avutoluogo il 21 febbraio39. L’iter procedurale dopo circa tre anni giunsea compimento. Alla fine del suddetto anno i lavori non erano peròancora terminati e pertanto l’arch. Vincenzo Fasolo avanzò una ri-chiesta di proroga al Ministero, che accordò altri 120 giorni40. Il 13marzo del 1950 il Vescovo scrisse al Sindaco della città di Palestrinaavvisandolo che al più tardi, entro il mese di maggio, la nuova chiesaparrocchiale dell’Annunziata sarebbe stata solennemente inaugu-rata e benedetta. La lettera aveva l’obiettivo anche di ricordare alprimo cittadino di provvedere quanto prima allo sgombero delle ma-cerie e dei letamai che esistevano ancora nelle aree adiacenti lachiesa41. Il 3 maggio venne richiesto il pagamento del quarto ed ul-timo stato di avanzamento dei lavori42. L’opera quindi si avviava allaconclusione. Il 25 giugno del 1950 avvenne la fornitura da partedello stabilimento per la lavorazione del legno del comm. Achille
36 ADA-PA, Pratiche di tutela, 282/9,Doc. 09-06-1947.37 ASDP, Ufficio Amministrativo, Pale-strina, SS.ma Annunziata, Nota riser-vata.38 App. documentaria n. 5. Alle impreseera stato richiesto di integrare la loroproposta, risultata parziale al momentodell’istanza di presentazione. La re-sponsabilità giuridica fu assegnata algeom. Cecconi Francesco. Il contrattocon la Curia Vescovile fu firmato mer-coledì 9 febbraio 1949 da quest’ultimoin rappresentanza legale della ditta Cec-coni Francesco, alla quale fu concessol’appalto per la realizzazione dei lavori(come riporta anche la nota fideiussoriadel Banco di S. Spirito in data 12-02.1949, conservata in ASDP, UfficioAmministrativo, Palestrina, SS.ma An-nunziata), realizzato però material-mente con la partecipazione delle altredue ditte Tomassi. 39 ASDP,Ufficio Amministrativo, Pale-strina, SS.ma Annunziata, Curia Vesco-vile, prot. n. 983/18-03-1949.40 ASDP, Ufficio Amministrativo, Pale-strina, SS.ma Annunziata, Curia Vesco-vile, prot. n. 1151/23-12-1949 e1150/01-01-1950.41 ASDP, Ufficio Amministrativo, Pale-strina, SS.ma Annunziata, Curia Vesco-vile, prot. n. 1208/12-03-1950.42 ASDP, Ufficio Amministrativo, Pale-strina, SS.ma Annunziata, Curia Vesco-vile, prot. n. 1255/03-05-1950.
Fig. 15 - La celebrazione della solennededicazione della nuova chiesa
della Santissima Annunziata.
119
26 giugno ’44. Archeologia di una ricostruzione
Bandiera di tutto l’arredo ligneo per la chiesa e i locali annessi. LaDitta Bernardini fornì i marmi per l’altare e il presbiterio. La DittaVilla di Milano installò l’impianto parafulmine mentre alla DittaConsoli e Tomassi toccò il compito di installare il castello delle cam-pane43. Nell’estate del 1950 venne finalmente istituito il Comitatod’onore44 per la Solenne Dedicazione della ricostruita Chiesa Parroc-chiale della Santissima Annunziata. A questo venne affiancato un Co-mitato effettivo, entrambi presieduti dal Cardinal Aloisi Masella. NelComitato d’onore figuravano, oltre ad alcune alte personalità delmondo ecclesiastico, alti esponenti del governo italiano: l’onorevolePietro Campilli, Ministro della Repubblica, il prof. Giulio Andreotti,allora Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, gli onorevoliNicola Angelucci, Giuseppe Caronia, Vincenzo Cecconi, Igino Gior-dani e Ortensio Pierantozzi, della Camera dei Deputati, gli onorevoliVincenzo Menghi e Quinto Tosatti, senatori della Repubblica. Nonmancavano i nomi dei rappresentanti della casata Barberini, don En-rico e don Urbano, di Angela Maria Cingolani Guidi, eletta nel ’46all’Assemblea Costituente e sindaco di Palestrina dal 1953 al 1965insieme con il marito Mario, ex deputato del Partito Popolare, gliarchitetti Vincenzo e Furio Fasolo, Mons. Giacomo Morelli, Incari-cato d’affari della Santa Sede, don Guido Croce, parroco della chiesafino alla fine degli anni ‘30 e molti altri ancora. Al Comitato effet-tivo presieduto sempre da Aloisi Masella e da Mons. Pietro Severiparteciparono il Sindaco di Palestrina, Licinio Bernardini, i parrocidelle altre chiese della città e dei conventi, e alcune delle personalitàdi spicco della società prenestina dell’epoca, quali l’avvocato GiorgioPinci, il prof. Ferracci e altri ancora.
La mattina del 24 settembre del 1950 (Figg. 15-17) la nuovachiesa venne solennemente consacrata dal Cardinal Vescovo dellaDiocesi Prenestina Benedetto Aloisi Masella e dal Vescovo Suffra-ganeo Mons. Pietro Severi, il vero artefice della ricostruzione della
Fig. 16 - L’ingresso del Cardinal Masella all’interno della nuova fabbricail giorno della solenne dedicazione.
43 ASDP, Ufficio Amministrativo, Pale-strina, SS.ma Annunziata.44 App. documentaria n. 6.
Andrea Fiasco
120
45 ASDP, Ufficio Amministrativo, Pale-strina, SS.ma Annunziata.46 ASDP, Ufficio Amministrativo, Pale-strina, SS.ma Annunziata.
chiesa, colui che passo dopo passo aveva monitorato l’edificazionedella nuova fabbrica.
Il progetto di edificazione della nuova fabbrica della SantissimaAnnunziata
Il progetto di costruzione della chiesa fu opera dell’arch. Vin-cenzo Fasolo, il quale fu anche direttore dei lavori di realizzazione,affiancato costantemente dal figlio Furio, negli stessi anni impegnatoassiduamente in città anche nello scavo archeologico del santuariodella dea Fortuna e nel restauro di Palazzo Colonna Barberini. L’edi-ficazione della nuova fabbrica della Santissima Annunziata fu tut-t’altro che semplice. L’edificio odierno costituisce il punto di arrivodi una serie di modifiche e ripensamenti che a più riprese interessa-rono l’iniziale progetto di ricostruzione. L’impianto prebellico dellachiesa45 (si veda il saggio di Roberta Iacono) occupava un isolatodisposto ad L, composto principalmente dal locale chiesa, dall’ora-torio della confraternita, dalla sacrestia e sul prospetto che si affac-ciava lungo via della SS.ma Annunziata dal campanile. Furono questicorpi di fabbrica che andarono completamente distrutti la mattina
del primo giugno del 1944 e che in parte erano stati danneggiati giàcon il bombardamento del 22 gennaio, come testimoniano i rilievie le fotografie dell’area eseguite subito dopo la guerra (Tav. IV).
Dalla lettura delle tavole46 (Tavv. V-VIII) dell’iniziale progettoredatto da Vincenzo Fasolo conservate presso l’Archivio Storicodella Diocesi di Palestrina si apprende con chiarezza la visione el’idea che il grande architetto aveva della nuova chiesa: un edificio di
Fig. 17 - Comitato per la Solenne Dedicazione della ricostruita Chiesa ParrocchialeSS. Annunziata. Invito Ufficiale.
121
26 giugno ’44. Archeologia di una ricostruzione
medie dimensioni, con orientamento ovest-est, servito da un in-gresso monumentale posto sul prospetto occidentale, caratterizzatoda una scalinata non troppo ampia, decorata sul versante nord daun piccolo emiciclo affrescato con pitture a tema religioso, prece-duto, nel punto iniziale di ascesa, dirimpetto la strada, da un’alta co-lonna con capitello coronata da una croce.
Il prospetto meridionale era caratterizzato unicamente dal vo-lume della cappella e dall’alto campanile. Nello spazio antistante - undeclivio roccioso che degradava verso la sottostante via della SS.maAnnunziata (ex via di San Francesco) - trovava posto nell’idea di Fa-solo la costruzione di una sala parrocchiale, con orientamento nord-sud, da circa duecentocinquanta posti a sedere, sormontata, al livellosuperiore, quello della chiesa, da una panoramica terrazza. Anche ilprospetto meridionale della fabbrica risultava decorato con temi pit-torici, relegati fra le intercapedini di una serie di pilastri che dove-vano sostenere l’aula di culto nel versante più occidentale delprospetto meridionale. L’interno della fabbrica, a navata unica, tro-vava il suo fulcro nella zona del presbiterio, caratterizzata da un al-tare con capitello e mensa e un alto pulpito posto di fronte all’unicacappella laterale. Il battistero trovava posto lateralmente all’ingresso
Tav. IV - Vincenzo Fasolo. Il rilievo della chiesa e degli edifici annessi distruttidal bombardamento del primo giugno ’44. Le aree in puntinato sono quelle
risultate completamente distrutte.
Andrea Fiasco
122
Tav
. V -
Vinc
enzo
Fas
olo.
Pro
getto
inizi
ale d
ella
nuov
a chi
esa d
ella
Sant
issim
a Ann
unzia
ta. P
lanim
etria
.Si
not
a ben
e la s
ala p
arro
cchi
ale a
sud
e l’in
gres
so m
onum
enta
le a
oves
t.In
scala
min
ore i
l pro
spet
to n
ord
della
scali
nata
d’in
gres
so.
123
26 giugno ’44. Archeologia di una ricostruzione
dell’aula di culto, mentre alte finestre scandivano il corpo della na-vata e risultavano anch’esse intervallate da una decorazione pittorica.
Questo primo progetto, notevolmente ridimensionato dalla nor-mativa espressa dal decreto del ’46, resta, per la storia dell’architet-tura, uno dei tentativi più interessanti intrapresi da Vincenzo Fasoloper esprimere l’idea, la forma e la concezione della sua architetturareligiosa contemporanea, perfettamente in accordo con la sua for-mazione teorica e con le esperienze acquisite nella progettazione diopere pubbliche. Vincenzo Fasolo nello stesso frangente era impe-gnato come architetto capo della Reverenda Fabbrica nel progettodi sistemazione della cripta di San Pietro e delle grotte sotto la basi-lica vaticana, ma anche nel restauro del Duomo di Catanzaro, di-
Tav. VI - Vincenzo Fasolo. Progetto iniziale della nuova chiesadella Santissima Annunziata. Sezione nord-sud.
Tav. VII - Vincenzo Fasolo. Progetto iniziale della nuova chiesadella Santissima Annunziata. Planimetria dell’aula di culto
e prospetto occidentale d’ingresso.
Andrea Fiasco
124
strutto dai bombardamenti che avevano colpito la città nel 1943,con cui il primo progetto della Santissima Annunziata condivide al-cune caratteristiche, quali fra tutte la ricercatissima integrazione fraarchitettura e decorazione pittorica, una delle colonne portanti delpensiero fasoliano.
L’odierna chiesa della Santissima Annunziata è il risultato dellasintesi fra il progetto originario di Vincenzo Fasolo e delle imposteed obbligate modifiche inserite in corso d’opera, le quali condusseroalla redazione di un secondo progetto (Tavv. IX-XI), su cui furonopoi effettuate ulteriori modifiche: la concezione odierna dell’edificio(Tav. XII), nonostante persista un volume architettonico notevole,è stata resa meno monumentale nei suoi prospetti esterni, spogliadelle decorazioni, sia dentro (le pitture presenti sono state realiz-zate dal pittore prenestino Giulio De Angelis nel triennio ’93-96)che fuori, lineare e semplice nelle sue architetture interne. Persistedel progetto originario l’ingresso a occidente, estremamente ridi-mensionato nelle forme e nella decorazione e il prospetto a meri-dione, che guarda verso la valle, scandito sempre da un’unicacappella e da un alto campanile, che spicca più in alto di tutto il tes-suto abitativo del quartiere. Scomparve dal progetto la grande salaparrocchiale posta sul versante meridionale del complesso. Oggi diquell’originaria sala polivalente destinata anche ad oratorio, pensatada Fasolo, all’inizio della redazione del progetto, anche come un sim-bolo della rinascita socio-culturale del quartiere, resta solo una pic-cola sala ricreativa dedicata a papa Giovanni XXIII.
Nel 1953, a tre anni dal termine dei lavori, fu pubblicato da FurioFasolo sulla rivista Fede e Arte un breve articolo47 sulla ricostruzionedella fabbrica. Risultano illuminanti le parole dell’architetto per ca-pire la sintesi finale dell’opera appena compiuta: «[...] la sfida in faseprogettuale è risultata essere inserire la chiesa nel volume urbanistico dellacittà e nella sua visione che si ha dal basso. Per tale ragione importanza no-
Tav. VIII - Vincenzo Fasolo. Progetto iniziale della nuova chiesadella Santissima Annunziata.
47 F. FASOLO, Chiesa della Santissima An-nunziata in Palestrina, in Fede e Arte, I,fasc. IX, 1953, pp. 280-281.
125
26 giugno ’44. Archeologia di una ricostruzione
Tav. IX a/b - Il secondo progetto della nuova chiesa della Santissima Annunziata.Planimetria del piano inferiore, con le fondazioni e la saletta parrocchiale,
e del piano superiore con l’aula di culto e la terrazza.
Tav. X - Il secondo progetto della nuova chiesa della Santissima Annunziata. Il prospetto sud.
Andrea Fiasco
126
tevole ha assunto la progettazione della fiancata (prospetto meridionale).L’idea è stata quella di porre a contrasto due masse solidali: la cappella la-terale e il campanile. A contrasto inoltre della forma longitudinale dellanavata unica si deve l’inserzione trasversale della casa parrocchiale nel vo-lume della massa della chiesa. Il prospetto W della chiesa, molto semplice,è stato anch’esso subordinato alla valorizzazione della fiancata [...]».
Quest’enfasi data al prospetto meridionale della chiesa, alla suaconformazione, fu l’elemento meno elaborato e di più immediatapercezione che ancora oggi riassume gli interventi di modifica al pro-getto iniziale effettuati in corso d’opera da Vincenzo Fasolo e dal fi-glio Furio. È da ricercare nell’adozione di questa soluzione la tracciadell’intervento congiunto di padre e figlio, da collocare cronologi-camente nella seconda fase dell’iter procedurale di realizzazionedella nuova fabbrica. Tutto ruotò intorno all’equilibrato inserimentodella chiesa non tanto nel tessuto abitativo del quartiere ma princi-palmente nel paesaggio urbanistico della città. Fu la nuova visionedel paese che si schiudeva dal basso della pianura circostante, dallezone ai limiti dell’abitato urbano, la chiave di lettura che orientò nelprimo dopoguerra in via definitiva sia gli interventi di ricostruzioneche di non ricostruzione all’interno della cinta urbana. La chiesadella Santissima Annunziata concorse a raggiungere questo scopo,ideato da Vincenzo Fasolo e promosso poi nel tempo anche su altricantieri della città soprattutto da suo figlio Furio.
La chiesa della Santissima Annunziata, sorta materialmente nelgiro di un anno e mezzo, risulta essere ai nostri occhi un cantiere tut-
Tav. XI - Il secondo progetto della nuova chiesa della Santissima Annunziata. Aula di culto, sezione ovest-est.
127
26 giugno ’44. Archeologia di una ricostruzione
t’altro che comune, nel quale, il proficuo spirito di cooperazione di il-lustri architetti, spiccate personalità ecclesiastiche e personaggi dellasocietà civile, produsse l’opportunità di offrire nuovamente al quar-tiere degli Scacciati nel giro di poco tempo il suo punto di riferimentonon solo religioso ma soprattutto culturale e sociale. Questa rinno-vata attività di intervento trovò attuazione anche perché era impie-gata contemporaneamente nel grande cantiere dell’area archeologica,sul quale, non a caso, stavano operando le stesse personalità.
La chiesa è a tutti gli effetti un simbolo della distruzione bellicache colpì il quartiere e l’intera città nel 1943-44, ma è anche verosi-milmente un luogo della memoria, non solo dei drammatici eventiche colpirono il paese in quei mesi, ma anche delle vittime uccise inun rifugio antiaereo situato lì vicino, colpito dalla stessa bomba checadde la mattina del primo giugno sulla chiesa, e di tutti gli altri in-nocenti caduti sul suolo prenestino. La presenza di due personalitàcosì illustri sul cantiere dell’Annunziata, Vincenzo e Furio Fasolo,attesta tutta l’aspettativa e l’attenzione che la Diocesi ebbe nei con-fronti di questa realtà parrocchiale, tale da affidare l’incarico di rie-dificarla ad un personaggio di fama nazionale, colui che in queltempo era l’architetto della Reverenda Fabbrica di San Pietro in Va-ticano.
Tutto questo contribuisce a rendere evidente anche l’interesse el’importanza che il Vescovo e la Diocesi ebbero nei confronti del po-poloso quartiere degli Scacciati, una comunità di cittadini e fedeli,nerbo portante della religiosità cittadina, che avrebbe potuto incli-narsi e sgretolarsi se per lungo tempo fosse venuto a mancare ilpunto di riferimento principale intorno al quale, generazioni di fa-miglie, si erano riconosciute e realizzate: la chiesa della SantissimaAnnunziata nel rione prenestino degli Scacciati.
Tav. XII - Chiesa della Santissima Annunziata. Planimetria dell’aula di culto, degliambienti della sacrestia e del prospetto sud. Stato attuale.
Andrea Fiasco
128
Bibliografia
AA.VV. AA.VV., Studi su Carlo Ludovico Ragghianti, in Predella. Rivista seme-strale di arti visive, n. 28 (predella.arte.unipi.it).
ANONIMO 1994 Anonimo, Dalla cronaca del Convento di San Francesco di Palestrina deiFrati Minori, Comune di Palestrina, Assessorato alla Cultura, BibliotecaComunale “Fantoniana”, Fondazione “Cesira Fiori”, Palestrina, 1994.
AURIGEMMA,FASOLO, GULLINI 1948 Aurigemma S., Fasolo F., Gullini G., Palestrina - Scoperte e restauri nel
complesso templare della Fortuna Primigenia, in Bollettino d’Arte, IV, Ot-tobre - Dicembre, 1948, pp. 346-354.
BARBANERA,DALAI EMILIANI 2000 Barbanera M., Dalai Emiliani M., Ranuccio Bianchi Bandinelli e il suo
mondo, Bari, 2000.
BARBANERA 2003 Barbanera M., Ranuccio Bianchi Bandinelli. Biografia ed epistolario di ungrande archeologo, Milano, 2003.
BRUNO 2004 Bruno R. (a cura di), Ragghianti critico e politico, Milano, 2004.
CIALDEA, LULLI 1995 Cialdea B., Lulli U., Palestrina 1945. Ricostruzione, una difficile partenza,Comune di Palestrina, Assessorato alla Cultura, Biblioteca Comunale“Fantoniana”, Fondazione “Cesira Fiori”, Palestrina, 1995.
CREVATO SELVAGGI 2011 Crevato Selvaggi B., Vincenzo Fasolo dalla Dalmazia a Roma. Vita e operedell’architetto spalatino, Catalogo della mostra, Roma Musei di VillaTorlonia - Casina delle Civette, 7 Dicembre 2011 - 26 Febbraio 2012,Roma, Venezia, 2011.
FASOLO, GULLINI 1953 Fasolo F., Gullini G., Il santuario della Fortuna Primigenia a Palestrina,Roma, 1953.
FASOLO 1953 Fasolo F., Chiesa della Santissima Annunziata in Palestrina, in Fede e Arte, I,fasc. IX, 1953, pp. 280-281.
FASOLO 1956 Fasolo F., Album Prenestino 1944-1956, Roma, 1956.
FASOLO 1991 Fasolo V., L’attività di Vincenzo Fasolo, ingegnere e architetto, in La ca-pitale a Roma. Città e arredo urbano. 1870-1945, Catalogo della mostra(Cardilli L., Cambedda Napoletano a cura di), Roma 2 Ottobre - 28Novembre 1991, Roma, 1991, pp. 96-99.
FERRACCI 1994 Ferracci E., Diario inedito. Cronaca di Palestrina dal 25 luglio 1943 al 27gennaio 1944, Comune di Palestrina, Assessorato alla Cultura, BibliotecaComunale “Fantoniana”, Fondazione “Cesira Fiori”, Palestrina, 1994.
129
26 giugno ’44. Archeologia di una ricostruzione
GIOVANNETTI,STABILE 2004 Giovannetti F., Stabile F.R., Vincenzo Fasolo. Primato del disegno e del-
l’ambientismo, in Bollettino dei Musei comunali di Roma, 18, 2004, pp.129-155.
GIOVANNETTI,STABILE 2011 Giovannetti F., Stabile F. R., Disegnare, osservare, pensare: il “primato del
disegno”, in Vincenzo Fasolo dalla Dalmazia a Roma. Vita e opere dell’ar-chitetto spalatino, Catalogo della mostra, Roma Musei di Villa Torlonia- Casina delle Civette, 7 Dicembre 2011 - 26 Febbraio 2012, Roma, Ve-nezia, 2011, pp. 15-29.
LUCARELLI 2007 Lucarelli A., Architettura della rinascita: l’UNRRA. Il caso Palestrina, Pa-lestrina, 2007.
MAGRINI 1999 Magrini P., Nei vicoli della memoria. Storie e racconti da Gli Scacciati, Pa-lestrina, 1999.
MARCONI 2002 Marconi P., Torniamo a riconsiderare la didattica della storia dell’archi-tettura: Fasolo, Benevolo e Zander la facevano meglio di noi, in Il restauroe l’architetto: teoria e pratica in due secoli di dibattito (Marconi P. acura di), Venezia, 2002, pp. 194-197.
QUILICI 1979 Quilici L., Palestrina. Cronaca della distruzione di una città antica, in LaParola al Passato, CLXXXVI, 1979, pp. 223-240.
TOMASSI 1983 Tomassi P., Fotografie e storie della gente di Palestrina. 1850-1950, Pale-strina, 1983.
Andrea Fiasco
130
INDICE DELLE FIGUREFig. 1 - ADA-PA, Archivio fotografico.Fig. 2 - FASOLO, 1956, t. II, 1-2.Figg. 3-8 - FASOLO, 1953, t. IV, 3-4, t. I, 1-2, t. III, 1-2.Fig. 10 - Università di Pisa, Sistema bibliotecario di ateneo, Archivio fotografico.Fig. 11 - Università di Pisa, Sistema bibliotecario di ateneo, Archivio fotografico.Fig. 12 - CREVATO SELVAGGI, 2011, p. 56, fig. 1.1.e.Fig. 13 - Collezione fotografica Famiglia Colanicchia.Fig. 14 - MAGRINI, 1999, p. 49.Fig. 15 - Collezione fotografica Carlo Ettore Lena.Fig. 16 - TOMASSI, 1983, p. 119.Fig. 17 - ASDP, Ufficio Amministrativo, Palestrina, SS.ma Annunziata.
INDICE DELLE TAVOLETav. I - ASCP, RGN 32/8, Doc. 03-03-1945. Tavv. II-III - FASOLO, 1956, tt. V-VI.Tavv. IV-XI - ASDP, Ufficio Amministrativo, Palestrina, SS.ma Annunziata, Tavole di progetto.Tav. XII - FASOLO, 1953, p. 281.
Veduta della città di Valmontone, sullo sfondo Palestrina. Maggio 1946.(Tratta da SPAZIANI, Artena, Colleferro, Valmontone. In Guerra, Valmontone, 1999).
135
26 giugno ’44. Archeologia di una ricostruzione
2 - ASDP, Ufficio Amministrativo, Palestrina, SS.ma Annunziata, Curia Vescovile, prot. n. 512/3-04-1946.
Andrea Fiasco
136
3 - ASDP, Ufficio Amministrativo, Palestrina, SS.ma Annunziata, Ministero dei Lavori Pubblici, D. M. 2692/2246 del 26-07-1948.
139
26 giugno ’44. Archeologia di una ricostruzione
4 - ASDP, Ufficio Amministrativo, Palestrina, SS.ma Annunziata, Doc. 02-02-1949.
Andrea Fiasco
140
5 - ASDP, Ufficio Amministrativo, Palestrina, SS.ma Annunziata, Prot. n. 929/03-02-1949.
141
26 giugno ’44. Archeologia di una ricostruzione
Comitato d’onore per la Solenne Dedicazione della ricostruitaChiesa Parrocchiale della Santissima Annunziata
Card. Benedetto Aloisi Masella, Vescovo Diocesi PrenestinaSua Ecc. Mons. Bernardino Bertoglio ,Vescovo di Bobbio
Sua Ecc. Luciano Migliorini, Vescovo di RietiOn.le Pietro Campilli, Ministro della Repubblica
Prof. Giulio Andreotti, Sottosegretario alla Presidenza del ConsiglioOn.le Nicola Angelucci, Camera dei Deputati
On.le Giuseppe Caronia, Camera dei DeputatiOn.le Vincenzo Cecconi, Camera dei Deputati
On.le Igino Giordani, Camera dei DeputatiOn.le Ortensio Pierantozzi, Camera dei DeputatiOn.le Vincenzo Menghi, Senato della Repubblica
On.le Quinto Tosatti, Senato della RepubblicaDon Enrico Barberini, Principe di Palestrina
Don Urbano Barberini Mons. Giuseppe Puliti, Arcidiacono della Cattedrale di Palestrina
Mons. Valentino Cianfriglia, Canonico Penitenziere Cattedrale di Palestrina Mons. Enrico Lena, Cancelleria Liberiana
Giacomo Morelli, Incaricato d’affari della Santa SedeDon Guido Croce, Arciprete Rocca di Cave, ex parrocco SS.ma AnnunziataPadre Raffaele Bitetti, Rettore del Pontificio Collegio Leoniano di Anagni
Dr. Angelo e Donna Angela Maria Cingolani Comm. Ramacci Roberto, Primo Pretore di Palestrina
Prof. Arch. Vincenzo Fasolo Prof. Arch. Furio Fasolo
Ing. Emilio CicerchiaComm. Guglielmo Mencacci
Don Antonio De Angelis, Rettore Università Int. Pro Deo Don Marcello Sbardella
6 - ASPA, B/22, Comitato Celebrazioni Dedicazione nuova chiesa 1950, Comitato d’onore, non inv.