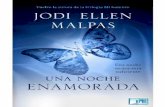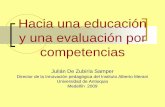"Diamesia: la nascita di una dimensione" (2015)
Transcript of "Diamesia: la nascita di una dimensione" (2015)
Parole, gesti, interpretazioni
Studi linguistici per Carla Bazzanella
a cura di
Elena Pistolesi, Rosa PuglieseBarbara Gili Fivela
Contributi diElena Pistolesi, Johanna Miecznikowski, Emilia Calaresu
Barbara Gili Fivela, Franca Orletti, Anna CilibertiRosa Pugliese, Pura Guil, Iørn Korzen
Erling Strudsholm, Gudrun Held, Irene RongaEva Thüne, Simona Leonardi
Alessandro Garcea, Letizia Caronia
Copyright © MMXVAracne editrice int.le S.r.l.
via Quarto Negroni, Ariccia (RM)
()
----
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.
Non sono assolutamente consentite le fotocopiesenza il permesso scritto dell’Editore.
I edizione: aprile
Indice
7 Presentazione
9 Bibliografia degli scritti di Carla Bazzanella
27 Diamesia: la nascita di una dimensione
Elena Pistolesi
57 L’argomentazione nelle recensioni online
Johanna Miecznikowski
79 La fagocitazione dell’interlocutore: dialoghi a una voce sola
nella finzione letteraria. Osservazioni sulla sintassi dialogica
del dialogo “spaiato”
Emilia Calaresu
107 L’integrazione di informazioni multimodali: prosodia ed espres-
sioni del volto nella percezione del parlato
Barbara Gili Fivela
129 Partecipazione e gestione dei turni in una interazione in classe con
bambini in difficoltà: il ruolo dei segnali verbali e multimodali
Franca Orletti
147 Lo studio della grammatica ‘generale’ come stimolo alla rifles-
sione sulla capacità di linguaggio
Anna Ciliberti
163 Figurati, tra i segnali discorsivi. Una prospettiva pedagogica
Rosa Pugliese
209 Traducciones italianas del marcador del discurso hombre/mujer
Pura Guil
Indice 6
233 Dalla Costituzione al Mr. Bean: aspetti diafasici di alcuni tipi
testuali italiani e danesi
Iørn Korzen
257 Quattro gatti e una mosca bianca. Espressioni con nomi di
animali in una prospettiva comparativa italiano-danese
Erling Strudsholm
285 Is the Italian figura just a facet of face? Comparative remarks
on two socio-pragmatic key-concepts and their explanatory
force for intercultural approaches
Gudrun Held
313 La comprensione della metafora fra lingua ed esperienza: col-
locazioni, costruzioni e ripetizioni polifoniche
Irene Ronga
331 Metafore e memoria in un’intervista narrativa del corpus IS
(Emigrantendeutsch in Israel)
Eva Thüne, Simona Leonardi
349 Il criterio della definitezza nell’Ars breuiata di Agostino
Alessandro Garcea
363 “Direi, una specie di…”: incertezza, approssimazione e prati-
che di purificazione nell’intervista di ricerca
Letizia Caronia
393 Autrici e autori
Diamesia: la nascita di una dimensione
ELENA PISTOLESI
Abstract. Italian sociolinguistics has been marked by a diamesic dimension for almost
three decades. The aim of this paper is to provide an overview of the stages which – starting
from the suggestion put forward by A. A. Mioni in 1983 – have led scholars to include medial
differences within Berruto’s 1987 architecture of contemporary Italian. Much of the interest
generated by that phase of research is grounded in the notions of written and spoken language
(at times only alluded to or theoretically presupposed as a point of reference), which have
converged into the two extreme points of the diamesic continuum. The objections which were
initially raised seem to be justified by the now prevailing tendency to consider the diamesic
variation as a subtype of diaphasic variation. The historical perspective adopted in this paper
provides the opportunity to assess the merits and limits of diamesia, to explain why it is an
all-Italian notion and to reflect on the self-same concept of variety.
Il termine diamesia fu coniato da Alberto A. Mioni (1983), sulla
falsariga della tassonomia già consolidata nella linguistica delle varie-
tà1, con riferimento al “mezzo via via usato per comunicare”. Il lavoro
di Mioni, dedicato all’italiano tendenziale, pur non insistendo sui rap-
porti di questa nuova dimensione con quelle di matrice coseriana, ha
aperto la strada alla problematica collocazione del continuum scritto-
parlato nell’architettura dell’italiano contemporaneo, una strada che
possiamo considerare provvisoriamente conclusa con la proposta di
Gaetano Berruto (1987: 19-27).
Questo contributo intende ripercorrere le fasi che hanno condotto
alla nascita della diamesia come dimensione di variazione. L’arco
cronologico privilegiato va dal 1983 al 1987, con alcuni slittamenti
verso le fonti e verso gli esiti odierni. La diamesia è infatti il risultato
della confluenza di più filoni di ricerca, dominanti a cavallo degli anni
settanta e ottanta del secolo scorso, quali:
- il dibattito sull’italiano popolare, animato dai lavori di M. A. Cortelazzo e
T. De Mauro, cui si possono ricondurre anche gli studi sull’italiano re-
1 Sulla nascita e sul consolidamento di questa terminologia, cfr. Bombi/Orioles (2003).
Elena Pistolesi 28
gionale2, consolidatisi nel corso di un decennio (1976-86) e oggi partico-
larmente vitali;
- gli studi sul francese contemporaneo, i quali, oltre a insistere sul divario
tra lingua scritta e lingua parlata, a ispirare le etichette di “italiano neo-
standard” (o dell’uso medio o tendenziale) e di “italiano popolare”, a
promuovere una riflessione sulla grammatica dell’orale, hanno incorag-
giato l’indagine sulla continuità dei fenomeni in chiave diacronica3;
- la ricerca sul parlato comune, senza aggettivi, programmaticamente di-
stinto dal dialetto e dall’italiano popolare4.
Tali nodi corrispondono grosso modo alle domande poste dal vo-
lume curato da Holtus/Radtke (1985), che meglio rappresenta questa
fase di studi:
˗ esiste una accentuata dicotomia tra italiano parlato e italiano scritto?
˗ il parlato italiano ha una grammatica diversa dalla lingua della tradizione
letteraria?
˗ quali elementi categoriali condivide l’italiano parlato con le altre lingue?
˗ quale contributo possono dare la linguistica testuale e l’analisi della con-
versazione allo studio della lingua italiana parlata?
I primi due punti richiamano il dibattito sul francese, il terzo insiste
sui tratti universali del parlato, mentre il quarto s’interroga sull’apporto
delle discipline emergenti.
È opportuno ricordare, prima di approfondire altri aspetti, che la
diamesia è nata in Italia. Di solito se ne spiega la genesi in rapporto alla
peculiare storia dell’italiano, nella quale lo standard si è identificato per
secoli con la lingua scritta, codificata dalle grammatiche, e il parlato
con i dialetti. Solo dopo un lungo e faticoso processo, di cui l’italiano
popolare avrebbe rappresentato uno snodo cruciale, si è giunti a una
lingua d’uso comune, tanto nelle realizzazioni parlate quanto in quelle
scritte5. In realtà la vulgata non tiene conto della forte influenza che i
2 Lo studio di Sornicola (1981) prendeva le mosse da un’indagine sulla “standardizzazio-
ne dell’italiano a Napoli” per approdare all’“organizzazione testuale degli enunciati orali”. 3 Per un inquadramento del dibattito sul francese, si veda la ricostruzione di Fusco (2000).
Fanno riferimento alla situazione francese: Lepschy (1983), Bruni (1984: 206), Holtus (1984:
7), Sabatini (1985: 174) e Sornicola (1985). Per lo studio in diacronia dei fenomeni del parla-
to, cfr. D’Achille (1990). 4 Si vedano Nencioni (1976), Sabatini (1980, 1985), Berretta (1985) e Berruto (1985). 5 Cfr. Trumper/Maddalon (1982: 18); per Lorenzetti (2002: 22) la diamesia è una «dimen-
sione particolarmente necessaria in una situazione linguistica come quella italiana»; Beccaria
Diamesia: la nascita di una dimensione 29
modelli di analisi di matrice europea e angloamericana hanno esercitato
sulle questioni nazionali6. Il risultato è senza dubbio peculiare, ma i pre-
supposti della diamesia sono più complessi, tali da spiegarne pregi e li-
miti. Inoltre, il concetto di diamesia come dimensione di variazione si è
affermato quando le caratteristiche dell’italiano popolare erano già state
definite, mentre gli studi sul parlato erano ai primordi, in particolare
quelli sui fatti prosodico-intonativi7: la sua definizione risulta perciò
condizionata dall’impostazione del dibattito su una varietà, l’italiano
popolare, che pone molti problemi definitori dal punto di vista mediale,
più che da una disamina approfondita del parlato in sé8.
L’interesse per questa fase di studi risiede, a mio avviso, nelle di-
verse nozioni di scritto e parlato, talvolta sottintese o teoricamente
presupposte come costellazione di riferimento, che sono confluite nei
due poli del continuum diamesico. Le obiezioni che allora furono for-
mulate sulla sua inclusione nello schema variazionale hanno trovato
una conferma nelle rivisitazioni dell’architettura dell’italiano contem-
poraneo (per es. Berruto/Cerruti 2014) e nella tendenza, oggi preva-
lente, all’assorbimento della diamesia nella diafasia9. Rispetto alle
proposte avanzate allora, è rilevante il fatto che gli studi odierni, so-
prattutto quelli relativi alla CMC (Computer-Mediated Communica-
tion), ripropongano, pur rivisitati, due modelli già presenti nel dibatti-
to di quegli anni: quello funzionale, riconducibile a Halliday, e quello
(2004, s.v. ‘diamesia’) osserva: «specialmente nella tradizione linguistica italiana è sempre
esistita una profonda separazione tra il livello della scrittura e il livello dell’oralità, tanto che
in taluni l’uso dell’uno e dell’altro mezzo era sufficiente a selezionare un codice linguistico
diverso (per es. italiano letterario per la scrittura, dialetto locale per l’oralità), comportando
pertanto non soltanto variazione, ma addirittura bilinguismo». Su questo punto, si vedano an-
che Coveri/Benucci/Diadori (1998: 229-32) e Rossi (2011). 6 Si vedano l’antologia curata da Giglioli (1972) e la ricostruzione di Mioni (1975). 7 È significativa l’assenza di questa prospettiva in Holtus/Radtke (1985). Un’eccezione
nel panorama di quegli anni fu il Seminario sull’italiano parlato, svoltosi presso il Centro di
Studi di grammatica italiana dell’Accademia della Crusca (Seminario 1977). Sulla nascita del
Centro, cfr. Cresti (2008). 8 L’osservazione è in D’Achille (2010), al quale si rinvia per la ricostruzione del dibattito
sull’italiano popolare. Per una valutazione complessiva di questa varietà, delle sue definizioni
e contraddizioni, si vedano almeno Lepschy (1983) e Bruni (1984: 205-27). Nencioni (1976:
2) parlava di “azione equivocante” che, a partire dalla peculiare situazione linguistica italiana,
aveva attratto gli studiosi sul “tema dell’italiano popolare”. 9 La linea che, fedele a Coseriu, riconduce alla diafasia le differenze mediali è ben rappre-
sentata: cfr. Albrecht (1986) e le rassegne di Koch/Oesterreicher (2001: 605) e Hans-Bianchi
(2005: 47). Sul rapporto tra studi sul parlato e diamesia si possono vedere: Lepschy/Lepschy
(1992), Radtke (1992), Voghera (1992: 62-69), Berretta (1994), Albano Leoni (2005), Hans-
Bianchi (2005: 42-57).
Elena Pistolesi 30
di Söll (1980), attinto direttamente o attraverso la rielaborazione di
Koch/Oesterreicher (1985, 1990, 2001)10
.
1. Dall’opposizione al continuum
Nell’ambito della discussione sulle varietà dell’italiano, l’articolo di
Mioni (1983: 508) introduceva come segue la dimensione diamesica:
Il diverso grado di standardizzazione degli italiani è connesso con tutte le di-
mensioni della variabilità linguistica: (…) differenze del m e z z o via via
usato per comunicare (per le quali si potrebbe usare il neologismo di ‘dimen-
sione d i a m e s i c a’). Queste ultime non consistono in una pura e semplice
opposizione polare tra scritto e orale, ma in un continuum di gradini interme-
di: il più interessante contributo in merito (Gregory 1967) tratta di tale varietà
di situazioni, facendo osservare che vi sono, ad es., testi scritti, testi scritti per
la sola lettura e cioè per non essere letti ad alta voce, ecc.
Oltre al contributo di Gregory, cui viene dato particolare rilievo,
sono citati a sostegno della nuova dimensione i lavori di De Mauro
(1970) e di Nencioni (1976).
Michael Gregory (1967: 189) articola la categoria contestuale del
MODO in sottocategorie che consentono di porre in relazione le caratte-
ristiche linguistiche con quelle situazionali11
. Il risultato è un dia-
gramma che presenta le possibili intersezioni fra scritto e parlato, ma
esso non è definibile in termini di continuum, come si evince dalla
struttura ad albero adottata. Il parlato è distinto in spontaneo e non
spontaneo; il parlato spontaneo in conversazionale e monologico. Il
parlato spontaneo, non riconducibile a marcatori indicali (indexical
markers) specifici, è caratterizzato dai segnali di familiarità (intimacy
signals), dai riempitivi (silence fillers), dal ruolo dell’intonazione nel
definire la “grammatical unit sentence”, da una grammatica “incom-
pleta” dei turni, ecc. L’aumento di forme deittiche senza un referente
intra-testuale è considerato un indicatore significativo per distinguere
la conversazione dal monologo, il quale si presenta, nel complesso,
meno dipendente dalla situazione extralinguistica, più coeso e sintatti-
10 Nel 1992 usciva in Italia la traduzione di M.A. K. Halliday, Spoken and Written Lan-
guage (1985). Il modello di Söll (1980) è adottato, con integrazioni, da Berruto (2005). 11 Per Gregory il termine mode è preferibile a medium perché consente distinzioni puntua-
li e più complesse rispetto a quella limitata al mezzo (medium).
Diamesia: la nascita di una dimensione 31
camente più complesso in quanto più pianificato rispetto al dialogo
spontaneo.
Il parlato non spontaneo si divide in recitazione (raccontare storie,
recitare poesie e altri testi propri della tradizione orale) e in «speaking
of what is written» (“oralizzazione dello scritto”)12
. Su questa sottoca-
tegoria s’innesta l’intersezione con forme diverse di scrittura: esse non
sono articolate in base a specifiche caratteristiche linguistico-testuali,
ma fanno riferimento a una gamma di possibili rese orali, che vanno
dallo “scritto per essere detto come se scritto non fosse”13
, fino alle
indicazioni di lettura contenute nei testi (“disse con gentilezza”, ecc.).
L’idea è che la relazione scritto/parlato si possa rappresentare in ter-
mini di gradi di orientamento dello scritto verso la sua possibile resa
orale. Questo non significa, precisa Gregory (1976: 191), che la scrit-
tura derivi dal parlato, ma indica piuttosto che nella società contempo-
ranea tutto ciò che è scritto può essere detto, perciò non è sempre pos-
sibile distinguere nettamente tra le due modalità.
Rispetto alle varietà legate alle categorie del CAMPO (inglese tecni-
co e non tecnico) e del TENORE (inglese formale e informale), le quali
afferirebbero alla diafasia nel modello coseriano, quelle legate al MO-
DO sono presentate come indipendenti (Gregory 1967: 185), tali cioè
da ispirare una dimensione autonoma, quale emerge dalla proposta di
Mioni.
L’idea del continuum è invece presente in De Mauro (1970)14
, ma
prescinde dalla (ovvia) differenza fisica di produzione del segno e dal-
le nozioni di lingua scritta e lingua parlata, che non delimitano concet-
ti ben definiti dal punto di vista formale. A tale dicotomia se ne sosti-
tuisce una diversa, costituita dai poli della formalità e dell’informalità,
così definiti: «l’insieme dei procedimenti di produzione e realizzazione
12 Il modello di Gregory (1976), riproposto in Gregory/Carroll (1978), è stato ripreso da
Lavinio (1986; 1990) e integrato con la terminologia di Nencioni (1976). Lavinio traduce
questa categoria con “oralizzazione dello scritto (letto ad alta voce)” e gli altri termini relativi
alla scrittura nel modo seguente: «to be spoken as if not written» (“per essere detto come se
non fosse scritto [parlato-recitando]”, «to be spoken» (“per essere detto”), «not necessarily to
be spoken» (“non necessariamente per essere detto”). 13 Sono i testi che simulano il parlato spontaneo, come quelli teatrali, i testi da recitare in
TV o alla radio, i discorsi dei politici, ecc. 14 Il contributo fu presentato al convegno Lingua parlata e lingua scritta (Palermo, 9-11
novembre 1967), i cui atti furono pubblicati nel 1970. L’intero volume presenta un notevole
interesse, in particolare la corposa introduzione di A. Pagliaro e l’articolo, inserito in un se-
condo momento, di Giulio C. Lepschy.
Elena Pistolesi 32
formale dei segni costituisce, per una data lingua, la norma formale, di-
stinta, attraverso gradazioni successive, dalla norma informale»15
.
Alcuni anni dopo, anche Giovanni Nencioni (1976) integrava la pro-
spettiva linguistica con quella semiotica16
per superare l’opposizione fra
scritto e parlato, riduttiva rispetto alle possibilità intermedie, quali il
parlato riferito o il parlato scritto per la recitazione17
.
Tavola 1. Parlato-parlato e parlato-recitato
18
PARLATO-PARLATO
PARLATO-RECITATO
presenza fisica dei parlanti e
percezione immediata della voce
naturale, integrata da fattori
paralinguistici e cinesici
+
situazione: referenziale e mal
determinabile
- referenziale, non descritta ma
presentata, inclusa nel testo, oltre il
quale non si può risalire
spontaneità: le scelte stilistiche del
parlante muovono dal livello
prelessicale (la risposta dell’allocu-
tario non è prevedibile)
- le scelte stilistiche dell’attore
muovono da un testo già costituito
(la risposta dell’allocutario è già
scritta)
interlocutori: dialogo ricco di
informazione e di valori illocutivi
- dialogo povero di informazione e
di valori illocutivi
riceventi tangenziali: informazione e
effetti perlocutivi scarsi
- gli spettatori (unici destinatari)
pretendono informazioni e una non
meno complessa efficacia perlocu-
tiva
espressività: rivelatrice del tempera-
mento del parlante
- solo indiretta, gestita dall’attore
15 Mio il corsivo. 16 Vale la pena di ricordare che Nencioni (1976: 30) considera «una momentanea aporia
della linguistica» la scissione teorica tra «analisi linguistica e analisi semiotica, fra analisi fra-
sale e analisi testuale». 17 Nencioni osservava (1976: 30): «Discutibile mi appare anche una netta separazione tra
lingua parlata e lingua scritta, le cui rispettive gradazioni e le interferenze reciproche sono, oltre
che istituzionali, promosse dal sempre più largo moto di partecipazione sociale alla cultura». 18 La tabella è elaborata a partire da Nencioni (1976: 51). Il segno + indica la condivisio-
ne dei parametri, quello – la gradazione o assenza delle caratteristiche descritte.
Diamesia: la nascita di una dimensione 33
L’analisi di Nencioni, che esclude le prospettive antropologica e
sociolinguistica19
, si concentra sui fatti legati alla spontaneità e ai va-
lori illocutivi del messaggio. Dell’articolo, che mira a una teoria unita-
ria dell’enunciazione, interessa qui la definizione di parlato-parlato
che emerge in forma esplicita dal confronto con il parlato-recitato
(Tav. 1). Nencioni ritiene infatti che le composizioni teatrali, una volta
definite le loro peculiarità, possano essere utili per la conoscenza delle
strutture del parlato in sé.
I lavori di Gregory, De Mauro e Nencioni ̶ spesso menzionati co-
me punti di riferimento per la definizione di un continuum sociolin-
guistico ̶ svolgono considerazioni che difficilmente possono essere
integrate nella proposta diamesica. L’articolo di Gregory, come ab-
biamo visto, non contiene propriamente l’idea di un continuum20
;
quello di De Mauro adotta parametri di tipo semiotico e situazionale,
approdando a una definizione di formalità/informalità che avrebbe po-
tuto orientare verso l’inclusione, problematizzata, della diamesia nella
diafasia. Per Nencioni il confronto con lo scritto è senz’altro utile, ma
se si vogliono «determinare i fenomeni salienti e costanti del parlato è
indispensabile il confronto intraspecifico tra i vari tipi di parlato», che
nel saggio sono individuati nel parlato in situazione e nel parlato-
recitato. Nella sua analisi il determinato resta sempre lo stesso (parla-
to), vincolato al canale e al contesto dell’interazione, mentre il deter-
minante (parlato, recitato, scritto) fa riferimento alla divaricazione o
alla gradazione rispetto ai valori illocutivi e agli altri parametri evi-
denziati in rapporto al dialogo teatrale (Tav. 1). Il discrimine principa-
le fra i diversi tipi di parlato riguarda la spontaneità, richiamata in più
occasioni come caratteristica propria del parlato-parlato, senza che
questo si traduca in tratti o prefiguri una varietà, prospettiva che il
saggio programmaticamente esclude. L’articolo contiene indizi che
potrebbero condurre a una definizione dello scritto-scritto, etichetta
mai usata dallo studioso21
, ma il suo interesse si focalizza sull’oralità.
Una conferma si ottiene dal confronto con il modello di Gregory, il
19 Nencioni diceva chiaramente di volersi concentrare sulle strutture dell’italiano, “non
dell’italiano popolare” (1976: 3). 20 Sul carattere “hétéroclite” del modello di Gregory rispetto alla proposta di Mioni, si ve-
da Wüest (1999: 147). Con Lavinio (1995: 32) si può osservare, a discapito della nozione di
continuum, che lo schema di Gregory è asimmetrico in quanto «orientato sul versante (e sulle
modalità) della produzione per il parlato e, viceversa, su quello della ricezione per lo scritto». 21 Per esempio, Sobrero/Miglietta (2006: 114) e Prada (2003b: 137) sembrano attribuire a
Nencioni la definizione di un polo scritto-scritto opposto a quello parlato-parlato.
Elena Pistolesi 34
quale classifica il teatro a partire dalla scrittura, definendo «writing to
be spoken as if not written» ciò che per Nencioni è parlato-recitato
(non “scritto-recitato”).
2. La diamesia come dimensione di variazione
Mioni si chiedeva quale posizione occupasse la dimensione diame-
sica nello studio dell’italiano popolare, ponendo in rilievo da un lato il
problema delle fonti, prevalentemente scritte o trascritte22
, dall’altro la
mancanza di categorie di analisi, a partire da uno standard orale di ri-
ferimento. Il passaggio più interessante per intendere il rapporto, qui
appena abbozzato, della diamesia con le altre dimensioni di variazione
fa riferimento ai vari ‘italiani popolari’, che si differenziano dallo
standard non solo «per fatti fonologico-ortografici o morfosintattici o
lessicali, ma anche per fatti ‘diamesici’ e ‘diafasici’». Dopo aver ri-
cordato che l’italiano popolare è spesso “a una sola dimensione” (con
rinvio a Mioni 1975), osserva:
Le classi sociali meno favorite si avvicinano ormai ad un possesso ragionevo-
le dell’italiano sotto la dimensione ‘diamesica’ orale, anche se forse non rie-
scono nemmeno in questa a fornire una varietà ‘diafasica’ soddisfacente. Ma
quando passano allo scritto, non riescono sempre a rispettare lo specifico
‘diamesico’ e vi trasferiscono usi ammissibili solo nell’orale; inoltre la ‘dia-
fasia’ che essi usano nello scritto è assai insicura e produce effetti ancor più
comici e discriminatori che non le violazioni ‘diamesiche’. A ciò si deve ag-
giungere la cattiva organizzazione dei testi, dovuta anch’essa alla scarsa di-
mestichezza con le esigenze dello scritto (Mioni 1983: 511).
Non è chiaro che cosa significhi, senza uno standard di riferimento,
avere un “possesso ragionevole” nel parlato ma “insoddisfacente” in
diafasia. Nel caso della scrittura il rinvio agli “usi ammissibili solo
nell’orale” è individuato in una serie di fenomeni, in parte presenti an-
che nelle produzioni orali delle classi borghesi23
.
22 Il problema delle fonti scritte per lo studio di un fenomeno prevalentemente orale, sol-
levato da Holtus (1984), è alla base della proposta dell’“italiano dei semicolti”, con riferimen-
to specifico alla scrittura, per il quale si rinvia a Bruni (1984, 20072) e a D’Achille (1994). 23 Tali fenomeni sono: l’ipercorrettismo, la scomparsa o l’uso ridotto del congiuntivo, che
usato come indicatore generico di subordinazione, la semplificazione flessionale, le frasi scis-
se e pseudoscisse, gli anacoluti, l’andamento paratattico e, in generale, la gestione della te-
stualità. In proposito Mioni cita il lavoro di Sabatini (1980), che aveva introdotto il concetto
di “lingua media” dell’uso informale borghese con riferimento sia al parlato (film non regio-
Diamesia: la nascita di una dimensione 35
Mioni insiste sul fatto che le due dimensioni più rilevanti per lo stu-
dio dell’italiano popolare, considerate solitamente un tutt’uno (forma-
le/scritto e informale/parlato), debbano essere separate e, dopo un ri-
chiamo ai lavori dei precursori (cfr. § 1), ricorda che la loro sovrapposi-
zione vale solo per i casi più semplici, da graduare anche lungo l’asse
diafasico.
Una volta affermata l’opportunità di considerare separatamente la
relazione scritto-orale dalla diafasia, emerge quanto sia difficile defi-
nire la prima senza ricorrere alla seconda. Di fatto, come nota Voghera
(1992: 38-9), non esiste una varietà che si possa caratterizzare solo dal
punto di vista mediale, indipendentemente dalle altre. Il paradosso
della proposta risiede nel fatto che la distinzione tra diafasia e diame-
sia viene elaborata a partire dalla discussione sull’italiano popolare,
nel quale tali differenze si annullano24
. L’esistenza di una varietà “a
una sola dimensione” dipende, ovviamente, dalle fonti cui si attinge e
dalla definizione che si dà dei poli diamesici, consistente a questa al-
tezza in una serie di tratti linguistico-testuali che non parrebbero
esclusivi del parlato delle classi popolari, ma tipici delle loro produ-
zioni scritte.
2.1. Intrecci di varietà
Il primo lavoro che riconosce alla dicotomia “uso scrittuale” / “uso
orale” un peso imprescindibile nella definizione del repertorio italiano è
quello di Trumper/Maddalon (1982: 18-24)25
. Ne deriva uno schema
delle varietà in cui l’uso scrittuale (X) e l’uso orale (Y) sono attraversati
dalle altre dimensioni di variazione. Si ottiene così la seguente classifi-
cazione, in cui A indica l’area dell’italiano e B quella del dialetto:
nalistico o espressivo) sia allo scritto (romanzo moderno non neorealistico e cronaca giornali-
stica non tecnica). 24 D’Achille (1994: 41) osserva che la lingua dei semicolti resta «tendenzialmente indipen-
dente rispetto alla dicotomia scritto-parlato», perché presenta annullati o quanto meno ridotti gli
effetti della variabile diamesica. L’italiano popolare è stato descritto prevalentemente sulla sulla
base di fonti scritte ed è grazie ad esse che se ne è enfatizzato il carattere “unitario”. 25 Gli autori rilevano che, se si escludono i lavori di Ferguson (1959) o Wexler (1971),
negli studi sulla diglossia il tema non è affrontato in modo esaustivo. Rinviano a Gregory
(1967) e a Nencioni (1979) per un approccio più articolato al tema.
Elena Pistolesi 36
Uso scrittuale (X):
(A) (1) italiano standard (diafasia) [letteratura, uso burocratico], (2) italiano sub-
standard (± diatopia, diafasia) [± regionale: stile giornalistico, ecc.]; (3) italiano
interferito substandard (+ diatopia, + diastratia [+ regionale];
(B) dialetto letterario (diatopia, diafasia) [basato su una koinè].
Uso orale (Y):
(A) (1) italiano regionale formale (diatopia, diastratia) [appropriato a situazioni
particolari]; (2) italiano regionale informale (diatopia, diastratia, diafasia) [usi
colloquiali]; (3) italiano regionale trascurato, fortemente interferito (diatopia,
diastratia);
(B) (1) dialetto koinè (diatopia, diastratia, diafasia) [± italianizzato]; (2) dialetto
urbano (diatopia, diastratia, diafasia) [± italianizzato]; (3) patois locali (diatopia)
[- italianizzati].
Solo per l’uso scrittuale si può parlare di uno standard, legato alla
scolarizzazione (si tratta della sola varietà priva di tratti diatopici),
mentre nell’orale si possono trovare al massimo italiani regionali for-
mali, già differenziati in diastratia, dimensione onnipresente nell’uso
orale, che nella scrittura interviene solo nell’italiano interferito sub-
standard. Quest’ultimo, insieme alla varietà 3 dell’uso orale (it. regio-
nale trascurato), non differenziandosi in diafasia, non solo è prossimo
all’italiano a una sola dimensione di cui parla Mioni per l’italiano po-
polare, ma prefigura anche l’italiano dei semicolti. In merito alla con-
tinuità dei livelli, avremo in A, sia per lo scritto che per l’orale, una
continuità di stile in diafasia, mentre nei gradi inferiori - e più in gene-
rale in tutto l’ambito Y -, avremo «funzioni del rapporto diglossico in
genere, cioè il tipo di rapporto continuo e non discreto tra questi codi-
ci nella realtà linguistica italiana dipenderà dal tipo di diglossia che
vige in determinate situazioni» (ivi, p. 21).
Sull’italiano popolare era intervenuto anche Günter Holtus
(1984)26
, ricordando che il rapporto di questa varietà con lo standard
riguarda lo spazio variazionale, da collocare perciò su un piano diver-
so rispetto a quello tra scritto e parlato, il quale non è riducibile a nes-
sun polo delle altre dimensioni (per es., non vale l’equazione lingua
parlata = dialetto). Holtus riprende, con una piccola deviazione termi-
nologica, lo schema di Söll (1980) per fissare i caratteri generali della
lingua parlata, da intendersi come universali dipendenti dalla situazio-
ne comunicativa, ai quali ricondurre i tratti che possono avere maggio-
26 Il convegno nel quale Holtus svolse le considerazioni qui riportate è del 1981.
Diamesia: la nascita di una dimensione 37
re o minore incidenza nelle diverse lingue. A partire da qui, osserva
che solo in francese le differenze tra la lingua parlata e quella scritta
riguardano il sistema e non la norma, come accade invece per
l’italiano e per lo spagnolo. Il problema posto da Holtus è quello di
dare una definizione rigorosa delle differenze mediali, evitando la
confusione tra canale e fenomeni variazionali collegati o prevalente-
mente associati ad esso.
La proposta di Söll ritorna, in forma più articolata, nel modello di
Koch/Oesterreicher (1985, 1990, 2001). Secondo Koch/Oesterreicher,
perdendo di vista la distinzione tra aspetto mediale (fonico/grafico) e
concezionale (vicinanza/distanza comunicativa), si confondono i fe-
nomeni diafasici con i parametri determinati dalle condizioni comuni-
cative generali. Qual è la relazione tra le dimensioni di variazione ca-
noniche e i parametri universali della vicinanza e della distanza comu-
nicativa? Secondo questo modello è il continuum concezionale a de-
terminare l’organizzazione di tutto lo spazio di variazione: le marche
diafasiche (formale, informale ecc.), diatopiche (dialettale, regionale
ecc.) si applicano solo quando una comunità decide di riservare uno
specifico uso linguistico al dominio dell’immediatezza o a quello della
distanza. Su tale presupposto si traccia uno schema che rappresenta il
rapporto del continuum concezionale con le altre dimensioni di varia-
zione (2001: 605-6). Immediatezza e distanza si articolano su due li-
velli: un piano universale (1a), comune a tutte le lingue, e un piano
che riguarda le lingue storiche (1b), al quale si ascrivono i fenomeni
non riducibili alle altre marche diasistematiche. Come già aveva sotto-
lineato Holtus, la couche (1b) può avere un peso diverso nelle lingue
romanze: in francese è rilevante (in tal senso torna la questione del di-
battito sul francese contemporaneo), in spagnolo è neutralizzata, men-
tre in italiano, portoghese e rumeno assume un valore intermedio.
Ho richiamato per sommi capi il modello perché fu elaborato, nelle
sue linee generali, negli stessi anni in cui si affermava la diamesia
come dimensione di variazione27
. Esso nasce dall’esigenza di definire
27 Sulla diamesia Koch (1990: 143 n. 3) osserva: «Der von Mioni (1983, 508) eingeführte
und in der italienischen und italienistischen Forschung verbreitete Terminus ‘diamesisch’ ist
insofern, wiewohl aus Gründen der terminologischen Symmetrie recht praktisch, nicht sehr
glücklich, weil er auf das Medium (agr. μέσoν entsprechend lat. medium) abhebt». La critica
si limita alla scelta terminologica.
Elena Pistolesi 38
in modo rigoroso le differenze mediali, scopo raggiunto scindendo il
codice (grafico e fonico) dalle condizioni comunicative universali28
.
Koch partecipò al seminario i cui atti furono pubblicati nel volume
di Holtus/Radtke (1985)29
, già ricordato all’inizio di questo lavoro. La
raccolta contiene interventi che hanno decisamente orientato gli studi
sull’italiano per oltre un trentennio, in particolare quelli di Francesco
Sabatini e di Gaetano Berruto. Sabatini presentava “l’italiano dell’uso
medio parlato e scritto” o “italiano dell’uso medio”, definito da 35
tratti, collocabili a diversi livelli di analisi, ricorrenti in situazione di
informalità e di media formalità, e persistenti in diacronia. Tali tratti
sono panitaliani, usati da persone di ogni ceto e di ogni livello di istru-
zione; formano un sistema nel senso che cooccorrono nello stesso tipo
di discorso; si trovano anche nei testi scritti non formali, oltre che
nell’orale non pianificato. Dopo aver passato in rassegna i diversi mo-
delli del repertorio, Sabatini si soffermava sulla modalità, invitando «a
distinguere tra fatti generalmente pertinenti alla comunicazione parlata
(variabili diamesiche e diafasiche) e fatti propriamente di natura socio-
culturale e geo-culturale (variabili diastratiche e diatopiche) e a valuta-
re debitamente anche il processo storico di affermazione della “nor-
ma”». Lo schema proposto, alternativo ai precedenti, è così articolato
(1985: 176):
Aspetti
Diatopici
Varietà Aspetti diamesici Aspetti diafasici
Varietà
nazionali
1. italiano standard scritto e parlato-
scritto
formale
2. italiano dell’uso me-
dio
parlato e scritto mediamente
formale
e informale
Varietà
regionali
e locali
3. italiano regionale
delle classi istruite
parlato informale
4. italiano regionale
delle classi popolari
(“it. popolare”)
parlato e scritto informale
28 I dubbi su questo modello si concentrano sulla separazione tra parametri situazionali e
canale (grafico o fonico), considerati come fattori indipendenti (cfr. Hans-Bianchi 2005: 53-
7). Su questo punto, si veda anche Voghera (1994: 142-3). 29 Il volume nasce dalla sezione del convegno dei romanisti tedeschi Italiano parlato nel
passato e nel presente (Berlino, 5-8 ottobre 1983).
Diamesia: la nascita di una dimensione 39
5. dialetto regionale o
provinciale
parlato informale
6. dialetto locale parlato informale
Le indicazioni dell’ultima colonna si riferiscono solo alle classi
istruite perché i primi tre livelli non fanno parte del repertorio delle
classi popolari, mentre quelli che vanno da 4 a 6 presentano un «uso
unificato, con informalità più accentuata per il dialetto». Le varietà 3-
6 sono solo parlate, con l’eccezione dell’italiano popolare, la quale si
spiega, pur nella sua evidente incoerenza rispetto alla continuità dei
piani, come omaggio al contemporaneo dibattito sulle fonti di questa
varietà. Anche l’idea di un uso unificato (4-6) pare riduttiva se consi-
derata dal punto di vista del parlante/scrivente incolto, il quale «sotto
la spinta di comunicare e senza addestramento, maneggia quella che
ottimisticamente si chiama la lingua ‘nazionale’, l’italiano» (De Mau-
ro 1970: 49).
2.2. La diamesia in Gaetano Berruto
Il contributo di Berruto, «Per una caratterizzazione del parlato:
l’italiano parlato ha un’altra grammatica?» interessa, al di là della
questione teorica posta nel titolo, che ha una risposta negativa30
, per la
terminologia e per le accezioni di parlato che adotta. L’analisi si muo-
ve tra i caratteri universali del parlato e la “gamma di varietà”
dell’italiano parlato e scritto, i cui punti di riferimento sono il parlato-
parlato di Nencioni e lo standard, inteso come “italiano descritto nelle
grammatiche” o “standard scritto”. Già a questo livello si osservano
alcune aporie, perché, come abbiamo visto, la definizione di parlato-
parlato fa riferimento a parametri generali di tipo pragmatico-
situazionale difficilmente riducibili a un continuum correlabile
all’italiano della norma.
In più occasioni Berruto ricorre al termine “varietà” per definire il
ventaglio di possibili realizzazioni scritte e orali, che estende anche al-
30 Nello stesso volume anche Monica Berretta si chiede come «questa (eventuale) gram-
matica si caratterizzi rispetto alla grammatica dello standard(-scritto) da una parte, e
dell’italiano popolare dall’altra» (1985: 185). Il suo intervento conferma il peso che l’italiano
popolare ha nella discussione, anche se la studiosa ritiene utile postulare un “italiano parlato
senza aggettivi” come livello di idealizzazione fecondo per la ricerca linguistica. Si vedano su
questo punto Nencioni (1976: 3) e Sornicola (1982).
Elena Pistolesi 40
la ‘lingua trasmessa’ (Sabatini 1982), detta “gamma intermedia di va-
rietà”31
. Che la diamesia sia assunta come dimensione di variazione è
confermato dai riferimenti a Mioni32 e dalla formulazione della do-
manda: «come si interseca la variazione scritto/parlato con la varia-
zione sociale e con quella diafasica?» (p. 139). Nella risposta, provvi-
soria, che intreccia le dimensioni di variazione con la fenomenologia
del parlato per discriminare tra ciò che è universale e ciò che invece
dipende dai fattori socio-situazionali, si intravede la soluzione presen-
tata due anni dopo.
Il consolidamento della diamesia avverrà infatti nella proposta del
1987, adottata dalla comunità scientifica italiana e riprodotta nei ma-
nuali senza prestare troppa attenzione alle cautele espresse da Berruto
(1987: 22):
Il riconoscimento dell’autonomia della dimensione diamesica non è del tutto
chiarito in sede teorica. Indubbiamente, uso scritto e uso parlato rappresenta-
no due grandi classi di situazioni d’impiego della lingua: e questo è un buon
argomento per ritenere la diamesìa una sottocategoria della diafasìa. D’altra
parte, è anche vero che l’opposizione scritto-parlato taglia trasversalmente la
diafasìa e le altre dimensioni, e non è riconducibile completamente
all’opposizione formale-informale33
.
La dimensione diamesica si estende qui dal polo dello ‘scritto scrit-
to’ al polo del ‘parlato parlato’ (Nencioni 1976), mentre per la diafasia
si rinvia a De Mauro (1970). Nella relativa nota (1987: 22 n. 12) si
specifica che, pur coincidendo di solito un registro molto formale con
l’uso scritto e viceversa, esistono anche situazioni in cui il parlato può
essere più formale dello scritto. Si richiama poi il discrimine «fra uso
orale o grafico (caratteri dipendenti dalla natura del mezzo) e codice
parlato e scritto (caratteri dipendenti dalla pianificazione, formalità
ecc.)»34
. Riprendendo quanto già rilevato da Sabatini (1985), Berruto
sottolinea che la
differenziazione diafasica (e, se vogliamo, quella diamesica, accogliendo il
felice suggerimento di Mioni 1983: 508) deve essere tenuta separata, pro-
31 Berruto (1985: 122 n. 3). 32 Ibid. e p. 153. 33 Mio il corsivo. 34 Il richiamo a diversi modelli conferma quanto sia difficile dare una definizione di scrit-
to e parlato da convogliare nello schema variazionale.
Diamesia: la nascita di una dimensione 41
grammaticamente, da quella socio-geografica, in quanto concerne il singolo
individuo parlante e taglia le dimensioni geografica e sociale: ogni varietà so-
cio-geografica ha la sua propria variazione diafasica, in linea di principio35
.
Tornando alcuni anni dopo sulla diamesia, Berruto (20039: 38) di-
stingue tra il canale e la situazione comunicativa da un lato, e le rea-
lizzazioni concrete riconducibili alla dimensione diafasica dall’altro:
La differenziazione fra parlato e scritto, pur realizzandosi in concrete condi-
zioni d’uso, è infatti preliminare e indipendente rispetto all’utente (e allo stra-
to sociale di appartenenza) e alla stessa diafasia, in quanto almeno per una
certa parte è determinata dalle caratteristiche generali del canale di comuni-
cazione e dalle circostanze ambientali di attuazione della comunicazione. Pe-
rò, nella realizzazione effettiva viene poi assorbita dalla variazione diafasica
e dai tipi di testi relativi. Ciò rende particolarmente difficile sceverare, in
molti casi, quello che è proprio del parlato e quello che è invece proprio delle
varietà che si servono della modalità parlata e del canale fonico-acustico36
.
La definizione dei poli si precisa in rapporto al canale in Berruto
(2004: 92), dove l’asse della diamesia
va dal polo di sinistra, tipicamente ‘scritto’ (le varietà in cui più nettamente si
manifestano le caratteristiche imposte dal, e correlate al, canale visivo-
grafico), al polo di destra, tipicamente ‘parlato’ (le varietà in cui più netta-
mente sono presenti le caratteristiche imposte dal, e correlate al, canale foni-
co-acustico).
Berruto ribadisce che «le due dimensioni della diafasia e della dia-
mesia sono di fatto inscindibili» (ivi, p. 93). In merito alla dimensione
diafasica osserva infatti:
All’interno della dimensione diafasica si situa tuttavia un’importante altra
sottodimensione di variazione, che per certi aspetti trascende di fatto l’ambito
della stessa diafasia, anche se fondamentalmente il fattore principale che cor-
rela con essa sta nella situazione comunicativa, e per la precisione nel mezzo
o canale ‘fisico’ attraverso cui passa la comunicazione verbale. Si tratta della
differenziazione fra uso parlato e uso scritto della lingua, dipendente per mol-
ti aspetti dalle caratteristiche strutturali e di realizzazione che il mezzo o ca-
nale impone alla codificazione del messaggio linguistico; spesso ci si riferi-
sce a questo genere di variazione, che a rigore si situerebbe all’interno della
35 Il passo (1987: 19) viene riproposto in Berruto (2012: 22), ma senza l’aggettivo “felice”. 36 Mio il corsivo.
Elena Pistolesi 42
dimensione diafasica, come a una quarta dimensione fondamentale di varia-
zione, la ‘variazione diamesica’37
.
Ho evidenziato il verbo “impone” nelle diverse occorrenze perché
si riferisce al vincolo del canale, e “a rigore” perché il suo significato
non è affatto chiaro, dal momento che il saggio, nonostante i dubbi
che esprime, ripropone lo schema presentato nel 1987.
I problemi di definizione dei poli diamesici si riversano sul concet-
to di continuum da essi dipendente. Quale tipo di asse è quello diame-
sico? Fin dalla proposta di Mioni, permane il dubbio su ciò che può
essere considerato in funzione di un continuum, quanto meno in rela-
zione alle fonti citate (Gregory, De Mauro e Nencioni). Poiché il re-
pertorio nel suo complesso, ancor prima delle singole dimensioni di
variazione, è definito come continuum pluridimensionale con adden-
samenti, anche la diamesia, una volta inserita in tale contesto, dovrà
presentare caratteri adeguati. Il continuum diamesico non è orientato,
perché le varietà non si dispongono da un estremo sociolinguisticamen-
te ‘alto’ a uno ‘basso’; né polarizzato, allo stesso modo in cui lo sono
quello diafasico o diastratico38
.
Le osservazioni di Berruto mostrano l’evoluzione di un dubbio che
prelude alla revisione dello schema (2011), nel quale le varietà diame-
siche sono considerate (ma l’affermazione era già presente nelle ver-
sioni precedenti) trasversali rispetto alle altre distinzioni: in luogo del-
la diamesia, l’asse orizzontale rappresenta gli italiani regionali, mentre
i poli diafasici includono quelli diamesici, estendendosi dall’italiano
scritto formale all’italiano parlato informale. Nella prima elaborazione
dell’architettura dell’italiano contemporaneo, la dimensione non rap-
presentata era quella diatopica, considerata il prius dell’intero impian-
to, poi inserita dal 2011, in luogo di quella diamesica, sotto forma di
asse non orientato e non polarizzato degli italiani regionali.
Abbiamo visto come l’inserimento della diamesia nello spazio va-
riazionale comporti, fin dalla sua nascita, notevoli problemi definitori,
in particolare rispetto alla diafasia. I dubbi non riguardano tanto le dif-
ferenze tra scritto e parlato, se debitamente definite, quanto la loro tra-
37 Ivi, pp. 85-6. Mie le sottolineature e il corsivo. 38 Sulla definizione di continuum, cfr. Berruto (1987: 27-31; 1998: 25). Il fatto che il con-
tinuum delle varietà non sia lineare ma multidimensionale non incide sul problema dell’asse
diamesico.
Diamesia: la nascita di una dimensione 43
sposizione in dimensione di variazione, come è stato sottolineato pri-
ma da Holtus (1984) e poi da Radke (1992)39
.
Attraverso la riduzione delle differenze tra realizzazioni parlate e
scritte alla situazione comunicativa, cui viene assimilato il canale, si
giunge all’inclusione della diamesia nella diafasia. Tale convergenza,
utile per il modello, non è del tutto soddisfacente sul piano teorico,
anche perché l’approdo conserva memoria della lunga storia qui rico-
struita: la diamesia non pare totalmente scomparsa dall’orizzonte40
.
Il percorso tracciato mostra come la diamesia, da dimensione au-
tonoma, sia tornata, forse provvisoriamente, nell’alveo della diafasia.
Il ricorso a più modelli, da quello funzionale a quello che scinde il co-
dice dal piano concezionale, indica che ci si è allontanati progressiva-
mente da una sua caratterizzazione del parlato modellata sul canale.
Per convogliare le differenze tra scritto e parlato in una dimensione di
variazione, si deve infatti rinunciare alla caratterizzazione essenziale
del parlato, dipendente dal canale, per concentrarsi su fatti “contingen-
ti” (storici), i quali, dopo un lungo tragitto, ci riconducono a quanto
aveva scritto a suo tempo Tullio De Mauro (1970).
3. L’italiano trasmesso
I problemi teorici posti dalla dimensione diamesica, ripercorsi qui
da Mioni fino alla revisione di Berruto, non hanno impedito che su di
essa si innestassero altre varietà, a partire dall’italiano trasmesso (Sa-
batini 1982, 1984, 19902, 1997). Nel manuale destinato alle scuole se-
condarie superiori del 1984, Sabatini affrontava le differenze tra il par-
lato (faccia a faccia) e lo scritto, individuandone le differenze prima
39 Radtke (1992: 67): «Per evitare possibili equivoci è da chiarire che scritto e parlato non
vanno intesi come varietà (cioè una deviazione dalla lingua comune), ma come due forme di
rappresentazione tramite media diversi (cioè come realizzazioni diverse di una lingua e delle
sue varietà)». La stessa osservazione era presente nell’introduzione al volume Holtus/Radtke
(1985). 40 Berruto/Cerruti (2014: 147-8), illustrando la nozione di modo, introducono «la varia-
zione della lingua in relazione alla distinzione fra scritto e parlato; ovvero, la variazione dia-
mesica. Essendo il canale di comunicazione fondamentalmente un carattere della situazione
comunicativa, la variazione diamesica può essere considerata un’ulteriore sottodimensione
della variazione diafasica». Permane anche la nozione di continuum (ivi, p. 150). Mio il cor-
sivo.
Elena Pistolesi 44
sulla base del coinvolgimento sensoriale, poi delle forme e delle fun-
zioni. Fissati tali punti, Sabatini introduceva un terzo sistema di co-
municazione verbale “attraverso mezzi speciali” (telefono, radio, TV),
«da mettere accanto a quelli della lingua parlata e della lingua scritta».
Nel 1994 l’Accademia della Crusca organizzava il seminario dal ti-
tolo Gli italiani trasmessi. La radio, i cui atti furono pubblicati nel
1997. Il saggio introduttivo di Sabatini non contiene, così come quelli
precedenti, indicazioni linguistiche in senso stretto, se non il richiamo
all’italiano dell’uso medio, i cui tratti risultano ben attestati nelle nuo-
ve forme di comunicazione41
. Come ha opportunamente rilevato Giu-
seppe Sergio (2004: 112-4), il “trasmesso” non presenta caratteri pro-
pri, né può essere considerato una gamma di varietà42
.
Seguendo nel tempo alcuni usi di questa etichetta, si osserva che il
trasmesso può “affiancarsi a”, “aggiungersi a” (D’Achille 20103: 245),
“innestarsi su”, “integrare”, “riarticolare” l’asse diamesico43
; definire
una modalità ibrida tra scritto e parlato del continuum diamesico
(Atzori 2003: 33); mostrare una “dialettica tra tratti tipici dell’oralità
(o meglio: della modalità comunicativa orale) e della scrittura (della
modalità comunicativa scritta)” (Prada 2003b: 151); essere caratteriz-
zato dal canale (o medium) di trasmissione e dai sensi coinvolti44
.
All’italiano trasmesso dedica ampio spazio il manuale di Coveri/
Benucci/Diadori (1998: 263-5), ma le sue caratteristiche complessive
non vanno oltre l’assenza di feedback (con l’evidente eccezione del te-
lefono) o l’uso di perifrasi, sinonimi e stereotipi tipici della cronaca
giornalistica, assunta qui come caso di studio45
. Sobrero/Miglietta
(2006: 114) scrivono che lungo l’asse che va «dallo scritto scritto sino
al parlato parlato» «sono state individuate altre varietà: la principale è
41 «Nemmeno a dubitarne, fra questi tratti figurano tutti i fenomeni tipici dell’“uso medio”
(…), ormai ben noti e che diventa perfino fastidioso rielencare» (Sabatini 1997: 19). 42 Sul modello cfr. Albano Leoni (2005, 2013). 43 Berruto (1985: 122 n. 3) accennava, rispetto alla dicotomia scritto-parlato, al «formarsi
di una gamma intermedia di varietà, la ‘lingua trasmessa’». In Berruto/Cerruti (2014: 150) il
trasmesso è definito «un’ulteriore categoria che è stata introdotta (…) nella zona intermedia
fra parlato tipico (detto a volte ‘parlato parlato’) e scritto tipico». 44 Prada (2003a: 251): «Il testo web è in primo luogo un testo trasmesso perché è veicola-
to, attraverso canali particolari (onde radio, cavi ottici, cavi di rame ecc.), da un mittente ad un
destinatario tipicamente lontano, purché questi abbia accesso alle risorse tecniche necessarie
alla sua ricezione». Cfr. anche Alfieri/Bonomi (2008: 15). 45 Gli autori ricordano che la lingua è molto diversa a seconda del tipo di trasmissione
(film, TG, pubblicità, ecc.), di cui si fornisce una campionatura “senza alcuna pretesa scienti-
fica” (ivi, p. 264).
Diamesia: la nascita di una dimensione 45
il parlato trasmesso (Sabatini 1984) proprio dell’informazione giorna-
listica radio-televisiva, della scrittura telematica (e-mail, chat, bache-
che elettroniche, newsgroup) o telefonica (SMS)». Esso è poi ibrido,
in quanto presenta «caratteristiche del parlato scritto e dello scritto
parlato». I tratti comuni sarebbero «la trasmissione in uno spazio fisi-
co diverso da quello in cui si trova l’interlocutore e la pluralità dei de-
stinatari di uno stesso messaggio» (ivi, p. 121).
Le definizioni del trasmesso oscillano tra la gamma di varietà e i pa-
rametri di ordine superiore elencati da Sabatini. Alcune si concentrano
sul mezzo di trasmissione (aria, onde radio, cavi ottici, ecc.) e insistono
sulla mancata condivisione dello spazio di interazione (assenza di feed-
back, ecc.), altre sul modo in cui il messaggio viene elaborato in fun-
zione della comunicazione a distanza, senza effettivi vantaggi rispetto
alle proposte di Gregory (1967) e di Nencioni (1976). Spesso non si tie-
ne conto della doppia cornice dei testi da analizzare: quella in cui si
produce il messaggio (dialogica, monologica, più o meno pianificata) e
la ricezione da parte di un pubblico distante e passivo.
4. Le prospettive globali
Non sono mancate, negli anni presi in esame, le proposte di una ca-
ratterizzazione globale e “in positivo” del parlato, non derivanti cioè
da una visione contrastiva entro il più vasto dominio dell’oralità o
dall’opposizione con il polo della scrittura. Esse non hanno avuto una
risonanza pari alle posizioni che oscillano tra parametri universali e
approccio sociolinguistico, in quanto non comprimibili nel continuum
scritto-parlato, né riducibili a un elenco di tratti utile per la definizione
delle varietà del repertorio46
.
Nel volume curato da Holtus/Radtke, Gianna Marcato (1985) insi-
steva sul canale come elemento discriminante fondamentale, il quale,
strutturando il messaggio, produce una differenziazione di modi «che
esclude ogni continuum, pur implicando reciprocità di modellamen-
to». Il parlato si configura come una gamma di variazioni inscindibili
dalla situazione e dalla funzione comunicativa, che «si mantengono,
46 Per limitarci al periodo preso in considerazione, si vedano i modelli di Pari-
si/Castelfranchi (1977) e di Cresti (1977), presentati al Seminario del 1976 (cfr. Seminario
1977). Sulla teoria della “lingua in atto”, si rinvia a Cresti (2000).
Elena Pistolesi 46
nei suoi confronti, variabili indipendenti, come variabili indipendenti
sono le persone che comunicano, con tutte le loro caratteristiche indi-
viduali e sociali». La definizione del parlato non può prescindere: «a)
dalla canalizzazione che gli è propria, b) dalle connessioni che lo ca-
ratterizzano a livello comunicativo, c) dalla funzione che gli è specifi-
ca, d) dalla contestualizzazione situazionale in un rapporto di intera-
zione personale» (ivi, p. 29). Il saggio insiste sulla dipendenza del par-
lato dal canale entro una teoria organica della comunicazione, attenta
sia agli ‘universali’ sia agli apporti interdisciplinari47
.
A pochi anni di distanza dal convegno tedesco, al quale aveva pre-
so parte con una relazione sui pronomi clitici nell’italiano parlato,
Monica Berretta sottolineava (1988: 762) in rapporto alla diamesia:
se teoricamente il mezzo può essere considerato una componente della situa-
zione, la sua influenza sulla variazione pare troppo importante, e soprattutto
troppo autonoma, per farla rientrare nella dimensione diafasica48
.
A questa altezza continua l’identificazione, con qualche distinguo,
delle varietà basse con il parlato. In seguito Berretta (1994: 242-3) sa-
rebbe tornata sugli snodi teorici e sulla problematica relazione con la
diafasia, chiarendo che la sovrapposizione della dimensione scrit-
to/parlato con altre accezioni, quali “lingua comune, lingua dell’uso”,
oscura «le peculiarità del mezzo orale in quanto tale, e le implicazioni
che esso ha sull’italiano parlato. È migliore una definizione più rigo-
rosa, il più possibile legata appunto alla variabile mezzo», perché le
modalità di elaborazione nello scritto e nel parlato sono “drasticamen-
te diverse”, tali da emergere in ogni altra dimensione di variazione.
La diversa prospettiva sul parlato, che si può osservare anche attra-
verso gli interventi successivi di Berretta (dal 1985 al 1994), si deve
all’arricchirsi della documentazione e degli studi ad esso esclusiva-
mente dedicati, fra i quali basterà ricordare: Sintassi e intonazione
nell’italiano parlato di Miriam Voghera (1992); il Lessico di frequen-
za dell’italiano parlato (LIP) (1993) e il volume, curato da Tullio De
Mauro, Come parlano gli italiani (1994), che contiene un primo bi-
47 Sornicola (1985: 3) scriveva a proposito della dicotomia scritto-parlato: «Ma se osser-
viamo l’hardware dei due sistemi, possiamo accorgerci che le differenze si trovano là. E sono
differenze di struttura associate a parametri psicolinguistici, come il grado di progettazione
del discorso, ed a parametri pragmatici, come il tipo di situazione comunicativa instaurato da
un evento parlato o scritto». 48 Mio il corsivo.
Diamesia: la nascita di una dimensione 47
lancio dei dati che emergono dall’interrogazione del LIP; Le facce del
parlare di Carla Bazzanella (1994).
Il confronto con i dati comporta una discussione più articolata dei
modelli teorici (come già in Sornicola 1981). Voghera individua nella
sintassi il luogo privilegiato per descrivere la specificità del parlato e
conciliare le accezioni correnti (e concorrenti) di parlato, spesso con-
fuse nei lavori dedicati al tema. Carla Bazzanella propone un modello
a prototipo, con riferimento al concetto wittgensteniano di «somi-
glianze di famiglia, una rete cioè di caratteristiche variamente condivi-
se, piuttosto che una proprietà (o un insieme di proprietà) comune a
tutte le entità di un termine generale» (1994: 31). L’esame dei dati
mostra i vantaggi descrittivi di un approccio che coniuga la pragmati-
ca, con riferimento alla scalarità dei fenomeni, e l’analisi multidimen-
sionale.
Grazie a questi lavori, che superano decisamente le proposte dico-
tomiche persistenti nell’idea di continuum, la ricerca si è affrancata
dalla discussione sull’italiano popolare per offrire una caratterizzazio-
ne del parlato “senza aggettivi”49
.
5. Considerazioni conclusive
La ricostruzione, per sommi capi, della storia della diamesia ci ha
portato a evidenziare alcuni problemi che riemergono nel dibattito sul-
le varietà o sui modi di comunicare, concentrati oggi sul polo della
scrittura e sulle nuove funzioni che essa ha assunto nella CMC, rispet-
to alla quale tutti i modelli citati sono stati mobilitati in sede definito-
ria. Presentando la diamesia come frutto di una peculiare fase storica
degli studi sull’italiano, ho cercato di evidenziarne i limiti teorici, le-
gati all’incerta definizione dei poli e alla loro problematica interdipen-
denza in un continuum. Ho poi sottolineato la necessità di riconsidera-
re le etichette innestate sulla diamesia, come l’italiano trasmesso, pro-
prio perché insistono su una dimensione claudicante. L’opportunità di
un ripensamento va oltre l’ostacolo della diamesia: il moltiplicarsi de-
gli “italiani” ha coinvolto la nozione stessa di varietà, che risulta spes-
49 Per un panorama aggiornato degli studi sul parlato, che non è oggetto specifico di que-
sto lavoro, si veda il portale http://www.parlaritaliano.it/
Elena Pistolesi 48
so applicata a fenomeni di superficie o a parametri generali privi di
una puntuale caratterizzazione linguistica.
Il problema più immediato che la diamesia pone riguarda la nozio-
ne stessa di parlato, che oscilla tra riferimenti all’oralità, al canale fo-
nico-uditivo e alla variazione sociolinguistica (Voghera 1992: 13-51).
Le tre accezioni sono state articolate entro una visione contrastiva con
la scrittura, intesa anch’essa in vario modo per adattarla alle esigenze
imposte dai modelli. Le difficoltà rilevate nell’uso del termine “parla-
to” si presentano, infatti, anche nell’adozione del suo opposto, ambi-
guo o mutevole tanto quanto il primo. Le tre accezioni di parlato si
pongono in un diverso rapporto con la scrittura e, dunque, con l’idea
di continuum che può derivarne o non derivarne. Come osserva Paul
Zumthor (1984: 34), «voce e scrittura non sono affatto termini omolo-
ghi»: «le differenze rilevate tra esse non sono tutte ugualmente perti-
nenti. L’oralità non si definisce per sottrazione di certi caratteri dello
scritto più di quanto lo scritto non si riduca a una semplice trasposi-
zione dell’oralità»50
.
Non appena ci si allontana dalla natura delle fonìe, cercando di in-
dividuare i tratti universali (parlato) o i loro correlati linguistici in una
lingua determinata (italiano parlato), entrano in gioco le realizzazioni
concrete, dunque le varietà con i loro tratti, e i rapporti storicamente
determinati fra uso e codificazione. Per questa via, come abbiamo vi-
sto, si giunge al dissolversi della diamesia nella diafasia, mentre resta
irrisolto il problema fondamentale così formulato da Voghera (1992:
28):
qualsiasi definizione di parlato presuppone in qualche modo le caratteristiche
della sostanza fonico-uditiva, senza per questo sovrapporvisi. Il problema è di
sapere quanto nel parlato è necessariamente fonico-uditivo, cioè quanto la
materialità della comunicazione influenzi la struttura dei testi parlati51
.
La riduzione delle differenze scritto/parlato a dimensione di varia-
zione è problematica non solo per la compressione della multimodalità
50 Sulla problematica definizione dell’oralità in rapporto agli studi sul parlato, cfr. Manci-
ni (1994: 5-14). 51 A differenza delle altre dimensioni (varietà sociali e geografiche, ad esempio) «anche se
si ammette, infatti, un ruolo autonomo della dimensione diamesica, non è facile riconoscere i
tratti linguistici sistematici che ne rappresentano i correlati» (Voghera 1992: 46). Su questo
aspetto si sono soffermati anche Berruto (1985, 1993), Sornicola (1985) e Berretta (1994).
Diamesia: la nascita di una dimensione 49
del parlato alla monomedialità della scrittura52
, ma anche rispetto alla
teoria generale, perché le tradizionali dimensioni di variazione, volen-
do usare una definizione di Albano Leoni, non rappresentano due
aspetti della stessa faculté de language53
. La diamesia è una dimen-
sione “troppo autonoma”, come osservava Berretta, per essere consi-
derata al pari delle altre. Il problema non è costituito, dunque,
dall’analisi delle differenze tra scritto e parlato, ma dalla loro riduzio-
ne a dimensione di variazione (cfr. Radtke 1992). Se nel caso della
diastratia, diatopia e diafasia il continuum è chiaro perché chiara è la
definizione dei poli, nel caso della diamesia il continuum si può trac-
ciare solo allontanandosi da una caratterizzazione modellata sul cana-
le. I rinvii ai lavori di Nencioni (1976) e di Gregory (1967) a sostegno
dell’idea di continuum sociolinguistico non sono pertinenti per le ra-
gioni discusse nella prima parte di questo lavoro.
Abbiamo visto che la diamesia è una dimensione di variazione tutta
italiana, che emerge da un quadro fortemente condizionato dal dibatti-
to sull’italiano popolare e sulle sue fonti scritte, orali, trascritte. Il fatto
che la sua efficacia descrittiva si annulli in alcuni punti dello spazio di
variazione ne evidenzia i limiti teorici dovuti, in primo luogo, al tipo
di documentazione. Dalle testimonianze scritte deriva anche la perce-
zione dell’unitarietà dell’italiano popolare, enfatizzata per porre in ri-
lievo il contributo delle classi popolari al processo di unificazione lin-
guistica. L’esigenza di distinguere l’italiano popolare da quello dei
semicolti, cioè di distinguere fra uso parlato e scritto, è significativa:
si torna a discriminare tra le due modalità, quando la diamesia è già un
parametro definitorio dell’italiano popolare54
. Scritto e parlato vengo-
no così impiegati a due livelli: parametrico, in quanto dimensioni che
concorrono alla definizione della varietà, e specifico, come discrimine
al suo interno. L’esito è una dinamica che potremmo definire frattale55
.
Pare conclusa la fase di un ricorso alla diamesia come dimensione
di variazione. Emerge, invece, la tendenza alla scissione del canale, ir-
riducibile a un continuum, dalle caratteristiche situazionali e da quelle
52 Cfr. Prampolini/Voghera (2012). 53 Albano Leoni (2005, 2013). 54 Bruni (1984) aveva posto immediatamente il problema, ma le due categorie - italiano
popolare e italiano dei semicolti – risultano spesso sovrapposte o integrate nell’architettura di
Berruto (1987). 55 La stessa osservazione vale per l’italiano trasmesso: in base alla relazione che si stabili-
sce con la diamesia, si divide, a sua volta, in parlato trasmesso e in scritto trasmesso. Cfr.
D’Achille (20103: 245-261) e Bonomi et alii (20102: 17, 256, 259).
Elena Pistolesi 50
linguistico-testuali, cui si deve il riassorbimento della diamesia nella
diafasia. I modelli che scindono il codice (grafico e fonico) dai para-
metri concezionali producono una semplificazione, in quanto la scelta
del canale è costitutiva, simultanea, non scindibile dal momento
dell’enunciazione. Le etichette che derivano da questa impostazione,
come “parlato grafico”, oltre ad essere circolari, ci riportano alla do-
manda iniziale sulla natura del parlato e dello scritto, senza produrre
un reale progresso sul piano teorico o descrittivo.
Una caratterizzazione specifica e in positivo del parlato gioverebbe
anche allo studio della scrittura, le cui definizioni oscillano, in modo
simmetrico rispetto al suo polo opposto, tra riferimenti al canale, ai
processi cognitivi e ai tratti linguistico-testuali vincolati alla tradizione
normativa.
Il peso che ha avuto la querelle sull’italiano popolare nella nascita
della diamesia mostra, a mio avviso, l’utilità di storicizzare le catego-
rie di analisi consolidate per verificarne, a distanza, la tenuta. Questa
considerazione si può estendere alle ricerche che, partendo da una se-
rie di tratti predefiniti, conducono alla conferma del già noto senza la-
sciare spazio a una (socio)linguistica esplorativa.
Bibliografia
ALBRECHT J. (1986), “‘Substandard’ und ‘Subnorm’. Die nicht-
exemplarischen Ausprägungen der ‘Historischen Sprache’ aus vari-
etätenlinguistischer Sicht”, in G. Holtus, E. Radtke (hrsg.), Spra-
chlicher Substandard, Tübingen: Niemeyer, pp. 65-88.
ALBANO LEONI F. (2005), “Studiare l’italiano parlato ieri e oggi”, in F.
Lo Piparo, G. Ruffino (a cura di), Gli italiani e la lingua, Palermo:
Sellerio, pp. 43-57.
ALBANO LEONI F. (2013), “Il parlato e la comunicazione parlata”, in
G. Iannàccaro (a cura di), La linguistica italiana all’alba del terzo
millennio (1997-2010), Roma: Bulzoni, vol. I, pp. 129-48.
ALFIERI G., I. BONOMI, a cura di (2008), Gli italiani del piccolo
schermo. Lingua e stili comunicativi nei generi televisivi, Firenze:
Cesati.
ATZORI E. (2003), “La lingua della radio”, in I. Bonomi, A. Masini, S.
Morgana (a cura di), La lingua italiana e i mass media, Roma: Ca-
rocci, pp. 33-66.
Diamesia: la nascita di una dimensione 51
BAZZANELLA C. (1994), Le facce del parlare. Un approccio pragma-
tico all’italiano parlato, Scandicci (FI): La Nuova Italia.
BERRETTA M. (1985), “I pronomi clitici nell’italiano parlato”, in Hol-
tus/Radtke, a cura di (1985), pp. 185-224.
BERRETTA M. (1988), “Italienisch: Varietätenlinguistik des Italieni-
schen/Linguistica delle varietà”, in G. Holtus, M. Metzeltin, C.
Schmitt (hrsg.), Lexikon der Romanistischen Linguistik, IV, Tübin-
gen: Niemeyer, pp. 762-74.
BERRETTA M. (1994), Il parlato italiano contemporaneo, in L. Serian-
ni, P. Trifone (a cura di), Storia della lingua italiana, vol. II: Scrit-
to e parlato, Torino: Einaudi, pp. 239-70.
BECCARIA G. L. (2004), Dizionario di linguistica e di filologia, metri-
ca, retorica, Torino: Einaudi.
BERRUTO G. (1985), “Per una caratterizzazione del parlato: l’italiano
parlato ha un’altra grammatica?”, in Holtus/Radtke, a cura di
(1985), pp. 120-53.
BERRUTO G. (1987), Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo,
Roma: La Nuova Italia (nuova ed. 2012).
BERRUTO G. (1998), “Noterelle di teoria della variazione linguistica”,
in E. Werner et al. (hrsg.), Et multum et multa. Festschrift für Peter
Wunderli zum 60 Geburtstag, Tübingen: Narr, pp. 17-29.
BERRUTO G. (20039), “Varietà diamesiche, diastratiche, diafasiche”, in
A. A. Sobrero (a cura di), Introduzione all’italiano contemporaneo,
vol. II: La variazione e gli usi, Roma/Bari: Laterza, pp. 37-92.
BERRUTO G. (2004), Prima lezione di sociolinguistica, con la collabo-
razione di E. M. Pandolfi, Roma/Bari: Laterza.
BERRUTO G. (2005), “Italiano parlato e comunicazione mediata dal
computer”, in K. Hölker, C. Maaß (eds.), Aspetti dell’italiano par-
lato. Tra lingua nazionale e varietà regionali, Münster: LIT, pp.
109-24.
BERRUTO G. (2011), “Varietà”, in ENCICLOPEDIA (2010-1).
BERRUTO G., CERRUTI M. (2011), La liguistica. Un corso introduttivo,
Torino: UTET.
BERRUTO G., CERRUTI M. (2014), Manuale di sociolinguistica, Tori-
no: UTET.
BOMBI R., ORIOLES V. (2003), “Aspetti del metalinguaggio di Eugenio
Coseriu: fortuna e recepimento nel panorama linguistico italiano”,
in V. Orioles (a cura di), Studi in memoria di Eugenio Coseriu,
Elena Pistolesi 52
supplemento di Plurilinguismo contatti di lingue e culture, 10, pp.
53-73.
BONOMI I., MASINI A., MORGANA S. (2004), Lingua italiana e mass
media, Roma: Carocci.
BONOMI I., MASINI A., MORGANA S., PIOTTI M. (20102), Elementi di
linguistica italiana, Roma: Carocci.
BRUNI F. (1984), L’italiano. Elementi di storia della lingua e della
cultura, Torino: UTET.
BRUNI F. (20072), L’italiano letterario nella storia, Bologna: il Muli-
no.
CORTELAZZO M. (1972), Avviamento critico allo studio della dialetto-
logia italiana, vol. III: Lineamenti di italiano popolare, Pisa: Pacini.
COVERI L., BENUCCI A., DIADORI P. (1998), Le varietà dell’italiano.
Manuale di sociolinguistica italiana, Roma/Università per Stranieri
di Siena: Bonacci.
CRESTI E. (1977), “Recenti studi sull’intonazione”; “Frase e intona-
zione”, in SEMINARIO (1977), pp. 33-43; 45-67.
CRESTI E. (2000), Corpus di italiano parlato, Firenze: Accademia del-
la Crusca, 2 voll + CD.
CRESTI E. (2008), “Nencioni e le ricerche sul parlato”, Studi di
Grammatica italiana, 27, pp. 41-54.
D’ACHILLE P. (1990), Sintassi del parlato e tradizione scritta della
lingua italiana. Analisi di testi dalle origini al secolo XVIII, Roma:
Bonacci.
D’ACHILLE P. (1994), “L’italiano dei semicolti”, in L. Serianni, P. Tri-
fone (a cura di), Storia della lingua italiana, vol. II: Scritto e parla-
to, Torino: Einaudi, pp. 41-79.
D’ACHILLE P. (20103), L’italiano contemporaneo, Bologna: il Mulino.
D’ACHILLE P. (2010), “Italiano popolare”, in ENCICLOPEDIA (2010-1).
DE MAURO T. (1970), “Tra Thamus e Theuth. Note sulla norma parla-
ta e scritta, formale e informale nella produzione e realizzazione
dei segni linguistici”, in Lingua parlata e lingua scritta. Atti del
Convegno (Palermo, 9-11 novembre 1967), Bollettino del Centro di
studi filologici e linguistici siciliani, 11, pp. 167-79.
DE MAURO T. (1970a), “Per lo studio dell’italiano popolare unitario”,
in A. Rossi (a cura di), Lettere da una tarantata, Bari: De Donato,
pp. 43-75.
DE MAURO T., a cura di (1994), Come parlano gli italiani, Scandicci
(FI): La Nuova Italia.
Diamesia: la nascita di una dimensione 53
ENCICLOPEDIA (2010-1) = Enciclopedia dell’italiano, a cura di R. Si-
mone, G. Berruto, P. D’Achille, Roma: Istituto dell’Enciclopedia
Italiana G. Treccani (http://www.treccani.it/).
FERGUSON C. A. (1959), “Diglossia”, Word, 16, pp. 325-40.
FUSCO F. (2000), “Français avancé, français populaire, français
branché: varietà e variabilità nel francese contemporaneo”, Pluri-
linguismo, 7, pp. 63-82.
GIGLIOLI P., a cura di (1972), Linguaggio e società, Bologna: il Mulino.
GREGORY M. (1967), “Aspects of varieties differentiations”, Journal
of Linguistics, 3.2, pp. 177-98.
GREGORY M., CARROLL S. (1978), Language and Situation. Language
Varieties and their Social Contexts, London/Henley/Boston:
Routledge & Kegan Paul.
HALLIDAY M. A. K. (1992), Lingua parlata e lingua scritta, Scandicci
(FI): La Nuova Italia.
HANS-BIANCHI B. (2005), La competenza scrittoria mediale. Studi sul-
la scrittura popolare, Tübingen: Niemeyer. HOLTUS G. (1984), “Codice parlato e codice scritto”, in Il dialetto
dall’oralità alla scrittura. Atti del XIII Convegno per gli Studi Dia-
lettali Italiani (Catania-Nicosia, 28 settembre 1981), Pisa: Pacini,
pp. 1-12.
HOLTUS G., RADTKE E., a cura di (1985), Gesprochenes Italienisch in
Geschichte und Gegenwart, Tübingen: Narr, 1985.
KOCH P. (1985), “Gesprochenes Italienisch und sprechsprachliche
Universalien”, in Holtus/Radtke, a cura di (1985), pp. 42-76.
KOCH P. (1999): “Gesprochen/geschrieben ̶ eine eigene Varietätendi-
mension?”, in N. Greiner, J. Kornelius, G. Rovere (hrsg.), Texte
und Kontexte in Sprachen und Kulturen. Festschrift für Jörn Albre-
cht, Trier: WVT, pp. 141-68.
KOCK P. (2001), “Oralità/scrittura e mutamento linguistico”, in M.
Dardano, A. Pelo, A. Stefinlongo (a cura di), Scritto e parlato: me-
todi, testi e contesti. Atti del Colloquio internazionale di studi
(Roma, 5-6 febbraio 1999), Roma: Aracne, pp. 15-29.
KOCH P., OESTERREICHER W. (1985), “Sprache der Nähe ̶ Sprache
der Distanz. Müdlichkeit und Schriftlichkeit im Spannungsfeld von
Sprachtheorie und Sprachgeschichte”, Romanistisches Jahrbuch,
36, pp. 15-43.
KOCH P., OESTERREICHER W. (1990), Gesprochene Sprache in der
Romania. Französisch, Italienisch, Spanisch, Tübingen: Niemeyer
Elena Pistolesi 54
(nuova ed.: Lengua hablada en la Romania: español, francés, ita-
liano, Madrid: Gredos, 2007).
KOCH P., OESTERREICHER W. (2001), “Gesprochene Sprache und ge-
schriebene Sprache / Langage parlé et langage écrit”, in G. Holtus,
M. Metzeltin, C. Schmitt (hrsg.), Lexikon der Romanistischen Lin-
guistik, I.2, Tübingen: Niemeyer, pp. 584-627.
LAVINIO C. (1986), “Tipologia dei testi parlati e scritti”, Linguaggi,
3.1-2, pp. 14-22 (riproposto in C. Lavinio, Teoria e didattica dei te-
sti, Scandicci (FI): La Nuova Italia, 1990, pp. 23-38).
LAVINIO C. (1995), “Testi scritti e testi orali: differenze, interazioni,
intersezioni”, in M. T. Calzetti, L. Panzeri Donaggio (a cura di),
Educare alla scrittura. Processi cognitivi e didattica, Scandicci
(FI): La Nuova Italia, pp. 19-43.
LAVINIO C., a cura di (2002), La linguistica italiana alle soglie del
Duemila (1987-1997 e oltre), Bulzoni: Roma.
LEPSCHY G. C. (1983), “L’italiano popolare. Riflessioni su riflessio-
ni”, in F. Albano Leoni et al. (a cura di), Italia linguistica: idee,
storia, strutture, Bologna: il Mulino, pp. 269-82.
LEPSCHY A. L., LEPSCHY G. (1992), “La situazione dell’italiano”, in
A. A. Mioni, M. A. Cortelazzo (a cura di), La linguistica italiana
degli anni 1976-1986, Roma: Bulzoni, pp. 27-34.
LIP = T. De Mauro, F. Mancini, M. Vedovelli, M. Voghera, Lessico di
frequenza dell’italiano parlato, Milano: Etaslibri, 1993.
LORENZETTI L. (2002), L’italiano contemporaneo, Roma: Carocci.
MARCATO G. (1985), “Italiano parlato, comunicazione di base e orali-
tà”, in Holtus/Radtke, a cura di (1985), pp. 24-41.
MANCINI M. (1994), “Oralità e scrittura nei testi delle Origini”, in L.
Serianni, P. Trifone (a cura di), Storia della lingua italiana, vol. II:
Scritto e parlato, Torino: Einaudi, pp. 5-40.
MIONI A. M. (1975), Introduzione a J. A. Fishman, La sociologia del
linguaggio, Roma: Officina, pp. 10-56.
MIONI A. M. (1983), “Italiano tendenziale: osservazioni su alcuni
aspetti della standardizzazione”, in Scritti linguistici in onore di G.
B. Pellegrini, vol. I, Pacini: Pisa, pp. 495-517.
NENCIONI G. (1976), “Parlato-parlato, parlato-scritto, parlato-
recitato”, Strumenti critici, 10, pp. 1-56 (ora in G. Nencioni, Di
scritto e di parlato. Discorsi linguistici, Bologna: Zanichelli, 1983,
pp. 126-79).
Diamesia: la nascita di una dimensione 55
PARISI D., CASTELFRANCHI C. (1977), “Scritto e parlato”, Studi di
Grammatica italiana, 6, pp. 169-90 [riproposto in D. Parisi (a cura di),
Per una educazione linguistica razionale, Bologna: il Mulino, 1979,
pp. 319-62].
PRADA M. (2003a), “Lingua e web”, in I. Bonomi, A. Masini, S. Mor-
gana (a cura di), La lingua italiana e mass media, Roma: Carocci,
pp. 249-89.
PRADA M. (2003b), Scrittura e comunicazione. Guida alla redazione
di testi professionali, vol. I: Comunicazione - Testo - Varietà di
Lingua, Milano: LED.
PRAMPOLINI M., VOGHERA M. (2012), “Multimodalità futura e origi-
naria”, Testi e linguaggi, 6, pp. 11-5.
RADTKE E. (1992), “Varietà dell’italiano”, in A. A. Mioni, M. A. Cor-
telazzo (a cura di), La linguistica italiana degli anni 1976-1986,
Roma: Bulzoni, pp. 59-74.
ROSSI F. (2011), “Variazione diamesica”, in ENCICLOPEDIA (2010-1).
SABATINI F. (1980), “Linee di tendenza dell’italiano contemporaneo e
problemi di norma”, in Lingua italiana in Finlandia. Atti del primo
convegno degli insegnanti di italiano in Finlandia (Turku, 17-18
maggio 1979), Università di Turku, Facoltà di Lettere (Sezione di
italiano), pp. 73-91.
SABATINI F. (1982), “La comunicazione orale, scritta e trasmessa: la
diversità del mezzo, delle lingue e delle funzioni”, in A. M. Bocca-
fumi, S. Serromani (a cura di), Educazione linguistica nella scuola
superiore: sei argomenti per un curricolo, Roma: Provincia di Ro-
ma/CNR, pp. 105-27.
SABATINI F. (1984), La comunicazione e gli usi della lingua. Pratica,
analisi e storia della lingua italiana, Torino: Loescher (seconda ed.
1990).
SABATINI F. (1985), “L’‘italiano dell’uso medio’: una realtà tra le va-
rietà linguistiche italiane”, in Holtus/Radtke, a cura di (1985), pp.
154-84.
SABATINI F. (1997), “Prove per l’italiano ‘trasmesso’ (e auspici di un
parlato serio semplice)”, in AA.VV., Gli italiani trasmessi. La ra-
dio, Firenze: Accademia della Crusca, pp. 11-30.
SEMINARIO (1977) = Atti del Seminario sull’italiano parlato (Acca-
demia della Crusca, 18-20 ottobre 1976), Firenze: Accademia della
Crusca, 1977.
Elena Pistolesi 56
SERGIO G. (2004), Il linguaggio della pubblicità radiofonica, Roma:
Aracne.
SOBRERO A. A., MIGLIETTA A. (2006), Introduzione alla linguistica
italiana, Roma/Bari: Laterza.
SORNICOLA R. (1981), Sul parlato, Bologna: il Mulino.
SORNICOLA R. (1982), “L’italiano parlato: un’altra grammatica?”, in
AA.VV., La lingua italiana in movimento. Incontri del Centro di
Studi di grammatica italiana (Firenze, 26 febbraio - 4 giugno), Fi-
renze: Accademia della Crusca, pp. 79-96.
SORNICOLA R. (1985), “Il parlato: fra sincronia e diacronia”, in Hol-
tus/Radtke, a cura di (1985), pp. 2-23.
SÖLL L. (1980), Gesprochenes und Geschriebenes Französisch, Ber-
lin: Schmidt (I ed. 1974).
TRUMPER J., MADDALON M. (1982), L’italiano regionale tra lingua e
dialetto. Presupposti ed analisi, Cosenza: Brenner.
VOGHERA M. (1992), Sintassi e intonazione nell’italiano parlato, Bo-
logna: il Mulino.
VOGHERA M. (1994), “Promemoria per una teoria del linguaggio”, in
T. De Mauro, a cura di (1994), pp. 131-45.
WEXLER P. (1971), “Diglossia, language standardization and purism.
Parameters for a typology of literary languages”, Lingua, 27, pp.
330-54.
WÜEST J. (1999), “La notion de diamésie est-elle nécessaire?”,
Travaux de linguistique, 59, pp. 147-62.
ZUMTHOR P. (1984), La presenza della voce. Introduzione alla poesia
orale, Bologna: il Mulino (ed. or., Introduction à la poésie orale,
Paris: Seuil, 1983).