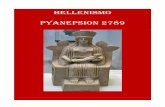L'area archeologica del teatro romano di Milano. Monumento e valorizzazione
La nascita della Rivista Archeologica Comense
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of La nascita della Rivista Archeologica Comense
R I V I S T A A R C H E O L O G I C A
DELL’ANTICA
PROVINCIA E DIOCESI DI COMO
PERIODICO SEMESTRALE DI ANTICHITA E D’ARTEDELLA SOCIETA ARCHEOLOGICA COMENSE
VOLUME N. 195 - ANNO 2013
ESTRATTO
NEW PRESSCOMO 2014
INDICE
La traversa del San Jorio tra basso Medioevo e prima eta moderna.
Relazioni politiche e socioeconomiche tra il feudo mesolcinese e le tre pievi
GIONATA PIERACCI p. 5
I materiali piceni nella Collezione Garovaglio dei Musei Civici di Como
FRANCESCA RONCORONI » 61
Le ricerche archeologiche nel castelliere sul monte Casle di Ramponio Verna.
I reperti e i dati archeobiologici
MARINA UBOLDI, ROBERTO CAIMI, PRISCILLA BUTTA, FULVIA BUTTI RONCHETTI,
ELISABETTA CASTIGLIONI, SILVIA DI MARTINO » 71
Corredi della prima fase golasecchiana da Sesto Calende (Va)
BARBARA GRASSI » 95
Ricerche dei Musei Civici di Como nel territorio comasco:
il Castrum di Laino in Val d’Intelvi
ISABELLA NOBILE DE AGOSTINI » 107
Recenti ricerche paleoecologiche in ambito lariano svolte in collaborazione
fra Universita dell’Insubria e Laboratorio di archeobiologia dei Musei Civici di Como
L. CASTELLETTI, F. LIVIO, E. MARTINELLI, A.M. MICHETTI, S. MOTELLA DE CARLO » 115
Richerche archeologiche: novita dal territorio del Canton Ticino
ROSSANA CARDANI VERGANI » 129
Atti della giornata di studio
‘‘...Monumenti pubblici e privati, gli oggetti di archeologia e di arte bella...’’
Como, Civico Museo Archeologico 16 Marzo 2013
2012: RAC 140 anni, SAC 110 anni » 141
L’organizzazione dell’editoria scientifico-archeologica nell’Italia postunitaria
ERMANNO ARSLAN » 143
Archeologia e storia transfrontaliera. 140 anni di rapporti italo-svizzeri
GIUSEPPE CHIESI E ROSSANA CARDANI VERGANI » 153
Un’istituzione al servizio della citta: la formazione del Museo Civico di Como
ISABELLA NOBILE DE AGOSTINI » 161
La nascita della Rivista Archeologica Comense
FULVIA BUTTI RONCHETTI » 171
Necrologi
Manlio Baccaglini (y 2013)MARIO DI SALVO » 179
Giorgio Grandi (y 2013)GIANCARLO FRIGERIO » 181
Atti della Societa Archeologica Comense
Verbale dell’Assemblea del 7 aprile 2013 » 183
INDICE4
LA NASCITA
DELLA RIVISTA ARCHEOLOGICA COMENSE
Fulvia Butti Ronchetti
‘‘Manifesto
La sottoscritta Commissione Archeologica provin-ciale nell’Adunanza del 14 dicembre 1871 ha stabili-to di pubblicare un Periodico da intitolarsi: RivistaArcheologica della Citta e Provincia di Como.Gli Articoli, di che si comporra il Periodico, avrannoper argomento i monumenti pubblici e privati, gli og-getti di archeologia e di arte bella, e la raccolta d’i-scrizioni, di documenti, di tradizioni, di canzoni po-polari, di voci vernacolari e di nomi corografici, at-tinenti alla Provincia’’.
E questo l’atto di nascita della RAC, che sanci-sce un ‘‘compleanno’’ decisamente invidiabile: 140anni! Firmatari: Vincenzo Barelli, Alfonso Garo-vaglio, Serafino Balestra, F. Peluso, L. Tatti, C.Scalini, A. Longhi 1.
L’intento dichiarato dai fondatori e di occupar-si di molti argomenti; l’elenco potrebbe stonare al-le orecchie di noi moderni, abituati alle ‘‘specializ-zazioni’’, ma in realta l’obbiettivo e unico: e il ter-ritorio, cioe tutto quanto gli concerne dal punto divista storico, artistico e culturale.
Pero, nelle pagine seguenti, ancora meglio sonospecificati gli obbiettivi dal Barelli (cioe il presiden-te della Commissione e il direttore della rivista),quando si sofferma sulla Commissione archeologi-ca, per la quale Como si configura assolutamenteall’avanguardia, essendo stata la prima in Italiaad averla istituita (13 settembre 1861).‘‘I monumenti, come ogni altro lavoro dell’arte uma-na, e segnatamente di arte bella, sono i caratteri incui si legge a chiare note la storia di fatto, direi cosı,
della nazione a cui essi appartengono. Sono un libroaperto a tutti che ci rivela la origine e lo svolgimentointellettuale della nazione stessa: ci conduce ad inda-gare il suo progresso od il regresso, le vicende pro-spere od avverse a cui soggiacque col lungo volgeredei secoli, le influenze esercitate su queste dal clima,dal commercio con altri popoli, dall’indole sua, daicostumi, dalla forma di governo, dalla religione, daquel complesso infine di circostanze ond’e intreccia-ta la vita socievole di tutte le popolazioni.Da cio si argomenta il pregio di siffatte opere sotto ildoppio aspetto, o sia dal lato della forma, se rappre-sentano nell’insieme (od anche solo in qualche loroparte) un tipo ideale del bello piu o meno perfetto;o sia dal lato della storia, se offrono qualche indiziodella civilta dei prischi tempi’’.
Si percepisce percio come negli appassionati lo-cali sia vivo l’interesse per la popolazione, per la vitaconcreta degli antenati, e come stia gia maturandopresso gli studiosi non cattedratici, non specializza-ti, l’esigenza di ricostruire una visione globale dellastoria dell’uomo, oggi diremmo della ‘‘rete’’ dei varifattori che l’hanno costituita, visione a cui dara poiforma in modo organico e perspicuo Braudel strut-turando i fenomeni in ‘‘eventi’’ (fatti della vita poli-tica), ‘‘congiunture’’ (fatti della sfera economica) e‘‘strutture’’ (elementi della vita materiale).
Trapela evidentemente nel testo la mentalitadell’epoca, che, influenzata dal Romanticismo edal processo del Risorgimento, e alla ricerca della‘‘nazione’’, quasi che fosse un processo lineare econtinuo, un ‘‘fil rouge’’ ininterrotto che lo studio-so, come in un appassionante rebus o puzzle, deve
Ringrazio il prof. E. Meroni per il gentile aiuto.1 RAC, 1, 1872, pp. 3-4.
ricostruire attraverso qualche traccia rimasta. Mal’impostazione e gia moderna, in quanto il repertonon e piu considerato l’oggetto curioso per stupiregli amici dotti in qualche serata salottiera, accantoad altre esoticherie provenienti da paesi lontani,cioe materiali estraniati dal loro contesto, ricercatisemplicemente per la loro particolarita ed esibiti inuna specie di ‘‘mostra di monstra’’; Barelli dichiaraesplicitamente che interessa l’aspetto storico, cioequalunque oggetto – a prescindere dall’aspettoesteriore – in quanto ‘‘documento’’ e ‘‘fonte’’, an-che se la vista non e cosı asettica da non gioire del-l’eventuale bellezza del reperto. Ecco cioe la curio-sita intelligente, la ricerca che ha come fine la rico-struzione storica, l’archeologia che nasce comescienza e si stacca dalla storia dell’arte.
L’impostazione della Rivista viene data princi-palmente dal Barelli che voleva privilegiare l’ar-cheologia locale comunicando le scoperte recenti;egli dichiara in una lettera che voleva ‘‘soddisfareil pubblico’’ e la sua curiosita, affrontando argo-menti piacevoli, e propone ad esempio ‘‘La storia
del Celti’’: una rivista cioe divulgativa, che peronon doveva perdere il suo taglio scientifico e dove-va percio rivolgersi sia agli appassionati che agliesperti, un ‘‘format’’ ancora condiviso oggi.
La Rivista e definita da Garovaglio un esempio‘‘piu unico che raro’’ in Italia, e questo orgogliodoveva essere giustificato se il ministro della Pub-blica istruzione Cesare Correnti il 17 aprile 1872 nechiede 70 copie da inviare gratuitamente alle altreprovince del Regno per fornire un esempio da imi-tare 2 (fig. 2); infatti il 5 marzo 1876 vennero istitui-te in ogni Provincia le ‘‘Commissioni provincialiconservatrici dei monumenti d’arte e d’antichita’’ 3.Il Governo si fa carico cioe della sorveglianza edella tutela dei rinvenimenti archeologici, compitoche era rimasto vacante ed affidato alla buona vo-lonta ed alla spontanea sensibilita dei cittadini.
Ma puo essere vista anche un’altra motivazio-ne, poiche la storia, in particolare l’archeologia ro-mana, poteva ben servire a saldare i legami tra legenti dell’Italia appena unita, a ‘‘fare gli Italiani’’(citando la celeberrima frase del D’Azeglio) con
FULVIA BUTTI RONCHETTI172
Fig. 1a-b - Schizzo per la copertina RAC e prima copertina (Archivio Societa Archeologica Comense)
2 Cfr. anche la lettera di Garovaglio, Magni, Riva del 30 Aprile 1900 inviata al Prefetto di Como (Archivio SocietaArcheologica).
3 A. GAROVAGLIO, in RAC, 46, 1902, p. 4.
la prospettiva di un comune passato. Infatti, comespesso e accaduto, si attinge alla storia quando,
per i piu svariati motivi, si va alla ricerca della pro-pria identita, o la si vuole costruire secondo criteridi interesse, o ci si vuole legittimare. L’Italia con ilsuo passato estremamente variegato ed articolatoha gioco facile, ed e una riserva quasi inesauribile
a cui attingere, ma certamente tra le eredita stori-che il periodo dell’impero romano ha creato unnetto discrimine tra quanto lo precede e lo segue,ed e talmente ricco di significati che quasi costringe
a prendere posizione a favore o contro. In partico-lare gli aspetti delle enormi conquiste e della sotto-missione/inglobamento di molte popolazioni costi-tuiscono un precedente particolarmente ghiottoper i ‘‘dominatori’’ delle epoche successive. La ro-
manita fornisce una miniera di simboli estrema-mente efficaci e vitali, a cui si attinge per palesareideali o per legittimarsi, ed il mito dell’impero per-dura attraverso il Medioevo fino a giorni non lon-tani, ad esempio con Napoleone e Mussolini.
Emblematico a questo proposito il popolo etru-sco, per il molteplice ‘‘riutilizzo’’ a cui e stato sot-toposto. Lo studio degli Etruschi e favorito daiMedici e dai governanti del Granducato di Tosca-na per sottolineare un’autonomia culturale rispet-to alla civilta romana ed alla curia vaticana. Nel-l’Ottocento l’‘‘Etruscheria’’, anche grazie al rinve-nimento di nuovi importanti siti, viene rivisitata,il Romanticismo idealizza il mondo etrusco e loeleva ad una sorta di paradiso perduto, abitatoda un popolo spontaneamente naturale, gioioso,carnale, contrapposto all’ordine, alla razionalita,alla morale della civilta greco-romana e cristiana,ma, evidentemente, in questa contrapposizione ilfilone storiografico antiromano tardosettecentescoed ottocentesco profila una critica allo Stato dellaChiesa ed all’imperialismo napoleonico, facendoanche da incubatrice ad un nazionalismo italiconon romanocentrico. Nella costruzione postrisor-gimentale dell’italianita, Adolfo Venturi (Storiadell’arte italiana, tomo I del 1901) e Giovanni T.Rivoira (Le origini della architettura lombarda,1901-1907) ‘‘credevano di cogliere sopravvivenzedella forma etrusca in manifestazioni dell’arte edell’architettura tardoantica e del Medioevo, sulpresupposto di una continuita etnico-culturale(«lo spirito delle popolazioni italiche») gia del re-sto affermata, proprio per la Toscana, da un saggi-sta tardoromantico del calibro di John Ruskin (neisuoi Mornings in Florence, 1875-1877)’’ 4.
Successivamente il Fascismo, che deve esaltare,per sua natura, l’impero romano, e costretto in ge-nerale a ‘‘italicizzare gli Etruschi e italianizzare gliItalici: fare ‘‘della civilta etrusca la pagina d’avviodella storia d’Italia’’ 5.
Un’operazione speculare viene compiuta dainazisti, che insistono su alcuni passi del Germaniadi Tacito per costruire, tramite il mito dell’autoc-tonia dei Germani, il mito della razza pura 6.
LA NASCITA DELLA RIVISTA ARCHEOLOGICA COMENSE 173
Fig. 2 - Lettere del Ministro Cesare Correnti(Archivio Societa Archeologica Comense)
4 M. HARARI, Etruscologia e Fascismo, in Athaeneum, 100, 2012, p. 407; qui anche riferimento al mito di ‘‘Miche-langelo neoetrusco’’.
5 Idem, p. 408: ‘‘Cio comportava, inevitabilmente, due sacrifici di non poco conto: da una parte, per teleologia ro-manocentrica, la rescissione della cultura figurativa etrusca da quella greca (...), dall’altra l’accantonamento della for-tunata ma insidiosa teoria dell’etnogenesi orientalistica, che poteva ostacolare il processo di nazionalizzazione degliEtruschi’’.
6 L. CANFORA, Tacito e la ‘‘riscoperta degli antichi Germani’’: dal II al III Reich, ripreso in La Germania di Tacito daEngels al nazismo, Napoli 1979. Ricordo anche la frase ‘‘Unde habitus quoque corporum, tamquam/quamquam in tantohominum numero, idem omnibus’’ (Germania, 4, 2), in cui la scelta filologica tra le lezioni tamquam e quamquam di-venta ideologica, poiche quamquam fu preferito dagli studiosi nazisteggianti che, prospettando cosı un Tacito stupefattodalla somiglianza somatica di una popolazione numerosa, sottolineano l’omogeneita antica del popolo germanico; latraduzione potrebbe essere nelle due versioni ‘‘Per cui l’aspetto dei corpi e lo stesso per tutti, per quanto e possibile (ge-neralizzare) in una popolazione cosı numerosa/nonostante una popolazione cosı numerosa’’ (cfr. pp. 227-229 del testodi Canfora).
Questa ‘‘ricostruzione a posteriori’’ del propriopassato, la ricerca delle radici non come fluire dellastoria, ma come selezione intenzionale ed ‘‘ideolo-gica’’ di fatti (talvolta anche falsata, forzata), comeun percorso gia segnato, predestinato quasi, e unprocesso piuttosto comune in momenti di crisi, incui allo smarrimento sociale si contrasta con il raf-forzamento della propria identita, e la storia (omeglio la parte che interessa di essa) ben si prestaa puntellare un pensiero. L’uso ideologico e fun-zionale del passato serve a delineare non una iden-tita che si forma, ma piu o meno presunte o piu omeno documentate caratteristiche gia impressedalla ‘‘nascita’’, come se si andasse alla ricercadel DNA di un popolo gia costituito ab origine 7.Con un’operazione di ‘‘taglia e incolla’’, si selezio-na dal passato un aspetto che si vuole enfatizzare elo si collega ad altri in un ‘‘bricolage’’ storico utileai piu svariati fini 8. Del resto la ricerca storica, chenon puo dare risposte dogmatiche, ma e in conti-nua evoluzione e ridefinizione, fornisce un facileappiglio a letture interessate.
Il momento in cui nasce la Rivista Archeologi-ca e particolarmente delicato: da pochi anni e statacompletata l’unita; gli Italiani sono poveri, analfa-beti, dediti per la quasi totalita ad un’agricolturaarretrata, il processo di industrializzazione si staavviando, e si sta costruendo il mondo modernocon tutte le sue contraddizioni. Agli occhi di unostraniero il Paese appare per molti aspetti incom-prensibile. Mark Twain pubblica a puntate nel1869 The Innocents abroad, un libro di viaggi du-rante i quali tocca anche le principali citta italiane.I suoi commenti sono istintivi e talvolta un po’ in-fantili; egli incarna uno spirito spiccio, infastidito espesso schifato delle miserie della gente, della spor-cizia, della burocrazia; non e attrezzato a com-prendere la complessita del vecchio mondo comelui stesso ammette: ‘‘[Le stazioni ferroviarie] miconquistano piu delle centinaia di gallerie di inesti-mabili tesori d’arte d’Italia, perche le une sono ingrado di capirle, mentre le altre non ho la compe-tenza per apprezzarle’’ 9, anticipando inconsape-volmente affermazioni futuriste. Passando per laLombardia dice: ‘‘Siamo partiti da Milano in tre-no. (...) Abbiamo attraversato una catena di colli-ne pittoresche e selvagge, ripide, coperte di vegeta-zione e a forma di cono, con picchi frastagliati chespuntavano di tanto in tanto e con abitazioni e ca-stelli in rovina appollaiati sulle vette, quasi a sfio-
rare le nubi di passaggio. Abbiamo pranzato nellacuriosa e vecchia cittadina di Como, lambita dallago, e poi abbiamo preso il vaporetto (...) facendouna gradevole escursione in questo posto, Bella-gio’’ 10. Dopo Lecco raggiunge Bergamo, e fra icommenti del viaggio: ‘‘Abbiamo attraversato lecitta vecchie piu strane, piu buffe e piu impensate,abbarbicate alle tradizioni e sature dei sogni delpassato e del tutto all’oscuro del fatto che il mon-do gira! E pure del tutto indifferenti al fatto che gi-ri o che resti fermo. Non hanno altro da fare chemangiare e dormire e dormire e mangiare (....). Co-me possono degli uomini, che si definiscono uomi-ni, permettere di essere tanto abietti e felici?’’.
Tra tutte le considerazioni possibili, emerge conevidenza quanto apparisse arretrata e sonnolental’Italia ad un uomo che proviene dall’America,che sarebbe diventata una protagonista economi-ca, politica e culturale nella nuova era.
Como in effetti sta lentamente diventando un si-gnificativo polo industriale: nel periodo concomi-tante alla nascita della rivista viene inaugurata al-l’interno dell’Istituto Tecnico una sezione di setifi-cio (1866) e nasce la tintoria Saba-Frontini (1865).L’analfabetismo e ancora consistente, sebbene nelComasco il tasso sia tra i piu bassi della penisola:nel 1878-1879 ci sono 43860 allievi di cui il 53%ma-schi (le donne percio erano spesso alfabetizzate) 11.
Il dissidio tra passato e futuro vive momenti par-ticolarmente tormentati a Como. L’impulso ediliziodettato dalle esigenze della modernita pone di fron-te a scelte difficili; gli scavi per gli edifici e le infra-strutture, i restauri si incontrano/scontrano con re-sti che emergono dal passato o con la necessita diabbattimento di edifici antichi. All’inizio dell’Otto-cento era stato sacrificato il duecentesco Castello diTorre Rotonda per edificare il Teatro Sociale; neglianni 1814-1815 viene demolito il fatiscente mona-stero di San Giovanni in Pedemonte, dove poi verraedificata la stazione ferroviaria quando la linea daCamerlata raggiungera Como (1875), ed in quel-l’occasione vengono rinvenute numerose tombe; al1835 risale la demolizione della navata destra dellaBasilica di Galliano in stato di degrado.
I fondatori della Rivista sono ben consci diquesto e di quanto sia ‘‘termometro’’ di una civiltail rapporto con il suo passato: ‘‘... la maggior o mi-nore premura dispiegata da noi per la conservazioneed illustrazione di questi nobili prodotti del geniopassato (...), come concorre a segnare il grado del-
FULVIA BUTTI RONCHETTI174
7 Sul problema M. BETTINI, Contro le radici. Tradizioni, identita, memoria, Bologna 2011.8 Cfr. M. AIME, Cultura, Torino 2013.9 M. TWAIN, In questa Italia che non capisco, (1885), Fidenza 2011, p. 96.10 M. TWAIN, op. cit., p. 44.11 F. CANI, G. MONIZZA, Como e la sua storia, Como 1993, pp. 231, 234.
l’affetto che ci scalda pel suolo natıo, e altresı unaprova non ultima del grado di civilta e di coltura acui possiamo vantarci di essere saliti ’’ (dal ‘‘Mani-festo’’).
Il secolo XIX si configura percio come un labo-ratorio in cui il rapporto con il passato viene me-glio delineato in una serie di rimandi tra le istanzeprovenienti dalla raggiunta unita territoriale, dagliideali del Romanticismo, dai rinvenimenti archeo-logici, dal positivismo e dalle necessita concretedell’industrializzazione e dell’urbanizzazione; na-sce la riflessione sulle varie culture antiche dellanostra penisola, sul loro rapporto, il ruolo e l’ere-dita nella costituzione della cultura italiana, su co-sa, come e quanto salvaguardare dei resti cosı ca-pillarmente presenti nella penisola e come coniuga-re queste necessita con le esigenze della vitaquotidiana e moderna. Tutto questo mentre l’ar-cheologia si sta formando scientificamente e meto-dologicamente, e sta concretizzando, con i mate-riali rinvenuti, i nomi delle popolazioni tramandatidagli storici antichi.
Qualche anno dopo l’istituzione della RivistaArcheologica Comense, Carducci, il vate ufficialedell’Italia unita, riproduce in pratica nella poesiaFuori alla Certosa di Bologna (Odi Barbare) unastratigrafia archeologica, strutturata conforme-mente agli studi dell’epoca.
...
udite giu sotterra cio che dicono i morti.
Dormono a’ pie qui del colle gli avi umbri che ruppero primia suon di scuri i sacri tuoi silenzi, Apennino:
dormon gli etruschi discesi co ’l lituo con l’ asta con fermigli occhi ne l’alto a’ verdi misterıosi clivi,
e i grandi celti rossastri correnti a lavarsi la strage
ne le fredde acque alpestri ch’ei salutavan Reno,
e l’alta stirpe di Roma, e il lungo-chiomato lombardoch’ultimo accampo sovra le rimboschite cime.
Dormon con gli ultimi nostri.
Nel testo il cimitero diventa in sostanza unoscavo archeologico parlante, in cui i morti recentisi trovano fianco a fianco degli antenati, accomu-nati nella morte che tutto unifica. Il passato e unfluire di ondate di genti che sembrano essersi sus-seguite su un territorio primordiale, che, comeuna gigantesca divinita archetipica, ha lasciatoscorrere su se stessa, in una sublime atarassia, que-sti popoli/personaggi stereotipati (‘‘grandi celtirossastri’’, ‘‘lungo-chiomato lombardo’’), e chetutto ha seppellito, fagocitato, ma anche conserva-
to. Protagonisti di questa carrellata storica sono lecategorie del tempo e dello spazio, ma mi sembrain particolare la seconda, cioe il territorio, che ap-pare gia costituito a priori, e che, divinamente in-differente, assiste al fluire del tempo ed al passag-gio degli uomini mortali, come figurine accessorie.L’Italia, in conclusione, era gia ‘‘fisicamente’’ esi-stente dall’origine ed aspettava solamente di mani-festarsi nell’aspetto conclusivo dell’unita, che ap-punto tutto ingloba, animata da un’altra forza, ro-manticamente eterna: l’amore. Anche il sole gioca,con la sua vitalita, in contrasto con la freddezzadella terra (‘‘Freddo e qua giu: siamo soli. Ohamatevi al sole! Risplenda su la vita che passa l’e-ternita d’amore’’) e il macabro scempio della mor-te (‘‘Putridi squagliansi i serti d’intorno i nostriumidi teschi’’).
Per dare un altro indizio del sentire dell’epoca,riportiamo alcuni stralci della poesia Il torso delloscapigliato Arrigo Boito (1842-1918): una Venereviene scolpita nel nobile marmo in epoca greca;della divinita non resta ora che un torso, che purecontinua ad essere animato (Quel torso era una Ve-nere/ Che un arcaıco scalpello/ Creo ne’ suoi piu fer-vidi/ Morsi d’amor col Bello;// Oggi, marmoreoenigma/ Dall’olimpico stigma,/ Di tant’arte non re-sta/ Che un busto senza testa.// Pur nelle tronche vi-scere/ La Dea non e ancor morta (....)). Gli uominisembrano degli esserini inutilmente esagitati cheviolano la divinita e tormentano gli elementi natu-rali (In alta pace estatica/ Tu la dormivi, o sasso,/Ne a te giungeva l’alito/ Di questo mondo basso/(...) // Ma poi discese un’Attica/ Gente brıaca d’ar-te./ Seminatrice prodiga/ Di monumenti e carte;/Vider per la campagna/ La magica montagna/ Econ gioia rubesta/ Ne distaccar la cresta.// Piomba-sti e fosti Venere.). La dea e stata scempiata damolte profanazioni (Tutto hai provato, e l’asta/Del santo iconoclasta/ E lo schiaffo plebeo/ Del por-co epicureo.), ma sembra che la piu turpe debbaancora arrivare: il restauro! (Ma no! Questa prosai-ca/ Gente ch’or ti raccolse,/ Adoratrice instabile/D’arti sfrenate o bolse,/ Oggi forse minaccia/ Quelletue monche braccia/ Di piu fiero dolore:/ Il restaura-tore. (Museo del Louvre 1862)).
La poesia e l’estremo prodotto del sentire ro-mantico, pervaso da sentimenti di eternita, dall’as-soluto, e stride fortemente con la fatica che, sap-piamo, l’archeologia sta facendo per costruirsi co-me scienza, con criteri e metodi rigorosi, e perdelineare oggettivamente ed in modo documentatole antiche popolazioni italiche 12.
LA NASCITA DELLA RIVISTA ARCHEOLOGICA COMENSE 175
12 Cito anche la poesia La mummia di Arrigo Boito, in cui il poeta precorre inconsapevolmente l’acquisto effettuatonel 1887 da Garovaglio, che coincide cosı con la figura del ‘‘paleologo’’ sacrilego; infatti nel testo la mummia sembrasubire violenza da parte della scienza archeologica, poiche viene sradicata dalla sua patria e indagata irrispettosamente,
In questo testo Arrigo Boito accusa gli studiosidi empieta, e la freddezza scientifica sembra blasfe-ma per la sua cecita che vıola la sacralita dei reper-ti antichi, volendoli studiare come oggetti: sembracioe buttare l’‘‘anima’’ per analizzare il ‘‘materia-le’’. La critica e ancora piu stridente se si pensache Arrigo e fratello di Camillo (1836-1914), coluiche ha posto le basi della teoria del restauro, valideancora oggi, percio il restauratore che si permettedi completare un cimelio pregno di divinita, di sto-ria e di bellezza, e ancor piu sacrilego degli altriprofanatori. Se nessuno oggi ovviamente approve-rebbe la posizione calcatamente romantica delpoeta scapigliato, comunque questo fatto ci da lacifra delle varie istanze presenti nella seconda metadell’‘800/inizi del ‘900 13.
I nostri studiosi locali, Barelli, Balestra e Garo-
vaglio (figg. 3-5) si inseriscono cioe coraggiosamen-
te ed intelligentemente in questo grande crogiolo
pur, bisogna dirlo, da inesperti, in quanto sı perso-
ne istruite e sensibili, ma non formate con studi spe-
cificatamente storici, muniti pero delle idee molto
chiare e rigorose dichiarate nel ‘‘Manifesto’’ citato:
salvaguardare, conservare, studiare, pubblicare:
quattro pilastri ancora oggi validissimi.
Come detto un altro grande problema e il re-stauro dei monumenti; anch’esso si sta strutturan-do in questo periodo sulla base del dibattito su co-sa vada conservato e cosa vada abbattuto negli in-cessanti interventi che le strutture conservano.Lavora in prima posizione Serafino Balestra nelgrande ‘‘cimento’’ del Sant’Abbondio, e, del tuttodigiuno di ogni conoscenza specifica, interpellacontinuamente esperti come il gia citato CamilloBoito e il de Dartein, il grande architetto che conmaestria ha rilevato molti degli edifici storici, an-che del Comasco. Se possono stupire ed anche spa-ventare l’ingenuita e la temerarieta di questi perso-naggi che si impegnano in imprese di tale portata,senza le conoscenze adeguate, possiamo ricordareche sono comunque loro che in prima posizione di-fendono questi monumenti.
Vari aspetti sono comuni ai tre fondatori dellanostra Rivista. Uno e che essi sono gia internazio-nali. Il Balestra partecipa a convegni all’estero edunisce nei suoi viaggi l’interesse artistico a quelloprofessionale (si occupa infatti di sordomuti): ‘‘Do-mani parto per Parigi e di la per Chartres, dove so-no aspettato al Congresso archeologico. Androquindi facilmente a Bruxelles, a Colonia, Franco-forte, Basilea, Zurigo, Coira, sempre allo scopo divedere stabilimenti di sordomuti e per esaminar lechiese del Reno, delle quali il nostro S. Abbondiodev’essere sorella’’ 14. La chiesa acquista rinomanzaeuropea ed il restauro compiuto dal Balestra vieneconsiderato ‘‘uno dei piu significativi ed esemplarinell’Italia dell’Ottocento’’ 15. Come si diceva anchela teoria del restauro e in fase di elaborazione, po-chi edifici erano stati restaurati nel senso ‘‘moder-no’’ del termine, per cui non esisteva ancora un re-pertorio di casi di riferimento, sebbene fossero ini-ziati i lavori al Sant’Ambrogio di Milano ed al SanMichele di Pavia. I restauri percio di Sant’Abbon-dio fanno scuola, anche perche Camillo Boito lodefinisce ‘‘un modello di restauro perfetto’’ nono-stante l’autore, il Balestra appunto, non fosse‘‘dianzi archeologo, ne architetto’’ 16.
FULVIA BUTTI RONCHETTI176
Fig. 3 - VincenzoBarelli
Fig. 4 - SerafinoBalestra
Fig. 5 - AlfonsoGarovaglio
tanto che un giorno gli empi studiosi moderni subiranno una sorta di giudizio finale ‘‘E venne il paleologo,/ Divinator de’segni,/ A ordir sul tuo sarcofago/ Cifre di stirpi e regni;/ Fu vıolato intero/ Della tomba il mistero;/ T’han lisciate le chio-me/ E t’han chiamata a nome. (...)
Ma un dı verra, novissimo,/ Che in una cupa valle/ Cadrem, tremanti, pallidi,/ Coi nostri errori a spalle,/ E sentirem latromba/ Che spezzera ogni tomba./ Mummia, quella mattina/ Romperai la vetrina’’. Museo egizio 1862, Torino.
13 Val la pena riportare anche una frase di W. Jensen: ‘‘Che uno debba morire prima di iniziare a vivere?’’ pensa laragazza. ‘‘Ma per gli archeologi questo e ovvio e necessario’’, stralciata dal racconto Gradiva (una ‘‘fantasia pompeiana’’,cosı lo definisce l’autore) pubblicato nel 1903, a cui Freud dedica un saggio; il passo e indicativo di quanto l’archeologiasia percepita come fortemente intrisa, oltre che dell’alone di mistero (che ancora oggi l’accompagna), quasi di mistici-smo.
14 Lettera a F. Valli dell’8 settembre 1869 da Chambery, in L. GRASSI, ‘‘Ristorando S. Abbondio sull’antica forma’’.Note sui restauri ottocenteschi della basilica comasca, in S. Abbondio lo spazio e il tempo, Tradizione storica e recuperoarchitettonico, Como 1984, p. 284.
15 Ibidem.16 Ibidem, p. 283; su Camillo Boito si veda anche L. COSTANZA FATTORI, L’architettura della basilica di S. Abbondio di
Sia Balestra che Barelli sono in contatto con ilMommsen, autore del monumentale Corpus In-scriptionum latinarum (1877). In calce al testo divarie epigrafi riportate nel CIL e nei Supplementa(1888) capita di leggere espressioni come ‘‘Barel-lius misit’’, ‘‘Barellius in Rivista Archeologica’’,oppure ‘‘Balestra descripsit’’. Il Pais scrive(p. 94): ‘‘Vincentius Barellius canonicus Comensiset a cura antiquitatum Comensium, vir patriae an-tiquitatis peritissimus, titulos per hos annos Comivel in agro Comensi repertos investigavit descripsitedidit in ephemeride Fiorelliana et in sua RivistaArcheologica della Provincia di Como’’; ‘‘Seraphi-nus Balestra professor Comensis, qui titulis inve-stigandis tam Comi et in agro quam in regionibuspropinquis operam sedulo dat, titulos, quorum bo-nam partem ipse repperit, edidit in ephemeride Ba-
relliana’’. Notiamo che la Rivista e definita ‘‘delBarelli’’ (‘‘sua’’; ‘‘in ephemeride Barelliana’’).
Il Magni riferisce nella RAC del 1904, nel ne-crologio per la scomparsa del Mommsen, che l’illu-stre epigrafista aspettava sempre con ansia la Rivi-sta che lo aggiornava sui rinvenimenti di iscrizioni,e ‘‘nelle sue gite a Como non dimenticava mai dimettersi in comunicazione cogli scrittori della Rivi-sta, specialmente con il compianto can. Barelli’’,che, in seguito all’incendio che aveva distrutto lasua ricchissima biblioteca, gli aveva spedita anchetutta la serie delle RAC edite.
Internazionale e sicuramente anche il Garova-glio, socio corrispondente della Societa archeologi-ca di Bruxelles, membro della Societa archeologicadi Francia e della Societa degli antiquari di Nor-mandia, socio corrispondente della Deputazionedi storia patria di Torino e grande viaggiatore.
Un altro elemento che accomuna questi perso-naggi e l’eclettismo degli interessi (oltre ovviamen-te all’attenzione all’archeologia), che va dagli studiletterari e religiosi (Barelli), dall’arte ed il restauroallo studio di un metodo di insegnamento per i sor-domuti (Balestra), ai viaggi ed al collezionismo, al-l’incisione, alla politica (Garovaglio).
Hanno anche frequentazioni di alto livello cul-turale: abbiamo citato la collaborazione fornita alMommsen, il rapporto di Balestra con CamilloBoito e de Dartein, e ricordiamo che Garovaglioconosceva il D’Azeglio (che aveva una villa a Lo-veno) ed era amico di Fogazzaro; infatti il patriotaPedraglio di Piccolo mondo antico, e ispirato pro-prio a Garovaglio.
E bello ricordare come gli studi antichi siano
stati presi in carico da altri appassionati della no-stra societa: ed ecco che, riferendoci agli interessidel Barelli, riguardo ai massi-avello ha recente-mente pubblicato un libro il nostro presidenteGiancarlo Frigerio, delle pietre con coppelle si oc-cupa il nostro segretario Alberto Pozzi, ai rinveni-menti di Villa Nessi in Valle di Vico e di Moncuccoha dedicato la sua tesi Mimosa Ravaglia, del no-stro Consiglio.
Gli scavi ed i monumenti comaschi divengonopresto noti a livello europeo, sia grazie alla retedi conoscenze, mutuata anche da altri ambiti (reli-giosi, educazione dei sordomuti), sia per la parteci-pazione a convegni internazionali, e si instaurauno stretto rapporto con esperti stranieri, in parti-colare la Francia costituisce l’interlocutore privile-giato. Gli studiosi locali hanno l’opportunita discambiare notizie di rinvenimenti o opinioni conaltri studiosi, gli articoli sulla RAC si arricchisco-no di confronti con culture transalpine, ed anchei nostri materiali contribuiscono ai dibattiti ar-cheologici in atto. La Rivista entra percio prestoin un circuito europeo, ottiene credito velocementeed e uno strumento preziosissimo con il quale i rin-venimenti del territorio divengono noti agli studio-si nazionali ed internazionali, contribuendo a crea-re un confronto di idee. Addirittura gli articolodella Rivista vengono citati, piu all’estero che ‘‘al-l’interno’’; la Rivista ‘‘Diede vitalita al Museo Ar-cheologico Civico, perche per essa affluiscono i do-ni alla citta e il Museo stesso non avrebbe gran si-gnificato se il materiale raccoltovi non avesse inpari tempo avuto illustrazione scientifica la qualenon gli e data che dalla Rivista’’ (lettera Garova-glio, Magni Riva del 1900 al Prefetto; Archivio So-cieta Archeologica Comense). Si instaura anche unutilissimo scambio di riviste che giungono nella bi-blioteca della societa, che vanta libri ormai rari. Inostri appassionati locali trovano percio documen-tazione, si aggiornano, diciamo che la rivista per-mette all’archeologia comasca di fare il salto diqualita, di entrare in un circuito internazionale.Sfogliando la RAC del 1905, quando il credito del-la pubblicazione e ormai consolidato, constatiamoche gli scambi sono effettuati con l’Archeografotriestino, con gli Atti dell’Accademia di Rovereto,con la Societa di Archeologia di Torino, con Bel-linzona (Bollettino Svizzera Italiana), con il Bollet-tino di Paletnologia di Parma, con Notizie degliScavi, con la Societa Storica Grigionese, l’Anzeigerdi Zurigo, la Societe d’Histoire et d’Archeologie di
LA NASCITA DELLA RIVISTA ARCHEOLOGICA COMENSE 177
Como, in S. Abbondio lo spazio e il tempo, Tradizione storica e recupero architettonico, Como 1984, p. 244; sul problemaC. DEZZI BARDESCHI, Savoir c’est prevoir. Questioni di metodo: dall’archeologia al restauro, in Fernand De Dartein. Lafigura, l’opera, l’eredita 1838-1912, Quaderni di Ananke, 4, 2012, pp. 88-90.
Ginevra, Praehistorische Blatter di Monaco, la Re-vue d’anthropologie di Parigi, la rivista di Etnolo-gia di Berlino, con la rivista Man di Londra, congli Annales di Bruxelles, con il Bollettino di Ar-cheologia di Spalato.
Seguono anni non facili. Dal 1879 fino al 1886la Rivista viene annessa all’Archivio Storico Lom-bardo per aumentarne la diffusione.
Il verbale del 22 ottobre 1898 ha come oggetto‘‘L’unione della Rivista Archeologica Comense colPeriodico della Societa Storica Comense’’. ‘‘Il dott.Garovaglio, stanco per l’avanzata eta, cede nel1898 la stampa della Rivista alla Societa StoricaComense, onde la pubblichi nel suo periodico, co-gli stessi patti gia prima fatti colla Storica Lombar-da’’.
Per evitare la soppressione si prospetta di crea-re una Societa che la finanzi ed ecco che il Giussanidice: ‘‘Non sapendo fare di meglio, faro l’agenteviaggiatore dell’Archeologia’’ e cerca di contattaredei soci che aderiscano al progetto.
La nascita di una nuova societa nel provincialemicrocosmo comasco fa scoppiare una serie dicontrasti, in particolare del presidente della Stori-ca: il 20 febbraio 1902 il Giussani scrive ad unignoto destinatario: ‘‘Ho risposto al dott. Ambro-soli, sperando di calmarlo, ma invece ho avuto ef-fetto contrario, come dalla lettera che le allego.Decisamente egli e nostro avversario. Teme che re-chiamo danno alla Storica, rubandole i soci. Riten-go pero che sia in errore, perche questo intendi-mento e da noi ben lontano. Oggi io gli avevo scrit-to che non sono alieno dal fondere in figurato ledue societa. Ora l’alea iacta est, cerchiamo di uscir-ne in accordo, se no avremo il danno e la beffa’’; edefinisce poi l’Ambrosoli ‘‘un nemico potente’’.
E successivamente ‘‘Il dott. Ambrosoli entranella nostra Societa col solo scopo di fonderlacon la Storica..... Mi pare pero meglio che lascil’Ambrosoli nel suo Medagliere’’.
Il 12 marzo nel palazzo del Civico Museo inComo (Liceo Classico) si prende la decisione co-raggiosa di diventare indipendenti e caricarsi del-l’onere della rivista. Illustra questo momento il
Garovaglio, unico superstite del glorioso trio fon-datore (RAC, 46, 1902, p. 4): ‘‘Ma, col volgere de-gli anni, il valoroso gruppo che ne curava la stam-pa si e assottigliato, e la Rivista, che prima si pub-blicava due volte l’anno, comincio ad uscire unavolta sola, per modo che l’Amministrazione Pro-vinciale ridusse da lire cinquecento a duecentocin-quanta il suo annuale sussidio. Spenti da ultimopressoche tutti Commissari, i pochi coraggiosi su-perstiti piu volte manifestarono il desiderio che laredazione venisse rafforzata da nuovi elementi.
L’invito fu raccolto da un gruppo di giovani di-scepoli, i quali, invece di arrestarsi a questo primoconcetto, ritennero opportuno di approfittare del-l’occasione per togliere alla Rivista ogni caratterepersonale, facendo di essa la palestra in cui ognistudioso delle nostre antichita potesse esercitarsied esporre liberamente i risultati delle sue ricerche.Parve che l’intento si potesse facilmente raggiunge-re colla costituzione di una Societa Archeologica,di cui la rivista fosse l’organo (...). Che la propostafosse felice e sentito il bisogno di dare agli studi ar-cheologici un nuovo e piu vigoroso sviluppo, loprova il fatto che in pochi giorni si raccolsero oltretrenta adesioni, le quali oggi sono aumentate a bensessantotto; adesioni che, facilitate dal tenue cano-ne annuo (L. 10), aumenteranno vieppiu in avveni-re’’.
Concludo con un episodio riferito dal Magni(RAC, 48-49, 1904, pp. 150-153) il quale raccontadi una venuta in Italia del Mommsen nel 1899, du-rante la quale si fermo piuttosto a lungo a Milano,ed alcuni soci della Societa Archeologia cenaronocon lui; una persona, durante la visita al CastelloSforzesco, gli parlo delle recenti scoperte milanesied egli domando: ‘‘Chi se ne occupa con diligenzae competenza? Esiste una Societa Archeologica?V’e una pubblicazione periodica che raccolga tuttele scoperte che si fanno nella citta e nel suo vasto ericco territorio?’’.
Noi oggi non possiamo che confermare quantoorgogliosamente il Magni afferma: ‘‘I suoi voti,per quanto almeno ci riguarda, vennero tosto esau-diti’’.
FULVIA BUTTI RONCHETTI178