Rivista di Studi Pompeiani, XX -2009
Transcript of Rivista di Studi Pompeiani, XX -2009
DirettorePietro Giovanni Guzzo
Comitato ScientificoGiusePPina Cerulli irelli antonio d’ambrosio stefano de Caro
attilio stazio andrew wallaCe-Hadrill Paul zanker
RedazionevinCenzina CastiGlione morelli
antonio varone
Agli Autori si ricorda di comunicare alla Redazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, il testo dei propri contributi, conforme alle norme redazionali, su supporto cartaceo e informatico, completo delle illustrazioni che si ritengono necessarie.
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE AMICI DI POMPEI
© 2010 «L’ERMA» di BRETSCHNEIDER – Via Cassiodoro 19, Roma
© Associazione Internazionale Amici di Pompei – Piazza Esedra, Pompei Direttore responsabile Angelandrea Casale
Rivista di studi pompeiani / Associazione internazionale amici di Pom-pei. -A. 1 (1987)-, - Roma: «L’ERMA» di BRETSCHNEIDER, 1987.-, III.; 29 cm.- annualeISSN 1120-3579
1. Associazione internazionale amici di PompeiCDD 20. 937.005
Periodico: Autorizzazione Tribunale di Torre Annunziata n. 34 del 26-11-1996
Pier Giovanni Guzzo, In memoria di Werner Johannowsky 7
Pier Giovanni Guzzo, In memoria di Giovanni Pugliese Carratelli 9
Pier Giovanni Guzzo, In memoria di Renato Peroni 11
Archivi privati di Archeologi
Archivi privati e interesse storico: teoria e pratica a confronto (Giulio raimondi) 13
Le carte dell’Archivio de Franciscis (vinCenzina CastiGlione morelli) 15
Archivio di Matteo Della Corte (laurentino GarCía y GarCía) 19
Fondo Olga Elia (Grete stefani) 23
Le carte Maiuri conservate presso la Biblioteca della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei (maria rosaria esPosito) 24
Il fondo librario di Amedeo Maiuri presso il Centro Internazionale per gli Studi Pompeiani a Pompei (umberto PaPPalardo) 25
L’archivio privato di Giovanni Oscar Onorato conservato presso la Biblioteca della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei (maria rosaria esPosito) 27
Italo Sgobbo (1991-1993): cenni sulla biblioteca e l’archivio (vinCenzina CastiGlione morelli) 29
Fondo Antonio Sogliano (Grete stefani) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Archivio di Halsted Billing van der Poel (laurentino GarCía y GarCía) 31
___________________
R. antonini, Documenti preromani dalla «Casa di Polibio» (C Iulius Polybius e C Iulius Philippus) 33
M. Grimaldi, Il Tempio di Apollo a Pompei nella Pompeianarum Antiquitatum Historia 39
L. JaCobelli, Pompei ricostruita nelle scenografie del melodramma “L’ultimo giorno di Pompei” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
S. rambaldi, Echi pompeiani ed ercolanesi nella scenografia teatrale del XIX secolo . . . . 61
R. melini, Gli strumenti musicali del Museo archeologico di Napoli 71
A.M. sodo, Il rinvenimento di due sepolture arcaiche in loc Calcarella (Castellammare di Stabia) 77
F. ruffo, Stabiae: Villa San Marco e l’impianto urbano alla luce delle recenti indagini archeologiche (2008) Osservazioni preliminari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
A. Ciarallo, I calchi delle cavità di radici rilevate nelle aree archeologiche vesuviane . . . 103
C. CiCirelli, Le monossili di Poggiomarino: nuovo contributo alla conoscenza della protostoria sarnese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
C. CiCirelli, G. di maio, Insediamenti perifluviali pre-protostorici e ricostruzioni del paesaggio archeologico della piana del Sarno Nota preliminare. . . . . . . . . . . . . 121
V. CastiGlione morelli, L’attività scientifica dell’Associazione Internazionale Amici di Pompei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Sommario
Attività di ricerca nell’area vesuviana
Notiziario
a. d’ambrosio, Ufficio Scavi di Pompei 135
a. Ciarallo, Laboratorio ricerche applicate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
m.P. Guidobaldi, Ufficio editoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
A.M. sodo, Attività del SIAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
B. Cesarano, Il GIS della necropoli di Madonna delle Grazie . . . . . . . . . . . . . . 138
M.P. Guidobaldi, Ufficio Scavi di Ercolano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
V. PaPaCCio, Grandi opere pubbliche di valorizzazione per gli scavi di Ercolano . . . . . 143
M.E. Pirozzi, Interventi di riqualificazione del Parco archeologico di Ercolano. Scarpata nord e Parco attrezzato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
M.E. Pirozzi, Il Parco di Ercolano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
G.F. de simone, M. lubrano, Y.T. amrHein, R. Cannella, Pollena Trocchia, località Masseria De Carolis: Campagne d’indagine 2006-2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
G. bonifaCio, Ufficio Scavi di Stabia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
H. eristov, N. blanC, Peintures et stucs des villas de Stabies: bilan de recherche et nouveaux projets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
D. Camardo, M. notomista, La cattedrale e il borgo medioevale nell’area del Castello di Lettere. Indagini archeologiche 2007-2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
F. seiler et al , Nuove ricerche nella Piana del Sarno, verso la ricostruzione dei paleo-paesaggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
C. CiCirelli, Attività dell’Ufficio Scavi Zone periferiche. . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Discussioni
W. JoHannowsky, Nota sul Tesoro di argenterie di Hildesheim . . . . . . . . . . . . . . 177
Recensioni
F. GiaCobelli, Larari pompeiani Iconografia e culto dei Lari in ambito domestico (M.G. Cerulli irelli) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
D.L. balCH, Roman Domestic Art and early House Church (M.G. Cerulli irelli) . . . . . . 182
Le scoperte di Ercolano (1738) e Pompei (1748) offrirono ad artisti, architetti ed uo-mini di cultura la straordinaria opportu-nità di studiare città antiche ritornate alla luce quasi intatte. Ciò incentivò presto an-che la pratica delle ricostruzioni grafiche dei luoghi così come era possibile imma-ginarli prima dell’eruzione del 791. L’idea era quella di far rivivere, almeno attraver-so il disegno, tutti quei monumenti di cui era possibile ricomporre le forme gene-rali. Ricostruzioni particolarmente accura-te furono realizzate dai giovani architetti dell’Accademia di Francia a Roma, mandati a compiere il loro apprendistato didattico anche a Pompei. Essi, influenzati dall’ope-ra del grande architetto François Mazois, oltre ad eseguire il rilievo di un monumen-to e a disegnare lo stato del rudere, realiz-zarono anche ricostruzioni ideali dei com-plessi in esame, restituendone la struttura, i colori e le forme2. La ricerca dell’ambien-tazione antica fu particolarmente curata anche in molte opere divulgative dedica-te agli scavi. Tra le più famose è il Voya-ge pittoresque ou déscription des Royaumes de Naples et de Sicilie de l’Abbé Saint-Non (1781-86), frutto della collaborazione di al-cuni tra i più dotati artisti, disegnatori ed incisori dell’epoca3, dove, oltre allo stato del rudere, compaiono ricostruzioni dei maggiori monumenti pompeiani. Altrettan-to accurate sono le ricostruzioni proposte da William Gell4 o quelle realizzate dal te-desco Carl Friedrich Weichardt5. La dimen-sione quotidiana dell’antica città risorta, il contesto intimo e familiare della vita delle persone, diventano temi dominanti di que-sti restauri virtuali che si animano di per-
sonaggi di ogni genere. Questo modo di intendere la ricostruzione si coglie anche nelle opere di molti pittori ottocenteschi italiani e stranieri, che daranno vita ad una vera e propria arte ‘neopompeiana’6.
Tra queste molteplici ricostruzioni esiste un filone ancora poco noto e stu-diato, quello delle ricostruzioni teatra-li, in particolare quello relativo agli sce-nari realizzati per il melodramma lirico. Proprio per questo tipo di spettacolo, in-fatti, nel corso dell’Ottocento, vengono realizzati solenni allestimenti scenici par-ticolarmente curati, giocati sulle fughe prospettiche, sulla profondità spaziale e sull’articolazione tra figure in movimento e sfondi architettonici7. Un recente Con-vegno organizzato dall’IRTEM ha eviden-ziato l’importanza e la vastità di questo particolare campo di studi, ancora tutto da investigare8.
Il presente contributo si incentra sull’analisi delle scenografie de L’ultimo giorno di Pompei, un melodramma an-dato in scena per la prima volta il 19 no-vembre 1825 al Teatro San Carlo di Na-poli, in occasione dell’onomastico della regina Maria Isabella9. L’opera di Gio-vanni Pacini, su libretto di Andrea Leo-ne Tottola, è del tutto priva di rapporti con il quasi omonimo romanzo Gli ul-timi giorni di Pompei di Eduard Bulwer Lytton, romanzo tra i più famosi ed imi-tati ambientati a Pompei, pubblicato solo nove anni più tardi (1834)10. La sola ana-logia tra le due opere è appunto l’am-bientazione pompeiana alla vigilia delle tremenda eruzione del 79 d.C.
Pacini e Tottola non sono stelle nel firmamento dell’opera romantica11, ma non sono neanche artisti di scarsa quali-tà. Giovanni Pacini (1796-1867), figlio di un cantante d’opera, cominciò giovanis-simo la sua lunga carriera nel mondo del melodramma. Gli vennero commissio-nate opere dai più importanti teatri lirici
d’Italia e nel corso di un cinquantennio ne compose quasi novanta, alcune del-le quali di grande successo. Andrea Leo-ne Tottola (seconda metà del XVIII sec. - 1831), a lungo denigrato come scritto-re di libretti di scarsa qualità drammati-ca e poetica, viene riabilitato dai critici moderni che gli attribuiscono un ruolo di innovatore nell’opera italiana. Insieme i due artisti realizzarono L’ultimo giorno di Pompei, opera che appartiene a quel filone di tema classico che aveva avuto il suo culmine nel secolo XVIII, ma che ancora nel XIX faceva i suoi proseliti12. La trama è semplice e non manca d’in-congruenze storiche: il pompeiano Sallu-stio è eletto primo magistrato della città, ma proprio durante l’investitura gli viene teso un tranello da Appio Diomede, in-namorato respinto di Ottavia, moglie del magistrato eletto. Con la complicità di Publio, custode delle Terme e del figlio di questi, Appio accusa Ottavia di cor-ruzione ed immoralità, obbligando pro-prio Sallustio, in veste di giudice esem-plare, a condannarla ad essere sepolta viva, procedura questa in realtà riservata solo alle Vestali e dunque di nessuna at-tendibilità storica13. Il risveglio improvvi-so del Vesuvio, proprio nell’imminenza dell’esecuzione della condanna, spinge al pentimento uno degli accusatori, per-mettendo così ad Ottavia di ricongiun-gersi al marito e di mettersi in salvo pri-ma della distruzione della città.
Al di là del valore dell’opera, il pre-sente contributo intende analizzare l’im-magine scenica di Pompei; la resa più o meno veridica dell’antica città; il ruo-lo giocato dalle decorazioni e dagli ef-fetti scenici e l’impatto che l’opera ebbe sull’iconografia pompeiana e sulla pro-duzione artistica dell’Ottocento.
A tal fine un ruolo fondamentale rive-stono le scenografie di Antonio Niccolini, Direttore delle scene del San Carlo e gran
LUCIANA JACOBELLI
Pompei ricostruita nelle scenografie del melodramma L’ultimo giorno di Pompei*
* Desidero ringraziare il Prof. Renato Ruotolo, il Prof. Domenico Antonio D’Alessandro e il dott. Sergio Ragni per le preziose informazioni fornite-mi, la dott. Francesca Colombo, il dott. Matteo Sar-torio e i dipendenti della Biblioteca Comunale di Palazzo Sormani per la disponibilità dimostratami.
50 Luciana Jacobelli
conoscitore di Pompei, per avere tra l’al-tro curato il distacco ed il trasporto del famoso mosaico della Battaglia di Isso14, e per aver seguito in qualità di Direttore la grandiosa pubblicazione del Real Mu-seo Borbonico, sedici volumi in cui era-no disegnati e descritti i reperti pompe-iani ed ercolanesi custoditi al Museo di Napoli (1824-1857)15. All’epoca il Niccoli-ni era all’apice della sua fortuna. Obera-to di numerosi incarichi di architetto, egli fu costretto a ridurre l’intensa attività tea-trale che aveva svolto sin dal suo arrivo a Napoli nel 180716. Nel 1817 era stato no-minato direttore della Real Scuola di Sce-nografia, nel 1820 aveva assunto il ruolo di professore di prospettiva e geometria pratica, e nel 1822 era stato chiamato a dirigere il Real Istituto di Belle Arti. Nono-stante i numerosi incarichi egli mantene-va il suo controllo sugli scenografi titolari del San Carlo, che gli erano più o meno sottoposti17. Dunque, all’epoca della pri-ma de L’ultimo giorno di Pompei il Nicco-lini conservava il suo ruolo di Direttore e supervisore delle scene, come per altro è specificato nel libretto (fig. 1). D’altronde la sua profonda conoscenza di Pompei lo avrà senz’altro portato ad avere un ruolo di primo piano nella realizzazione delle scene dell’opera18. L’importanza data alla scenografia emerge nel dettaglio minu-zioso con cui esse vengono descritte nelle pagine introduttive del libretto. Purtrop-po l’opera napoletana non è, a mia co-noscenza, documentata da disegni, come altre realizzate dal Niccolini ispirate all’an-tico19. È comunque possibile ricavare pre-ziose informazioni sull’apparato sceno-grafico de L’ultimo giorno di Pompei dalla descrizione fattane nel libretto; da accen-ni dedicati dal Pacini all’opera nei suoi Ricordi; dalle entusiastiche critiche com-parse sui giornali dell’epoca, e soprattutto dai bozzetti delle scenografie eseguite da Alessandro Sanquirico per l’edizione del-lo spettacolo tenutasi a Milano nel 1827.
Nella parte iniziale del libretto ven-gono descritte sommariamente le scene del dramma e accanto vi sono apposti i nomi dei realizzatori20:
atto Primo:1. Atrio della casa di Sallustio (Sac-
chetti)2. Ingresso a Pompei dalla parte del-
la strada dè sepolcri (Pelandi)3. Foro di Pompei (Canna)4. Portico del teatro grande (Sac-
chetti)
atto seCondo:5. Basilica (Canna)6. Giardino della casa di Diomede
presso alle mura (Sacchetti)7. Sotterraneo destinato al supplizio
dei rei dal cui portico si vede la strada dè sepolcri (Pelandi)
8. Vesuvio (Pelandi)
Di seguito appaiono delle importanti precisazioni:
«L’interno della casa di Sallustio non è quello della casa conosciuta propriamente sotto questo nome; ma di altra più adattata a far co-noscere il carattere di quelle case di Pompei che non hanno l’atrio Toscano, e sono più grandiose, e più idonee alla località del teatro».
A Pompei la dimora conosciuta con il nome di ‘Casa di Sallustio’ si trova nel-la Regio VI, 2, 4 (fig. 2). Venne riportata alla luce tra il 1805 ed il 1809, e fu deno-minata “di Sallustio” da iscrizioni dipinte
1. Frontespizio del libretto L’ultimo giorno di Pompei (Napoli, ed. Flautina 1825).
2. Pompei, Casa di Sallustio, VI, 2, 4 (pianta).
Pompei ricostruita nelle scenografie del melodramma L’ultimo giorno di Pompei 51
sulle facciate di case ad essa adiacenti e da un sigillo ritrovato al suo interno21. La casa è più volte riprodotta in quadri ed acquerelli dell’Ottocento (fig. 3), e pertan-to era ben nota ad un pubblico colto, e forse questo spiega quanto precisato nel libretto. Dunque la scena non riproduce-va l’atrio reale della Casa di Sallustio, pri-vo di colonne (tuscanico, appunto), ma un atrio colonnato, più idoneo alla sceno-grafia teatrale e più rispondente all’idea di una casa romana diffusa tra il pubblico22.
Di questa prima scena dell’atto pos-sediamo un’acquatinta conservata al Mu-seo della Scala di Milano, ed una litogra-fia edita da Ricordi - che pubblicò anche l’edizione della partitura23 - entrambe del Sanquirico (figg. 4-5). Al pari di altri boz-zetti che discuteremo più oltre, essi mo-strano delle notevoli differenze tra loro sia nell’ambientazione sia nella resa gra-fica. Queste differenze sono in parte da attribuire al fatto che le scenografie del Sanquirico ebbero una duplice diffusio-ne a stampa. All’incirca un’ottantina fu-rono incise all’acquatinta e colorate a mano24, e sono molto più dettagliate nei particolari che non le tavole in litografia (sempre colorate a mano) pubblicate pe-riodicamente da Ricordi e destinate a un pubblico molto più vasto25.
L’acquatinta sembra riprodurre più esattamente la scenografia teatrale, e probabilmente riflette piuttosto fedel-mente anche la scenografia dell’edizio-ne napoletana (fig. 4). Infatti sulle pare-ti dell’atrio corinzio sono ben visibili le raffigurazione di Menadi in volo e nei la-cunari del soffitto, di Menadi e Centauri, temi ricavati da le Antichità di Ercolano esposte (fig. 6), che ebbero un enorme diffusione nella decorazione di ville e di-more lussuose del tempo26. Il tema del-le Menadi, poi, fu ampiamente utilizza-to dal Niccolini anche nella decorazione dei maggiori teatri napoletani27. Meno ri-
3. H. Wikins, Prospetto Casa di Sallustio (1819).
4. A. Sanquirico, bozzetto ad acquatinta del l’atrio della Casa di Sallustio.
5. A. Sanquirico, Litografia dell’atrio della Casa di Sallustio (ed. Ricordi).
52 Luciana Jacobelli
spondenti al carattere ‘pompeiano’ sono le litografie Ricordi (fig. 5): sulle pareti non c’è più traccia delle Menadi e nei lacunari del soffitto compaiono anoni-me figure alate. Due statue dorate su alte basi campeggiano in primo piano davan-ti a due alte colonne. Il tutto è imprezio-sito da arredi e tendaggi di uno sfarzo eccessivo e poco realistico.
Sempre nella parte introduttiva del li-bretto si legge un’altra annotazione, que-sta volta relativa alla scena ambientata al Foro e alla Basilica di Pompei:
«Il Foro e la Basilica sono state in parte modificate per la necessità di restringere l’azione, e la rappre-sentanza degli oggetti nello spazio che può dare il Teatro. In queste due scene si dimostra lo stato di restauro, in cui trovavansi gli edi-fici pubblici di Pompei al tempo dell’eruzione, a cagione del terre-moto, che li aveva scossi e rovina-ti pochi anni prima».
Anche qui, dunque, vengono fatte al-cune precisazioni legate alle difformità rispetto all’originale imposte sia da esi-genze sceniche, sia dalla necessità di raf-figurare Pompei ‘restaurata’ così come doveva apparire prima dell’eruzione.
Poco più avanti nel testo del libretto (Atto I scena VI) c’è un’altra didascalia sempre relativa al Foro:
«Foro di Pompei festivamente adorno. In prospetto il tempio di Giove e lateralmente ad esso i due archi trionfali dai quali veg-gonsi le contrade che introducono al Foro e, di lontano, i vari edifizi della città. A sinistra una tribuna ornata di ghirlande».
Uno sguardo al Foro di Pompei (fig. 7) mostra l’intenzione di dare un’imma-gine archeologicamente veritiera dell’an-tica città. Anche di questa scena posse-diamo i preziosi bozzetti del Sanquirico, che si mostrano abbastanza simili nella resa iconografica e nell’attendibilità ar-cheologica (figg. 8-9). È rappresentata la ricostruzione del lato settentrionale del Foro: il Capitolium, con due plinti che sorreggono delle statue poste ai lati della scala che conduce al podio28; il tempio è affiancato dai due archi onorari, sormon-tati da statue di aurighi bronzei. Ai lati, a mo’ di quinte, è una serie di costruzioni
meno verosimili che dovrebbero rappre-sentare alcuni degli edifici pubblici affac-ciantisi sulla Piazza (Macellum, Lari pub-blici, Vespasiano, edificio di Eumachia, tempio di Apollo); sullo sfondo sono al-tre costruzioni archeologicamente poco attendibili.
Lo scavo del Foro di Pompei, inizia-to nel periodo francese, fu completato dopo il ritorno dei Borbone tra il 1816 e il 1822. Esso costituisce un insieme mo-numentale che, sin dai primi anni del-la scoperta, suscitò un grande interesse soprattutto presso gli architetti, che ne rilevarono gli edifici principali, li dise-gnarono e ne tentarono anche una ri-
costruzione29. C’è da sottolineare che lo scavo era stato completato solo po-chi anni prima della rappresentazione de L’ultimo giorno di Pompei e dunque dob-biamo considerare queste tra le prime ri-costruzioni del Foro. Esse si ispirano in maniera piuttosto stringente alla ricostru-zione proposta da Gell pubblicata pochi anni prima30 (simili appaiono le figure acroteriali del tempio, le bighe sugli atti-ci degli archi onorari, i monumenti sullo sfondo) (fig. 10).
La seconda scena del primo atto pro-pone l’ Ingresso à Pompei dalla par-te della strada dei sepolcri (figg. 11-12). Questa arteria di Pompei è tra i luoghi
6. Menadi da Le Antichità di Ercolano esposte.
7. Pompei, Foro, lato nord.
Pompei ricostruita nelle scenografie del melodramma L’ultimo giorno di Pompei 53
più ammirati e celebrati da artisti e viag-giatori31, e la sua immagine è tra le più riprodotte nei quadri e nelle gouaches Sette-Ottocentesche32. Ne erano state tentate anche ‘ricostruzioni’ come quel-la del Gell, che anche in questo caso è piuttosto simile a quella della scenogra-fia in esame (fig. 13). D’altronde la no-torietà iconografica del luogo non po-teva dare molto spazio alla creatività, e dunque questa scenografia del San-quirico non sarà stata troppo diversa dal bozzetto del Niccolini, che purtrop-
po non ci è giunto. I bozzetti, sia quel-lo ad acquatinta sia la litografia33, mo-strano un’alterazione spaziale senz’altro dovuta ad esigenze teatrali. È raffigurata correttamente la sequenza delle tombe ad ovest: il cenotafio fatto costruire da Naevoleia Tyche (fig. 14, 22), la tomba di Caio Calventio Quieto (fig. 14, 20), la tomba a tamburo cilindrico (fig. 14, 18) e la tomba di Umbricio Scauro (fig. 14, 17), che nella litografia mostra la deco-razione con gladiatori in stucco (fig. 11), ma manca tutta la parte con la cosiddet-
ta Villa di Cicerone e le tombe a schola (fig. 14). Dunque nei bozzetti vengono raffigurate le tombe scenograficamente più attraenti, che appaiono molto più vicine alla Porta di Ercolano di quanto non siano in realtà. Lungo la via dei Se-polcri si trova anche la tomba di Arrio Diomede (fig. 15). Tra il 1771 e il 1774 proprio di fronte, sul lato opposto del-la strada, fu riportata alla luce una Villa che in maniera del tutto arbitraria fu as-sociata alla tomba e denominata Villa di Diomede34. Nel secondo atto una scena si svolge proprio nel giardino della casa di Diomede: di essa possediamo un’ac-quatinta e una litografia del Sanquirico, che appaiono piuttosto diverse tra loro ma filologicamente piuttosto corrette. Nel bozzetto ad acquatinta è raffigurato il grande giardino circondato su quattro lati da un portico a pilastri, con al cen-tro una piscina ed una pergola colonna-ta adibita a triclinio estivo (fig. 16). L’im-magine ricorda il “restauro” della Casa di campagna, come era denominata ori-ginariamente la Villa di Diomede, in un noto disegno del Desprez (fig. 17), inci-so dal Saint-Non nel I volume del Voya-ge pittoresque (1781). La litografia (fig. 18) sembra riprendere il disegno prece-dente, ma con una visione frontale del-la pergola triclinare e con una maggiore fantasia sia nella resa del portico (rea-lizzato con colonne e non con i pilastri real mente esistenti) sia nell’enfasi data alla decorazione della fontana.
8. A. Sanquirico, bozzetto ad acquatinta del Foro di Pompei. 9. A. Sanquirico, litografia del Foro di Pompei (ed. Ricordi).
10. Ricostruzione del Foro di Pompei da Gell (Gell 1817-1819).
54 Luciana Jacobelli
13. Ricostruzione della Porta Ercolano da Gell (Gell 1817-1819).
12. A. Sanquirico, bozzetto ad acquatinta raffigurante Via dei Sepolcri e Porta di Ercolano.
La scena quarta del dramma si svol-ge nel portico del Teatro Grande. Anche in questo caso possediamo i disegni del-le scenografie del Sanquirico, che però non appaiono archeologicamente cor-rette35 (fig. 19). La visione è dai Propilei (che non hanno in realtà una doppia fila di colonne), da cui si accede all’area del Foro Triangolare ed al Tempio Dorico vi-sibile, nel bozzetto, sulla destra; a sinistra è l’ingresso al Teatro Grande. Sullo sfon-do è il Vesuvio fumante, impossibile a ve-dersi da questo lato dal momento che si trova a nord e non a sud della città36.
La scena quinta è ambientata nella Basilica che, come recita il libretto37, ap-pare modificata per necessità sceniche (fig. 20). I bozzetti del Sanquirico mo-strano questo edificio con il suo dop-pio ordine di colonne, ioniche nel piano inferiore e corinzie in quello superiore. Poco definito appare invece il tribunal sul lato di fondo. Nella Basilica si svol-ge il duetto tra Ottavia e Sallustio, a det-ta dei critici una delle parti liriche più riuscite del melodramma, ed il bozzetto ad acquatinta di Milano riproduce que-sto momento topico dell’opera: Ottavia è in ginocchio davanti al marito che è anche il suo giudice, e proclama la sua innocenza.
La scena sesta si svolge nel «sotter-raneo destinato al supplizio dei rei, dal
cui portico si vede la strada dei Sepol-cri». Poiché un luogo adibito a tale scopo non è stato individuato a Pompei, tan-to meno nei pressi della Via dei Sepol-cri, non c’era bisogno di attenersi ad una realtà archeologicamente riscontrabile, e la scenografia sembra essere un assem-blaggio di fantasia, o una combinazione di edifici antichi non meglio identificabili (fig. 21). Dai portici inoltre non si vede la
strada dei Sepolcri, così ben rilevata nel-la seconda scena del Primo Atto, ma una serie di edifici che sembrano anch’essi d’invenzione.
Infine nell’ultima scena si rappresen-ta l’eruzione del Vesuvio che copre di ceneri e lapilli la sfortunata città (figg. 22-23). L’eruzione è vista dallo stesso luogo della scena precedente, il sotter-raneo, nel quale – nella litografia – si
11. A. Sanquirico, litografia raffigurante Via dei Sepolcri e Porta Erco-lano (ed. Ricordi).
Pompei ricostruita nelle scenografie del melodramma L’ultimo giorno di Pompei 55
evidenzia il crollo dei portici. Più inte-ressante appare l’acquatinta conservata alla Scala, che risponde anche meglio alla descrizione che dell’eruzione si fa nel libretto:
«preceduta da orrendo scoppio, si slancia dal Vesuvio immen-sa quantità di cenere e pomici che, innalzandosi rapidamente, piomba sulla città…..Gli abitan-ti sbalorditi e sparsi in vari grup-pi procurano salvarsi colla fuga. Le madri spaventate seco traspor-tano i ragazzi ed i bambini: altre cò loro preziosi arredi. Le Vesta-li fuggono colla loro sacerdotes-sa. Tutto è confusione e presen-ta il quadro della desolazione. La pioggia cresce mista a lampi ed a tuoni».
Così si chiude il dramma, con i prota-gonisti miracolosamente in salvo.
14. Pianta della Via dei Sepolcri.
15. G. Gigante, Pompei Strada de’ Sepolcri. A sinistra la tomba di Arrio Diomede.
56 Luciana Jacobelli
16. A. Sanquirico, bozzetto ad acquatinta del giardino della Casa di Diomede.
17. L.J. Desprez, Vue d’une Maison de campagne (1779-86).
19. A. Sanquirico, bozzetto ad acquatinta del portico del Teatro Grande.18. A. Sanquirico, litografia raffigurante il giardino della Casa di Dio-mede (ed. Ricordi).
Dai bozzetti esaminati e dalle descri-zioni del libretto appare evidente che si volle dare allo spettacolo un’imma-gine attendibile ed animata dell’antica Pompei. Questa verosimiglianza storica è sottolineata anche dall’entusiastica re-censione apparsa il 21 novembre 1825 sul Giornale delle Due Sicilie:
«onore e laude all’Architetto Signor Nic-colini, ed alla fiorente sua scuola; negli scenari di questa produzione noi abbia-mo osservato il vero incantesimo dell’ar-te scenografica. La massima conformità in taluni punti della copia coll’originale nella raffigurazione delle varie parti del-la città di Pompei, produsse negli udito-
ri una mossa generale di sorpresa e di approvazione; colpì poi in modo stra-ordinario l’ultima scena presentante un quadro per quanto grandioso altrettanto desolante e terribile, la distruzione della città sotto la pioggia di cenere e lapilli in mezzo all’inondamento delle fiumane di fuoco che traboccavano dal Vesuvio».
Pompei ricostruita nelle scenografie del melodramma L’ultimo giorno di Pompei 57
21. A. Sanquirico, litografia del sotterraneo destinato al supplizio dei rei (ed. Ricordi).
22. A. Sanquirico, litografia con eruzione del Vesuvio (ed. Ricordi). 23. A. Sanquirico, bozzetto ad acquatinta con eruzione del Vesuvio.
20. A. Sanquirico, bozzetto ad acquatinta con raffigurazione della Ba-silica.
È da sottolineare che questa “con-formità all’originale” sembra essere stata perseguita piuttosto raramente dal Nic-colini scenografo, e ciò emerge sia ana-lizzando i bozzetti di altre opere am-bientate in contesti antichi, sia dalle idee espresse più volte dal Niccolini il qua-le, come abbiamo visto, rivendicava alla
scenografia una libertà creativa che se-condo lui doveva rispondere in primo luogo alle finalità spettacolari proprie di ogni allestimento38. Evidentemente que-sta ripresa filologica dell’antica città di Pompei rispondeva a diverse esigenze: la prima è che l’opera si poneva un fine celebrativo degli scavi che, come abbia-
mo visto, dopo il periodo francese ri-prendevano con successo sotto la dire-zione borbonica39. Un altro motivo è che a quell’epoca, almeno per alcuni luoghi di Pompei, era già radicata una tradizio-ne iconografica che spingeva all’esigen-za di rendere credibile lo scenario entro cui si svolgeva il dramma: troppo diffusa
58 Luciana Jacobelli
era ormai la coscienza visiva del luogo. Infine già da qualche tempo si guardava a Pompei in modo diverso: la città non appariva più solo un sito in cui reperi-re oggetti e pitture come durante la pri-ma fase dell’esplorazione borbonica, ma anche il luogo che forniva agli storici la possibilità di studiare e rileggere l’antico in tutti i suoi aspetti. Come abbiamo vi-sto, era evidente l’interesse di artisti ed architetti a realizzare delle ricostruzioni dei luoghi così come essi se li immagi-navano prima dell’eruzione del 79. Que-sta moda coinvolse anche i figli di Anto-nio Niccolini, Fausto e Felice, che tra il 1854 e il 1896 pubblicarono i quattro vo-lumi de Le case ed i monumenti di Pom-pei disegnati e descritti ricchi di ricostru-zioni delle case, delle strade e dei negozi della città romana. Naturalmente un me-lodramma ambientato ai tempi dell’anti-ca Pompei – tra l’altro, secondo quanto sostenuto dal Pacini nelle sue Memo-rie40 sembra l’idea fosse venuta proprio a Niccolini – offriva l’opportunità di una ricostruzione molto più realistica e im-manente della città distrutta, fascino al quale il Niccolini non solo non si sottras-se, ma che volle il più coerente possibile con l’originale.
Il grande successo dell’opera, più che alla trama piuttosto ingenua e talvolta in-coerente, è da attribuirsi essenzialmente alla scenografia del Niccolini, alla quale sicuramente si ispirarono altri scenografi
come Sanquirico, e alla musica del Pacini. Nelle sue Memorie Pacini ricorda che L’ul-timo giorno di Pompei fu il maggior trionfo del suo primo periodo di compositore, e che gli fruttò un contratto di ben nove anni con il Teatro San Carlo41.
Il buon esito dello spettacolo è dimo-strato anche dalle numerose repliche che si tennero a Napoli tra il 1825 ed il 183042 e in seguito in diverse città italiane ed europee43.
L’entusiasmo suscitato dall’opera, la fedeltà ricostruttiva di alcune scenogra-fie dell’antica Pompei, gli ‘effetti speciali’ dell’eruzione del Vesuvio44, hanno inciso sull’arte del tempo più di quanto sinora si fosse creduto, anche per la mancanza di studi sistematici sui bozzetti qui in di-scussione. Naturalmente l’impatto mag-giore si ebbe nella pittura. A questo pro-posito vorrei formulare un’ipotesi che, spero, non appaia troppo azzardata. La descrizione che si fa nel libretto degli sfortunati abitanti di Pompei in piena eruzione riporta alla mente un famosis-simo quadro realizzato dal pittore russo Karl Brjullov, intitolato proprio L’ultimo giorno di Pompei (fig. 24). Per realizzare questa imponente opera (m 6x4) il pitto-re impiegò tre anni. Il quadro fu esposto per la prima volta a Roma nel 1833 ed in seguito a Parigi, dove vinse la meda-glia d’oro al Salon del 1834. Infine giun-se in Russia, ove il conte Demidov, che l’aveva commissionata per quarantami-
la franchi, l’offrì in dono alla casa im-periale russa. È probabile che all’idea di realizzare la grandiosa tela contribuì proprio la messa in scena dell’opera di Pacini/Tottola. Karl Brujllov giunse a Na-poli nel maggio del 1824 insieme al fra-tello Aleksandr, architetto, che realizzò disegni e ricostruzioni dei monumenti pompeiani. Dopo un breve soggiorno in Sicilia, Karl fu di nuovo a Napoli nell’e-state del 1827, dedicandosi allo studio delle antichità pompeiane ed ercolane-si del Museo Borbonico. Fu proprio a Napoli che Brujllov incontrò il magnate russo Demidov, che stipulò con il pitto-re il contratto per la realizzazione della grande tela sulla fine di Pompei. Dun-que il soggiorno a Napoli dei fratelli Brujllov corrisponde a quello della mas-sima fortuna dell’opera L’ultimo giorno di Pompei45. Niente di più facile che, vi-sto anche il loro spiccato interesse per la città vesuviana, essi abbiano assistito a questo spettacolo di grande successo. Il dipinto è ambientato sulla via dei Sepol-cri, proprio come la scena finale del me-lodramma. Anche i personaggi che affol-lano la via ricordano la descrizione del libretto: «Gli abitanti sbalorditi e sparsi in vari gruppi procurano salvarsi colla fuga. Le madri spaventate seco traspor-tano i ragazzi ed i bambini: altre cò loro preziosi arredi. Le Vestali fuggono colla loro sacerdotessa. Tutto è confusione e presenta il quadro della desolazione. La pioggia cresce mista a lampi ed a tuoni». Nel quadro non ci sono le vestali con la sacerdotessa, ma un sacerdote a destra, che afferrata l’ara e gli oggetti rituali fug-ge a capo coperto. A sinistra c’è una ma-dre che stringe a sé due figlie, dietro si vede un gruppo di persone sulla scala che conduce alla tomba di Scauro che trasportano i loro arredi. Vicino a que-sti una famiglia in fuga, accanto a loro una donna morta con il figlioletto accan-to ed altri personaggi travolti dal tragico evento. Su tutti piovono ceneri e lapilli. Il raffronto con la descrizione del libret-to appare piuttosto stringente, come già il titolo stesso dell’opera.
Nello stesso anno in cui Karl Brujllov presentava al pubblico il suo quadro ve-niva pubblicato The Last Days of Pompeii di Eduard Bulwer Lytton, un romanzo destinato ad un enorme quanto inspie-gabile successo46. Sin dalla sua pubbli-cazione questo romanzo ispirerà il tea-tro47 e poi soprattutto il cinema, sin dagli esordi48. Ma, come è stato giustamente
24. K. Brujllov, L’ultimo giorno di Pompei (1833-34), S. Pietroburgo, Museo Statale Russo.
Pompei ricostruita nelle scenografie del melodramma. L’ultimo giorno di Pompei 59
notato, già dagli anni Dieci del Nove-cento le grandi ricostruzioni dei film storici si rifanno piuttosto che a quel-la del teatro di prosa all’eredità figurati-va del melodramma lirico italiano49. An-che se il modello per tutti fu il romanzo di Bulwer Lytton, l’opera di Pacini-Tot-tola riveste comunque una enorme im-portanza, in quanto ha inaugurato una moda culturale incentrata sul dramma di Pompei che è cresciuta ed è continuata incontrastata fino ai nostri giorni.
AbbreviAzioni bibliogrAfiche
gArcíA y gArcíA 1998: L. gArcíA y gArcíA, Nova Bibliotheca Pompeiana. 250 anni di bibliografia archeologica, I-II, Roma 1998.
gArzyA romAno 1978: c. gArzyA romAno, Interni neoclassici a Napoli, Napoli 1978.
gell 1817-1819: W. gell, Pompeiana: The To-pography, Edifices, and Ornaments of Pompeii, London 1817-1819.
giAnnetti − muzii 1997: A. giAnnetti, r. muzii, Antonio Niccolini architetto e scenografo alla corte di Napoli (1807-1850), Napoli 1997.
guzzo 2003: P.g. guzzo (a cura di) Storie da un’eruzione. Pompei Ercolano Oplontis. Guida alla mostra, Milano 2003.
JAcobelli 2008: L. JAcobelli (a cura di), Pompei la costruzione di un mito. Arte, letteratura, aneddoti-ca di un’icona turistica, Roma 2008.
lAbinAux 1998: g. lAbinAux, L’ultimo giorno di Pompei (Le dernier jour de Pompei), opéra de Gio-vanni Pacini e Andrea Leone Tottola, in Il Vesuvio e le città vesuviane 1730-1860, Napoli 1998, pp. 497-508.
mAncini 1980: f. mAncini, Scenografia napoleta-na dell’ottocento. Antonio Niccolini e il neoclassi-co, Napoli 1980.
Pompei 1981: AA.VV. Pompei e gli architetti francesi, Napoli 1981.
PPM: Pompei. Pitture e mosaici, I-V, Roma 1990-1994.
redi 1994: r. redi (a cura di), Gli ultimi giorni di Pompei, Napoli 1994.
Scherillo 1984: A. Scherillo , Il Vesuvio e Pompei nel melodramma italiano dell’800, in Atti AccPont. N.S. 1984, pp. 331-338.
note
1 Sul tema delle ricostruzioni anche JAcobelli 2008, in particolare p. 21 sgg.
2 Pompei 1981, soprattutto da p. 67 sgg. 3 Si veda per la bibliografia gArcìA y gArcìA
1998, II, p. 1029 sgg.4 W. gell, Pompeiana: the topography edifices,
and ornaments of Pompeii, London 1824.5 C.F.W. WeichArdt Pompeji vor der Zerstoe-
rung. Reconstructionen der Tempel und ihrer Um-gebung, Leipzig 1897.
6 Recentemente si è avuto un proliferare di stu-di sull’argomento, mi limiterò a citare: e. Querci, S. de cAro (a cura di), Alma Tadema e la nostalgia dell’antico, Milano 2007, con numerosi contributi sull’argomento.
7 S. PArigi, La rievocazione dell’antico, in redi 1994, p. 67.
8 L’antichità greco-romana nell’opera lirica ita-liana dell’Ottocento, Convegno organizzato dall’IR-TEM (Istituto di ricerca per il teatro musicale), Ca-stellammare di Stabia, 14-16 novembre 2008.
9 Su quest’opera: Scherillo 1984, pp. 331-338; R. redi, La tragedia di Pompei in teatro, in R. redi 1994; lAbinAux 1998, pp. 498-508; F. PeSAndo, Om-bre di luce: il cinema peplum e Pompei, in guzzo 2003, pp. 35-45, in particolare pp. 36-37; JAcobelli 2008, pp. 37-38.
10 Sul romanzo si veda da ultimo: E.M. moor-mAnn, Evocazioni letterarie dell’antica Pompei, in guzzo 2003, pp. 15-33; J. meddemmen, “Destare a nuova vita la città dei morti”. Gli ultimi giorni di Pompei di Edward Bulwer (1834), in R. cremAnte et al. (a cura di), I misteri di Pompei. Antichità pom-peiane nell’immaginario della modernità, Atti del-la giornata di studio (Pavia, 1 marzo 2007), Pompei 2008, pp. 33-51.
11 lAbinAux 1998, p. 498.12 Scherillo 1984, p. 333.13 Assolutamente sproporzionata ed impensa-
bile per una società civile come quella romana del I sec d.C., quando i casi di adulterio si condannava-no – ed assai di rado – con la relegatio in insulam, secondo la legge Iulia de adulteriis, promulgata da Augusto e che colpì proprio la figlia dell’imperato-re, Giulia, relegata in una villa a Ventotene.
14 A. niccolini, Ricordi di taluni fatti, riguar-danti il distacco da terra, il trasporto e la colloca-zione del gran musaico Pompeiano. In confutazio-ne di quanto fu su di ciò divulgato, Napoli 4 giugno 1849, Napoli 1849, p. 12 sgg. La nota fu pubblica-ta dal Niccolini per rivendicare la soluzione da lui inventata per il trasporto del mosaico, che Pietro Bianchi e Gennaro Belliazzi volevano invece far passare come propria.
15 Si veda gArcíA y gArcíA 1998, pp. 846-848 e 857-859.
16 Questo doppio ruolo di scenografo ed archi-tetto lo portò più volte a realizzare in architettura alcuni dei suoi disegni scenografici (cfr. giAnnetti − muzii 1997, p. 12 con note bibliografiche). Inoltre, come architetto egli si ispirò più volte a Pompei: nel 1816 aveva creato per Ferdinando I nel Real Sito del Chiatamone una perfetta ricostruzione di un tempietto “ad immagine di quelli di Pompei” (cfr. A. giAnnetti, Il giardino napoletano dal Quat-trocento al Settecento, Napoli 1994, pp. 115-118), e molte delle sue dimore napoletane si ispirano all’antichità pompeiana (cfr. gArzyA romAno 1978).
17 Così mAncini 1980, p. 29.18 Sembra che l’idea di un’opera ispirata a Pom-
pei fosse nata proprio al Niccolini, cfr. infra, p. 58.19 Cfr. mAncini 1980 e giAnnetti, muzii 1997, p.
42.20 Il libretto della prima fu stampato a Napoli
dalla tipografia Flautina (se ne conservano alcuni esemplari al Museo della Scala, al Conservatorio Napoletano e all’Accademia Pontaniana).
21 PPM, IV, p. 87 sgg.22 Niccolini era assertore del principio che sul-
la scena un edificio dovesse rispondere a caratte-ristiche che lo rendessero immediatamente ricono-scibile alla massa del pubblico, anche a rischio di sacrificare la correttezza della ricostruzione storica (cfr. giAnnetti − muzii 1997, p. 13). Tuttavia la real-tà storica di Pompei e la sua fama, rendevano in-dispensabile specificare quello che veniva adattato alle esigenze sceniche.
23 P. goSSet, Italian Opera 1810-1840, New York-London 1986, vol. 32.
24 Queste tavole sono di formato di cm 30 × 40 circa. Le tavole all’acquatinta venivano raccolte in edizioni in genere stampate ad personam, con un frontespizio studiato appositamente, di volta in vol-ta. Elenco qui di seguito alcuni dei frontespizi del-le edizioni conservate al Museo Teatrale alla Scala: “RACCOLTA / di varie Decorazioni sceniche/ inven-tate ed eseguite per l’I. R. Teatro alla Scala / da / Alessandro Sanquirico / Architetto Pittore scenico degli Imperiali Regi Teatri di Milano / Membro di quella R.I. Accademia di Belle Arti / e di altre d’I-talia / Dedicata alla Signora Antonietta Corbellini / Pasetti”, contiene 73 tavole + 1 tavola con i dodi-ci figurini dei personaggi dell’opera L’ultimo gior-no di Pompei.
“Raccolta / di / varie Decorazioni sceniche / in-ventate ed eseguite per l’I.R. Teatro alla Scala / da / Alessandro Sanquirico / Architetto-Pittore scenico degli Imperiali Regi Teatri di Milano / Membro di quella I. R. Accademia di Belle Arti / e di altre d’I-talia / Dedicata / alla / SACRA MAESTA’ DI CARLO ALBERTO / Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusa-lemme; / Duca di Savoja e di Genova, / Principe di Piemonte / ecc. ecc. ecc.Contiene 74 tavole
Scelta / di Sceniche Decorazioni / inventate, ed eseguite dall’Architetto, Pittore Scenico / Alessandro Sanquirico/ e dal medesimo consacrate / all’esimio merito della Celebre Cantante ed Attrice / GIUDIT-TA PASTA / in attestato della verace inalterabile sua stima”, contiene 24 tavole.
25 Le litografie sono in numero maggiore del-le acquatinte. Il loro formato è di circa 15 × 21 cm. Devo queste informazioni al Dott. Sergio Ra-gni, che ringrazio. Tutte le litografie qui riprodotte appartengono alla collezione Ragni.
26 Si veda per i temi rappresentati Le Antichità di Ercolano esposte, I, t. XX, p. 109; t. XXV, p. 135; t. XXVI, p. 41.
27 P.L. ciAPPArelli, Il “teatro pompeiano” di Fau-sto Niccolini, in G. AliSio et al., I disegni d’archi-vio negli studi di storia dell’architettura, in Atti del Convegno (Napoli, 1991), Napoli 1994, pp. 178-181. A proposito del San Carlo il Niccolini dichia-ra esplicitamente: “La maestà di Ferdinando I … allorché si era benignata incaricarmi della riedifi-cazione del Real Teatro S. Carlo … ordinò al fu Duca d’Ascoli che mi fosse dato dalla medesima biblioteca un esemplare dei Volumi dell’Ercolano per prendere qualche disegno degli ornamenti del-la sala”. Cfr. gArzyA romAno 1978, p. 77.
28 Contrariamente a quanto rappresentato si trattava di due statue equestri, come si deduce dal rilievo del larario della Casa di Cecilius Iucundus; A. mAiuri, L’ultima fase edilizia di Pompei, Roma 1942, p. 10 sgg.
29 Si veda F. mAzoiS, Les ruines de Pompéi, des-sinées et mesurées, Paris 1824-1838; Pompei 1981, p. 108 ss.
30 La prima edizione di Pompeiana di William Gell è del 1817-1819. Egli visitò Pompei per la pri-ma volta nel 1815 e si stabilì definitivamente a Na-poli come rappresentante plenipotenziario del-la Società dei Dilettanti in Italia, nel 1820. Si veda gArcíA y gArcíA 1998, I, pp. 545-547.
31 Si veda, tra i tanti, il commento di W. goethe, Viaggio in Italia, 13 marzo 1787.
32 Alcune di queste innumerevoli immagini sono riprodotte in l. fino, Ercolano e Pompei tra ’700 e ’800. Acquarelli, disegni, stampe e ricordi di viaggio, Napoli 2005.
60 Luciana Jacobelli
33 Nel bozzetto ad acquatinta conservato al Mu-seo del Teatro la Scala la didascalia è errata per-ché è scritto Porta Nolana e non Porta Ercolano. La didascalia della litografia è corretta, menzionando Via dei Sepolcri.
34 Sulla villa cfr. t. roCCo, La Villa di Diomede, in Guzzo 2003, pp. 226-232, con bibliografia pre-cedente.
35 Anche in questo caso, come nel precedente, la didascalia dell’acquatinta è scorretta, in quanto nomina l’anfiteatro e non il teatro, dove si svolge l’ultima scena del Primo Atto cfr. infra, p. 50.
36 Dal Foro triangolare e dal Teatro sono visibili i monti Lattari ed il Faito.
37 Cfr. infra, p. 52.38 Si veda infra, nota 20 ed inoltre manCini
1980, pp. 28-29. Si veda anche la lettera inviata al Monitore delle due Sicilie il 17 dicembre 1811 per difendersi dalle accuse di scarso rigore storico nel-le sue scenografie (Giannetti − muzii 1997, p. 13).
39 Come abbiamo visto tra il 1815 ed il 1832 si esplorarono molti edifici del Foro: Basilica (1813-19); Tempio di Apollo (1817-19); Tempio di Giove (1816 sgg.); Macellum (1818-21); Sacello dei Lari Pubblici e Tempio di Vespasiano (1817); Terme del Foro (1824).
40 Così sCHerillo 1984, p. 333.41 «Fu un lavoro che entusiasmò tutta Napo-
li e mi fece acquistare una fronda di alloro che era ben difficile conseguire presso quella musica-le popolazione. Ricevei lettere di congratulazioni per ordine di Sua Maestà il Re Francesco e fui no-minato socio corrispondente della Real Accade-mia di Belle Arti. Il Barbaja, dopo tanto clamoro-so successo, mi propose per nove anni il contratto qual direttore dei suoi teatri, ai medesimi patti e condizioni che il sommo pescarese [Rossini] ave-va ottenuto”.
42 Stagione 1825-26: 18 rappresentazioni; sta-gione 1826-27: 6 rappresentazioni; stagione 1827-
28: 11 rappresentazioni; stagione 1828-29: 10 rappresentazioni; stagione 1829-30: 5 rappresen-tazioni.
43 Milano, La Scala (prima il 16 agosto 1827), Venezia, La Fenice (prima carnevale dell’anno 1831-32), Roma (1828), Vienna (1827), Parigi (Théatre des Italiens, 2 ottobre 1830).
44 Talvolta su alcuni libretti (per es. ‘fuochi-sta’) è riportato anche il nome dell’illuminatore e quello per la messa in scena dell'opera al teatro La Fenice.
45 Cfr. nota 42.46 Cfr. nota 10 e JaCobelli 2008, pp. 11-12, 17
sgg. e 36.47 R. redi, La tragedia di Pompei in teatro, in
redi 1994, p. 63.48 redi 1994.49 E.M. marGadonna, Cinema ieri e oggi, Mila-
no, Domus 1932, p. 122 e s. PariGi, La rievocazione dell’antico, in redi 1994, p. 67.



















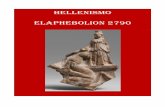
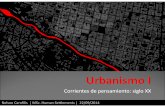









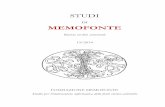
![Nexos sociais e violência. o caso do conflito de 2004-2005 entre os Maxakali [Quaderni di THULE - Rivista italiana di studi americanistici]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631ca29ba906b217b9070cd6/nexos-sociais-e-violencia-o-caso-do-conflito-de-2004-2005-entre-os-maxakali-quaderni.jpg)





![La rivista del Turismo TCI Febbraio[1]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631b01c3d5372c006e03bf8c/la-rivista-del-turismo-tci-febbraio1.jpg)

