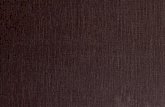Rivista Italiana Paleontologia - Forgotten Books
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Rivista Italiana Paleontologia - Forgotten Books
R IVISTA ITAL IANA
PALEONTOLOG IA
.REDAT T ORE
‘
P . VINASSA ma: REGNY
COLLABORATORI
FR. BASSA.\II G. G. B .\SSOLI G. CHECCH lA - RISPOU
E. FLORES M . GORTAXI C. PARISCH P. L. PR EVER
G. ROV EREDO D. SANGIORGI A. SILV ESTRI 0. VIALE
Volume XII. Anno 1 906
P E R UG IA
T I P O G R A F I A G U E R R I E R O G UE R R A
INDICE DEL VOLUME X II.
l l . Po u l ] ! d e l q ua l i «Il t r a t to n e l l av o r ] r e c e n n l t l .
Piante pag. 8,72
Foram in ì feri Il , 1 3 , 63, 67 , 70,
73,Rad iolari
Uom ilari 63
Graptoliti 72
Echinodermi 6 1,67
"I . T e r r e n i d e l q ua l i n l
pa'. 72
7 1,73
73
9 65
62 66
63
1 2, 63, 65. 67, 60
Crostacei pag. 5. 6 1 , 62, 66, 74
Molluschi 62, 65, 66 , 67
Cel”
nloxw li 62
Pesc i 1 . 10
C e tacei 4
Problematici 65, 7 1
t r u t h n e l l.vo r l r e c e n n l t l .
Terziario. pag. 6 1 , 69. 70, 7 1 , 1 38
Em ene 5,9,1 2
,1 3
,62
,63
,65
,67 ,
1 37
Oligocene . 74
M iocene . 7 , 65 74
Pliocene . 4,66
,1 40
Quaternarie 1 5 8 1 39
I V . E l e n c o d e l l e n u o ve fo r m e d e s c r i t t e n e l l a vo r ] I ta l i a n i .
aenleata (Collina)Almerai (Ax csmilia).Almerai (Convex astraen)amphinra (Cythere ) .
apmndiculatus (Oph id ium)arcuatus (Otolithus) .
arthaberoides (St emm a)Bassan ii (Gratelenpia)bellar0phentis (Pecten) .
bifenestrata (Dietyoeha)Bofilli (Ax eszn ilia)Benarelli i Hammateeerae)br ibirensis (Rissoina).hnranense (Harpoceras).calabra (
Cythere) .
calcarata
Lanavari i Al w ohna)Canavar i i ( 1 oe !oeeras) .
Canw aì (Bellem pbon ) .
carbon ifera Ily0pbm nopsis)ca1 n ica (Myophorîa) .carn icns (Bellonephen)carrubaren9 is
Casagnasi (Peplusm ilia)catala m ica
datalaunica Thecosm ilizi)Catefi nae (Huldoceras)(
‘
belnssii (Li llm )(
'
helnss ii Paronaia) .C iofaloi (Alveolina)Cioh loi (Lepidocyclina).
clarus Perisbed ien)contortus (Maa nrns
)Coqnand i (Peplesm i ia)Cremai (Alveeh
'
na)i ici (Cer ith ium ;dalmatina (Pleurotomaria)dalmatinus (Trochus)De Angelisi Bollew phon )De Stefam i (Postalia)Dieneri (Liebea)Di Stefanoi (Alveolina) .Di Stefane i (Ont hephragmma)Doderloin i (Lhrys0ph rys)elongata (Rnpertia)ex pansus (Orthothotes)Fe l lX i
foroj ulw nsis ( I’seudomenotus)
fragi lis (Otholitu‘ì )Frech i (Epismilia)Frome :fleli Peplosm il ia)Gnhr iellinae ( t
‘
ladecera)gibbus (O'holitue)Guiec i&rd im i (Id lecetus
)h imaerensis (Lep idneyc ina)iber ca
incamjana (Gervilleia)nw arojens is (Aviculopecten )in llntus (Otholithus) .
irregularis Psew lom0notis
Italiae (Lytocoras )italicus (Bellerephen)
INDICE DEL VOLUME X II.
italiens (Hemiramphus) .Kobyi (Pleurosmilia)Koken i (Solea)laev igata (Cytheridca)l.avallei (Cyrtocapsa)Lemoinei (Lepidocyc ina)Linas (Cellina)lobatus Platessa).luc idus (Lahmx )maem ra Cylhere)magnum (Oph id ium) .max imus (Macrurns).Mazzaretii (Murchis n ia)m iocaen icus (Trachiurus)mirabilis (Trigla)mut inensis (Otholitus)Nevian i i (Trochosmi lxa) .novus Macm rus) .
Og ì lv iei (Epìsm i lia)orbicularis (Hoplosthetus)ornatus (Mac rurus)estrov izense (Cerith ium )ostrow zensis (Sca‘aria)I’ar t . 0 6 1… (Oph id iurn)l ’aronai ( Ilurchmon i
parvulus (Oph idium ).
patens (Solea)paularensis Astarte) .
perforatus (Heplosthetus)I’ ietralatae (Ha.poucras)I‘ironaì ( l loerw s in)pizzulana (Archaeoe idaris)planulata (Lep 1decyclina)Pertusi (Trochm wm lìn )
praerubeseens n‘
epe la 1
| nseudocaenus ( l‘ecten )
pulcher (Oph id ium)
Radimm (Trochus)rad imskyanum (Cenithium)relictus (Inocexamus)Salinch ìeti (Pecten ) .
Salvanii (Av icula)sandalina (Ti cchosmilin)Sax elensis (Opli id inm) .
Schuhe…‘
i1 harus) .Schw ageri Alveolnna)seguenz iana ( l
’seudocythere)
S * lver ì i (Avicula) .Speronatus (Dentex )Staebe i (Cassianella).
suhelliptica Cytherura
subfovcolata bythere) .
sublatissima
subm0rchelia (Latimanduaea)sulcatus (Olhohtus)Taramelli i Ceelocerns)Taramelh i (Conocardium )Tara… elli i (Sigillaria)Taramclh i (Spiriferina)Thi ldae (Pcplosm ilia)Tommasn IB°IIOI°OPIIOIÌ )Temmasii (M w hisen in)tuhexculatus (0 1 11 01 tus)L
'
h ligi (h upentia)un ices ln us )urbiense ( [ h idecems)vac ianense
Vaughn… ( l’ lcuresm iha)
\'
id : l ll (Ap losm iha)\
'
iua.ssai
\'
massai l IIe « -ke lla)V ie l… (Alveolma)\
'
isuan in (Sealan a)Voltzi Plcuresmifia)
2 RIVISTA ITALIANA
gli al tri , er pr ivi della testa o di una parte del tronco e di qualche
p inna e coi raggi spezzati .
L’
autore confronta l’ittiefanna in discorso con quella raccolta
nei Tr ipoli della Sicilia, della Calabria, delle Marche, della Romagna
e della Toscana,nella marne sarmatiane della Croazia e nella
argille subappenn ine della Toscana, del Bolognese, dell’Ast igiano acc.,
r ilevandone le strettissime affinità ; e conclude che le marne argille
se di Taranto e di Nardò di formazione marina, 9. tipo litorale
vanno assegnata al Plistocene inferiore
Da ultimo,r iassumendo le r isultanze delle proprie ricerche e di
quelle d i altri paleontologi (0 . G. Costa, C. Fornasin i , A. da Gaspa
r is, M . Pasquale, O. Frans), egli dà il seguente elenco delle specie
vegetali e animali rinvenuta nelle dette argille marnose
TARANTO
Nedeaaria sp.
ALGAE
Chactomerpha crassa Ag. Sp .
Codium tomentosum Ag.
Dictyota d ichotoma Ends. sp.
Callithamn ien grannlatum Duel. sp.
Gratalonpia Bassani i da Gasp.
Dudresnaya coceinea Ag. sp.
Delesseria crispa Z anard.
Gel id ium corneum Huds. sp.
RHIZ OPODAClavul ina communis d
’
Orb.
Glandulina retundata Ras.
Lagena striata d’
Orb .
Marginn1ina glabra d'
Orb.
M . glabra d'Orb. var. subbullataHantk .
Nodosar ia commun is d'
Orb.
N commun is d’
Orb., var. annoiataBas.
Nodosaria h ispidtt d'
Orb.
Pelyrn0rph ina amigdaleides Rss., var.
pida Fern.
BRAC HIOPODAOmn ia ringans Hòn ingh .
Terebratula (Liothyrina) vitrea Born.CRINOIDEA
Antedon rosaeea Norm.
ECHINOIDEASehizastar canalifarus Ag.
Spatangus purpureus Lenka.
PELECYPODAAnemia sp.
Chlamys inflax a Poli sp .
Mactra triangnla Ren
Pinna sp.
Tallinn (Entellina) donaeina L.
Tellina (Id .) incarnata L.
Tellina (Id .) serrata Ren.
A questa stessa conclusione è giunto anche i l prof. Aurelio da Gasperis
con l’
esame,testè compiute , dalla alghe (Le alghe delle argi lle mam an p lei sto
con iche d i Taranto,in Atti R. Ace. se. fis. e mat. di Napoli, volume XII, sa
rio n .°
DI PALEONTOLOGIA 3
Thracia papyracea Poli sp. (T. phasecli
na Lam.
GASTROPODACclumbella rustica L. sp.
PISCES
Careharcdcn Rendeleti M. et H.
Ox yrhina Spallanzan i i Benap.
Myliobatis aquila L. sp .
Syngnathus acne L.
Hippocampus antiquorum Leach
Nyetephus can in ianus G. et V. sp.
Nyctcphus Rafinesquei (L eee
Nyctcphus Kissoi Cocco sp.
Nyetcphus sp.
Maurolicus Pavvariae Coecc sp
Maurolicus amathystinc—puneh tus Cecco NARDO
Maurolicus attenuatus Cecco
Balena seus Bisso PISCES
Recmbrescx Rondeleti G. et V Mullus barbatus L.
Gadus peutasseu Bisso Secmb r seomber L.
Merluceius vulgar is Elem. Lepidcpus caudatus Euphr. sp.
Solea lutea Bisso sp.
F. BASSANI .
Bm w : B . Le varie facies del Miocene medio nelle colline di To
rino. Boll. Soc. 9601 . i t., XX IV ,2, pag. 607 -653.
È un lavoro molto interessante, e che sarebbe bene r ipetere per
parecchie altre region i italiane destinate a mostrare la diversità
della fauna nelle d iverse facies dell’
elveziano dei colli torinesi .
Secondo l’
A. 1 van piani muccemcx hanno sign ificato cronolo
gico, ed in ciascun piano si possono distinguere varie facies con fauna
d i abito difi'
erente.
Le facies in cui l’
A. d ivide i l miocene medio sono cinque e
cioè : dei grossi molluschi litorali ; dei gasteropodi litorali e dei cc
rulli ; delle turr itelle ; dei litctamni e delle lucine ; dei ptereped i.
Un lavoro del genere per il pliccene d i Castallarquatc fu esegui to dal Dr.
Levi, e pubblicato in questa stessa Rivista, anno VI, pag. 59.
Balistt s capriscus Gm.
Heliastes chromis L. sp.
Dentex ap . (cfr. vulgaris C. et V.)Chrysophrys aurata L. sp .
Ch rysophrys caarulecstieta 0. et V .
Cran ilabrus I? )‘
sp.
Trachypterus ir is Walb. sp.
Z eus faber L.
Seember scomber L.
Trachurus trachurus L. ap.
Seriola Dumerili Bisso
Fam . ? (Ossa ingrossato per iparcstcsi) .MAXIMALIA
Tursiops tarsie Fahr. sp .
4 RIVISTA ITALIANA
Le singole facies sono descr itte accuratamente e na vien data
la fauna in r icchi elenchi .
L’A. concluda l
’
importante memori a osservando che i vari pian i
m iocen ici sono depositi di mari successivi ; che l’
alveziano mostra
varie facies distinte per natura litologica e per habitus bat imetrico
della fauna ; che la faunaes tipo di clima caldo non tropicale ; e che
la sua presenza non è incompatibile cci ghiacci galleggianti , a non
contraddice quindi all’ipotesi del Gastaldi relativa all
’or igine dei con
glomerati delle colline di Torino. V
Cu a mm G. Balena tessili toscana. lll. ld iecetus Guicciardinn
M em . R. Accad . Sc. Ist. Bologn a, Ser ie V1 , Tomo Il , Bo
logna 1 905, pag. 1 0 con due tavola.
Il genere Idi oc etus fu fondato dal prof. Capellini nel 1 876,in
una nota Su le balene foss i li toscane, su alcun i resti di cetacei rin
venuti a Montopoli nel Valdarno e conservati nel museo di Geolo
gia di Firenze. In questa memoria 1’Autore mantiene la promessa
fatta ai Colleghi Lin cei nella seduta del 2 gennaio 1 876 e descrive
gli avanzi.
La prima parte d el lavoro r iassume notizie storiche sui resti di
Montopoli e sulla or igine del genere Idiocetus, con un cenno alle spe
cie del bacino d’Anversa riferite dal Van Beneden alle stesse ge
nere. Nella seconda parte sono descr itti gli avanz i fra i quali e im
por tantissimo l’
apparato uditivo e l’
atlante. Riguardo all’apparato
uditivo fa notare che le casse timpauicha dell’
Id iocetus lamotua di
Anversa,descritta dal Van Beneden , discerdano completamente con
quelle dell’Id iocetus di Montopoli , e che piuttosto sono da riferirsi al
gen . H eterocetus .
Da quanto l’
A. r ileva può resultare evidente che il gen . Id io
cetus abbia rapporti con le balene e le balenc ttere, accordandosi pe
rò meglio con la pr ima. Quegli avanzi di Anversa descr itti dal Van
Beneden,invece
,sono più da accordarsi con le balencttere. E l
’illu
stre Autore così conclude : Ora che sono pubblicate le figure degli
apparati uditiv i , della mandibola, dell’
atlante,delle scapola, r iesce fa
DI PALEONTOLOGIA 5
cile di istituire confronti con i misticati d’Anversa r ifer iti al genere
Idiocetus e convincersi che volendo mantenere per essi il nome del
genere fondato coi resti della balena di Montopoli, bisognerebbe pri
ma dimostrare che per quei resti non dovevasi creare un nuovo ga
nere, ma che invece si potevano r iferire al vero genere balena,ciò
che non torna in nessuna maniera E. Frears.
Onmecnu —Rrsr cu G. L’
At e l e c ye l us r e tun datus Olivi, fossile
nel postpliocene dei dintorni di Palermo. Natural. Sivi l.,X VIII
,
4, pag.
.4 e 1 fig .
Nel postpliocene palermitano sono rari i gusci di crostacei ben
conservati . L’A. quindi ha creduto interessante descri vere une scu
do di Atelecyclus rotundatus di Ficarazzi,assai ben conservato
,del
quale da una figura. V .
Camomn-Rrsrou G. Sull’
oceano di ChiaromonteGulli in provincia
di Siracusa. Rand. R. Acc. Lincei,X IV
,2°
sem.,1 0
, pa
gine 528-529.
Il r invenimento fatte dal dottor Ragusa d i calcari nummulitici
in posto a Chiaromonte-Gulfi e molto interessante. L’
A. dallo studio
della nummuliti ha ri levato trattarsi d i ceceno medio. V
CHECCHIA -RISPOLI G. Sopra alcune Alveoline oceaniche della Sicilia.
Palaeon tographia Italica, vol. X I, pag. 1 47- 1 68,tav . X II
X III. Pisa,1 905.
Vediamo con piacere la comparsa di questo lavoro, atteso già da
qualche tempo, essendo desse accurato, ben condotte,e tale quindi
da serv ir d i buona guida in nuove r icerche sulla Alveoline in gene
rale,a le italiane in particolare.
L’A. vi esamina
,con profonda conoscenza dell
’
argomen to, le
Alveoline avuta in istudio dai professori G. Di Stefano e S. Ciofalo,
6 RIVISTA [TALIANA
provenienti dalla prov incia di Catan ia (regioni Sparaccgna e Freehissa
tra Centuripe o Catenanucva) o dei d intorn i della ormai classica lo
calità di Termin i-Imerese in provincia di Palermo (regione Rocca),
promettendo una opportuna introduzione geologica sul loro giacimento,
in cui conclude con l’
attribuiruo il principale all’ eccone superiore ;
ed anche : la storia del genere Alveolina, alcune considerazioni tas
sinomiche, morfologiche, strutturali , e sull’
habi tat di esso, e l’
ospe
siz iono dei cr iteri adottati per d istinguere le specie. Consistonti que
sti nel tener conto della forma esterna, logge d’avvolgimento della
lam ina spirale, diverso numero dei giri su d’
uno stesso raggio, anda
mento genoralo della lam ina, numero della concamerazicn i pr incipali
per ogn i g iro, numero e forma delle collette trasversali per ogn i con
cameraziono pr incipale, forma dei canali settali .
Le specie descritto dal Cheechia uniformandcsi a tali criteri sono
lo : Alveolina ellipsoida li s Schw ager. e var. lep idu la Schw ager ; A.
eramaa Checch ia . (perchè non oramai A. ciofaloi Checchia ; A. cfr .
oblonga d’Orb igny ; A. eanavar iz
'
Chocch ia ; A. elongata d’Orbigny ;
A. schw ager i Checchia ; A. d i-stefanoi Cheech ia ; A. (F losculina) de
cip iene Schw ager ; A. (F loscul ina) pastici lln ta Sehvvager. In tutto 1 0
forme reputate distinto, cui, in appendice, l
’
A. agg iungo una nuova
specie dell’
oceano medio di Rosazzo e Buttr io nel Fr iuli,l’
Alveolina
violae Checchia (perchè non che a detta sua è probabile sia
da identificarsi all’
Alveol ine sp. O. Mar inelli ( 1 902 ; Descr . goal.
d in i . Tarcen to nel F r iu li, pag .
Meri tano particolare menz ione il fatto delle var ie leggo embrio
nali (da 2 a 1 0) osser vato dall’
A. in alcuni da’
suoi esemplari , al
quale da per sp iegaz ione possibile la fusione di prctoplasma in indiv i
dui c rigiuar iamento distin ti. e l’
affermaz ione che egli , contrariamente a
ciò che ri tenne Brady , non è d’
avv isc possa stabi lirs i alcun rapporto tra
le Alveolina elongata d’
Orb.,A. hosoi o I
’A. gaoyi d
’
Orb.’
a causa della complicatissima o diversissime struttura di quest’
ul
tima
Agli habitat recenti d i quest’
ultima specie siamo al caso d’aggiungere
presso Port Blair, Isole Andamane, alla profondità di circa 29 m.
DI PALEONTOLOGIA 7
Corredanc la memoria due buono tavole,dove però avremmo
desiderato trovare presso ad ogni figura di sezione mer idiana, pur
quella della corrisdondento sezione equatoriale, e ciò in particolare
per le forme nuova ; ossia l’applicazine del metodo diagnostico delle
sezion i orientate,col quale, pur non accettando per intero i criteri
suddetti , è assai facile orizzontarsi senza il bisogno di r ipetere m i
surazion i lunghe, fastidiose, e forse inuti li . È assai singolare a questo
proposito il contrasto tra una scuola che vuol vedere nei Rizopodi la
la miglior prova dell’
evoluzione zoolog ica, con la conseguente impos
sibilità di defin ire con esattezza la specie, e l’altra che li vuole dalla
forma fissa e traducibile quindi in espression i numeriche.
Il recensore e pal suo stesso ufficio un revisore,e pertanto egli
non può esimersi dal rilevare che la suddetta storia del genere Al
eeolina non è del tutto esatta, che sulla parte zoologica trattata dal
Checchia vi sarebbe da cr iticar qualcosa, come ad esempio la osama
zione della famiglia Peneroplidae Schw ager che all’A. e sfug
gita la recisa affermazione del d imorfismo in Alcoolica fossile da parte
d i Schlumberger , sulla fede di Mun ier Chalmas. e di dimorfismo dob
biamo bon ammettere questi s’intendesse, che difettano le indica
zion i r iguardanti la frequenza delle diverse forme passate in rassegna,
che egli , a proposito delle Alveolina oblonga ed elongata, ha trusen
rate di citare i l Fornasin i , e che,infine
,non sembra completa la
parte in iziale di talune delle sez ion i mer idiane prodotte. Ma son tutti
nei,nessuno dei quali scema la bontà del lavoro, degno dell
’A. e
dell’ottima Palaeorztograp hia Italica
,che in bella veste glio l
’
ha
pubblicato. A. SILVESTRI.
Cecce L. I Radiolari fossili del tripoli di Oendrò (Sicilia) . c d ic .
e M em . R . Acc. Sc. Lei t. Ar ti Acireale,ser . 3
,vol. 1 1 1 0904
II M em . Cl. Sc., pag. 1 -1 4. Acireale
,1 905.
Comprende l’elenco descrittivo d i alcun i (2 1 ) radiolar i con pre
valenza di forme clipeali indizio di considerevole profond ità.
Sono descr itto come nuove ma non figurate : Dictyochrz bifenestrata e Oyrtocap sa La Vel lei . V.
8 RIVISTA ITALIANA
DE GASPARIS A. Le alghe delle argille pleistoceniohe di Taranto.
Atti R. Acc . Sc. fis . mai . d i Nap oli , 2 , X II, 4.
L’
A. ha studiato le alghe delle argille marnose d i Taranto, ap
partenenti al Museo civico di St. naturale d i Trieste. Dal suo studio
risulta che tali argille appartengono al Pleistocene interiore. È nuova
la Grateloup ia Bassan i i . V .
DI Pesaro E. Elementi di Paleolitogia. Tor ino, Un . tip . ed i tr i
ce,1 906
, pag. 200 con 7 1 fig.
E veramente lodevci e questo libro, che r isponde ad una neces
sità senti ta in Italia. La Paleofitolog ia ha avuto da noi cultor i i llu
str i ed e bene che si trovi un libro che delle p iante fossili , special
men te italiane,si occup i . Questo ha fatto 1
’
egregio A., gia noto per
altr i libr i di argomenti geologici .
Il lavoro si in izia con un rapido cenno storico, cui seguono con
siderazion i ed osservazioni sull’
importanza della paleofitologia, sulla
conservaz ione dei fossi li vegetali , sulla determ inazione d i essi . È mol
to da lodarsi nell’
autore la r ipetuta affermaz ione, che le determina
z ioni delle filli ti sono di grande d ifficoltà e suscettibili di molti
error i.
La vera e propria parte sistematica e preceduta da alcun i cenn i
sui periodi geologici e sulle pr incipali località fillit ifero d’Italia.
La Classificaz ione adottata si discosta poco da quella del Carne] .
I var i tip i sono accuratamen te descr itti con accenni speciali alle 10
cal ità italiano, e parecchi sono anche ben figurati .
Term inano i l libro una osservazione sulla distribuzione delle piante
durante i per iodi geologici , e degli indici copiosi e molto utili.
Poichè la cr itica è facile tanto quan to è di fficile una compila
zione del genere di quella del Prof. Di Poggio, così potrai accennare
a più di un p iccolo neo nel lavoro ; m i lim iterò però solo a raccoman
dare all’
autore, per una seconda edizione che auguro prossima, una
p iù accurata trattaz ione della parte che si r ifer isce ai periodi geolo
gici , che così,com
’
è era presentata, può ingenerare confusion i ed
errori non pochi nè lievi . V.
DI PALEONTOLOGIA
Lamm in Am our (Z .) Feraminiiori oceanici di San Genesio, Gelli
na di Torino. Il genere Rupe rtia. Atti Soc. It. Sc. Nat.,
vol. X LIV, pag. 97 - 1 05
,tav . II. M ilano
,1 905.
Esposta la storia del genere Rup er tia, dove, certo per svista,
le è accaduto di qualificare per chiari e precisi disegni che
lo stesso autore (Schlumberger) r iconobbe non poter esser tali, di tra
scurare i l Goes e di sdoppiare la personalità del dott. Flint, llo
gregia Autrice descr ive ed i llustra con fotografie, le forme fossili che ad
esso ri ferisce,raccolte personah ent
‘
e e dal Bellini,nei terreni ecce
nici di S. Genesio presso Chivasso, nella Colline. di Torino,distin
guondcle in tre specie : elongata n . sp.,i 1w rassata Uhlig, ed uhligi
n. sp . ; fra le quali alla credo poter r i levare addir ittura delle d if
ferenziazion i evolutivo stabi lendcno l’
ordin e ascendente così come
lo abbiamo indicate.
Sulle Ruper tiae conosciamo poco, ma questo poco ci permette
d"asserire che la specie vi e polimorfa, bastando pocho legge in più
ed in meno,cresciuta in una certa guisa p iuttosto che in un
’
altro,
a cambiarne i con notati morfologici , tra cui persino la posizione ed
i particolari dell’orifiz io ; e pertanto, fin chè l
’Airaghi non pubbli
cherà figuro diverse dalla attuali,ciò che ci auguriamo per l
’inte
rasse doll’
argomento, osiamo affermare che le tre specie citato ne co
stituiscono una sola : Rup er tia incrassata Uhlig.
Agli habi tat di : S. Genesio, calcare di Lacedonia,affioramento
oceanico d i Porcinarc presso Pozzuoli,e brecciato nummulitiec di
S. Martino presso Bobbio, provincia di Pavia segnalati dall’A.
per tale specie, possiamo aggiungere quello di : Cave Dofilippi presso
Gassino (Tor ino), in terreno puro ocean ico. A. v asrm.
M… … E. Caratteri Massini dellaFauna rotiea lombarda. Rond .
R. Ist. Lamb. d i Se. e lett.,2,XXXVIII
, pag. 854-858 e
1 fig.
È nota la discussione se il retico sia da rifer irsi al Lies o al
Tr ias. In Lombardia il retico presenta spiccasi caratteri triassici , non
1 0 RIVISTA ITALIANA
solo li tolcgici ma anche faunistici,come del resto 1
’
A. ebbe già a
far r i levare i n altre pubblicazion i, e come farà r ilevare in seguito,
terminata la revisione della r icca fauna retico. lombarda a cui atton
de da qualche tempo. V .
Pragm a: (M .) Avanzi di Diedon votus nel miocono inferiore del pro.
m aterie di S. Elia presso Cagliari in Sardegna. Rand . R.
Acc. Sc. fis. e mat. di Napoli , fasc. 2°
o Febbraio e Mar
zo 1 905.
V i è illustrata una bellissima armatura boccale superiore di
Diodon,raccolta dal prof. Lovisato nelle arenarie del piano a Scatol
la d i S. Elia. È una placca palatina col relativo apparato dentale
marginale e con una covertura di smalto, in forma di fascia, sulla
lamine inferiori delle due pile, in conti nuazione della superficie tri
turante,di modo che la parte destinata alla masticaz icne si vede
tuttora lim itata cosi come era nell’
an ima v ivente. Dopo un’
efficace
descrizione,corredata da tre ottime figuro, la dott. Pasquale confronta
l’
esemplare con tutt i i eongeneri fossi li e v iventi , concludendo ch’osso
deve r iferirsi a Diodon vet—as Leidy, r invenuto nel M iocene della Ca
rolina settentrionale e nei depositi a fosfor iti di Ashley (Carolina del
Sud) e rappresentato, secondo 1’
A.,anche nel calcare elvezianc di
Lecco. Poi,traendo partito dalle osservazion i eseguito, propone qual
che sinon imia e dà l’
elenco di tutte le specie fossili,che sommano
a undici,indicando per ciascuna di esso la bibliografia completa e
la proven ienza. F. BAB… I.
1 2 RIVISTA ITALIANA
loculine, les dern ières en ser ies symétriques cpposéos perpendiculai
rement à l’
ax o d’
enroulement et imitant les Spiroloculines. Lour
surface ex terne est très costuiée. Ouverture garnio d’
un trématophore
en pomme d’
arrosoir .
H eter i llina car inata Schlumb. Oligocone di Gaas (Landes).
Forma A.
H eter i llina guesp ellensis Schlumb. Eccone medio di Le Gue
spello. Forme A o B.
Idalina berthelin i Schlumb. Eccone medio di La Close, Bois
Genet, e Valognes. Forme A o B .
Pen tellina chalmasi Schlumb. Sonon iano delle Stagno di Bar
ra (Martignos). Forme A e B .
Pm tellina douvi llei Schlumb. Sonon iano delle Stagno di Bar
ra (Martignos). Forma A.
Pen tetlina haber ti Schlumb. Sononiano dello Stagno di Bar
ro (Martignos). Forme A e B .
Pen tellina p seudosax orum Schlumb. Eccone medio di Par
nos,Chaussy , Chàteaurouge, Grignon , ecc. Forme A e B.
Pen tellina sax orum Lamarck). Eccone superiore di Montron
ge. Forma A.
Pen telli na stri gi llata (d’Orbigny). Eccone medio del bacino
di Parigi ; a Parnas, Chaussy, Gri gnon, Noauphles, ecc. Forme
A e B.
Per i loculina raincour ti Schlumb. Luteziano superiore di Va
lognes (Mancha) e di La Close (Leiro-Infériouro). Fermo A e B.
Chiude la nota esaminata l’interessante osservazione che
,a somi
glianza di altri gruppi di Ric edi , le M iliolidi comuni e la trama
toforate convergono, nel modo seguente
MILIOLIDI
COMUNI
Quingueloen lina
Nuovo nemo proposto in sostituzione di Pentell ina sax om m (d’ Orbigny),
la Quinqaelocul ina del 1 826, endo distinguornola, essendo specie diversa dalla
Pm iell ina saacm m (Lamarck) , la M ilzb lites saox rum del 1 804.
DI PALEONTOLOGIA 1 3
Il recente stud io delle Schlumberger viene ad aumentare la co
noscenze sulla distr ibuzione stratigrafica del genere M alina,che pos
siamo r iassumere cosi
PIANI SPECIE LOCALITÀ
Eccone medio Idalina ber thelin i La Close,Bois Genet ,
e Valognes, in Francia.
Cretaceo superiore Id atina an tiqua Trago di Noguera nei Pi
renei dintorni delle
Martigues (Stagno di
Berra e di Caronte),nella Provenza.
Questa distribuzione modifica necessariamente quanto si scrisse
nella recensione della nota del dott. Prever Sulla fauna nummuli
tica della scaglia nell’Appenn ino centrale ed in merito al ge
nere citato, nel senso che : se l’M alina r iscontrata dal Prever nella
rocce nummulitifora pertinenti alla scaglia ed al calcare rosate, rite
nuti crotacei, può attribuirsi o semplicemente confrontarsi alla ber
thelin i,non r imangono che argomenti favorevoli alla oooenicità delle
rocce stesse ; sempre, s’in tende
,dal punto di v ista paleontologico.
A. SILVESTRI.
Scw nsaaosa (Ca.) et DOUVII.LE (H .) Sur deux Foramîniiòres 600€
nos. Dictyoconus egyp tiensis Chapm. et Li tuonella Rober ti nov.
gen. el sp.— Bu ll. Soc. 6 150 1 . F ran ce
,ser. 4
,vol. V
, pag. 291 -304
fig. 1 -7,tav. IX . Par is
,1 905.
Noll’introduziono di questa nota
,che e purtroppo l
’
ultimo lavo
ro lasciateci dallo Schlumberger , i chiarissim i Autori espongono al
cune consideraz ioni generali sull’
ordinamento dei Rizopodi reticolari
distinguendo i caratteri che ad esso servono d i base in
(2) Vedasi a pag. 1 02 , anno XI, fasc. 3, di questa Rivista.
RIVISTA ITALIANA
A ; der ivanti dalla natura del n icch ia, e cioè in primo luogo la
presenza o mancanza in esso di perforazion i , ed in secondo la sua
costituzione,calcarea
,ed arenacea
,cui però attri buiscono importanza
subordinata,vedendovi un semplice fenomeno d
’
adattamen to a par
ticolar i cond izioni d i v ita,così spiegato : le forme che nuotano sono
costretto a secernere un n icch ie calcareo,mentre le altro le quali
vivono sul fondo dei mar i possono invece usufruire per costruirselo
dei materiali bell’—e pronti, su cui stanno
,realizzando in tal modo
notevole economia di sostanza, poichè non r iman loro da fornire che
il cemento agglutinante. Al cune forme fossili poi oltre all’
economiz
zare la sostanza secreta,in egual man iera, raggiungono un perfezio
namento maggiore uti lizzando p iù razionalmente i detriti di cui di
apongono, e questo, fabbricandc al loro n icchie una parete esterna e
corticale conche épidermique molto sottile, la quale sostengo
no mediante impalcatura sottostante, che determina un reticolato più
o meno fitto ; per la parete in discorso il sarcodo adopra soltanto e
lomenti arenacei minutissimi, o per lo strato successivo si serve di
altr i decisamente granulari (n icchie arenaceo e reticolato). Perfezio
namento questo, però di interesse secondario, potendo forme assai
prossimo come Alveoline e Loftusio cfl‘
riro nel primo caso conchiglia
porcellanacea, o nel secondo arenacoa e reticolata.
B ; inerenti all’
aggm ppamen to delle legge, ossia a quei tali con
notati che hanno sernpre costituito il fondamento d’
ogn i classifica
zione,ma i quali però acquistano importanza diversa a seconda dei
casi . Per esempio nella M iliolidi determinano un dato di primo or
dine per ciò che r iguarda il loro ordinamento sopra un piano tra
eversole r ispetto al n icchie,ma non su quello verticale corrisponden
te al piano o ad un piano d’
avvolgimento, dove l’
avv iluppo a spi
rale delle legge e soggetto a innumerevoli var iaz ion i,da valutarsi
quali caratteri di secondo ordine.
Così, pure p. es. nella Orbiculino l
’avvolgimento rimane a spi
rale dall’inizio al term ine della conchiglia, ed invece nella Orbitoli
tid i si modifica con l’
età allargandosi lo leggo sempre più, e ripio
gandosi , finchè venendo a contatto i loro estremi, questi fondonsi ,
convertendono la forma primitiva in anulare. In altri casi,allargan
dosi meno lo legge pianospirali , esse, in seguito a tal modificazione,
DI PALEONTOLOGIA 1 5
o disponendosi in ser io lineari , vengono a dar luogo, come in Pene
rep lis, a c onchiglia depresso o più o meno triangolari , oppure coni
che,cd anche baculiformi ; ed in tutte le modificazioni considerato la
fase spiralata in iziale potrà mantenersi in grado di verso ed anche
scompari re affatto. Per cui,in conclusione
,le forme discoid i, triongo
lari,con iche
,c bacalari
,era considerato, si troveranno sempre in
rapporto con un tipo fondamentale, il quale, secondo i casi , sarà spi
ralatc appiattite, spiralatc nautiloide, e perfino spiralatc tusifcrme (Al
ocolina ad esempio).
Ciò per gli organism i simmetr ici, di solito nuotatori , ma per quelli
che si trascinano sul fondo il fenomeno complicasi con la facile prc
duz ione dell’asimmetria nel n icchie
,nella quale v iene a modificarsi
avvolgimento a spirale piana di esso in conico-Spirale, a somiglian
za di quel che si verifica nei Gasteropodi ; pur non di manco, po
tranne pur sempre i Ric edi dal nicchie a sp irale con ica r iportarsi
a tipi ancestrali simmetr ici.
O ; fondati sulla configuraz ione delle legge, ovvero sulla forma d i
esse ed il relativo numero di aperture ; caratteri questi sempre di
prima importanza. La legge alcune volte lim itansi ad una sola pare
to,attraverso cui comun icano con l
’
esterno,e per mezzo d
’orifizio u
n ico rotondo,e cosi essendo r idotti al m inimo gli elementi soggetti
a variare,le forme resultanti difieronziansi ben difficilmente tra di lo
re, anche attraverso le età geologiche ; o mediante apertura fonduta
diritta,curva
,ramificata
,eppure interrotta da appendici svariate, ed
in ciò ha origine la prima complicazione, che nei tipi veramente com
plessi aumenta per via degli orifizi multipli. Ma quasi sempre allora
nell’interno delle legge svi luppasi un m doloscheletro di aspetto ed
importanza svariati,secreto dal prot0plasma nei punti dove, fuorn
scendo dalla legge attraverso alle loro aperture, e incapace di r icon
giungere lo proprie ram ificazion i, perchè troppo discoste ; la materia
calcarea prodotta con tale secrezione,si presenta normalmente sotto
l’
aspetto di pilastri rotondi e lamelliform i , dalla base allargata, a se
gli orifizi suddetti sono in serie lin eari,i pilastr i occupano lo spazio
tra di essi,formando setti più o meno continui. Ciò osservasi assai
bene nelle Orbitolitidi,dove può seguirsi passo passo il processo della
1 6 RIVISTA ITALIANA
produzione endoscholetrica,dalle forme semplici come lo B roeckina
alle complicata come Orbi toli tes.
Gli A. soggiungonc che le forme complesse offrono necessar ia
mente partieolaro interesso, perchè un tipo morfologico e tanto più
suscettibile di var iazion i per quanto più complicato, essendo la sua
sensibilità di reazione ai camb iamento delle condizion i esterne, in
rapporto d iretto con la sua stessa complicazione ; e con questo Spie
gano come mai le forme semplici dei Rizopod i reticolari abbiano dato
luogo a fossili di quasi nessun valore,men tre lo complicato ne ab
biano prodotto nel maggior numero dei casi di veramente caratteri
stici, quali : Orbi toli tes, Orbi tolina, Orbi toid es , Alveolina, ed anche
Nummuli tes ; e per quest’ultimi a cagione del loro reticolo secon
dario e delle granulazioni , avendo realmen te importanza la moltepli
cità delle aperture, solo nelle forme dal n icchie imperforato. Der i
vando però le forme complesso dalla semplici , occorre stabilire la clas
sificazione della pr ima su quella delle seconde, prendendo per tipo le
forme dal n icchie calcareo ; così facendo, forme arenacea,non retico
lato e reticolato, forme asimmetriche,'
e complesse in generale, ver
ranno a resultare nella tassinom ia quali diramazioni di stipite dalle
forme semplici calcaree.
Premesse le importanti considerazion i , che abbiano qui esposto
compendìosamente, e sulle quali dobbiamo fare alcune r iserve, poichè
ad esempio riteniamo che non tutti i Rizopodi debbano necessaria
mente esser passati per una fase spiralata, essendovene dei tipi ori
ginatisi per semplice sovrapposizione rettilinea di segmenti , che poi
dà,come var iaz ione
,or igine alla curv i linea ed alla spirale, che e già
il prodotto d’
una evoluz ione, e non il punto d i partenza, costituito
invece da una loggia unica globosa. La forma complessa e poi
per noi i l prodotto dell’
ambiente e non i l resultato dell’
azione sem
plico d i esso sopra tipo già complicato, ammettendo che un tipo sem
pliciss imo posto in ambiente dai molteplici stimoli , possa, non debba,
modificarsi profondamente, assumendo caratteri differenziali dai suoi
eongener i ; questi caratteri saranno,si,l’
indice dell’
ambiente,ma
per quals ivoglia forma che abbia potuto r isen tirne, e non per que
sto a quel gruppo. Ci sembra poi non esatto far derivare i tipi dal
n icchie avente tessitur a aggregata, arenacea, terrosa, ecc., da quelli
DI PALEONTOLOGIA 1 7
dotati di conch iglia calcarea e di tessitura omogenea e stratificata
la facoltà di produrre da per sè le di fesa contro l’
amb iente è,
nel
nostro modo di vedere un progresso e non un regresso, e pertanto
c i pare debbasi accettare l’
ipotesi che da un t ipo n uotatore o galleg
giante chi tinoso siano derivat i,da una parte altro tipo pure dotato
delle stesse proprietà, ma capaée d i secernersi una conch iglia calca
rea,dall
’
altra un tipo lim icolo ed aranicolo, privo o scarsamente
provveduto d i tal potere. Il primo si può essere adattato poi a v ivo
re, anzichè pelagico, sul fondo o presso i l li ttorale, con perdita della
simmetria,ecc ., ove, trovando pronti dei mater iali detritici , se ne ap
p r0fittava qualche volta, producendo così forme di regresso ; mentre
i l secondo,all
’incontrario
, passato in alcuni casi dalla vita di fondo
o littoranea alla pelagica, può aver acquistato, oltre a simmetria che
prima non aveva,la facoltà d i secernersi una conchiglia tutta sua
,
determ inando forme di progresso. Da ciò ripetono la loro or igine, al
meno in parte, i numerosi casi d’
isomorfismo,molti dei quali sareb
bero altrimenti inesplicabili ; da ciò pure la grande difi coltà d i sta
bi liro l’
ordinamento dei Rizopodi su basi naturali , poichè forme strut
turalmonte simili resultano da processi evolutivi perfettamente con
Prerhesse, dicevamo, dette importanti considerazion i , Schlumber
ger o Douv illé vengono a descr ivere, col sussid io di disegn i e d’una
ottima tavola fotom icrografica, due specie che secon do i loro cr iter i
apparteugono 9. tipi complessi , le qual i sono la
Li tnonella rober ti Schlumberger ,
nuovi genere e specie, istituiti su indiv idui fossili dell’
oceano (lute
zianc medio) di Saint-Gildas—des-Bois fontaine du Verdier » Arthon ;
Ooislin ; Saint—Palais le Bureau p resso Royan ; tutte località fran
cesi . Ed i l :
Di c tgoconus aegyp tiensis (Chapman)
già i llustrato dallo Chapman come Patell ina e Conn i i tcs aegy
p tim sz'
s,o per la quale specie il Blanckenhmn propose l
’
assegnazio
Schlumberger e Douv illé scrivono egyp tiensz'
s ma è questo un eri—ora
ortografico, che per le vigenti regole di nomenclatura va corrotto.
1 8 RIVISTA ITALIANA
no al suo nuovo genere Dictyoconus La incompleta e non del
tutto esatta descriz ione pr imitiva della specie stessa,dovuta al fatto
che lo Chapman ebbe a prepria disposizione soltan to individui ia
castrati nella roccia,aveva cagionato diversi equivoci , a dissipare i
quali si era in parte interessato ch i scrive ed era esaurientemente
ne trattano i sullodati Autori,r iprendendo in esame gli esemplari
raccolti dal Fcurtan sul versan te settentrionale del Djebel Geneffe in
Egitto, di cui ormai sembra accertata la proven ienza stratigrafica dal
I’
eccone (parte inferiore del par isiano).
Non e il caso di riassumere le descr izioni di detti gener i e spe
cie,epperò veniamo addirittura alla conclusion i : i due gener i Li tuo
n ella e Dictyoconus appartengono entrambi alla Lituolid i,cui noi
stessi li avevamo aggregati ed al primo si attr ibuisce la deriva
zione dalla Li tuola cretacee,mentrc r iten iamo debbansano ricercare
gli antenati nel carbonifero, per la qual ragione l’
assegnammo alla
sottofamiglia delle Endothyri nae. Non trov iamo difficoltà a r iunire
Orbi tolina,Spi ro
c
yclina, Dicty0p sella e Chofiatella, in gruppo tas
sinomico un ico,detto degli Autor i delle Chofi
'
atellidés ma che
preferiremmo chiamare delle Cho/Îatellinae, considerandolo in sette
famiglia delle Lituofidao ; la sottofamiglia delle Orbitolîninao, treppo ar
tificiale,resulta cosi scomposta, e degli antichi membri
,Orbi tolina
ha avuto,come si e visto, opportuna collocazione, Dictyoconus va
con In'
tnon ella ; r imarrebbero Chapman ia o Conul i tes . Schlumberger
e Douvillb non si pronunziano in preposito, ma in seguito agli spo
stamenti da loro in iziati , non vediamo per ora altra risorsa che far
passare Chapman ia tra le Textularidao, e Conu li tes , per quanto sia
questo un passo arrisch iato,fra le Rolalidae. Finchè però non si tro
veranno forma intermedie, che collaghino i nominati generi ai loro
Anche per questo nome é stata necessaria una correzione,e l
’
ha fatta il
Douvi llé ; il Blanckenhorn proponeva quello di Dz‘
ctyoconos
Sul Dictyoconus aegyp ticns is (Chapman) Atti Pontif. Ace. N. Lincei
anno, LVIII, pag. 1 29- 1 3 1,fig. 2. Roma ( 1 9 marzo) 1 905.
La Chapman ia gasm'
n cn sis Silv. Riv. It. Paleont .,anno X I
, pag . 1 1 3
1 20,fig. 1
-2,tav. II. Perugia (5 agosto) 1 905.
Ultima delle due note sopra citato, pag. 1 1 9.
20 RIVISTA ITALIANA
III.
No tizie som nia r ic s u tra f aun u lc d e l Lazio
1 1 . Non DI A. SILVESTRI
3) Argi lla gr ig io-ch iara della Cava Baldin i , nei d intorni d i TorCaldara
, presso Anzi o (Romo) Con tiene :
MILIOLININAE.
B i localina g lobulus Schlumbergcr (non Bornemann ). 1 89 1 ; M èm .
Soc. Z ool. F ranco,vol. IV. pag . 1 88, fig . 42-44 ; tav . X II, fig . 97 1 00.
In modelli d i p ir ite , dai quali però r ilevasi com e fosse som iglian te alle
fig . 97-1 00 citato. Rar issima.
Sp ir olocu li na ex c rvata d’Orb igny . 1 846 ; Foram . fose. Viann e, pag.
27 1, tav. XVI
,fig . 1 9 2 1 . M odelli interni d i p ir ite , che la d imostrano
corrisponden te alla fig . 68,tav. III
,d elle Schlumberger ( 1 893 ; M em .
Soc. Z ool. Fran ce,vol VI
, pag . Rar iss ima.
Q n inquelocu li na cfr. vu lgar is ? d’ Orb igny . 1 826 ; Ann . Sc. Nat .,
vol. VII, pag . 802
,num . 83. (F ig . 1 3
, pag. 2 1 , del F ornasin i , 1 902 ;
M em . R . Acc. Sc. Bologna, sor. 5 , vol. X ) . Con la m agg ior riserva,
attibniscc a form a un po’allungata della specie , l
’un ico modello p ir i
tico d i q nqneloculina, che ho potuto isolare. Rar issima.
S igm oi l ina celata (Costa). Sp ir olocu l ina cela ta , 1 856 Atti Acc.
Pontan iana,vol. VII
, parte 1 , tav. XXVI, fig . 5 (non Foru m
delle figure del Costa (1. orifizio sen za dente. Comune.
AS'
I'
RORHIZ INAE.
As trorh iza ? cfr . gran ulosa Brady . 1 884 ; F oram . Challenger , pag.
234, tav . XX , fig. 1 4—23. Rassom igl iasi alle figura 1 9, 1 5 o 1 7 (I
Si veda la c I. Nota sul lo stesso argomento (Riv. It. Paleont., anne
XI, pag. 1 40 1 45) di cui questa è il seguito.
Avuta dal gent.mo sig. Grassi . Dà scarsissimo residuo alla lavatura,nel
quale ho csservato, oltre ai Rizopodi reticolari che vi predominano, particolarmente
poi i generi Glob igerina ed Orbnlina. quanto segue : OSTRACODA (frequenti ed in ec
collante stato), LAMBLLIBRAXCH IATA poche e piccolo valve di Pectin idae) , Gnsm oronz
(qualche raro modello interno d i pirite, con frammen ti di guscio), Preore (minuti
e scarsi dentin i ).
DI PALEOLN'I‘OOGIA 2 1
però trattasi d i modelli d i pir ite e quind i la d iagnosi va accolta con
la massima r iser va. Rara.
RHABDAMMININAE.
Rhabdamm in a ? sp. Nel residuo di lavatura dell’arg i l la presa ad
esam inare, ho trovato mol tissim i corp i a forma d i bastoncelli,d iritti
,
ram ificati o no,regolari od irregolar i , lisci o scabr i
,un iform i oppure
segmen tati , costitu iti d i pir ite ; alcun i im itano esem plar i del genere no
m inato, e pertan to ne potrebbero essere i model li. F requente.
H yp er amm in a ? sp . Come sapra. F requen te.
M ar sip ella sp. Idem idem . F requen te.
LITUOLINAE.
Reop hmt: cfr . scorp iur us M on tfort. 1 803 Couch . Syst ., vol. I , pag .
33 1, gen . 83. Modello d i pir ite i l quale non sembra forma im itativa ;
ad on ta d i ciò la determ inaz ion e r imane assai dubbia. Rar issimo.
H ap lop hragm i um cfr. fon tin en se Terquem . 1 870 ; Mem . Ac. Im p .
Metz,vol. LI ( 1 869 pag . 235, tav. XXIV
,fig . 593 0. Piccola
forma, parzialm en te di strut ta e sostitui ta dalla pir ite essa r icorda la
fig . 2,tav. XXXIV, d e l B rady ( 1 88 1 ; Foram . C hallenger ) . Rari ssimo.
H ap lop h ragm i um w r igh ti De Am ic is. 1 895 ; Naturalista S iciliano,
anno X IV, pag . 58, tav . I
,fig . 1 2 . Per quanto irregolare nella sua fi
gura e superficie, nel comp lesso sembram i cor risponda p iuttosto bene
ai caratter i della specie, com e resultano dall’ opera ci tato. ; i l n icch ie e
formato prevalen tem en te d i Globigerine ed Orbn line cementato assieme.
M ediocrem en te raro .
Psammoli ngu l ina p ap i llosa (Neugeboren ). L ingul ina p ap i llosa,
1 856 ,Denk sch. k . Ak . W iss. W ien , Math . Naturw . C l . vol. X II ,
pag. 97,tav. V,
fig . 6. Corr isponde alla m ia fig . 1 2,tav. III (Reap hcm
p ap i llosa (Neugeboren ) var. comp r essa (Seguenza) , 1 896 ; M em. Pon t if.
Acc. N. Lincei , vol. X II ) , però con un segmento in p iù ; ha orifiz io,
lineare,lievemente arcuato. Rara.
LOFTUSINAE.
Cyclamm ina cfr,can cellata Brady . In Norman
,1 876 ; Proc . Roy .
Soc.,vol. XX V, pag . 2 14. 1 879 ; Quar t. Journ. M i cr . Sc., vol. X IX ,
pag. 6 3. 1 884 ; Foram . Challenger , pag. 35 1,tav . XXXVII, fig . 8 -1 6.
Piccolo ind ividuo megalosferico, da attr ibui rsi con ri serva alla specie
22 RIVISTA ITALIANA
can cellata. perchè completam ente soscituito dalla p irite , la quale però
ne mantiene in par te anche i caratter i strutturali. Rarissima.
TEXTULARINAE
Tex tu lar ia cfr . sag i ttu la Defran ce. 1 824; Dict. Sc . Nat., vol. XXXII ,pag. 1 7 7 . 1 828 ; idem ,
vol. LIII, pag 344 ; Atlas , Conch .,tav. X III
,
fig . 5 . Esemp lar i mol to logor i e qu ind i dubbi . Rara.
Temtu lar ia soldam‘
i F ornasin i. 1 883 ; Boll. Soc. Geol . It ., vol . II,
pag . 1 83,tav . II, fig . 2 . H a segm enti p iù fitti
,ma sostanzialm ente non
s i d iversifica dal le fig . 4, 4’
a,4b
,tav. IX , del Fornasin i ( 1 887 ; Boll.
Soc. Geol . I t.,vol. VI ) . Piuttosto rara.
Vu lvul ina p en natu la (Batsch ). Nauti lus Or thoceras) p ennatula ,
1 79 1 ; Conch . Seesande=,tav . IV
,fig . 1 3a, 1 3b, l 8d . Corr isponde ag li
ind ividui al cen tro ed a d estra in basso d e l la fig . 8, tav . XXXII
, del
F lin t ( 1 899 ; Rep . U. 8 . Nat. Mus. for Rara
Sp i rop lecta cor rugata (Costa) . Tea:tula r ia corm gata , 1 857 ; Mem .
Acc. Sc . Napoli , vol . II, pag 1 25
,tav . I
,fig . 1 5. Come gli ind ividui
d i lato a s in istra del la fig . 3,tav . XXXII
,del F lin t ( 1899 ; l. Rara.
Gaud ry ina p up oides d’Orb igny . 1 840 ; Mem . Soc. Geol. F rance,
ser. 1 , vol . IV , pag . 44,tav. IV, fig . 22 -24. Con segmen ti meno nume
rosi d i quelli indicat i nella fig. 1,tav . XLVI
,del B rady ( 1884 ; Fo
rum . Challenger). Rara.
C lavu lina r ud is (Costa) . Glandu lina r ud is , 1 857 ; M em . R. Acc.
Sc. Napol i, vol . II, pag . 1 42 , tav. I,fig . 1 2 e 1 3. F orm e sferoidali ed
ellisse i dal i simulan t i la Psamm osp haer a fusca Schulze,e la Tharam
m i na albican s B rady , o vvero allungate come l’esem plare della fig. 4,
tav. III, del Fornas in i ( 1894 ; Mem . R. Acc. Sc. Bologna, ser . 5, vol.
IV) ma senza collo per l’
or ifiz io ; costantem en te fabbricate con Orbn
l ine e Glob iger ine. Abbondan te.
C lavulz'
n a comm u n is d’Orbigny . 1 826 ; Ann. Sc. Nat., vol. VII ,
pag . 268, num . 4. 1 846 ; Foram . fose. V IGDDO, pag . 1 96
,tav. X II ,
fig. 1 -2 . Linee d i sutura. pm larghette d i quel le degli esemp lar i figurati
ai num er i 10 1 2 , tav. I,de i Fornasin i ( 1 893 ; M em . R . Acc. Sc. Bo
logna, ser. 5 vol. III) , ai quali i m iei pel rimanen te corr ispondonsi.
F requen te.
Ho r invenuto di recente questa spec ie, ed in forma simile a quelle indi
d icate,
anche nel calcare a Lep idocyclz'
na delle vicinanze della stazione ferro
viar ia di Castel Madama, d i cui nella prima parte del presente scritto. Vi è ra
russxma.
DI PALEONTOLOGIA 23
C lavulina gaud ry ino id es Fornasin i . 1885 ; Boll . Soc. Geol . It ., vol .
IV, pag . 106 , tav . VI, fig. 3 9. L ’
alternan za dei segmen ti uniser ial i è
incip iente , come nel la fig. 1 , tav . VI,del Fornasin i (Cla vul i na comm u
n is 1 885 ; l . la quale io attr ibuisce pure alla specie gaad ry inoides .
Rara.
BULIMININAE.
B ul im ina ovata d ’ Orbigny . 1 846 ; Foram . foss. Vienne, pag . 1 85,
tav. X I, fig. 1 3- 1 4. Ind ividui con poch i segm enti , più raccorciati ed 0
voidali del tipo specifico (fig. ottusi (forma A), ma qualche volta
anche acuti alla base (forma B). R icordo che la B ulim i na ovata, come
le altre Bulim ine in genere, è dotata di processo assile in terno. Ab
bondante.
B u lim ina p y rula d’ Orb igny . 1 846 ; Foram . foss. V ienne, pag . 1 84,
tav. X I,fig. 9- 10. P iù ottusa in fer iormen te della fig . 9. tav . L
,del
B rady ( 1 884 ; Foram . Challenger) Rar issima.
B ulim ina aj im’
a d’ Orb igny . 1 839 Foram . Cuba, pag. 1 05 , tav. II
,
fig. 25-26. Maggiormente allungata ed ovoidale della fig . 1 4
,tav . L»
del Brady ( 1 884 ; Foram . Challenger ). Di st inguo questa forma dalla
ovata,
‘
perchè decisamen te con ica nella m età in fer iore. Rar issima.
B oliv i na p unctata d’ Orb igny . 1 839 Foram . Amer . Merid .
, pag . 63 ,
tav. VIII,fig . 10- 1 2 . Come la fig. 1 8
,tav . LII
,del B rady ( 1884 ; Fo
ram . Challenger) , ma ha l’asse d ir itto. Rar iss ima.
Plcuro'
s tonella alter nans Schw ager . 1866 Novara-Ex ped . geol. Theil ,vol. II, pag . 238
,tav . VI . fig . 79—80. Eccez ion e fattane del prolunga.
men to tubulare mancan te sull’orifiz io, si rassom ig lia alla m ia fig . 9,
tav. II (Pleurostom ella alter nan s var. tubu lata Silv,1896 ; M em . Pon
tifi. Acc. N. Lincei, vol. XII). Rari ssima.
CHILOS'
I‘OMELLINAE.
t lostomel ’a ovoid ea Renee 1 850 ; Denk schr. k . Ak W ise. W ien ,vol. I
, pag . 380,tav. XLVIII
,fig . 1 2 . Un po
’
p iù r igonfia, ma de lla
forma indicata nella fig . 1 4, tav. LV,del B rady ( 1 884 ; F oram . Chal
lenger ). Rara.
POLYMORPIIININAE.
Uv iger ina asp er ula Czjzek . 1 848 ; Naturw . Abhaud l. W ien , vol . II.
pag . 146,tav. XIII
,fig . 1 4—1 5. Forme tozze cor r isponden t i a que lle
24 RIVISTA ITALIANA
date dall ’ autore per la sua Uvz'
ger in z Orbignan a ( l . 0 ,fig . 1 6 si
non ima di U. as p er ula. Frequente .
Uvigor ina tcnu is tr iata Renss . 1870 Si tzungsb. k . Ak .W ise. W ien ,
vol. LXII, pag . 485. (Tav. XXII, fig . 34-37,déllo Sch l ich t
,1 870 ;
Foram . Pietzpuhl, pag . 65 66,
num . 379 Presentas i n ella forma
abbreviata delle fig . 32 -33,tav. IV
,del F ornasin i ( 1 895 ; M em . R. Acc.
Sc . Bologna, ser . 5,vol. V ) , però completamen te coperta d i costicin0.
Per me la U. ten u istr ia ta non d ifi'
er isce sostanz ialmen te dal la U. p y
gmaea d’ Orbigny , d i cui va considerata qual var ietà. a costole sotti li
F requen te.
RAMULININAE.
Ramutin a globul ifera B rady . 1869 ; Quart. Jour n . M icr . Sc vol.
XX I, n . s ., pag . 58
,tav . VIII, fig . 32 33. Segm en ti staccati por tan ti
vari stolon i , sim i li a quell i della fig . 25,tav. LXX VI
,del B rady ( 1 884 ;
Foram. Challenger). Rara.
NODOSARINAE.
G land ulin a laevigata d’Orb igny . Nodosar ia (Glan d ul ina) laevigata,
Ann . Sc Nat ., vol VII, pag. 252
,num . 1 , fig . 1 -3. Pross ima
alle fig. 20 e 2 1 , tav . LX I,del B rady ( 1 884 Foram . Challenger ). Rara.
Vag in u loglan d uli na Iaevigata n . sp . Forma bimorfa avente le prima
legge d i Vagi n ul i na e le success ive d i Glan d uli na laevigata. Rarissima.
Vag in ul ina comm un is (d’Orb igny ) Nodosar ia (Den tal ina) com
mun is , 1 826 ; Ann . S c. Nat , vol VII, pag . 254,n um . 35. Non per
amore d i novi tà, sibbene n ell’ in ten to d i d istinguer m eg lio, r iun isco le
form e s im i li al le fig . 1 4 e 1 5 de l la tav . d e l F ornas in i ( 1 890 ; M em . R .
Acc. Sc. Bolog na, ser . 4 , vol . X ) sotto la denom inaz ion e ind icata, per
ché han no i segm en ti d isposti obl iquam en te ed il n icch io com p resso,
come nelle Vag inul ine F requen te .
Vag i nu l i na i n sol i ta (Schxvag e r ). C r istella r ia i nsol i ta ,1866 No
vara-E x p . g eol . Thei l, vol. II, pag . 242 , tav. VI
,fig . 85. Pi ù d ir itta
del la forma tip ica, ma, come essa,Vagiuul ina e non Cr iatellar ia, man
e m de d i legge d isposte a sp irale. Rar issima.
Vag in ul i na c lava ta Costa. 1857 ; Mem . R Acc. Sc. Napoli , vol. II ,
pag . 1 45,tav. I l
, fig . 1 8. Prossima al cam pione della fig . 25 . tav. IV,
del F ornasin i ( 1 894 ; Mem . R. Acc. Sc. Bologna, ser . 5,
vol . V ) ; ha
l inee sutural i intere , larghe, ed in legg iero r ilievo, ialine . F requente.
DI PALEONTOLOGIA 25
Vaginul in a legumen (Linné) . 1 758 ; Syst . Nat ., ed. 1 0. pag. 7 1 1 .
1 788 ; idem ,ed. 13 (d i Gme lin) , pag . 3373 . Spesso tipica come n el le
fig . 9 e 1 0, tav. II,del Fornasin i ( 1 893 ; M em . R . Acc. Sc. Bologna,
ser. 5, vol III) altre volte attraversata infer iorm en te pel lungo da oo
stole rettilin ee, a som iglianza d i q uelle che ornano l’esemp lare del la
fig . 22 , tav. IV,del lo stesso autore ( 1 894 ; Mem . R . Acc. Sc. Bologna,
sor. 5, vol. V ). Discretamen te abb ondante.
Vagin ul inop s ic in versa (Costa ). M arg in al ina in ver sa, 1 856 ; Atti
Aoc. Pontaniana, vol. VII , parte 1, pag . 1 83 . tav . X II
,fig. 1 6. F ram
men ti logori , i quali r icordano, toltene le costicine inferiori , le fig. 30
e …31 , tav. II,del Fornasin i ( 1 894 ; Mem . R . Acc. Sc . Bologna, ser . 5 ,
vol. IV). Non rara.
Vag i nulin0p s is cor n ucop ia (d’Orbigny). M argin al ina corn uco
p‘ae, 1 826 ; Ann . Sc. Nat ., vol. VII, pag . 259, num .
'
7 . (Fig . 34, pag .
384, del Fornasin i , 1 900 ; Mem . R . Acc . Sc . Bologna, ser 5 , vol. VIII).Specie di dubb io valore , trattandosi del la Vagi nul i nop s is inver sa (Costa),di m i sopra, provved uto d i costole longi tud inal i poco rilevate, g iungenti a
quas i due terzi della lunghezza, contati dall’estrem ità. infer iore. Ra
Vagi na l inop sis calcato (Costa). Vag in u lina su lca ta, 1 857 ; Mem .
B’
, Aoc. Sc. Napoli , vol. II , pag . 1 45,tav. II, fig . 1 7 . F orme sim i l i, per
quan to d i frequen te più al lungate, a quel la ri prodotta nella fig . 35,tav .
II, dol .Fornasin i ( 1894 ; M em . R . Acc . Sc. Bologna, ser . 5 , vol. IV) .
… omente rara.
C r ictellar ia p liocaena Polymorp h ina p liocaena , e Palym .
var . tr icostata, 1 899 ; M em . Pon tif. Acc . N. Lincei , vol . X V,
pag. 234 e 235, tav. IV,fig . 3 e 4. Ben g iustam en te in mer ito a questa
singolare forma ebbe a d ire i l Fornasin i Piuttostochè d i una polimor
fina, pare si tratti d i una cr istel lar ia Ed i n vero posso oggi r icono
soerla per 1’embr ione d
’
una Cristellar ia triedra, la forma defin i tiva
della, quale .non sono ancora al caso d i precisare, benchè sospett i sia
l .’i tali ca (Defi ance ). L
’un ico cam pione r in venu* one è prossimo, ma non
identico a quello delle m ie fig . 3 (I. Rariss ima.
C'r istollam'
a i talica (Defrance) . Saracenar ia i ta l ica, 1 824 ; Diet .
So. Nat ., vol . XXXIII, pag 1 77 . 1827 ; idem .,vol. XLVII
, pag .
At las ,… Gench i, tav XIII
,fig . 6 Somigl iante alle fig . 1 7 e 18
,
tav. LXVIII , del Brady ( 1 884 ; Foram . Challenger ) , però e più corta.
Med iocremente rara.
C rù tellar ia i talica var. volp icelln (Costa). C'fi stellar ia Volp i
cellu,1 857 Mem . R. Acc. Sc. Napoli , vol
° II, pag. 1 20
,tav. I
,fig . 4.
26 RIVISTA ITALIANA
E sulla forma della precedente, ossia degli esem plari che assegno al t ipo
della specie, con l’aggiun ta d
’una sot tile carena dorsale i aliua, decor o
ren te all’esterno, dal primo all
’ultimo segmen to. La m ia Gr istcllar ia,
p l iocaen a è forse l’embrione d i questa var ietà , che ho sempre r iscon
trato d i piccole d imension i . Rar issima
Or istcllar ia var iabi lis Renee. 1 850 ; Denk schr. k . Ak .Wise. W ien ,vol. I
, pag . 369, tav . XLVI,fig . 1 5 -1 6 . Corr isponde alla fig . 1 2
, tav .
LXIII,del Brady ( 1 884 ; Foram . Challenger) . Rar issima.
C’r is tcllar ia aur is (Soldan i) . Orthoceras Aur is 1 79 1 Testac.,
vol. I. pag . 98, vas 239, tav . CIV. fig. A. Spesso t ipica, ma non in
frequen temente dotata d i carena, con aculeo od aculei nella par te infe
r iore. Comune.
C r istellar ia cymba (d’ Orb igny) . Planu lar ia cymba , 1 826 Ann . So.
Nat ., vol . VII, pag . 260,num . 4
,tav . X . fig . 9. Sim i le alle fig .
e 24, tav . V, del F ornasin i ( 1894 ; M em . R. Acc. Sc. Bologna, ser. 5,
vol. V). Rara.
Ofi atellar ia pu lchella Costa. 1 857 ; M em . R. Acc. Sc . Napoli , vol.
II, pag . 1 2 1
,tav . I
,fig . 8. Pel maggiore av vi luppo all’ in izio della spi
rale su cui sono d isposte le logge p rimordiali , attr ibuisco i m ie i esem
plar i alla specie p ulchella anzichè alla elongata (Mon tfor t) ; essi rasso
m igliansi alle fig . 1 7, e 1 7a, tav. III
,del Fornasin i ( 1 894 ; M em . R.
Acc. Sc. Bologna, ser . 5,vol . IV). Rara.
Cr istellar ia r en iform is d ’ Orbigny . 1 846 ; F oram . foss. Vienne,
pag . 88, tav . III , fig . 39 -40. Tenendo conto del grado di compressione
e della rotond ità del primo segmen to esterno, nonché del numero dei
segmenti , resulta molto prossima a quella r iprodotta n elle fig. 35, pag .
385,del Fornasin i ( 1 900 ; M em . R . Acc. Sc . Bologna, ser. 5, vol. VIII).
Rara.
C r istellar ia cass is (F icthel et Moll). Nauti lus cassia, 1 798 ;
Test. M icr ., pag . 95, tav . XVII. R icorda le fig . 22 e 23, tav . III,del
Fornas in i ( 1 894 ; M em . R . Acc. Sc. Bologna, ser . 5,vol. [ V). Non rara.
C r istellar ia sch i zzata (d’ Orb igny ). Robuli na ech i nata, 1 846 Fol
ram . fose. Vien ne , pag . 100, tav . IV ,fig . 2 1 2 2 Com e le fig . 34
,
tav . III, del F ornas in i ( 1 893 ; M em . R. Acc . Sc . Bologna, ser . 5, vol.
IV) . M ediocremen te frequen te.
C r istellar ia echi nata var . p ap illoso-echinata (F ornasin i). C r istel
lar ia p ap i lloso—ech inata
,1 893 M em . R . Acc. 84 . Bologna, ser 5, vol . IV,
pag . 222, tav. III, fig . 33. C orr isponde alla figura citata ; non m i pare
possa d istinguersi dalla specie sch i zzata se non come varietà. Rara.
28 RIVISTA ITALIANA
lar ia cu ltrata (Mon tfi) , se ne d iscosta per i segmenti visib ili pm nu
merosi , i l marg in e esterno de i quali , p rima della carena,è festonato
come nel la fig . 27 , tav. III , del F ornasin i ( 1 894 M em . R . Acc … So.
Bologna, ser . 5,vol. IV) . Potrà sembrare strano che
,dopo i l seppel
l imen to fatto dal Fornasin i del la Robuliua festonata (I. c. pag . 222,
LXXII ) io l ’ abbia voluta esumare,ma r i tenendo si confondano cc
munemente C ristel lar ie d ifi'
eren ti , a causa d ella loro analogia d’aspetto
esterno, prefer isco, fino alla conoscenza d el la loro r ispettiva struttura,
d i d istinguere quelle in cui ciò trovo oppor tuno, come n el caso attuale .
Alla forma in d iscorso parm i sia pure attr ibui bi le la C ristella r ia p oli ta
Schw ager , non Renee ( 1 866 ; NovaraE x ped . geol . Thei l, vol . II, pag .
242,tav . VI
,fig . 86 . F requente .
Marginu lina glabra d’ Orb igny . 1 826 ; Ann . Sc . Nat , vol . VII,
pag . 2 59, num . 6 . M odèlee, num . 55. Si tratta della forma detta
dall’Han tk en : M arg. subbullata ( 1 875 ; M i tthe il . Jahrh . k . ung . geol.
Anst., vol. IV, pag. 46,tav. IV , fig. 9- 1 0 ; tav . V
,fig . i m iei e
sem plari corrispondono alla fig . 7,tav. III
,del Fornasin i ( 1894 Mem .
R . Acc. Sc. Bologna, ser . 5,vol. IV). Rar issima.
M a rg inul ina h i r suta d’Orb igny. 1 826 ; Ann . Sc. Nat ., vol. VII,
pag. 259,num . 5 . 1 846 ; F oram . fose. Vien ne , pag . 69
,tav . III,
fig . 1 7- 1 8 . Ind ividui del t ipo ri prodotto nelle fig . 14 e 1 5 , tav . II del
Fornasin i ( 1 894 ; M em . R . Acc . Sc. Bologna, ser . 5 , vol. IV) , bench è
magg iorm en te allungat i . F requen te.
M argi nulina costa ta (Batsch). Nauti lus (Or thoceras) costatas ,
1 791 ; Couch . Seesandes, pag . 2 , tav . I,
fig . 1 a- 1 g . Rassom ig lia alla
fig 1 9,tav . II
,d el F ornasin i ( 1 894 M em . R . Acc. Sc . Bologna. ser . 5 ,
Vol. IV), pur avendo in feriormente var ie sp ine. Rara.
Marg in ulina costa ta var . subsp in u losa 1 1 .E questa una var ietà della
specie costata , in cui le costole n on sono ancor d i vise ma accennano a
d iv idersi in sp ine, com e nelle fig . 7 ed 8,tav . II
,del Fornasin i ( 1 893 ;
M '
em. R . Acc. Sc. Bologna, ser 5,vol . III) , da questi attribu ite alla
Marginu lina sp in ulosa (Costa) , d i cui sotto in basso però i l n icch ia e
decisam ente sp inoso. F requen te.
M arginulina costata var . sp in ulosa (Costa). Nodosar ia sp inulosa ,
1857 M em . R. Acc. So. Napoli , vol. II, pag . 1 37,tav. I
,fig . 28. Alla
var ietà ind icata assegno le forme che d ietinguonsi dalle preceden ti per
avere le costole del tutto conver t ite in sp ine. Pi ù che frequen te .
Glan du lon odosar ia rap han is trum (Lin n é). Nauti lus r ap han is tr um
1 758 Syst. Nat., ed 10, pag . 1 788 ; idem , ed . 1 3 (di Gmel in),
DI PALEONTOLOGIA 39
pag. 3372 . F rammento della parte iniziale , dotato d i costole più rade ,
marcate e d iritte, d i quelle d isegnate n ella fig . 1 , tav. I , d i O. Silve
str i ( 1 872 ; Att i Acc. G ioen ia Catan ia, ser . 3, vol. VII). Rar issima.
G land ulonodosar ia rap hanus (Linné) . Nauti lus rap han us , 1 758 ;
Syst. Nat., ed . 1 0, pag . 7 1 1 . - 1 788 ; idem ,
ed 1 3 (di Gm elin ) , pag .
3372. Come le fig . 41 , 43, e 44, tav. I, del Fornasini ( 1894 ; Mem . R.
Acc. Sc. Bologna, ser . 5, vol. IV. Rara.
Glandu lonodosar ia obl'
qua (Linné). Nauti lus obliquu s. 1 758 ; Synt.
Nat.,ed 10
, pag . 7 1 1 . 1 788 ; idem , ed . 1 3 (d i Gmelin ) , pag . 3372.
Non d i rado si. presen ta come le fig . 46 e 47,tav. I, del Fornasin i
1 894 ; M em . R . Acc. Sc. Bologna, ser . 5 , vol. IV) . F requen te.
Gb adulonodosar ia obliquata (Basteh) Nauti lus (Or thoceras) obli
guatas, 1 79 1 C onch . Seesan des,tav. II
,fig . 5a — 5d . F rammen ti , ed
esemplar i com pleti ; i pr im i r icordano quel li figurati ai num eri 30 e 3 1 ,
tav . I,del Fornas in i ( 1894 ; M em . R . Acc. Sc . Bologna, ser . 5, vol IV),
i secon d i,le fig . 2 e 4
,tav . VIII
, del lo stesso autore ( 1890 ; B011 . Soc.
Geol . It .,vol . IX ) . F requente .
Glandul onod osar ia soluta (Renee). Den tal in z soluta, 1 85 1 ;
Z eitschr . deutsch . geol. Gesellsch .,vol. III, pag . 60, tav . III, fig . 4.
Frammen ti , da cui però possonsi agevolmente r icostrui re forme sim ili
a quelle delle fig 14,tav . III
,dell
’Han tk en ( 1875 ; M i tthei l. Jahrb .
k . ong . geol . Anet vol. IV) . Rara.
G la ndu lonodom r ia farc im en (Soldan i ) . Or thoceras F ar cimm
1 79 1 ; Testac .,vol . I, pag . 98
,vas 239
,tav . CV ,
fig . 0 . Abbastanza
som iglian te alla fig . 1 3 , de lla tav . del Fornasin i ( 1 890 ; M em . R . Aoc .
So. Bologna, ser . 4,vol . X ) . Piuttosto abbondante .
G landu lonodosar ia elegan tissim i : (d’Orb igny ) . Den taliua elegan
tiss im a,1 846 ; Foram , fose. Vienne , pag . 55, tav . II
,fig . 33-35 . Allun
gata come nella fig 7 , pag . 54,del Fornas ini ( 1 901 M em . R. Acc. Sc .
Bologna, ser . 5 , vol. IX ) , ma con i seguen ti m eno staccat i . Rara.
Glan dolonodosar ia p leum (Costa) . Den talina p leura 1857 ; Mem .
R . Acc . Sc . Napoli , vol . II, pag . 1 43, tav . I
,fig . 20. F rammen ti i
quali hanno la configuraz ione d i quel li de lle fig . 2 1 e 22 , tav . I, del
Fornasin i ( 1 894 ; Mem . R . Acc. Acc . Sc . B ologna, ser . 5,vol. IV ). Rara.
Glan d ulon odosar ia uer tel»ral is (Batsch ) . Nau ti lus (Or th .ceras )
ver tebral is , 1 79 1 ; Conch . Seesandes, tav . II, fig . 6a Gb . u cor ta a si
m ilitud in e della fig . 20,tav . I , del Fornasin i ( 1 894 M em . R . Acc . So.
Bologna, ser . 5, vol. IV) , però offre alla superficie costole numerose .
Rar issima.
30 RIVISTA ITALIANA
Lagenodosar ia h isp ida (d’ Orbigny ) . Nodosar ia h isp ida, 1 846 ;
F oram . fose . Vienn e , pag . 35,tav . I
,fig . 24 25. Come le fig . 22 1
,222 ,
e 225 , tav . IX ,d i O. Si lvestr i ( 1 872 ; Att i Acc. Gioen ia Catan ia, ser . 3.
vol . VII) . Rara.
Lagen on odòsar ia r ud is d’ Orbigny ) . Nodosar ia r ud is , 1 846 ;
F oram . fose. Vienne, pag . 33 , tav . I , fig. 1 7—1 9. Due logge term inali
un ite assieme, ma più d istaccate tra d i loro d i quan to non lo siano
quelle rappresen tan te nella fig . tav. VI l I, d i O‘ Silvestr i (Nodo
sar ia asp era , 1 872 Att . Acc . G ioen ia Catan ia, ser. 3, vol . VII).Rarissima.
Lagcn onodosar ia scalar ia (Batsch) . Nauti lus (Or thoceras) sca
lar is , 1 79 1 ; Couch . Seesandes, tav . II , fig . 4a-4b . Prossima alla fig . 36,
tav . I,del Fornasin i ( 1 894 ; M em . R . Acc . Sc. Bologna, ser . 5, vol. IV) .
Rar is sima.
Lagen odosar ia adolp h i na (d’ Orb igny) . Den ta lina Adolp h i na, 1 846 ;
F oram . foram . fose. Vienne , pag . 5 1 , tav . II,fig . 1 8—20. Piccoliss ima,
m egalo e m icroefer ica, con segmenti globosi , come quelli della fig .
1 8 ora citata. Rara.
Lager: on odosar ia fistuca (Schw ager) . Nodosar ia fi stuca, 1 866 ;
Novara-Ex ped . geol. Thei l, vol . II , pag . 2 1 6 , tav . V,fig . 36 - 37 . E
sem plar i interi , arcuati, som iglian ti , per quanto p iù snelli , alla fig . 37
or r icordata ; framm ent i rifer ib ili all’ altra (fig . Med iocremente rara.
Lagen onodosar ia p er versa (Schw ager) . Nodo far ia p erver sa, 1 866
Novara-Ex ped . geol . Thei l, vol . II , pag . 2 1 2,tav. V
,fig . 29 . Prossima
ag li esemplar i delle fig . 1 51 e 1 52 , tav . VI d i O. Si lvestr i (Nodosar ia
p upeid es, 1 872 ; Atti Acc . G ioen ia Catan ia,ser . 3
,vol. VII) ; nonché
a quell i della fig . 29,tav . V ,
dello Schw ager (l . 0 ) Rara.
Nodosar ia long iscata d’Orb igny . 1 846 ; Foram . fose. V ienne, pag . 32 ,
tav . I , fig . 1 0 1 2 . Come la fig . 45,tav . V
,dello Schw ager (Nodosar ia
am nd in ea , 1 866 ; Novara-Ex ped . geol . Theil , vol . II) , e sempre in
framment i della parte med ia o della in iziale . Rara.
E llip soid ina ell ip soidcs Seguen za. 1 859 ; Eco Pelori tano, anno V,
pag . 1 2 estr., tav .,fig . 1 -3. Completa e tip ica, benché un po
’
p iù al
lungata della fig . 1 suddetta. Rara.
E llip soglon d ul ina labiata (Schw ager ) . Glan du lina labiata, 1 866 ;
Novara geol . The il , vol . II , pag . 237 , tav . VI,fig . 77 . Forme
di verse d i questa var iab ilissima, però caratterist ica
, specie, una delle
qual i assai regolare, ovoidale allungata. Trovas i nelle stesse proporzion i
della E llip soid ina cll ip soides, pel num ero degli esem p lar i. Rara.
DI PALEONTOLOGIA 3 1
E ll ip sonodosa r ia ambigua (Neugeboren ) . Nool / sa r ia am bigu a,
1 856 ; Denkschr . k . Ak . W uss. W ien,Math . Naturw . C l .
,vol. X II,
pag . 7 1,tav. I
,fig. 1 3 1 6 . Un po
’arcuate , e coi due penult imi ee
gment i d i d iametro magg iore dell'
ultim o ; per i l resto ha i connotati
della fig . 1 6 anz idetta. La E ll ip 30n odosa r ia am bigua non é una buona
spec ie, dovendosi p iuttosto‘
cons iderare qual var ietà a i orifiz io rotondo
della E ll ip sonod . r otun data (d’ Orb .) (Lin gul i na r otundato , 1 846 ; Foram .
fose. V ienne, pag . 6 1 , tav . II,fig . 48 Rar issima.
E llip sonodosar ia glan d igen a (Sch w ager) . Nodosar ia g lan d igen tt ,
1 866 ; Novara—Ex ped . gbol. Theil , vol. II, pag . 2 1 9, tav . V,fig . 46 . Anche
questa é una varietà della E llip sonod . r otundata (d’
d i cui sopra ;
presen tasi in forma p iù slanc iata d i quella riprodotta nella fig . 46 ora
ricordata. Rar issima.
L ingulina car inata d’ Orbigny , var . sem inuda Hantk en . Lingu
lina costo la d ’ Orb .,
var . sem in uda, 1 875 ; M it theil. Jahrb . k . ung .
geol . An st.. vol . IV, pag . 4 1,tav . IV
,fig . 8 . (Li nguli na costata d
’ Orb . ,
var . s ubglabra, nella spiegazione della tav ) . Sim i le alla fig 1 4,tav .
LXV, del B rady ( 1884 ; F oram . Challenger ), però più ar rotondata in
feriormen te . Rar issima.
L ingulonodosar ia car in ata (Neugeboren ) . I) en tulina car inata, 1 856 ;
Denk schr . k . Ak . W ise. W ien,Math . Naturw . Cl .
,vol . X II, pag .
27,tav . IV , fig. 1 7 . Come le fig. 1 59
,1 60
,1 63
,1 64
,e 1 67 , tav . VII ,
di O. Silvestr i (Nodosar ia gem ina, 1 872 ; Atti Acc . Gioenia Catan ia,
ser . 3 , vol . VII ) . M ed iocremen te frequente .
F r ond i cular ia i naequalis Costa. 1 857 ; M em . R . Acc. Sc. Napol i ,
vol . II, pag . 372
,tav . III, fig . 3. Alcuni esemplari som igl iano alle
fig . 8, 9, e 1 0, tav . IV, del F ornasini ( 1 894 : M em . R . Acc . Sc . Bo
logna, ser . 5 , vol . V ) , altr i a quella ch ’ io d iss i var . ap icu lata ( 1 896 ;
M em . Pon tif. Acc. N . Lincei,vol . X II, . pag . 1 86
,tav . V
,fig. e
che con tutta probab il ità. va r iguardate qual forma m icrosfer ica della
specie ; resultando la pr ima, cioè il t ipo Coetiano, megalosfer ica. Medio
cremente rara.
GLOBIGERININAE.
Globiger ina bulloi des d’ Orbigny . 1 826 ; Ann . So. Nat., vol . VII,
pag . 277,num . 1 . M odèlee, num . 1 7 e 76 . Come l ’ ind iv iduo delle
fig . 7, tav . LXXIV
,del B rady (1 884 F oram . Challenger) . Abbondante .
Globiger ina conglobata B rady . 1 884 ; Foram . Challenger , pag . 603,
tav . LXXX,fig . 1 5 ; tav . LXXXII
,fig . 5 . Prossima alle fig . 1 0
,1 0a
,
32 RIVISTA ITALIANA
1 05,tav. I
,del F ornasin i (Globiger i na gom i tu lus [Seguenza] 1 897 ;
Rend ic. R . Acc. Sc. Bologna, n . s .,vol . II
,1 897 Rara.
Or bu l in a un iver so var . bi l oba ta Globiger ina bi lobata ,
1 846 ; F oram . fose. V ienne, pag . 1 64, tav . IX,fig . 1 1 1 4. Esem plari
costi tui ti dall’un ion e d i due segmen ti sfer ic i aventi i connotati delle
0fl ml ina un iversa,d i cui scpra ; tali segmen ti possono essere p iù o
meno’
com penetrat i . Non rara.
Has tiger ina p elag ica “Orb igny ). Non ion ina p elag ica, 1 839. Fe
ram . Amer . Mér ., pag . 27 , tav . III,fig . 1 3 e 14 1 1 e 2 per er rore ).
Come i d ue ind ividui a destra ne l la fig . 3,tav . LX X ,
del F li nt ( 1899 ;Repor t . U. S . Nat . M us . for . e per lo p iù i n model li i ntern i em
ati tuit i dalla p ir ite. Discretam en te comune.
P ullem'
a sp haeroides (d’Orb igny ). Non ion i na sp haer0 ide3, 1 826 ;
Ann . Sc . Nat . vol . VII, pag . 293
,num . 1 . Medèles.
,num . 43. Come
la fig . 1 3, tav . LXX X IV,del B rady ( 1 884 ; Foram . C hallenger) . Ra
rissima.
Sp haeroid ina bu lloides d’
Orb igny . 1 826 ; Ann . Sc . Nat ., vel. VII
pag . 267,num . 1 Medèlee, num . 65. Meno regolare, ma sim ile alla.
fig. 1,tav . LXXX IV,
del B rady ( 1 884 ; Femm . Challenger ). Fra
quante.
ROTALINAE.
D iscorbina g lobular'
s (d’ Orbigny ) . Rosal ina globu lar is , 1826 ;
Ann . Sc . Nat .,vol. VII, pag . 22 1
,num . 1 , tav . XIII
,fig . 1 -4. Mo
dèles,num . 63. Pur avendo le due facce rispettivamen te rassemiglianti
a quelle delle due fig . 1 2a e 1 25, tav . LXXXVI , del Brady ( 1 884 ;
Foram . Challenger), re lative alla D iscor bina v i lar deboanu d’
Orb igny) ,at tribuisce la m ia ferma alla specie globu la r is , a mot ivo della de.
pressione del suo n icch ie ; le cui perferaz ien i sono med iocremen te gros
solane . F requente .
Trun catu l i na var iabi lis d’Orb igny . 1826 ; Ann . Sc. Nat.
,vel . VII
pag . 279, num . 8 . In form e di verse,alcune delle qual i rammen tano la
fig . 1 8,tav. VI
,del Terquem ( 1 878 ; Mém . Soc. Géol . F rance , ser . 8,
vol . I,m em . 3
, pag . Rara.
Tr uncatu l in a unger iana (d’Orbigny ). B atalin o unger iana, 1 846 ;
Foram . fees. Vienne, pag . 1 57
,tav. VIII
,fig . 1 6- 1 8 . E la ferma t ipica
mancan te però delle gramilazien i dal lato i nfer iore . Rara.
Tr un catu lina d utemp lei (d’ Orb igny ) . Rotalina Du tcmp lci , 1 846 ;
Forum. fees . Vienne, pag . 1 57
,tav . VIII
,fig . 1 9 - 2 1 . Ha le ultime
DI PALEONTOLOGIA 33
legge pm rap idam ente crescen ti e le per feraz ien i p iù m inuto,ma nel
rimanen te rassem igliasi alle figure ri cordate . Abbondantissima.
Trun catul ina du amp lai var. r en es i n . Cor r isponde alla int erpreta
zione della specie data dal Renee, n ella fig . 1 6, tav . IV ( 1 865 ; Denk
seh r. k . Ak W ise. W ien , Math. Naturw . C l , vel . X X V, pag .
cioè a forma magg iormente dep ressa r ispetto al tipo, ed un po’con vessa
infer iormen te. Abbondan te.
Tr un catu lina du temp lei var . aj a is (s zek ) . B otulina aj m'
a,
1 848 ; Naturw iss. Abhand l . W ien ,vol . II
, pag. 1 44, tav . X II, fig .
36—38 . Sim ile alle figure ci tate ; qualche volta vi si osserva l ’ avvolgi
men to sin ist reree Rara.
Anom alina ar im in ens is (d’ Orb igny) . P lanu lin a a r im i n en s is, 1 826 ;
Ann . Sc. Nat., ve l. VII, pag . 280
,num . tav . X IV,
fig . 1 - 3. C or
r isponde alle fig . 10, tav . XCIII,del Brady ( 1 884 ; F 0 ram . C hallenger ) .
Abbendan tiseim a.
An om a li na cfr. r otula d’Orb igny . 1 846 Foram . fees. Vienne, pag.
1 72,tav . X ,
fig . 10-1 2. E della forma d i queste figure , però magg ior
men te r igenfia e disuguale dai due lat i . Rar issima.
Anomali na helicin a (Cesta) Non ion in a hel icin a , 1 856 ; Att. Acc.
Pen taniana, vol. II, par te 1
,tav
,X IV
,fig . 1 3 (non deecr) . M em . R .
Acc. Sc . Napoli , vol . II, pag . 1 23, tav . I
,fig . 1 8. Più r igenfia dell
’in
d ividuo figurato ai num er i 1 2,l 2a
,e 1 2b , tav . VII
,del F ernas ’
n i ( 1 895 ;Palaeen t . I tali ca, vol. I), e con marg ine ar rotondate . F requen te.
Anom ali na gr osser uyosa (Gùm bel) , Tr un catu li na gr osserugosa,
1868 Abhand l . k . bayer . Ak . \Viss., II C l . , vol . X , pag . 660
,tav . II
,
fig . 104. Pross ima al le fig… 4,tav . X CIV
,del Brady ( 1884 Foram . Chal
lenger ), ma p iù pian egg ian te dal lato in fer iore (fig . 4a). Rar issima.
P ulv in ulin a aur i cula (F ichte l et Moll) . Nauti lus au r icu la,
1 798 ; Test . M icr ., pag . 1 08,tav . X X
,fig . a-c . Depressa com e nelle
fig . 43,43a, 43b , tav . III
,del F ornas in i ( 1 894 ; M em . R . Acc . Sc. Bo
legna, ser . 5, vol. IV) . F requente .
Rotalz'
a cfr . beccar u (Lin né ) N au ti lus B eccar i i,1 758 ; Syst. Nat .
ed . 1 0, pag . 7 10. 1 788 ; id em ,
ed . 1 3, (d i Gm elin ), pag . 3370. H a
i l d isegno d ella specie, m a v i man cano i particolar i ; semb ra una forma
degenerata. Rar issima.
Retal ia soldan i i (d’Orb igny ) . Gyr oid in a Soldan i i , 1 826 ; An n .
Sc. Nat .,vel . VII
, pag . 278,n um . 5. Modèles, num . 36. Come le
fig. 6, tav. CVII,del Brady ( 1 884 ; Foram . Chal lenger) . Rara.
RIVISTA ITALIANA
POLYS'
I‘OMELIJNAE.
N em'
om’
na umbi licatu la (Mon tagu). Nauti lus um bi licatuluo 1 803
Testac. B r it, pag . 1 1 9. 1 808 ; Supp l., pag . 78, tav . XVIII, fig. 1 .
C on embell ice più r istretto d i quelle segnate nella fig . 8, tav. CIX ,
del B rady ( 1 884 ; Foram . Challenger). Rara.
La fanculo. così esposta offre i caratter i d’essersi sed im entata nelle
acque tem perate d i un mare, piuttosto ma non eccessivamente pro
fondo, spet tante al m iocene
,
‘
ovvero al pliocene, avendo dessa la fil one
m ia m ie-
p liocen ica, che,a farm i m eglio intendere , chiamerò zancleana ;
p er cui, se da un canto posse confron tarle e magari reputar la equiva
len te, prescindendo dal suo peculiare carattere batometr ico, p . es. a
quelle : della marne bianca langhiana di M en teg ib io nel
del la marne. gr ig ia tort oniana d i S. Rufille presso Bologna della
mar e a g ialliccia probab ilmente langh iana, d i Sansepolcro nella pro
v inc ia d’
Arezzo dall’altro ne trovo ind iscut ibili i rappor t i in tim i
con le faunule, p . es. : della marne blu de l Vaticano pliocen ica,
d elle marn e biancastre , giallas tro, g r igiastre, della Calabria, del M es
sinese, e del la provincia d i Palermo mol te delle quali , se non la
m agg ior par te, sono da r iguardarei per gli antichi stud i d i G. Seguenza,e pei m odern i di L. Seguen za, com e spettanti al pliccene (zona pro
fon da nonché del calcare g rossolane arenacee'
, pliocen ice , detto
macce d i Pa'o,tra la foce del Tevere e C ivi tavecch ia Dati
quest’ultim i rapport i , che crede r ipetansi dal pun to d i v ista stratigra
fico, non esi to a qualificare come p liocen ica anche l
’arg illa gr ig ia d i
Tor Caldara,che r icetta la faunula in questione, ed a r iten erla cee
tan ea e batometr icamen te corr ispondente alle marne del Vaticano,le
quali , cel De Stefan i , attribuisce a zona m ar ina p iù profonda della co
ralligena (piacien zan e), benché non di profond ità r ilevante, ossia alla
facies geolog ica da lui detta Vaticana
Studiata dal Ceppi .
Idem dal Fornasin i .
Idem da A. Silvest ri .
Idem dal Costa, del Ponz i, dal Mantovan i , e dal Fornasini .
Stud iate dal Cesta, da G. Seguenza. dal Ciofalo, da Fornasin i , dal De A
m ic is, da A. Silvestri,ecc .
Secondo le osservazion i del Terr igi, ed in parte anche ( inedite ) di chi
36 RIVISTA ITALIANA
O to l i ti foss i l i te rzia r i d e ll ’ Em i l ia
Nera DI G. G. BASSOLI.
(Tav . I,II).
Nel M useo Geologico della R .Un iversità d i M odena esiste una rac
colta d i Otolit i fossi li,n ella massima par te separati dal p rof. Doderlein
da altr i fossili che più lo interessavano, in parte raccol ti da m e e sepa
rati da sabbie e da materiale del m useo. Le località d i r invenimento
sono le seguen ti : Rio Rocce , Quattro Castella,
'
S. Valen tino, S. Pole,
Cà di Regg io pliocene del Regg iano ; Fossetta d i Sassuolo,Spez
zano p liccene del Mod en ese ; M onte Z ago, Castellarquato, B ierzo
p liocene del Piacentino ; M en te Gibb ie , S. Maria m iocene m ed io del
M odenese ; Pan tano m iecene m ed io del Reggiano.
Per la loro determ inazione m i sono valse d i cop ioso mater iale vi
ven te,ia parte da m e raccolto
,in parte gen t ilm en te donato al Museo
de i Con ti dottor i Ben t ivog lio. Per cortes ia del p rof. Ficalbi , ebbi in cc
m un icaz ione la raccolta del M useo d i Padova, fatta da Canestr in i e Par
m ig ian i : ultimam ente potei anche consultare m olti d isegni in ed i ti di
K ok en possedut i dal prof . Schubert della K . K . Geol . Re ichsanstalt di
Vienna. C on questi che ha g ià. in iziato la pubblicaz ione n l1 otoli t i
terz iar i d ’Austr ia-Ungher ia abb iam o con venuto d i dare i l nom e in cc
m une alle spec ie nuove trovate da am bedue.
Fatta eccezione per l’Ar ius
,d i cui non si r in vengono che lap il li ,
tutti gl i otoli ti sono sagitte : nelle d iverse forme , il colore var ia dal
rosso,al g iallo, al nero : le d imen sion i van no da un m in im o d i mm .
0 3 (lunghezza larghezza spessore ) d e ll’
Ot . ( B eryc ida
r um f rag i lis Proch. 9. mm . 1 4 dell’Ot. (M acr ur us) m a
arim as n . sp. Il mass imo peso e i l m ass imo spessor e sono ragg iun t i dal
1’() t. (Sciaena) sp ec iosus K ok . che m isura mm . 8 e pesa
2 g ramm i .
DI PALEONTOLOGIA 37
C irca la morfolog ia, la fisiologia e il valore per la sistematica degli
otoli ti vedansi X ok en e Fryd
A. PHY SOSTOMI .
S i lu r o i d a e .
Or omr nns (Am e s) cnarmm eus K e k e n
Tav. I. F ig . 1 . 2 .
1 89 1 . K ek en Neue Untersuchungen an ter t iaren F isch-Otol ithen II
Tav . VI, fig . 8.
Già nel 1 884 K ek en aveva pubbl icato la descrizione d i un Ot. ( in
cer tae sed ie) crassus , che poi, per avere avuto t ra man i un Ar ias v i
vente e per averne trovat i al tri fossi li i n s i tu r iconobbe per lap i llo d i
Ar ius .
Altri prossim i a quelli trovò in seguito e fra questi i l german icus
che corr isponde p ienamente ai nostr i . La forma generale è lent icolare,
for temen te biconvessa, una delle faccie è p iù tondegg ian te, l iscia e le
vigata, l’altra è leggerm en te appuntata nel cen tro e m ostra la strut.
tura ragg iata e concentr ico… Dim . m ed ia mm . 10 6 esem plar i .
M . Gib io.
Una figura d i Sismonda (4) d i un otolite di Tor tona è quasi iden
tica a questa forma
S com'
br e s oc i d ae .
Or emr nus (H sum aurnus) ITALICUS B a s s o l i .
Tav. I . F ig. 8.
Ferma allungata : faccia in terna p ianegg ian te mun i ta d i lungo solco
d ifi'
erenziato in lunga e larga coda che'
fa un angolo ottuso all’insù col
Z eitschrift d . Deutsch. geol. Gesell. Bd . 36.
Die 0tolithsn der Fische (Un iv . K iel
Z eitschr ift d. Deutsch . geolog. Gesellschaft. Bd , 36.
Descrizione dei pesci e crostacei fossili del Piemonte (Mem. della R. Acc .
della Sc. Tor ino Sez. II, t . X ,
Il Prof. Bassani Ittlofauna d i Gass ino ) descrisse e figurò un otoli te di
M ac,che mi pare possa identificarsi col german icus.
38 RIVISTA ITALIANA
grande ostie : l’area superiore è magg iore dell
’ inferiore : esiste un re
s tro pronun z iato. La facc ia esterna è convessa e liscia. La determ ina
z ione fu fatta sopra un d isegno ined ito d i K ok en di H em i ramp hus at
t uale che corr isp onde p ienamente. Dim . m ed ie mm .
7 es. M on te Gib io.
B . ANACANTH INI GADIFORMES.
I . G ad l d ae .
Or omr nvs (Par ere) n ume K o k e n
Tav . I. F ig . 3. 4.
1 89 1 . K ok en l . o. Tav . IV,fig . 3, 3a 6
,6a.
Queste sagi tte hanno una forma allungata e con tor ta, appuntata
n ella par te poster iore : la facc ia. intern i. è fortemen te convessa, mun ita
d i lungo e largo ost ie non d ifferenz iato, ostruite da un grande collicole
unico . L’
area inferiore ha una lieve sporgen za parallela al solco : da
q uesta par tono, arr ivando sino al marg ine p iccole eolcature perpend ico
lari . La faccia esterna è p iù o m eno finemente tubercolata. Dimensioni
var ian ti da mm . 1 2 5 a 5
47 ce. M on te Gib ie 1 Castellarquate 1 Cà. di Reggio 1
Terr . p lico. Med .
Or eu r aus (Pa r ere) a m m e var . scuz ru K e k e n .
Tav. I . F ig. 5 . 6.
1 884. K ok en Usher Fisch-Otel ithen Tav . IX ,fig . 4.
1 89 1 . K ek en l . o. Tav IV,fig . 2
,2a.
Analogo al pr eceden te da cui si d istingue bene per l’andamento
non con torte , per i l solco, d iviso in breve coda e lungo ost ie, per i
margin i lobosi e per la presenza nella faccia esterna d i tre file d i tu
bercol i,una cen trale e due laterali che interessano i marg in i . Dim en.
m ed ie 1 0 4
250 es. c irca M onte Gib ie 1 Terr . pl ice . M od .
Z eitschrift d . Deutschen geol. Gesell. 1884 .
DI PALEONTOLOGIA 39
Or onrrs us (Par ere) annes s e K e k e n
var . PL ANATA B a s s o l i et S c h u b e r t .
Tav. I. F ig . 1 1 . 1 2 .
I caratter i che d istinguono questa var ietà. della precedente sono i
seguen ti : i l solco più profonde è meno nettamente d iviso, i margi n i
sono l isci,i tubercoli della faccia esterna sono m eno r i levati e m eno
regolar i , le d imen sion i sono notevolmente m agg iori tan te che rar iss im e
sono le sagi tte in tere. L’estrem ità. poster iore è curva in fuor i . Dim .
m ed ie mm . 1 3 5
C irca 1 50 se. M . Gibie 3 Quattro Castella 2 Terr . plico. M ed .
Orou r s ns (M en ecmo) p am scuass r us B a s s . et S e b u b .
Tav . I. F ig . 7 . 9. 10.
Due sagit te, una delle quali rot ta e assai consen ta nella faccia in
terna, che corr ispondono perfettamen te a quel .e del M er lucius escu len tus
Riese. L’esemplare rette ha la faccia esterna conservatiss ima e in essa
sono ben v isibili i m inuti tubercolet t i d ispost i in file concentr iche che
seguono l’andamento dei marg in i . La faccia in terna d ell
’
esem plare in
tere mostra il solco che si restri nge sino a m età. ci rca del la sag itte , indi si
allarga nuovamen te nella coda : questa è occupata da un g rande coll i
cole . La lunghezza del l’esem plare r ette fu st imata col con fronto d i
sagitte attuali mm . 1 6 x 3. L’esemplare inter e m isura 1 .
Ambedue sono d i Mon te G ibio .
M ac ru r i d i .
Or o: .u nus (M acauaus) s ou r r rcus S e b u 5 .
Tav. I. F ig . 1 7 . 1 8
1 905. Schuber t F isch-Otel ithen des òst. - ungar . Ter ti ii rs Tav .
XVI, fig . 3 1 -33.
Faccia in terna p iana e d ivisa in due par ti ugual i dal selce che non
arr iva ai marg in i, è poco d ifferenz iate e occupate da cellicoli. Facc ia
Jahrbuch der k . k. Goel Reichsanstalt , Band LV. 1905 .
40 RIVISTA ITALIANA
esterna convessa, tubercolata i rregolarmente. Dim ens ion i medie mm .
6 x 3 2 x L2
500 es. circa Monte Gibbie 1 7 Cà. d i Reggio 3 Terr. plico. Mod.
1 Quattro Castella 2 Castellarquate .
Or eu r us (Macanaus) cann es B a s s .
Tav. I. F ig . 25.
Facc ia inter na piana d i v isa in parti inegual i del solco : arca iafa
r iore magg iere de lla super iore : facc ia esterna m inutam ente tubercolata.
poco convessa : c irca ne l centro d i figura un tuberceletto circondato da
altri disposti in cerch io . Dim m ed ie mm . 1 .
50 es. M en te Gib ie .
Or eu rus (Macaus us) es s er ne B a s s
var . APICATA B a e e
Tav. I . F ig. 2 1 . 22 .
Ferma subtrapezeidale, faccia interna inegualmente divisa dal solcolarge, profondo es teso e d ifferenz iate . La l inea dorsale circa paral lela al
selce ha un r ialzamen to nella parte an ter iore. Non vi e ex c isura, n ella
faccia esterna leggermen te tubercolata e poco con vessa,manca i l tuber
solette cen trale dell’orn atus . Dim . mm . 7 5
23 es. Mente Gibie 2 Castellarquato.
Orearrnus (Mam mana) cex r ear us B a s e .
Tav. I. F ig . 28.
Forma lrregolare , app iat t i ta : faccia in terna pianeggiante , di visa i
negualmen te da un solco ad andamen to arcuate con restring imen to circa
a m età : P oet ic ragg iunge i l marg ine e v i forma una leggera ex cieura,l t coda è c irca di uguali d im en sion i, ambedue sono forn i ti di collicole ,sull
’area inferiore è una p iccola depression e : legg iere crenellature verso
i l m arg ine poster iore. Facc ia. es terna leggerm ente tubercolata, poco con
vessa. Dim . da mm . 6 3 1 a mm . 6 8 2 .
1 5 ss. Monte Gibie 1 Fossetta Sassuolo.
DI PALEONTOLOGIA 41
Or omr nus (Macanaus) Aarm s saerìms B a s e .
Tav. I . F ig . 26 .
Ferma subtr iangolare : l inea dorsale fortemente r ialzata in corr i
spondenza dell’ost ie : faccia in terna p ianegg iante, solco d ifferen z iate in
coda e ostie con una espan sione circolare nel m ezzo. Faccia esterna fer
temente e g rossolanamen te tubercolata. negli esem plari gran d i , p iù m i
nutamen te e finem en te ne i p iccoli . In tu tti i tubercoli sono d isposti a
piram ide. I margi n i sono crenel lat i. Schuber t r itiene queste sagi tte u
gnali al suo Ot. (Moor . Ar thaber i fondato su sei esemplar i d i d i verse
local ità . R itengo che sia m olto prossimo, ma non uguale, per la forma
del con torno, per i l solco m eno es tese e p iù d ifferen z iate e per la tu
bercolatura. C fr . Schubert. I. 0 . pag . 62 1 - 622 e Tav . X VI, fig . 38.
Dim . m edie mm . Le dimension i m assime di Schuber t
sono mm . X
100 ea. circa M on te G ibie 1 Castellarquato.
Or onrre os (Macauaus) TOULAI S c h u b .
Tav. I. F ig. 1 3. 1 4.
1 905. Schuber t l. o. Tav X VI,fig . 34-37.
Il solco d i questi d i Modena è m en o profonde e la facc ia esterna
ha tubercoli ben p ronun z iat i, ma tutti g li altr i caratter i corr ispondono
bene alla descr iz ion e e alla figura d i Schubert . Dim . da mm . 3 X 2
0. mm. 1 1 5 2 (es. consun te).85 se. M ente Gibie 3 Terr . p li co. M ed .
Or emr nus (MAcausus) TOULAI S c h u 5
var . CR ISTATA B a e e
Tav. 1 . F ig . 1 5. 1 6.
Difi'
erisce dal preceden te per 1’area super iore che è fatta a cresta,
com e bene s i r i leva dalla figura in luogo d i essere con tinua. I tubercoli
della faccia esterna sono d ispost i a p iram ide e i cen trali sono molte sper
g6 n t i . Dim . da mm . 4 a mm 1 1
22 es. Mon te Gibie.
42 RIVISTA ITALIANA
Or omrus (Macauaus) novus B a s s .
Tav . I. F ig . 27 .
Faccia in terna divisa circa a metà dal solco d i fferenziate in tre
ben d istinte parti occupate c iascuna da un collicole : in alcun i esemplari
manca quelle di mezzo. Le aree formano fra d i loro un angelo cui sulla
faccia esterna corr isponde un r ialzo. Soltan to le meglio conservate hanno
traccie di tubercol i, le altre sono liscio. Dim . med ie mm
82 se. Mon te Gibie.
Orozrrnus (Mzcauaus) caacru s S c h u h
Tav. I. F ig. 1 9. 20. 28. 24.
1 905. Schubert l . o. Tav. XVI.
Faccia in terna, leggerm ente convessa d ivisa inegualmente da un
solco lungo, strette e non differenz iato, che non arr iva ai margini .
L’area infer iore, magg iore della superiore è finamente e regolarm en te
sol cata da crenellature d isposte a ragg i e da depression i concentr iche
specialmente presso i margin i La faccia esterna è tubercolata. Dimen
sion i notevolmen te var iabi li da mm . a mm .
200 ea. circa M onte Gib ie .
Oronrraus (Mam mana) Teom a S c h u bTav. 1 . Fig . 34. 35 .
1 905 Schubert I. c. Tav. XVI, fig . 1 4-1 9.
Grande solco che arr iva ai marg ini occupate da un grande collicole
depresso. L’
esemplare figurato è meg lio conser vato d i quelli austr iaci
e in esso si vede nettam en te una piccola coda che fa coll’ estro un angolo
d i circa L ’area super iore è espansa, a marg in i continui , di forma sub
trapezoidale , l’ inferiore e leggermen te crenellate Dim .mm . 9 X
(se. con sunte) a mm . 1 3 4.
4 es. Monte Gibio.
Or emr nns (MACBUBUS) maxm us B a s e
Tav. I. F ig . 29. 30.
Questa forma si avv icina all’Ot. (Macr .) Haww fuchm Schub . ma
ne d ifferisce pei seguen ti caratteri : 1’area super iore è rialzata anz iché
44 RIVISTA ITALIANA
1 30 ea. circa Monte Gibie 6. Fessetta Sassuolo 2 Rio Recca
3 C i di Regg io 1 Pan tano 2 Caste llarquato.
Dr ocrrrm s (Dr amm a) Sax emrs sm B a s s .
Tav. I. F ig. 48.
Sag itte p ir i form i r igonfie nella parte an ter iore : faccia interna forte
men te convessa con solco d ifferen z i ate in lungo ostie e breve coda am
bedue occupat i da collicole . Faccia esterna p ianegg ian te. Tutti gli e
sem plar i mostrano gli efi'
etti della flui taz ione. Dim . da mm . 1
a mm . 4
25 ce. Fossetta Sassuolo Rio R ecca 1 S. Polo (Sassuolo)Cb. d i Regg io.
Dr or.rrs us (Dramma ) raavm.us B s e e
Tav. I. F ig. 43.
Di forma p iù raccolta che gl i altr i Op h id i um sono evidenti le os
ratter istiche del solco. K ek en in d icò col nome d i falloso un otolite ei
m ile a questo, ma più allungate e d i dimensioni assai magg ior i . Dim .
mm . 1
9 ce. Gb. d i Reggio.
OTOLITHUS (Dramma ) rum ena B a e s
Tav. I. F ig. 46 . 47 .
Prossimo all’Ot. (Dp h .) Pan tan ellu , che supera parecch io nella di
mension i. La faccia. interna è convessa e d ivi sa del solco caratteristico,
l’esterna è pianegg ian te e acciden tata da protuberan ze e avval lam en ti
che in qualche esem plare producono lob i ben distinti nel margine eu
per iore. Dim . da mm . 6 2 a mm . 1 6 1 0
1 2 ss. Mon te Gibio.
Dr emr rm s (Dramm a ) m es os B a s s .
Tav. I. F ig . 44. 45.
Grandissime sag itte b icenvesse, allungate. Il solco è come al solito
d i fferenz iate in lunga coda e breve ostie quas i perpend icolare a questa.
La coda è occupata da un lungo coll icole,che in tre esemplari mostra.
DI PALEONTOLOGIA 48
piccole solcature trasversal i. -La faccia esterna ha grosse , irregolar i
protuberanze. Un esemplare ha i l collicolo anche nel solco. B imen . da
mm. a mm . 23 1 2
4 se. Monte Gibio.
Dr onrrrm s (Fmassr nn) rosw nnus K 0 k
Tav. I. F ig. 36 .
Dalla figura d i p ortan za di K ok en d ifl’
erisce leggermente per es
sere piriforme per la simmetria delle par ti , e per l’estrem ità appuntita.
Il solco ba andamento un i form e nella par te in feriore ed è occupato da
un grande collicolo. Man ca il r igonfiam en to nella parte inferiore. Dim .
mm . 8 4 2.
1 es. Mon te Gib io 3 Cà d i B ogg io.
Dr onrrrms (Dr nmn nanr m) n 1 r r onm s K o k .
var . ADUTANGULA K 0 k
Tav. I. F ig. 3 1 . 32 . 33.
1 89 1 . K ok en I. c. Tav. V,fig . 9.
Belle sag i t te con breve coda e lungo ost io che arr iva a formare
una ex cisura nel marg in e an ter iore : quel lo poster iore è ap pun t ito. Al
cun i esemplar i ben con ser vati hanno la faccia esterna con g rossi e nett i
tubercoli che interessano i marg in i e corr ispondono a crenellature dol
l’ area i nfer ior e della faccia interna. Dim . mm . 5 2 .
6 es. M on te G ibio.
Dr onr rns (Drum rm anmu) om nns B a s s .
Tav. I . Fig . 39. 40.
Grosse sag it te sim ili al le precedenti : ne d iffer iscono per'
i l solco
larghissimo la faccia in ter na for temen te convessa e le aree d i d im en
s ion i circa ugual i in gran dezza al solco. La faccia esterna ha una pro
tuberan za sporgente che rammenta quella delle Corvino. Le d imen sion i
sono assai magg ior i. Dim . mm . 1 7 l l 6.
6 se. Monte Gibio.
46 RIVISTA ITALIANA
0. ANACANTHINI HETEBOSOMATA.
P l eu r on ec t ld ae .
Dror.rrrms (Drrnanns) Sounni:ar x B a s s
Tav. II. F ig. 9.
Potsi identificare questo genere, non trovato s inora, per mezzo del
confron to col viven te C i tlzarus li nguatula. La sag itta è p iri forme : nella
faccia interna p ianegg ian te sporgono le due creste del solco che d i ver
gono lentamente dalla coda all’ ostio : presso i marg in i le creste si ab
bassano e cosi il solco svan isce sen za confini netti.
La faccia esterna leggerm en t e e irregolarmen te convessa ha la
parte r igonfia r ivolta all’ind ietro. Dim .
5 se. Mon te Gih l0 .
Dr omr rm s (Fu r nesa) nonrm s B a s s
Tav. 1 1 . F ig. 9.
Per la grandissima som igl ian za di questo sagitte con quelle della
Platessa p assar della collezione d i Padova le r ifer isco a detto genere.
La forma,1 ’ andam en to e l
’esten sione del solco, la forma generale, le
lobature dell’area infer iore
,tutto corr isponde pienamen te.
K ok en ha un Ot. (Plat ) sector completamon te d iverso da questo
lo determ inò d ietro confronto colla Platessa flesus di cui da una figura
che d ifferi sce totalmen te dalla P . p assar d i Padova.
Dim . mm .
1 1 ss. Monte Gibio 2 Terr. p lico. Mod.
Dronrrrms (Souza) K ox nm B a s s et S o b u b
Tav . II. F ig . 3.
Un solo esemplare che corrisponde assai bene alle Solee attuali ca
ratter izzate da una scanalatura che circonda i l solco tutt’attorno e fa
appar ire più elevate le creste . La faccia inter na è convessa l’ esterna
leggerm ente concava. Dim . mm .
1 es. M onte Gib io.
DI PALEONTOLOGIA 47
Dr onrrnus (Soana) ram e B a s s . et S c h u b .
Tav . II . F ig. 4.
Più che a tutte le altre queste sag itte sono prossime all ’ attuale
Solea lascar ia. Il solco è lungo e le creste r i levate : circa a metà èun accenno a una strozzatura. Il margine inferiore ha un r igonfiamento
verso l’ ind ietro. La faccia esterna è leggermen te con vessa. Dim . mm .
8 es. M onte Gibio.
Dr om r n ns (Pnnuaon ncrmannm) acnum ar ns K o k
Tav . II . F ig . 5. 6.
Lunghe, sot,ti li
,b ioonvesse
,appuntite alle due estrem i tà.. Solco poco
netto,occupato da un grande col icolo. La figura d i acum inata: d i K o
k en ha creste p iù sporgent i . Dim . med ie mm . 8 2
40 es. Monte Gibio.
D. ACANTHOPTERYGII.
S c i ae n ld ae .
Dr onr rrms (Convnu ) ornamam .us K o k
Tav. II. F ig . 7 .
1 89 1 . K ok >n l. o. Tav VIII , fig. 7 .
Piccole,tondegg iant i : facc ia interna lievemente con vessa col solco
caratter istico poco profondo a largh issimo ostio e stretta coda r icurva.
Faccia esterna finemen te tubercolata. Dim . mm . 3 2
6 es. Mon te Dib ia.
Dr ou r sus (Scu m… ) srna osus K o k .
Tav. II. F ig. 8 .
1891 . K ok en l. 0. Tav . VII,fig . 2 -2a.
Il solco è quello della fam igl ia le d im ension i sono notevol i. La
facc ia esterna ha una gibbosità molto r ilevata, ma non a spigoli vivi
RIVISTA ITALIANA
1 905. Schubert l. o. Tav. XVII, fig. 1 2-1 6.
Piccole,tondegg ianti leggermente biconvm e. Nella faccia interna
è un largo solco d ifl‘
erenziato in ostio e coda occupat i ambedue da col
licc io. Faccia esterna liscia poco convessa.Dim .medie mm . 3
800 es . circa Mon te Gib io 3 S. Polo (Sassuolo) 1 S. Maria
2 Cà d i Bogg io.
Dr or.rrrms (e cmannu ) sr r.nunmtxs P r o c h
Tav 1 1 . F ig. 2 1 . 22 .
1 893. Prochazka l. e. N. X XVI, pag . 8 1
,III
,6.
1 905. Schuber t 1. r. Tav . XVII, fig. 1 7 .
F orma elli tt ica, solco come i l preceden te , esiste una pronunziata
ex cisura con rostro e antirostro acum inati. Il marg ine infer iore è piz
zettato. Dim . medie mm . 5 X
1 400 se. circa Monte Gibio 1 S. Polo.
Dror.rnm s (Buar cmaaum) suw ar us B a s s
Tav. II. F ig. 23. 34.
Sim ile al preceden te : ne d ifi‘
erisce per il rostro e l’ant irostro ar
rotondati e per la presenza n ella faccia esterna.
d i una ben d istinta
dep ressione che s i esten de su tutta la faccia, in corrispondenza dell’asse
m inore. La larghezza d i questa d epressione è circa un ottavo della
lunghezza della sag itte . Il gran numero d i esemplari m i autor izza a
farn e una specie a parte. Dim . mm . 6
1 800 es . ci rca Monte Gibio 50 Fossetta Sas'
suolo 60 Terr.
plico. M od .
Dr ox.rnm s (Ban r cm anuu) r unr ncunar us B a s s .
Tav. II. F ig . 25. 26 .
Anche questo è simi le ai preceden ti . I l contorno non è altrettan to
regolare avendo una leggera dep ressione nella par te super iore. C iò che
lo caratter izza è la presenza, sulla faccia esterna,d i un un ico tubercolo
ben rilevato, lungo l’asse magg iore, un po
’al l
’
indietro. Il solco e re
lat ivam en te forse un po’stretto. Dim . mm . 6
3000 es. circa Mon te Gib io 1 Rio Rocca 3 Cà di B oggio.
DI PALEONTOLOGIA 5 1
A proposito d i questi otoliti debbo notare che il solco pm che a
tutti gli altr i è somigliante a quello dell’Ot. Op h id .) d ifi orm is K ok .
Furono riferiti ai B erycid i per l’autor ità d i K ok en
,che ha un austr ia
ca: e un m cd iter ran eus prossim i a questi . Il seguente fu da Prochazka
riferito ai B erycid i anch’esso, ma dubito assai della sua assegnazione.
Dr ou rnus (Bnnr cm anuu rnaen.rs P r o c h
Tav. II. Fig. 27.
1 893. Prochazlra l. o. Tav. III, fig. 1 1 .
1 905 . Schubert l. 0. pag. 40, fig. 4.
Piccolo, con rostro appuntito, solco lungo e stretto,senza collicoli
,
non d iflerenziato. Dim . mm . 1 2
2 es. Cà di Boggio.
P e r c l d ae .
Dm nrrnus (Du r e x ) uom u s K 0
Tav. II. F ig. 82 .
1 884 . K ok en l. o. Tav. VIII , fig . 8.
Faccia interna convessa con solco d ifferen ziato in lunga stretta
coda e largo breve astio. Le aree sono m inutamen te crenellate. La
faccia esterna è leggermente con vessa. Non esistono collicol i . La so
miglianza col Den ton: vu lgar is è grand i ssima. Dim .medie mm . 5 4 8.
52 es. Monte Gib io.
Or om nus (Dun n: ) sranom rus B a s s
Tav. II. Fig. 37 . 38.
Forma subellitica : i l margine super iore ha costantemente un’espan
sio’
ne lobosa eporgente all ’ indietro. Soloo caratteri stico più profondo che"
nel precedente , coda alquan to più incurvata. Facc ia esterna legger
men te convessa. Dim . med ie mm .
1 50 ea. circa Monte Gibio 1 Rio Bocca.
DI PALEONTOLOGIA‘
v53
Drou r nus (Su m m a) u nrmmxsrs B a s s.
Tav. II. F ig . 36.
Faccia interna p ianeggian te col s olco caratterist ico : l’ostie pro
porz ionatamente più lungo, la coda è al largata all’estrem i tà. Marg ine
:per ioi e irregolare , i nferiore cont inuo e l iscio. Rostro acuto e sporgen
te, «p iccola m eisara 1Faccia esterna legge rm ente con vessa liscia. t m .
m edie man . 8
800 as … o. H aute Gt hio 1 Rie Boone.
Dr ou r nus (Sr aamaaux ) r naou.1 s iBaaa .
Tav.
”
II . Fig . 38 .
1P'
moab aag itte d 1 1fom a m bellittiea. Faccia.interna pianeggiante,oel
solco caratteristico : la coda è re lativamente p iù profonda. Fac…
na convessa. Dim . mm . 2
4 es. Cà di B oggio.
Dr ou rnus (Paarsrnnror ) cam us B a s a.
Tav. 1 1 . ,F ig . 42.
Prossimo all’
Ot. (Per ). p er sonatus Kok .—ma ne difierisoe per
—l’an
damento « k l M i t o —un po’
r icurvo leggeu nen te strom toa metà » e al
largato all ’ ostie anzichè retto e un iforme. Rostro ottuso, contorno irre
golare sabellitt ico faccia interna .com—a, esterna pianeggiante. Dim .
mm .
2 ea.‘Hon
'
te Gib io 2 Fessetta Sassuolo.
Dror.rrrms (TRIGLA) m am m e B a s s.
Tav.‘IL Fig. 40. 41 .
'Un solo esemplare grande c onservat issima in tutto simi le all’at tua
le —Trigla m aw , fascia in terna convessa con lungo e largo solco a llar
»gato n ella coda e nell’ost ia. Faccia e sterna leggermente concava : pic
cola lobatura nel marg ine infer iore. Dim . m m
Monte Gibio.
54 RIVISTA ITALIANA
Or ou ruus (Domus) ar r . vmmau s K o k .
Tav. II. F ig . 39.
Sebbene moltò prossimo non credo si p ossa identificare col vicina
li: di K ok en per la forma subquad rata, espansa nel margine intero pe
ster iore : la forma caratter istica del solco e netta e ben v isibi le, uguale
all’attuale Gobias quadn
'
maculczlue. L'
area i nferiore è ornata da leggera cunellatura. La faccia interna è pianegg iante, piram idata. Dim . mo
d ie mm . 4
100 es. c irca Mon te Gibio 100 o. Fessetta 5 S. Palo 5
Rio Rocca 1 Terr . pl ieo. Mod . 80 Cà d i Bogg io 2 Mon te
Z ago 1 Quattro Castella Quelli d i Monte Gibio sono alquan to
maggiori .
C epol i d ae .
Dr omrus (Carona) ranaunnscans B a s e
Tav. II. F ig . 43.
Forma allungata leggermente b ioen vessi . Soloo d ifi'
erenziato da
strozzature med iana : la coda e l’ostio fanno tra loro un leggero ango
lo e s’allargano verso i marg in i . Piccolo rostro, faccia esterna liscia.
Dim . medie mm .
2 ea. Monte Gibio 2 Fosseth Sassuolo 1 Rio Rocca.
C e eun g i d ae .
Oromruus (Caaanemaauu ) .m aaw auue K o k .
Tav. II. F ig . 44.
1 888 K ok en l. o. Tav. XVII fig . 1 .
Forma ellittica Faccia interna convessa con solco d ifl'
erenziato in
breve e largo ostie e lunga stretta coda, r icurva for temente all’ estro.
m ità. Aree crenellate , faccia esterna leggermen te concava, con p iccole
costolature irregolar i. I v iventi da m e consultati hanno il rappor to tra
i d iam etr i magg ior i . Dim . mm . 6 3 1
40 es. Monte Dibie .
DI PALEONTOLOGIA 55
Dronrrnus (Caaauemanuu ) m r u rus B a s s .
Tav. II . Fig. 45 .
Forma più raccolta della preceden te. L’area inferiore supera d i
molto la super iore : la coda si incur va meno e più dolcemen te : la fac
cia in terna è p iù fortemen te convessa e l ’ esterna p iù con cava : i l con
torno è p iù regolare. Dim . da mm. 3 a 5 4
7 se. Mon te Gibio.
P ed i cu latae .
Dr or.rrsus (Lormus) um ous B a s s.
Tav. II. F ig. 46. 47 .
La piena corrispondenza coll’attuale Lop h i us budegassa non lascia
dubbio circa 1’assegnazione. Forma subell i ttica faccia in terna con bre
ve solco mal defin ito, in un rigonfiamen to centrale . Faccia esterna don
molte irregolari sporgenze cui corr ispondono numerosi e profond i lobi
nel marg ine in fer iore. Il marg ine super iore è liscio e spesso. Dimensione
mm . 9
1 es. Monte G ibio.
Oltre le forme descr itte ve n e sono alcune altr e di i n cer ta sed e: una
è sim ile all’um bona tus d i K ok en , un
’altra si d istingue da questa per
l’ andamento del solco non ob liquo, altre due sono nuove,ma credo eu
perfino decr iverle ora, non d isperando d i r iuscire a determ inarlo.
R iassumendo, questi otoli t i appartengono alle seguen t i 1 6 fam iglie
S i lurold i , Scomb msocid i , Gad id i , Moc rur id i,Op h id i id i , P leuron ecti
d i , Sciam id i , Troch in id i , B crac id i , Per cid i , Sp ar id i , Gobi id i , Tr igl id i ,
Cep olld i , C'arangid i e Ped icu lati .
I gener i son o i seguen t i : Ar 1'
us,H emi ramp hus , Phycis , M cr lucz
‘
us,
M acr urus , Hymenocep halus , Op hid i mn , F i er asfer , C i lhar us , P la tessa,
Solea, Corv in a, Sc iaena,Trach in us
,H ap losthetus , Den tcw ,
Labra:lf,
C'hrysop hr ù , Gobi us , Ccp ola, Pagellus , Per i : : led ion , Tr igla , Lop h ius .
Il numero totale del le forme e 64 delle qual i 40 sono nuove : d ie
ci di queste fur ono trovate anche da Schuber t nel terz iario aus tro
ungarico e perciò nom inate in comune .
Anno XII Fasc. Il-l ll.
RASSEGNA DELLEPUBBLICAZIONI ITALIANE
Anaao… (C.) Echinidi miocenici della Sardegna. Atti Soc. i t. Sc.
nat.,XLVI
, p . 1 2 e 1 fig. M ilano, 1 905.
Gli echinidi della parte mer idionale della Sardegna erano abba
stanza noti ; men noti sono quelli della par te settentr ionale.
Le specie descritte nella nota del dott . Airaghî sono le segnen
ti : Clypeaster crassz'
costalzw Ag.,(
‘
l. altz'
costatus Ag.,Cl. in tarma
dz'
us Des Moul.,('
l. lati rostr z'
a Ag.,Cl. sard in z
'
ensz'
s Cott.,Cl . ellip
ticus Mich.,Cl . Lom
'
satoi'
Cott,E cln
'
nolampas.hem isp haer z'
w s Lam .,
Heteroclypu s sem z'
globus Lam .,Sch im ster Sei llac Des Moul.
,Na
m iaster ovatus Siem . e B r issas oblongus Wr ight. Tutte forme m io
cen iehe e principalmente elvezianc, tra cui interessano il b l. attico
status ed i l Cl . ell ij i tz'
m s,spec ie già note della Sardegna, ma di cui
non si conosceva l’
or izzonte stratigrafico. V .
Amaom (C.) Brachiuri nuovi e puo: noti nel terziario veneto. Atti
Soc. i t. Sc. nat.,X LIV
, pp. 1 0 e 1 tav . M ilano,1 905.
Sono illustrate e ben issimo figurate tre spec ie d i brach iur i e
cioè Ranma Reuss i Woodw . spec ie mal nota e spesso confusa con
altre ; Ph lyctenodes dep ressus M . Edw . sinora mal figurato, e X an
thopsis Kressenbcrgensi s Mey . finota ignota in Italia. V .
DI PALEONTOLOGIA 73
II.
RASSEGNA DIPiBBLIG‘ZIONI ESTERE
Cm … (G.) Usher die Bellerophokalklauna. Z ur Frage der Perm
Triasgrenzen. N. Jahrb. M in . etc .,I,2, p . 52-60. Stutt
gart, 1 906.
L’
A. da sei anni si occupa del calcare a Belk rop hon del Ca
dore e della sua fauna. Ha potute così scoprire nuove e r icche lo
calila fessil ifere, e mettere insieme una stupenda collezione di mol
luschi e brach iepedi , di cui presentò un saggio nella scorsa riunione
estiva della Societa geolog ica italiana. Nella sua comun icaz ione egli
dà un elenco dei pr incipali gener i trovati , d i cui uno nuovo : Om
bon ia. Riprendendo in esame il livello stratigrafico dei calcar i a Bel
leronhon, egli giustamente conclude per la loro pertinenza al Per
m iano superiore e li sincronizza con gli strati a dell’
Ima
laia. Attendiamo con desider io impaz ien te la completa illustrazione
dell’interessantissima fauna. M . Genm m.
Carcass (F.) and How cm x (W.) A Monograph of the Foraminilera
of the Perme-Carboniierous Limestones oi New South Wales.JIem . Geol. Sur rey Nea: South Il
’
ales,Palaeon tologg , num . 1 4
,
pag. I-XVI,1 -22
,tav . I-IV. Svdnev. 1 905.
La collaboraz ione d i due illustraz ioni scientifiche come lo Chap
man e l’
Hew chin,ha prodotto questo eccellente lavoro sui Hizopo
d i reticolar i dei calcar i perme-carben iferi della Nuova Galles del Sud ,
cui il David, professore di Geologia all
’ Un iversità d i Sydney , prc
mette importanti notiz ie stratigrafiche (pag. IX -XVI), facendoci cene
scere che le forme descr itte dai suddetti trevansi principalmente in
due or izzon ti,separati tra loro dalla potenza di circa 1 2 1 6 m . di
strati : The Upper Horizon (Wellong Horizon) is in the Upper Ma
r ine Series,and the Low er Horizon (Pokolbin Horizon) is in the
Low er Marine Ser ies of the Perme-Carben ifereus System of N. S.
Wales (pag. XV).
DI PALEONTOLOGIA 75
Fau n a d eg l i s tra ti a C o ngc r ic e d e i te r re n i
sov ras tan ti , n e l le v ic in anze d ’ lm o la
Nera nm. DOTT. Denun ce Sp eroner.
Da ol t re m ezzo secolo,lo Scarabell i , in d iver s i pun ti dell
'Appen
n ino Romagnolo, av ve rtiva la presenza d i fossil i d i acqua salmastra, e
in una del le sue pr im e pubblicaz ion i su lla geolog ia locale , accenna al
r inven imen to d i tali fossi li,m et tendo i n r i lievo la loro importanza per
la de term inaz ione de i ter ren i da cui prov engono
In seguito, m olti an n i dopo , c i dava magg ior i ragguagli sopra
g li avanz i organ ici del la zon a salmas tra e terr en i ad iacen ti , e con la
scorta d i n uovi documen t i paieoutolog i 0 i , sv i luppava i suoi concetti sul
la stratigrafia d ei te rren i terz iar i recent i dell’Appenn ino romagnolo, e
spec ialm en te dell’Appen n ino imolese .
I fossi li caratter istici d ella zona salmastra trovat i dallo Scarabel
li,erano alcun e Congw i e p roven ien t i da sabb ie e arg ille prepl iocen iche ,
sovrastan ti ai gessi presso Rivola n el la vallata d el Sen io ; la M oian o
p s is B on ell i S is,che le Scarabe lli r iteneva p roven isse dag li strat i su
periore de i gess i , pure d i R ivola ; e (‘
onger ze e p iccol i Card i , scoper ti
alle falde del mon te d ella Galoppa in val le d e l Montone,infer iorm en te
alle arg i lle p liocen iche . In alcun i pun ti d i dette località. s i erano tre
vati,
sop ra i gess i , d e i fossili d i ti po d ecisamen te torton iane, quali
1’An c i llar ia g la n d t
'
fo rm i v Lk .,la C a rd i ta Jouan n eh
‘
Bust , ed altre form e
d i Casanova Calises i,non m olto lon tano da Sog liano.
Questi fatti raffermaron o lo Scarabelli in quella che era per lui
quasi un’idea fissa : che cioè nel terz iar ie nostro , s i fossero fatte troppe
Scaaas szu G. Su r la format ion m ioce'
ne, da versant N—E,de l
’
A
p en in de Bologna S in igaglia, Bnl. d. l . Sec. Géel. d. Frau.,Ser. 1 1 , t. VIII,
pag . 234.
Sem ana:e G. e Fenasn L. Sop ra alcun i foss il i raccolti nei colli fian
« bagg iant i i l fiume San terno n elle vic inanze d’
Imola . Bol. d. 800. Geol. It . ,
vel. XVI,fasc . 2 , pag. 201 , 1 897 .
76 RIVISTA ITALIANA
suddivision i,e che quindi , anzichè moltiplicare, convenisse d im inuire le
d ivision i. In base a queste idee, e appoggiandosi alle scoperte paleontolo
giche che aveva sottomano, egli r iun iva nel torton iano le arg ille marine
sotto i gessi , i gessi e le sovrastanti arg ille e marne e sabbie con fau
na salmastra : il tutto pogg iante sopra le sabbie e le melassa a Luci na
p omum,del m iecene med io.
Scopo della presente nota non è certamente quello d i fare oppos i
z ione alle idee dell’i llustre geologo imolese , la cui perdita lamen tammo
or non è m olto in questa R ivista, e al quale fino in ultimo ho r ivolto
la p iù r ispettosa ed am ichevole devoz ione . Le sue benem erenze verso
la geologia. romagnola sono troppo note e r iconosciute da. tutti, perchè
io abbia la. pretesa d i discuterle .
Dal suo pun to d i v ista non poteva pensare d iversamente, ed era
logico nella interpretaz ione dei fatt i . Egli partiva da cr iter i p revalente
men te stratigrafic i : elem en ti paleon tolog ici che con trad icessero ai suoi
concetti non ne aveva, an zi n e aveva che in parte ven ivano a raffer
marlo nelle sue idee . Ma è g iust ificato i l camb iamen to, e la d iversità
d’opin ione , quando s ia sopravvenuta la cer tezza, e per le meno i l forte
dubb io,che
,r iguardo alle anomalie paleontologiche r iscontrate
,si trat
‘
i
d i fenom en i locali d i in vers ion i d i strati , e quando siano accresciut i
quei docum en ti paleon tolog ici che valgono a d ist inguere le singole for
maz ioni geolog iche . E appun to a m e pare che la d iversità d’Opin ione
r iguardo ai terren i considerat i vada r isolvendosi in seguito alle ulter ior i
osservaz ion i ed alle nuove e p iù numerose scoperte* fossih fere . Quan to
alla presenza d i fossili tor ton iani scpra. i gessi , fu già. ammesso,da goo
log i com peten tissim i , la possib ili tà d i rovesciament i strat igrafici : e d i
fossil i ne abb iam o era abbastanza e abbastanza caratter ist ici, da per
m ettere ulter ior i d ist in zion i nelle diverse formaz ion i . Il desider io dun
que d i concorrere alla con clusione d i questi problem i di stratigrafia lo
cale, portando nuovi e valid i documen t i , m i spinse a r innovare e a inten
s ificare le r icerche e le raccolte, nei luoghi ove g ià. era passato le
Scarabelli . E sarò page a sufficienza,se l
’enumeraz ion e dei fossili che
p iù sotto presen to, con tr ibuirà a dimostrare che sono g iust ificate anche
per l’Appen n ino romagnolo, quelle sudd iv ision i proposte de i geolog i
per i l terziar io super iore d elle alt re part i d’Italia. Io r itengo per
forme che le local ità fossi lifere p iù ricche, present ino caratteri fau
n istici abbastan za t ip ici e d istin t i , da leg itt imare tali d iv ision i .
Sp iegato. la rag ione d i essere di questa breve nota, vengo ad esper
re i r isultati delle m ie r icerche.
DI PALEONTOLOGIA
R imettendo ad altro tem po lo stud io dei terren i che sollevarono
le più fort i d iscussion i , ho lim itato per ora l’indag ine ai luogh i, che lo
Scarabelli pr ima poi i l Prof. Toldo ind icarono come magg ior
mente foss iliferi . R isultato d i questa indag ine è stata la scoper ta d i
un notevole numero d i form e d i zona salmastra, e ne i pun t i g ià cono
scint i e in reg ion i vic ine. Queste località fossi lifere s i trovano, com e ho
già accennato, lungo la catena de i Gess i , fra le vallate del San terno,
del Sen io e del Lemons . Non m i ferm erà a parlare della formaz ione
gessoso-solfifera del l
’Appen n ino romagnolo in generale , de i suoi rapporti
strat igrafici , de lle var ietà litolog iche che p resen ta, dopo quan to hanno
scr itto in proposi to e per esteso,i l Capellin i , lo Scarabelli , i l Sacco, e
per ultimo Il prof. Toldo . Per semplice sch iar im ento topografico, noto
che le locali tà dei C r ivellari presso R ivola, uno dei pun ti estrem i da
me esplorato, situato sul la destra de l torrente Sen io, e ove e massimo
1’affioramen to foss ilifero, trovas i al cen tro d i quella gran lente se len i
tosa, che, dalla vallata del Sillaro, va a. que lla del Mon tone. Appena
passato i l torrente Sen io, contro R ivola,andando verso le case ch iama
te C r ivellar i , si in con trano gli strat i superior i dei gessi , che sono qua
e là. coperti da una marna arg i llosa cen er ina. Questa marne, per quanto
non con tenga fossi li , io r itengo debba r i ferirs i al pliocene . Il gesso e
cr istallino e nei pun ti più espost i e scopert i presen ta deg li in teressan t i
fenomeni d i erosione superficiale : l’
in clinaz ione m ed ia è d i c irca
N. e la d i rezione prevalen te NÉ—SW . E
’su quest i banchi gessosi , e spe
cialmen te verso la cresta della collina,ch e si trovano sparsi dei blocchi ,
o m eglio croste,d i selce p iromaca, in cui lo Scarabelli . cosi afferma i l
Toldo n el lavoro ci tato trovò le pr im e M ela 1 1 0p s is B on elli i Siam .
Per ver ità i o non ho trovato nella selce questo foss ile , v i ho t ro
vato invece, e comune , un gasteropode , che r ifer isco gener icamente a
una H ydrobia.
Scam … G. Op . cit.
Tonno G. Strati a Conger ic nelle vic inanze d’
Im ola,Bol . (1 . Soc
6 601. It., vol . X VII, fasc. pag. 200, 1898
Idem . Note p relim inar i sulle cond iz ion i geolog iche de i Con trafi’
or ti A
parm in z'
ci , compresi fra i l Si llaro ed i l Lamm a. Imola, Tip. Coop. Paolo Ga
leati , 1 904.
(3) Tonno. Op . cit. Veramente lo Scarabelli nella sua prima memoria in
Bol. Soc. Geol. Franc. Vol. I, VIII, 1 85 1 , dice che si trovarono nella selce : Palu
dim s,O'
yclostonus .
RIVISTA ITALIANA
Proseguen do verso i Crivel lari , si trova un piccolo burrone, in cui
gli strati , m essi a nudo per ven ti o tren ta metr i, si p resentano in se
z ion i verticali o quasi , tali da permettere uno stud io m inuto e accurato.
In fondo al burrone si trova una roccia m icro-cr istallina, la cui po
tenza non è poss ib ile determ inare, tenera, g iallo m iele,in cui è facile
r iconoscere una var ietà d i gesso. Su questa roccia posa, perfettamente
concordante , uno strato dello spessore d i qualche metro, d i un’argi lla
verdas tra fina, q uasi untuosa al tatto
,contenente con crez ion i calcaree
p isol itiche , e in tutt i i luogh i da m e esplorat i, pr iva d i traccie organ i
che. Solo in un punto , i n alto,dove vi e i l passagg io ad un terreno
d i natura d iversa, ho trovato num eros i frammen ti d i bivalvi indeter
m inab i li . Ma poiché si trova appun to al con tatto d i due ter ren i , alme
no d iversi d’aspetto, n on si può affermare che appartengano, o si deb
bano ascr ivere,al l
’una p iuttosto c he all
’
altra formazion e. Questa arg i l
la verdastra. oltrechè ai C r ivel lari , l’ ho t rovata in altri punti della re
g ione studiata, e sem pre aven te g li stessi rappor ti coi ter ren i che le
s tanno sopra e coi sottostan t i : in m odo ri levante la ved iamo fra
il San terno e i l Sen io, poco lon tano dalle Banzole, pure al contatto
coi ban ch i gessosi . Questa. arg i lla verdastra, in alto,fa passaggio insen
sib i lm en te ad una marna d iscretamen te sabb iosa, scura.,spesso add i
r i t tura nerastra, abbastanza d ura e com patta, r icch issima d i fossi li : in
questa mam a,che ai C r i vellar i ha circa un metro d i poten za, si rac
colgono in gran copia le form e caratter istiche delle zone salmastre. Le
Conger ie e i Card ium ,sono i generi p iù comun i : le pr im e in ot t imo
stato d l conservaz ion e : i second i m eno,spesso anzi ridott i a cumuli d
detr iti indeterm inab ili . Le M elanop s is pure sono abbas tanza comun i,non
m olto le M elan ie : le Ner i tin e relativamente rare,r ispetto ag l i altr i fos
sili ci tati .
Non ho b isogno d i ins istere e far r ilevare,come sieno queste le for
me t ipiche che d is t inguono i p iù classici g iac imen ti i tal ian i Non in
tutt i i punti ove appare , la marma scura offre eguale r icchezza d i ” fos
si li : an z i all'i n fuori del g iac im en to dei C r ivellari , s i può considerare
r elativamente povera. Però in tutte le locali tà si p resen ta con g li stes
si caratter i stratigrafic i e litolog ici e con qualche form a ben e caratter i :
st ica. E ’strati ficata in modo ev iden te
,e concorda coi gessi , coi quali si
PANTANELLI P. Mon ografia degli strati pon tici del m iocene super iore
nell’
Ital ia Settentr ion ale e centrale nelle Memorie de lla R. Acc . d i Sc . Let. e
Ar. di Modena. Tom . IV,Ser. II.
80 RIVISTA ITALIANA
a qualche centinaio d i metr i , e apparen temen te sopra i terren i ora r i
cordati , appaiono le argi lle p lim en iche tipiche, coi noti e soliti foss ili
che le d ist inguono. Questa intera ser ie d i terr en i,o almeno qualche
m embro,r iscon tr iamo sempre nel le d iverse località c itate
,fra i l Sen io
ed i l Santerno.
Senza alcun dubb io g li ultim i tre terr en i d i cui ho sopra parlato,
c ioè la marne b iancastra,la molassa sabb iosa
,e le arg i lle , apparten
gono al la stessa formaz ion e pliocenica. La molassa non può cer to esse
re scamb iata, per quan to l itolog icam en ta non d iversifich i molto, con la
m olassa dell’astiano propr iam en te detto, molassa che è molto p iù
a Nord de i terren i in esam e : t utt’
al p iù , r iferendoci a quanto ho ripetuto
p iù volte,s i potrebbero r i scontrare fra le due formaz ion i delle analog ie
batinxe triche. Qui nd i si debbono r itenere sem plic i var ietà li to log iche lo
cali , l im i tate a qualche t rat to de l terr i tor io im olese .
C iò posto, n e lla nota de i foss ili che presen to s i potrebbero r iun ire
n ello stesso elenco i foss ili de i tre or izzon t i geolog ic i : ma poichè l i ho
trovati d ist in ti , e li ho tenut i d ist in ti n ella raccolta, cosi credo oppor
tuno trascr iv er l i in elench i separat i . C iò è p i ù r i sponden te allo stato i n
cui si trovano in natura : e la massima scrupolos ità nelle ind icazion i
dei rinven imenti non è mai superflua.
Fossn .r DELLE MABNE sonnu SOVRAS'
I‘ANT I AI (ness i .
l ). D reissencz s imp lex E’i l fossi le pra com une negli
strati d i R ivola : m eno com une neg l i alt ri g iacim en ti d e ll’
im olese .
E’una forma molto var iab i le : dalla D. s imp lex
: t ipi ca,‘
s i passa
qua—i i i nsensibi lmen te alle forme co +tate e allungate sul t i po del le D .
clavaefw m is (K rause) .
D . als asua d ub ia (May er ) . C or r isponde pe rfet tamente al la
descr iz ione e figure date dal Fon tan nes P iù al la v . ler r eolen s is
Fontann es , che alla d ub ia t ip ica. V i r fer isco anche p iccole form e che ,
salvo per le d im ension i , corr ispondono esattamen te pe r tutti g li altri
caratte ri.
Questo spec ie si avvic ina alla D. clavacform is (K raus che nei
g iacim en ti i talian i accompagna la s imp le.r z pure ho prefe r i to, p er la
FONTANNES. Les m ollusq p lioci w es de la Val lée du Rhòn e et du
Roussillon . Tome second Paris, Savv Librairo, 1879—82. pag. 1 40, Pl .
VIII.,fig. 1 1 , 1 2, 1 7 .
82 RIVISTA ITALIANA
Adaclma ca r inata (Dosh ) . La carena è assai svi luppata. E’
comun issima in tutti i deposit i a Conger ie.
Adachna p rotraete (Bich ). Vi r ifer isco un gran numero d i
esemplari trovati n el giacimento d i Rivola. Ma per i l catti vo stato d i
conservaz ion e, ho dei dubb i sulla g iustezza del r ifer imen to spec ifico.
Àdachna B allen enae Non raro a Rivola.
Adachna sp . Alcun i esem plar i , forse d i spec ie d iverse, non
r i fer ib i li alle preceden ti. L’ass ieme dei caratter i indurrebbe ad avvici
narla al gruppo del l’A. cz r i na ta (Doch )
l l ). Ner i todon ta m utin ens is. (D’Ana ). E ’
un fossile comune,
specialmen te nel g iacim en to de i C r ivellari presso R ivola. Generalmente
ha d imension i m olto r idot te . Non i n tutte sono conservate le caratteri
stiche e d elegan ti ornamentaz ion i che adornano le spire. La troviamo
tan to n e i depos i ti sulla d estra, quan to in q uelli sulla sinistra del ter
ren te Sen io .
I l ) S tr iatella tubercn lzta Vi è la t ipica. e altra a tuber
coli assai ri dotti. Non com une .
Lg rcaea n arzol in z E’com un issima. Vi sono d iverse
forme : la t ipica d el Bone lli fig urata dal Sacco che ne r iporta l ’ ind i
retta d iagn os i del D’Arch iac e varietà. comparabi li al la v. agaten
s is del Pantanelli (2) Con queste, trov iamo p rom iscuamen te p iccole M e
lan0p is , in cui il r i lievo al m arg ine inferiore dell’anfratto
, è mancan te
o è mol to r idotto : form e che sono rappresen tat
e dalla na rzol i na v . eca
r inata Si trova pure la var ie tà. d i n otevoli d imens ioni parago
nabi li alla e . Dod er lein i del Pantanel li
Fossu.r DELLE M ARNE nm x casr ar: m nvm r s
se r na e u sraar r A Cer e sara.
I) . Nodosar ia comm un is d’Orb
Nodosar ia r ap lw n z'
s trum d’
Orb.
L i ngul i na cos tata d’Orb .
C r istellar ia aculeata d’Orb.
C'r istellar ia cu ltr ate (Montf.)
Su mo F. Mollusch i terz iar i del Piemonte è della Liguria .
X VIII. pag. 1 2,fig. 20, 20 bis.
l'
ax u sm.u D. Malan . foss . e via. d’
l lal. p. 78.
Idem . Op . c it., pag. 78
,fig. 5 e 7 .
DI PALEONTOLOGIA 83
Questi sono i foram in i feri p iù comun i e che si avverton o per le loro
notevol i d imen sion i. Troviamo poi le accumulaz ion i d i foram in iferi d i
cui ho parlato prim a,fra cui p redom inano la B iloca lin d bullo ides d
'Orb .,
la G lobiger in a bulloides d’ Orb .,
l’0 rbulina un i verse d
’Orb.
,Nodosar ia
baci llum Defran . Interessan te i l r i levare le notevoli analog ie che esi
stono fra questa fauna a r izopodi , e quella corr ispondente delle argi lle
pliocen iche d i Sivizzano nel Parm ense, pure sovrapposte a fauna sal
mastro.
Trechocyathus sp . ind . Un solo esemplare , e non ben oon
servato.
F labellum avicula M icht. Gli esemplar i dell’imolese, sono a
calice molto espanso : quindi si possono rifer ire o alla forma tipo di
M ichelotti,o alla v royss iana M il. Ed . et H . i llustrati dal Simonel
l i Non è raro nel giacim en to presso Rivola.
F labellum cf r . ex tensum M chn . Raro.
IO) . L imea str ig i lata Comun e.
Pecten op ercu la r is L . Ne ho trovato un solo esemplare, e
assai corrose : perciò dubb ia è la d eterm inazione.
Nucula salcata Bre en . S i trova assiem e alla tip ica, la v.
tr iangu lar is Sacco, che, oltre la forma generale un po
’d iversa, ha pure
un’ornam en taz ione p i ù marcata. E
’comune.
Den talium gad us Mon t Raro.
Den ta lium sex angulam Sehr. Raro.
Den ta lium vulgar e (Da Costa). Vi r iferisco un solo esem
plare : e d ir itto, e le coste lung itud inali per numero e d imension i, cor
r ispondono ag li esem plar i i llustrat i dal Secco
Diacr ia tr isp inose . (Les ). l’
unico pteropode t rovato
nella marea biancas tra. Tutti gli altr i si rinvengono n elle sovrastanti
argi lle turchino tipiche del pliccene. Sono diverse im pronte abbastan za
ben conservate.
Fossrm nanne sr aar o sass ros o se r n a LE n anna BIANCASTE .
l ) . Pycnodon ta cochlear (Poli). E’
d i forma ne v icn lar is, e col
guscio piuttosto g raci le. Abbastanza comune.
Smoxm .m V. Sop ra due nuovi pteropodi delle argil le d i Sivizzano nel
Parmense in Bol. d . Soc . Geol. Ital. vol . XV ( 1896 ) fasc. 2 .
Idem. Antozoi neogen ici del Museo parmense in Palaeon tograp hia Ita.
lica . Vol. 1 1 . pag 187- 188 , tav. XXIII, fig . 2, 3.
C) Suno F. Op . cit: part. XXII, pag. 98-101 , tav. VIII,143.
84 RIVISTA ITALIANA
Fossru DELLE ARGILLE r nrocam cn n T IPICHE
sovaasr as r r ALLE manna uranoasr an.
I ) . F ron d icula r ia alata d’Orb.
F rond icu lar ia a-zn ula r is d
’ Orb .
Alectryon ia tau rop z r va Sacco. Si trova un po’d istan te dalla
zona salmastra,alla somm i tà della collina a nord del burrone con fauna
Conger ie.
L imea s tr ig i lata Le costic ine trasversali sono pm ao
cen tuate d i quelle che adornano gli esemplar i figurati del Sacco, (ap .
c i t. par t. 25, fig . 2 1 , tav . 6,fig . 4 v i sono pure v isib ilissim i cor
don c in i, nel sen so del l’
accrescim ento delle valve .
Pseudoarn uss i um oblongum (Ph i l) Pleuronectia com i tatus
Fon t . Corr isponde assai p iù alla figura ch e n e dà. i l Sacco,
che a
quella data dal F on tan nes. (Sacco, ep . c it, par t . 24, pag . 52
,tav . X IV
,
fig . 40-45 Fontannes , up . c i t., pag . 250,Pl X III
,fig .
E’
assai comune . C om e osser va i l Fon tannes , q uesta specie e ca
ratter ist ica d el la base de l pl iocen e. (Z ancleano d i Seguenza) : egli purene ha raccolto n e l classico val lon e della M o r ra alla base delle marne
g rig ie , d irettamen t e sovrapposte ag li strat i a Conger ie. G li esemplar i
g iovan i li , hanno la forma p iù allungata, ( il che è stato osservato pure
dal Sacco) .
Tel l ina ell ip tica (Br Gli esem p lar i che poss iedo sono po
ch i e sc iupat i : q uind i la d eterm inaz ione è dubb ia
Corbula g ibba L’ho trovata alla somm ità . della for
maz ion e stud iata. Alcune possono iden t ificars i con la forma tipo del
1’Ol ivi
,d escr it ta e figurata dai autor i : altre
, p iù allungate e quasi
l isc io, potrebbero r iferirsi alla v . p seudolaev is Sacco. (Sacco, ap . c i t ,
part . X X IX, pag . 36
,tav. IX ,
fig . 1 0, I l ) .
Teredo n orveg ica Speng l . Numerose im pron te : in molti
camp ion i si con serva i l gusc io calcareo.
Valvo la sp . Un solo esem plare e mal conservato . Per l ’ or
nam en taz ione,e caratter i generali p i trebbero forse r ifer i rsi al n . Tour
noaer i Cap . : ma non arrisch io una determ inaz ione specifica, trattandosi
d i un solo esemplare in così catti ve cond iz ion i .
10) Ap or rhais p esp elecan i (L.)I l ) . Sveltia var icosa (Br.) Assai più a Nord delle marne a C'en
g er i*
,in p iena formaz ion e p l iocen ica tipica.
I? ) Sv :: ltia t r ibulus . Ass iem e al preceden te.
DI PALEONTOLOGIA 85
Hyalaea ggp sor um Bell . Il Sacco nel suo Catalogo p a
leon tologi co del baci no terz iar io del Piemon te. Roma, 1 889. r iporta
questa specie come propr ia del solo messin iano. Nel l’imolese, posso as
sicurare che passa nel pliccene : è anz i una forma relati vamente comu
ne nel le argil le cenerine o turchina pliocen iche , che stan sopra gl i strat i
a Conger ie. Si raccoglie tanto sulla sin istra, che sulla destra del Sen io
e del Santerno, scpra i gessi . Ne ho degli esemplar i assieme al Pseu
doamuss ium oblongum (Phil ) e al la Diacr ia tr isp inosa Les . Con que
st’ultima si trova in n id i
,in grande quanti i tà.
D iacr ia tr i sp i nosa Les. E’comun e quanto la precedente, colla
quale, come si è detto sopra, si trova spesso un i ta in grand i accumula
z ioni .
B alan tium sp .
Vag in ella sp. Con gli pteropod i nom inat i, si trova pure una
Hyoloa, prossima alla ggp sorum , ma che ha abbastanza caratteri d ifi'
e
renz iali, per essere tenuta da essa d istin ta. La parte ventrale e perfetta
mente liscia, assai g lobosa, e mancano 0 sono r idottissime, le punte delle
estrem ità posteriore.Per l’aspetto generale, convessi tà, r ipiegamento verso
l’
apertura boccale, si accosta alla r evoluta B ell.,da cui però diversifica
per molti altr i caratter i. M i propongo di dare una descrizione p iù com
p leta quando io venga in possesso d i esemp lar i meglio conservati . Sono
del resto convinto che con nuove r icerche,si potrà arr ichire la paleon
telog ia locale, con forme di pteropod i tecosomi , non ancora descritte .
Questo lo deduco degl i innumeri e d iversi frammenti che ivi si trovano, che se sono indecifrab ili
,sono tuttavia un ind izio sicuro della
r icchezza, in quei g iacimen t i , d i molluschi spettanti a questo gruppo.
Gabinetto Geologico della R. Un iversità di Parma. Marzo 1 906 .
86 RIVISTA ITALIANA
D i a lcu n e Le p id o c ic lin e eo cen ic h e
d e l la S ic i l ia
Non nm. Dor r. G. Canossa RISPOLI
(Con tavola III )
Soupo della presente Nota paleontolog ica è la i llustrazione d i alcuneform e di Lepidocicline eocen iche della Sic ilia, già da noi in parte pre
ventivamen te annunziato in altri lavori an ter iori . Pensando che la loro
pubblicazione potrebbe essere utile allo sviluppo dello studio delle Or
bitoidi , che ha r ich iamato in questi ultim i tem pi l'at tenzione d i molti
stud iosi, m’afi
‘
retto ad illustrarle lim itando per ora lo stud io alla for
me da me rinvenuto in una sola locali tà.
Le Lepidocicline che formano l’oggetto d i questo lavoro proven
gono dalla locali tà Rocca ed Impalastro nei d intorni di Term ini —Imerese,
in provincia di Palermo, e m i furono comun icate in istudio dal prof.
Saver io C iofalo.
Troppo lungo sarebbe i l voler riportare qui la ser ie dei lavori che
r iguardano i deposit i eocen ic i di quel la regione , i quali fanno parte della
grande formaz ione delle arg ille scagliose, tan to estese in Sicilia, e da noi
e da tanti altri prima, già r ifer i ta all’Eocene superiore ma per i l
nostro scopo basterà piuttosto r iportare la lunga lista dei fossili , che
accompagnano le Lepidocicl ine e che r iuscimmo a determ inare sia sul
mater iale esistente nel M useo d i Geolog ia della Un iversità di Palermo,che su quello gentilmen te offertam i in varie volte dal sunnom inato prof.
S. C iofalo e che fa pure parte delle collezion i dello stesso M useo.
Cunocnu Rlsrou G. I Foram in ifer i eocen ic i del Gruppo del Monte
Iudica e dei d intor n i d i 0atem nnova in Provinc ia di Catan ia. (Boll. Soc. Geol.
Ital., Vol. XX III. fase. 1 904.
88 RIVISTA ITALIANA
Lep idocgclina Ciofaloi n . sp. (A) .
p lan u lata n . sp . (A).
h im er en s is n . sp . (B) .
Queste lep idocicline r iguardo alla in terna struttura non mostrano
nessuna sign ifican te d ifferen za r ispetto a quello dell’Oligocene e del
M iocene con cui l’abb iamo paragonate . Abb iamo r iscontrato fra d i esse
forme m icrosferiche e form e macrosfer iche : l’appare
c ch io embr ionale
macrosfer ico nelle form e sez ionate r isulta o di una sola concam eraz ioao
rotonda (monoloculare) com e in Lep idocy cl in a C iofa loi , o d i due leggio
p resso a poco circolar i,tangen ti in ter iorm en te (bi loculare), come in L.
p lan alo ta .
La forma poi delle logg ie equator iali è quella og ivale o d i un esa
gono regolare : la forma d i esse però var ia da. un ind ivid uo all’al tro
ed anche n ello stesso indiv iduo, com e in L . h im er en sis , dove si osser
va il graduale passaggio dalla concam erazion i esagonali (cen trali e m ed iane) a quelle og ivali (per ifer iche) .
In rapporto al la ornamen taz ione d ella superficie della conch iglia e
alle spessore d i essa sta la presen za ed assen za dei pi lastri : inquan to.
che in quelle forme. a superficie l iscia e quasi piatta (L. p lan ulata) si ver ifica assenza d i p ilastr i ; in ind.v idui p iù spessi e a superfic ie ornata
da numerosi e p iccoli tubercoli (L. C iofa loi) si osservano sottili e n n
merosi p i lastr i ed infin e in i nd ividui m olto spessi e a superficie ornata
da grossi tubercoli (L. H imerens is) ci sono internamen te pochi e g ross i
p ilastr i .
La constataz ione della presenza di lepidocicline nell’Eocene che io
feci da parecch io tempo, m i rese guardingo nell’accettare comp letam en te
i cri ter ii della nuova class ificaz ione delle Orbitoidi propost i dai S igg .
Donvi llé e Man ier-Chalmas,nè starò qui a r ipetere quan to d issi in al o
tr i m iei lavori a proposito d i d etto ord inam ento s istematico solo a
me sembra che si sia voluto correre oltre ne l generalizzare osservazion i
troppo lim itate e d ipendenti da un solo ord ine d i fatti . Lim i tandom i
ora alle sole Lep idocicline, credo d i poter fare le seguen ti conclusion i
dalle osservazion i da me comp iute
Cnnoom -Rxsrom G. I fw am in ifer i eocen ic i del grupp o del M . Iud ica
e dei d intorn i di Oatenanuova in p rovinc ia d i Catan ia , pag. 54,1 904. Os
servaz ion i sulle Orbitoid i,1 905.
DI PALEONTOLOGIA 89
1 . Che le Le p i docicline non succedettero alle Ortofragm ine,
ma convi ssero con esse non solo nell’Oligocene , ma anche nell
’Ea
cone
2 . Che le Lepidoc icl in e n on sono solo localizzato in istrati poste
r ior i alle faun e veramente n ummuli tiche , ma con vissero con esse
8. Che i l term ine inferiore della d istr i buz ione vert icale della
Lepidoc icl ine non è l ’ Aqui tan iano , com e è asseri to n ella m emor ia de i
S igg . Douvillé e Lemoine
Per ora s i può i nd icare com e te rm in e in fer iore per lo m eno i l Bar
toniano (ascende l’an tica d iv is ione d ell
’
Eocene) . Rig uardo al lim i te su
per iore sin da ora poss iamo con ce rtezza assicurare, in v ia preven tiva,
che le Lep idoc icline non s i est insero n el M i ocene i nfer iore , ma che r i
sali rono alm eno s ino n e lla par te p iù alta de l M iocen e med io, ove con
v issero con le m iog ipsi ne , secondo d im os zre remo i n una Nota in v ia d i
pubblicaz ione , g ià presen tata alla r iun ione in vernale de lla nostra Società
Geolog ica.
L e p i d ocy c l i n e. C i o fa l o i (A) Checchia.
(Tav. III,fig . 4
1 905 Lep idocyclina C iofaloi Checch ia R ispoli Osservaz ion i su lle Or
bi toid i (R iv ista Italiana d i Paleon tolog ia
an no X I,fasc. II) pag . 80.
Anche il prof. A. Silvestri ha riscontrato la coesistenza di Lepidocicline e
di Ortofragrn ine in rocco riputate eocen iche.
Furono puro segnalate le Lepidoc icline nell’
Eocene dalla Signorina 0 . Gen
t ile nel 1 901 , la quale in un suo lavoro i ndica varie local ità eocen iche dell’ Um
br ia ove ne constatò la presenza. Essa rinvenne la L. m arg inale M icht. con le
Nmnmul it is Mel i i Tell . in un calcare compatto, grigio scuro con brecce silieoe
ed oficlitiche fra C ibottola e Vergnano a destra deila valle del Nestore,e le 0 .
Gambel i i Seg. e O. dilatata Micht. con N . Guettard i d’
Arch.,O. stellata d
’Arch
ed 0 . nummul itica Giimbel in un calcare marnoso a Civ itella del Conte davant‘
Poggio Aquilone, calcare che la Signor ina Gentile attribuisce al Bartòn iano. (Ved i
Con tr ibuz ione allo stud io dell'
Ec cone dell Um br ia,Boll. Nat., anno X XI
,n . 9 ,
S iena Vedasi a prososite d i questi r inven imenti i l recente lavoro del Prof.
A. Silvestri o Sulla Orbitoides Gi imbeli i & g. dove in nota si accenna ad
altr i rinven imenti di Lepidocicline ne ll’
Eccone superiore , fatti da molto tempo da.
professor i Ile— Stefan i e De Agelis.
Lameme P. et. Douvm .a R. Sur le gen re Lep idecgclino Gi imbel.
Mem. de la Soc. Géol. de France. Paleontologia, tom . XII, fasc.) 1 904.
RIVISTA ITALIANA
1 905 Lep idoeyclina C iofaloi Checch ia Rispoli Sop ra alcun e Alveoli
n e eocen i che della S ici lia (Palaecntogra
ph ia Italica, vol. X I) pag . 1 48 .
DIMENSIONI
Non conosco d i questa specie che la forma m icrosfer ica (A) .Orbitcide d i piccole d imension i, debolm ente gonfia, con un largo
mammellone poco sporgente nella parte centrale ; dal marg ine assetti
gliato. L’intera superficie della conchiglia e coperta da. una fittissima
g ranulazione d i p iccoli tubercoli , alquan to p iù p iccoli verso la perifer ia.
L’apparecchio embr ionale r isulta d i una sola logg ia circolare, non
molto grande , e a parete non molto spessa.
Le concamerazion i equator iali sono embricate, verso l’ interno a
forma di losanga 9. lati incurvati , verso i gi ri m ed ian i la parte supe
riore del le concameraz ion i è og ivale e più o meno tondeggian te. Il per
corso della lam ina spi rale e in questa specie molto regolare e molto
chiaramente si scorgono nello spessore d i essa i sottilissim i canalicoli
che l’attraversano. Le concamerazion i sono di piccole d imension i , però
man mano che s’avvicinano alla per ifer ia e
’ingrand isconc e l
’andamen
to della lam ina è alquan to m eno regolare .
Pi lastri numerosi e poco sviluppati .
L e p i d ocy c l in a. p lan u la te (A) Checch ia.
(Tav. III, fig. 6 7
DIMENSIONI
Lepidocicline d i p iccol i d imens ion i , quasi piatta, sottil issima, dal
margine tagl ien te, e dalla superficie quasi l iscia .
L ’apparecch io embrionale m egasfer ico è grande : esso si com pone
di due leggio tangenti in ter iormen te. La esterna è d i forma subqua
96 RIVISTA ITALIANA
mon t i d i Sutr io pur espr im endo la convinzione che gl i or izzon ti
fessi lifer i del Com elico si ripetano an che da noi con gli stessi caratter i
faun ist ici . La fortuna arr ise pr ima ai geolog i austr iaci ; e lo S t ae h e,
che già aveva i llustrato nel 1 877 e 78 i fossi li del calcare a B etlem
p h0n del Tren tino, del Cadore e del Comelico annun ciò nel 1 888 la
scoperta d i Sp i r ifer voltar St .,S . m egalotis St. e Sp ir igei a Jan icep s St .
nello Sehw efelgraben presso Lassn i tz , a est d i Pon tebba Dopo tale
r inven imen to, doveva r iten ers i sem pre pm probab i le l ’ esisten za an che
nella Carn ia d i fossi li d i questo ori zzon te. Vollero farne accurata r icer
ca i professor i B r u g n a t e l l i ,T a r a m e l l i e T o m m a s i n elle
for tunate escursion i com p iute n el 1 895 ; e non fu opera vana. I l T a r a
m e l l i (4) n e accenn ò 1’au tunno stesso e i l T o m m a s i n e espose
d iffusam en te l’i nverno successnvo 1 r isultat i br i llan t i : quind ici form e
d eterm inate e parecch ie nuove , scoper te in ben c inque località. nei cal
car i pogg ian ti sul la dolom ia cariata . Ul timam en te ebbero pure buon
s i to le esploraz ion i che i n trapresi io stesso col m edes im o scopo, com e
in parte accen nai d i sfugg i ta in altr i lavor i
La m em or ia descr ittiva p rom essa dal T o m m a s i nel 1 896 n on è
pur troppo uscita Quest ’ an no,m en tr e m i accinge vo a stud iare i l m io
mater iale,i l ch iaro Professore eb be la bon tà e la gen ti lezza squis ita d i
cederm i tutt i i nume ros i foss i li da lu i raccolti d iec i ann i or sono nelle
vallate carn iche . All’eg reg io paleon tolog o d esidero d i esp rim ere qu i
n uovam ente la m ia g rat i tud in e per la sua cor tese e am ichevole l ibera
Sp iegaz ione, pag. 58.
Bei trage zur Fauna des Beller0phonkalkes Sudti rols . Jb . k . k . geo] . B.
Anst.. XXVII, pag. 27 1 -3 18 , e XXVIII, pag. 93- 1 68
,con 7 tav.
(3) Nachw eis des sz'
i 1 ltir ol ischen Bellerophon kalk-Hor izon tcs in K ii rn ten . Vr rh .
k . k . geo] . li .-An st ., pag. 320. Il Fascn (Kam . Alpen , pag. 342 ) aggiunse una
forma d i Stachella,e trasportò la Sp i r igera nue ] genere Athyr is ; al mede simo gc
nere ascrisse pure lo Sp i r ifer m egalotis , da lui figurate nella Lethaea palaeozoica
(vol. II, 3, 1 901 , tav. 67 , fig .
Osservaz ion i su l Palenm ico delle Alp i Carn iche. Boll. S. Geol. It., XIV,
pag. 280 Osservaz ion i stratigrafiche su i ter ren i p aleozoic i n el versan te i taliano
delle Alp i Carn iche. Read . Acc. Lincei , ser . 2,IV
,2°sem .. pag. 1 9 1 - 1 92.
(5) Sul recente r inven im ento d i foss il i ne l calcare a Bellerop hon della Car
n ia . Read. Acc. Lincei , ser . 5,V,1°sem.
, pag. 2 1 6—22 1 .
P. Vmassa oa Raouv e M. Gouras r Osservaz ion i geolog iche su i d in
torn i d i Paularo. Boll. S. Geol . lt XX IV,1 903
, pag. 8 ; i l . Gonu x 1 . Iti n e
rar i p er escurs ion i geologiche n ell'
alta Oarn in,ibid.
, pag. 1 10.
R IVISTA ITALIANA
Grande valva a con torno sem icircolare, molto rigonfia, con apice
gran de , acuto, un po’r icurvo, molto prom in ente ; area alta
,tr iangolare,
ben c ircoscr it ta, in apparenza lisc ia, con delt id ie tr iangolare isoscele
due volte p iù largo che alto ; marg ine super iore d ir itto ; angoli laterali
super iori leggermen te ot tus i ; comm essura sinuate dentata ai lati e alla
fron te . Seno r istret to, p rofondo, lim i tato da due fort i p ieghe longitud inal i alt re tre p ieghe , d i cui l
’ult ima b iforeata, corrugano ciascun lato
della valva . Le p ieghe hanno sez ione triangolare acuta e andamento ar
cuato, concavo all’esterno , un po
’
si m ese. La valva ha mm . d i al
tezza, 1 3 d i larghezza,’
1 9 d i lunghezza m isurata lungo la linea media
na es ter na, d i spessore .
Calcar i b i tum inosi compatt i della Forca Salinch iet .
4. Smarr sam a Taaan m.r.u n . t'
. (Tav. IV,fig . 2 a oo).
Valva ventrale molto r igonfia, con ap ice grande , acuto, appena ri
curvo, p rom inen te e molto sp in to in avan t i . Con tor no subcircolare, tron
cato dal m arg in e super iore d ir i tto e m eno lungo della larghezza massi
ma d el la conch ig lia, che è ver so la m età. de ll’ altezza. Area n ettamente
lim itata,tre volte p i u larga che alta, tr iangolare , lisc ia
, con delt id ie
tr iangolare is .;seele a base d i m e tà i n feriore all’alt ezza. Guscio sotti le
con supe rfic ie lisc ia. La comm ess ura,d iri t ta ai lat i
, sembra m olto leg
germ en i e sinuosa alla fron te . I l r ife r imento gener ico e confermato delle
naz ion i che ho ten tato in un esem plare e che m i hanno d imostrato l’o
si stenza d i un setto med iano m olto e levato e delle p lacche dentar ie.
L ’altezza della valva e d i mm . la larghezza d i 1 4, la lunghezza
m isurata lungo la curva è d i 1 7,lo spessore d i
Non è lon tana, per la forma esterna, dallo Sp i r ifer p lano-c0nvex u3
Shumard La specie amer icana è però molto p iù p iccola, m eno allar
gata, con l’
apice p iù ottuso e 1’
area d i forma alquanto d i versa.
Calcar i oscur i e com patt i della F orca Sal ineh iet .
5. Smarr r:arx a ? f. i n d . (Tav. IV,fig .
F rammento d i valva dorsale, che r icorda alquanto la forma della
specie pu cedente . E’un pezzo d i valore molto scarso
,che accen no e
1 . ma! Il . Report of Geolog ical Surrey of Missour i , 1855, 1 1 , pag. 202.
1 04 RIVISTA ITALIANA
1 2 . Avrenna (OXY TOM A) Si nvaan n . f. (Tav . IV,fig .
Valva s in istra r igon fia, molto p iccola, ob liquam en te allungata in
add ietro, con sette ceste rad ial i ben r i levate , acute, separate da solchi
larghi i l doppio d i esse. Marg in e card inale rett i lin eo, lungo più d el la
maggior larghezza del corpo de lla valva ; marg ine in fer iore convesso e
arr eton date , bord i laterali regolarm en te concav i per l’attacco delle e
recch iette. Di queste l’
an ter iore è p iccola, tr iangolare , lisc ia ; la peste
r iore espansa ad ala e percorsa da una costa parallelam en te al marg ine
cardinale le altre sei coste percorrono i l corpo del la valva arcuandosi
verso i lati e d ivergendo a ven taglio dalla sua estrem ità anter iore. Il
loro decorso appare molto sinuoso, specialm en te sull’umbone ; ma è
probab ile che tale apparen za sia dovuta alla cat tiva fossilizzaz ione. Le
l inee d i accrescimento son poco visib ili . Altezza d i mm . larghezza
d i 5.
Arenar ie scistose della F erca Salinch iet.
Ricorda per qualche carattere l ’ Oo:y toma atavum W a a g e n e
ancor p iù la P seudom onotis Ia ticos tata N e t e c b a j e W che è molto
affine alla precedente e va probabilm ente compresa nello stesso genere.
Il m inor numero d i p ieghe, il con torno e le d imension i distinguono però
facilmen te la specie carn ica dall ’ una e dall’ altra.
1 3. Psaunem s or rs roao.mmnusre n . f. (Tav . V,fig . 1
,2 e 10 9)
Con ch igl ia p iù o m eno inequilaterale a con torno variabile,era tanto
alta 1 uan to larga, era e p iù spesso con l’al tezza un po
’magg iore della
larghezza. Le valve sono poco r igonfie, la sin istra meno che la destra.
Umbone piccolo, non prom inen te sul marg ine card inale . Orecchiette d i
solito poco sv iluppate , l’anteriore p iccola e tr iangolare , la poster iore
p iù espansa e con marg ine laterale concavo. La superficie è tutta per.
corsa,trann e che sull
’orecch iette anter iore
,da num erosissime coste e
costicine rad iali arrotondate o depresse , d ir itte , semplici, che aum entano
verso l’esterno per i nterposiz ion e, mai per biforcaz ione. Se n e hanno
in generale una ven t i na più larghe e r i levate, g ià presen ti sull
’ambone ;
tra esse si interpengono costicin e di al tr i due cicl i poco regolarmente
W . Wu cns,Salt-Range Fossil ) , I, Productus—Limestone Fossile (Pa
laeontol. Indica, Meu . Geol. Surv . Ind ia,ser . X III, I), p . 287
,t. XX
,5-6.
A. Narsonsczw ,Op . c it., p . 2 1 5, t. VII, f. 7
-8 .
RIVISTA ITALIANA
mm . di altezza per 8 a 1 1 d i larghezza ; il margine card inale si estende
per a 5 mm .
Calcar i ner i compatt i presso Dier ico.
20. PECTEN cf. Pannum e 8 t a c h e
1 878. P ecten Par d ulus. Stuebe,B ellem p h. Sild tir ols, I. c., p . 1 2 , t. IV,
f. 7 .
1 896 . Tommasi,Su l r ec. r i nven . ecc .
,l. o., p . 220.
1 904. Gortan i,F auna Col M ezzodi , l. 0 t . IV,
f. 5.
Già notato in Val d i R in e al Col Mezzodi, compare nei calcari
compatti presso Dier ico associato con la P seudomonotis fw oj uli eneùr.Gli ornam enti della superfic ie corr ispon dono alle figure citate , ma I
’al
tezza ia proporzione è m agg iore (7 mm . con tro 6 d i larghezza) . Tale
carattere lo avvicina al P . p raecox Waag . (ved i più sotto) e alla forma
seguen te ,'
en trambi però ancor meno allargat i e con un numero di costo
magg iore.
2 1 . PEC'
I‘EN BELLEBOPHONTIB n . f. (Tav. V, fig . 4
,7 e 10 a).
Chiudo la lunga serie di Av icul id i e Pettin id i con superficie ornata
e reticolata, che abbiamo ora passato i n rassegna, con una forma sube
qui valve e pressochè equilaterale . L’aspetto generale è quello di un
I’celan poco r igonfio, con guscio sottile , a con torno ovale oblunga, sem
pre p iù alto che largo , regolarmen te arrotondato. L’umbone è piccolo,
acuto, non sporgen te sul marg ine card inale e si tuato sulla linea ma
d iana della valva. Orecchiette med iocr i,tr iangolar i, forman ti un seno
aperto e poco profondo coi marg in i laterali ; l inea card inale dir i tta, d i
lunghezza in fer iore a quella della conch iglia. La scultura consta di 20
a 30 costicine prim ar ie sem pl ici e di r itte, d ivergenti a ven tag lio, de
p resse, separate da solch i larghi e piat ti in cui si adag ia un secondo
c iclo d i costicine in generale alternan t i con le prime ma soven te d ispo
ste senza regola fissa, per lo p iù g iacenti n el mezzo del solco ma non
d i rado più vicine all’una 0 all ’ altra delle due coste pr imar ie con tigue.
S tr ie di accrescimento ora p iù ora m eno visibili,sempre molto fitte e
sott ili,man ifeste anche sulle orecch iette dove le coste rad iali ord ina
r iamen te spar iscono. A 1 5 mm . dell’ap ice si con tano da 1 5 a 20 costo
in ogn i in tervallo di 5 mm . L’altezza osci lla fra mm . 1 2 e 1 6, la lunghezza
del margi ne cardinale fra mm . 7 e 10,l’
angolo apicale fra 70° e
1 10 RIVISTA ITALIANA
con i l margi ne superiore d ir itto e i l laterale e in feriore convesso al
I’esterno. L ’
attacco de ll’orecchietta poster iore è accennato invece sol
tan to da una larga insenatura del marg ine laterale ; e p iù allungat a
della precedente , a forma d i ala,con rostro più o m eno protratto. Il
corpo della valva è fiabellare , Spesso p iù largo che alto, arrotondato in
basso, di ritto ai lat i,con angolo ap icale largamen te aperto. La super
ficie è percorsa sulle orecch iette da 5 a 8 p ieghe rad iali d iri tte e in
tere,sul corpo da una ven t ina d i coste quasi tutte d icotome , ugual i fra
loro, ottuse , poco r i levate,d isg iun te da solchi più largh i d i esse. Le
strie d i accrescim en to,for tissim e sull
’om och ietta an teriore
, che ne r i
sulta reticolato-imbr icata, sono poco accen tuate nel resto della valva ;
neg li esemplari erosi talvolta però r isaltano p iù delle coste. Esiste una
profonda insenatura per l’usci ta del b issa. Dim en sion i d i alcun i esem
p lar i : altezza, mm . 9,1 0 e 2 1 ; larghezza, 1 0, 1 2 e 2 7 ; linea cardinale
,
mm . 1 5, 1 6 e 3 1 r ispettivam ente :
Calcar i scistosi d i Entrampo e Sostasio .
24. PEC TEN (ENTOLIL‘M ) Sanmcn xrrrr n . f. (Tav . IV
,fig .
Con ch ig lia equ i laterale , a corpo fiabelli form e,d ir itto ai lat i , arro
tondato in basso. con angolo ap icale d i Orecch iet te tr iangolar i , ad
dossate al corpo d ella valva,col quale tormano un un ico fiabello ad
angolo molto aper to , d i ci rca Ali d ivergen t i fra loro, in alto,d i
un angolo ottusiss imo, ar roton date ai lati ; i l loro marg ine in feriore
forma un’
insenatura col bordo laterale del la valva. Sup erfic ie q uasi l i
scia, segnata qua e là da s tr ie e cer cin i d i accrescimen to ; verso il
marg ine infer iore s i sco rgono le tracce d i i rregolari , ineguali e inter
rotte cost icin e rad ial i . Altezza di mm . 33 ; larghezza m assima all’in
circa uguale.
La forma è molto s im i le a quella del p iccolo E n tol i um aviculo tum
S w a l l o w che però, oltre ad avere una statura molto m inore,è
in teram en te pr ivo d i coste rad iali. Non m i son note altre spec ie che
possano utilmen te con fron tars i con quella era descr itta.
Calcari arenacei della Forca Sal inchiet .
Cfr. Mm e HAYDEN, F ina l Rep . of the U. 8 . Geolog ical Survey of Xc
braska ,1 872
, p . 1 89. t. IX,f. 1 1 .
1 1 2 RIVISTA ITALIANA
g hezza e 5 d i altezza) sono iden ti che a quelle deg li esemplar i russi .
Le valve descr itte e disegnate dallo S t e c h e come B . lad in a cf . bi
car inata e B . cf . ceratop haga (2) sono pure molto prossim e a que
ste ciclo d i ferme,le qual i si potrebbero forse raggruppare tutte sotto
una medesima specie.
Arenar ie scistose della Forca Salinchiet.
28. Gunvn .u a m canoras a n . f. (Tav . IV,fig .
Valva destra grande, a con torno romboidale , r igonfia, con guscio
spesso e robusto. Marg ine card inale d ir itto o appena sinuato-concavo,
lungo quan to l’infer iore che
‘
e leggermen te convesso. Umbone molto
ri levato, poco sporgente in alto
, prot ratto in avan ti ; da esso par tono
tre grand i p ieghe ondulate,larghe , dep resse, d ivise da solchi poco pro
fond i,le qual i si d ir igono d iagonalmen te verso l
’estrem o posteriore e
occupano la magg ior par te della valva. La p iega m eg lio spiccata e quella
superiore, che ha più forte r i lievo e cade bruscam en te sulla lunga ala po
steriore. Tutta la superfic ie è percorsa da fittissim e str ie d i acc resci
m en to abbastanza regolari , qua e là. p iù spi ccate ed ev iden ti in part icolar
modo sulle gran d i p ieghe . Il resto della valva mostra d i preferenza le
tracce d i una scultura granulare p er l’ incon tro delle str ie concen tr iche
con sott ili cost icine rad iali . Dimension i : mm . 52 d i lunghezza, 25 d i
altezza, 23 d i lunghezza della l in ea cardinale , 1 0 d i spessore .
Ha rapport i s tretti con var ie forme tr iasiche , com e la G . S tap p am :
P a r o n a e specie affin i,d i cui può supporsi lon tana progen it r ice ,
ma dalle quali i caratteri accennat i la tengono però ben d istin ta.
Arenarie scistose della F orca Salinchiet .
29. Hos ax zsra Pm onax n . f. (Tav . IV,fig
Anche questo genere propr io del Tr ias è rappresentato nel Per
m iano super iore della Carn ia. Vi r ifer isco una valva sin istra molto con
vessa e rigonfia, a con torno trapezoi dale, subaugoloso infer iorm ente . Il
marg ine card inale e d ir itto,or togonale col poster iore che è appena si
Balleroph. Siidt irols , 1 878, p . 20,t. IV,
t‘
. 5.
Ibid ., p. 2 1 , t. IV, f. 1 5.
(3) 0. F. Panor u, Stud io monografico della fauna m ibi iana di Lombardia,
1889. p. 102, t. VIII, f. 1 .
RIVISTA ITALIANA
I tre esem plar i proven ien t i dagl i strat i con P roductus d i Byan s
e descritt i dal D i e n e r gli hanno perm esso , malgrado i l loro stato d i
con servazion e poco felice, d i darne una buona d iagnosi e un’ottima fi
gura. Com e egl i stesso d ice , tal i esem plar i si avvicinano bensì alla L ie
bea Hausman n i,ma hanno d imension i m olto m agg ior i ; inoltre i l loro
con torno e p iù allungato e at tenuato in alto,lo spessore è m eno forte,
la superficie p iù i r regolare e con str ie concen tr iche p iù grossolane.
Nei calcar i scistos i d i Ent ram po e Sostasio g li agent i atmosfer ici
hanno isolate alcun e valve che ben cor r ispon dono a tali caratter i . La
m agg iore ha 33 mm . d i altezza e 1 7 d i larghezza ; la m inore ne ha 23
e 1 2 r ispetti vam en te. Per i l m odo d i conservaz ion e ‘tali valve non si
prestano a esser ben figurate . M i l im ito perciò a r ichiamare l ’ icono
grafia del D i e n e r , che p iù s i allon tana dalla L . H ausman n i , e a foto
grafar l’
esem plare che in vece r icorda megl io questa forma ben nota.
Potrà così esser m eg lio compreso i l c iclo di var iaz ion i del la specie
descritta.
32 . NUCULA cf. BEYR IC HI v. S c h a u r o t h .
1 854. N ucala B ey r i ch i i . v . Schauroth , Z ei tsch r. Dent. Geol. Gea., VI ,
p . 55 1,t X X I
,f. 4.
1 86 1 . Nucula B ey r i ch i , Ge in itz,Dye r , pag . 67
,t . X II I, 22-24.
1 878. N ucula cf B ey r ich i , Steche , B ellcrop h . S ii d ti rols , o., p . 24,t.
IV,1 . 24.
1 894. Nucala B eyr ich i , Netschajew ,op . c it .
, p . 248,t . X
,f. 1 2 .
1 903. N ucu la cf. B ei/ r i ch i , K i ttl, op . c it., p . 1 78.
Ne i calcar i di Dier ico e sopra tut to n ei calcar i e arenar ie della For
ca Sal in ch iet,si raccolgono n um erosi avan z i d i una B w alve che senza
dubbio appar t iene al genere Nucula. I gusci m egl io conservati mostra
no una con ch igl ia equivalve , con torno tr iangolare con angoli ottusi e
arrotondati , abbastanza r igonfia. Gl i um bou i son o convessi, prom inenti ,
grand i , r icurvi in m odo da rend e re la sez ion e trasversale reg olarm en te
cord iform e ; da ess i parte una car ena ottusa che s i d i r ige verso l’estre
m ità poster iore . La superficie è ornata d i una fitta e m inuta str iatura
concautr ica. Ne i due esem plar i com plet i l’altezza d ella conch ig lia e r i
spett ivamen te d i mm . 7 e 10,la lunghezza d i e 1 2
,lo spessore d i
e 8. In com plesso ta li caratter i r ispondon o su per g iù a quella del la
N ucu la Bag/ r ich i , mas sim e quale è rappresen tata ne l le figure del G e i n i t z.
DI PALEONTOLOGIA 1 1 9
89. Bsnnsnornon Janus S t a c h e. (Tav. VI,fig. 4
,
1 877. B elle rophon Janus . Stache,Baller0p h S ud tir oler
,o., p. 37
,
t . II,f. 3 a , 5.
Di questo Bellerofon te era nato sino ad oggi un solo modello in
terno,che lo S t a c h e descr isse accuratamen te . Tre esemplari ne potei
r iconoscere fra i l mater iale raccolto presso Comeglian s, verso Entram
po ; i l magg iore d i essi , rappresen tato n ella fig . 4 della tav . VI,coin
cide perfettam en te con i l modello del geologo austriaco ; nel m inore èconservata la scultura superficiale , che è uguale a quella del B . semim
s is. La carena m ed iana è spianata in alto , larga 1 mm . sul penultim o
giro, ornata come nelle altre forme di questo g ruppo. Il diam etro della
conchiglia var ia da 1 3 a 2 1 mm . ; la larghezza della bocca da 8 a 1 4
la sua altezza da 5 a 8.
40. Bunnmaopnon em maus 1 1 . f. (Tav. VI, fig . 7
1 896 . B eller 0p hon fallace (non Stache) Tommas i , Sul r ec . r inven . ecc.
1. o., p . 2 1 9 e 220.
Appar t.ene, come le tre form e preceden ti , alla sezione Asymm etr ici
ca r i nal i delle 8 t a c h e . L’asimmetr ia è molto pronunciata ; il lato più
espanso è ind ifi‘
ereutemente i l destro o i l sin istro. La carena ha un o
scarso rilievo,e men tre appare d ist in te sulla superficie esterna, nei m o
delli è spesso così ridotta da d iven ire impercettibi le : Dim ension i med io
cr i ; guscio resistente e d i spessore notevole. Ult imo giro ben sviluppa
to, con diametro regolarmente accresciuto
,con altezza d i almeno un
terzo superiore a quella del g iro precedente. Se i l guscio è intatto, l’om
bilico è comp letam en te nascosto ; nel modello si presen ta largo e pro
fondo,con d iametro d i mm . 5. La bocca è alta, sem ilunare , a con torno
esterno ed interno più o meno regolarm en te og ivale. I l penultimo g iro
ha un d iam etro vert icale magg iore dell’orizzon tale , e perciò la bocca
ha una figura molto r icurva, profondam en te incavata dal lato in terno.
Il labbro esterno è sinuato. La superficie ha scultura uguale alle form e
già vedute. Sulla carena, quasi sp ianata in alto ,appaiono sott i li costi
cine trasversali d ir itte o un po’con vesse ; tali costicin e si continuano
sui due lati cur vandos i regolarmente verso l’omb i lico. Sono p iù tenui
che nel B . sex tens is e se ne contano da 3 a 5 in ogn i m illime tro d’in
RIVISTA ITALIANA
q uan to mai . Omb ilico quasi tutto coperto. Profi lo regolare , subcircolare
nei due terz i in fer ior i, poi r ialzato e assai meno r icurvo. L
’ultimo gi ro
ha r ispett ivamen te mm . 2 l e 1 7 di diam etr o massimo e m in imo ; la
bocca è larga mm . 1 5 e alta mm 7 sulla linea m ed iana,1 1 fra gli e
strem i super iore e in fer iore.
Questa forma, che d ed ico con tutto i l p iacere all’am ico dott. C i o r
g i o C a n e v r icorda per var i caratter i i l B eller 0p hon Stachella) bifr onsW a a g e n (op . cit ., pt . II , p . 1 73
,t . X V
,f. 5 a-d ) , che è pure quasi
s immetrico e con apertura larga e bassa. La magg ior d ifferenza sta
nello svi luppo m inore dell’ult imo g iro e nello sch iacciamen to laterale
,
che dà al la specie cam ica un aspe tto ben d iverso da quella ind iana.
Calcar i ner i fra Com eglian s ed En tram po.
47 . Muncm som a M .szzanor x 1 1 . f. (Tav . IV, fig .
Conch iglia p iccola, con ica,com posta d i 6 6 g iri a rapido svi luppo,
l ’ ult imo de i qual i m ol to g rande e alto ci rca m età del l’ in tera conch iglia.
An fratti poco convessi , con sutura poco p rofonda. Ogn i giro è muni to
lungo la sutura,in alto
,d i un sotti le r ilievo long i tud inale a foggia di
cordoncino. Sull’ult imo an fratto è d istin ta una linea m ediana che se
para la reg ione super iore dall’infer iore , sem bra ottusament e carenata e
rappresenta la traccia della fessura boccale L’aper tura è ovale ar ro
tondata, un po’
più al ta che larga. con i l labbro esterno poco d istin to .
Superficie l iscia. L’altezza d el guscio non supera mm . 6 ; la massima
larghezza è d i quasi mm . 3 .
Per la forma gen erale 1 1 fossi le si avvicina pm ad un M acm chei ìus
che ad una M ur ch ison ia ,ben ché la traccia della fessura boccale m i per
suada ad ascr iverla, alm eno per ora, a quest’ultimo gen ere. Qualche
analog ia ha con la M . Tscher n yschew i Y a k 0 w l e w che è più gran
de,sprovvista d i cordonc ino suturale
, e con l ’ ultimo g iro in propor
z ione m inore.
Calcar i compatt i oscur i della F orca Salinchiet.
Cfr. ad es . M . co m'
cus G e m m e 1 1 a r o, La fauna dei calcar i con Fusul ina
della valle del fiume 80350 in p r ovinc ia d i Palermo , p. 1 27 , t. XIX , i'
. 8-9. Pa»
lermo 1 889.
Die F aun a cim°
ger oba y mlaeox oischer Ablagerungen Russiands, I, Dio
Cep halop odm and Gastrop odan (Mem . Com. Géol. St. l ’etersb., vol. XV,n . 3,
p. 108, t. V,f. 1 .
DI PALEONTOLOGIA
48. Namcorsm rusm ncuu S t a c h e sp .
1 87 7. Nat ion p usiuncula. Stacha, B ellerop h. Sud ti r olo, I. c., p . 48, t. I,
f. 7 a-c,
1 896. Natica p usi uncula , Tommasi, Sul r ec. r i nven . ecc., 1. c.
, p . 2 1 9
0 220.
Negli scisti calcareo-mam osi fra En trampo e Sostasio non sono in
frequen ti alcune tracce d i Gasteropod i mal conservati , r i feri bil i alla
Naticopsid i o a gener i afi n i . Gli esemplari meno infe lici hanno somi
glianze notevoli con la. Nation p us iuncula dello Stache : forma questa
che, al par i d i tutti i fossi li paleozoici ascr i tti a tal genere , va fino a
prova contraria collocata in vece n el genere Naticop s is.
Alla specie tirolese appartiene poi senza dubbio alcuno un individuo
completo, che son r iuscito a isolare dai calcari compatti della Forca
Salinchiet e che presenta t ip icamen te i caratter i della specie stessa.
49. LOXONEMA cf. GRAC ILE d e K o n i n c k em . (Tav. IV,fig.
1 848.L omoncma graci l is. de K on inck in Omalius, Pr e’
cis e'
le'
m . de géolog ie,
p. 5 1 6.
1 905. Laaconema subgraci le, C or tan i, F oss i l i M . Pizzu l, I. o., p . 582 , t.
XV,f. 28
,cum syn .
È forse azzardato il ri fer im en to d i un fossi le neoperm ico ad una
specie cocarbon ifera. B isogna notare però che forme quasi identiche a
quelle del Belgio sono comun i nel Carbonifero super iore del monte Piz
zul, e che ad esse è molto vicino i l L subgraci le Netsch. cm .
del Perm ico russo. L’esemplare che ora presento, raccolto nella arena
rie scistose della Forca Sal inchiet, ha un angolo ap icale acuti ssimo,
1 0 g iri a len to sv iluppo, poco convessi , e superficie liscia. Il piano de i
g ir i e quasi normale all ’ asse della spira. L’altezza è d i mm. 5 ; l
’ul
t imo anfratto ha mm . d i d iam etro.
50. LOXONEMA cf. VOLGENBE G o l 0 w k i n 8 k y sp . (Tav. IV,fig.
1 868. Turbon i lla volgens is . Golow k insky , Pam . F ormat , Mater. Geol .
B ass., I, p . 306 , t. V ,f. 9 1 0.
1 894. Lox onema valgens is, Netschaj ew ,op. cit., p. 356, t. X II, f. 33 e
34 cum syn .
RIVISTA ITALIANA
su lla fauna car bon ifera del M . P izzul. B. S. Geol. It., IX , p. 8
d . astr.
1 899. Tuber culop leura anomala. Yakow lew ,Palaeoz. Ablag. Russi., l.
o., p . (‘
O e 1 22 , t. V,f. 27.
1905. Tuber cu lop leum anomala , C ortan i , F ees . M . Pizzul, c., p . 584,
t . XV,f. 23-26 e se 6 .
Ho cercato d i supplire qui con ingrand imenti fotografici e con uno
sch izzo schematico alle figure in gran par te m al r iusci te dello scorso
anno. Gli esemplar i hanno g li stessi caratter i di que lli russ i e del mon
te Pizzul in qualcuno è m inore i l numero dei tubercol i, che oscilla
fra 1 5 e 20 sul l’ultimo giro. L
’eterostrofia dei prim i anfratti è spesso
ben visibile e appariscente. La bocca è largamen te ovale, quas i circo
lare,con i l marg ine laterale esterno e l
’in feriore p iù o meno dentat i .
La T. anoma la è abbastanza comune nelle arenar ie scistose del la
Forca Salinch iet, assoc iata con la Promath i ld ia biser iaetuberculatm
RISULTATI PALEONTOLOGICI E STRATIGRAFJCI.
Negli strati con B ellerop hon della Carn ia, dove finora erano cono
sciuto quattord ici sole specie d i an imali , abbiam o cosi potuto raccogliere
una fauna r icca d i cinquantatre form e. Questo è ancora ben poco quando
si pensi , per non andar troppo lungi , ai numerosissim i fossi li neoperm ia
n i de l Trentino e del Cadore , in cui lo S t ac h e d ist inse quasi un cen ti
naio d i specie, che le pazienti r icerche del C an e v a han no per lo me
no raddoppiate. La fauna carn ica, come ogg i si presen ta, non è però tra'
aen
rabile ; e ci offre un insieme d i forme, raggruppate in associaz ioni d i verse ,
che si prestano a var ie considerazion i .
La tabella che ho esposto a pag . 1 27—1 28 mette in evidenza i l t ipo ein
golare della fauna stud iata. Su 53 forme, 1 9 non erano state ancora da
scr itte delle altre quasi nessuna fu trovata ne ll’Europa setten
trionale e centrale, ben poche in Russ ia e nell’India ; 1 7 sol tanto son cc
muni agli strati con B el lerop hon della Carn ia e delle altre reg ion i alpi ne
insieme ; delle trenta specie r invenute dal K i t t l nella Bosn ia la sola N u
cula Bey ri ch i pare abbia vissuto nei nostri mari . I Brach iopod i , cosi ab
La Cassianella Siaehei , l’
Avicula ch iaia-costata var . infic i a e la Licbca
Disaer i furon già rinvenute altrove, come fu detto a suo luogo.
SPIEGAZ IONE DELLA TAVOLA IV.
Fig . 1 . Sp ir ifer ina cr i istata Schoth. sp . Grande valva : a
dal lato ventrale, b di fianco, c area. Ingr. 2 . pag . 99
g 2 . Sp ir ifer ina Taram elli i Gortani. Grande valva
letterac… …s — O s . x 1 00
3. Sp ir ifar ina sp . Porzione dalla valva dorsale.C . B.
4. Pmducius sp . Valva dorsale . C . s.
5. Lox onema cf. volgense Golow . Grand. nat .
6 . Lomone—ma of. graci le Ko .n Iugr . 2
7 9. Tuberculop leura anomala Yakow . Fig. 7 e 8mgr.2 volte, fig. 9 mgr . 6 volte . .
10. M ur ch ison ia M an aroti i Gortan i. Iugr . 5
1 1 . Z ygop leura backmouth in em is Yakow . Iugr. 5 .
1 2 . L iebea Dienem‘
Gortan i. Valva destra.Grand . nat.
1 3. Oro:/ toma Vinassai Gortan i . Valva sin istra.
Ingr . 6
1 4. H oem es ia P i ranai Gor tan i. C . s. Grand . nat.
1 5. Pecten (En tolium ) Sal in e/rieti Gortan i . Grand . nat.
1 6. Avicula Salvan i Gortan i . Valva sin istra. C . e.
1 7 Ox ytom a S i lver i i Gortan i . C . 8. Iugr. 6
1 8. Gew i llia incaroiana C ortani . Valva destra.
Grand . nat.
1 9 . Sch izod us dubi iform is Waag. C . 8. Iugr . 2 .
20. Mgop hor ia carn ica Gortan i . C . C . 8 .
Anno. X" Fasc. 1V
1 .
RASSEGNA DELLEPUBBLICAZ IONI ITALIANE
Cnnccnm —Rrsrom G. Sull’
Eocene di Capo 8. Andrea presso Taor
mina. Rend ie. R. Acc. Lincei,Cl. Sc. fis . mat. nat., vol. XV ,
ser . 5,sem . pag. 325 - 327 . Roma
,1 906.
Ricordate il r inven imento dell’eccene sulla spianata del Tou
do al Capo S. Andrea,dovuto al Di Stefano e citate le
specie ivi già. segnalate da questi e dal Cortese, come anche dal
Tellini,l’A.
,che ha ripreso in esame paleontologico i campion i di
roccia raccolti dallo stesso Di Stefano, produce il seguente elenco di
fossi li , assai p iù completo e più esatto dei precedenti
Alveolina : oblonga d’Orb.
,canavar i i Checc.
Operculina ammonea Leym .
Ggpsina : globulus Reuss.
Nummu li tes : str iata d’
Orb.,con tor ta Desh.
, guettard i d’Arch .
Baeulogyp sina : m eneghin i i , var. tetraedra, (Giimb.)
Or t1w p hragm ina : p ratli (M ich) , d ispansa cfr. aspera
sella stellata (d’
d i — stefanoi Cheoc. sp. n .
Dai caratter i litologici e paleontologici dei suddetti campion i.
il Checchia deduce che la formazione di Capo S. Andrea,
con cui
continuasi l’
altra della valle del Torrente S. Giovanni (Giardin i), ap
pertiene alle argille scagliose dell’
eocene superiore.
In nota al lavoro trovasi una succinta descr iz ione dell'
Or tho
p hragm ina di-stefanoi , trovata precedentemente dall
’
A. nel bacino
d i Palermo,di Term in i-Imerese e di Collesano ; attr ibuisce ad essa il
valore d i fossile caratteristico dell’
eccene super iore della Sici lia.
A. Su.vssrm.
1 38 RIVISTA ITALIANA
Cru-:ccnxa Rxsr om G. Sulla diffusione geologica delle Lepidocicline.
Boll. Soc. Geol. It.,vol . XXV , pag. 2 1 7 - 220
,Roma;
1 906 .
Nella nota indicata,1’A. replica ad osservazioni fatte dal Prc
ver a sue antecedenti pubblicazion i, e contenute in calce alle pagg.
68 1 - 684 del lavoro d i quest’
ultimo che s’
intitola Ricerche sulla
fauna di alcun i calcari nummulitic i dell’
Italia centrale e meridionale
(Boll . Soc. Geol. It. vol. X X IV . Roma,
confermando l’
o
s istenza d i Lepidocicline nell’
eocene,resultante non tanto dalla Le
asp era (Gumbel) del Monte Judica,sulla nomenclatum
della quale il Prever fa una questione curiosa quanto dalla L .
d i - s tefan0 i di Sciacca, e da tutte le altre forme aventi le camere
equatoriali sicuramente caratteristiche del genere, rinvenute di poi a
Bagher ia presso Palermo, a Term in i- Imerese
,nelle vicinanze della stes
sa Sciacca,e nella provincia di Lecce.
Conferma inoltre l’
A. che le Lepidocicline raccolgonsi anche
n ell’
elvez ianc p iemontese, ed aggiunge d’
averne trovate in ab
bondanza,
accompagnate da M iogipsine, presso Burgio (Girgenti),in terreni m iocen ici indubbiamente non più antichi
,ma forse più
g iovan i dell’
elveziano. A. Sn.vssrnr.
F. Contribuzione allo studio dei Foraminiferi fossili dello
strato di sabbie grigie alla Farnesina presso Roma. Boll. Soc.
Geol. It.,vol. XXV
, pag. 32 1 376,4 fig. e tav . I V. Roma
,
1 906 .
Premesse opportune notizie storiche,tecn iche e tassinom iche
,il
dott. Napoli descrive le specie riscontrate nelle sabb ie gr igie della
Dico curiosa, perché mentre i l Prever afferma che la forma osservata dal
Checchia è intermedia fra le Ortofragm ine e le Lep idocicl ine d’
altra parte
la vuole i nch iodare tra le prime. Ma come form a i n termed ia avrà caratteri dello
una e delle altre, per cui la nomenclatura potrà esser mod 1ficata a seconda di c iò
che gli stud iosi stimeranno sia il tipo generico prevalente. Nella fattispecie potremmo
sostenere con buon i argomenti la prevalenza del tipo Lep idociclina ; in altri casi
1 vverrà l'
incontratrio. Ma non è qui il luogo, nè i l momento d’
insistervi.
DI PALEONTOLOGIA 1 41
MEMORIA DELLE Dor r. CLELIA B unsen s DOTT. CLELU VIALE.
C o n tr ib uzio n e a llo s tud io d e l le am m o n i ti
d e l Lias sup e r io r e
(Con tav. VII - X I.)
Il Museo Geolog ico della R . Un i versità d i Tor ino possiede una
n oce collezione di ammon iti , proven ien ti dal cosidetto calcare rosso em
mon i tico del Lies super iore (Toarciano), in buona par te raccolte dal dot
tor GUIDO BONARELLI . La gran maggioranza d i queste ammon iti pro
v iene dall’Appenn ino Centrale (Val d
’Urbia, Monte Penna,M on te
Tenetra, M onti del F urlo, Acquajura, Rocchetta d ’ Arcev ia) ; altr i
esemplar i provengono dalla Lombard ia (Buco del Piombo ed Alpe Tu
rati sopra Erba) .
Questo calcare rosso amm on i tico,come è noto, costituisce una zona
calcareo -marnoso - m icacea,la quale inferiorm ente pogg ia sopra strat i
calcarei gr ig io—cerci con amm on iti p i ri tizzate O limoni tizzate del le Char
mutiene super iore (Domer iano e superiormen te comprende una serie
d i strati a fauna notevolmen te d iversa e r iferi ta all’Alen iano.
Col consiglio e la guida del Prof. Parona, noi ci occupammo del lo
stud io e della determ inaz ione delle ammon i ti provenien ti dagli strati
toarcian i del rosso ammon itico,e,r iord inando cosi la collezione
,ci si
p resentarono alcun i esemplar i molto interessan t i O per la eccezionale
loro conservaz ione,o perchè appar tenenti a specie imperfettamente
conosciute,oppure rifer ibi li a forme specifiche non ancora d escr itte e fi
gureto.
Il nostro lavoro ha appunto lo scopo d i i llustrare questi esemp lar i ,
e con ciò sper iamo d i con tr ibuire alla maggior conoscenza della fauna
toarciana della Lombardia e dell’Appennino Cen trale.
Come a guida del nostro studio ci attenemmo all’Opera classica
del Hm omm : Monograp h ie des fossi les ap p artenents au calca i re
142 RIVISTA ITALIANA
r ouge ammon i tique d e Lom bard ic et de l’
Ap en n in d e l'
Ita lia Cen trale
Quest ’ opera fu pubblicata n eg li ann i dal 1 867 al 1 88 1 , dopo la quale
epoca g li stud i sulle ammon i ti progred irono d’assai
,sicchè oppor tuna
m en te i l Dot t . G . BONARELLI procedet te ad una revis ione d el g rand e
lavoro del M ENEGH INI , lim i tatam en te agli esemp lar i figurati , la quale ha
per ti tolo : Le Amm on i ti d el Rosso Ammon i tico d es cr itte e figa
r ate da G iusep p e M en egh i n i
Com e r isulta da questa re‘
v isioue, parecch i r i fer iment i gener ici e
specifici vennero rettificati , e parecch i gruppi d i form e dal M ENEGBINI
r iun ite sot to ad un un ico nome specifico, furono r ipart i t i in specie di
verse.
M olt i altr i lavor i consultam m o per accor tarci delle nostre deter
m inaz ion i , qualcuno r elativo alla stessa fauna d el Rosso Ammon i t ico
dell’ Appenn in o e del la Lombard ia, la magg ior par te r iguardante la fau
na l iassica d i altre reg ion i i tal ian e o stran iere
Ne l corso del lavoro avr em o occas ion e d i c itare i seguen t i
1 . R. BE LLIN I . L es ammon i tes d u Ca lca ir e Rouge Ammon i tique (Tomcien ) de l
’Om br ie. Jour nal de Conchy l iolog ie, Vol. X LVIII,
1 900, pag . 1 23.
2 . A. BETTON I . F oss i l i dom er ian i d ella p rov . d i B rescia. Mem .
de la Soc. Paleon t. Suisse, Vol. X X VII, 1 900.
3. G . BONARELLI. Osservazion i sul Toa r c iano e l’ Alen iano dell
’
Ap
p en n in o Cen tra le. Boll . Soc. Geol. It., X II, 1893.
4. G . BONARE LLI. I l gen . Pa ron icer as B on . 1 893 . B ull. Soc.
Maleo. Ital. Vol. X IX,1 895
, pag . 226 .
5 . G. BONABE LL I. Le ammon i ti d el Rosso Ammon i tico deser i tte e
figur ate da G. M en egh in i . B ull. Soc. Maleo. Ital. Vol .
X X,1 896
, p . 1 93.
6. S. S. BUC K MANN . A M on og rap h on the Infer ior Ool i the Ammon i tesof the B r itish Islan ds . The Palaeon te graph ical Society .
(In corso d i pubb licaz ione).
7 . E . DUMOB 'PIER. Étud . p a lc
'
on i . s ur les Dc'
p ot3 Jurass iques du bas
s in da Rhone. 1 864- 1 874,I - IV.
8. A. FUC INI. Amm on i ti d el L ia s m >d io d ell’App en n i no Cen trale es i
s ten ti u.cl M useo d i P isa . Palaeon tograph ia Ital ica, 1 899
(V) , 1 900 , (VI).9 . A. FUC IX I Cefa lop od i Ilass ic i del M on te d i Cetona .
- Palaeonto
g raph ia Ital ica, 1 901- 1 905
,Vol. VII - X I (Par ti I-V) .
1 44 RIVISTA ITALIANA
T. TARAM ELLI . M onografia stratigrafica e paleon tologica del
L ian n elle p rovin cie ven ete. Append . Tom . V. Atti R . Ist.
Veneto, 1 880.
J. SOWERBY. The M in eral Con chology of Gr eat Br ita in .
London 1 81 2.
M . VACEK . Ueb. d ie F auna d . Ooli the von S . Vigi l io. Abhandl.
11 . K . k . Geclog. Reichs., X V. Bd . W ien , 1886.
T. WRIGH T. Th e b ias Ammon i tes of B r i tish Islan ds (Palaeonto
graphical Society London ) dal X X X II al XX X IX Vol.
1 878 - 1 885 .
DESCRIZ IONE DELLE SPECIE
(I ) Lvr oennas ITALIAE n . t’
. Tav. VII, fig. 1,2 .
Diametro
Altezza dell’ ultimo g iro i n rapporto al diametro
Spessore dell’ultimo g iro in rapporto al d iametro
Ombelico i n rappor to al d iametro
Modello in terno, incompleto, d iscoidale, a len to avvolg imento d i
spira, ombelico am pio, g ir i lisci , p iù alti che largh i, che si toccano ap
pena, col dorso a sez ione subtriangolare, appiatti ti sui fian ch i , convess i
sul lato esterno, in numero non m inore di 6. Ogni g iro por ta delle atroz
zature lievemen te arcuate sull’ avan ti, in numero di sette sull’ultimo
g iro che è tutto concamerato.
La descritta forma appartiene al gruppo del Lyt.Dorcad is Mgh . e
del Ly l. catri en s is M gh .,ma d iffer isce dal primo per l
’avvolgimen to
d ella spira di gran lunga p iù len to. e quind i per la magg ior amp iezza
del l’ ombel ico, e poi per la sez ione che è p iù compressa all’
esterno.
Per questo carattere megl io si avvicina al Lyt. catr iens is,dal quale
tuttavia si d is tingue per la sp ira a più lento svi luppo, magg ior amp iezza
dell’ombelico e man canza d i ogn i traccia di costolature, che invece i l
DI PALEONTOLOGIA 1 45
Izy t. catr ien sis figurato dal Menegh in i presen ta sull’ultima metà
dell’ultimo g iro : d i p iù, men tre i l nostro grande esemplare è tutto con
cam erata,i l tipo del Lyt. catr iens is
,sebbene molto più piccolo, ha una
cam era d i d imora che occupa oltre la m età dell’ult imo g iro. R iguardo
alla linea lobale, essa r ipete, sia nel numero degli elementi , com e nel
frastag lio, i caratter i d i quel la del Lyt. Dor cad is data dal M enegh in i .
Per ques to differenze,e specialmen te per l
’am p iezza dell
’ombelico
,
quale r isulta anche col con fronto dei valor i proporz ional i esposti dal
Meneghin i , ri ten iamo che questa forma debba essere tenuta di stin ta.
Locali tà. M on te Penna, presso Gualdo Tadino, sopra la m in iera
d i ferro. (Appennino Centrale) . Raccolse G . Bonarelli.
e ocanas noncm xs Ms n . ( v a r . ) Tav . VII,fig . 8
,4.
Altezza dell’ultimo gi ro in rappor to al d iam etro
Spessore dell’ultim o g iro in rappor to al d iam etro
Ombelico in rapporto al diam etro
Modello in terno incompleto, d iscoidale, a len to avvolgimen to di spi
ra, ombelico ampio , g i ri in numero d i quattro, più alti che larghi , che
si toccano appena sul dorso, a sezione ovale, leggermente convessi sui
fianch i e dorso arcuato. Ogn i g iro por ta delle strozzature sette sul
l’ultimo g iro. Cam era d
’abitazione incompleta che occupa quasi la metà
dell’ ultim o giro. La descri tta forma appart ien e sen za dubbio al Lyt .
Dor cad is com e è con fermato anche dall’ iden ti tà. nei caratteri della
l inea lobale , ma ne d iffer isce alquan to per avere i fianchi più schiac
ciat i ed i l dorso p iù con vesso, ciò che r isulta anche dai numeri sue
spost i relat ivi alle m isure proporz ionali.
Locali tà. Val d’ Urbia. Raccolse G. Donat ell i.
(B.) FB ECHIELLA susoaamam Y. et B . Tav. VII , fig . 5,6 , 7.
Poeci lomoqahus subcar inatus . BONABELLI . Oss . sul Toar c. e l’Ale .
n iano d ell’Ap p . Cen t., pag. 5
,1 893
, (ved . sinon im .)
( 1 ) G. Mm mm… . N. 1 7 , pag. 107 - 1 9 1 - 1 92,tav. 20
,fig. 4 ; tav. 2 1 .
fig. 1 . G. Bassan a . N. 5, p. 2 1 6, fig. 4.
G. Mm mm. N. 1 7 , pag. 107 , pl. XXI, fig. 1 .
DI PALEONTOLOGIA 1 49
per la l in ea lobals come è data da Haug ma ne difi'
er isce per la
forma delle costicine che sono quasi sempre a coppia, men tre n ello H arp
subp lanatum sono sempre sem plici .
Altrettan to può d irsi in confronto alla fig . 3, colla quale Meneghin i
illustre una delle forme da lui r iferi te all’Amm . comp lanatus Brug .
[H arp subp lonatum (Opp .) in Bonarelli]Per lo spessore assai m inore d iffer isce pox evidentem ente e spe
cialmen te dalle altre due form e (fig. 1 - 2 ) r ifer i te dal M eneghin i alle
Amman . comp lan atus (Harp . subacraratum Bon).Il nostro esemplare si avvicina anche alle H arp . aalense (Z ieten )
per l’ornamen tazione a cost icine flessuose e quasi sempre a copp ie, per
biforcaz ione che si com pie poco prima della m età del fianco ma ne d if
fer isce però per la m inor am piezza dell’ombelico, i l m inor spessore e
per la forma del dorso, perchè lo H arp . aalens e presen ta i l dorso ta
gl ien te, m entre n el nostro esemplare è ot tuso. Le H arp . aalen se pei
presen ta i l suo magg ior spessore verso la parte esterna del la sp ira,
m en tre i l n ostro esemplare lo presenta verso i l margine ombelicale.
Per i descritt i caratter i , r i ten iamo che questa forma possa essere
tenuta d isti nta come nuova.
Locali tà : Esem plare raccolto alle foci del Burano tra Can t iano e
Cag li Raccolse G. Bonarelli .
HARPOCEBAS (POLYPLECTUS) m scoma Z i e t e n Tav. VIII,
fig 1 — 3 (II ) 4 (I) .
H arp oceras d iscoides WRIGHT Lias amm en . 1 884, p. 467 , P l. LX X X II,
i . 1 2 - 1 3.
Harp ocera 9 d iscoides HAUG Bei tr . M anag . der Amm . Gott. H arp e
cer as , 1 885 , p . 620 .
Polyp lectus d iscoid es BUCH LÌANN I nf . Ool. Amm . 1 89 1 , p . 2 1 5,P] .
X X X VH,£ 1 — à
Lgoceras d iscoides BELLINI Amm . d u Calc. r ouge Amm . de l’
Ombr ie,
1 900 , p . 1 43.
E. HAUG . N. 1 2, p. 720, T. X l
, f. 9.
(2) G. Mam emm . N. 1 7 , p. 1 6- 1 7 . T. IV,
I‘
. 3.
(3) G. Besaan m. N. 5,1 896, p. 201 .
M. VACEK . N. 30, 1886, p. 76, T. VII, f. 1 1 .
RIVISTA ITALIANA
H arp oceras (Polyp lectus) d i:}
coides JANENSCH D ie Jarens issch. ri
E lsass . 1 902 , p . 62. T . IV,f. 1 . 2 .
Diametro
Altezza ult imo g iro in rapp . al d iam .
Spessore ultimo g iro in rapp . al Jiam .
Ombelico i n rapporto al diam e tro
M eneghin i descr isse ques ta specie e fece notare come essa abbond i
nell’ Appennino C entrale e sia invece m o lto rara nella Lombard ia, ma
non figurò nessun esem plare . Avendo in esame parecchi esemplar i d i
Polyp lectus , notammo due modelli in ter n i m olto ben caratter izzat i e dc
g ni d i i llustrazione , ambedue proven ien ti dall’
Appen n ino Centrale.
I. Pol ip lectus n . f. afi'
. P. d iscoidm Z iet. Un esem plare por ta
una piccola porz ione della cam era d i ab itaz ione,e r ipete ev iden tem ente
nel complesso i caratter i del la specie , solo allon tanandosi alquan to dal
t ipo per i caratter i or namen tal i , perchè le sue costole sono in magg ior
n umero ; infatti per quest i caratter i si avv ic ina alla fig . 8 del d’ Orbi
g ay , più che alla fig . che è iden tica al t ipo d i Z ieten.
Questo bel modelle,raccolto dal Prof. Chelussi , prov iene da P iob
b ico presso i l Mon te Nerone .
II. L’
altro è di d imension i assai g rand i in fatti, pur essendo tutto
concamerato,ragg iunge un d iam etro di mm . 1 01 esso si allontana mag
g iormen te dal tipo, corriepondendog ì i per lo svi luppo ed andamen to
d ella l inea lobale. Ma d i fferisce per l’ornam en taz ione : presenta un nu
m ero molto magg iore d i cost ic ine che sono pi ù fini e p iù fiessuose. C s
ratteristici poi in questo esem plare sono cer ti r ialzi lim i tati alla por
z ione med iana dei fianch i e si tuat i a regolare distan za l'
un dall’altro,
che r iun iscono quasi come a fasci le cost icine e dànno a questa parte
del m odello l’aspet to t rasversalmen te ondulato . Questo è un carattere
che non si in contra in n essuno degli esem plar i figurati d i questa spe
cie, ed al quale non accenna i l M eneghin i .
Questo esemplare proviene da F ur lo S. Anna (Appenn ino C entrale) .
H anr eoanas POLYPLEC ‘
I‘UB) PIETBALATAF n . f. T.VII
,fig . 1 2 1 8.
Diametro
Altezza u lt imo gi ro in rapporto al d iam etro
Spessore ultimo g iro in rapporto al d iam etro .
Ombelico in rappor to al d iametro
DI PALEONTOLOGIA 1 53
fer irono al gen . H ammatoceras e da d’Orb igny e Bellin i fu confrontato
coll’H amm . i n s ign e, ci pare d i poter osservare , che piuttosto i l nostro
esemp lare è paragonab i le col l’H amm . p lan i n s ign e Vacek col quale
ha infatti qualche carattere comune, com e l
’andam en to delle costole
,
per quan to si not i che quelle delle H amm . p lan i z: s ign e sono ben si
r iun i te a copp ie , ma fra una copp ia e l’altra sta in tercalate sem pre una
costola sola, d i più si osserva che la r iun ione del le costole,invece d i
effe ttuarsi sul marg in e ombel icale,avv iene assai pr ima, p oco oltre la
m età de l p iano e’che i l nodo d i ciascuna copp ia s i prolunga a guisa
d i var ios verso i l marg ine ombelicale.
Locali tà : Esemplare m ooolto in Val S. Anna F ur lo. Raccolse
G. Bon arelli .
( 10.) H 1 Lnocnnas (ARIET IC ERA89Un snmsn n . f. Tav . VII,fig. 1 4.
Diametro
Altezza d ell’ult im o g iro i n rappor to al d iam etro
Spessore dell’ultim o g iro in rapporto al d iam etro
Ombel ico in rappor to al d iam etro
M odello interno in com pleto mancan do i g ir i intern i , d iscoidale, a
lento avvolg im en to d i sp i ra, om belico am p ie , g i ri costati più alti che
larghi , appiatt it i su i fian ch i, probabi lm ente in numero non m inore d i
sei,a sez ione subrettangolare.
I g ir i portan o num erose costole,43 sull’ ultimo g iro, proverse, d i
r i tte sul fian co,arcuate all ’ avan t i sul passagg io al lato esterno. Il
dorso p iat to porta una carena m olto al ta e due solchi assai profond i tra
la carena ed i l m arg ine esterno formato dall’estrem i tà piegate all
’avan t i
delle coste La conchig lia è concam erata fin oltre ai due terz i dell’ul
t imo g iro. La l in ea lobale p resen ta i l tipo che si r ipete nelle spec ie
del gruppo cui appar tiene la forma descr itta, ma è troppo mal conser
vata per poterne trarre un d isegno d i qualche ut i lità.
Questa forma appar tiene al gruppo dal l’Ar ietic. a lgovian um e del
l’Ar ieti c. r etror s i costa (Opp .) e si avvicina segnatam en te a questo ul
timo ma ne d iffer isce per l’avvolg im ento della sp ira p iù rap ido, e
M. VACEK . N. 30, 1 886, pag. 89, T. X III.
(2) G. Mzszemm. N. 1 7 , 1867—8 1 , p. 46, T. X ,
I. 3.
G. Benzem a N. 5, 1 896, p. 205.
1 54 RIVISTA ITALIANA
quindi per la m inor am piezza dell’ombelico
, per la sez ion e del gi ro piùcompressa su i fian ch i
,e per i l magg ior num ero d i costole, essendo esse
nel nostro esem plare in num ero d i 43 sull’
u lt imo gi ro, mentre l’Ar ie
tic. r etrors icosta (Opp .) non n e presenta che 34.
Per le d ifferenze suesposte ri teniamo che questa forma debba es
sere tenuta separata dallo Il i ldoceras r etrors icos ta, e d ist in ta con n om e
specifico par ticolare .
Local i tà. Val d’ Urb ia (Toarciano super iore). Raccolse G .
Bonarelli.
(1 1 H 1 1.nocanas (Anm r xonnas) CATERINAE n . f. Tav.VIII, fig . 7 9 .
Diam etro .
Altezza d ell’ult im o g iro in rappor to al d iam etro
Spessore d el l’ultimo g iro i n rappor to al d iam etro
Ombel ico in rapporto al d iam etro
M odelle i n terno ben conservato, appiatt ito, con len to avvolgim en to
d i Spira, ombelico am pio, poco profon do, g ir i costati che s i cop rono sul
dorso a sez ion e p iù alta che larga, col mass imo spessore sulla par te
m ed iana dei fianch i .
I g ir i por tano numerose costole,38 sull
’
ultim o g iro, semplici , cia
scuna delle quali por ta a metà decorso una prom in enza sp inosa. Il dorso
è appiatti to ; por ta una g rossa carena fra due solch i assai largh i e del i
m i tat i dall’estrem ità assai proversa delle cos tole . La conch iglia è tutta
concam erata. La l in ea lobals ha i carat ter i d i quella degl i H arp oceras .
C om e r isul ta dal la descr iz ione questo esemplare ha molte afi n ità.
cell’Ar ctic. Algovianum (Opp .) e più coll
’Ar ietic. r ctror s icos ia (Opp .)
se con .—ader iam o l
’
andam en to r etroverso del le costole,lo spessore del
g iro e la p rofond ità dei solch i dorsali ; ma ne d iffer isce essenzialm ente
per avere le costi cin e provviste d i un nodo sp inoso, per cui questa for
m a assum e un’im pron ta tutta prepr ia.
Local i tà . Rocchetta d’
Arcevia.
(1) F. A. Qnavsranr . N. 24, T. 22, t
'
. 28 (tipo dell'
Ar ietic. Algovi anum ) ,
fig. 30 (tipo dell’
Ar ietic . retrors icosta) .
1 56 RIVISTA ITALIANA
Harp ooeras Levison i . WB IGT . M on ogr . the Lias Amm …n i tes , Vol . 37 ,
p . 438, T. IX ,f. 1 2 , T . LX I
,f. 6 - 6
, (esc i
f. 1,
H i ldoceras BONARELLI . Le amm . d el ros. amm . descr . e
fig. da G. M enegh i n i , p . 200.
FUC INI. Cofal. lias . d M . d i Cetona, V,1 905
p . 1 1 3,T. VI, fig 3.
Diam etro
Altezza dell’ul timo g i ro un rappor to al d iam etro .
Spessore dell’ul tim o g i ro i n rappor to al d iam etro
Ombel ico in rapporto al d iam etro
M od ello in terne a len to avvolg im en to d i spira, omb el ico am p io, g ir i
costat i che si to ccano appena, in num ero d i 5,a sez ion e subquadrata. I
g ir i por tano num erose costole , 27 sull’ultimo
,ret roverse , grosse all
’e
s tern o e che van no scom paren do verso i l m arg i ne om be l icale, e sfu
mate sul lobo esterno all’in con tro cei solchi . Il dorso arcuato porta una
carena molto alta e grossa e due solch i largh i ed a8sai profond i . La
conchig lia è concamerata fin oltre ai due terz i d e ll’ult imo g iro Le linee
lobali p resentano l’andam en to t ip ico della specie , e sono m olto ben
conservate .
Questa forma appar tien e all’
H i ldoo. Lev ison i e ne d iffer isce l ievemente
per la ancora m agg iore retrovers ion e de lle sue costole in confron to del
g rande esem plar e figurato da \Y r igh t e per la se z ion e del g iro nel
nostro esemp lare p i ù basse e p iù retòn degg ian te , nonchè per i l m inor
num ero d i costole, essendo esse 2 7,m en tre sulla figura c i tata del M ene
gb in i se ne con tano 29.
Locali tà. Val d’ Urbia. R accolse G . Bonarelli .
H ILDOCERA8 (LILL IA) C nm r ssn n . f. Tav. X I,fig .
Diam etro
Altezza dell’ult im o g iro in rappor to al d iam etro
Spessore del l’ultimo g iro in rapporto al d iam etro
Ombelico in rappor to al d iam etro
Modello in terno ben conservato in un fian co, ed un po’sciupato
n ell’altro, d iscoidale, app iatt ito, a len to avvolg imen to d i epira, con em
DI PALEONTOLOGIA 1 57
belico am p io, g ir i costat i che s i toccano appena, a sez ione subrettango
lare. I g ir i , assai compressi , portano num erose costole,54 sull
’ultim o g iro,
assai pronunciate , d ir itte sul la m età. in terna e falcate sulla m età esterna
del g iro, retroverso,a cop pia, rar issim e quelle semplici , r iun ite al mar
g ine ombelicale, dove al pun to d i r iun ione formano un leggero tuber
colo. I l dorso p iat to por ta una carena alta,com presa fra due solchi lar
gh i e p rofondi , lateralm en te delim inat i da un m argine r ialzato e cost i
tui to dall’estrem i tà. arenata all
’avan t i delle coste suascennatd . Le lin ee
lobali si l im i tano al p r imo quarto dell’ultimo g iro, che nel resto forma
la cam era d i abi taz ion e incom pleta verse l ’ apertura. Le linee lobali
p resentano i l lobo sifonale p iccolo e s tretto,i l pr imo lobo laterale as
sai largo e profon do con tre in cision i term inal i , i l secon do lobo laterale
s im ile,ma molto p iù p iccolo e m eno profon do ; le selle sono poco fra
stag liate , e quella esterna assai larga e b ifida,d ivisa in due part i in e
gual i , d i cui l’in ter na p iù larga.
Questa bella forma si può con fron tare con la L i ll ia com en s is (v .
Buch) alla quale si avvicina per la forma del dor so e per il t ipo
dell’ornam en tazione , ed anche per il poco r icopr im en to dei g ir i della
Spira, d ifl'
erendene tuttavia in m odo eviden te pe r il m inor spessore della
conch iglia, per i l p iù len to avvolg im en to della sp ira, e quind i per la
m agg iore amp iezza d ell’om belico
,se cons ider iamo come t ipiche le fi
gure d i Hauer e la fig . 3 d ella Tav . VII del M en egh in i. E senza dubb io
stret ta la som ig lianza fra i l nostro esem plare e que llo eccez ionalmen te
g rande attr ibui to da Men egh in i alla L illia com ens is figurate alla
T. V, pe l quale anche Bonarelli conserva lo stesso riferim en to speci
fico. La som ig lian za d ipen de soprattutto dal modo d i sviluppo della ep ira,
com e r isiilta dal con fron to fra i valor i ottenuti per le d im ension i pro
porz ionali dell’esemplare d i Suello e d el nostro ; ma se consideriamo i
caratter i dell’ornamen taz ione
,si nota che sui fianch i p iù appiatt iti del
nostro esemplare le costole sono più d ir itte , p iù retroverse e p iù sot
ti li , per cui la fisionom ia del fossi le ap pare notevolm ente d iversa. Ad
ogn i modo sono eviden tem en te troppo accen tuate le d ifferenze d i svi
luppo e d i ornam en taz ione fra la n ostra forma e la L i llia com en s is tipo
per poter le considerare specificam ente corr ispondenti .
G. Mzs semsx. N. 1 7, p. 26, T. VII,f. 3 a. b. e.
G. MENEGIIINI. Ibid ., p. 27 , T. V
,f. 1 .
(3) 0 . Be… . N. 5, p, 201
DI PALEONTOLOGIA 1 6 1
A questa specie del Bonarelli si avvicina per la forma del demo,
per la scar si tà de i nod i e per la stretta som iglianza dei caratter i orna
m ental i dei g ir i in tern i , ma se ne d istingue per le notevoli d ifferenze
ne i caratteri del g iro esterno. In fatti questo g iro invece d i avere come
i l Cod ec. an nu latiform e,le costole d ir itte e regolar i , le presen ta forte
men te preverse, irregolar i e fascicolate , e la‘
sua sezione e p iù depres
sa. Tali differenze si ver ificano an che in confronto della fig. 8 del M e
negh in i , che rappresenta un esemplar e d i d iam etro di poco m inore de l
nostro,ma non completo, man cando esso del per istoma e che pure nel
g iro più esterno conser va imm utata l’ornam en tazione dei g ir i in tern i .
Pare dunque che si tratti d i due forme specifiche realmen te d istin te.
E’anche affi ne al Goel. an n ula tum (Sow ) pel num ero, irrego
lar i tà ed andam ento della costole, ma questa specie , oltre avere le oo
stole m eno proverse e non fasciculate, presen ta d iversa la sez ione de i
g ir i e p iù am p io l’ombelico ; d i gu isa che non è possibi le r iferi rvi i l
nostro esemp lar e . Perciò cred iamo necessar io d i d istinguere questo esem
p iare com e forma nuova.
Local i tà . Buco del P iombo sopra Erba. Raccolse il Prof.Ta
ramel li .
Com.ocanas cor.nnn rroams B e t t . Tav . IX ,fig. 5 8.
Goeloceras colubr iform e. BETTONI . F oss . dom er ian i , 1 900, pag.
tav. VII,fig . 1 0.
F UCINI. Cefal. liase.M . d i Cetona,V.
,1 905,
pag. 294, tav. X LVI I, fig. 1 3- 1 4.
Diam etro
Altezza de ll’
ult imo g iro in rappor to al diam etro
Spessore dell’
ultima g iro in rappor to al d iam etro
Ombelico in rapporto al diam etro
Modello in terno app iattito, con len to avvolgimen to d i spira, con
ombel ico am pio, poco profondo, giri regolarm ente costati,che si toc
cano appena, a sez ione p iù alta che larga, subrettangolare, app iatt iti sui
fianchi . I g ir i in numero d i cinque portano numerosissime cost icin e,alte,
regolar i , sem pre sem pl ici ed assai preverse , con andam ento eguale a
quello di un cordoncin o attorcigliate intorno al g iro. Le costicine sono
ben v isib ili anche nei giri interni . Nel m ezzo del dorso, largo e leg
RIVISTA ITALIANA
germente convesso, questa costic ine descr ivon o una leggera curva pro
versa. La camera d’ab itaz ione occupa tutto intero 1
’ult imo g iro, ma
manca i l per istoma. La lin ea lobals poco vis ib ile per corrosione si può
rilevare incompletamen te.
Questo esem plare appar tiene al gen . Coeloceras per il tipo del la
linea lobals , e per la forma del dorso larga, arrotondata e sprovvista d i
chiglia, si può confron tare col Goelac. croceum var. i nd an ense Mene
gbin i che i l Bonarelli considerò com e speci e a sè,conser vandole
i l nome d i Coeloc in d un ense Ad esso il nostro esem plare
si avvicina per la form a del dorso, per avere le costole sempl ici , per
la magg ior am p iezza dell’ombel ico
,ma n e d iffer isce per la sezion e del
la spira più str etta e p iù alta e subrettangolare , per le costole più sot
ti li, più num erose, p iù p roverse ed affatto pr ive d i nodi al marg ine
esterno, e per avere i l dorso m eno convesso.
Corr isponde invece quasi perfettam en te al Goel. colubr iform e B ett
inquan toche la sola d ifferenza che s i può notare sta n ella larghezza al
quanto magg iore d el suo ombelico e nello spessore d i poco magg iore
dei giri , il che non ci impedisce d i r i ten ere queste forma toarciana cor
ri spon den te a quella dom er iana g ià d ist inta dal Betton i .
Locali tà . Val d’ Urb ia. Raccolse G. Bonarell i.
COLLINA commun e (S o w ) Tav. X,fig .
Ammon i tes commun is . SOWERBY . M in . con ch . vol. II, p . 1 0,
pl . 107 , fig. 3 .
D’ ORBIGNY . Pa l. F r . Ter r . J uras . 1 842 . p .
336 , p l . 1 08.
DUMORT IER. Études Paleon t., Dip . j uras,B ass . du Rh6ne. 1 874. L ias sup .
, p ar t. inf .
pag . 93 , p . X XV,f. 1 -2 .
REYNÈS. M onogr . des ammon i tes 1 878. L ias
sup . p . VIII, fig . 1 3 a 1 8 .
S tep hanooem s commune. WRIGH T . L ias . amm . 1 884. Vol .
X X XVIII, p . 473, pl . LX XX III f. 34
p l. LXXX IV fig . 1 -3 (pl . LX XXVII fig . 9
e 1 0 esclusa) .
G. I … . N. 1 7 , p. 208,'I . XVI, 4.
RM … N. 5. gi g—2 1 1 .
RIVISTA ITALIANA
COLLINA GEMM A B o n . Tav . X,fig .
G. BONARELLI. Osser v. sul Toar c. e I’Alen iano d ell
’
App . Cen tr .
1 893, pag . 1 3 e figure .
I . Diam etro
Altezza dell’ult ima g iro i n rapp . al d iametro
Spessore dell’ultima g iro in rapp . al d iametro
Ombelico in rappor to al d iametro
Modello i nterno mal con servata, app iattito , con lento avvolg imen to
d i sp ira, ombelico molto amp io, p iatto, i g ir i numerosi, sciupati quell i
in tern i , a sez ion e subrettangolare , che s i toccano r icoprendo i l dorso,
por tano num erose costole che s i r iun iscono a copp ia formando un nodo
sp inoso sul margi ne estern e dei fian ch i Da ciascun nodo si d ipar tono
nuovamen te, quasi sem pre, due altre cos t icine che attraversano i l d orso
descr ivendo una cur va proversa. Il dorso, poco convesso
, è pseudo-care
nato. Linee lobali ind istin te.
Questo esem plare per i sopradetti caratter i si può considerare come
var ietà della Colli n a Gemma Ben .,dal la quale d iffer isce per avere le
costole dei fianch i r iun i te a coppia sul m arg ine esterno,m en tre i l tipo
ha le costole sempl ic i su l fianco,le qual i s i biforcano sul dorso dopo
aver formato i l tubefcolo.
Locali tà. Val d’Urbia presso Schegg ia. Raccolse G. Bo
narelli.
II. Diametro
Spessore dell’ultimo g i ro i n rapp . al d iam etro
Al tezza dell’ult im o g iro in rapp . al d iam etro
Ombel ico in rapporto al d iametro
Accennihm o anche a questo esemplare d i Gallin a Gemma Bon . per
chè eccez ionalm en te p resenta due sp in e b en con servate,una sul penul
t imo g i ro e l’altra sul terz
’ultimo, le qual i sono lunghe assai e sottili
,
e si appoggiano sul g iro successivo.
L ’esemplare è alquanto sciupata, ma i caratter i della specie sono
eviden ti .
Locali tà : Piobbico. Raccolse I . Chelussi .
DI PALEONTOLOGIA 1 65
COLLINA ACULEATA n . t. Tav. X I,fig . 4-6.
Diam etro .
Altezza dell’ultimo g iro in rapporto al d iam etro
Spessore dell’ultimo g iro in rapporto al d iam etro
Ombelico in rapporto al d iam etro
M odello interno mancan te de i g ir i in tern i , e d i metà dei gir i estern i ;e app iatti to, con len to avvolgimento d i spira, con ombelico ampio, poco
profondo, g i r i costat i , che s i toccano appena coprendo i l dorso, a sez ione
p iù alta che larga, subr ettangolare , app iatti ta sui fian chi .
I gir i portano numerose costole,che si staccano sem pl i ci dal mar
g ine ombelicale, sono d ir i tte , fin i , e sull’ultimo g iro si riuniscono a tre
a tr e in un grosso tubercolo aculeato.
Sul marg ine esterno d e i fianchi e sul penult imo g i ro si r iun iscono
sim i lm en te m a a due a due . Il dorso è leggerm en te convesso, depresso
fra le due corone d i nod i ed è att raversato da numerose costicine , che
descr ivono una for te cur va convessa all’avant i ; queste cost ic ine si d i
par tono a tre a tre dai nod i,e si d i rebbero la con t inuazione de lle co
stole de i fianch i,ma fra ogn i gruppo d i esse se ne in tercala un
’altra
semplice . Nessuna traccia di linea lobals .
Questo esem plare appar t ien e al gen. Coll ina per la presen za d i
spine , e si può con fron tare coll’Amm . s ubarmatus secondo M eneghin i
( i ), che i l Bonarelli cons id erò com e forma d ist inta sot to i l nome d i
Call. M en egh in i i Vi si avvicina anche per i l len to avvolg imento
d i sp ira, per l’ombelico poco p rofondo e per i g i ri p iatti sui fianchi ,
ma ne d iffer isce per avere le costole dei fianch i r iun i te a tr e a tr e con
un acuieo,men tre nella Coll. M enegh i n i i le costole s ono tutte sem
plici , e dopo aver form ato l’una si e l
’altra no un nodo sull
’estrem ità
dei fianch i,si b iforcano sul d orso, pr oseguendo i nvece sem plici quelle
senza nodo ; ne d iffer isce pure per la sez ione quasi quadrata, m entre
la specie d i Bonarelli la presen ta arrotondata. Per la r iun ione delle
costole in gruppi ai nod i , questa forma meg lio corrisponderebbe al Pe
G. Mzssenxsx. N. 1 7, p . 69
,T. X IV
,f. 6 .
( i . BONARELLI. N. 5, p. 2 10.
INDICE DEL VOLUME X III
1 1 . F o cal"d e l q u."al tr a t to n e i l a vo r i r e ce n s i t i .
Piante . . .pag 5,64
Foram 1 n 1 fer 1 10 l 5, 1 8,
49,55, 57 ,
81 , 84, 107 , 109
Coral 1ari 3, 7 1
Graptoliti 59
Echi noderm i 1,45
Brachiopodi 9,53, 83
Verm i pag. 85
Mollusch i 2 9 60, 72, 77 ,Cefalopod i . . 6
,7,53
Pesci 48
Retti li . 48
Mammiferi 2 , 6 24,48
,54
59, 73,Problematici
l l l . T e r r e n i d e i q u a l i al m eu n e i l a vo r i re ce n s i t i .
8 ilnriano. pag. 59 Cretaceo pag. 3, 58 , 107Devon iano. 5 1 Terziar io 10
,1 5
,18, 2 1 , 24, 26, 57 ,
Carbon i fero 8, 1 4, 1 5, 23, 26 , 49, 84 73, 75
Ferm iamo . 45,7 1 , 84 Eocene 2
,4, 1 6, 2 1 , 48 , 70, 74, 1 09
Trias 9, 52, 53, 60 Miocene 1 , 78, 82Lias 6
,7 , 7 1 , 77 , 83 Pliocene 1 2
,54, 59
Giura 9,1 1
,47 Quaternario . 2
,1 2
,1 3
,56
I V . E l e n c o d e l l e n u o v e fo rm e d e ae r l t te n e l l n vo fl h o l l n n l
aonm inatns Ech inocyamns) pag.. 1
acutisepta ontlivanltia) 7 1
Adel ia (Orbitoides) . 1 07
aegrnm (Coeloceras)ambigua (F1bnlaria)angusta (Montlivaultia)
1 0 RIVISTA ITALIANA
Di alcune Nummuliti e Orbitoidi dell’
AppenninoLigure
Piemontese. M em . R. Acc. Sc. Tor ino, ser . vol. LVI,
pag. 7 1 - 95,tav. I - II. Tor ino, 1 906.
Questo bel lavoro va considerato,a detta dell
’A., qual comple
mento all’
altro del Tellin i dal titolo Le Nummulitidee terz iar ie
dell’
Alta Italia Occidentale. Parte I. ed esso tratta non solo d i
Nummuliti ed Operculine ma anche d i Lepidocicline dell’eccone ed
oligocene di var ie località comprese nel bacino della Liguria e del
Piemonte, ed appartenenti alle raccolte del R. Museo Geolog ico d i
Tor ino e del Marchese G. Rovereto. V i sono descr 1 tte e figurate
queste specie e var ietà
Nummu li tes (Paronaea) Guid i 11 . f.,sub-Gu id i n . t.
,Li nae
11 . f.,sub—Lim e 11 . f.
,Lin ae var. Mar iae n .
,m iocon tor ta Pellin i ,
sub -m iocon tor ta n . t.,m iocon tor ta var . ex z
'
lis Tell.,m iocon tor ta
var . crossa Tell.,Tchihatchejfi D
’
Arch . var . dep ressa Tell.,Tah i
hatcheffi var. Roveretoi n ., Rosai Tell., Rosai var . obesa n .,Bou i lle
'
i
De la Harpe, Bou i lléi var . lax isp i ra n .,vasca Joly et Leym .
,rosea
var . i talica n .,vasca var . tenu isp i ra De la H .
,Boucher i De la H .
,
Boucheri var. var iabi lis Boncher i var . incrassata De la H .,
Tournouer i De la H .,Yournouer i var . lar isp i ra De la H .
,n i tida
De la H ., sub-n i tida De la H .,str iata D
’
Orb. var . p edemon tan a
Tell., striata var . car ros iensis Tell.,con tor ta Deshayes, sub
-Im rien s is
Prever .
Nummuli tes (Guembel iz) : op ercul in iform is Tell.,ep ercul i nifor
m is var. granu lata n .
Nummuli tes (B rugui er ia) F i chteli M ichelotti,F ichtel i var.
Violei n .,F ichteli var . garansens is (Joly et i n term ed ia
D’Arch .
,in term edia var. borm iens is Tell.
Op ercu lina camp ionata (Defrance), camp ionata var . granulosa
Preeer i n . t., Prerer i var. elegans n .,F ormai 11 . f.
Lep idocyclina : d i latata (M ichelotti), d i latata var. Schlumberger i
(Lem. et M an telli (Morton), Rau lm i Lem . et Douv .
Passando sopra al poco posto dato in esso al dimorfismo Spec i
Boll. Soc. Geol. It., vol. vn , pag. 1 69-230, vm . Roma, 1888.
DI PALEONTOLOGIA
mòsio, a Timau e alla Forca Morarèt. Una cartina al segna
i l limite mer id ionale della trasgressione secondo I’
A. ; le altre 3 fig.
documentano i fossili della Forca Morarèt. M . GOR'
I‘ANI.
V1NASSA ne Rsex v (P.) A proposito della esistenza del Colm nelle
Alpi Carniche. Rem i . R. Acc. Lincei, (5) XV , sem.
, p .
647 -49. Roma 1 906 .
Il dott . K r a u s e in una recente comun icaz ione (vedi Pubblica
zion i estere) r isollevo la questione dell’
esistenza del Culm nelle AI
pi Oarn iche, la quale, dopo i lavori del Ta r am e l l i,del G e y e r .
del V i n a s s a e del sottoscr itto, pareva ormai interamen te r isolta in
senso negativo. Il prof. V m a s s a,esaminando gl i argomenti avan
zati dal K r au s e,li cr itica m inutamente
,d imostrando che almeno
una parte degli scisti r ifer iti dall’
A. tedesco al Colm,appar tengono
invece al Carbon ifero super iore in trasgressione sulla ser ie silur ico
devon iana. M . GOR'I‘ANI.
Il .
RASSEGNA DI PUBBLICAZIONI ESTERE
Der su J. Sur l’identità absolue de Nummul i na p r i s t i na
Brady, et de Nummul i tes var i ola r ius , Lmk., et sur son
ex istence dans des depots tertiaires néo- calédoniens. An n .
Soe. Roy . Z ool. Maleo. Belgi que, vol. X L, pag. 1 7 - 22 .
Brux elles,1 905 .
Certe rocce della Nuova Caledon ia furono er roneamente assegnato
dal Piroutet al carbon ifero,
avendo questi determ inato in esse per
Fusn line delle Ortofragmine, la Num nm li tes p r i.vtina Brady , la
quale ultima già dal 1 898 si sapeva attr ibuita per circostan za affatto
16 RIVISTA ITALIANA
fortuita, ma ad ogni modo inesattamente, a tale periodo, mentre è
terziaria. Il Deprat, ricordati i fatti, s
’intrattiene sulla N. p ristino ,
della Nuova Caledonia, che ha potuto studiare nel materiale del Pi
routot,
ed in seguito a desiderio di questi : descrivendolo. e compa
rondnla,ne ricava l
’
identità tra essa (forma megalosferica) ed il tipo
specifico (pure forma megalosferica), e d’
entrambi alla Nummuli tes
var iolar ia Quindi l’identità di altra Nummulite della
Nuova Caledonia (forma microsfer ica), che con la prima costituisce
una coppia dimorfa, alla N . hcber ti d’
Arch. per cui v iene a eon
statere la presenza nella supposta formazione carbonifera neocaledo
n iese,della copppia N . voriolor io N. heberti
,la quale, se da sola
basterebbe a defin ire un livello dell’
eccone, a maggior ragione, es
sendo anche accompagnata daOrtofragmine (le credute Fasuline), Num
muliti identiche a quelle dei depositi eocen ici di Giava, Operculine,
e Litotamn i,e la prova sicura dell
’eoceno
L’A. fa poi la cr itica agli altri supposti rinvenimenti di Num
moliti preterziarie, e cioè carbon ifero, giurassiche, e cretacee, pur
ammettendo la possibilità della comparsa del genere verso la fine del
cretaceo. A. SILVESTRI.
Da mn J. Les depots éocénes Néocaledonions ; leur analogie avec
ceux de la Sonde. Description da deux espboes nouvelles d’Or
bìloi’
des. Bo ll. Soc. Geol. F rance,ser. vol. V
, pag. 485
5 1 6,fig. A
-F,tav . XVI—X IX . Paris, 1 905.
Dopo la parte stor ica sull’
eoceno della Nuova Caledon ia, per
errore del Piroutet preso in precedenza come carbonifero, e la topo
grafia della formazione, il prof. Deprat fa conoscere lo studio petro
grafico delle rocce di cui questa consta,e quindi la descrizione dei
fossili seguenti
Nummuli tes boguelensis I Verb.,bogoelensis II Verb., Naug
goulon i Verb., voriotor io h aber ti,Jogiolcor toe Mart.
Or thophrogm ino umbi licoto n . sp.,umbi licoto var . Four
n ier i n ., j ovana Verb. var . m inor Verb.,cfr . sella (D
’cfr .
d isponso cfr. var iano (Kaufman n), n ummuli tieo ?
pentogonolis n . sp., stella loneeoloto
DI PALEONTOLOGIA 1 9
gica ; ci limiteremo quindi a far conoscere che l’argomento trattato
r iguarda la distribuz ione di Rizopodi reticolari nel luteziano, barto
uiano,sannoisiano
,stampiano, aquitan iano e burdigaliano di Borneo,
e vi sono aggiunte notizie analoghe sulle Celebes, su Giava,1’
Isola
Natal,Sumatra
,la Birman ia
,il Sind
,e l
’Arabia. Tale distribu
zione è poi riassunta in un quadro, dov’è messa in confronto con
quella di forme affini d’
altre region i ; ne riproduciamo qui la parte
per noi più interessante, e che rifer iscesi a Borneo, la Francia, I’I
talia, ecc.
Bonsso : Or th0p hragm ina j ocono , 0 . omphalus, O. stellato
Heterostegino retico la to N ummuli tes biarr i tx cns is .
FRANCIA : Or thophrogm ino d iscus, O. stellata Heterostegino re
ticu loto Nummu li tes biorr i tx ensi s.
v zzm : come per la Francia.
BARTONIANO.
Bensen : Or thop hrogm ino p rati i Opercul ino cfr . ommon eo .
FRANCIA (Cote des Basques) : Or thnphrogm ino p rotti Nummo
li tes con tor ta .
Bensen : Orbi toli tes mar tin i ; Op erculino camp ionato Hetero
stegino retic olato Nummuli tes sobbrongn ior ti .
FRANCIA (Biarritz) : Nummuli tes i n termed io.
STAMPIANO.
Bonomo : Lepidocycl ino formoso Nummuli tes subbrongn ior ti .
SINI) : Lep idocyclino Nummuli tes subloevigoto.
ALABAMA : Lep idocyclino man telli ; Num nm ti tes.
AQUITANIAZVO.
BORNEO Lep iclocyclino i nsuloenotolis, L . formoso Heterosteg ino
margor i toto Sp iroclyp eos commun is,S. p leurocen trolis ; Cyclocly
p ens comm un is ; Alveolino.
PANAMA (San Juan) : Lep idocyclin o chap er i .
FRANCIA (Aquitan ia) : Lep idocyclino d i latato.
ITALIA : come per la Francia.
BURDIGALIANO.
BORNEO Lep idocyclino tournouer i , L. sumotrensis M iogypsino
0p erc nlino n iosi .
28 RIVISTA ITALIANA
S o p ra a lcun e fo rm e te ra to log ic h e d l Fib u
Ia r id i d e l m lo cc n c m e d io d e lla Sa rd egna .
NOTA DEL DOTT . G. CAPEDEB.
Tempo fa, essendo occupato in uno stud io sulle F ibular idi del m io
cene m edio, che ho raccolte a m igliaia d i esemplar i a S. Gavino a inare
presso Perte ter res, ebbi da osservare in mezzo a quei num erositsim i
ind iv idui , che in parte nel ci tato lavoro ho determ inato,delle ferm
'
e te
ratologiche interessan ti sotto d iversi punt i d i V i sta.
M en tre molti si occuparono g ià d i forme teratoleg iche di Echino
derm i , per quan to è a m ia conoscenza, r isulta però che finora nessuno
ebbe ancora. a descrivere form e fossi li mostruose d i F ibular id i ; d’altra
par te è noto quanto gli Autor i eb bero a dich iarare nei loro scr itti pe
limorfe parecchie specie. Per cui se la posiz ione d el periprocto e del
l’apparat o ap icale sono ancora i m igliori caratteri spec ifici, la posizione
d i quegli organ i può nond imeno subire non lievi spostamen ti, che pos
sono trarre a notevol i confusion i , e che a parer m io, sono molte volte
i n d ipendenza di fenomen i teratologiei e però in quei casi d i nessun
valore specifico e generalmente solo r i levab ili in seguito a m inute esa
me. Perciò p sr portare qualche con tr ibuzione alla conoscenza del valore
specifim dei var i caratteri fra loro d ipenden ti , g iud ico opportunoI que
sto lavoro e degno d i ogni studio p iù accurate le forme teratologiche
d i questi p iccoli esseri , per potere apprezzare nei dovuti lim it i questi
caratteri e poter con adatta. comparaz ione rilevarne i rapporti e laloro
importanza.
Alcun e mostruosità,appena. accennate, interessano soltanto la {
Jorma
generale , determ inandosi soltanto uno spostam ento dell’
apparato ap i cale
del peristoma o del per iprocto ; questo in non poch i casi , possono ingenerare error i essendo molte volte d i ffici lmente r ilevab il i ; altre mestruo
sità. p iù profonde interessano lo sviluppo degli ambulacri , altre infine
F ibulorid i del m iocene m ed io di S. Gavino a mare Boll. Soc. Gi o1.
It., 1 906, Vol. XXV, fasc . III.
se RIVISTA ITALIANA
r ipor terò i l d iagramma ( i ) dell’apparato apicale sul quale soltanto e
possib ile d i fondare la discussion e , essendo la sua s truttura prim iti va,
da cu i d ipende, come si vedrà, lo svi luppo degl i embulacr i non solo,
ma d ipende altresi la forma tutta dell’ech inoderma.
Le teratolog ie r iscon trate sono apparentemen te determ inate da. tre
diverse cond izion i ; perciò d iv idero per maggior ch iarezza la trattaz ione
nei tre seguen ti paragrafi
a) Eccentr ici tà abnorme dell’apparato apicale all
’ innanzi o
lateralmente.
b ) Eccentricità dell’ apparato apicale all’ indietro.
e) Incomp lete svi luppo dell’apparato apicale.
ECCERTRICITA ABNORME DELL’APPARATO APICALE
F requen tissima è lo deformazione della faccia super iore del guscio
d i m olte forme d i E ch in ocyam us dovuta alle spostarsi dell’apparecch io
ap icale irr egolarmente a destra ed a sinistra dell’asse an tere postc
r iere , innanz i ed ind ietro. Lo spostamento all’ind ietro determ ina l
’
i n
cur varsi delle zone ambulacral i par i poster ior i d i questo fenom eno però
par lerò nel paragrafo seguen te. Lo spostamen to al l’innanz i è un caso
ben frequen te e può parere carattere specifico, simulando m olte volte
ferm e nelle quali tale spostamen to e carattere costan te e non accidentale .
Lo spostam en to a destra ed a sin istra dell’asse an tere—
poster iore, qual
che volta deve considerarsi come carattere fissate n ella specie , ma i l
p'
ù soven te è soltan to accidentale indetto da un fenomeno teratoleg ice.
C esi I’E . um bono tus Pemel , è sem pre ben caratter izzate dal l
’ec
cen tr icità appena accennato. in avan ti dell’apparato ap icale m en tre nel
l’E . d ecliv io Pemel,l’
eccentric ità in avan t i , qualche volta straord ina
r iamente spinta, dev’essere considerata come fenomeno teratolog ico avendo
trovato alcun e form e n elle quali 1’apparato apicale è affatto centrale .
Lo spostamento laterale è frequente e quasi la regola nell’E . p oly
morp hos Cap.,ma l
’osser vai pure n ell’ E . S tuder i S iem .
, ne ll’
E . p y
r'
form is Ag , nell’E . decliv is Pom el , nell
’
E . p seud oumbonatus Cap .
Queste forme appaiono sghembe verso destra e verso sin istra, come
Nel già citate lavoro F ibulor id i del m ico. della Sardegna, 1 906, per
agevolare lo studio e la comparazione della struttura dell'
app. apicale del‘e d iverse
forme,ho preposto di rappresentare con d iag ramm i quegli apparati , proiettando i
diversi pori su di un piano equatoriale e collegandoli poi tra di loro con rette che
valgono a determ inare la loro relativa posizione.
DI PALEONTOLOGIA 3 1
fossero state sottoposte ad una pression e laterale che le avesse defor
mate .
L’ec cen tr ici tà dell
’apparato apicale determ ina sem pre l
’assottigliarsi
del marg ine dal la par te del decl ivio vhs d iven ta d i necessità p iù lungo
e p iù dolce, e l’
ingrossarei d i esso dalla parte opposta, come pure lo
spostarsi , nel medesimo verso. del peristoma e del per iprocto. Per cu i
v ien fatto d i doman dars i se I’E . d ecliv is Pomel, I
’E . tw en ti nus Lam ,
1 ’ E . p olymorp hus Cap che pur hanno fra loro caratter i d ifferenziali ,non fossero al caso form e teratologiche d e ll
’E . ambon atus Pom el , la
forma p iù s immetr ica. che ad essi si av vicin i e le differ enze, ri tenute
sin qui specifiche, non fossero indotte che dalla loro mostruosità .
Eocnmr axcrrA DELL’APPARATO APIC ALE A'L
’INDIETRO.
La osser vai in un solo esem plare , che è però assai interessan te
perchè s im ula assai bene una spec ie normale , m en tre non rapp resen ta
secondo m e, ch e una forma teratolog ica im possibile a determ inare
,s ven
do I’eccentri c i tà indot ta una fisionom ia tut ta spec iale per l
’incurvarsi
deg l: am bulacr i par i , an ter ior i e poster ior i .
La sua forma è subrotonda, (fig. a con torno un
po’
irregolare , la faccia super iora convessa, la in fer iore
p iana. Somm ità am l>ulacrale m olto eccen tr ica verso
il margine poster iore . Area ambalacrale anter iore d i
r i tta, molto aperta p iù larga delle altre ; aree ante
F ic. EW M _
rior i par i con elegante curva a convess ità r i volta in
( Va nn a.
ad are e am avanti,aree par i poster ior i dopp iamente i ncurvate ad
bulaca n i n cu rvate .
S col la con cav ità. in avan t i pe l solo tratto della stel la
ambulacrale e colla convessi tà per la r imanente zona. Le aree ambula
oral i pos ter ior i fortemen te in curvate in alto, avvic inate e convesso, fanno
abbassare 1’area in terambulacrale impar i poster iore che s
’ in iz ia perc iò
d iet ro all’apparato ap icale con una forte depr ess ione. Z one por i fera for
m ate d i por i eguali , rotond i , in file d i r it te e d ivergen t i , non r iun iti da
solco, alcun i d i ess i sono v isibi li anche sulla faccia in fe r iore fino al pe
ri stoma. Z one i n terpor ifere larghe q uan to due por ifere . Aree in terambu
ora li stret te,r un—e rrate dalle am bulacrali , coper te sulla facc ia super iore
: la tuberco li scm b icolati,allineat i in elegan t i file sinuose , d iverg f n ti .
Sulla faccia i nferiore i tubercol i sono p iù rad i e sono pure all ineat i in
file con vergen t i al pe r istoma. Peristoma grande, poligonale, cen trale ;
RIVISTA ITALIANA
Pesc i te rzia r i d e l la reg io n e Em i l ia n a.
NOTA DEI. DOTT. G. G. BASSOLI.
De i pe sc i d el terziari o m od enese si sono occupat i i l Copp i ( 1 0) che
pubb licò un b reve cata logo d i q ue l li da lui r in ven i1 t i,
e i l Pan tauel l i
(30) che fece un o stud io esaur ien te d e i l ) ieden : avendo determ inato l’ab
bon dan te m ate r iale d e i M use i d i Mod ena e d i Regg i o credo ut i le puh
b li care un catalogo r iassun t ivo per tutta la reg ion e Em i l iana, in c luden
dov i que lli parz ial i pubb l icati da B ian con i,Cape ll in i , Bom b i cc i , Vinassa
d e Begny , Ne l l i pe r i l bo logne se ; da ( far rarol i e da l sse l (che deter
m i nò i M y liohat'
i d i ) per i l pun n en se e i l p iace n t in o ; da C opp i e da Per
ret t i per i l m od enese e i l regg iano .
Le determ inaz ion i d i Ferre t t i son o alquan to d ubb ie e dove m i è
stato poss ib i le le ho rett ificate . Alcun i dei pezzi de l M useo d i Modena
son o g li stess i che hann o serv i to a Cocch i pe r i l suo c lassico lavoro
sui pesc i Lab ro id i .
NOT IDANL'
S GRISEUS G m e l i n Bassan i ( 1 7 ) p rovò che tutte le
d i verse spec ie ist i tu i te da Law ley (3) sono da r ifer i rs i a questa . La d ott .
M . Pasquale (3 1 ) rett ificò secondo le regole d i p reced en za i l n om e del
1’
auto re . Un d en te b en con ser vato : ce net te maggi ore fin issimamen te se
gh et ta to al marg in e an te r iore , conett i m i nor i ord inatam en te d ecrescen t i .
M on teg ibb io ex -col l . Guana, F e ssetta. Copp i Mon tegazzo . Ferrett i
P ian togna , Bacedatsco , Tab ian o . Carrarol i Rio sto . Vinassa .
N . PRIM IGEN IUS A g . F ramm en to d i den te a corrett i tozz i,
e
guali . Lugag nan o e x —co ll . C o llin e Bo logn es i . Bom b icc i , Vinuesa.
C ARC HARODON M EGALODON A g .
'
l‘
ren taquatt ro d en t i caratter i
st ici , un o d e i q uali m i sura mm . 1 1 1 d i larghezza per 1 43 d i alte zza.
M o n teg ihb io , Sam on e,Pan tan o ex —co ll . P ie tra d i B isman to va
,Carp i
n e t i . M useo d i Regg io M on te Baran zone . C opp i Pan tano,M on te
gazzo , M on teg ibb io , Co ll i p iacen t in i , Carp ine t i , S . Ruffi no . F errett i
Maiat ico , M iano . Car raroli Mae ign o d i Porre tta. Ne ll i Coll ine Bole
gn es i . V ina—xsn,Cape l l in i , Bom b icc i , Bian coni .
38 RIVISTA ITALIANA
Questo den te alto appena 20 mm . è acut issim o,a rad ice molto r igonfia
nel m ezzo della quale è ben v isib i le i l foro nutr it izio ; ha due co n ett i
late rali quasi vert ical i p icc ol i e m olto aguzzi . Quell i d i Reggio son o d i
assai maggior i dim en sion i . Mon tegibb io , Gianca eur—col l . (Lamm :
Mon tegibb io , Rio Can tone , Guana. Copp i Piacen t in o. Carraro li .
C . HOPE ! A g Form a slan ciata , corona tondeggian te alla base,
margin i affilat i che n on arr ivan o mai sin o al la base,ma si arrestan o a
m età d el den te e anche p r… a bel li ssim o uno del M . d i B . che seb be
n e non in tero m i sura mm . 25 per 9 per 8 . M outeg ibb io , M on tese ex: -col l .
P . d i B . M . d i R. M on tegazzo . F er rett i .
O. CUSPIDATA A g Faccia in terna della corona in teram en te l i
sc ia ; margin i affi lat i che n on sem p re arr ivano sino alla base ; corna d i
var icate : 5 d en t i . Mon tegibb io ext -coll . P . d i B . M . d i R. M on
tese , M on te Baran zone , Nic io la. Copp i Bacedasco . Carraroli .
O . VOBAX L e H o n T iola. V inassa.
O. CONTOBTIDENS A g Forma generale p ross im a a Oryrhiaa da
cui si d ist ingue per le caratte r ist iche str iature della faccia in terna. M on
tese , Castellarquato , Lugag nano exc—coll . Seguenza pon e n el la sinon im ia
d i questa spec ie la Leman acutissz'
ma d i Ferrett i (i ) Pliocene bolognese .
Vin assa.
OXYBBINA HABTALIB A g Sin on im ia r icch issima causata dal la
d ifferenza gran de d i forma che passa tra i den ti a seconda del posto che
occupano nella bocca. Servendom i d i con fron t i con v iven ti e de lla be l
liss ima fotografia d i De Alessand r i , che r invenne n el m iocene d i Alba
un ammasso d i den t i qu asi indubb iamen te del lo stesso in div iduo , pote i
determ inare an che la posizion e d i quasi tutt i i 47 d en ti d i questa spe
cie possed ut i dal Museo . Notevoli tre cen trali che sen za rad ice raggi un
gon o m in . 52 per 41 per 1 1 . Per la notevole larghezza e per la p resen za
d i p rofonde p ieghe che solcano la facc ia esterna dovrebbero essere r ife
r i t i a p licati lis , ma questa specie è st ata r iun ita all’hastalis : la sin
golar i tù d i quest i den t i m i fa r i tenere che la p licati lis dovrebbe con ser
varsi almeno com e varietà . C ian ca,Lugagnano , Caste llarquato , Chero
,
Mon teg ibb io , Mon tese , Guig l ia, Rio Rocca ex: -coll . P . d i B . M . di R.
Fossetta , Guana, Mon te g ibb io. Copp i Fossetta ,Mon tegazzo , Viano ,
S. Romano . F erretti P iacen t in o . Car raro l i Riosto,Belpoggio , B ian
cano , S. Loren zo , S. Giorg io , Maiola, Casalecch io , M on te Vaglio, Casa
b ianca. V inassa Coll ine bolognes i . Biancon i .
O. DEBOB II A g F requente , fac i lm en te r icon oscib i le per la for
ma snella,la facc ia interna rigonfia e l
’esterna p iana , la rad ice spessa.
DI PALEONTOLOGIA 39
a corna d ivar icate . 23 den t i . C ian ca, M on teg ibb io , Rocca Malat ina ex -coll .
P . d i B . M . d i R. M on tegazzo ,S . Ruffino
, Carp i n e t i , M on tebab
b io . F errett i M on teveglio . Vinass a.
O. SPALLAN Z ANI B o n A questa sp ec ie fu r iun i ta la 0 . Agas
siz i d i Law ley . Gian ca, Cas te l larquato , M on tese ex -coll . P . d i B .
M . d i R . P liocen e b o logn ese . V i nassa.
O. CBASSA A g For ma bassa e t ozza , rara a trovars i in te g ra .
Mon tegibb io ,Pan t ano
,Carp in et i ex -co ll . P . d i B . M . d i R. Stra
m on te , Caste l larq uato . Car rarol i S . Loren zo . V inassa.
SELAGHE AUBATA v B e n ( Cetorh in us) P l iocen e parm . Carraro l i .
HEM IPRIB'I‘IS SERRA A g C inq ue d en t i caratte r i sti c i , g rossolana
men te seghettat i s o ltan to n e l la parte in fer iore . P l iocen e (i ) ex -co ll .
P . d i B . M . d i R. M on tegazzo . F er re tt i .
GALEOCERDO EGERTONI A g Den t i r icurv i e to zzi a fin i ss im a
seghet tatura lungo tutto i l m arg ine : la rad ice sv i lup pata m ost ra i l fo ro
nutri t iz io . M on teg ibb io , Lugagnano , Cas te l larq uato , C he ro e x —c o l l .
Mon teg ibb io . Copp i M on tegazzo . F er ret t i Bacedasco , S . V i tale . Car
raroli .
G . M INOR A g . P iccol i den t i aguzzi a base al largat i s s ima e
marg in i fortem en te seghet tat i pm da un a parte che dall’
altra p resso la
base . M on tegibb io ex -co l l . id . Copp i Mon taguzzo . F e rre tt i (G . m i
wcimus) .
G . ADUNCUS A g Den t i cort i e largh i a facc ie l ievem en te con
vesse,r icurv i
,ti na1 nen te segh t3ttat i lungo i l m arg in e an ter io re : fo r te se
ghettatura d i gradan te lungo i l poster iore . Lugagnano ex: —co l l . M on te
gazzo . F er rett i (G . Ia tidcas) M ulazzan o,S . V i tale . Carram l i .
G . CAPELLINII L a W M on tegazzo . Ferrett i Col lin e bo lognesi
Bomb icci .
G . PANTANELLH L a w Reg istrato dal solo F e rrett i a M on te
gazzo . Noto che i l G . P an tanclln era stat o da alcun i autor i iden t i fi cato
F errett i ci t ò a M on tegazzo (Mod us Law lcyi Bass .,( ) tod ns sulcatus
Sisn 1 . Otod us hasta lis Law . Bassan i aveva n e l 7 7 c reato l’0 . Law lcz, i
poi l’aveva ri un i to a Lamaa sa len tina C . m a De Alessan d r i Se
guen za (28) e lo s te sso Bassan i ( 1 6 ) r icon obbero l’n len t 1 t 1 d i ta le sp e ( l e
con 0.vyrh ina Desor i i Ag . Seguenza d i ce che l’
( ) tod ns su lca tus n o n
è altro ch e un d en te laterale d i 0 .1:yrh ina , so lo che p resen t i d ue p i c
cole p ieghe ai lati d ella base de l la corona ch e p osson o essere s cam b iat e
p er cusp id i accessor ie e affe rm a d i avere r iscon trato tal e an omal i a
nella bocca d i una Ox . Sp allan zan i pescata a M ess in a ; questa osse r
vazione è con fermata da Bassan i stesso ( 1 6) p . 2 1 .
RIVISTA ITALIANA
c ol Go lem: caais Bon . Altr i invece la r i tengono buona specie : non aven
do esem p lari non posso farmene un con cetto esatto .
CARCH ARIAS EGEBTONI A g P iccol i den t i tr iangolar i app iatt i t i ,
m inutamen te seghettat i . C ian ca, Lugagnano, p lioc . in genere ex —col l .
Mon tegazzo . Ferretti (P r ioaodoa subglaucus) . Bacedasco . Carraro l i
Z ola Predosa. Vinassa ( (J. etruscus) .
C . BABISULCATUS S i s m Piccol i den t i tr iangolar i a base al lar
gatissima,a seghettatura quasi impercett ib i le , p rovv i sti d i rad ice bassa
e largh issima. M on teg ibb io ex:—col l .
GLYPHIS UBCIANENSIS L a w (i ) Mon tegazzo . F errett i .
SPHYRNA PRISGA A g M an tegazzo . Ferrett i Casalecch io. V i
nassa.
SQUAT INA D’ANCONA! L a w Den ti caratteri stic i a facc ie r igou
fie , p rovv ist i d i rad ice grossa , sporgen te dal lato in terno e p ian egg ian te
infer iorm en te così che i den t i i solat i posson o stare in posizion e eretta .
Lugagnan o cx —coll . Mon tegazzo . F errett i Baced asco . Carrarol i .
MYLIOBA'I‘ES mousr w us 1 s s e l Grosso framm en to d i p iastra den
tar ia che m isura mm . 32 per 6 1 . Spessore an teriore mm . 1 7 posteriore
mm . 1 8 . La cur va d i sutura e sin uosa e r isen t i ta . L’esemp lare d escr i tto
d a Issel è alquan to maggiore , m a i rapport i sono eguali . Den ti m ed ian i
d i mm . 52 per 8 ; lateral i d i mm . a 8 per 3 a I r i liev i ra
d i cal i d i stano da mm . 1 a ve n e son o 37 scaglion i , i den ti late
ral i n e man cano . Il pezzo è cen trale in fer iore . Mon tegibb io ex'
coll .
M . STBOBELI I s s Estrem ità term inale d i p iastra den taria
superiore . Den ti p i ù b rev i e m aggiorm en te r icurv i d i q uel l i de l la spec ie
p receden te : la p iastra è p i ù arenat a ed ha i l caratter i st ico aspetto cra
q uele. Dim en s ion i d el la p iastra mm . 2 7 per 23 p e r d en t i m ed ian i
mm . 3 1 p e r 7 lat eral i mm . 7 per p er r i l iev i rad ical i a mm .
scag l ion i 33 , an ch e in questa man cano i r i l iev i sotto i d en t i lateral i .
C ian ca ex co l l . Mulazzan o . Carrarol i .
M . GRANULOSUS I s s Un frammen to d i den te i so lato e due
den t i un it i, p rovv isti de i r i l iev i rad icali . Questa assegnazione è dubb ia
cau sa i l catt ivo stato d i con servazion e . Lugagnano ex —coll . Baced asco
Car rarol i .
M . PLACENT INUS C o s t a Pl iocen e parm en se—
p iacen tino . Carra
M . APENN 1NUS C a r r . Pliocen e parmen se —
p iace… in o . Carraroli .
M . ANGUSTIDENS S i s m Bagalo . Copp
42 RIVISTA ITALIANA.
Chero , Castellarquato ex: -coll . P . d i B . M . d i R . Fossetta ,M on
tegibb io , Tagl iata,'
l‘
iep ido . Copp i M on tegazzo . F erretti Bacedasco .
Carraroli Be lpoggio . V inassa Col l . bologn esi . Bomb icc i Sp haew odus
p arvas
Paon t nus aqmram ous D e 1 f Mon tegazzo . Ferrett i F errett i
c i ta questa spec ie senza d ire , come sem pre del resto , che avanz i abb ia
trovato : è notevole che d i questo gen ere non si sono trovati avanz i ch e
al M on te Bolen : in M useo esiste un magn i fi co oto l ito ch e corr i spond e
all’attuale P . b ud cgassa .
Bnacm ar ucnus r anmrmos rms v B e n Z en zano,T iep ido .
Copp i
SC IAENA SPEC IOSA K o k L’ Umbr ian P ecch io ln d i Law ley è
m olto prossima a q uesta d i cui n on si trovan o che oto l i t i : credo che
per non essere stat i n ot i i lavor i d i K ok en e per la som igl ian za grand e
d el le due specie alm eno alcun i deg li otoli t i d i Copp i , d i Ferret ti e d i
Carrarol i sian o da r i fer ire a questa spec ie 26 oto l i ti in M useo .
Scu m u (Umnam u) Paccm omr L a w . Mon teg ibb io . Copp i
Mon tegazzo . Fer rett i Bacedasco . Car rarol i .
M EB LUC IUS BOSNIABCK II L a w Ques ta spec ie fu fondata sop ra
den ti : Copp i d ice d i avere ri n ven uto d egl i otoli t i ! Sarebbe in teressan te
sapere com e abbia potuto stab i l ire la corr ispondenza d egli un i coialtr i . In Museo sono parecch i oto li ti da. m e determ inat i n el m io lavoro
speciale su d i essi ; n on m i è poss ib i le con trollare a quale d i quest i cor
r ispondan o quelli d i Copp i .
Lanu s CRA8810AUDA Collin e bo lognes i . Cape llin i in Bom b icci .
Opere citate in questa nota
1 . BIANCONI G. G. Cenno stor ico sugl i studi geologic i ecc . Atti Soc .
Ital . d i Sc . Nat . Vol . IV M i lan o 1 862 .
COCCH I I . Nuova fam ig lia d i pesci Labroid i F iren ze 1 864.
LAWLEY R. M on ografia del gen ere Not idan us Att i Soc . To
scana d i Scien ze Naturali vol . II fasc . 1 Pi sa 1 87 7 .
Nuov i stud i sop ra i pesci F i renze 1 87 6
Quattro m emor ie s0p ra resti fossi li P i sa 1 878.
Nuovi den t i fossi li d i Not idanus Pisa 1 87 9 .
Stud i com parativ i sui pesc i Pisa 1 88 1 .
Issnt. A. Cen n i sui Myliobat id i terziari An nali Mus. Civ ico
vol. X Genova. 1 87 7
DI PALEONTOLOGIA 43
9 . COPPI F . Del terreno tab iano modenese Boll . Com . Geologico
n . 8 e 4 Roma 1 880.
Paleon tologia modenese Modena 1 881 .
BOMB ICC I L . Mon tagne e
'
vallate ecc . Bologna 1 882 .
FERRETT I A. Il m iecene reggiano mod enese Reggio Em .
1 886 .
Il p l iccen e reggiano m od enese Reggio Em .
’
1 886 .
BASSANI F . Itt iol it i m iocen ici Napoli 1 89 1 .
Avan zi di Carcharod on aur iculatus Verona 1 895 .
It tiofauna de l calcare d i Gassino Napoli 1 899 .
Il Not idanus griseus ecc . Atti Soc . d i Se . Fis . e
Mat . fasc . V Napol i 1 901 .
Avan z i di pesci p l ioc . d i Toscana Mon . Z ool . anno
X II n . 7 F iren ze 1 901 .
DE ALESSANDRI G . Con tr ib . allo stud io de i pesci te rziar i To
r ino 1 895 .
Ricerch e sui pesc i foss i li d i Par anà Tori no 1 896 .
Avan zi d i Ox y rh ina hastal is M i lano 1 897 .
La p ie tra da Can ton i d i Rosignano M em . Soc .
Ital . d i Scien ze Nat . vo l . VI fasc . I M i lan o 1 897 .
Appun t i d i Geolog ia d e i d in torn i d i Acqu i M i
lano 1 901 .
Su alcun i i ttiod on to li t i Att i Soc . Ital . d i Scienze
Natural i vo l . XLI fas c . 3 M i lan o 1 892 .
No te d’l tt io log ia foss i le ib id . fasc . 4 M ilano 1 903 .
CARRAROLI A. Avan z i d i pesc i foss i l i d el Parmen se e P iacen t ino .
Ri v . d i Paleon t . Ann o 3,fase . III e IV . Parma 1 897 .
V 1 s .1 ssa DE Rnox r P . E Pesc i n eogen ic i de l bolognese
ib id . an no V . fasc . 3 . Bo logna 1 899 .
SEGUENZ A L . Vertebrati fossi li della p rov . d i Mess ina parte
Pesc i Roma 1 900.
NELLI B . Foss i l i m iocen ici d e l m ac igno d i Porret ta
Soc . Geo l . vo l . X X II ann o II,Rom a 1 903 .
I’ AN'
I‘
ANELLI Sul Diodon Se i l lac Mem . R. Acc . d i Se .
Let t . ed Art i ser ie Il l . vol . I , Mod ena 1 903 .
PASQUM .B M . Rev i s ione d e i Se lar ian i foss i li Napo l i 1 90
BASSOLI G . G . O to liti foss i li te rziar i Riv . d i Paleon t . An no
X II f. 1 , Perug ia 1 906 .
DI PALEÒNTOLOGIA 63
don t tout le développ emen t, ce son t en autre des Hétérostég ines où
la lame sp irale est subd ioisée dans la région du bouton , don t elle
p rodu i t ains i la p roluberanoe
b) c i l semble p reférable de lim i ter ee gem e aux Hétérosté
p i nes à sp ire embrassan te et à lame sp i rale subd ivisée dans la ré
gion da bouton
c) Je p ropose d’oppeler H e t e r os t eg i n a d
’
Orb. ton ies ‘
les formas où la lame sp i rale reste simp le dans la region du bou
ton, que la sp ire soi t embrassan te oa non
Questi ultimi partiti ci sembran buon i,ma il criter io della lama
Sp1 role suddiv isa o no e sfor tunatamente d iffici le ad applicarsi. e
pertanto gradire'
mmo fosse trovata la correlaz ione con la configu
raz ione esterna, nummulitoidc od operculinoide, del n icchio. Ad ogni
modo,non sarà inutile far presente che Sp i roclqp eus segna il pas
saggio da h eterosteqi na ad un complesso d i forme cicliche,ora iso
morfo ad Or thophragm ina ed ora a Lep idocyclina ,cui abbiamo im
posto il nome d’Orbi toolyp eus ne è probabile esempio la Orbi
toides aspera del Giimbol.
Chiude la nota la descr iz ione dello Sp i roclypeegs gran ulosew n .
sp., di Pr iabona.
Eccellenti son le figure che corredano 1’
ottimo testo,dalle quali
risulta anche l’
abilità come preparatore del Boussac ; e ciò c i fa spe
rare una buona serie d i lavori da parte sua,degni della fama della
scuola francese. A. Su.vasrm
Boussac (J.) Sur la formation du réseau dos Nummulites réticu
loss. Bu ll. Soc. Ge'
ol. F rance, ser. vol. VI, pag. 98
1 00,tav. III. Paris
,1 906.
Può considerarsi questo scritto qual continuazione del precedente,
e difatti v i è ripreso lo studio sull’
orig ine'
del reticolo nel n icchie
delle Nummuli tes estendendolo alle specie i n termed ia, laevigata,
Non comprend iamo perchè gli scienziati francesi modern i abbiano voluto
cambiar d i sesso alle Nummul iti ; .ci sembra che la filologia e l‘
uso, e soprattutto
questo, non lo consentano.
66 RIVISTA ITALIANA
Fo rm a i ta l ian a
d e l la L ì n g u l i n a i m p r e s s a Î c rq ucm
Non DI A. SILVESTRI.
Il gen ere L ingulina d ’ Orb ign y , secon do gli autor i mod ern i , è per
m e ibr ido al pari d i q uel lo ch'
essi ch iam an o Nodosar ia Lam arck
se r imon t iam o al la sua or igi n e , lo trov iam o così d efin ito :
Logos cnrp i lées ou sup c 1p osées sur un seul ax e bout à bout, soi t
qu’elles de
'
borden t ou non cn se recouvràn t p lus ou moins la téralc men t
p oin t de sp i ra le
Les coqui lles son t toutes comp osées dc p ar ties oi treuscs
p lus ou moins cassan tes ( l ) .
Ouver ture en fon te et term ina le, logos recouvran tec, test dep r ime sur
ses faces
E questa descr izione r iman e poi com p letata dal r ich iam o che fa i l
d’Orb ig ny al suo m ode llo num . 26 ed al le figure N (tav . X C IX ) ,
E ed F (tav . CVIII) , e P (tav . X II) d e l So ldan i d i cu i però le E
ed E van no scartate perchè in com pat ib i l i con la d escr izion e stessa ; ed i n
vero non r iguardano L ìngul in e , m a Vulvul in e, p erc iò ad esse n on ad d i
cesi i l n om e d i L ingulina Solda n i i im p ostov i dal d ’ Orb igny
sibben e l’altro d i Va len tina soldan i i (d
’sinon imo d i Vulvulin a
p ennatula (Batsch ) .
Ora n on occorre spon da paro le , b astando i l con fron to accurato delle
relative i llustraz ion i con le sudd e tte d escr iz ion e e figure , e col m od e l lo
2 6 d el d’Orb igny , p er parte d i ch i legge , affi n chè sia m esso i n ev iden za .
come le cosidette L ingulinae : car inata [d’Orb .] B rady f uroi lla ta
Be rthe l in r ed iviva Bar th . sl i ttata Bar th . limbata M i lle tt
p agoda M i llett ecc .,abb ian o p oca affi n i tà gen er i ca e tra d i loro e
con le Lì ngul in e d el d’Orb igny . M a l
’esemp io che passo a trattare con
vi n cerà. an cor m egl io sull’ibri d ism o d el gen ere L inguli na, auc torum
72 RIVISTA ITALIANA
K ing:, Streblop ter ia pusi lla Schlth.,Str . ser icea Vern . , Str . subre
tzm da n .,Posidon iella p ssudogibbosa n .
,Posidonomya in cer ta n .
,
Gervi lle ia ell ip soidalis n .,Macrodon str iatum Schlth.
,M . K ingia
n um Vern.,Nucula Beyr i chi Schlth.
,M yop hor ia subtr igonata n .,
Sch izodus truncatus K ing.,Sch . p inguis Waag.
,Sch . Schlotheim i
Gein .,Edmorulia so lcata Phill.
,Ed . filigrana Kon .
,Allor isma ty
ralease St.,All. cfr. elegans K ing.
,All. To mquisti n .
,All. Stachei
n .,e Lozanema cfr. Ph i llip si How . che provengono dalle marne do
lomitiche sottostanti agli strati con Voltx ia che contengono : Sp ir i
gera biparti ta St., Dielasma elongaium Sohlth. e Naticops is m in i
ma K ing. V .
Bru-:sr (E.) Calcari nummulitici e Nummulites dell’Ascolano.
In (senza numero e senza indicazione della Tipografia) .
Ascoli Piceno, (9 marzo) 1 907 .
Fa menzione i l ragioniere Brest d i due forme litologiche del
e periodo numroulit ico nell’
Ascolano, e cioè d i un calcare bianco,
sem i-cr istallino,esistente sotto il Monte Polesio (e dell
’Ascensione) ,
e d’un calcare bruno esternamente, rossiccio nell
’
in terno,arenaceo
che si r inviene a Torre di Visso,Monte Gardesa, Fosso d i Falloppa,
Matera,Pizzo d i S ivo
,Macereto
,Fonte delle Trecche (Vettore) ecc.
,
ambedue contenenti molte Nzw mm l i tinae.
Di queste egli dà una lista piuttosto copiosa, ma la quale è evi
dentemente derivata da un lavoro del conte A. Spada Lavin i e del
prof. A. Orsin i, che rimonta al 1 835 per la qual cosa,e pe l
fatto d’
aver compilato questi la propr ia lista or iginale, complessiva
mente su materiale del Gargano, della Maiella ecc.,essa non può
esser tenuta in molta con siderazione. Il tipografo l’
ha poi arrich ita
di tal i error i di stampa da render la in alcuni punti pressocchè in in
telligibile ; p. es. la Nummu li tes carp en ter i D’
Arch . et Haime,vi
e stata convertita in N. charp en tier i Haime
Quelques observations géologiques sur les Apennins de l'
Italie centrale
Bull . Soc. Géol. F ranca, ser . vol XII. Paris,1 835.
80 RIVISTA ITALIANA
Side l‘
t t' '
dalforma eperculinoide
ro es 1pe m i )
Arnaud iella
eterosteginoide (semmsciuta)
ferme cicliche
Binderina (tipo del Omp halocycluscampan iano di Bel
ves,in Francia)
Lep iderbi teides (tiposocial is)
Or th0p hragm ina
forma eperculinoide (da iden tificarsi )
eterosteginoide M iogypsina
ferme cicliche
(da iden tificars i) Lep idw yclina
(tipe burd igatens i3 ) (3)
marginata)
d i latata)
Questa dmivaziene è dubbia, date 1’
apparate embrionale, d'altra
per ora non ci sembra sia da attribuirsi al Poly .trem
Ramo fi n qui geologicamente non provato ; esistendo, deve chiamarsi Le
p id ocycli na (str .Esiste certo questo ramo di forme lepidoc icline, ne è solo dubbia la con
tinuazione nei tipi marginata e d ilatata , poichè qualora vi sia pure il ramo d i
simil 1 ferme alle stesso live llo e delle stesse coppe d i Or thophragm ina (v. avanti ),i due ultimi tipi indicati vi debbono essere trasportati , ma in allora le Lepidoc i
cline derivanti[’
da M iogypaina vanno rinomi nate in Miotep idocyelina .
DI PALEONTOLOGIA 85
riunisce in una sola, indottovi dall’
esomorfia,r iconosciamo una grande
uti lità,teor ica e prat ica, in questo suo nuovo studio, il quale se
mai lascia un poco a desiderare sotto il r iguardo delle tavole, buone
ma dall’ingrandimente troppo piccole e di conseguenza inadatte
mettere in sufficiente ri lievo i particolar i strutturali , pure bene in
dicati nelle ottime preparazioni di cui 1’
A. si e giovato, come attestano
le stesse fototipie.
A. SILVESTRI.
Douva H . Perforations duos a des Annelides. Comp . Bend .
Sommai re des Se'
a1 w es de la Soa. Geol. de F rance,11 . 7-8
,
1 907, pag. 57 .
Il signor Deuv illé ha studiato parecchie perforazien i dovute ad
anellidi. Ricordate che nell’
elvezianc del Portogallo il Cheffat ha
trovato perforazien i in forma di U,e che delle analoghe r invenute
dal Lissen nelle quarziti del Perù sono state riferite a Tigi lti tes da
Meunier-Chalmas, i l Deuvi llé osserva delle perforaz ion i a U in una
Ostrea edu lis attuale,e su consiglio del Giard e del de St. Joseph ,
rigonosce che sono dovute ad una Polydora. Aggiunge inoltre che
esiste un altro organismo, attribuito ai Taon urus da Saporta e Marion
e dal Dew alque, i l quale per sua forma a U è d i certo un anellide
prossimo alle Polydora, ma avente d imension i molto più grandi , i l
suo tubo oltrepassando i 1 0 mm . di diametro, e propone per esso il
nome generico di Lissmzites , il cui tipe sarebbe il L. Sapor tai Dew .,
e che comprenderebbe i l L. Pan escorsei Sap. et Mar . del trias, e il
L. u i timns degli stessi del m iocene d’Alcov . Al signor Deuville è
sfuggito che io ho trattate le stesso argomento dandone una dif
fusa bibliografia e segnalando parecchie perforazioni d i Polydora
dovute a d iverse specie ; in quanto a Lisson i tes mi sembra un
nome inutile, perchè v ivono delle Polydora che hanno dimensioni
molto notevol i come la P . concharmn degli Stati Uniti , e la stessa
P. kop tara dei nostr i mari scava un foro che raggiunge i 5 mm .
Paleon tot. Ital ica, vel. VII, pag. 2 19, 1 901 .
DI PALEONTOLOGIA 93
Qui com e ne i bac in i lign i ti fer i d i Poggio d e l la Cava e d i M ic ia… »
pure n el Pe troiese , com e in pane cch i luogh i de lla p rov in c ia d i S iena
(d in to rn i d i S iena, d i S . M in iato ,d i C h ius i ) s i ver ifican o i n tercalazion i
d i sed im en t i d’acqua salmastra o d o lce a d epos i t i d i o r ig i ne sch ietta
m en te m ar i na.
Queste alternan ze d i strat i mar in i con q ue ll i p i ù o meno sal
mastr i s i sp iegaron o con success iv i ab lm ssam c n t i e so llevam en t i , per
cu i era poss ib i le a te r re n o abbassato , l’in vas ion e d e l 1 n are ed i l depos i
tars i d i mate riali e d i avanz i o rg an ic i in es so c on te nuti , m en t re co l l’e
m ersion e c iò che p r im a era fon d o mar in o v e n iva al lo sc operto , potend o
i n segui to col con corso d e lle acq ue do lc i , con vert irs i in bac in o salmastro
e in palud e .
Per alcun e c i rcostan ze i l De -Ste fan i e i l Pau tan e lli han no in
terp reta to d iversam en te tale fen om en o , e ipo tes i lo ro , alm en o pe r al
cun i s trat i salmast r i de l Senese a» p iù attend i b i le . Ess i op inaron o che
ne i go lfi ,la poca p rofon d ità d e l m are , la fr eq ue n za de lle iso le e la d o lce
pend en za d i esse , favo r i'
a l ’ in c lus ione d i s tagn i e la fo rmaz ione d i la
gun e . Ques te separate dal m are d a d une e s im i li in s tab i l i apparat i l i to
rali, p otevano ven i re i nvase dai flutt i mar in i , e le acq ue r iman evano
p i ù o m eno salm astre .
Que l le palud i o bac i n i e rano d un q ue allo ste s so l ive llo d e l m are e
separate so lo da esso da d une o da p laghe sabb iose p iù o m eno es te se ;
perc iò tan to i depos i ti m ar in i q uan to q ue l li salmas tr i d e von o esse re
con s id erat i com e due fac ie s e te rom e s t ic he d i un’
un ica e tà p l iocen ica .
Gli strat i che s i d epo s i taron o in q ues te am p ie lagun e appena s alma
stre son o d ett i appun to S tra ti Lc ran tin i n om e che fu p ropos to dall’Hoch
ste tter pe r ind icare g li stat i a Palad in e d e l la Slavon ia e ch e venn e a
dot tato e app l icato agl i strat i d i tut to i l bac ino darm b ian o e d e ll’Arc i
pe lago . Si è d imostrato che e ss i n on rapp resen t avano n e l l’Arc i pe lago un a
età d i st in ta , e che tutt’al p iù s i p otrà ch iamare con ques to n om e una
fac ies d’acqua dolce o leggerm en te salmast ra d e l Pl iocen e
,com e s i i s
r iscontrato i n, Ital ia. Ne l bac in o d e l ”marb io,
n e lla par te occ iden tale
d ella Ruman ia n eg l i s trat i a palud in e s i t rovan o i l .Il . ar r em cusis e I’E.
Da-e n nx Molluschi continentali pliocen ici. - ltti della Soc . d i Sc .
'
at., Pisa 1 888.
Pann a… Dei terren i terz iari intorno a S iena. At ti dell’
Acc . dei
F isiocrit , Serie III, Vol. 1 , fase . VIII, Siena 1887 .
94 RIVISTA ITALIANA
m er id iona lis Il Petro ies e in quest’epoca cost i tuiva per la magg ior
e sten sion e , un estrem o lembo l i toran eo i n vase dal M ed i te r ran eo , e n el la
sua parte se t te n tr ionale form ava un golfo in cu i erano racch iuse palud i
e bac i n i con te n en t i acq ue p iù o m en o salmast re , n ei q ual i s i accum ula
rono in o lt re i n g ran d e q uan t i tà avan z i d i p ian te te rrestr i , che d iede ro
luogo a st rat i d i l ign i te che v ien e an cora ogg i scavata ed usata com e
com bust ib i le .
Ne lle arg i l le pm 0 m en o m arn ose,
n e i calcar i , n e l le arenar ie d e i
d epos i ti m ar i n i d e l Pe tro iese abbo ndano i gen er i Ostrca , Anom ia, F iabe !
lip ecten , Aequip ecten , lll od io la , I ’ectun culus , Ven us, Te lli na , Chenop us ,
fhclicon us ecc . Ne i bac in i salmast r i in paro la racco lsi in vece le seguen t i
sp ec ie
l . Card ium edule . L . 8 . Stm'
atella tulmrcn la ta v . granu
2 . Turbo subangula tns B roch . lesa Bon .
3 . Tur r i tella tr icar inata B r . 9 . Cer i thinm vulgatwm Brug .
4 . Nematurella sabca r ina ta Bon . 1 0 . do liolum Bora.
5 . P er ingia p rocera M av . 1 1 .
°
P thycop otam ides tr icinctus B r .
6 . I ’c r iagia aim e Pen n . e . p scudo 1 2 . P o tam idcs nodosop licatum Horn .
s tagna lis De — S t . 1 3 . Ne ssa M aycr i Be ll .
7 . J[ elunop sis fianmm la ta Il e — S t . 1 4. Nossa bollenensis T ourn .
Quest i foss i l i ap par isco po i in n um ero stragran d e bast i d ire che
i so l i gusc i d i ('
u rd i um , Turbo , Tur r i tella , l ’otam ides, Nassa
ecc . accalcat i e t'
ran tum ati i p iù , cos t i tu i scon o con poca arg i l la d eg l i
strat i fino a 1 0 cm . d i spessore , in te rcalat i ai ban ch i d i legn i te . V i è
ino lt re un cal are marnoso fr iab i le, g ial lo b ian ch icc io st ipato d i sott i li
e frag i l i con ch ig li e d i Nema turclla , P erengia , M c lanop sis e n on mancano
d e i fi lar ett i d i m ar n e b ian castre , sp ec ie d i tr ipo l i , g rem it i d i gusc i d i
X ema turella , Str ia tclla e d i valve d i (‘ip r is a rap p resen tare i p er iod i d i
perman e n za d i ac q ue m en o salmas trc o «mas i d o lc i .
Lo sch e le t ro c co lo s sale m amm i fe ro g iaceva,e g iace an cora in
par te , in m ezzo ad un lmn c o d i l ig n ite e d’arg i lla , n eg li S t rat i Levan
t in i salmas t r i d e l Canap in o a 25 un. c irca dal la sup erfic ie ed a poco
p iù d i 7 0 dall’
ing resso d e l la galle r ia.
G l i strat i com e l i ho potut i vede re al p r in c ip io d el la gal ler ia , ap
par i scon o i n sez ione dall ’ alto al basso con quest’
ord i ne
De-Srsn m Les terrains tortiai res du Bassin du Mediterranée. So c .
Géolog. de Belg iqtac.
96 RIVISTA ITALIANA
esse 3 m etr i . In queste la c ircon feren za m in ima d i cm . trovas i a
35 cm . dalla p un ta . C redo p erc iò d i po te r sup p orre che g l i in c is i v i d e l
l’i nd iv id uo da m e esam inato
,abb iano ragg i un to una lun ghezza non i n
fer iore a q ue l la d e l p r imo esem p lare d i Ca’d e
’Bosch i .
I d en ti m olar i sp len d idam en te con servat i , han n o lo smalto in tat to
e lev igato , e d i es si es i sto no i d ue ul t im i in fer ior i e l’ult im o supe r io re
destro Il m o lare supe r io re d est ro e com p le to e con serva inoltre
due lunghe rad ic i p oss ied e c in q ue c opp ie d i con i (manunel lon i ) con
tubercol i in te rcalat i e un ta llon e . ed ha le seguen t i d im en sion i
Lunghezza m ass im a mm . 1 90
Larghezza alla p r im a copp ia d i con i 85
al la quar ta cop p ia d i con i 7 3
al ta l lon e 5 7
C om e ind icano le m i sure , i l d en te va gradatam en te restr ingen dos i
dal l’avan t i al l ’ ind ie tro fino al tal lon e .
Questo che e com p os to d i d ue grupp i d i tuberco l i laterali , term ina
br uscam en te a d ango lo o ttuso .
Il grado d i logoraz ion e d e i con i va d im in uendo dag l i an ter iori , co
m e q ue ll i che p r im i en tra rono in funz io n e , ai pos te r ior i , ed è maggiore
in quel l i s ituat i dalla parte i n te rna .
Difatt i i con i in te rn i an te rior i m i surano un’alte zza dal co lletto del
den te,d i mm . 34
, gl i este rn i d i mm . 5 1 . In vece i l con o in ter no del la
quar ta cop p ia è alto 52 mm . e q ue l lo e ster no d e l la terza e d i mm . 58 .
L’ultim a c opp ia che d ista an cora parecch io dal p ian o d i logorazion e m i
sura una altezza d i‘-1 4 mm .
Il M ;; in feriore s in i stro è in com p leto man can do d e l tal lone . Le d i
men sion i de lle sole c inque copp ie sono,le seguen t i
Lunghezza i am 1 96
Larghezza alla p r ima copp ia d i con i 7 2
alla te rza 7 6
al la qu in ta 65
In questo com e n e l l ’ altro M ;; in fer iore d estro la parte m ed iana d el
den te e p iù slargata, e i con i d e lla m e tà esterna han no sub ita magg ior
erosion e d i q uel li d e lla m e tà in terna. C os icche m en t re i con i ester ni
m ed i sono r idott i a 32 mm . d i altezza ed a mm . 36 g li estrem i, quell i
s i tuat i dal l’al tra parte con servan o l
’altezza m ed ia d i 46 mm .
È pure incomp leto i l M ;; in fer iore destro e manca de lla seconda cop
p ia di con i .
DI PALEONTOLOGIA 1 03
Principali pubblicazioni di Benedetto Corti ( l890— l903)
1 . Breve nota sul quaternar io ed i’
terren i recenti della Valsas
sina e alta Brianza. Boll. Soc. Geat It., vol. IX,fasc.
Roma,1 890.
2 . Congerie erratica di Valle Venina. Corr ier e della Dome
n ica. Tip. Cavaller i ; Como, 1 89 1 .
3. La mancanza di diatomee fossili in alcune argille e marne
calcari del bacino d i Pian ico. Tip . Cavalleri ; Como, 1 89 1 .
4. Ricerche micropaleontologiche sulle argille del deposito lacu
stre-glaciale del lago di Pescarenico. Boll. Scien tifico, anno X III,n . 3 e 4. Pav ia
,1 89 1 .
5. Sulle diatomee del lago del Palù in Valle Malenco. Boll .
Scien tifico,anno XIII. Pavia
,1 89 1 .
6. Sulle diatomee del lago di Paschiano. Boll. Scim tifico
anno X III. Pav ia,1 89 1 .
7 . Sui fossili della Majolica di Campora, presso Como. Nota pre
ventiva. Rend ic. R. Ist. Lamb. Sc. e Lett.,ser. vol. XXV ,
fasc. Mi lano,1 892.
8. Sulla marne di Pian ica. Osservazion i geologiche e m icropa
leon'
tologiche. Rezzd ic. R. Ist. Lamb. Sc. c Lett.,ser . vol.
XXV,fasc. pag. 20 e seg. M ilano
,1 892.
9 . Foram in iferi e diatomee fossili del pliocene di Castenedolo.
Rend ie. R. Ist. Lam b. Sc. e Lett., ser . vol. XXV,fase. 1 5
“
e Mi lano,1 892 .
1 0. Sulle d iatomee del lago di Varese. (In collaborazione col
dott. ANGELO FIORENTINI) . Boll. Scim tz'
fìco, anno X IV . Pav ia,
1 892 .
1 1 . Sulle torbe glaciali del Ticino e dell’
Olona. Ricerche micropa
leontologiche. Bolt. Sci en tifico, anno X IV,n . 1 e 2 . Pavia,
1 892 .
104 RIVISTA ITALIANA
1 2. Ricerche micr0paleontologiche sulle argille del deposito la
custre-g laciale del lago di Pescarenico. Boll. Soc. Geol. l t., vol.
X, pag. 69 1 -7 1 6
,tav . X X Roma
,1 892 .
1 3. Il terreno quaternar io di Valle Intelv i. Cor r iere della
Domen ica ; pag. 1 4. Tip . Cavaller i ; Como, (agosto) 1 892 .
1 4. I terrazzi dell’
Olona. Carm'
ere della Domen ica ; pag.
Tip . Cavalleri ; Como (agosto) 1 892 .
1 5. Foram in ifer i e radiolar i fossili delle sabbie gialle plioce
niche della colli na tra Spicchi o e Lim ite sulla sponda destra dell’Arno.
Boll. Scien tifico,anno X IV
, pag. 6 1 -70,1 tavola. Pavia
,1 892 .
1 6. Foram in iferi e d iatomee fossili delle sabbie gialle plioceniche
della Folla d’Induno. Boll. Soc. Geol . It.
,vol. X I pag.
223v 230. Roma,1 893.
1 7 . Osservazion i stratigrafiche e paleontologiche sulla regione
compresa tra i due ram i del Lago di Como e limitata a sud dai laghi
della Brianza. Boll. Soc. Geat. It.,vol. X I ; pag. 99
,1 carta
geol. Roma,1 893.
1 8. Supra una marm itta dei giganti in valle di Cosia. Boll.
Club-Alp ino Ital. pag. 7 Torino,1 893.
1 9. Sul deposito v illafranchiano di Castelnorate, presso Somma
Lombarda. Rendtc. R. Ist. Lamb. Se. e Lett.,ser. vol. XXVI
,
fasc. pag. 26 . M ilano,1 893.
20. Diatomee delle Acque Al bule. Boll. Scien tifico,anno
XV ; pag. 7 . Pavia,1 893.
2 1 . Appunti stratigrafici sul miocene Comense. Nota preventiva
Boll. Scien tifico,anno X V ; pag. 8. Pavia
,1 893 .
22. Diatomee di alcun i depositi quaternari di Lombardia.
Boll. Scien tifico,anno X V
,11 . 3. Pavia
,1 893.
23. Di alcuni depositi quaternar i d i Lombardia. Rendùc. R.
Ist. Lamb. Se. e Lett.,ser. vol. X XVI
,tasc . 1 7 ; pag. 5 .
Milano,1 893.
24. Sul bacino lignitico di Lombardia. Boll. Scien tifica,anno
XV,11 . 3 ; pag. 8. Pavia
,1 894.
25. Sopra due nuove specie di fossili infraliasici. Boll. Scien
tifico, anno XV ; pag. 8,con tav. Pavia
,1 894.
Anno XIII.
RASSEGNADELLEPUBBLICAZIONI ITALIANE
CHEGCBIA Rrsrou (G.) e Gam m a (M .) Prina nota sulloOrbitoìdi
dal Sistema Drotaooo della Sicilia. Giorn . di Se. Nat. ed
Econ .,vol. XX VII ; 1 907 .
Da parecchio tempo il Prof. Di Stefano e il Dr. Checchia-Ri
spoli scrivono su quel terziario di Termin i-Imerese
,che ha sollevato
recentemente tante discussioni per i l suo r iferimento cronologico. In
questa nota,che ha lo scopo di dimostrare come certe forme di Or
bitoidi appartengano alla Creta e non al sop rastante Eocene, Checchia
Rispoli arrende nuovamente in campo, e, insieme col Dr . Gemmellaro,
illustra un certo numero di Orbitoid i s. str . e di Lep idocicline cre
taciche. Le forme descritte,e illustrate assai bene in due n itide ta
vole, sono 9 ; di esse 7 appartengono, secondo gli autor i , al genere
0 rbz'
taides s. str ., e 2 al genere Lep idacycl ina. Tre d i esse sono forme
conosciute,sei sono nuove (Orb. Add is , O. panarm z
'
tana,0 . s im la,
0 . euraeens is,Lep id . senan iana
,L . bayhar iensz
'
s) .
Gli autori insistono sul fatto che i ] r inven imento di Lepidocicline
nella Creta autorizza a r itenere che delle forme appartenen ti a tale
genere possano trovarsi anche nell’Eocene, . ciò che venne sinora ne
gato da parecchi . Appoggiandosi all’autorità d i Douvillé H .
,il quale
a Biarr itz avrebbe recentemente rinvenute delle Ortofragmine nella
scaglia cretacica,tendono poi a dimostrare che i d iversi gener i
delle Orbitoidi non sono limi tati ad un’epoca geologica determ inata,
come si vorrebbe da molti. Noi fummo i primi ad insorgere contro
questa tesi , quando essa ven ne enunciata da Schlumberger e Don villé,
molto prima che quest’
ultimo mutasse opin ione, e quindi conveniamo
1 10 RIVISTA ITALIANA
Le fac ies faun is tich e d e l M io ce n e Î o r in eSe
NOTA DEL PROF . FEDERICO SACCO
Dopo che s i è comp lessivamen te sgrossato lo stud io della Fauna ter
z i ar ia d c l Bac in o m ed ite rran eo,e si passa ora ad una sua anal i si un po
’
p i ù m in uta,sem pre p iù ch iaro appare com e
,oltre al l
’im por tan za che su
ta le r iguardo han n o nat uralm en te i d iversi p er iod i 0 p ian i d el la ser ie
te rz iar ia, gran d e in te resse p resen tano pure le d iv erse fac ies faun i st iche
co l legate con spec ial i am b ien ti , con certe profond i tà, con determ inat i
d ep osit i , ecc . Anz i ogn i giorno p iù c i accorgiam o come tali facies bat i
m e t r iche,o sim i l i
,abb iano talora
, en tro certi l im it i , maggior valore che
n on lc fac ies d i rc i cronolog iche , tanto che n on d i rado spec ial i fac ies,
par t ic o lari…-n to d e i fond i tranqu i lli fangos i , q uasi si r ipetono , o si pre
s c n tano m o lto s im i li in d ivers i per iod i geologi c i success iv i .
Su q ue s to r ico r ren ze faun ist ich e . corr i spon d en t i a r icorrenze d i am
b ic n t i analogh i i n pe r iod i geo log ic i d ifferen t i,ebb i g ià a dare varn
e sem p i n c l le C on s id e razion i generali d e l m io lavoro sui Illal lnschi ter
m r i d c ! P iemon te e della L iguria, Vol . X X X ,1 90-l»
, pag . IX e X IX
fur c o an ch e r isaltare n el la m ia Nota sap ra La questione com iaeon ica
de ll ’ App en n i no , 1 906 g li even tual i error i d i at tr ibuz ion e cronolog ica
ch e p osson o d e r i vare da una troppo r ig ida app l icazione de l cr i te r io pa
leon tolog ico , se n on s i t iene con to suffi c ien te d el le mod ificazion i che su
d i c sso p uò p rod urre i l fattore hat ime tr ico od altro s im i le .
\'
i d’a ltra par te d eves i esage rare n e l c r iter io op p osto ,
coll’attr i
bu i rc c io è a sc n np l ic i d i ffe ren ze d i fac ies le d iv i s ion i che furono fat te
nc l la sc r ic te rz iar ia, q uand o tal i sudd iv i s ion i
,com e p . es . que lle segnate
w ] a g t* l l t * d c l Bac in o d e l P iem on te
, per quan to co rr i spon d en t i nata“
rln w n tc a ( l i ll'
c i°
c n zc d i fac ics , l i to log i'
a e qu i nd i faun i st ica,m ostrano
.i c l nm d o p i ù ch iaro cd asso luto d i cor r i spon d ere p ure a v er i p ian i ,
s o tto p ian i , c ro n o lcig ic an i cn te d is t in t i c rego larm en te successiv i .
DI PALEONTOLOGIA
P h o l l d o p h o r u s f a c c l î f.
n e i Ra lb l lan o d i C azzaso in C a v i.
Non nx MICHELE Gomu x
( Con tav . II )
Ne i fossi l i corn ic i i llustrat i fin ora. i p e i « n n
tan to da un p iccolo den te d i Colobod u . rì x. r en zzn
d i Sezza La scaperta d i una bella i1 t ì o ìm
G . B . F ac c i ha ora t rovato sop ra Cam -n.
tologi co ha quind i una certa importnnn p i
m er ita una n ota particolare .
L ’ i ttio l i te fu raccolta sul ven u m
dalce d ella tavoletta Tolma n
mare , e p rec isam en te v icino .S
che da o ltre m ezzo secolo in
zaso vecch io , la sua campagna e .
‘
I l .
—lon na ver
. i i l S i tutta la
a 35 verteb re
c in fer ior i sono
re i corp i ver te
l i‘
,son o scompars i
assolute dell ’ esem
360esim i somatic i .
360esim i 360
1 04
7 2
7 6
32
56
24
1 1 8 RIVISTA ITALIANA
I] fossi le ven n e m esso i n r i lievo dagl i agen ti atm osfer ic i sul la su
perfice e rosa d i uno sc is to calcareo b i tuminoso n ero , e g rig io este rna
m en te . Gl i ossici n i d e l p esce , d i un n ero p icco luc id o , si d isegnano in
m od o netto e p reci so sul fondo gr igio d e lla rocc ia. Iv i s i n otan o pure
qua e n. d ebol i tracce d i alt r i in d iv id ui , ma non tal i da pote rn e r ica
vare qualche par ti to.
I p esc i tr ias ic i fi nora con osc iut i son o in n ume ro re lat ivam en te es iguo ;
e n on può q uind i m erav ig l iare ch e a n essun o d i ess i m i s ia r iusci to d i
r ifer i re l’esem p lare stud iato Per d eb ito d i grat i tud in e ded ico al suo
scop r i tore la sp ec ie che ho d ovuto i sti tui re,e che ora passo a descr ivere .
PH OLIDOPH OBUS FACC I I n . f. T av . Il,fig . 1 .
Pesc iol in o d i p iccole d im en sion i , d i fo rma generale slanciata, con
a magg iore al tezza n el te rzo an te r iore , rap idam en te assott igliato in ad
d ietro . L’altezza m assima (raggiun ta po
co oltre 1’in serzione delle p in n e
pettoral i ) è uguale ai c irca de l la lunghezza totale del corpo. In que
st’ul tima e com p resa tre volte e m ezzo la lungh ezza d el la testa, e c inque
vol te la sua altezza, che è appena. in fer iore a que lla d el tron co .
La testa ha con t orno irrego larmen te tr iangolare , ad angol i ottusi ;
i l lato poster iore è con vesso ; i l super iore un po’
s inuoso,
“
concavo
in avan ti ; l ’ in feriore leggerm en te arcuato,
con p revalen te con vess ità
all ’esterno . Il m uso è lungo , ottuso ; la fron te s i m ostra r istretta fra
gl i occh i ; la lin ea fron tale forma un angolo d i 1 50°con q uella del dorso .
Sulla mascella i nfer iore s i n otano an cora tre den t i m inut i,con ic i
, ap
pun t it i , d ispost i in una uni ca ser ie . L’orb ita sub ci rcolare , relati va
men te p iccola, c in ta da sottorb i tali , è si tuata n e lla parte super iore
del capo , a ugual d istan za dai m arg in i an teriore e poster iore d i esso ,
notevolm en te p iù in al to d el paras fenoide i l suo d iam etro e compreso
quasi sei volte nella lunghezza del la testa . Il fueoperco lo è ob lungo
tr iangolare , con i margin i laterali sionati ; l'
operco lo subtron cato al
l’ap ice in fer iore , poco p iù alto che largo, a lat i quasi rett i li n e i ed in ter i .
Di tutte le p iano la sola robusta e la dorsale,
relat ivam en te bene
sv i luppata, composta d i otto ragg i robust i,n ettam en te v is ib i li . Si tuata
in cor r ispon denza d ell’in tervallo fra le p inne ven trali e l
’anale ha i l
raggio an teriore in ser i to appena in avan t i d ella m età d el corpo, a
mm . dal l’ap ice del m uso
,e l
’ultimo a mm . 1 2 dal l ’ in serz ione del la
p inna. nodale .
Quest ’ ultima e forcuta, composta d i circa 1 0 raggi p r in c ipal i per
ciascun lobo. Esternamente si hanno da amb i i lati 5 o 6 ragg i semplici .
1 20 EN ISTA ITALIANA
mm . 360esim i 1 72
38 304
dall’ap ice del muso 26 208
delle p inne2 1 1 68
1 00
La forma descr itta ha vari caratter i del gen ere Lep tolep is, che già
l'
Ag a s s i z osservò essere in m olt i casi d iffic i lm ente d istinguib i le da
P holidop hor us. Ma la posizion e d el la p inna dorsale , che non è opposta
alle ven tral i , e la p resen za de i den ti re lativam en te robust i , sono suffi
cien t i per r ifer i re sen za esitazion i i l n ostro esem p lare a. quest’ult imo ge
n ere . Si not i pure che i p iù an t ich i Lep tolep i s son o de l L ias super iore ,
m en tre i l gen ere P holidop horus è g ià. noto in m olti g iac im en t i c lassic i
del T r ias sup er iore : in fraraib l ian i , com e a Besan o e Per ledo ; raib l ian i
in fer iori, com e a Raib l ; de lla Dolom ia p r in cipale , com e a Gifi
‘
on i,See
feld e Lum ezzane .
Lamassima parte dei Fol idofor i si d istinguono dal nostro per un carat
tere essen ziale : la forma quad rangolare e le d im ension i m olto m aggi or i
d e l le sq uam e . T ra le n um erose spec ie d i questo gruppo , i l solo P holidop hom s
B ronn i K n e r fu trovato n eg li strat i i tt iol i t ic i d i Raib l. Esso ha ben
poch i caratte r i com un i co l n ostro esem p lare , che s i av v i cina m olto d i
p i ù al P h . p us i llus Ag a s s . Quest ’ ult im o ha però i l capo in propor
zione m olto m in ore , g li occh i p iù grand i , la p in na dorsale m eno robusta
e le squam e sem p re assai p iù d i latate .
T uttavia le squam e d c l P h . p us i llus r icordan o n otevolm en te i Foli
dofori p iù sim i li al n ostro,che i l De e c k e vorrebbe separare dai con
Vedi L. Ae : ssrz. Recher ches sur les poianon e fosso'
les, vol. 1 1 , pt. 1 , 1 843,
pag. 287 ; R. K arn . Die fossi le» : F ische der Asphaltschiefer von Seefeld in
Tir ol. Sitzb. math . nat. Cl. k . Ak. W ise. W ien , vol. LlV, pt. 1, 1 866, pag.
330,tav. VI
,fig. 2 ; In . Nach trdge zur fossi len F auna der Asphaltschz
'
efer
von Seefeld . Ibid .,vol. LVI, pt. 1 , 1867 , pag. 803 ; W . Daron . Ueber F isiche
aus w r : chiedm m Hor i zon ten der Tr ias. Palaeontographica, vol. LIU, 1 889 , pa
gina 1 36 ; A. D: Z reso. Pesci fossi li d i L um ez zan e i n Val Tromp ia. Mem .
R. Acc . Lincei,ser. 4, vol. VII, 1 891 , pag. 9 ,
tav. Il,fig. 3 e 4 (sab Ph. Kner i
n . F. Bu en o. La i ttiofauna della Dolom ia p r incipale d i Giffon i (Saler no). Palaeont. Ital ., vol. I
,1 895 , pag. 205 , tav. X I, fig. 7 , e tav. XV,
fig. 2 0 3.
W. Demons. Palaeon raph ica, vol. LIII, 1 889, pag. 1 24.
Fo ss i l i d e l Lias In fe r io re
d e l C an a l d i B re n ta
Non D: D. Dm. CAMPANA.
con Tav . III
Le poche sp ecie pm sotto d escr it te p rovengono dal calcare ool it ico
d i Asolon e d el la P iovega d i so tto ,n e l Canal d i Bren ta .
Il S e c c o,n el le sue n ote geolog iche sul Bassanese , cosi d escr ive i
giac im en t i d e l calcare r icordato Lungo q uesta val le (Santa F i là) e
p recisam en te al p iede d i Aso lon (N 0 . d el Grappa) trova i assai be lla
la coli te a g rana m in uta, che credo s ia la coli te infer iore p rop r iamen te
detta del Prof. S t o p p a n i . (Strat i d i Ston cstie ld ) ed in essa r invenn i i l
P ecten C ismon is n . sp . M en . e tc . E p iù so tto agg iun ge Le oo l it i
trovan si in poten t i formaz ion i spec ialmen te salen do dal la Piovega ad
Enego sul la destra de l Br en t a, e sul la s in i s tra esse form an o la base d e l
mon te , ap pena passato i l p on te sul C i sm on . Ed i n vero d ietro l’albergo
Regrel lo , s i ap re un sen t iero su l la v iva rocc ia, i l quale p orta ai v i llagg i
d i Rocca e d i An c in ; q ue l la. rocc ia e oo l i te a m inut a grana e in q ualche
pun to è una vera lum achc lla d i I’cctcn
'
ismon is . La oo l i te d’una be lla
t in ta b ian corosea,trovas i in ab lm nd an za lungo la st rada che dalla con
trada d i Enego cond uce a Foza e tc
Se d un que dovess im o r i tene re g iusta la suppos izion e del S e c c o ,i l
( l ). Asem Szcco. Note Geologiche sul Bassanese. Pag. 38. Bassano Tip.
Pozzato 1 883.
124 RIVISTA ITALIANA
calcare oolit ico d i cui stiamo occupandoci , dovrebbe r iferirsi agli strat i
in fer ior i d e l Es ton iano , perchè, come è n oto, gl i sch isti d i Stonesfield
succedon o immed iatam en te al deposi to arg il loso del Fuller’s ear tt che
costi tui sce la base del Baton iano , opphre al T rias , se s i dovesse p restar
fede alla d ete rm inazione d el P ecten C ismon is M en .
Ma le spec ie fossi l i r itrovate in d etto ca lcare , quan tunque poco nu
merose , c i offrono dei dati sicuri per r isolvere una tale questione.
Dette spec ie sono
Tercbratulo p anciuto Sow . Var . Ceres Di St .
Scatti . Fucin i (Lias. inf. d i Longobucco) .
Sp inf cr i na sp . i nd .
P ecten H ehli i d ’Orb .
P ecten sp . n .
A queste s i agg iungono spec ie d i coralli e d i P seudochaetctes del le
q ual i , per la catt i va con servazione,riesce impossibi le dare una classifi
cazion e sicura .
Pe rtan to tenendo con to d elle form e classificate,è noto che la Tere
hratula p uncta to Sow . e i l P ecten H chli i d’Orb , sono abbo.-dant issim i
n e l L ias in fer iore ; e per g iun ta la Sp i r ifcr ina sp . in d .,offre essa pure ,
com e avrò occas ion e d i m ostrare pm innan zi , d el le analog ie con altra
forma appar tenen te an ch’essa a strat i de lla stessa età .
Per c iò che r iguarda po i la n uova Spec ie d i P ecten , essa, ben lungi
dall’esser i l P ecten C ismon ie M en . d el la d o lom i te tr iass ica, com e potrebbe
far supporre c i o che abb iamo r ipor tato sop ra dal Se c c o , è in vece una
spec ie d ist in ta m o rfo log icam en te e cron o log icam en te , com e si può ved ere
con sultan do l’ altra m ia memor ia sui fossi li de lla Dolom ia p r inc ipale i n
Val le d el Bren ta .
C redo qu ind i n on errato che quest i calcar i ool it ic i vadano attr ibuiti
al Lias in fer iore . Ess i stanno in fatt i sopra la Dolom ia p r in ci pale del
T r ias , ed al la base de i calcar i g r ig i che secondo g li stud i p iù recen ti
d i Neumavr ed al tr i , d evon o att r ibu i rsi al L ias , ed in m ezzo d e i qual i
e ss i p ure stan n o pm vo lte in te rcalat i .
Pr im a d i ch iud e re q ue s t i b rev i cenn i in trod ut t iv i d ebba agg iungere
che i foss i l i d e’
q ual i sto per dar n ot iz ie s i t rovavano n e lla col lezione
S e c c o , ora ap par tenenen te al M useo Geo log ico d i Fi renze .
Dm. CA… »ANA. Fossili della Dolomia principale della Valle del Brenta
(Boll. d . Soc . Geol. Ital.
1 26 RIVISTA ITALIANA
Sr rnrr nnm a se . m n .
L’esem p lare che q u i con s id e ro p rov ie n e dal la Piovega d i sotto
,e
n on ha c on servato d el la conch ig l ia alt ro ch e la par te d e l la valva ven t rale
la «male s i m ostra p ercorsa i n sen so an te r o -
poster iore da un’in cavatura.
Diffic i le peralt ro r iesce i l dare una c lass ificazion e an che app ross i
mat iva d el l’esem p lare , p er la d eficen za d e lla sua con servaz ione ; pu
tuttavia, dopo ave r lo con fron tato con var ie sp ec ie che con esso potevan o
offr i re d e l le affi n i tà , m i è sem brato che una d e lle form e p iù v i cin e fosse
la Hp i r ifer i na M iisch i Haas r in ven uta p er la pr im a vo lta n e l L ias in fe
r iore d i Bodm i p resso M er l ingen n elle Alp i Valdesi È per ò a n o
tars i che n e lla sp ec ie d e l H aa s l’un c inetto de l la valva ven trale è m o lto
p i ù sp iccatam en te r icurvo d e l la n ostra ; carat tere che in d uce altresì una
d ive rsa m n fo rm az io ne d i valve .
Pem ex l lnn r.u d’Orb .
Tav . Il l . F ig . 4,6 .
1 850. I ’ecten Hch li i . D ’
Orb igny . Prod rom e . E tage S inem ur ien nu
m ero 1 30.
1 892 . F uc in i . Jll olluschi e B rach iop od i de l Lias
infer iore d i Longobucco (Cosenza) pag . 48 .
(C um sy n .)1 893 . F uc i n i . A p rop osi to d i d ue sp ecie d i P ecten
de l L ias infl r iore d i Longobucco Cosenza) .
(Soc . Toso. d . Sc ien ze Nat . Ad unanza 5
Marzo . Pi sa) .
È sp ec ie abbastanza nota sp ec ialm en te n e l Lias in fer iore ; non è par
t ico lare d i un dato p ian o , p o ichè dal l’ In fral ias sale s i n o al L ias m ed io .
I d i ve rs i esem p lar i r ifer i t i da m e al P ectcn Hebli i d’
Orb . p roven
gono in m ass ima par te dai calcari d e lla P iovega d i sotto , poch i altr i
furon raccolt i ad Asolon . C on fron tati cogl i esem p lar i p roven ien t i da
l ) Hu s Il . Etude monograp ln'
qt m et cr iti que des Brack z'
0podef rhètim s f l
jurass iques des Alp es Van doi ses et des Con t rées m r i ron nan tm . Trois iòme partie .
Pag. 1 39, Tav . X l,fig. 1 —3 (Mém oires de la Socrété Paléont010gique Suisse.
Vol. X VIII,
RIVISTA ITALIANA
non posso d ire con certezza i l n um ero d e l le coste su c iascuna d e lle due
valve , le quali d ovevano esse re c irca 20 sul la valva d estra.
Su questa le coste son o separate l’un a dall
’
altra da un so lco p oco
p rofondo , e ad un cer to p un to s i parte da c iascuna d i esse una costa
secondar ia assai sott i le , la quale al par i d e l la p receden te segui ta verso
i bord i de lla valva . P roce d end o dal l’om b on e verso la per i fe r ia si ve
dono abbas tan za p resto le str ie d i accresc im en to,
rapp resen tate da nu
m erose l in ee rego larm en te sp ezzate , pm 0 m en o ravv ic inate tra loro ,
cog l i angol i corr isp on d en t i q uas i sem p re e coi solch i i n tercostal i e cel le
parte m ed iana de lle coste .
Le orecch iette , che avrebbero po tuto offr irci dei buon i caratter i d i
classificaz ione , man can o in tut ti g li in d iv idu i da m e esam in at i , e così
pure man cano i part icolar i d el la regi on e card i nale .
Dal lato in terno la valva è ugualm en t e ornata da coste ,i rrad ian t i
dal l’om bone e semp re p iù slargate v erso la per i fer ia ; queste però hann o
sezion e rettangolare sch iacc iata, s im i le a que lla d e i solch i con cui si
alternan o e che son o m ol to p iù slargati d i quan to non s i e v isto sulla
pagina super iore d el la valva.
Fatta eccezion e pe r d ue sol i esem p lar i , tutta la superfic ie in terna
della valva appare solcata da coste ; n e i d ue esem p lar i e ra r icordat i si
nota in vece che lateralm en te le coste scom paion o p er dar luogo ad una
superficie l isc ia. Ho accenn ato a tal par t icolare , poichè con p robab i li tà
si tratta d i un carattere sp ecifico , che qui n on possiano e sam inar e in
tutta la sua in tegr i tà., n è ap p rezzare in tut to i l suo valore p erchè le
valve , o le im p ron te da esse lasc iate sulla rocc ia,n on sono mai comp lete .
Del la valva sin istra non son o conservate che poche imp ron te im
perfette , le qual i m ostran o so ltan to che le coste erano sem p l ic i a d ifi‘
erenza
d i c iò che s i è osservato per la valva d estra, e al te rnate con so lch i assai largh i .
Di tutt i i P ed on con osc iut i de l L ias in fe riore,i l P ecten M eneghin ia
nus F ue . è forse quello che p e i caratte r i gen eral i , r icorda i l n ostro m eno
lon tanam en te . Questa spec ie fu g ià. d escr i t ta brevemen ie dal F u c i n i
e d istin ta com e nuova, e fu in segu ito descr it ta d i nuovo e r ifign
rata dal G r e c o Il con fron to p er al tro de lla forma i n parola con un
esemp lare tip ico d el la sp ecie de l F u c i n i mostra che i n quest’ultimaman
cano ls coste secondar ie e le p r incipal i hanno sezione regolarmen te r i
(1) Foam A. Molluschi e Brachiopod i . Pag . 48.
a o B‘ l l Dias i nfer iore nd Oircondar io d i Rossano Calabro, pag. 142,Tav. VI, fig. 1 . (Atti d. Soc. Tese. d. Sc. Nat . Vol. X III. Pisa).
DI PALEONTOLOGIA 129
curva. Ques to caratte re n on s i ved e n el Pccten Pa ro lin n n ob . perchè
le str ie d i accresc im en to son o m olto p iù sco lp i te e dan n o luogo c iascuna
ad una l i nea spezzata ; m en t re ne l Pecten m eneghi n ian ns F ue . le str ie
sono im percet t ib l l i e d escr ivono p i uttost o una l inea s in uosa.
Avevo g ià scr i tte ques te osse rvazi on i , quan do p r ima d i ch iude rle
m i ven n e d es ider io d i sottoporre l’esem p lare m eg l io con servato d e l m io
Pectcn al g iud iz io d e l Prof. F n c i n i , i l q uale p e i suo i in teressan t i lavor i
sul L ias i n fer iore p oteva dar mi d eg l i sch iar im en t i p er m e d i m o l ta im
portanza.
Ecco q n i le osservazion i che m i ven ivan o gen ti lmen te comun icate
con let te ra d e i 1 2 marzo 1 907 .
Il suo Pectcn c de l t ipo d e l P ecten J[ cneghin ian ns Fue . d i Lon
gobucco , e cor r i spon de specialm en te al la forma figu rata d e l G r e c o la
q uale , forse p er una leggera corr os ione supe rfic iale , m ostra le cos tol in e
rad iali sulle p ieghe p ure rad ial i , com e s i sc orge n e l suo e sem p lare p iù
grande . Le figure d e l G r e c o n on son o per fe tte . Non v i s i vedono le
cost ic i ne lon gi tud inali sop ra le p iegh e e le str ie d’ac c resc im en to son o
poco arcuate . La sua sp ec ie semb ra d ifi'
er ire p e r av ere le p ieghe rad ial i
men o d ep resse e separate da i n te rval li pm largh i e d an che per le str ie
d’accrescimen to p iù ango lose
Queste osserVaz ion i con cordando con quan to ebbi ad osservare s0p ra,
d ebbo agg iungere che m i han n o forn i to un argom en to d i p iù per t en ere
spec ificamen te d ist in to i l P ectcn Parolinn,
sebb ene s ia man can te d el la
regione umb onale e de l le orecch iette . Queste , com e giustam en te osserva
an che i l F u c i n i n ella lettera r icordata, forn iscon o è vero i cr i ter i
p iù giust i e p iù s icur i p er una buona classificazione , m a i caratter i dellavalva d estra sono tali che m i pare autor izzino d i p e r sè stessi a te n ere
le forme in parola spec ificam en te separate. D’
altra parte g l i esem p lar i
(allo stato d i impron te im p er fe tte) ch e m ostrano an cora i con torn i d e lla
r egione um bonale , hanno un angolo magg iore ( 1 0 1°app ross.) che n el
Poctea M eacghin ianus F ue . (95°app ross.)
SPIEGAZ IONE DELLA TAVOLA III.
F ig. 1—2 Terebratula p anciuto Sow . var . Ceres Di Stefano.
3-4 Sex ti i F ue .
5 -6 P ecten Hehli i d'
Orb .
7—9 Parolin ii sp . n .
1 30 RIVISTA ITALIANA
Ele p h as an tiq uus Fa lc. r inve n uto p resso
S an t’ Aga ta d e i G o ti (P rov. d i B en c
ven to ).
Non DI s no MATARAZ Z I
(con Tav . IV)
Essendosi eseguit i alcun i scav i p resso i l fiume Isch lero , a breve
d istan za da San t’Agata dei Got i (Prov . d i Beneven to) , furono r invenuti
alcun i avan zi d i schelet ro , i qual i dapp r ima fecero parte d el la colle
zion e d el Dott . Piccol i de lla p redetta c ittà , po i , essendo venut i in pos
sesso d el sig . Ra ffae l e De L u c i a, d i st in to p rocuratore legale e notaio d i
San t ’ Agata , un tempo m io alun no , m i furono dal medesimo gen t i l
men te inv iat i in dono , d el che g li esp r imo tutta la m ia grat i tud ine .
Quest i avan z i sono rapp resen tat i da un den te m olare d i specie ele
fan t ina,dal l
'
estrem i tà super iore del la t ib ia destra e da alcun e altre ossa.
Quan tun q ue n el C a t a l o g o d e i m am m i fe r i fo s s i l i n e l l’I ta l i a
m e r i d i o n a l e c o n t i n e n t a l e pubb l icato dalProf. FLORES la p rov inci a
d i Beneven to n on s ia c i tata,n on essend os i avuta
,fin o alla data de l la p re
det ta m em or ia , no t izia veruna d i scop er ta cò là av venuta d i qualche spe
c ie d i mamm i fe ro fos s i le ; pure d eve rag ionevolm en te amm etters i che
gli e lefan t i,cosi d iffus i per i l r esto d el l
’Ita lia, non siano man cati a
q ue l la p rov in c ia .
Pe r essere stati i dett i avan z i r in ven ut i dap p resso 1 ’ un l’al tro e
p er alt re caratter i sti che an co ra ,s i d eve con g iusto c r iterio r iten ere che
es si appar ten n e ro tut ti allo ste sso in d iv id uo .
Per ora m i l im i te rò a d escr ivere soltan to i l d en te m olare,la cui
imp ortan za sup era que lla d el le al tre par t i r in venute . La sua superfic ie
d i t r i turaz ion e,r ip rodo t ta n e ll
’an n essa tavo la in g randezza naturale , è
i n parte spezzata su i marg i n i lateral i : c iò potè essere l'effetto d el
t raspor to al q uale i l d en te fu assogget tato dal le acque , e d i rottura ao
caduta d uran te l’escavaz ione . Ino ltre i l d en te m an ca d
’una p iccola parte
V. Atti dell'
Accadem ia Pontaniana,vol. XXV
,1895
,48 pag. con I tav.
1 82 RIVISTA ITALIANA
Lo smalto e b runo lucido ; la d en t ina, co lor rossastro b run o ; i l cc
m en to de l le val late g iallastro , sfum ato q ua e là. d i roseo e d i b runo ;
quello d e lle superfic i e sterne , n e i var i pu nt i, g r ig io o rossastro .
La sesta col l in a t raversa in l in ea ret ta la superfic ie d i tr i turazion e .
Le al t re collin e (almen o le m eg l io con ser vate,com e la quar ta e la q ui n
ta) p resen ta no una non for te curvatura con con vess i tà in avan t i .
Ne lla m assa d el d en te le lam ine , pur essen do in c l inate dall’alto i n
basso e dall’innan zi al l
’i nd ietro sul p ian o d i t r i turaz ion e , con servan o
fra loro un cer to paral le l ism o . La set tima co l l ina p erò e p iù for tem en te
in cl inata del le altre secondo la d i rezion e p red etta. An che la superfic ie
poster iore d el d en te ( in par te scop er ta d i cem en to) p resen tasi in c linata
dal l’alto in basso e dal l
’in nan zi al l
’in d iet ro , m ostran do un tratto de
p resso de l d iametro d i 32 mm .,d ovuto forse al la p ressione d i altro
den te , che doveva esistere i n,si tu al d i d ietro d i questo .
Il n um e ro d elle col l ine , la sott ig l iezza d ello smalto,l’increspatura
del icata, fatta da costo lature parallele , long i tud inal i , quasi tutte egual
m en te sporgen t i sul la superfic ie delle lamel le d i smal to , la d ir i tte zza
d elle lam i ne , tutto c iò fa, sen z
’
altro , ascrivere q uesto den te ad un in
d iv iduo d el la speci e E lep has an tiquus FALCONER.
Per i l suddet to paralle l ism o de l le lam in e in tan to , per la loro d i
r i ttezza, per una certa relat iva largh ezza d ella sup erfic ie d i tr i turazione ,
per la forma d i curvatura de lle lam ine,a convessi tà in nan z i , credo trat
tarsi qui d’un d en te . m olare sup er iore : e p er i l numero app rossimat ivo
del le col line,agg iungendo c ioè con l ’ immag inazione le col l in e an date
perdute (una e m ezzo o d ue e m ezzo,secon do i l calcolo del Pen n e ) , e
per i l d iverso consum o del le part i late rali del den te credo con ragione
vole p robab i l ità che i l den te sia un D’sin istro o un M
'
de llo stesso
lato : den ti, che , in com pagn ia degli altr i molari d i latte, i l Form e
crede essere rar i nelle collezion i .
Stab i l i ta questa d iagn osi , è p erò giuocoforza amm ettere che i l den te
si sia un po’allon tanato dal t ipo ord inar io p er le seguen ti ragion i :
1 ) Il den te e p iuttosto basso ; cosa che s i ravv isa d i p referenza
nell’ E lep has mcr id e
'
onalis a r x , essendo invece i den t i dell ’E . an tigene
provvedut i ord inar iamen te d i alte lam ine ;
Pom o,H.
,Dentition und Kram log£a des E. antiquas s .
,m i! Bei
trc'
igen fiber E. primigenius Bu m, and E. meridionalis NES‘
I'
1 . Erster Abschm'
tt m it
10 Tafel m ud 1 1 0573 dm Tent aingcdruokten Z inkographic:am Halle 1888 pag. 1 1 1 .
DI PALEONTOLOGIA 1 33
2 ) Delle coll ine le ultime tre son e strette (sebben e in grado di
verso) e soltan to le an teceden ti sono , i n modo crescente , un po’
p iù d i
lattzte n el m ezzo ;
3) Il den te e un po’largo ;
4) Le coll in e man cano d i quei p iccol i sp ron i caratter i sti ci che si
r invengono n el la parte espan sa d i esse n ei den ti dell’
E . an tiquus ;
5 ) L’ind ice den ta le è un po
’
grand e .
La deficienza d i quest i caratter i n on è però tal cosa da p ermettere
l’esclusion e d ella d etta specie e l
’amm ission e , in suo luogo , della spe
c ie p iù .an t ica, vale a d ire dell
’E . mefi d iona lis. La debole altezza, in
fatt i,del den te si può sp iegare per i l con sum o n otevole , al quale andò
incon tro i l d en te : con sum o che trova anche la sua sp iegaz ione n ella
sott igl iezza dello smalto . Per la d i latazione m ed iana osserv iam o che essa
non man ca in modo asso luto,e va sem p re c rescendo dal le coll in e po
ste r ior i alle an ter ior i . Per la larghezza , s i fa n otare essere questo un
den te d ella mascel la super iore . Ma,con tutto c iò , è sem p re un po
’lar
go , avv ic inandosi , sotto questo rappor to , agl i esemp lar i ing lesi della
stessa specie , a larga corona ( 1 ) Resta in fine la d efic ien za dei caratter i
accen nati ai N . 4 e 5 .
Questa defic ien za può bene sp iegarsi per una certa var iab i lità, alla
quale (den tro certi lim i t i ) vanno in con tro i den ti d egli elefan t i ; var ia
bi li tà r iconosciuta da tutt i quel l i che si occupano d i s im i li stud i . Il
WEITHOFER (op . c i t .) p ur amm ettendo come caratter ist ico lo sp rone me
diano d elle collin e del l’E . an tigo ne, c i ta però q ualche caso d i den ti d i
elefant i i ta l ian i (com e que llo d e l por to d i L ivorno ) , in c ui i l de tto sp ro
ne manca,ed agg iunge che n e lle figure d eg l i esemp lar i inglesi del LE I
TH ADAM S e de l FALCONER esso sp rone sem b ra m an care assai spesso
Presci ndend o dal le accennate d efic ien ze , non mancan o,
com e si è
v isto,tut t i g li altr i carat ter i d i valore asso lutam en te ind iscutib i le per
unm ettere n e l caso p resen te l’E lep has an tigone FALCONER, e per esc lu
d ere I’E lcp has mer id iona lis N t:sr t ; p er la d iagn os i d e l q uale fan no d i
fetto p iù carat te r i d i g rand e r i l ievo .
Non cred o in tan to sp en d e re parole p er i s tab i l i re con fron t i tra l ’ e le
fan te in esam e e la n uova spec ie E lep has trogon ther i i POH LIG . E . p ur
amm ettendo quest’ultima forma com e spec ie d ist in ta
, cosa che m olt i
Wexraorza, bp. cit. pag. 102 .
Lvozx n a R., Catalogue of fossi! Mammalz
'
a i n the Br it ish Museum ,
Parte IV, London , l886.
RIVIS'I'A ITALIANA
( Wnn norna, LYDEK K ER ed altr i ) non credono di fare, resta sem
p re i l fatto che la p redetta nuova spec ie abb racc ia soltan to un certo
num ero d ’esemp lar i (n on tutt i ) g ià riun iti dal L . ADAM S ne lla varietà
A d e ll’E . a n tiquus (var ietà a larga corona) . Il POH LIG stesso non manca
d i far notare la relazione i n te rce den te fra la spec ie , o razza naturale
(come egli la d ice), da lui ist i tui ta, e la p redetta var ietà. del L . ADAMS ,
quan do scr ive : Au s s e r d e n an g e f ii h r t e n B e i sp i e l e n sc h e i n e n
m i r n o ch ,w e n n an ch n i c h t a l l e , s o d o ch e i n e gan z e A
‘
n zah l
v on M o lar e n ,
‘
au f w e l c h e L . ADA M S s e i n e b r e i t k r on i g e An t i
q u u s v ar i e t ìi t g e g r ii n d e t h a t , s o w i e au c h v i e l l e i c h t un t e r d e n
v on i hm z u E . m e r i d i on a l i s g e zog e n e n , n i c h t au s d em C rag
h e r r ii h r e n d e n ,c om p l e t e n od e r f r agm e n t ii r e n Z ii h n e n , zu E .
t r ogo n th e r i i zu g e h ò r e n
In conc lusione io credo che l’e lefan te d i San t ’ Agata de i Got i ap
partenga al la specie E lep has an tiquus FALCONER , amm ettendo tuttav ia
che esso p resen t i alcune var iaz ion i dal t ipo c lassico stabi lito dal FAL
cox nn , le q ual i però n on sorpassano i l im i t i d i var iab il ità consen t it i pe r
le spec ie e lefan t ine e possono far r ien t rare l’ind iv id uo i n esam e n el la
p rima d e lle tre var ie tà stab i l ite dal L s rrn ADAM S n el dom in io d ella
spec ie E lep has an tiquus FALCONER , la q uale V i sse nel p l istocene m ed io,
e s i sp in se an che nel p l istocene super iore , lasciando i suoi avanz i n e i
deposit i fluv iati l i .
Nel term inare questa n ota sen to i l d overe d i r i volgere v iv i r ingra
ziamen t i al Ch .mo Sig . Prof. FRANC ESCO BASSANI d e lla R. Un iversita d i
Nap oli per averm i gen t i lm en te con cesso d i esam inare la r icca collezion e
d i e lefan t i foss i l i d e l M useo d i Geo log ia e d i Paleon to log ia d ella. stessa
Un iversi tà , p er averm i p erm esso an ch e d i con sul tare le opere della c o
p iosa b ib l ioteca ann essa al M useo e per ave rm i date in fin e n on poch e
ind icazion i b ib l iognn ti ch e .
Ringrazio p ure i l C h .mo S ig . Prof. EM IDIO M ARTINI , Diret tore d e l leB ib l io teca Naz io nale in Napol i pe r ave rm i co r te semen te p roc urate alcun a
op e re , la cui le ttura era n ece ssar ia pe r i l m io lavo ro , facen do le , all’oc
cor ren za, ven i re an che d a lon tane b ib l io teche .
S. M. Capua Voters, d icembre 1 907 .
Poema,op. c it . pag. 206.
Lum ADAMS,Monograph on the Br itisch fossi ! Elephants, London 1877
INDIC E DEL VOLUM E XIV
Recension i italiane . pag . I , SI , 1 49
Recension i estere 1 6 , 1 52
MEMORIE E NOTE ORIGINALI
Osimo G . Di alcun i foram in il'
eri d ell’
Eocene supe riored i C e lebes (con Tav . I - III) pag . 28
P rovala Di alcune Nummulitine e O rb itoid ine d e l
l’Iso la d i Borneo (con Tav . IV - VI) 55
No te geo log iche e paleon tolog iche sul Ira
vertino d i Ascoli P icenoSu d i una nuova forma d i O strica d el Plio
cen e Italiano (con Tav. V II) 1 0 3
Vinasse de Reg ny l l Devon iano med io ne lla g iogaia d el Co
g lian s (con Tav . V III) I 08
M iliolid i Irem atoforate nell’eocene della terra
d’
O tran to (con T av . IX ). I I 7
REC ENS IO N I
I . Autori dei quali furono recensiti i lavori.
Airagh i .
Bassan i .
Be llin iCanestrelli
Capellin iC avara
C hapman
C hecch ia RispohDal PiazD i S tefanoDouvilléFab ian i
Fornasin i
F orti
ForteauFuc in iGald ie ri
C o rtan i
Lambert
INDICE DEL VOLUME XIV
Fossili dei quali si tratta nei lavori recensiti
I l l'
l’
errenì dei quali si tratta nei lavori recensiti
I V . Elenco delle nuove forme descritte nei lavori italiani.
Airaghn (Scutella)alpinus (Bron theus)A mb rosion ii (PectenBatheri (Ech inus)Betton i i (Coe loceras)Be tton i i (H ildoceras)Bonarell i i (Baculogypsina)Caffii (Pholidophorus)canovatensis (Rhynch0nella)Cape llin i i (C lypeaster)carn ica (Pterinea)C lymen iae (Edmond 1aC onsue lo (K arp inskyaìcretensis (Anog loch is)De l Cam panai (H ildoceras)De S tefan i i (Tapes)d isputab ile (H ildoceras)Di S tefanoi (Av iculopecten )Di Stefanoi (H ildoceras)
82 , 86 , I49
4. 1 6. 1 9. 2 0 . 2 2 . 2 5. 83. 93. 94
83. 89. 95. 96. 1 57 . 1 58. 1 59. 1 62 . 1 63
IO , I I .
I , IO , I I , 82 , 88 , 89 , 96 , I49
I : , 87 , 96
1 0 , 1 2
86 , 1 50
S I
95. 1 50 ; 1 5 1 . 1 52 , I 53. I 54 ,! 55
9 , I I
89
8. 88. 1 49
87
7 . M . 93
1 6 , 1 8 , 2 3
1 . 4. 8. 1 3. 1 49. 1 58
86. 88. 92 . 1 55. 1 59
86 , 1 50
3 1 95 : 1 5 1 : 1 52 , I 54»
forojuliensis (O rth is) .g labra (H eterosteg ina)italica (Dechenella)K ufste in i (H arpocera5 )Lambert i (Spatangus)laverdana (Tapes )laverdana (Te llina)LEPII)ORBITO IDE5liernensis (Pec ten )Lorio li (Ech inocyamus) .M anzon ii (Psammech inus) .Manzon i i (Spondy lus)M arinelli i (Lox onema)M enegh in i i (Deroceras).Oppenhe im i (Diastoma)Osimoi (Nummulites)Paronai (Lima)Paronai (Lind erina)percostatum (H arpoceras)
RIVISTA ITALIANA
L’autore
, per m ezzo della magn ifica collez ione d i Ech in id i del
Museo Geologi co della Un iversità. d i Palermo,ha potuto in i
z iarn e lo studi o,sp in tovi anche dal fatto che 1 ’ Opera dell
’Aradas,
nonostan te i suoi preg i , p iù non r isponde alle es igen ze dei temp i .
L’autore si pm pone d i d ividere i l suo stud io in tante parti quan ti
sono i terren i che racch iudono i fossi l i in esame ; però, pr imad ’ i ntrap renderne la trattaz ione al lo scopo d i renderla p iù che
sia possib i le comp leta, la fa precedere da una, per quan to rap ida,
uti le revisione delle specie attualmen te v iven ti sulle coste del
1’
Isola.
Dalle sue accurate r icerche r isultò che la fauna viven te degl i
Ech in id i della Sici l ia è rappresen tata da 1 6 specie d i cui 9 ap
partengono agl i Ech in id i regolar i , e 7 agl i i rregolar i . Per la
pr ima volta in Ital ia v iene an nun ziata la es isten za d i una p iccola
ed elegante specie, nota finora un icamen te n el golfo d i Oran
(Alger ia) c ioè del l’Ar bacina Pa l lary i Gauth ier , che l
’A. descr ive
e i llustra accuratamen te. Così pure per la pr ima volta è an
nunziata nel mare d i Sici l ia l’esistenza del l’ E ch inocard ium cor
datum Gray. Vengono descr itte e figurate i noltre : E ch inocard ium
m ed i ter raneum e Cen trostephanus long isp i nus che, per quanto
note,mai erano state finora figurate.
Nell ’ un ica tavola sono figurati alcun i frammenti ingrand i t i
d i fossi l i del Piano Sic i l iano d i Palermo. Tra questi è l’ingrand i
mento d i una porz ione d i superficie d i rad iolo della C idar i s ro
sar ia Bronn , che appartiene certam en te alla C idar is rosar ia, per
quan to i l Lambert ne abb ia molto dubitato.
Infine 1 ’ autore figura alcune var iaz ion i dello S trongy locen tro
tus l ividus ed alcun i esemplari dello Psammecizi nus m i crotuber cu
lotus proven ien ti dal golfo d i Palermo.
Questi ultim i si d ist inguono da quell i d i altre local ità ital ian eper la loro forma em isfer ica
,m en tre
,è noto
,come gl i esem
p lar i tip ic i del la spec ie sieno semp re depressi , per cui l ’ autore
r iconosce in c iò un carattere suffic ien te per la ist i tuzione d i una
var ietà. ( var . alta) . Accompagna l'
interessan te lavoro una tavola
el iotip ica.
M . GEMMELLARO.
4 RIVISTA ITALIANA
fauna del p iano Sici l iano,è corredata d i quattro tavole el io
t ip iche ben r iuscite.
M . GEMMELLARO.
CHECCHIA—RISPOLI (G.) Sulla p roven ienza d i alcune Lep ido
cicl ine dei d i ntorn i d i Term in i — Imerese (Palermo) .
G iorn . d i Sc. Nat. ed Econ . ; XXVII, pag. 1 - 7 . Palermo,1 907 .
L’autore
,accusato d i aver sbagl iato local ità c i rca la p rove
n ien za d i tre forme d i Lep idocicl i ne, si d ifende, polem izzando vi
vacemente con i suoi contradd itor i . Le tre Lep idocicl ine, le pr im e
trovate sin allora in g iac im en t i affermat i dall’autore com e eoce
n ici,secondo i con tradd i tor i proven ivano da strati che per la loro
fauna furono sem pre r itenuti ol igocen ic i . L’autore però l i r i tiene,
assiem e ad altr i,eocen ic i
, e d ich iara che,anche se quelle tre Le
p idoc icl i ne furono stud iate in un mater iale non da lui raccolto,
dal la m edesima local i tà., e da altre,lui ed altr i raccolsero abbou
danti Lep idocicl ine eocen iche ; quin d i non v i è p iù dubbio sul la
eocen ici tà d i queste forme sinora r itenute ol igocen iche e m ioce
n iche solamen te.
P. L. Pan sa.
C HECCH IA-RISPOLI (G) Nota p revent i va sulla ser ie Nummu
l i t ica dei d i n tor n i d i Bagher ia e d i Term in i - Imerese
i n provincia d i Palermo . G iorn . d i Sc. Nat. ed E con ;
XXVII, pag. 1 — 35. Palermo 1 907 .
Aspettando che una sua estesa m emor ia,corredata d i tavole
,
fotografie e sezion i geolog iche, sulla ser ie nummul i tica d i Bagher ia
e d i Term in i , veda la luce, l’autore crede bene
,anche in v ista delle
v ivac i d iscusion i sol levate in torno all ’ attend ib i l ità d i certe as
soc iaz ion i d i fossi l i in date local ità,d i pubbl icare la p resen te
nota preven tiva; n el la quale vengono p rese i n esame successiva
m ente parecch ie fra le p iù n otevoli local ità d i dette region i ed
DI PALEONTOLOGIA 5
esam inata la successione stratigrafica e la fauna dei r ispett ivi
or izzonti .
Tutta la ser ie eocen ica poggia sul Tr ias e su d i un calcare
cretac ico ad Orb itoid i s. str. e a Rud iste : essa s i può sudd ivi
dere in 4 grupp i . Il pr imo è formato d i calcar i compatti ; esso
con t iene, assieme a parecch ie form e nuove , per ora non i llustrate,
e solo succin tamen te descr i tte ; Or t/zop hragm ina Protti,0 . d i
sp ansa ,O. sel la
,Parouaea numm i form is comp lanata Par .
Tch ihatchefii , Par . d i scorbina,Par . subd i scor bina, Guembeli a
crossa,Assi l i na sp i ra, Ass. ex p onen s, A lveol i na g igan tea, A l .
elongata, Al. el lip soidal i s, Orbi tol i tes comp lan ata . Esso sembra
r i fer ibi le al Lutez iano m ed io.
Il secondo gruppo è formato da arg i lle scagl iose alternan ti
con calcar i o brecciuole ; esso cont iene,oltre parecch ie forme
nuove d i Lep idocicl ine : Or thophragm in a F ratti , 0 . sel la,0 . d i
sp ansa ,0 . p atel lar i 3 , 0 . stel la
,0 . p r iabonensis stel lata
Paran oea Ramond i, Par . str iata
,Par . biar r i teen si s,
Par . Tch ihatcleefi7, Guembel ia cr asso,Assi l i na granulosa ecc .
Esso sembra rappresen ti i l Lutez iano super iore assieme ai calcar i
marnosi sop rastan ti .
Questo secondo gruppo è m eno r icco del p r imo in Alveol ine,
per con tro con ti ene le pr ime Lepidocicl ine eocen iche r invenute
sino ad ora. E in questo gruppo che si trova la brecc ia eocen ica
d i trasgressione che con tien e Nummul it i eocen iche assiem e ad
Orbi toid i cretac iche. Il terzo gruppo, formato da calcar i marnosi
selcifer i e da marne a Fucoid i e brecc iuole,con tiene parecch ie
form e nuove d i Orbi toides,0r t/eop hragm iua P ro tti , 0 . sel la
,
O. d i sp ansa, 0 . stel la,0 . p r iabon eusis, Paronaea con tor ta
,Par .
str iata, Par . bm len sis, Par . Tchi hatchefiî , Par . cur visp i ra , Guern
bel ia crossa, G. len ticu lar is
,Laharp eia tuberculata (N . laeviga
ta) , Assi li na sp i ra ,A. mam i l lata ecc . Questo or i zzonte oltre a
parecch ie forme nuove d i Orbi toid i r ifer ibi l i a Lep idocicl ine , ne
con tiene pure qualcuna r ifer ibi le ad Orbi toides s . str .,e furono
appun to queste, secondo l’autore e Di Stefano, che fecero r i te
nere i l giac imen to come cretac ico a Si lvestr i (Dordon iano) .
Di notevole in questo gruppo v i è l ’ appar iz ione d ella Par .
6 RIVISTA ITALIANA
buden s is, p ropr ia dell
’O l igocene, e che non c i r i sulta sia stata
sinora trovata in or i zzon ti pm vecch i ; e pure assai cur iosa la
presenza d i Lair. tubercu lata, che verrebbe a trovarsi i n un or iz
zonte p iù alto d i quel la in cu i ab i tualmen te si trova. Inoltre cre
d iamo s ia pure la pr ima volta che la copp ia Par . con tor ta
str iata viene trovata cos i in basso e con I’assoc iaz ione d i form e
an zidette. In questo or i zzonte sono num erose le Ortofragm ine e le
Nummul iti ; sono rare le Ass i l ine : le Alveol ine v i si trovano
per l’ultima volta.
Negl i strati super ior i ( IV gruppo) si trovano. oltre a parecch ie
nuove form e d i Lep idoci cl i ne 0r thoy lzragmm a p a
tel lar i s , 0 . ste l la . 0 . p r i n bonens ì .v, Paronaea d i stan s, Par . Telai
chate/mffi Par . B on e/zer i,Pu r . curvi sp i ra . Laharp oia tubercu lo fn ,
B rugu i erea sub- Cap eder i . B m g . F i c/d el i var .,Ass i l i uu sp i ra
ecc. Non c i sono p iù Alveol ine. Le Assi line v i sono rar iss ime ;
Assiem e al le Nummul i ti v i si trovano parecch ie forme d i Lep i
docic l ine : ma c iò che v i è d i p iù cur ioso i n questi strat i s i e la
strana. stran iss ima assoc iaz ion e che s i presenta n elle form e num
m ul i t iche. Con questo no i non vogl iamo m ettere in dubb io le
determ inazion i, poiche abbiamo buon i motiv i per crederle esatte.
C i l im it iamo a notare i l fatto,abbastanza cur ioso
,d i trovare de l le
forme,e parecch i e , n ettamen te o l igocen iche in terren i eocen ic i ,
e per g iun ta as soc iate a form e m olto vecch io. d el l'
Eeeenc i n fer iore,
del m ed io,in un or izzon te r i tenuto Bartom ano dal l
’
aut0re .
Quest i strat i appartengono dunque , secondo l’autore
,al Bar
ton iano ; secondo Si lvestr i ess i apparterrebbero al l'
Ol igoeene in
fer iore,e secondo Di Stefano rappresen terebbero un passaggio
forse dal Barton iano all’Ol igocene. Certo la strana assoc iaz ione
del le su c i tate form e nummul it iche fa r iman ere m olto perp less i
c irca i l r i ferim en to cronolog ico d egl i strat i che le con tengono,
e g iustificano le molte Op in ion i eme sse al r iguardo. tra esse q uella
che s i tratt i d i roba r iman eggiata . Noi per conto nostro non sa
p remmo cosa d ire .
Nel corso de l suo lavoro l’autore accen na a de i caratter i
del le Orb itoid i , e m ette in ev iden za un certo num ero d i fe rme
le q ual i hanno le r umore equator ial i i n le rma d i esagono. Sono
8 RIVISTA ITALIANA
Anche tenendo d ist in te le Orbitoid i s. str. dalle Lep idocicl i
ne che invece Prever Checch ia, Si lvestr i r iun iscono in un genere
solo,vi sono
,nei calcar i cretace i in posto, delle forme r ifer ibil i
assolutamen te a delle Lep idoc icl ine, come nella serie eocen ica d i .
Cacasacco si trova una forma d i Orbitoide ri fer ibi le al le cosidette
Orbi toidcs s. str . Ne consegue che queste non sarebbero esclusive
del Cretaceo, come le Lep idocicl ine non lo sarebbero del M iocene
inferiore. Queste hanno avuto una vi ta lungh issima, dal Dordo
u iano all’ Aquitan xano.
P. L. Paavsn.
FABIANI It. Sul la p resenza del la Fauna Luteziana del Gazzo
d i Z ovencedo i n un’altra local i tà dei Col l i Ber i ci .
Atti Acc. Scien t. Ven .—Tren t.- I str iana, cl . I
,IV, p . 85-42.
Padova,1 907 .
È nota . la controvers ia sull ’ età. dei fossil i dei tufi d i Z oven
cedo,nei Coll i Ber ici . In questi tufi glaucon itic i , finora i fossil i
erano stati trovati soltanto nella perforazione d i un pozzo scavato
per r icerche m inerar ie e poi interrato ; cosicchè non era possib ile
raccogl iere nuovo mater iale. In base ai fossi l i esam inati , l’0ppen
be im r itenne tale fauna sincrona a quel la d i S. Giovann i Ilar ione ;
i l Vinassa sincrona a quella. d i Roncà. L’A. è r iuscito a scopr ire
la medesima fauna n el versan te occidentale dei Ber ic i, presso la
fon tana del Caval iere,e a determ inarne 56 forme, d i cui da l
’e
lenco. Basandosi sop ra tutto sul le Nummul it i,sembra che la.nuova
fauna (e conseguentemente anche quel la già. nota) sia alquanto
p iù recen te del p iano d i S. Giovann i Ilar ione, e quind i probabi l
m ente molto p iù prossima a quel la d i Roncà.
M . GORTANI.
GALDIERI A. Osser vazion i geologi che sui Mon t i Picen ti n i
nel Salern i tano. Rond . d . B . Acc. d . L in cei, (5) XVI, 2
°
sem ., p . 529- 534. Roma
,1 907.
L’A. r iconosce nei Monti Picen tin i (prov. d i Salerno) la se
guen te ser ie tr iasica
DI PALEONTOLOGIA 9
Dolom ia stratificata ch iara, con Gi roporelle e numerosi MOI
lusch i (Wor theni a, N er i top sis, Avi cula, M ysid iop tera,
Gcr ci l l ia,M acrodus
,M egalodus, ecc. : 28 forme ) .
Calcar i dolom it ici con la ittiofauna d i Gi ffon i .
Dolom ia stratificata oscura con Acteon ina scalar i s,Proma
t i ld ia tyrsoecus, Arcomya San son i i , Tr igonodus.
Dolom ia m assiccia con num erosi Megalodonti .
Dolom ia massicc ia ch iara con Sp hacrocod ium B orn emaun i
alla base .
Calcar i oscur i con Sp haerocod ium B orn emar mi .
Scisti marnoso- calcarei con E sther ia, Pseudomclan ia , nume
rose Cassianelle, H oer nesia bip ar t i ta, Card i to ecc. ( 1 6
forme) .
Dolom ia massicc ia con grossi Megalodont i e rar i Sp haera
cod i am
Scisti argi lloso—marnoso- si l icei .
Calcar i oscur i selci fer i .
Calcar i a l iste e nodul i d i selce.
I sed imen t i mesozoic i della regione stud iata sono attraversati
da numerose fratture longitud inali e trasversal i .
L’A. si ferma da ultimo su i terrazz i d i erosione,che assumono
qui particolare importan za e sono r i fer ib i l i al Quaternar io an tico.
M . GOR'
I‘
ANI.
GORTANI M . Con t ri buziou i al lo stud io del Paleo ico car
n ico. Parte II. Faune devon iane . Pa laeoutograp h ia I ta
l i ca,vol . X III
, p . 1 - 63,in con 2 tav.
,Pisa
,1 907 .
Con questo lavoro l’ A. in izia lo stud io delle faune devon iane
nel versante ital iano del le Alp i Carn iche. Nella breve in trodu
z ione è osservato come la Carn ia possegga i sol i giacimen ti devo
n ian i finora scoperti con certezza nella pen isola i tal iana, ed
è fatta una storia sommar ia degl i stud i fin qui comp iuti sep ra
d i essi .
1 0 RIVISTA ITALIANA
I l lavoro è d iviso i n due parti . Nel la p r im a sono descr itti
fossi l i del M . Germula ( nella Carn ia or ientale) ; n ella seconda,
fossi li della C ian evate e del M . Cogl ians (parte centrale del l’alta
Carn ia) .
I fossi li de l M . Germula sono i seguen t i : Or th is str iatula
Sch loth . Or thothetes n . f. A t : yp a desquamata Sow . A.
desquamata var. a lti cola Frech . A . desquamata var . rugosa.
A . r et i cu lar i s L. Sp i r igera dubia Barrois. Pen tammw s cfr.
g lobus Bronn . S tr i ngocop ha lu3 B ar t in i De Fr .
Questa faunula spetta al Devon iano m ed io,or izzon te nuovo
p er la geolog ia i tal iana.
Nel la C ian evate e sul M . Cogl ians compar iscono le seguen ti
forme : S trop homena i r r egu lar i s Roem . Lep taena cfr . r homboi
dal i s W i lek . Or thothetes umbracu lum Sch loth . Atrypa asp era
Sch loth . K arp in sìcya Consuelo var . alp i na. K,C'. var .
Tar amel l i i . K . C'. var. Geycr i . Sp i r i /er cfr . i n d i /î ier en s Barr .
Sp i r ifer cabedan us Vern . var . bifid us. S . Der ci n si ( )ehl . S .
n nd iferus Roem . S . i nfinm s Wh idb . Retz ia H a in d i nge
Barr . var . p rom inu la (Roem ) . R . H ai d i nger i Barr . var . d icho
toma Barrs. R . baschlri r i ca Tschern . Pen tam erus bip li catus
Schnur . P . Deh lcr t i Barrs. P . op tatus Barr. Rhyn o/zon e ! la
subtetragon a Schnur R. b ij ugata Sch nur . It. p r in cep s Barr .
R . aff. Jl[ eyendor jî i Vern . R . cfr. B ischofi Room . R . ama l
t/zoides Barrs . R . tran sversa Hal l. R . can oraten sis. l l’ fd d
heim ia i uren i s Sow . W. l l’ h idborn ei Dav. P ter i n ea rar
n ica. Avicu la B oy/ (Ii Cour . Pos idon ia cfr. oblonga Trenk .
Avi cu lop ecten p r in cep s Cour . A . i n cer tas Oeh l. Cyp r icard i
n i a g ratiosa Bar r. Pa racyclas sp . Con ocard imn ar tifexBarr . C . abrup tum Barr . M urch ison iu sp . S trap n rol lus
cfr. flex i str iatus Wh i t. E uomp ha lus suba latn s Vern . E . P i
rona i . Cyclon e» … Gu i l ler i Oeh l . N at i cop s is sp . P laty
corus sclcanmn Gich. P . e r tensum Barrs. Lo.r on ema p ex a
tum Hal l. L . J[ ar i nc l l i i . L. L'
r ban is i . Or t/zoceras car
n osam Hal l . cfr . ten u istr i atmn BIstr . Ca lymmen e cfr . r e
p er ta Oehl . B routon s a lp in us. PI: acop s Iatifron s Bron n .
Choi rur us S ter n berg i Boeek . C . 1’cngd l i Wh idb. L ie/cas
DI PALEONTOLOGIA 1 3
1 0. macroccp ha lus Richter sp .
H .M . i ncisus Roemer sp.
Esam inati i rapporti con le p i u note faune scpradevon iche,l ’A. conclude che nel mare relativamente basso
,che r icopr iva la
regione cam ion sul fin ire del per iodo devon iane , regnavano con
d iz ion i fisiche e b iologiche molto sim i l i a quelle dom inanti sul
1 ’ Europa centrale.
M . GORTANI.
Parm a (I’. I ter ren i nummul i ti ci d i Gassi no e d i B iar
r i tz. Atti R. Acc. d . Sc.: XLI, pag. 1 — 1 7 . Tor ino,1 906.
L’analogia stretta delle faune dei giac imenti nummul itici d i
Gassino e d i B iarr i tz ha indotto l’autore a ten tam o la comparaz ione.
La fauna d i Gassino, forse perchè questo giacimento è natu
ralm en te p iù r icco O è stato p iù frugato, è p iù abbondan te d i
quella d i B iarr i tz ; tuttavia i confron ti s i possono stabi l ire con
grande p r ec isione. A Gassino pare sia an che rappresentato i l
Lutez iano in fer iore, che m ancherebbe a B iarr i tz ; i l Lutez iano
m ed io e i l super iore si corr ispondono faun ist icam ente assai bene,
con faune abbondan ti , tra cui pr imeggiano le Nummul i ti e le
Ortof'
ragm ine.
Il r inven imen to nel la parte super iore del la Còte des Basques
del la Paranoea Orbignyi- w emmelensis
,ha permesso d i d ividere
questo giac imento in due or izzon ti ; l’ infer iore è r ifer ibi le al Lu
tez iano super iore, l’altro al Barton iano
,dal quale forse esso non
rappresen ta che la parte infer iore. A Gassino si trovano i corr i
spenden ti d i questi due or izzonti ; i l Barton iano però v i è rappresen tato in tegralmente : v i manca com p letamen te invece i l Ton
gr iano colle sue caratter istiche Nummu l i ti,le qual i invece sono
largam en te svi luppate , n el p iano corr isponden te, a B iarr i tz.
P. L. Parm a.
1 4 RIVISTA ITALIANA
PRINCIPI P. Cenn i geolog ici sul Monte Malbe presso Pe
r ug ia. Rond . d . R . Acc. d . L incei, (5) XVI, 2
°sem .
, p .
535- 537. Roma, 1 907.
Nel Mon te Malbe,si tuato a W d i Perugia, l
’A. ha r icono
sc iuto terren i tr iasici , giural iasici , cretacei ed eocen ic i . Partico
lare in teresse ha i l Tr ias, rappresen tato da calcar i cavernosi a
Jl egalodus Gfimbel i e da calcar i e scisti marnosi retici con p ic
col i Lamel l ibranch i , Gasteropod i e Brach iopod i . L’A. elenca 20
form e in questo or izzon te. Elenca pure 1 9 forme d i Ammon it i del
Lias super iore.
Quan to alla tetton ica,i l Monte Malbe costituisce in linea ge
nerale un el l issoide, i ncomp leto nel la parte nordor ien tale ove è
probab i le l’esistenza d i una faglia.
Nei calcar i si osservano t ip ici fenomen i carsici .
M . GORTANI.
STEFANINI G. Ech i n i fossi l i nel m iocene med io dell’ Em i
l ia. Rond . d . R. Acc. d . Li ncei . (5) XVI, 2°sem .
, p . 538- 541 .
Roma, 1 907.
L’A. ha fatto una revisione generale degl i Ech in id i finora rac
colti nel M iocene med io dell’ Em i l ia. Sono 58 specie, d ivise in 28
gener i ; 1 0 non sono state ancora descritte,e delle altre la mag
gior parte son comun i ad altre formazion i sincrone della regione
med i terranea. Alcune specie hanno particolare in teresse paleonto
logico ; sopra tutto talune d i tipo antico. Notiamo infine che l ’A.
ha potuto esam inare oltre 2000 esemplar i ; ciò che attesta l ’ im
portanza delle collez ion i e la d il igenza del lavoro.
M . GORTANI.
PARONA C . F. Risultati d i uno stud io sul Cretaceo supe
r iore dei mont i d i Bagno presso Aqui la. Rond. d. R.
Acc. d . L incei, (5) XVI, 2
°sem .
, p . 229-236. Roma,1 907.
L’A. aveva fatto da tempo due comun icazion i preventive sulle
faune cretacee dei mon ti d i Bagno (B . S . geol. i t., XVI, 1 897 ;
1 6 RIVISTA ITALIANA
RASSEGNA DELLE PUBBLICAZ IONI ESTERE
C H .\PMAN (F.) Ter t iary Foram in i fera of Victor ia, Austral ia.
The Balcom bian deposi ta of Por t Ph i l l ip : Par t I .
L i n n . Soc. Jour .,Z ool .
,vol . XXX , pag. 9-35
,tav. I- IV.
London,1 907.
Il dotto paleon tologo del Museo Nazionale d i Melbourne c i
fa conoscere in questo suo lavoro,i Rizopod i ret icolar i con tenut i
n elle argi lle terz iar ie dei d i ntorn i d i Victor ia i n Austral ia (baia
d i Balcombe, Gr ice Creek , K ack eraboi te Creek , e vic inanze della
baia d ’ Altona), la fac ies generale dei qual i , secondo l ’ A.,è da
confron tarsi con quelle del le faunule subappenn ine, del m iocene
del bac ino d i Vienna, e dell’
ol igocene e m iocene del le Ind ie Oc
c idental i,e con ragione ; però essa c i sembra. p iù p l iocen ica che
m iocen ica.
Rispettan do la nom enclatura adottata dall’A. stesso
,e che a
nostro avviso r ich iederebbe var ie rett ifiche,in part icolare per le
M ILIOLININAR,i l cui stud io è stato condotto sui connotat i estern i
,
i qual i poi non sem pre sono stat i correttamen te valutati r i
( 1 ) A t i tol o d’esem p io , c i b ast i r i cor d a re l e spec i e d et te d al l
’
A. : B i lan : i no r i n
gen s (Lam ck . ) ( loc. c i t ., p ag . 1 3. t av . 1 , fi g . 9 B. (aor ta «De fr .) ( i bi d ., p ag . 1 4, tav . 1 ,
fi g . B . Ir r egu lar ls D’O rb . {i b i d ., p ag . 1 5, tav . I , fig . h o e B . glolnd u s B orn em an n
( Ibi d ., pag . 1 5, tav . I , fi g . 1 7 e d i c u i l e pr i m e t re con g ran d e p robab i l i tà son o
al tra cosa, e la q ua r ta lo è d i c e rt o , n on essen d o l ’aut en t i ca B . g lobu lu s d el Bar
n em an n d i ve r sa d al la P lan i sp i r i n a sp iaaer a m en t r e la form a d e l lo C hapm an
agevolm en te r i con osces i p er un a v e ra B i loe n l i n a. Q uest i h a sb agl iat o, p e r n on os
s e rsi acc ort o d’un eq u i voco i n c u i cad d e lo Sch l um b er gcr , al qual e u l t im o effet t i
v am en t e ap p ar t e r reb be la p at ern i tà d e l la f orm a i n qu est ion e , B . gloou l u s B euss .,
n on B orn em ., aven d o la stud ia t a s t ru t t uralm en t e .
DI PALEONTOLOGIA 1 7
portiamo qui le specie da lui determ inate, r i tenendo ciò possa
g iovare a dar un’ idea complessiva d i faunule a Rizopod i del ter
ziario super iore austral iano
B i loczd ina bu l loides d’ Orb. P lan i sp i r i na ex igua (Brady)
r i ngen s (Lam ck .) Ar ti cu lina funali s BradyE rud i i Sch lumb. Cornusp i ra crassi sep ta Brady
Sarai Schlumb. i nvolvens (Reuss)
dep ressa d’ Orb. str iolata Brady
laevis (Defr .) foli acea (Ph i lipp i )elongata d
’ Orb . Jacu lel la obtusa Brady
angusta sp . nov. H ap lop hragm ium sphaeroid i
i r regu lar i s d’ Orb. n iforme Brady
g lol mlus Born em L i tuola simp lex Capm .
Sp i rolocu l i na acutimargo Brady Tex tu lar ia gramen d’ Orb.
afii x a Terquem g i bbosa d’Orb .
cana l icu lata d ’ Orb. var. tuberosa
asp eru la K arrer
M i l iol ina oblonga (Montagu) abbrevi ata d ’ Orb.
ci rcu lar is (Bornem .) sip hon ifera Bradyschr ei ber iana ( d ’ Orb.) rugosa (Reuss)
p olygona (d’ Orb.) Sp i rop lecta sag i tta le (Defr .)
tr igon u la (Lam ck ) var .fistu losa Bradytr i car inata car inata
vu lgar is (d’ Orb.) nussdorfensi s
envier iana (d’ Orb.) (d
’ Orb.)
sem inu lum (Linné) Gaudryina pup oides d’ Orb .
con tor ta (d’ Orb.) sip hon el la Reuss
F erussaci i (d’ Orb.) ox gcona Reuss
agg lutinon s Olavu li na commun i s d ’ Orb.
l i n n eana (d’ Orb.) angu lar i s d
’ Orb.
venusta (Karrer) tez tu lar ioidea Goes
S igmoi l in a sigmoi dea (Brady) B u lim i na elegan tissima d’Orb.
,
celata (Costa) var. ap i cu lata nov.
Sch lm nberger i A. Vi rgu li iza subdep ressa Brady
Si lv. Bolivina tcx tu lar ioi des Reuss
24 RIVISTA ITALIANA
dan t issime invece quelle d i med ie d imension i del tipo della
Lep . marg inata, e le p iccolo del tipo della Lep . Tournouer i .
Con esse, spec ialm en te negl i ori zzonti pm vecch i , si trovano pure
dei frammenti e qualche esemp lare in t iero del le grand i form e.
Dappertutto sono poi abbondanti anche le M i ogyp sina questa ca
ratterizzano i l Langh iano e l’Elveziauo inferiore, mentre le Lep i
docycl ina term inano colle ultime assise del Langh iano. L’autore
accenna pure che i Pteropod i non sono esclusivi d i un dato piano,
ma si trovano dappertutto ove le cond iz ion i ambien ti permettevano
loro d i vivere. Assieme a questi fossi l i se ne trovano numerosi
altr i,Corall i
,Ech inoderm i
,Mol lusch i
,Pesc i
,F i ll iti
,ecc.
, quasi
tutti stati i l lustrati in apposite Monografie ; e l’autore ne da fre
quen t i elen ch i , d imostrando come le deduzion i statigrafiche che
si possono fare, in base alle Nummul iti e alle Orbi toid i,si ac
cordano perfettamen te con quelle che si possono fare, e in parte
furono fate cogli altr i fossi li . P. L. PREVER.
Sramm x u G. Ein fiì h rung i n d ie Palaeoutolog ie 2‘
ed i
z ion e r ifusa ed aum entata Leipzig, Engelmann ; 1 907 Mk .
1 4 pag. 542, e 905 fig.
L’opera del lo Steinmann che modestamente è inti tolata In
troduz ione alla Paleontologia è troppo nota anche in Italia,ove
l’ i l lustre autore conta num erosi estimator i ed am ici personali ,
perchè occorra spenderc i attorno parola.
Come l ’opera sia stata accolta dal pubbl ico lo mostra i l fatto
che in poch i ann i ( 1 903) si è resa necessar ia una seconda ed izione.
Questa è stata quasi del tutto r ifusa dal l’ autore, e tra i ca
p i tol i nuovi p iù interessan t i c i teremo quello sugli insetti , pei qual i
l ’ A. ha potuto valersi del manoscr i tto del Haudl irsch autore d i
un’opera, tuttora in corso d i pubbl icazione.
Sarebbe troppo lungo segu i re passo a. passo le var ie mod ifi
caz ion i ed aggiunte fatte in questa seconda ed izione. Esse però
hanno servito a render sem pre p iù armon ico ed im portan te que
sto bel l ibro.
DI PALEONTOLOGIA 25
L’ord ine del la successione degl i organ ism i è accuratamente
segui to, le p iante c ioè p recedono gl i an imal i , a d ifl‘
erenza d i
quanto si avvera in parecch i altri trattati . Tengo a far ri levare
questo fatto poichè, se non erro,sono stato io i l primo, nel m io
modesto compend io d i Paleontologia, pubbl icato nel 1 902,a se
guire questo m etodo d i esposizione che è certamente i l p iù logico.
L’opera dello Steinmann term ina con un succeso r iassunto
sul lo sv i luppo del la vi ta nei per iod i geologici .
VREDENBURG E. Numm ul i tes Douvi l léi , an undescr i bed spe
cies from K ac luh , w ith Remar k s of th e Z ona] B istr i
hut ien of Ind ian Nummul i tes . B cc. Geol. Sur e. I nd ia,
X X X I V ; pag. 73- 95,con tavola. Calcutta 1 906.
Duran te i mesi estivi del 1 905 l’ autore vol le r istud iare le
Nummul i ti conservate nel Museo Geologico d i Calcutta ed altre,
da lui raccolte in gite fatte nel Beluc istan e nel Sind,e stendere
le descr izion i delle var ie forme r iconosciute. Tra queste trovò unaforma in teressan te, che gli parve d iffer ire da tutte le descri z ion i da
lui lette d i Nummul i ti ; e d i questa, al la quale dai l nom e d i Namm .
Douc i l lc'
i,dà una descr izione nel la presen te nota. Effettivamente
r isulta a noi che egl i non ebbe tra le man i un l avoro i tal iano
Prever Le N ummuli ti del la F orca d i Presta e dei d in torn i d i
Potenza) , dove appunto sotto i l nome d i Gucmbel ia Douvi l léi è
descri tta una nuova form a r invenuta a Potenza. Per la legge d i
p r ior ità. cade i l nom e usato dal Vredenburg, come dato a due
Nummul iti ; che per giunta appartengono anche al m edesimo
sottogenere, Guembd ia : ma ciò che vi è d i p iù cur ioso si è che
nemmeno la forma è nuova, poi chè essa è perfettamen te identica
ad una seconda,r invenuta pure a Potenza, e descr i tta n el m ede
simo lavoro col nome d i Guembcl i a p arva. L’un i ca d iversi tà tra
quest’ult ima form a e quel la in d iana r isiede nelle d im ension i , che
sono maggior i in quest’ultima : perc iò la Namm . Douvi l léi Vred .
(non Prev.) deve passare nel la sinon im ia della Gucm b. p arva Prev.
26 RIVISTA ITALIANA
L’autore da inoltre degl i in teressan ti dati circa le affin ità.
d i questa con altre forme, e c i rca la sua d istr ibuz ione geolog ica
e geografica. Essa è stata trovata i n due local i tà ; nel K achh,
dove si trova associata con N amm . laevigata (probabi lmente
Laharp . tuberca lata Bm g.) e Paronaea g isehcnsis, associaz ione
quasi identica a quella osservata in Ital ia.
Ch iude i l lavoro una interessant issima d iscussione sul la d is
tr ibuzione stratigrafica del le Nummul i ti ind iane e l ’ affermaz ione
che la Namm . N iasi I è una Amp hi steg ina.
Le Nummul i t i ind iane si d istribuiscono verticalmente in 4
successivi p ian i . I tre pian i p iù vecch i cost ituiscono r ispettivamente
le cosidette ser ie d i Ran i kot,d i Lok i
,d i K h i r thar dell
’ Ind ia oc
c identale.
La p iu bassa sudd ivisione della ser ie pm recen te (4) è cono
sciuta col nome d i Nar i,e con tiene le p iù recen ti assise r icche
in grosse Nummul iti .
La serie d i Ran ikot,racch iudente i terren i terz iar i i p iù vecch i
dell’ Ind ia,r iposa trasgressivamen te sul cretaceo (Maestr ichi ano) .
Delle quattro zone,in cui si sudd ivide la p arte super iore I
’ul
tima cont iene N . p lan u lata ,e,assieme al la penult ima
,delle
p iccole Assi l i na N . m iscel la D’Arch.)
La ser ie d i Lak i,corr ispondente al Lutez iano in fer iore, viene
sudd ivisa in 3 sottop ian i : i l pr imo contiene N . atacica , Ass.gra
n a lasa var . Op er . tattacn sis i l m ed io (A lveol i na l i
meston e) con tiene: Ass. g ran u losa, N . ataci ca,N . i r regu lar i s var .;
i l super iore : N . ataci ca,Ass. granu losa, Ass. ex p on en s var .
La ser ie d i K hi rthar (Luteziano m ed io e super iore), è sudd i
visa i n due grupp i ; l’ i nfer iore contiene : Ass. ex p on en s, N . i r re
gu lar i s, N . laevigata , N . p erforata t i po e var . obesa ; i l superiore ,
sudd iviso in due or izzon t i , con tien e nel p r imo : Ass. ex p onen s, Ass.
i nflata n . f. Ass. obesa Cartefl , N . lacvigata, N . p erforata,tipo e var . obesa, N . d i scor bi na , N . g izehensi s (forma comp lessa
che ingloba la N . obtusa ,Vi cary , Lycl l i N . Douvi l lc
'
i
Gucmbcl ia p ar co ) ; n el super iore : Ass . er p on cns, Ass. sp i ra ,
N . Car ter i (che secondo l’autore sarebbe una grande var ietà
d el la N . laevigata ,analoga probab i lm en te alle form e ascr itte in
28 RIVISTA ITALIANA
DI ALCUNI FORAM INIFER I
D E L L’E O C E N E S UP E R I O R E D I C E L E B ÉS
M EM ORIA DI GIUSEP P INA Osm o
Con Tav . I-III.
Nella località d i Dongala, sulla costa occiden tale d i C elebes , all ' ing ressod ella baia d i Palos , il con te Do tt. Guido B o n a r e l l i raccolse una mam a ar
gillosa d i colore b ianco -g iallastro , ricchissima d i piccoli fossili terz iari , che
eg li inv iò e donò al R . Museo d i Geolog ia d i T orino , e ch’
io ebb i in istud io .
T ra quest i , in sieme con una piccola valva d i Arca e frammen ti d i altre B ivalvi(Per la r, Ostrca) , placche tte d i Echinod erm i e c idarit i , Coralli (gen . Is is ) , al
cun i piccolissim i esem plari d i Brach iopod i (gen . Tcrcbratula ; , un esem plared i Verme (D i tr upa C irriped i (Cor on ata) , Briozo i , chele d i C rostace i , si
trova una com plessa fauna d i Foram in iferi , no tevole per la sua varietà e
per la presenza d i alcune form e , carat teristiche , rare , o finora non trovate
ancora insiem e .
Scarse notiz ie s i hanno per ora sul terz iar io d i Ce lebes , e ques te pochesparse e framm en tarie . K . M a r t i n (5) ne accenna appena incid en talm en te ;
H . Do u v i l l é ( 1 3) no ta qualche N ummul ites e Or t/zop lrr ag m ina , proven ien tida calcari neri o rossastri d ella locali tà Pic Van Maros ,
‘
e numerosi esem
piari d i Lep idocy cl ina ed H cterostcg ina osservat i da lui in calcari bianchicompatt i d i pian i superiori della m edesim a località .
Cosi , anche sotto tale aspetto ,la picco la fauna da m e avuta in istud io
è d egna d i attenz ione . V i si notano parecch i generi d i Foram in iferiTex tular ia Detr . , Calcar ina d
'
O rb . , Opercul ine: d’
O rb ., N ummul itcs
Lam k ., H eterostcg ina d'
O rb . , L indcr ina Sch lumb Lep idocy cl ina Gambe] ,B acalogypsina Sacco . Alcun i d i ess i , com e g ià d issi , sono assai notevoli , e
p iù o m eno ampiam en te rappresen tat i .Io non in tendo occuparm i estesam en te d i tutt i questi generi : alcun i
hanno un’importanza troppo lim itata , o rich ied erebbero d i p er sè un lavoro
ch’
io non in tendo fare per ora. Così m i basta r icordare la presenza d i al
cune Tcx tular ia sp . , d i num eros i esem plari d el genere Calcar ina , p robab ik
DI PALEONTOLOGIA 29
m en te riferibili a p iù d'
una specie , d i molte piccolissim e Opercul in e assai
ben conservate , fra cui la Op . ammonea Leym . e la Op . g ranulosa d’
Arch .
e t Huime . La fauna d i Nummulit i è in vece assai in teressan te per le form e
tutte conosc iute , e pe r alcune ve ramen te caratteristiche , che la compongono .
A m p h'
i s t e g i n a . N i a e i (Verb .)
Tav. I , fig . 1 —3 .
N ummul itcs Ramond i Defr. , var . Vcrbcek iana Brady. Brady . On so m
fossi ! F oram in ifera f rom the West Coas t d istri
cts , Sumatra. G eo l. Magaz . p . 532 . 1 875 .
Ramond i Defr., var . Vcrbeck iana Brady . Brady . Jaarb . M i
j uw ezen , I , p. 1 6 2 , tav . I , fig . 5 , a, b , c 1 878.
N iasi I Verb . Verbeck e t Fenn ema. Description g eolog i
qac dc j ava ct M adm an . p. 1 1 55 , tav . IX , fig .
1 20 , 1 2 1 , 1 2 2 . 1 896 .
Amp /ri stcg ina N ias i (Verb .) È . Vred enburg , N unmm li tcs Donvi llci , an un
des. sp . f rom K achh , w i th ra narks on the zona!
d istr ib. of Ind ian N um » . Records Geolog ical
Survey of Ind ia, l . XXXIV , Part 2, p . 93 .
1 906 .
H o d i questa forma esem plari megasferici e m icrosferici affatto sim ili ,
e un po’
p iù rigonfi d i quelli figurati dal Verbeck . Quan to alla N . Nias i
Ii Verb ., che il Verbeck riteneva omologa della sua N iasi 1 , io la riferirei
p iuttosto alla N . H còer ti , della quale si può considerare com e una muta
z i one .
N u m m u l i t e s (Paronaea) v e n o s a (Ficht . e t Moll).
N au ti lus venosus F . et M . Fichte ] ét Moll , Testacca m icroscopica, pag .
59 , tav. VIII , fig . e , f, g , h . 1 803 .
N ummulites anomala ( 1 . L. H . De La Harpe , N ummul ites des enr/ i v
ron : de N ice et M en ton f Boll . Soc . Geol. de
France , 3 , vol . V ,82 7 , t. XVII, fig . 1 3 , 1 6 ,
1 7 , 1 8. 1 877 .
anomala d . L. H . De La Harpe . Études sur les N ummu
l ites de la Com té de N ice. Boll. Soc. vaud . Sc .
nat ., vol. XV I , Losanna, p . 2 1 1 , tav . X , fig . 1 3 ,
1 6 , 1 7 , 1 8. 1 879 .
30 RIVISTA ITALIANA
N ummul ites anomala (I. L . H . T ellin i . Lc N ummulitid ee terz iari e dcl
l’
A lta Ital ia Occiden tale . Boll. Soc . G eol. Ital
vol. V II, Roma. p. 46. 1 888.
anomala d . L . H . T ellin i . Le N ummul itid i della M aiella
ecc . Boll. Soc . Geo l. Ital IX ,Roma, p . 2 0 ,
tav . X I , fig . 2 5-26 . 1 890 .
budcnsis H an tk . Oppenhe im . Ueber d ic Nmnrnul i tcn des
Venetian ischcn Tcr t. tav . I , fig . 1 0 , 1 1 , 1 2 .
1 894.
H an tbcn ia (rett. Paranoea) venosa (F . e t M .) Prever. Le N ummul i ti
della F orca d i P resta nell Appenn ino Cen trale,
e dei d in tor n i d i Potenza nell’Appenn ino M er i
d ionale . M ém . de la Soc . paleon t ., Suisse , XXIX ,
p. 8 1 , tav. IV , fig . 23 , 24, 2 5. 1 90 2 .
Ind ividui d i piccole d im ension i , in cu i , per la colorazione b ianca, non
si vedono le strie esterne , se non logorando in parte l ’ esemplare. In terna
m en te corrispondono in tutto alle figure che ne danno g li autori .
N u m m u l i te s (Paronaea) s u b B e a u m o n t î de la Harpe .
N umvnul i tcs sub-B canmon ti d . 1 . H . Ph . d e la Harpe , M on . dcr in Acgyp .
n . d . lib. Vi ste vor komm . Nunn n . , Palaeon togr . ,
pag . 2 8 , tav. II, fig . 48-
56 .
Forme piccolissime , che non oltrepassano 1 mm . d i d iametro , e d i fferi
scono pure dalla t ipica per essere p iù rigonfie e quasi ro tondegg ian ti . Le
strie , subrette , sono poco v isib i li , e s i rendono p iù percettib ili in corrispondenza co i se tti dell
’
ultimo g iro d i camere , soltan to verso il marg ine d ella
conch ig lia.
N u m m u l i t e s (Paronaea) G u e t t a r d î d’
Arch .
N arnm n l itcs Ramona? var . m inor . d’Arch . d
’
Arch iac . H istoire des
p rog rès de la Gr'
olog ic , vol. III, p. 2 9 2 . 1 850 .
Gucttard i d’
Arch . d'
Arch iac et H aim e . M onog rap/ n‘
c das
N ummuli tcs , p . 1 30 , tav . V II , fig . 1 8 a,b, c ,
1 9 a, b . 1 853 .
Gnettard i d’
Arch . T e llin i. Le N ummul iti della fl[ aj clla ecc. ,
p. 50 e 56 , tav . X I, fig . 2 1 - 2 2 , Boll. Soc . Geo l.
Ital . , vol. IX . 1 890 .
32 RIVISTA ITALIANA
N nm rnalites planulata Lemk. (pars) d ’
Arch iac e t H aime . M onog rap lrie .
p . 1 42 , tav . 9. fig . 7 c-g , 8 ad , 9 a-b . Non
fig . 5-a, 6-a, 7 a-b , 1 0 a-c . 1 853.
N ummul ina planutata Lemk. var . P restw iclriana Jon . T . R. Jones. N ote
on N arnmal ina p lann lata Lam k . var . Prest
m ich iana Jones Q. Geol . Soc . vol. 1 8 ,
p . 93. 1 86 1 .
N ummul ites Wemnrelensis (I. L . H . var . Prestw icbiana Jones. De La
Harpe . Etude des N ummuli tes de la Suisse.
Mem . Soc. paléont. Suisse . 1 879.
elegans Sow . (pars) De La Harpe . Etude des N ummulites de la
S uisse. Mem . Soc . paléon t . Suisse . vol . X ,
p . 1 75 . 1 883 .
Wermnelensis d . L . H . var . eleg ans Sow . T . Rup . Jones .
Q . Geol. Soc ., vo l. 43 , p . 1 32 . 1 887 .
Orb ig ny i (Gal.) Lister. On the D imorp l n'
sm of the E ng lish Spe
cies of N ummul ites ecc . Proc of the Royal
Soc ., vol. B 76 , p. 304, tav. 5 . 1 905.
Il primo che figurò e descrisse tale Nummuli te fu il Sow e rby , che n e l
1 82 5 le impose i l nome d i N . eleg ans . Non so perchè molt i d eg li autori
seguen t i , pur riconoscendo al Sow erby la creaz ione d ella spec ie , l’abb iano
considerata soltan to una varie tà d ella l l'
emmetensis , fatta da De La Harpee Van d er Broeck nel 1 879 ; e i l Lister, volendo riun ire so tto un solo nom e
spec ifico le due forme con siderate com e coppia, abbia loro im posto il nom e
d i Orbig ny i , col quale il Galeo tt i nel 1 837 d es ignò la forma m icrosferica
d ella N m n rn . eleg ans.
A m e pare , po ichè i l nom e d i N ummul i tes eleg ans ha la priorità sug li
altri d ue , che questo debba d i preferenza essere conservato ; e volendo con
sid erare la eleg ans e la Wemmelensis come due var ie tà d i una sola specie ,
s i dovrebbe quind i ch iamare quest ’
ult ima col nome d i N umm ul ites (Paro
naea) eleg ans Sow , var. Wemm d ens is d . I H . et v . d . Broeck .
O ra, la N . (Paronaea) eleg ans non fu trovata sinora altro che nel tipicoBarton iano , d i cui s i ritiene s ia carat terist ica. Nel Barton iano in ferio re d i
Biarritz il Prever ( 1 4) trovò pure associate la Paronaea venosa e la Pam naea
G nettard i e quest ’ultima ,
insiem e colla N . s ub—B eaumon ti s i trova pure ne l
DI PALEONTOLOGIA 33
Barton iano superiore d i Gassino . Non consta veramen te che la Par . H eer i
s ia stata finora trovata tan to in alto nella serie strat igrafica , ma non è peròda escluders i che essa possa anche risalire , e c iò è tan to p iù amm issibilepo ichè non si tratta q ui d ella tipica, m a piuttosto d i una forma leggerm en temod ificata, che po trebbe con molta probab ilità cost ituire una semplice mu
taz ione .
Infine , d i tutte queste Nummuliti nessuna fu trovata p iu su d e ll'
Eocene
ne i t ipic i g iacim en t i d i Biarritz , e sim ile fauna non può appartenere altro
che all’
Eocen e superiore , e rappresen ta senz’
altro un’
assisa d el t ipicoBarton iano.
Ad essa po i si associano q ui esemplari cos ì num erosi d ella Amp ln'
steg ina
N iasi che quas i caratterizzano uno strato , i l quale si potrebbe sen
z’
altro d efin ire : strato ad Amp /: isteg ina N iasi . Può essere quind i che
tale forma, com e il Verbeek ne esprime il dubb io , consid erando la g iaci tura
in cui eg li la trova, sia tuttora v iven te . Essa ragg iunge però nel Barton iano un g rado d i g rand e sviluppo , che sembra tuttav ia s ia caratter istico
d ella reg ione .
l i e t e r o s t e g i n n r e t i e u l a t a Rutim eyer .
T av . I, fig . 9 .
H eteros/eg ina reticulata Rtl t im . Rù tim eyer. Ueber das Schw ei z . N ummul i
te n—ter rain . p . 1 0 9 , Taf. IV , fig . 6 1 . 1 850 .
r eticulata Rii tim . M ax von H an tk en . D ie F arm a der Cla
zrulina Szaòoi -Sclziclzten . Jah rb . k . ung . geo l.
An st . , IV , p . 8 1 , tav . X II, fig . 3 . 1 875 .
ret iculata Rfi tim . H . Douv illé . Les F oram in i/ ères dans le
Ter tiaire de B orneo. Bull , Soc . Geol . d e
F rance , p . 44 1 . 1 90 5.
Tale form a, rappresen tata in ques ta fauna da numeros i esem plari , p resen ta tutt i i caratteri pe r essere id en tificata con que lla d el Rtl tim eyer . Soltan to non si p uò osservare , per il colore bianco de i foss ili e la loro supe rficiealquan to logora, alcuna traccia d i re ticolatura es terna. La spira, spiccatam en te op erculin iform e , dà all
’
esterno una forma m olto espansa, con um
bone eccen trico ri le vato .
RIVISTA ITALIANA
I -I e te r o s t e g i ii a g l a b r a n . t'
.
Tav . I, fig . 5-6 .
E una forma esternamen te l iscia, a d isco regolare , piuttostoappiattito ,con spessore che d im inuisce regolarmen te fino al marg ine acuto . La spiraè numm ulitiforme, i setti principal i , assai inclinati , decorrono per un cer
,to
tratto quasi paralleli alla lam ina spirale ; alcun i sono in terrotti e dànno alle
camere tte secondarie un andam en to assai irregolare .
Tale forma si presen ta, in sez ione , affatto sim ile alla H eterostegina
(sp i roclypeus) g ranulosa (Bouss .) ma ne d ifferisce esternamente per
essere affat to sprovvista d i g ranulaz ion i (quind i probabilm en te avrà lam inanon in terro tta ; non posso accertarlo , essendom i impossib ile , per mana hza
d i altri esemplari , d i eseguire una sezione trasversa) e per la forma rego»
larmen te d iscoidale , senza traccia d i umbone e d i e spansione marginale
appiat tita. Ragg iunge il d iam etro d i 4 a 5 m illimetri .
A proposito d i questa forma, m i pare qui il caso d i osservare che non
credo opportuna la d ivisione delle ,
H eterosteg inae nei due generi d i H ete
rosteg ina e Sp iroclypeus , fatta da H . Douv ille
Eg li basa questa d istin zione su parecchi caratteri , che a me sembra peri;non abb iano una vera importanza : Sp iroclypens,
,è , secondo lui , una H eteroste
g zna a spira 11 ummulit iforme , in cu i le lam ine de i successivi g i ri g iungonosempre a r icoprire il cen tro . Queste lam ine non si saldano però le une colle
altre , ma lasciano tra loro un certo spaz io , d iviso po i dai sett i in modo da
assum e re l’
aspe tto d i pàrecch 1 p ian i d i camerette . I canali , che dal pianoequatoriale vanno alla perife r ia , sono assai grand i e spesso raggruppatiin fasc i , e at traversando le lam in e successive , le fanno apparire , in sez ione
trasversa, com e sudd iv ise in tan ti trattin i isolati.
O ra, l’
essere la spirale p iù o m eno avvolta od aperta cost ituisce un
buon caratte re specifico , m a nulla p iù il fatto che le lam ine d ei successiv i
g iri g iungono sempre a ricopr ire il cen tro non è esclusivo d i quelle formeche il Douv illé ch iama Sp ivoclypeus , ma comune a tutte le H eterosteg inae.
Que
sto m i fa ritenere che il genere H eterasteg ina sia stre ttam en te legato ,
piuttosto che con Operczrl ina, col genere N ummul i tes . Probabilm en te le
H eterosteg inae t ipiche , con umbone prom inente eccen trico ed espansionem arg inale d epressa, saranno p iù affin i a nummulit i a spira piuttosto svolta,
d e l t ipo de lla A'
. op ercul in ifon n i.r T ell., nella quale si osserva talvolta il
fatto de ll’
apparire sui setti d i seghettature , che potrebbero essere i l princ ip io d e lla formaz ione d e lle cam e rette d i H eterosteg ina.
36 RIVISTA ITALIANA
Le due d enom inaz ion i d i Orbitoid inae e d i Cycloclypeinae vennero finorausate come sinon im e , a comprend ere tutte le forme de i generi : Cycloclypeas ,
Or thoplrrag m ina , Lepidocy cl ina, M iogypsina, e ult imamen te anche L indefi na .
Tut ti quest i gene ri vennero ragg ruppati s inora in una sola sottofam ig lia,
ch iamata dapprima d elle Cy cloclypeinae . Il Preve r ( 1 2 ) fece po i osservare
com e fosse p iù opportuno d ist inguere tale so ttofam iglia col nome p iù com
p rensivo d i Orbi toid inae , il quale rappresenta po i le forme p iù numerose
ed evolute de l g ruppo ; in ques to eg li comprese anche i l genere Bacalogypsina, ed io credo d i poterv i agg iungere anche Gypsina, che , come p iù in
nanz i tenterò d i d imostrare , possiede pure i caratteri per esse re collocata
in questa sottofam ig lia.
Però , secondo m e , tale g ruppo non è abbas tanza omogeneo , e si do
v rebbe sudd iv idere in d ue altr i : de lle Cy cloclypeinae e delle Orbitoid inae ,
com prendendo nel pr imo i due generi Cy cloctype ns e L inder ina, e raggrup
pando nel secondo tutti g li altri , cioè Or t/zop lrragm ina, Lep idocy cl ina, M m
g ypsine , Bacologj zpsina e Gyps ina. La fam ig lia d elle N arnmalin ia'
ae , oltre le
F usn l in inae e le Polystomell inae , verrebbe quind i a com prendere le tre
sottofam ig lie d e lle : N amm ul itinae , Cycloclypeinae e Orbitoid inae.
Le form e d elle N ummul i tinae hanno un solo piano d i cam ere , formated a una lam ina spirale p iù o m eno svolta, com un ican t i fra loro per un ori
fiz io , che nell’
ult ima camera corrisponde alla bocca.
Ne lla so ttofam ig lia de lle Orbi toid inae esiste un piano equatoriale d i
camere d isposte non p iù in spira, ma in cerch i concen tric i , che possono es
sere con tinui e sudd ivisi in tante camerette , com e nelle Or t/roplzrag rn inae ,
o essere formati da tan te camere tte isolate , a parete propria, che per la
loro forma si incastrano fra quella dei cerchi con tigui , come in Lep idocy clina.
V i sono po i altr i pian i d i cam ere , che hanno lo stesso carattere in tutte le
Orbi toid inae , e sono c ioè formati da lam inette staccate e alternan ti con
quelle de i pian i con tigui . T ale d isposizione può , come ved remo , per mod i
ficaz ion i posteriori , estend ers i anche al piano equatoriale , che non appareq uind i affat to d ifferenziato dag li altri (Gypsina) . Nel genere B acalogypsin a
poi appare , ne l piano equatoriale , assai sviluppata la parte a sp.ra, che s i
osserva ne l cen tro d i qualche altra orb itoid ina (M iogypsina , T av . II, fig .
e tale carattere , che ravv icina le due fam ig lie d elle N ammn li tinae e delle
Orbitoid inae , m an t iene d istin to anche in questa forma un p iano equatorialed ifferen ziato . Le camere d elle Orbitoidinae com un icano fra lo ro solo per i
po ri d e l gusc io , che non presenta alcun orifiz io , che possa far ufficio d i
bocca.
Le Cy clocbrpeinae han no invece un so lo piano d i camere , non pm d ispo
DI PALEONTOLOGIA 37
ste in spirale com e nella sottofam ig l ia d e lle Nm nm n ti t inae , ma piuttostocon una d isposiz ione sim i le a quella d elle 0 ròi toia'inae
,in cerchi concen tr ici
d i cam ere tte non comun ican ti che per i pori 0 canali d el gusc io . Questi cerch i sono con tinui come ne l piano equatoriale d elle Or thop lzrag rn i rzae n el
genere Cy cloclypeus , o format i da cam ere tte isolate e che s i incastrano fra
quelle de i cerchi con tigui , com e ne lle Lep i docy cl inae , n el gene re L inder ina.
Ne lla parte cen trale d ella conch ig lia , le lam ine , form an t i i d ivers i g ir i d i
camere , si ricoprono fino al cen tro ; p iù es te rnamen te si accollano so ltan to
al marg ine d e l cerchio p iù interno . Questa d isposiz ione è com une tan to a
Cy cloclypeus che a L inder ina, ond e io credo che , ri tenendo Or thop /zrag
m ina d er ivata da Cy cloctypeas , non si può esclud ere , che , allo stesso modo
e con una mod ificaz ione affatto sim ile , L inder ina abbia dato orig ine a Lep i
docycl ina.
E questo m i pare tan to p 1u probab ile , po ichè noi osserviam o in Al io
g yps ina, che rappresen ta, p er m e , n ien t’
altro che una forma d egenerativa
d i Lep idocyclina , dovuta probab ilm en te all’
attaccars i dell’
an imale , un ritorno
a caratteri affatto sim ili a quelli d i L inder ina. E noi ved iamo in fatti ne lla
.Miogypsina cornp lanata Sch lumb . i l marg ine ond ulato p er l’
appar ire all’
e
s terno d e lle cam erette d eg li ultim i gi ri ; i pian i secondari d i cam ere sono
assai ridotti e talvolta scompaiono affatto ; la parte embriona le è formata
da una spira p iù o m eno sv iluppata, in cui le lam ine s i ricoprono fino al
cen tro , com e avv iene forse anche p er alcun i cerch i d ella parte non p iù
d isposta in spirale . (Tav . II , fig .
Amm ettendo dunque un tale m odo d i fo rm az ione per le Lep idocy cl inae
d igo-m iocen iche , sarebbe così spiegato i l fatto d i non aver trovato tale
genere nell’Eocene ; e il trovare ora, in una fauna d ell
’
Eocene super iore ,
insiem e con L inder ina , alcune form e indubb iamen te riferibili al genere Lep idoey cl ina, con ferm erebbe , secondo me , sempre p iù lo stre tto legam e tra
questi due generi . Le Lep idocy cl inae cretacee e le posteriori han no dun
que forse orig in i ind ipenden ti ; esse hanno però caratteri sim ilissim i ; e
derivano senza dubb io , se pure in tempi d iversi , da form e d elle N ummul i
t inae ; onde è bene conservare p er le une e per le altre una stessa deno
m inaz ion e g enerica, in tend endo con questa d esignare , non esclusivam en te
form e derivate le une dalle altre , ma soltan to form e aven ti caratteri uguali
e che si può presum ere abb iano avuto orig ine da form e sim ili .
Riassum endo , la fam ig lia de lle N nmmalin idae ve rrebbe così ad essere
d iv isa.
F asul in inae (Fusulina, Sch w agerina) .
Poly stom ell inae (Non ion ina,Po lystom ella).
38 RIVISTA ITALIANA
N ummul itinae (Archaed iscus , Amph isteg ina, Em isteg ina, Op ercu lina,
Numm ulites , S id ero lithes , Aés iliua. H e terosteg ina).
Cy cloclypeinae (C ycloclypeus , Linderina) .
Orbitoid i nae (O rthoph ragm ina, Lep idocyclina, M iogyps ina, Baculogy
psina, Gypsina).
L i n d e r ì n n Sch lumb .
Il genere L inder ina fu ist ituito nel 1 893 dallo Schlumberger su d i
una forma assai rara d ell’
Eocene super iore d i Brugues (G ironda) , a cui
eg li d iede il nome d i L inder ina B rug esi . Fu trovato po i da New ton e H o l
lan d ( 1 0) nel O rb i toidal lim estone of Goman ton H ill d i Borneo , ove
g li esem plari ne sono abbondan t issim i , ma ing lobati nella roccia in mod o
che non s i prestano pe r una s icura d ete rm inaz ione spec ifica. Successiva
m en te g li stess i Ne w ton e Ho lland ( 1 1 ) ritrovarono i l genere nel Iriometé
limestone del l’
isola d i Riu-K iu , e anche in questo la determ inaz ione e
assai d ubb ia. I poch i esem plar i raccolti dal Bonarelli n e ll’
isola d i C elebes
sono pure certam en te r ife r ibili al genere dello Schlumberge r , m a d ifferiscono
dalla forma t ipica per caratte ri tali ch ’
io credo d i doverli r iferi re ad una
n uova specie del genere Linder ina .
[ J i n d e r i n u P a r o n u i n . i .
Tav . 1 , fig . 1 3- 1 4 , tav . II. fig .
C on ch ig lia d isco idale , d i mm . 1 d i d iam etro , a con torno irrego
lare , leggermen te p iù spessa al cen tro che al marg ine , com posta d i un
solo piano d i cam erette a forma d i arco o d i quad ran te , d isposte in cen tri
concen tric i ed in castrate quelle d ’
un cerch io fra que lle d e l preced en te . C a
m era cen trale sub ro tond egg ian te , segu i ta da un accenno d i spirale . La ca
m era d ella fo rma m egasfe r ica è c irca il doppio d elle cam e rette successive ;,
la m icrosfe ra ha d im ens ion i molto m inor i , che però non posso prec isare ,
n on avendola v ista che in sez ione trasve rsa. Le lam ine form an t i le cam ere
d e i prim i g iri si con tinuano s ino a ricoprire il cen tro , e sono attraversate
d a canal i g rand issim i , che dalle cam e re d ire ttam en te s i con t inuano attra
verso le d iverse lam ine , fino alla superfic ie d e lla conch ig l ia.
Ne i g ir i success iv i le lam ine non g iungono p iù fino a r icoprire il cen
tro , m a 3 1 acco llano soltan to al m arg in e d e i g iro preceden te d i camere , e
le cam e re tte , essendo ind ipend en t i le une d alle altre e assai irreg olari , s i
40 RIVISTA ITALIANA
n um ero d i esemplari a m ia d isposiz ione , non m i fu poss ibi le avere una se
z ione equato riale sodd isfacen te , nè posso figurare la sezion e trasversa.
L’
apparato embrionale è assai con fuso , ma sempre costitui to da due
loggie , a pare te legge rm en te ispessita. Tutti g li esem plar i sez ionat i sono
m egasferici .
L e p i d o c y c l i n u P r o v u l e i 11 . f.
Tav . 1 , fig . 1 0 — 1 2 .
Un solo esemplare d i 7 ad 8 mm . d i d iam e tro su uno spessore d i c irca5 mm . Forma cope rta da fitte granulazion i piuttosto picco le e d istribuite
ugualm en te su tut ta la superfic ie . F ra esse vi è un reticolo assai poco v isi
b i le , formato da una sola se rie d i cam ere tte decorren te fra i pilastri . Le lam ineche le separano collegano cos ì d ire ttamen te le granulaz ion i . P iano equatorialefor temen te e irregolarm en te ondulato , che appare quind i all ’esterno in forma
d i linea tortuosa, che non co inc ide sempre col margine d ella conch ig lia,acuto e pure assai con torto . In sez ione tangen ziale si osservano , in corri
spond enza colle granulaz ion i es terne , de i g rand i canali circolar i , che percorrono i pilastri , sottili e regolarmen te d istribuiti . Forse p e r causa della for
t issima con torsione d i tutta la conch ig lia, tan to in sez ione tangenz iale , com e
nella sez ione equatoriale (verso l ’ esterno ) si scorgono in molti pun t i dellecam ere appartenen ti alla sez ione trasversa ; nella sez ione trasversale po i si
ved e spesso lo sbocco , alle volte obbliquo , d ei canali che percorrono i pilas tri .Non credo però che tale fatto abb ia vera importanza, ma probabilmen te d i
pende dalla con formaz ione affatto spec iale d ell ’ ind iv iduo . La form a esam i
nata e m icrosferica le cam ere che circondano i l cen tro sono piccolissime edhan no la forma a quad ran te , caratterist ica d i Lep idocycl ina. L
’ampiezza delle
cam e re aum en ta g radatam en te verso l’
esterno , ove queste assumono pureform e pm irrego lari ad arco . Spesso appaiono romboidali o quas i rettangolari come in Or thop lzrag m ina , ma c iò d ipende dall'essere sez ionate ob liquam en te . In sez ione trasversa si osserva che lo spessore del piano equatorialeè assai variabi le e sogge tto q uà e là a camb iam en t i repen t in i . Le cam ere
d e i p ian i secondari , grand i e ret tangolari , sono lim itate da lam in e d i m e
d io spessore , alte rnan tesi rego larm en te .
B a c u l o g y p s i n Sacco .
Tinoporus M on t i"
. D. M on tfort. Conc/rylz'
olog ie siste'
matigne , p . 1 50 , fig . 3 ,
p . 1 5 1 , Paris . 1 80 8 .
DI PALEONTOLOGIA 41
Orbi tolina d’
Orb . (pars.) K . Parker and R . Jones , On the nomenclature
of the F oram in ifera. Ann . and M ag . Nat . H ist. III,vol . V I, p . 33 , n . 8 . 1 860 .
Tinoporus M on tt. W . Carpen ter. Researches on F oranu'
n i/ era. Ph il. T ran s .
of the R . Soc. London . vol. 1 50 ,p . 557 , tav . XVIII,
fig . 2 - 1 0 e tav . XX I, fig . 5- 1 1 . 1 860 .
Calcar ina d’
Orb . (pars.) G timbel. B ei trag e zur F orarn in ij'
erenf auna der
nordalp i nen Eocà'
ng ebflde , Abband . K . Akad . Munchen ,
p . 78 , tat. II, fig . 97 . 1 868.
Orbitoides d’
O rb . (pars .) M eneghin i (in Gambe l) . 1 868 .
Tinoporus Mon tf. K . Moebius. Der B au des Eozoon . Palaeon tograp h ica,
XXV , p . 1 80 , p l . XXXVIII. 1 879 .
H . B . Brad y . Repor t o n the F oram in if er a d redg ed byH . M . S . Challeng er . p . 7 1 4 , tav. C I, fig . 4-7 . 1 884.
(‘
alcar ina d’O rb . (pars) . L . Rovasenda. [ f ossil i d i C assino. Boll. Soc .
Geo l . Ital. X I, p. 420 , Roma. 1 892 .
F. Sacco . Sur quelques Tinopor inae du 1l1'
iocène de
Tur in . Bull. Soc . be ige de Geol , V II, p. 2 0 4—2 0 7 , Bru
x elles . 1 893.
A . De Am ic is . Osserv az ion i cr i tic/ze sop ra talune
Tinopor iuae fossi l i . Soc . Tosc. Sc . Nat . Pisa, p ag . 5.
1 894.
C h . Schlum berge r . N ote sur le g en re Tinopom s .
Mem . Soc . zool . de France . Paris , p . 87 , tav . 3 e 4.
1 896 .
P. L . Prever. Osservaz ion i sulla sottof am ig lia delle
Orbi toid inae . Riv. Ital. d i Paleon tolog ia. 1 904.
A . S ilvestri . Osservaz ion i cr i t iche sul g enere B acu
log ; p sina Sacc . Atti Pon t . Acc . Romana de i Nuov i
Lince i . Anno LVIII. 1 90 5 .
Il Menegh in i p er i l primo stud iò forme indubbiamen te appartenen ti aquesto genere , con siderandole com e appartenen t i alla so ttofam ig lia de lle
Orbitoid inae e dando loro i l nome d i Orbi toides cor nuta. Non so pe rchètale nom e non s ia stato conse rvato dai autori successivi , e tan to m eno
comprendo com e tali foram in iferi siano stati agg regati alla fam ig lia d elle
R otal idae , ove , insiem e con Gypsina , formano ora un g ruppo affatto isolato ,
con caratteri a sè , ne lla so ttofam ig lia d elle Tinopor inae . Forse i l fatto è
dovuto ad alcun i caratteri d i questo gene re , che io non consid ero pe rò
42 RIVISTA ITALIANA
affatto essenz iali , che sono comun i nella fam ig lia d elle Rotal idae , ma che
possono ben issimo trovarsi anche in altre fam ig lie d i foram in iferi , avend o
un valore affatto secondario .
C om e ho g ià de tto , 1’
essere il guscio forn ito d i pun te (org an i d i sosteg no o d i conduz ione) non cost ituisce affatto un carattere importante , m a sol
tan to forse un adattam en to d e ll’
an im ale a date cond iz ion i d’
am b ien te . Un
altro carattere , certo p iù e ssenz iale , può avv icinare le Rotal ia'
ae e le Orbi
toid inae , ed è l’
apparire in form e appartenen t i s i all ’uno che all’
altro g ruppod i pian i sovrappost i d i camere tte second arie ,
formate da tan te lam ine iso
late , alternan t i con que lle de i pian i con tigui , sulle quali si appogg iano .
Questo dà , all’
este rno , un carattere assai importan te d i som ig lianza, col
l'
apparire sulla superficie d ella conchig lia , d i un ret icolo , aven te ne i d ue
casi caratteri sim i li ed uguale orig ine ; anche p er la struttura in terna, quand os i consideri soltan to qualche framm en to d i sez ione trasversa o tangenz iale
d i sim ili forme di Rotalz'
d ae, si possono ben issimo confondere questi , con
framm en t i d i Or bi tanti , in cui non s ia v is ibile alcun a parte d i p iano equatoriale . Questo caratte re è forse il pm im portan te com une alle d ue fam i
g lie , ed è quello , sensa dubb io , che fece nascere la con fusione r iguardo ai
g eneri , che d ebbono essere asseg nati all'
uno piuttosto che all’
altro d e i d ue
a mop i .
Non credo che esso esista in alcun altro g ruppo d i Foram in iferi , e q ues to sarebbe forse una d elle prove d ella stretta affin i tà delle Rotal inae e
d elle N ummul itinae , d erivate probab ilm en te le une dalle altre , 0 m eg lio d a
una forma ancestrale un ica, che potrebbe forse id en t ificarsi con A rup /l iste
g ina. L’
un icO fatto che ve ram en te d ist ingue le form e d e i d ue g ruppi e, a
pare r m io , il carattere d e lla s imm e tria rispetto al piano in cu i sta la cam era
embr ionale , caratte re che , cons id erato con certa . larghezza d i vedute , si
osserva sem pre ne lle N ummul itinae , m en tre manca affatto ne lle Rolal inae .
Il genere Amph i .rteg ina qu ind i potrebbe forse considerars i com e una forma
d i passagg io fra le d ue fam ig lie , po ichè , com e ne lla N ummul i tinae , la sua
lam ina spi rale g iunge a r icoprire il cen tro d ella conch ig lia , s imm e tricamen te
r ispetto al piano d e lla cam era embrionale , m en tre essa si avvic ina alle
Rotalx'
nae pe r la mancan za d i s imme tria ne lla d isposiz ione d elle camere .
Il carattere d e lla simm e tria s i conse rva pure , alm eno in iz ialm en te , nelle
form e d erivate dalle due fam ig lie , cosi che , m en tre nelle Orbi taia'
inae le
came rette d e i pian i secondari sono d isposte p iù o m eno s imm etricam en te
rispetto a un piano m ed iano , d ifferen z iato o non , questo non avviene n elle
R otal ia'
ae , ove i pian i secondar i d i cam e re tte s i trovano so ltan to da una
parte d e lle cam ere princ ipali , che conse rvano la d ispos iz ione in spira svo lta,
RIVISTA ITALIANA
la simmetria propria alla fam ig lia a cui l'
an imale appartiene , d imostran d o
ch iaramen te quale sia la forma orig inaria, e p er quale causa essa ab b iad ovuto successivam en te mod ificarsi .
Non è m ia in tenz ione esam inare ora m inutamen te tutte le form e d e l
genere Gypsina ; d irò so ltan to che in tutte quelle da m e esam inate (G . g lo
bulus , G . vesicular is , G . m elobesioides) ho trovato form e in cu i la cam e ra
in iz iale è collocata al cen tro , e form e in cui essa è pm 0 meno spostata
verso la pe riferia. Tale spos tam en to si osse rva, naturalm en te , facendo un a
sez ion e che pass i pe r il cen tro e per il pun to d ’
attacco dell’
an imale (T av . III,
fig . 1 5 po ichè in una sez ione perpend icolare (Tav . III, fig . 1 3) a questa la
cam era s i trova sem pre ne l cen tro , spostandosi po i v ia v ia d i p iù quan top 1u la d irez ione d i una sez ione , obb liq ua ai d ue pian i accennati , si avv i
cina a quella d el prim o d i essi .
Tornando o ra ad esam inare i l genere B aculog ; gòs ina Ssec . , è im portan teosservare che mo lte d elle form e d i questo gene re , avendo assun te form e
strane ed irregolari p e r i l num ero , lo sv iluppo e la d isposiz ione varia d e lle
loro pun te , non s i prestano allo stud io d e i caratteri propri d el gen ere ,
pur essendo probabilm en te assai caratter istiche e qu ind i im portan t i paleontolog icam en te com e m od ificaz ion i specifich e . Lo stud io del genere B acalo
g ypsina d eve essere fatto princ ipalmen te sulle forme appiatti te e simm etriche ,
d i cui le altre non sono che leggere m od ificaz ion i ; non vog lio d ire con c iò
che in ques te ult im e non esistano i caratteri essenz iali d el genere ; soltan to
e assai d ifficile osservarli , non essendo d eterm inab ile , all'
esterno , il piano incui si possono fare le sez ion i ind ispensabi li pe r l ’ esam e d i tali caratter i ,
spesso pure mod ificat i in parte pe r la con torsione d e ll'
in tera conch ig lia.
O ra , una forma appiattita d i B acalogypsina , (Tav . Il . fig . 1 8 , esa
m inata ne lle d ue sezion i , equatoriale (Tav. III, fig . 1 e m erid iana ,
(Tav . III. fig . 3 presen ta i caratteri necessari , non soltan to p er essere
co llocata fra le Orbitoid iuae , ma pe rchè se ne possa chiaram en te d ed urre
l ’ orig ine da form e d e term inate d el genere S iderol i thes , che per con to m io
Bac :d og vpsrna sarebbe q uind i , secondo me ,il g enere che si or ig ina nell
’Eocene d al
S zderolrthes Lem k . ,i l q uale scompare appun to co l C retaceo , e p iù precisam en te col M aestri
ch t iano. Non so che cosa in tenda d ire il professore A . S ilvestri , asserendo che probab ilm en te
d el C re taceo potrebbe esse re caratter istica qualche forma di Calean'
na , o p iù esattam en te d i
S rde rolrllzes e q uind i tan to meno comprend o l’appun to ,
che“
, a tale rig uardo ,eg li cred e d i
poter fare alla m ia no ta su ques to g ene re .
i l S 1 lves tr i r it iene po i inesatta l'
ortografia d e lla paro la S iderolithes, invocando pe rc iò la
e t 1molog ia e l’uso g enerale ; ma io g li facc io osservare che cosi fu scri tto dal Lamarclt , q uand o
eg li ist ituì q ues to g en ere , e che cos i scr issero pure i prim i autor i , che se ne occuparono ,com e
Faujas d e Sain t F ond ,M on tfort , De france , e q ualche volta anche d
’
o rb igny . Non cred o q uind i
oppo rtun o fare alcun camb iam e n to, per q uan to q ues to possa essere insign ifican te .
DI PALEONTOLOGIA 45
si p uò r itenere una semplice mod ificaz ione d el genere N ummul i tes B a
culogypsina è indubb iam en te una de lle fo rm e che m eg lio c i mostra i legam i
esisten t i fra le so ttofam igl ie delle Nummul i tinae e d elle Orbitoid inae. Ne lla
parte cen trale no i ved iam o d elle cam e re seriali forman ti una spira assai
n e tta (Tav . III , fig . 1 —2 ) che m e tte capo alla cam era em brionale . La lam in a
spirale , ripiegandosi verso la parte in terna, forma i setti d iv iden ti le d iverse
camere seriali , che p er tal m odo d i formaz ione sono qu ind i cost ituiti da
una lam ina doppia. Il calcare secondario , attrave rsato da g rand i canal i , e
pm 0 m eno sv iluppato nelle d ive rse fo rm e e accompagna la lam ina in tutto
i l suo pe rcorso , facend osi p iù poten te ove questa, ripiegandosi verso la parteperi ferica, costituisce le pun te caratteristiche d i S iderol ithes . Più innan z i laspirale cessa, e ved iamo invece d e i cerchi concen tric i , p iù o m eno rego
lari , d i cameret te aven ti la d isposiz ione caratterist ica de lle Orbitaia'
inae .
Anche le pun te con t inuano ne lla parte esterna il loro sv iluppo in m odo
assai d iverso dal cen tro , po ichè vengono formate dal ragg rupparsi d i molti
pilastri in torno alle pun te d ella parte in terna, che vengono in tal modo
con tinuam en te accresciute e spo rgono dalla massa d e lle cam ere de lla con
chig lia (Tav . II, fig ,In sez ione trasversa ved iamo ne lla parte cen trale
la po rz ione nummu lit iform e (che p uò essere p iu o meno sviluppata) , in cu i
le lam ine si ricoprono p iù o m eno ev iden temen te ; in seguito le d ive rse ca
m e re tte , formate come nelle Orbi toid inae sono d isposte simm e tricam en te
sopra e so tto il piano equatoriale . (Tav . II, fig . 1 0 , Tav . III. fig . 3 , 4,
Le B aculogypsinae hanno d unque un piano equatoriale d iflerenz iato , se
non in tutta la sua estens ione , alm eno ne lla parte formata d i cam ere d ispostein spira in torno alla camera embr ionale . Tale piano equatoriale d ifferenz iatoesiste certam en te anche n e lle B acalogypsinae , la cui forma esterna, man
can te all'
atto d i simm e tria, rende quas i imposs ib ile il d eterm inarne la d irez ione . Esso può anche , m olte volte , segu ire le con tors ion i del resto della
conch ig lia ; infatt i , facendo una sez ione equatoriale d i B acalogypsina, in
cu i le pun te non g iacc iano perfe ttamen te in un piano , si vede anccra nelle
cam ere un accen no a d ispos iz ione spirale , ma assai confuso ; tale d isposiz ione si ved e po i varia e irregolare affatto ne lle sez ion i d i form e in cui le
pun te g iacciono in tan ti pian i d ive rs i. (Tav . III, fig . 5
I caratteri de l genere B a ulogypsina variano assai spiccatam en te ne i
successivi pe riod i , e m i spiace d i non ave rne la serie con tinua ,pe rchè se
A tale proposito , non comprendo perchè i’egreg io Prof. A . S ilvestri ( 18 ) n on g ind i
chi sufi cien te rnen te pr ovata asseg naz ione de l g enere a lle N ununulrtmae Io non conosco
altre fam ig lie d i F oram in iferi in cui si trovino i caratteri d i S iderol i thes, nè m i pare che alcun
carattere d i q uesto sia inconcep ib ile ne lla fam ig lia d e lle Nummuh ti nae .
RIVISTA ITALIANA
ne potrebbe forse ded urre un im portan te cri terio stratig rafico per il genere .
Cosi m i lim ite rò ad accennare che le B aculogypsinae p iù an tiche (Gassino )presentano num erosissim i esemplari mancan t i esternam en te d i ogn i s imm e
tria (Tav . II, fig . 2 0 ) e tale carattere va po i m an mano d im inuendo , cosi
che nelle form e v iven ti la simme tria è quasi sempre conservata. (Tav . III,
fig. 9 Le forme d e ll’
Eocene supe riore (Tav . Il , fig . 8 9- 1 3) d i C elebes
presen tano un carattere interm ed io , ind icando assai —bene la mod ificaz ioneche le B aculogypsinae sub iscono ne l tempo . In tutte le form e esam inate s i
man tengono costan t i alcun i caratteri , g ià notat i nelle form e d el gen . S idero
l ithes, e c iò m i con ferma sem pre p 1u nell’
opin ione che ques ti (contrariamen te a quan to asserisce i l S i lvestri ) avessero una certa importan za per
l’
an imale .
Le form e d i Siderol i thes , che han no generato Baculogyp sina, apparten
gono— tu tte alla serie A , che rappresen ta quind i probabilmen te i l g ruppo d i
forme p iù evo lute , e con tutta probabilità non una sola d i tali form e , ma
alm eno due d i esse , la Pret/ er i e la calc itrapoid es , hanno sub i to tale trasformaz ione ,
po ichè il carattere d ifferen z iale fra queste d ue , si man tiene purefra due serie d i forme d i B aculogypsina. Abb iamo c ioè una serie d i B acu
log ypsinae a quattro pun te , in cui queste possono assumere posizion i assaid iverse ; ne lle B aculogyp .vinae app iatt ite e s immetriche le pun te stan no per
lo pm ne lla posiz ion e caratterist ica d e i ram i d’
una croce , po tendo avere
sviluppo assai d iverso secondo g l i ind iv id ui , ed anche in un ind iv iduo
essere d iverse le une dalle altre . Possono po i spostarsi fuori d el piano equatoriale ,
fino a dare alla conch ig lia la forma caratterist ica d i tetraed ro, com u
n issima fra i fossili d i Gass ino (Tav . Il , fig . 8 , 9 , 1 3 , 1 9 , 2 0 , Tav . III,
fig . 9 , Un '
altra serie d i B aculogypsinae , in iziatasi probab ilm en te dalla
S id erol ithes calcitrapaides Lemk , ha invece un numero d i pun te m agg iore ;in generale però non sono pm d i se i le pun te ben sv iluppate in ogn i ind i
v iduo , benchè in alcune forme se ne vedano parecchie altre rud imen tali .
Anche in ques ta seconda serie d i fo rm e abb iamo ind ivid ui appiatt it i e sim
m etrici accan to ad altri mancan ti d i simm etria, ma questi ultim i presentano un tale carattere m eno spiccato ed io non li ho trovat i altro che fra
le form e fossili d i Gassino . (Tav . II, fig . 1 8 T av . III, fig . Ne i
tempi success iv i l ’ amb ien te mutato dovette certam en te favorire piuttostolo sviluppo d elle forme p iu simm e triche , poichè no i ved iamo che esse prendono il predom in io , ed assist iamo pure ad una rid uz ione graduale d i alcune
d elle forme irregolari , che , per adattam en to all’
amb ien te , perdono in g ran
parte i l loro carattere d i asimme tria.
Le B aculogyps inae sub iscono pure , col tempo , d elle variaz ion i in altri
48 RIVISTA ITALIANA
B a e u lo g y p s i n a B o n a r e l l i i var. t r i c u e p i d afl n n .
Tav. II fig . 1 3- 1 6 .
Forma a tre punte , g iacent i quas i in un piano , ne lla quale s i p uò segu ire
p erò lo sv iluppo reg ressivo d i una quarta, che doveva formare con questeun ango lo quasi retto. Tale fatto non è esclusivo d i ques ta forma, po ichèlo Schlum berger (8) lo ha g ià notato ne lla vive n te sua B aculogypsina F lo
r esiana , ma c i perm ette d i stabilire la d erivazione d i questa forma da un"al
tra a quattro pun te , che , pe r quan to asimmetrica, non posso assolutam en te
d istinguere specificam ente dalla B . B onarelli i 1 1 . f. No i possiamo in que
s ta forma avere ancora in ternam en te il residuo della pun ta, che p iù non
Sporge dalla massa delle cam ere , e anche quando tale res iduo scompare ,la forma rimane tuttavia as immetr ica, e cioè p iù rigonfia in corrispondenzad e l punto ove doveva prima esistere la quarta spina.
Nella fauna Numm ulitica esam inata si possono num erare parecchie formed i Nummuliti , tutte appartenen ti al sottogenere delle! s triate , Paronaea
Prev. Dall’
esame d elle form e , tutte g ià conosc iute , e c ioè : Paronaeaeleg an s Sow ., Paronaea venosa F et M . , Paronaea Guettard i d
’
Arch . , Pa
ronaea sub—B eaumon ti d . 1 . H Paronaea H eer i d . 1 . H . , Amph isteg ina N iasi
Verb .,s i p uò dedurre , quasi con certezza, l
’
e tà Barton iana del g iacimen to.
In questo si trovano po i d elle form e d el genere Lep idocy clina (L . Tourna
uer i , Lem . et Douv . e L . Provalei , 11 . f.) a d imostrare che i l genere non
appare soltan to nell’
O ligocene , ma g ià ne ll’Eocene superiore . S i trova an
c he una forma del genere L inder ina Schlumb . (L . Paronai , 11 . che p re
sen ta caratteri tali , che m i pare autorizz ino a r itenere che le Lep idocy clinae
d igo-m iocen iche non s iano forse una con t inuaz ione delle form e cre tacee , m a
abb iano piuttosto rapporti co l genere Linder ina. A ltro genere rappresen tatoabbastanza ampiam en te è B aculogyps ina , il quale presen ta caratteri tali da
essere collocato , insiem e con Gypsina , fra le Orbitoid inae , an zichè fra le
Dall ’ esame d elle form e appartenen ti al genere H eterosleg ina, m i parec he non si possa accettare la creaz ione d el nuovo genere Spi roclypeus Douv .
Nell’
ins iem e , i rapport i esisten t i fra le N ummuli tinae , le Cy cloclypeinae
e le Orbitoid inae s i potrebbero , secondo m e , riassum ere nel seguen te specc h ie tto
DI PALEONTOLOGIA 49
Gypsina
H e terosteg ina Lep idocycllna (C reta)
M i è dato ved ere ora, a d iscussione com piuta, i l lavoro d i H . Dou
v illé in cui eg li accenna brevemen te a parecch ie delle ques tion i , che
formano argomen to d ella m ia nota. M i compiacc io d i notare che , so tto cert i
pun ti d i vista, le ded uz ion i d ell’
i llustre paleon tologo collimano perfettam en te colle m ie : cos i eg li amm ette , senza d iscuss ione , che i generi Gy
psina e B aculogypsi na siano da co llocarsi fra le Orbitoid inae ; e ritiene
quale progen itrice d elle Orbitoid i str icta sensu (ch’
io non so d istinguere
per alcun carat tere da Lep idocyclina una forma aven te caratter i sim ili a L in
der ina , ch’
eg li trova nel C ampan iano dei d intorn i d i Be lves. È certo as
sai probab ile che anche ne l C retaceo la forma spiralata, che ha dato ori
g ine alle O rb ito id i , abbia dovuto passare p er uno stad io in term ed io qualesarebbe questo d i L inder ina ; men tre , com e ho g ià d etto , il non aver t ro
vato finora Lep idocy clinae p i u in basso d ell ’ Eocene supe riore , ed i carat
teri della Lind er ina B rug esi Sehlum ., che p iù l’avv icinano alle Nummu
li tinae , c i autorizzano a ri tenere che le Lep idocyclinae (cre tacee e oligoce
n iche) abb iano avuto o rig in i ind ipend en t i , da forme s im ili , ma in tem pid iversi .
Non altre ttan to cond ivido le idee d e l Douv illé , p er c iò che riguarda
la posiz ione sistematica d i tutte le Orbitoid inae , ch’
eg li fa derivare d ire t
tam en te dalle Rotal iclae . C om e ho g ià d etto a proposito d i Sz'a'erol ithes e B a
culogypsina, le N ununulin ictae d ifferiscono dalle Rotal in iclae essenz ialmen te
pe r la simmetria rispetto a un piano equatorale , simmetria che manca af
fatto nelle seconde , m en tre è , p iù o meno evid en tem en te , sempre conser
vata nelle prim e .
Non posso poi conven ire con lui riguardo alla d ifierenza fra N ummul i tes
e S ideroli thes , po ichè anche nelle N ummul ites , per il m eccan ismo stesso d i
formazione della spira, e d e i setti che d iv idono le d iverse camerette , tan to la
lam ina spirale come i sett i debbono esse re ugualm en te perforat i . C redo invece che la d ifieren za con sista essenz ialm en te nello speciale svi luppo del
calcare secondario , che da luogo in S iderolithes alla formaz ione d elle pun te :
RIVISTA ITALIANA
n ecessariamen te ci saranno d elle form e d i passaggio , in cu i le pun te ap
paiono soltan to come d en ticolature o add iri ttura non com paiono all’
esterno
d ella conch ig lia,. ma non so se con una d i queste si possa iden tificare la
S ideroli thes Vidal i Douv . , po ichè. 1 ’ autore ne d à soltan to una figura d ella
parte esterna, che potrebbe appartenere ben issimo anche a una N ummul i tes
o ad una Polystomella. Lo stud io d ei Foram in iferi è oramai g iun to a tal
pun to , che soltan to con sezion i numerose e praticate in d irezione varia s i
può tentare molte volte d i farne la d eterm inazione . Questa è pure una
delle ragion i p er cui ho creduto d i poter d ire che il d’orb igny non ha d e
scritta nè figurata la sua S idera/ ina laevig ata, d i cu i del resto non sono
riusc ita a poter vedere il modello
Ed altre ancora sono le quest ion i su cui d issen to dall’
opin ione d e l
noto paleon tologo francese , ma esse esorb itano dal m io argomento , nè ho ,
per ora, p rove sufficienti per poterle d iscutere.
RIVISTA ITALIANA
1 906 . I. Boussac Developpemen t et mo rpho log ie de quelques F ora
m inif e‘res de P r iabona. Bull. Soc . geol. de France , 4 , tomo V I, p . 96 ,
tav. II, fig . 1 5- 1 6- 1 7 - 1 8 , tav . III, fig . 1 9.
1 6 . 1 906 . H . DOUVILLÈ . Evolution et enclzatnements des F oram in ife
res. Bull. Soc . Geol. d e F rance , 4, VI , p. 589 , tav . XVIII.1 90 7 . A . S ILVESTRI. F ossi l i Dordon ian i de i din torn i di Term i n i
Imer ese (Palermo) Atti Pon t . Acc. Rom . dei Nuov i Lincei , Anno LX ,
p . 1 06 .
1 90 7 . A . S ILVESTR I. Rivista Italiana d i Paleon tolog ia. Perug ia,
Anno XIII, fasc . II, p . 55 . (Recensione della m ia Nota : Il g en . S i
derol ithes , Att i R . Acc . Sc . Torino ,
DI PALEONTOLOGIA 53
SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE
TAVO LA 1 .
F ig . 1 —2 A mp /zi s t e g i n a .V i as i (Verb .) (sez ione eq uatoriale) C e lebes3 (sez ione m erid iana)
4 eleg ans , Sow . (sez ione equatoriale)5 H eterosteg ina g labra 1 1 . f. (aspetto esterno )6 (sezione equatoriale )
g ranulosa (Bouss .) (sez ione merid iana) M .te Piano( Priabona)
8 N amm . (B rug n ien'
a) fi iclzteli M icht . (sez ione m er id iana) Borneo9 H eterosteg ina reticulata Rù tim . (sez ione m erid iana) C elebes1 0 ] .ep idocy cl ina Provalei 11 . f. (aspetto esterno )
1 1 ( sez ione equatoriale )1 2 (sez ione m er id iana)1 3- 1 4 Lind er i na Paronai 11 . f. (aspe t to esterno )
TAVO LA II.
F ig . 1 xl l iogypsina complanata Sch lum b . (sez ione equatoriale ) C o lli Torinesi2 (sezione m erid iana )
3-4 L inder ina Paronai 11 . f. (sez ione equatoriale ) Celebes5 (sez ion e m erid iana)6 Lep idocy el ina Tour nouer i Lem . et Douv .( sez ione equator iale )7 (aspe tto esterno )
8-9 B aculogyps ina B onarellu 11 . f. (aspetto esterno )1 0 - 1 1 (sez ione m erid iana)1 2 (sez ione equatoriale )
var . tr icusp idata n . (aspe tto esterno)
(sez ione m e rid iana)
(sez . equatoriale)sp . (sez . equatoriale) Borneo
(forma simmetrica ) (aspe tto esterno) Gassino
(forma as imme tr ica) (aspetto esterno )
V
V
V
V
RIVISTA ITALIANA
T AVO LA III.
1 —2 B aculogyp.rina sp . (fo rma simmetrica} (sezione equatoriale ) Gass ino(sez ione merid iana)
5—7 (forma asimmetrica) (se i . in pian i d ivers1 ,8 (sezione merid iana) V iv . stretto d i To rres
(aspetto esterno )
1 1 (sez ione equatoriale)1 2 Gypsina vesicular is Park. and Jon . (forma simmetrica) Gass in o
1 3 sp . (forma eccen trica) (sez ione normale ai pian i d i simmetr ia) Regg io Calab ria
(aspetto esterno)(sez . in un piano d i simm .)
DI PALEONTOLOGIA 55
DI ALCUNE NUMMULITINE E ORBITOIDINE
DELL ’
ISOLA DI BORNEO
M an oa u D I I R E N E P n evn .a
con Tav . IV -V I.
Dei Foram in iferi terz iaru d i Bo rneo g ia si occuparono parecchi stu
d iosi , ultimo i n ord ine d i tem po , Enrico Douv illé Nulla d irò d e i lavorian teriori a quello del Douv illé , avendone g ià quest i ampiamen te parlato .
Per la stessa rag ione non m i d ifl‘
ond erò sulla geolog ia d i Borneo , e solo
ricorderò che il T erz iario è in quest ’ iso la molto sv iluppato , e che fa parted i un bacino assai esteso che si prolunga all
’ovest nell
’
isola d i Giava,
nella Birman ia, nell’Ind ia e nell
’
Arabia, e che è un ito in parte a que llod ell
’Europa e dell
’
Asia, per m ezzo della Persia.
Il materiale che ho in esame fu raccolto pochi an n i or sono dal Con te
Dott . Guido Bonarelli, che lo inv iò in dono al R. Museo Geologico d i To
r ino .
I cam pion i sono num erosi , quasi tutti ricch i d i fossili , gen eralmen teben conservati , e provengono dalle seguen ti località
BORNEO MER IDIONALE
Poulo Soreng ; T ellok Bunk si t ; Pamoukan Bai ; Batu Lichien ; Tandjong Tam iang fra Sam alan takan e Tug iong Batu ; Tandjong Tam iang (T anah bumbu) se tt . ; S imbuang .
BORNEO ORIENTALE
Poulo M iang ; S . Mc lain , S . San tan ; Sounghe i Lembah (Bungalun ) ;Sounghe i K ele i , Berow ; San tan ; Gunung M lendon , K ari O rang ; BatuGh ian , S . San tan .
BORNEO C ENTRALE
Oedg ioe Halang sopra Lo ng Iran Talikor presso Raman . Bocajoer.
1 905 H . DOUV ILI.È , Le s F orann n i/ eres dans le Ter l iarre de Bormio. Bull . d e la Soc .
Géo l. d e F rance , 4e s . , t . v ., pag . 436 .
56 RIVISTA ITALIANA
Fin ’
ora m i sono occupata d ello stud io de lla collez ione proven ien teda Oedi oe H olang sop ra Long I ran , che è la p iù ricca d i tutte . 1 fossili ,
abbondan tissim i , sono com pres i in una m am a d i colore g rig io scuro , fina
m en te sabbiosa , con parti p iù com patte concrez ionate . Ques te m arne cou
tengono pure d e i C orollari , d eg li Ech inode rm i (placche e cidariti) , dei
Briozoi , de i piccoli Gasteropod i e deg li avan z i d i Pesc i ( ictiodoruliti).T ra i F oram in iferi sono abbondan t i le N ummul ites e le Assi linae : e
si può d ire , che i tre quarti d e i foss ili sono rappresen tati dalle coppie d i
due nuove form e d i N ummul ites e dall’
Assil ina M adar risz i , Han tk en , delle
quali , e specialmen te de ll’ultima, d ispongo d i parecchie cen t inaia d i ind i
v idui . In siem e con le N ummul ites , v i sono d elle Opercul inae , molte Or
thoph rag m inae , d elle Lep idocyclinae , rare H eterosteg ina e rare Gypsi
noe .
Per lo stud io delle N ummuli tes seguo la classificaz ione de l Dott . P. L.
Prever , che d ivid e il genere N ummul i tes in Camer ino e Len t icul ina , sud
divisibi li nei sottogeneri B rug uier ia e Laharpeia, Gambel ia e Paronaea, i
quali rispe ttivamen te com prendono le Nummulit i ret icolate ,le reticolate
g ranulate , le striate g ranulate e le striate .
Ho trovato d elle Paronaeae , alcune Gambel iae , nessuna B r ug uier ia e
nessuna Laharpeia.
Le form e da m e esam inate sono le seguen ti
1 . Num m . (G timbe lia) Formai 1 1 . f.
(Paronaea) Prever i 1 1 . f.
Paronaea) Osimoi 11 . f.
(Paronaea) sub -Beaumon ti , d . 1 . H .
(Paronaea) sub -Airagh i i Prever.
(Paronaea) m am illa (Ficht . et Moll) .Assilina M adaràszi (H an tken ).
Ope rculina pyram idum Eh remb .
H e terosteg ina reticulata Rtl tim .
O rthoph ragm ina varians K aufmann .
O rthop hragm ina sella (d’Arch iac ).
Archiac i Sch lumb .
lanceolata Sch lum b .
scalaris Sch lumb .
1 90 2 Pnn vs n I’ . L N ummuli ti de lla F orca d i Presta e d r Poten za. G inevra M ém .
Soc ieté Paleon t . Suisse XX IX .
RIVISTA ITALIANA
B eaumon ti d . H . e la N . (Paronaea) sub-A irag bn Prever. La prima d i
queste form e si trova ne i giacimen ti de l Lutez iano m ed io e superiore di
Gassino , ed insiem e con l’
omologa N umm . (Paronaea) cr ispa Ficht. et
M oll , costi tuisce una d elle coppie p iù com un i del Luteziano super iore e de l
Barton iano inferiore .
La N unn » . sub—Airag ln‘
z'
Prever fu trovata la p rima volta nel Lute
z iano superiore a Forca d i Presta. Con queste form e v i sono , come ho
accennato , molte Or thophrag m ina queste com paiono con l’
Eocene , si tro
vano in tu tto questo peri odo , e pare non abbiano per ora un grande va
lore stratigrafico . Part icolarm en te abbondan t i tra esse , sono l’
Or thophra
g m ina var ians K auf. e l’
Or thoph rag m ina sella Gambel ; la prima è d iffusain tutto l
’
Eocene , la seconda e comun iss ima neg li strat i ad O rb ito id i d i
Priabona. Le Or thophrag m inae, secondo l’
opin ione de llo Schlumberger, delVerbeck , del Douvillé e d i altr i , sarebbero caratteris tiche dell
’
Eocene ,
scom parend o con esso . C iò p erù , solam en te in via generale , po ichè il Dottor Prever trovò d e lle Or lhopbrag mz
'
nae nell’
Oligocene inferiore , a Manerba
( lago d i Garda) e a M . Berico presso Vicenza. Data però l ’ abbondanza d iesse nella località in questione , e con siderando che iv i le Ori hopbrag m inae
sono assoc iate con Nummul iles eocen iche , si può ritene re trattars i d i un
so ttop iano d ell’
Eocene superiore .
H o accen nato pure alla presenza d i alcune Lep idoey d z'
nae come la Lepid .
d i latata (M ich). var . Sch lumberg en'
(Lem . e t la Lep id . Tour n0uen
Lem . e t Douv . e la Lepid . Raul im'
Lem . e t Douv . F in’
ora si riteneva
che le Lep idocy eh‘
nae com inc iasse ro con l'
Oligocene , nè io posso qu i afi'
er
mare ch’
esse s i trov ino nel so ttop iano in questione , poichè m i furono dateg ià separate dal resto d e l m ateriale , e po iché si tratta d i forme trovate
fin ’
ora solo in terren i p iù g iovan i . C redo però bene d i accennare a que
sto propo sito , che a Dongala, presso Parig i , nel Nord -Est d ell’
isola di
C elebes , la Dottoressa G iuseppina Os imo trovò in uno stesso camp ione
d elle Lep z'
docy cl inae com e la Lep id . Tournouer i Lem . e t Douv . , e la Le
p id . P rovala"
O sim o associate a forme d i N ummul ites com e la A'
. eleg ans ,
la N . venoso ,la N . sM -B eaumo nti , la A
'
. Guettard i , la N . H ee n'
ecc ., tutte
indubbiam en te eocen iche . Ed io pure , in un’
altra località d i Borneo ,d e l
cu i stud io m i occupe ro in segu ito , ho trovato in uno stesso campionede lle Lep idory elz
'
nae e de lle 0 r thop /zm g m z‘
x ae , p er cui bisogna ammettere o
che le 0 r t/xop lzrag m z'
nae passino n ell’O ligocene , o che le Lep idoey el inae s i
trov ino g ià nell’
Eocene supe r iore .
Pr ima d i ven ire all’
esame de lle s ingo le forme , m i è g rato porgere i
m ie i sen ti t i ring raz iamen t i al Con te Do tt . G u ido Bonare lli che raccolse i l
DI PALEONTOLOGIA 59
materiale , al Prof. C . P. Parona che m e lo affidò e che m i fu prod igosempre d i consig li e d i aiuti , al Dot t. P . L. Prever che m i in iz iò in quest istud i e che m i fu guida nel m io lavoro , e al S ig . Ern esto Forma che ese
gui le fotog rafie .
N u m nn . Paronaea) m a m i l l a Ficht . et Moll sp .
Tav . IV , fig . I.
1 80 3 Nauti lus n tam illa . F ich tel e t M oll , Testaeea m icroscop ica ,p. 53.
tav . V I, fig . a, b , c , d .
1 850 N ummulina mam illafi s . Rutim eyer , L’eber das Schw eiz . Numm .
Ter rain , ecc ., p. 8 1 , tav . III, fig . 3 1-
32 .
1 850 N ummul i tes Rfitimey efi . d’
Archiac , H ist . des prog rès de la g éol .,tav . III, p . 242 .
1 853 A'
ummul ites Ramond i , var . d . d’
Arch iac et B aime , M onog r . des
N umm . , p . 1 28 , tav . V II, fig . 1 7 , a,b.
1 866 -69 N ummul i tes d’Archiac , Asie M z
'
neure un Tchibachefii ) p. 242 , tav . IX , fig . 5 , a, b , c .
1 883 N umm ul i tes Rfitimever i d’
Arch . F . de la Harpe , M onog r . der
i n Aegypk n and ] .ybz'
sehen Wiiste, eee. p. 1 63 , tav . XXX ,
fig . 9 a 1 1 .
1 90 2 Paranoea m am i lla F icht. e t M oll. P . L. Prever , Le N ummul it i della
F orca d i Presta e dei di n torn i d i Potenza , Mem . de la Soc .
Pal. Suisse , Vo l . XXIX , p . 87 , tav . IV . ,fig . 2 6- 2 7 .
Diam e tro m m . 5 Se tti 5 a 6 in 114 del 4
°g iro
Spessore mm . 2 6 a 7 50
Giri d i spira 7 su un ragg io d i mm . 2 I l: 6 a 7 6°
Se tti 3 in d el 2 ° g iro 5 a 8 70
» 30 »
L’
un ico esem plare ch no posseggo d i questa specie , s i avvicina molt is
s imo alla d escr iz ione ed alla figura che d i d e tta spec ie dà i l Prever nella
g ià citata opera. La conchig lia è len t ico lare , rigonfia, a spessore che d e
cresce regolarm en te dal cen tro al m arg ine . Sulla supe rficie s i trovano nume
rose strie , ben v is ib ili , rad ian ti dal cen tro , irregolari e con andamen to vario .
La spira e irregolare , i l passo spirale cresce rapidamen te ed irregolar
m en te sino al penultimo g iro . La lam ina spirale ha spessore m in imo ne i
prim i g i ri , che cresce no tevo lm en te e in m odo irregolare sino alla perife
60 RIVISTA ITALIANA
ria. I sett i , com plessivamen te poco numerosi , sono p er lo p iù irregolar i ed
inequid istan ti , non sottili , rigonfi leggermen te verso il pav imen to della ca
m era, sottili ne l loro tratto m ed iano , ingrossati verso la volta, d iritt i o leg
germen te ri curv i , quasi perpend icolar i alla d irez ione d e lla lam ina spirale conla quale determ inano un angolo postero-superiore acuto , talvolta legger
men te arrotondato . Le came re non numerose , sono sub —regolari o irrego
lari , assai p iù alte che larghe , supe riorm en te fatte a volta, e com plessivam en te sub—rettango lari .
N u m m . (Paronaea) s u b -T e l l î n i i Prev .
Tav . IV ,fig . 2 .
1 883 N ummul ites sub—B eaumon t i de la Harpe op . c it . , pag . 2 8. tav . Il ,
fig . 48-56 .
1 90 2 Paran oea sub-Tell im'
z'
Prev . P . L . Prever , op . cit , pag . 78 , tav .
V II , fig . 8- 1 2 .
Diam etro mm . 2 Se tti 4 in 114 d el 2 0 g iro
Spessore mm . 1 c irca 4 30
G iri d i spira 4 su un ragg io d i 1 mm . 5 40
Se tt i 3 in 114 d el 1 ° g iro
I poch i esem plar i d i questa spec ie presen tano una picco la conchig lialen ticolare , p iù o m eno rigonfia, a marg ine sub-arro tondato . La superficieè ornata da strie rade , rad ian t i dalla parte cen trale , sub —re tte , equid istan t i ,non sem pre ben v isib ili . La spira è regolare , il passo sp irale cresce rego
larm en te e len tamen te s ino al marg ine . La lam ina spirale , spessa sin dal suo
in iz io , cresce d i poco sino al penult imo g iro , d ecresce sensibilmen te ne ll’
ul
timo . La cam era cen trale , d i g rand ezza m ed ia, è sub—circolare ; la primacam era seriale e irregolarm en te sem icircolare .
I setti sono piuttosto rad i , d i no tevole spessore , retti ne l primo tratto ,
leggerm en te r icurv i ve rsa la volta d ella camera, regolari , equ id istan ti . Sonoben v is ibili i fog l ie tt i se ttali tra i quali spesso appare il canale settale . I
setti sono r igonfi e r ipiegat i all ’ in d ie tro verso l’
es trem ità , p iù so ttili nel
loro tratto m ed iano, e nuovam en te s
’
isp essiscono avvicinandosi alla lam ina
alla quale si saldano in t imam en te , d e term inando un angolo postero-supe
r iore quasi retto , arrotondato . Le cam e re , non numerose , sono regolar i , d i
poco p iù alte che larghe , e com plessivam en te sub -rettango lar i .
62 RIVISTA ITALIANA
cam era. Sono eviden ti i fog li se ttali , e cos ì pure le comun icaz ion i tra due
camere con tigue . L’
angolo postero-superiore è sub —re tto , arrotondato . Le
camere , non sem pre regolari , sono sub-ret tangole o falciform i . La sez ion e
m erid iana s i presen ta come un ellisse p iù o meno rigonfia, e talvolta add i
rittura sch iacciata. Le d iverse lam ine d’accrescimen to si assot t igliano ne lla
parte cen trale dove si saldano in timamen te 1’
una con l’
altra. Questo fattoè poi ev id en tiss imo per l
’ult im o g iro , nel quale la lam ina, prima d i rico
p rire la lam ina so ttostan te , si assott ig lia tanto da essere v isib ile so ltan to
con forti ing rand im en ti .
Questa N ummul ites ricorda la N amur. To um oaerz'
d e la Harpe per
le d imension i , pe r l’aspetto esterno , pe r la sez ione m erid iana, pe r l
’
anda
men to operculin iform e de lla spira, e p er lo spessore pressochè costan te
d ella lam ina spirale . Ne d ifi'
erisce però pe r le magg iori d imension i della
camera cen trale , pe r i setti p iù spessi verso la volta della camera, e pe r
l’andamen to de i sett i stessi , che nella N amm . Toum ouen
'
sono rettilinei
in tutto il loro pe rcorso , e s’
incurvano po i bruscam en te , d irigendosi per un
certo tratto quasi parallelamen te alla lamina spirale . prima d i saldarsi ad
N u m m . (Paronaea) O n im o i n .
Tav . IV ,fig . 3
—5.
D iametro da 4 a 7 mm .
“
Setti 3 a 4 in m del 2° g iro
Spassore da fi, a x mm . 4 a s » » 3°
G iri 4 su un raggio d i z mm . 5 a 7 » »
Se tt i a 3 in del 1 ° g iro
Ques ta Nummulites , che per l’aspetto esterno si con fonde facilmente
a tutta prima con un’Opercul ina , presen ta una conchig lia len t icolare , de
pressa, sottile , a margine sub—tag lien te o sub—arrotondato , a superficieornata da strie sottili , irregolari , sub-rette , o ad S
, o falciform i , talvolta
sudd iv ise in altre p iù sottili , non equid istan t i . La spira,regolare , ha passo
spiccatamen te operculin iforme sin dal suo in iz io . La lam ina spirale , h a spes
sore che cresce len tam en te e qua e là irregolarm en te , dall’
in terno all’
es
terno . I sett i sono sub -regolari , re tti p er tutto il loro d ecorso , e solo si
incurvano a sem icirco lo là dove s’
inseriscono alla lam ina spirale alla quale
1 88 1 , DE LA H ARPB . Étude des N um alr'
tn de la Suisse, M ém . de la Soc . Pal. Suiu e ,
Vol . V II, pag . 1 66 , Pl. V l. fig . 1 2-2 1 .
DI PALEONTOLOGIA 63
s i sald ano in timamen te . Rigonfi alla base , s’
assottig liano in seguito , per
ingrossarsi no tevolmen te e gradatamen te verso la volta della camera. Ev i
den t i sono i fog lietti settali . L’
angolo postero -super iore è acuto , legger
men te arro ton dato. Le cam ere , sub-regolari o irregolari , sono sem pre p iùalte che larghe , specialme n te neg li ultim i g ir i in cui l
’
altezza e tre o quattro volte magg iore d ella larghezza. Sono sub-rettangole ne i prim i g iri, falciform i nei seguen ti . La sez ione merid iana mostra un e llisse assai allun
gata e depressa , e presen ta tutt i i caratteri accennati per la forma omologa.
N u m m . (Paronaea) P r e v 0 r ì 11 . f.
Tav . IV , fig , 9- 1 1 .
Diametro da 1 I; : a 3 mm . Sett i 4 a 5 in q., del 2° g iro
Spessore da x a 2 mm . 6 a 7 » »
Giri 5 su un ragg io d i 1 ‘la mm . 7 a 8 4°
Setti z a 3 în ’u del I° g it 0 8 8 3 5°
Questa forma presen ta una conch iglia len t icolaxe , molto rigonfia, a mar
g ine sub-arrotondato , provv ista d i um bone , e ornata da numerose strie
sub—regolari , generalmen te ben v isib ili , sub -re tte o a forma d i S . La spira,regolare ha passo che cresce regolarmen te dal primo al secondo gi ro , e
che si man tiene pressochè un iforme nei g iri successivi. La lam ina spirale ,regolare , piuttosto sottile , aumen ta in spessore fino al secondo g iro , si arre
sta in segu ito . I sett i sono abbastanza n umerosi , sottili , regolari , rigonfi
leggermen te alla base e verso la volta de lla camera, sub-retti , quas i perpend icolar i alla d irez ione della lam ina con la quale de term inano un angolo po
stero-superiore sub retto , arrotondato . Ben v is ibili i fogl ietti se ttali . Le
camere sono regolari o sub-regolari , p iù alte che larghe , leggermen te fatte
a volta. In sez ione verticale si ha un’ellisse rigonfla ; …le lam ine d
’accresci
men to , d i notevole spessore , s i saldano in timamen te tra d i loro solo per
brevi tratti , e aumen tano in spessore dalla pe riferia al cen tro . Un fascio d i
pilastri s ’irrad ia dal cen tro d e l piano equatoriale e giunge s ino alla perife
ria determ inando sulla supe rficie un umbone .
N u m m . (Paronaea) s u b -P r e v e r i 1 1 . f.
Tav . IV , fig . 1 2 - 1 5.
Diame tro 3 mm . Giri 5 su un ragg io d i 1 il: mm .
Spessore 1 mm . Setti 3 in ’I4 del 1 ° g iro
64 RIVISTA ITALIANA
Sett i 4 a 6 in !p del 2
°g iro Sett i 5 a 7 40
La conch ig lia è len ticolare , rigonfia, a marg ine acuto , priva d i umbone ,ornata da n ume rose strie a forma d i S . La spira è regolare , il passo Sp i
rale cresce un iformemen te e len tamen te sino all’ult imo g iro , talvolta si
man tiene costan te d epo il terzo giro. Anche la lam ina spirale , p iù spessache nella form a omologa, ha uno spessore che può crescere sino alla
'periferia , o mantenersi costan te dopo il terzo g iro . 1 se tti sono sottili , poconumerosi , sub—retti , leggerm en te rigonfi alla base , p iù spessi verso la volta
d ella camera, quasi perpend ico lari alla d irezione d ella lam ina spirale alla
quale in timamen te s i saldano . L’angolo postero—superiore è sub -retto , arro
tondato . La cam era centrale ha m ed ia g randezzaed è c ircolare , la primacamera seriale e falciforme . Le camere , sub—regolari , sono p iù alte che lar
ghe , leggermente fatte a volta, sub—rettangolari . In sezione verticale s i ha
un’ellisse rigonfia ; le d iverse lam ine , p iù spesse al cen tro che al marg ine ,
si saldano tra d i loro solo p er breve tratto p er cui le camere sono molto
grand i .
Questa forma e la sua omologa s i avvicinano pe r alcun i caratteri alla
N unm r. deser ti d e la Harpe e alla 1Vumm . (Bm g uiefi a) Capeder i Pre
ver Della prima ricordano l’
aspetto esterno , le d imension i , la regola
ri tà della spira, lo spessore della lam ina, d ifi'
erendone p er l'
andamen to
generale d e i setti e per i l m inor num ero d i g iri di spira. Alla N amm . Cd
peder i s i accostano per le d im ension i , p er la regolarità d e lla spira, per lo
spessore della lam ina spirale ; ne d ifferiscono per l’
aspetto esterno , per
l’andam en to dei set ti , assai meno ricurv i , e p er la form a complessiva delle
cam ere . Questa forma è abbondan tissima, p iù della sua om ologa.
N u m m . (G timbelia) s u b -F o r m a i n .
T av . IV , fig . 1 6-ao .
Diam etro da 1 mm . a 2 *la mm . Se tti 3 a 4 in 1
14 d el 2°g iro
Spessore da mm . a 1 mm . 4 a 5 3°
Se tt i 2 a 3 in 114 d el 1
°g iro
1 883 , N ummuh les deser lz, d e la Harpe ,F . d e la Harpe , M onog rafi a? der in Aeg rpten
und der l iby schen M iste vorbommen den .Vumm lrlen , pag . 2 3 , tav. XXX I ( l l ) fig . 2o—25.
1 90 2 , Bm g m‘
er ia Capede n , Prev .,P . L . Prever , op . ci t . , p ag . 24 , tav . I , fig . 4.
66 RIVISTA ITALIANA
damen to d ei sett i , p er le d im ens ion i d e lla camera cen trale , e dalla quales i d iscosta p e r la spira p iù operculin iform e , pe r l
’
aspetto esterno , pe r la
fo rma e per le sue m inor i d imens ion i .
Essa infine , per le d imension i , p er la forma e p er l’
aspe tto esterno ,
s i accosta alla N umm . (Gzîmbel ia) parva Prever (uguale N amm . Donvi t
tei Vredenburg (pars) , dalla quale si d ifferenz ia p er i caratteri in tern i
n ella pam : la spira non è operculin iform e , la lam ina spirale e p iù spessa,
i se tt i‘
assai m eno ricurv i e p l l.l numerosi , le cam ere com plessivam en te
rettango lar i .
A a s i l i n a . M a d a r r'
ms z i H an tk en .
Tav . IV ,fig . 2 1 -24 ; Tav . V , fig . 1 -4 .
N ummul ites Al ad ara'
sz i H an tk . H an tk en ,D ie F auna der Ctavutina
Szabé i …Se/richten , p . 86 , tav . X VI , fig . 7 a, 7 b , 7 c.
Ass il ina M ad ara'
sz i H an tk . A . T ellin i , Le Namm zd it id i della M a
iella,Isole Trem i ti e p r om . Garg an ico, Boll. S . G . i . , IX ,
p . 40 ,
tav . XIII , fig . 1 6 .
Ass il ina Aladardsz i H an tk . Schubert : in d . .è. Reichsanst ,
pag . 84.
Assi l ina fl! ad ara'
sz i H ANT K . ,P. Oppenhe im , D ie I ’
r iaòonaselz. ihre
F auna ecc . , Palaeon tog r . XLVII , p . 42 .
Pellat isfl ra Douvi l lei Boussac , e t Pellat is) ira fl! ad aro'
sz i (H an tlc.)Boussac , Developpem en t et M orpholog ie de quelq ues F or am in ife
res de P r iabona, Bull. Soc . Geo l. de F r . 4 s. , t . V I, p . 9 1 ,
tav . V I, p l. II, fig . 1 0 - 1 4.
Il Boussac , ne l lavoro ora citato , fa d i questa forma un nuovo genere
al quale d à i l nom e d i Pellatisp ira. Eg li s i fonda pe rc iò sul fatto che il
cordone sp irale appare com e sosti tu ito da una cresta spirale sporgen te .
A m e pare che c iò non s ia cos i im portan te da g iustificare la formaz ione
d i un nuovo genere . In fatti , la cresta spirale e data un icam en te dal calcare
secondario , che presen te , e p iù o m eno sv iluppato , in tut te le N ummul i ti
nae , assum e nell’
Ass i l ina in questione , un notevole sv iluppo , ed una carat
terist ica strut tura fibrosa , che in proporz ion i m inori , appare de l resto anche
1 90 2 , G timbel ia pom a Prev P . L . Prever , op . c it., p . 68 , tav . V II,fig . 1 e 2 .
1 906 , N ummuh te s Doum'
lte i , E . V red enburg , Recor ds of the Geolog ical S u r vey of Ind i a ,
Vo l. XXX IV , Parte II, p. 79 , tav . 8 , fig . 9 , 9 a, 1 0 , 1 2 , 1 2 a , 13 a.
DI PALEONTOLOGIA 67
in altre Assi l inae e À’umm utites ( .Vumm . g ranulosa d
’
Arch iac e N umm . Ley
nu r ic i d’
Arch .) Questo , secondo m e , è un buon issimo carattere spe
c ifico , m a nu lla p iù . L’
Assitina M ad ar dsz i Han t . ha veram en te de i carat
teri a sè , che possono ricordare talvolta anche le Orbi toid inae , ma si tratta
d i caratteri non costan t i nè sem pre ben d efin i ti , pe r cu i se essa d eve con
siderarsi com e una spec ie in teressan te , pe rchè p uò fare in traved ere , com e
ora accenne rò , d e i passagg i tra le d ue so ttofam ig lie , non p uò asso lutam en te
cost ituire un nuovo genere .
Sarà bene ved ere quali sieno i caratte r i d elle due so ttofam ig lie , per va
lutare l’
imp o rtan za d e i caratte r i d e lla nostra Ass i l ina.
La fam iglia d e lle .Vamm al in idoe s i può d iv idere n elle due sottofam i
g lie d e lle .Vumm ul i tinae e de lle Orbitoid z'
nae.
La prim a è caratterizzata dall’
ave re un solo piano d i cam ere d isposte
secon do una spirale . Le cam ere , d i forma e d im ens ion i variab ili , sono separate le une dalle altre da sep im en t i format i dal ripiegarsi d e lla lam ina sp i
rale , che , ne l piano m ed iano , non s i salda alla lam ina preced en te lasciando
un orifiz io che serve alla com un icaz ione d elle camere fra d i loro . Questasot to fam iglia s i d iv id e in d ue g ruppi : N ummul i tes , in cui le lam in e si rico
prono sino al cen tro e Assil ina ed Operculina , in cui le lam ine s i r icopronosino al cen tro , so lam en te ne i prim i g ir i d i spira , m en tre ne i g iri successiv i
si accollano le une alle altre ,v ic ino al m arg ine d ella conch ig lia. I se tt i e
la lam ina sono pe rforat i , e dove le lam ine s i sov rappongono , i pori si contrnuano dall
’
una all’
altra,formando d e i canal i con tinui , che dal piano
equator iale , spec ialm en te dalla parte cen trale , g iungono alla perifer ia. Q ue
st i canal i possono ispessire le lo ro paret i e dare orig ine ai pilas tri . La
sottofam ig lia d e lle Orbitoid inae è carat ter izzata dall’
avere parecch i pian i d icam ere . Le cam e re d e l piano m ed iano non sono p iù d isposte a spira, ma
in cerchi concen tric i , e quelle d i un g iro sono pe r lo p iù alternate con
que lle d e i g iri con t igu i . Le cam e re laterali sono d isposte in strat i concen
tr ic i ma non con tinui , p er mod o che le cam ere d i uno strato si adden
trano neg li spaz i lasc iati fra le cam ere tte d e i due strat i con t igui. Le cam ere
lateral i si sov rappongono in colonne d ir itte che dal piano equatoriale g iungono alla superficie . La so ttofam ig lia d elle Orbi toid inae si p uò d ivid e re in
d ue g ruppi : il prim o , che ha pe r t ipo le 0 r thop /xr ag nzinae , in cu i le ca
m ere d e l piano cen trale sono sub —rettangole , e in cu i le cam ere d i un g iro
non s i ad d en trano in que lle d e i g ir i con t igui ; il secondo , che ha per t ipo
1853 , fi ! onog rap lue des .a mu lrtes, d’
Arch iac et M aim e , p l. IV ,fig . 1 7 ; p l . X I, fig . 1 0 c.
RIVISTA ITALIANA
le Lep idoq l inae , in cui le cam e re tte d e l piano equatoriale , aven t i form a a
q uad ran te ,sono d ispo ste come le cam ere tte seco ndar ie .
T alora , ne lla parte cen trale d el p iano equator iale , appare un accenno
alla d ispos iz ione spirale , ma in sez ione m erid iana non si vedono le d iverse
lam ine che si ricoprono . I pilastr i , quasi sem pre presen ti , sono dat i dal
l'
ispessim en to d e lle pare t i de i canali 0 d e lle camere sovrappos te. Ess i s i
origi nano dal piano equator iale o da p ian i laterali , g iungo no s ino alla periferia o si arres tano prima, talvolta si bi forcano , si saldano tra loro in vario
mod o . Sulla superfic ie es terna essi form ano d e lle g ranulaz ion i tra le qualiv
’ba un ret ico lo com plesso le cu i mag lie sono date dalle cam erette aper te
d ello strato p iù es terno . Form e d i passagg io t ra queste d ue so ttofam ig lie ,
s i hanno ne l g ruppo de lle Cy cloelypeinae (Lind er ina e Cy cloetvpeus) . Questehanno , com e le Nummul itinae , un solo piano d i camere che assum ono peròla d isposiz ione caratteristica d elle Orbitoid inae . F ra le esse
s i accostano d i p iù alle Assi l iaae e Opere:: tinae po ichè , com e in queste ,le
lam ine che lim itano i success iv i g ir i , s i ricoprono fino al cen tro , ne i pr im ig iri d i cam e re , m en tre ne i seguen t i si accollano sem plicem en te al marg ine
d el cerchio p roced en te . Nelle C} ctoclypeinae sono assai sv iluppati i canali
che g ià ne lle N ummul i tinae m ettono in com un icaz ion e il piano d i came re
con l’esterno . Essi assumono q ui d im ens ion i assai m agg iori , acqu istano
paret i in generale assai v isibili , e una tale d isposizione pe r cui danno alla
supe rficie 1 ’ apparenza d i g ran ulaz ion i in r ilievo , c ircondate dallo sbocco d iparecch i d i quest i canali . Questo carattere s i osserva pure assai bene ne l
I'
Assitina M ad ar a'
sz i H an tk ., e sarebbe , secondo il Douv illé pm spiccato nel suo nuovo g enere A rnaud id ta , che non ho po tuto fin ’
ora esam i
nare , ma che segn erebbe , secondo la sua descriz ione , anco ra un term ine d i
p assagg io fra l’Assil ina fl! adar dszi e le Orbitoid inae . Veram en te il ge nere
A rnaud ietta s i trova fin’
ora solo ne i d epositi cre tace i , ma anche in ques t iv i sono form e de lle N ummul it inae e d e lle Orbitoid inae , ed è naturale che
v i s i trovino anche le form e d i passagg io . Nella d escriz ione della Spec ieved remo ancora altr i caratteri che possono farc i in traved e re i legam i tra le
due sot tofam ig lie .
C on ch ig lia len ticolare , a d iam e tro da 2 a 7 m m . e spessore da 'I? a
1 ilz mm . Alcun i esemplari han no conch ig lia d epressa , talvol ta legge rm en te
se lliform e e con torta , ornata da un solco spirale , p iù o m eno v is ib ile , cor
H . DOUVILLÈ , E vo/atro» et E ncha î nen evd des F oram rmferes , E x tr . d u Bull. d e la So c .
Geol. d e F rance , 4 s ., t V l. pag . 599 , fig . 1 1, 1 2 , tav . XVIII, fig . 1 0 -1 7 , 190 6 .
RIVISTA ITALIANA
come un pav im en to alla cam eretta, va a cong iung ersi co l set to preced en tela cam era appare quind i chiusa , e le comun icaz ion i tra due cam ere con ti
gue ,sono date un icamen te dai canali che solcano la lam ina. Il canale se t
tale segue I’
andam en to d ella lam ina e circonda pure tutta la cam era.
Questo fatto ricorda un caratte re d i Cycloelype us e , se fosse costan te ,
avrebbe una g rand e im portanza , perchè , probab ilm en te , darebbe passagg ioad un accrescim en to s im ile a quello d i Cyetoetypeas , c ioè per cerch i con
cen tric i , anz ichè a spira come ne lle N ummul i tinae . Del res to ciò si osse rva
talvolta anche in altre Assil inae , N ummul ites e Opercul inae . pe r cu i non
costi tu isce un carattere gene rico , ma solo un accenno che potrebbe ind icareun passagg io tra le N umm uli tinae e le Orbitoid inae . T ra il calcare second a
rio e la lam ina sp irale è ben v isibi le i l canale spirale , talvolta in te rrot to ,
dal quale partono altri canali m inor i , che spesso si in trecc iano tra d i loro ,
d eterm inando una vera rete d i canali ne l calcare secondario .
H o esem plar i m icrosferic i ed esem plar i m egasferici . I pr im i , com e in
generale , sono p iù g rand i , i second i p iù p iccoli . La cam era cen trale , d i
grand ezza m ed ia, è sub—c ircolare . Le cam ere ser iali sono sub —regolari o ir
rego lari , sub —re ttango le , fatte a volta. Spesso dalle pare t i laterali e dalla
volta delle camere partono num erosi e sott ili canali rad iali . I laterali fanno
capo generalmen te ne l canale settale , g li altr i , sudd iv idendos i in ram i m inor i ,
possono attraversare tutto i l calcare secondario . La camera è cos ì c ircon
data, ad eccez ione d e lla base , da una vera aureo la d i canali . La sezione
ve rt icale è un’
e llisse , ora allungata e sch iacc iata, o ra alquan to rigo nfia. Le
cam ere sono piccole , le d iverse lam ine calcar i , sv rlup pat iss im e si assott i
g lisno ne lla parte cen t rale dove s i saldano in tim am en te 1’
una all’
altra.
Num e ros i e ben v isib ili sono i pilastri ed i canal i , non ragg ruppat i so lo
al cen tro , ma spars i in tutta la conch ig lia.
Il Boussac com pren d e nel genere F ellat isp i ra due spec ie : la rapprese ntan te t ipica d e l genere I ’
etlatisfl ra Doum'
llei Boussac , e la I ’al/atisp ira
M adaràsz i Boussac . La prima d ifferisce dalla seconda so lo pe r ave re d i
m ension i m agg iori e g ranulaz ion i p l ll picco le e d isposte m eno rego larmen te .
M a esam inando num eros i esem plar i d i q uest ’
Assil ina , tale d ist inz ione non
ha valo re , perchè s i osservano d e i g raduali passagg i dall ’ uno aspe tto all’
al
tro . Le due spec ie non presen tano po i d ifferenze in terne , come ha v is to
ben iss imo anche i l Boussac , che dà il d isegno d i una so la sez ione p e r rap
presen tare le d ue spec ie , p er cui io ritengo che I’
Assi l ina Dour itlei Bouss .cost i tuisca soltan to una var ie tà de ll'Assitina fll adar àss i H aut . A questavarie tà appartengono i m ie i esem plar i .
DI PALEONTOLOGIA 7 1
A s s ì l i n a var . o r b i t o i d 0 a . 11 . f.
Tav . V , fig . 5.
Io posseggo pure , insiem e con numeros i esemplari d ella var . Dom/ i l
lei , un’
altra form a che può cost ituire una seconda varie tà della stessa spe
c ie . Essa presen ta una conch ig lia d i d iame tro da 2 a 5 mm … ,spessa da 1
a 2 mm ., r igonfia, con marg ine breve , sott ile , tag lien te e frag ilissimo . La
superfic ie è ricoperta da num erose g ranulazion i , p iù g rand i verso il cen tro ,
d isposte un iformem en te su tutta la conchig lia. Per la forma r igonfia, p er la
d isposiz ione un iform e delle g ranulaz ion i , e per la mancanza d e l solco sp i
rale , ques ti esemplari si accostano mo ltissim o , esternamen te , alle Orbitoid i ,
dalle quali solo s i d ist inguono per la mancan za d i un vero re t icolo . T utt i
g li esem plari d i questa varie tà ,da m e sez ionat i , sono m egasfe ric i . Ess i in ter
nam en te sono affatto s im i li ag li esem plari d e lla var . Douvi lle i Boussac .
O p o r c u l i n a p y r a m i d n n n Ehrenb .
Tav . V , fig . 6 .
1 838 Opercul ina Avram idm n Ehrenb . , Eh renberg , Abhand l . 4e. Wissen
seh . , Berlin , p . 93 , tav . 4 , fig . 7 .
0peroaliaa py r am idum Eh renb Ehrenbe rg ,fl! ik rog eolog ie , tavo la
XX III, fig . B , in fig . 38.
etc .
Questa Opercul ina , d e lla quale posseggo appena d ue esem plari , p resen ta una conchiglia de l d iame tro d i 3 mm . e dello spessore d i 1 mm .
circa,d epressa, a marg ine sub -arrotondato . La superfic ie presen ta ne lla sua
parte cen trale , d elle g ranu laz ion i g rosse e' p iatte ; da queste si staccano
d elle strie irregolar i , falc iform i ; tra le strie , e talora su d i esse , s i d ispon
gono de lle g ranu laz ion i . La spira è regolare , il passo spirale cresce assai
rapidam en te s ino al marg ine . La lam ina spirale va crescendo regolarm en te
in spesso re dall ’ in terno all’
esterno . I sett i sono regolari , non sem pre equ id istan t i , retti line i , e solo leggerm en te ricurv i p resso
‘la volta d ella camera.
L’
angolo postero—superiore è sub-retto , un po’
arro tondato . I se tt i , d i rego
lare spessore , sono rigonfi alle due estrem ità . La cam era cen trale è piccola.
Le camere , non num erose , sono sub -regolari e com pless ivam en te trapezo i
dali
72 RIVISTA ITALIANA
H e t e m m t e g i n a r e t i n-u l a t a . Rtttimeye r.
H eterosteg ina r eticolata Rtl t im . Rfi tim eyer , Ueber das Schw eiz .
N mm nul in ten a in , S . 1 0 9 ; Taf. IV ,fig . 6 1 .
H eterosteg ina reticulata Rfi tim . M . H an tk en , D ie F auna der Cla
zml ina Szaboi Sch ichten . Jah rb . k. ung . geol . Anst . , IV . ,p . 8 1 ,
tav . X II, fig . 3 .
H eterosteg ina reticolata Rtl t im . H . Douv illé , Op . cit . , p . 44 1 e
443 .
Rifer isco a ques ta specie i rarissim i esem plari trovat i . La conch ig lia,de l d iam e tro d i 4 mm . c irca, e assai sot ti le e provv ista d i un piccoloum bone , ornata da un ret icolo specialmen te v isibi le ve rso la per iferia e
presso la bocca. La lam ina spirale è so ttile , a spessore costan te . La spiraè rego lare , i l passo Spirale cresce mo lto rapidam en te sino al m arg ine . La
camera cen trale è g rande , c ircolare . Le camerette secondarie , picco le ed
irregolari n e i prim i g ir i , s i fan no p iù g ran d i , assai m eno irregolari n e l g iro
esterno dove assum ono complessivam en te fo rma re ttangolare .
Per la scars ità e la catt iva con se rvaz ion e deg li esem plar i non ho potutofare una sez ione sodd isfacen te .
O r t h o p h r u g n 1 i n a v a r i a n s K auf.
T av . V ,fig . 7 - 1 0 .
1 867 Or thoph rag m ina var ians K auf. K aufmann .B eitra'
g es . g eolog . K ar te
der Schw eiz ,p . 1 58 . Tav . X , fig . 1 - 1 0 .
1 903 Or thoph rag m ina var ians K auf. Sch lumberger , Troisitm e nole sur
les Orbi toides , Bull . Soc . G eol. de France , pag . 2 8 1 , Pl. X ,
fig . 3 1 , 33. 35. 38 .
Diam e tro da 2 a 5 mm . ; spesso re d a 1 a 2 mm .
Alcun i esemplari presen tano una conch ig lia rigonfia , quas i sferica, a
marg ine arrotondato ; da quest i si passa g radatam en te ad altri esemp lari
rigonfi solo ne lla parte cen trale , a marg ine so tt ile , tag lien te . La superficieè ricope rta da g ranulaz ion i tondegg ian ti , d i ugual g rand ezza, p iù num erose
n e lla parte cen trale . Neg li esem plar i un po’
erosi , le g ranulaz ion i sono
74 RIVISTA ITALIANA
O r t h o p h r a g n x i n u s e l l a
Tav . V , fig . 1 3 .
Len t ieutites eph ipp ium , Sch lot . Schlo t the im , Petre/ actenhunde , p .89 .
Orbitol ites sella , d’
Arch . d’
Archiac , Description des F ossi les da
Groupe N ummul itique ecc . envi rons de B ayonne et de Dax .
Mem . . Soc . geo l . de F rance , III, pag . 40 5 , p l . VIII,fig . 1 6 a.
() rbitoides eph ipp ium , Sch lot . sp . G ùm be l B ei tra'
g e zur F oram in i
f erenf auna ecc ., pag . 1 1 8 , tav . III, fig . 1 5 e 38.
Or thoph rag m ina setta (d’
Arch iac) C h . Schlumberge r , op . c it . , pag .
2 78 , Pl. IX , fig . 1 4 , 1 5 , 1 6 , 2 5 .
G li esem plar i d i m agg ior mole m isurano un d iam e tro d i 8 mm . e uno
spessore d i 1 lp mm . La conchiglia è irrego larm en te d isco id e , notevol
m en te p iù spessa nella parte cen t rale , so tt i le al marg ine , pm 0 m eno r ip ie
gata a sella. I m ie i esem plar i presen tano in com plesso uno spesso re mag
g iore della forma t ipica. La superficie è ricope rta da g ranulaz ion i piccole ,
regolari , tond egg ian ti , num e rose . Q ua e la I’
erosione perm ette d i vedere
tra le g ranulazion i un fin issimo re t ico lo . La cam era cen trale , c irco lare , è
avvolta p er m età da un’altra camera d i d im ens ion i assai magg ior i , d i
fo rm a sub -c ircolare . Le cam e re equato riali d e i g iri p iù in te rn i sono piccoliss im e , quad rangole , que lle d ei g iri successiv i , irrego lari , s trette , allungate .
In sez ione ve rt icale il piano cen trale è rappresen tato d a cam e re piccole ,
pm basse al cen tro che ve rso il marg ine , e che s i d ifferenz iano bene da
que lle secondarie , che appaiono com e fessure n e lla m assa com pat ta d e l calcare . Mancano i pilastr i ; v is ibili sono in vece i canali .
O r t h o p h r a g m i n a A r o h'
i a o i Sch lumb .
Tav . V I, fig . 2 .
1 90 3 Or thophrag m i na A rch iaci Sch lum b . Sch lumbe rge r , op . c i t ., pag . 2 7 7 ,
Pl . VIII , fig . 5-7 , 1 1 .
I pochi esem plar i hanno d im en s ion i m ino r i d i que lli che serv irono allo
S ch lumbe rge r p er la d eterm inazione d e lla spec ie . Il p iù g rande t ra essi ,
infatt i , m isura so ltan to 5 mm . d i d iam e tro e 2 mm . d i spessore . La con
DI PALEONTOLOGIA
ch ig lia è irrego larm en te d isco ide , m o lto rigonfia al cen tro , a marg in e p iù
o meno so tti le ed espan so , arro tondato o sub-tag lien te . Le g ranulaz ion i
sono picco le e rade o mancano de l tutto , nella parte marg inale ; num erose ,
ben visibili , tond eggian t i od e llisso idali , nella parte cen trale .
L’
apparato embrionale corrisponde perfe ttam en te a quello dato dallo
Schlumberger. Le cam ere equatoriali , spesso irregolari , han no paret i d i consid erevole spessore e form a d i re ttangoli molto allungati . In sez ione m e ri
d iana, le camere equato riali non d ifferiscono g ran chè da quelle secondarie ,
s tre tte , allungate , rego larm en te re t tango lar i , a paret i spesse , d isposte a pilarego larm en te le une sulle altre . È poco v isibile l ’ alternanza tra le cam ere
d i due pile con t igue . I p ilastri sono so t tili e num erosi , specialm en te nella
parte cen trale .
O r t h o p h r a g rn i n u l a n c e o l a t a . Sch lumb .
T av . V I, fig . 3-5 .
1 904 Or thoph rag m ina lan ceolata Schlumb . Schlumbe rger , Quotn cm e Note
sur les Orbi toides , Bull . d e la Soc . Geo l. de F rance. pag . 1 28 ,
Pl. V , fig . 2 5-30 .
I poch i esem plar i ch ’io po sseggo presen tano una conch ig lia piuttosto
piccola e so tt i le . Da un bo ttone cen trale s’
irradiano quattro , cinque o se i
costole che s i spingono sino all’
es trem o d el marg ine , so ttile , spesso ro tto
ed eroso . De lle granulazion i , g rosse , sporgen t i , tondegg ian t i , s i scorgono
su l bo ttone cen trale , altre piccole e rade nelle parti d epresse com prese fra
le costole . T ra le g ranulaz ion i appare un fine ret icolo . La sez ione eq uato
riale ia vedere una cam era cen t rale un ica, g rande , irrego larm en te circolare ,
e d e lle cam e rette esagonali , rego lari . In corrispond en za de lle costo le esterne ,
le cam e re tte m od ificano rap idam en te la loro fo rma e si fanno re ttango lari ,
assai allungate e p iù g rand i , com e bene appare dalla figura schemat ica data
dallo Schlum berge r . La sez ione m e r id iana, passan te pe r due costole , fa
ved ere le cam e re tte equator iali p iccole , irrego lari , e le cam ere t te seconda
rie s im i li a fessure ne l calcare com patto . I pi lastr i sono num e rosi e regolar i .
O r t h o p h r a g n 1 i n a . s c u l a r i s Schlum b .
Tav . V ,fig . 1 4- 1 5 , T av . VI , fig . 1 .
1 90 3 Or thophrag m ina scalar is , C h . Schlum be rger , Troisièm e note sur les
O rbi toides , Pl. V III, fig . 4 ; p l. IX , fig . 1 2 — 1 3 , p . 2 7 7 .
76 RIVISTA ITALIANA
La conchig lia è len t ico lare , rego larmen te d isco id e , legge rmen te rigonfia
al cen tro , a m arg ine tag lien te , talvolta ondulato . Sulla superfic ie si d ispon
gono irrego larm en te d elle g ranulaz ion i ben v is ibi li , tond egg ian t i , sporgen ti ,p iù g rosse e p iù rade al cen tro , p iù picco le e p iù fitte nella parte m arg i
nale . L’
esemplare p iù g ran d e m isura 7 m m . d i d iam e tro e 2 mm . c irca d i
spessore . La sez ione equator iale presen ta una cam era cen trale un ica, g rand e ,
sub -circo lare , e d e lle cam e re tte regolari o sub -rego lari , stret te , allungate ,a
pare ti spesse . Nella sez ione merid iana , la cam era cen trale è un’
ellisse al
quan to r igonfia. Le cam ere t te equatorial i sono piccole , depresse . Le came
re tte secondarie sono rego lar i , re ttangolari , a pareti spesse ,regolarm en te
sovrapposte le une alle altre . I pilastri sono ben v isib ili , regolari , e p iù
num erosi n e lla parte cen t rale .
L e p i d o o y o l i n a . d i l a t a t a var . e‘
o l r l u m h e r g e r i (Lem . e t
Douv .)
1 904 Lep id . .Schlm nberg er i Lem . e t Douv . P. Lemo ine e t R . Douvillé ,
M em . Soc . Geol . d e F rance , Paleon t . , tom e X II, p . 1 4, p l . 1 ,
fig . 1 0 ; p l . II, fig . 6 .
1 90 6 Lep id . d i latata var . Schlumber g er i C . Par ish , D i alcune A hm n nul iti e
Orbi toid i dell’
Appenn ino Lig ure Piemon tese , p . 9 1 , tav . Il , fig . 38 .
La conch ig lia. che m isura un d iam etro d i 3 cm . e uno spessore al
cen trod i 4 mm è d isco id e , r igonfia al cen tro , dove si trova un grosso
bo ttone , r ipiegata a sella, sottile , a marg ine tag lien te . La supe rfic ie è or
nata da g rosse granulaz ion i tond egg ian t i , tra le quali appare il reticolo . Le
g ran ulaz ion i ed il re tico lo si ved ono m eg lio ne lla parte cen trale . Ben visi
bili , ia sezione tangenz iale , sono i pilas tr i che appaiono sot to fo rma d i
pun ti p iù chiari d e l fondo . Avendo un solo esemplare , e avendo solamen te
esegui ta la sez ione d i un framm en to , non so se v i s ia o no la cam e ra cen
trale . Le camere equatoriali sono piccole , a pare t i spesse , sub -quad rangoleo sub —esagone .
L e p i d « »c y c l i n a [ Z a u l i -s i (Lem . e t Douv . )
T av . V I , fig . 6 -8 .
1 904 Lep id . Rautin i P. Lem o ine e t R. Douvi llè , Sur le g en re Lep idocy
cl ina G‘
i ì m bel , pag . 1 1 (ved i p l . I , fig . 3 , 6 , 9 , 1 3 , 1 6 ;
p l . II , fig . 3- 1 0 ; p l. III, fig . 4- 1 4 .
RIVISTA ITALIANA
m atrens is (Brady) danno New ton e Holland nel lavoro : On some F ossi l
f rom the Islands o] F ormosa and R iak ia, Vo l. XVII, 1 90 2 .
L e p i d » c y c l i u n o f . T o u r n o u e r ì Lem . et Douv .
Tav . VI, fig . 1 2 , 1 3 .
Per le d imens ion i , p er la forma e per l’
aspetto esterno , questa formas i avvic ina moltissimo alla Toarnouer i tipica, dalla quale si d iscosta per
essere un pò p iù rigonfia al cen tro . Le camere equatoriali sono ora sub
c ircolari , ora sub—esagone , com e ne lla t ipica. La cam era cen trale , piuttostog rand e , sub-circolare , a paret i spesse , è avvolta per m età da un
’
altra ca
m era d i d im ension i magg ior i e a pare t i p iù spesse . In torno a queste due
camere si d ispm gono d elle camere tte quas i sem icircolari , d i d imension i
d iverse , assai p iù grand i d i quelle de i g iri successiv i . L’apparato embrio
nale appare quind i p iù com plesso d i quello de lla Lep id . Tournouer i . Avendo
appena d ue esemplari , non ho po tuto esegu ire una sez ione vert icale , che
avrebbe forse perm esso d i ved ere altre d ifferenze t ra questa forma e la
form a tipica.
G y p s i n a g l o b u l i-s Reuss , sp .
Tav . VI , fig , 1 4, 1 5 .
1847 C‘
er iopora g lobulus Reuss Reuss , H aind iger’s N otun o . Abhandl .,
vo l. II. p. 33 , p l. v,fig . 7 .
1 860 orbitolina laevis Park . and Jon . F. Parker and R. Jones , Ann .
and Mag . Nat . H ist . , ser. 3 , vol. V I, p . 3 1 , N . 7 .
1 87 1 Tizzopom s p ilar is Brad y , Ann . Soc . malac. Be lg . , vol. X I, p. 1 03.
1 87 7 Tino;>orus , var . sphaeroid al is C art. Carter , An n . and M ag . Nat.
H ist ., ser. 4 , vol . X IX , p . 2 1 5 , p l. XIII, figs . 1 8 , 2 0 .
1 87 7 Gypsina vesicular is , var . sphaeroidal is Cart . H . Carte r, Ib id .,
vo l. XX , p. 1 73.
1 882 - 1 884 Gypsina g lobulus Reuss , sp ., Hen ry B . Brad y Report on the
Foram in ifera d red ged by H . M . S . C hallenger , ecc.
S eguendo le idee della s ignorina G . Osimo , pongo il gen . Gypsina nella
sottofam ig lia de lle Orbitoid inae , anz ichè ne lla fam ig lia d elle Rotal idae , come
fin ’
ora si è fatto .
Rife risco i pochi esemplari che posseggo alla Gypsina g lobulus, della
DI PALEONTOLOGIA
quale hanno tutti i caratteri estern i conch ig lia sferoidale , a superficie or
nata da un ret icolo a mag lie rego larm en te poligonali , d eterm inate dalle
cam ere aperte de l g iro p iù esterno .
Delle sez ion i fatte secondo pian i d iversi , mostrano d elle cam erette che
s’
irrad iano da una cam era in iz iale p iù o m eno eccen tr ica. Questa è p iù o
m eno grand e , irrego lare, e sudd ivisa in cam ere tte m inori . Le cam ere hannola forma d i esagon i irregolari e sch iacc iati , e aumen tano g radatam en te in
grand ezza dal cen tro alla perife ria. Le cam eret te sono d isposte in cerchiconcen trici , e quelle d i uno strato si adden trano neg li spaz i lasc iat i fra le
cam erette d eg li strati con t igui , com e avv iene per le camere secondarie delle
Orbitoid i .
Altri lavori consultat i , non ci tat i ne l corso de lla presen te m emoria,
re lat iv i a Borneo e ad altre reg ion i d e lle Ind ie O rien tali .
1 87 1 R . D. M . V ERREE K , D ie N umm ul iteu des B orueo-A’
alhsteines , Neues
Jahrbuch , p . 1 .
1 878 K . v . F RITSC H , (Palaen tog raphica, Supp l. III) .1 88 1 R . D . M . V ERREER , ( Pal. Suppl . III, liv r . 8 e
1 882 K . MART IN , Samm luu,gr en des Geol . Re ichs 1 ll useum s in Leid en ,
PP I 3 12- 1 47 .
1 888 VAUG HAN JENN INGS , Orbitoid al l imestone of N or th Borneo , Geol.
M ag . ,III, v
,pp. 52 9
—53 2 , p l . XV .
1 899 R . B . NEWTON ET R. HO LLAND, Ou som e ter tiary F oram in ifera
f rom B or neo , Ann . a. M ag . nat . h ist . , III.
1 90 0 C H . SC HLUM BERGER , N ote sur deux Espe‘ces de Lep idocyctina des
[ ndes A'
éer landaises .
1 90 2 C H . SC H LL’M BERG ER . Sur une Lep idocy cl ina nouveau de B or neo , Samm .
der geo ] . R . Museum s III Leid en .
1 880 K . MART IN , Ter t ì'
ar schiclzten auf j ava , N ied erland isches Arch iv . fur
Zoo log ie v .
1 896 R. D. M . V ERREEK ET R . F ENN EM A,Descr ip tion Geol . de l ava et
M adoura.
1 849 W . C ARPENT ER (Quart. journ . , vol. V ) .1 853- 1 86 1 F . C HARTER , A nn . m ag . nat. h ist ., ( 2) vol. X I, (3 ) vol. VIII.1 90 0 T . RUPERT JON ES AND F REDER IC R
'
C HAPMAN , On the F ora» : iuifera
of the Orbitoidal Limestones and reef rocks of Ch r istmas Island .
1 880 F EDDEN , g eol . Survey of Ind ia,vol . 1 7 , p , 1 97 .
RIVISTA ITALIANA
SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA IV
N amm . (Paronaea) m am illa F icht. et Mo ll.
N umm . (Paranoea) sub Telliui i Prev .
N amm . (Paranoea) Osimoi 1 1 . f.
N umm . (Paronaea) sub-Osimoi 11 . f.
N umm . (Paranoea) Prever i 11 . f.
N amm . (Paronaea ) sub-Prever i n . I'
.
Numm . (G ilmbel ia) sub-Form ai 11 . f.
Assilina Aladaràsz i H an tlc.
SPIEGAZIONE DELLA. TAVOLA V
Assi l iua M ad aràsz i H an tk .
Assil iua M adaràsz i H an tk . var . orbitoidea n . I.
Opercul iua py ram idum Eh renb .
Or thophrag m ina var ious K auf.
Or thophrag m ina var ious K auf. var. setti/orme , n
Or thophrag m ina sella d ArchOr thophrag m ina scalar is Schlumb .
SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA. V I.
Or thophrag m ina sca/or is Schlumb .
Ort hophragm ina Ar chiaci Schlumb .
Or thophrag m ina lan ceolata Schlumb .
Lep idocy cl iua Rautiu i Lem . et Douv .
Lep idocy cliua Tour nouer i Lem . et Douv .
Lep idocy cliua c . f. Tour uoueri Lem . et Douv .
Gypsiua g lobulus (Reuss).
… A r u» . (ml u n ueon)’
Anno XIV Fasc. III
RASSEGNA DELLE PUBBLICAZ ION I ITALIANE
AIBAGHI C. Revisione degl i Asteroid i e degl i Ech in id i lombard i . Rend i con ti del R. I st. Lamb. d i se. e lett., ser ie
II,vol . XLI ( 1 908) pag. 247- 259.
La scarsa bibl iografia che si ha sulla fauna ech i nologica
lombarda, ha determinato l’ A. ad i llustrare alcune forme r iave
nute ulter iormente nei d iversi p ian i fossi l ifer i della Lombard ia,
al lo stesso tempo a r ivedere le determinazion i d i tutte le spec ie
già. conosciute. Del Tr ias (Muschelkalk e Retico) descrive sei forme
d i cui una nuova : 1 ’ Op h iurel la lar i ensis. Del Lias ( infer iore e
med io) descrive sei specie ; del Ti tan ico due, del Senon iano altre
due, e del Terziario ventuna, delle qual i quind ici appartengono
al p l iocene. È proposto i l nuovo nome : Sp atangus Taramel li i per
una forma già. dall’A. determ inata come Sp . austr iacus.
P. PRINC IPI.
Bssssm F. Su alcun i avanzi d i pesci nel l’arenar ia glau
con iosa del le isole Trem i ti . Rond . R. Acc. Sc. fis. e mat.
Nap ol i , (8) XIII, 11 . 5- 7, p . 1 56 - 1 60. Napol i , 1 907.
L’A. descr ive alcun i denti d i pesc i raccolti dal Tell in i e dallo
Squinabol nell’arenaria glaucon iosa m iocen ica delle isole Trem iti .
V’
i r iconosce Carcharodon megalodon Ag., Galeocerdo aduncus Ag.,
84 RIVISTA ITALIANA
classe des C@ha lop odes ( l ), d i cu i poche notizi e avevansi in
p iù o dal suo Prodrome de Pa le'
on tologi e stratigrap h i que,
ecc. oppure dallo stud io del Terquem su e Les F oram in i
feres de l ’ Eocene des en vi rons de Par is è per noi modern i ,
ma non ultra—modern i , d’ ind iscutibi le uti l ità generale, prez ioso
poi per la corretta interpretazione delle spec ie d’ Orbignyane.
Con la sua consueta conc isione e prec isione d i l inguaggio, e
n itidezza d i figure, i l Fornasin i c i mette sott’occh io 1 ’ i llustra
z ione delle forme che passo a citare
N od osa r i a avicula,lamarclci
, p ulchel la,aequal is, or thocera.
D en l a l i n a caudata,str iata.
F r on d i c u l a r i a laevigata.
fil a r g i n u l i n a str iata.
R oba l i n a cu ltrata, Roba li na sp .
G a t t u l i n a laevigata.
0 v i g e r i n a tr i lobata .
P l a n o r bu l i n a r ubra.
T r u n c a tu l i n a i nfractuosa,con tecta.
Ro t a l i a p unctu lata dubia.
G y r o i d i n a umbi l i cata
1 n r b i n u l i n a crassa,beccar i i .
C a l ca r i a gaimard i , d efrancei , sp eug ler i gaud ichaud i
gaoy i .
P l a u u l i n a dubia, P lanul ina sp .
B u l i m i n a arenata,madagascar ien s is.
B i l o u l i n a elongata,laevi s.
A 71 om a l i n a nauti loides.
Due d i esse,e c ioè la Raba l ina sp . e la P lan ul ina sp., per
quanto facessero parte delle Planches im‘d i tes riguardanti i l
Tableau méthodz'
que ecc. non vi erano state neanche c itate
dal d ’ Orbigny.
( i ) An n . So. Nat ., vol . VII . Par is ,
(2 ) In vol . I-III. V ic to r H annon ; Par i s , 1 860 o 1 862 .
(3 ) M ém . Soc. Géol . F ran ce , aer . voi . i l , m em . Par la, IGQ .
DI PALEONTOLOGIA 85
Oii'
rono part icolare interesse,in quest i temp i nei qual i si
cerca d i confermare e stabi l ir megl io le d istinzion i tra Calcar i na,
S iderol i tes (I), e B acu logyp sina, generi isomorfi, le suddette Cal
car ine ; d i cui la C . defrancei , fig. 3,tav. III
,del Fornasin i , che
non e corr ispondente al la C . «lef'
rancei,fig. 4 del la stessa. tavola,
nè al la C'. defranci i , fig. 5— 7
,tav. X III, del Tableau méthod i
que ecc. le qual i alla loro volta sono d ifferenti tra.
loro,m i
rassom iglia cosi stranamente a certe forme d’erosione o corrosione
del Penerop l is p er tusus (Forsk èi l ) , da farm i sospettare si tratti
proprio d i una d i esse.
Al term ine del lavoro trovasi un ind ice del le 330 specie d i
Rizopod i reticolar i d i cui l’autore ha i llustrato le figure ined ite
( 1 ) A p roposi t w d i S ider ol i tes , la s ig .na G iusep p in a Osim o cu i n on è p iac iuta ,
sem b ra, un a m ia r ecen sion e spassi onata com e al sol i to , ch e la r i guardava , con te
n u ta a pag . 66 , an n o XI II d i questa Ri v i sta , h a vol uto far d el la con t r ocr i
t i ca, al la q uai d , pe l con ce t to d el la m assima im p ar z iali tà. i l Redat to r e cap o h a
aper to le p ort e d e l la m ed es ima. Rep l ich ero, for se, a t em p o e luogo ; n el m om en t o
m i e g rad i to r i levar e com e , p er i l p er iod o ch e t rascr i vo, ed i l q uale n on av re i p o
tuto passa r sotto si len z io, p er ch è led eva la m ia scr upolosi ta n e l recen si re , la cosa
al la q uale p iù t en go, la sud d et ta con m ol ta cort esia e lea ltà ha d esi d e rato fosse
i n ser i ta la r et t i fica c h e segue . Ne la r in g razi o sen t i tam en t e , p e rch é quest i cas i d i
l ealta son o pur t ropp o rar i .
Il p e r i od o era. quest o
a Il Si lvest r i r i t ien e po i in esat ta l’or tografia d el la parola S i d er ol i thes , i n vo
can d o p e rc i ò la et im ologia e l ’ uso gen e rale ; m a i o g l i facc io osservar e c h e così fu
sc r i tto da Lam arck , quan d o eg l i i st i tuì q uesto gen e re , e c h e cosi scr isser o pu re i
p r im i auto r i , ch e se n e occuparon o, com e Fauj as d e Sain t F on d.M on t fort , De fran ce ,
e q ualch e v ol ta an ch e d’ Or b ign y . Non cr ed o q u in d i op p or t un o far e al cun cam b i a
m en to , p er quan to p ossa esser e i n s i gn i fi can t e (Ri v . I t . Pa leon t ., an n o X IV
pag .
Ed ecco la r et t ifica
Ne lla recen t e m i a n ota su DI alcun i Foram in i fer i d el l’
Eocm e sum o—tor e d i Ce
lebes e, com parsa n e l fasc . I—II , an n o X IV, d i q uesta Ri v i sta , i n un a an n otaz ion e a
pag. 1 9 , r i bat ten d o un a cr i t ica d el p rof. A. S i lvest r i , d i ss i er ron eam en t e ch e i l La
m arck,i l Fanj as d i Sa in t F on d ed a l t r i autori , h an no con sac rata c o i loro sc ri t t i
i ’ n n e l l’or tografia d e l la p arola S i dero li thes. H o sbag l i ato e con fesso volen t i e r i i l m io
e r r ore : q uan d o sc r iss i la m ia n o ta sul gen ere S i d er0 l l la pu r aven do con sul tat i tut t i
quest i aut or i . p res i , sen za d are a q ues to fat to al cun a im p or tan za, l 'or tog rafia dal
p r im o l ib ro su cui t rova i n om in ato i l gener e (ch e n on m i parve p un to e r rata , data
la d er i vaz i on e dall a par ola g reca l i lhos ) . Q uand o v id i l ’osser vaz ion e d ei S i lvest r i i o
n on avevo p iù a m ia d isp osiz i on e tut t e le op ere c i tate , m a sol tan to i l Cuv ie r e i l
M on t for t , ch e , p ur sc r i ven d o S i derol i th es sem p l i cem en t e pe r con to l oro , m i c i tavano
p er i l Lam arck la scr i t t ura S i de rol i t hes ,
-adat t i , e fec i m a le , d i po te rm i fid are d el
l’autor i tà d i q uest i autor i . È p rop ri o vero ch e , spec i al m en te i n fat to d i c i taz ion i ,
n on b isogn a m ai fidarsi d i n essun o ! e G i u sep p i n a Osimo
RIVISTA ITALIANA
del d ’ Orb igny, assai comodo per rendere agevol i le r icerche nel
comp lesso delle m emor ie ( 1 ) dove esse sono state r iprodotte.
Coi preceden ti stud i d i Parker , Jones e Brady del Ter
quem (3) ed i successivi del Fornasin i , nei qual i comprendo an
che quell i sulle opere del Soldan i i l Tableau méthod ique
ecc. r iman completato, e viene a cost ituire un’opera d i fonda
mentale importanza pei r izopod isti . A. SILVESTRI.
FORTI A. Pr imo elenco del le d iatomee fossi l i contenute
nei depos it i m iocen ici d i Bcrgonzano. Nuova Notar i sia,
X IX, pag. 4.
L’A. avendo sottoposto a stud io numerosi preparati contenen t i
per la maggior parte i l Coscinod iscus Gazel lae Jan .,ha potuto
però r iconoscere numerose altre forme e c ioè 8 Rap h idcae, 4 Pseu
dorap h z‘
deae e ben 65 C ryp toraph ideae. V.
FUCINI A. Sopra alcun i rest i d i vertebrat i del le arg i l le
p l iocen iche dei d intorn i d i Empol i . Atti Soc. lose. d i
S e. nat. Proc. verb. XVII,4 ; pag. 4 e 1 fig.
I vertebrati fossil i i n questa parte della Valdarno sono ah
bastanza rar i . I p iù numerosi esemplari si sono r invenuti nel la
cava per laterizi dei Frat. Ch iarug i . L’A. ne dà un elenco : Cer
vus cfr. d i cran ius,M astodon arvenensis
,Rhynoceros etruscus
,
H ystr i x Can is Thalassochd i s F ul igu la È figurata una
coprol i te probabi lm en te d i cane. V.
( i ) V . a p ag . 63, an n o X II ( 1906 ) d e l p resen te p e r iod ico , ed avan t i .
(2 ) On th e Nm n em la l n r e of th e F om m im fera . X , X I! e X ! I'
An n . an d M ag .
H i st ., ser . vol . X II e X VI ; ser ie 4.l , vol . VII I. Lon d on , 1963, 1 803 e 1 87 1 .
( 3) CH .
(4) Fo ram i n i fer i i l l u s tra“ da Sold an i e vi ta l i d ag’ i a u tor i e . B i l l . Soc . G eo l .
I t ., vol . V . Rom e , 1 886. E cc .
DI PALEONTOLOGIA 89
La roccia,in cui si trovano i fossi l i
,e un calcare compatto,
pr incipalmen te costitui to da Briozoi,ed è molto sim i le ai calcari
della Verna,d i Ufi
'
ogl iano, della Pescia Romana, delle Vene del
Tevere ecc.
Le specie rinvenute in questa formazione calcarea ascendono
complessivam ente a 57,fra le qual i sono da notare le seguenti
forme nuove : C idar is Scarabel li i Stefan in i nov. sp .,Psamme
ch inus M ancan ti,Olyp easter Cap el l in i i , Scutel la Ai ragh i i , E chi
nolamp as S tefan in i i ; P l iolamp as ti tanensis, Trachi sp atangus sp .
n .,E up atagus sp . n . Sm i ttia ? nov. sp . ; Serp ula subnìunmu
las, Sp ondylus M aneon i i .
L’ A. conclude affermando che i l calcare d i S. Mar ino si e
depositato in una zona intermed ia fra quella delle lam inar ie e
quella corall igena ; e stratigraficamente e paleon tologicamente può
r iferirsi alla parte infer iore del M iocene med io.
P. PRINCIPI.
PEOLA P. Im pronte vegetal i del Carbon i fero del l’ I ll inois
B ol l. Soc. Geol. I tal. vol . XXVI, pag. 324- 332
e l tav.
L,A. descr ive alcun i esemp lar i d i impronte vegetal i raccolti
lungo i l letto del Mesonrover nel la con tea d i Mor is nell’ Ill inois.
Le impron te si trovano su c iottol i costituiti da un’arenar ia com
patta o stratificata a sotti l i straterell i , d i color gr igio rossastro
esternamente. nerastro nel l’ in terno.
Le specie esam inate sono 1 2, delle qual i d iec i appartengono
alle Felc i , le altre alle Equisetine. Questi fossi l i avendo grandeiden tità con quell i d i Mazon Creek , ascr itti dal Lesquereux al
Westfal iano super iore, e comprendendo pure avanz i d i Card io
p ter is ed°
Ulodendron propr i del Culm e del Westfal iano supe
r iore, ed essendo inclusi in arenar ia, che si trova alla base del
Westfal iano, rendono legittima l’ iscr izione d i Mesonrover al West
fal iano, cioè alla base del Mescoarhon i fero.
P. PRINCIPI.
DI PALEONTOLOGIA 93
SILVESTRI A. L’0 u p h a l oey e l sse m a c r a p o r n (Lamck .) a
Term i n i - Imerese (Palermo) . Atti Fautif. Acc. N . Li ncei,
anno LXI ( 1907 pag. 1 7—26,fig. 1 -3. Roma
,1 908.
L’esistenza del cretaceo nella contrada Calcasacco p resso Ter
m in i - Imerese i n provincia d i Palermo,sostenuta dall ’ autore
,e
che ha grande importanza nel l’in terpretazione del cosidetto or iz
zon te infer iore a Lepidocicl ine eocen iche, gl i era stata contrastata
dal prof. G. Di Stefano e dai suoi assistenti . Egl i la d ifende per
mezzo d’un nuovo argomento paleontologico, all
‘
atto sconosciuto,
a quanto sembra,dai suoi contrad ittor i : i l ri conoscimento della
presenza tra i fossi l i stud iati d ’una var ietà. dell
’ Omphalocyclus
macropora (Lamarck ) (var. sehlumberger i A. Si lvestr i ), essendo
noto che tutti ind istintamente gl i Omp halocyelus sono cretacei .
Inoltre l ’ A. espone le seguenti conclusion i paleontologiche,
desun te da abbondante mater iale belga avuto in esame
a) gl i Omp halocyelus sono d imorfi ;
b) essi rappresen tano la forma arcaica del le Orbi toides ;
e) anche in loro, come in tutte le Orbi toides, l’apparato
embr ionale è var iabi l issimo, pur presentando un tipo ben deter
m inato cui le sue var iaz ion i sono attr ibuib i l i .
Conclusion i che oggi è al caso d i con fermare integralmente
per mezzo d’esemplari del la Franc ia e delle Ind ie Orien tali gen
tilmente comun icatigl i , con l’aggiun ta che sotto i l nome d ’
Om
p halocyelus d i scutas (Leymerie) si è designata d i sol ito dagl i
autor i la forma m icrosfer ica dell’O. macrop ora, per cui 0. d i sca
lus non ha motivo d’esistere come specie a sè.
A. SILVESTRI.
SILVESTRI A. Sul la 0 r b l t o l d e e eo e l a l i e (Leymer ic )
Atti Pon tif. Ace. N . L i ncei , anno LXI 0907 pag. 94
99. Roma, 1 908.
Sotto i l nome d’ Orbi toides socia l is (Leymerie) furono com
prese almeno due spec ie d iverse. Il Si lvestri ha procurato d i sch ia
94 RIVISTA ITALIANA
r i re la situazione,trattando contemporaneamente del suo nuovo
genere Lep idorbi toides, in cui comprende le spec ie lep idocicl in i
form i del cretaceo.
A. SILVESTRI.
SILVESTRI A. Sul la O r b h u l l t e a c om p l a n a ta Martel l i .
Atti Pontif. Ace. N . L incei,anno LX I ( 1 907 pag.
1 28— 1 37 . Roma, 1 908.
Per quanto apparen temente slegati , questo, i lavor i sopra re
censi ti,e vari altri che li precedettero sono in stretta connes
sione, e m irano tutti ad uno scopo : quello d i mettere in essere la
contrastata eocen icità delle Lep idocicline, se effettivamente suss iste,demol irla affatto se c iò non è. E per questo, che l’autore d i
essi si occupa nel presente stud io d ’un cur ioso equivoco in cui
cadde i l dott. A. Martel l i , nel determ inare per Orbi toli tes comp la
nata Lamarck , la forma Lep idocycl i na con tenuta in un certo cal
care saccaroide delle Isole Ion ie, Pax os ed An tipax os, dal Mar
tell i medesimo attribuito al lutez iano inferiore. Equivoco, cosa
ancor p iù curiosa, sfuggi to ai sosten itor i del l’ eccen ità. in d iscorso,
ma che i l Silvestri , per le argomen taz ion i le qual i espone, non
crede possa, almeno allo stato dei fatti , forn irne la prova
Ch iudono la nota alcune considerazion i prel im inar i sul la d i
str ibuzione delle Lep i docic l ine n elle formazion i dell’ Appenn ino ;
sul quale soggetto l’ A. dovrà. r itornare in seguito, con 1
’ i llustra
z ione d i nuovi mater ial i venuti a sua conoscenza,ed in parte da
lui personalmen te raccolti .
A. SILVESTRI.
I) I l d ot t. p rof. A. M ar tel l i , c on osc i u to questo stud io c r i t i co . con rara cor t e
s ia h a p r om esso al l’A. d i far g l i esam i n ar e i l m ater ial e c on t r ov e rso , afi n ch è quest i
p ossa g iud i car m eg l io d el la sua d e t er m i n az ion e s trat igrafica, c h e i l p r im o r i t i en e
esat ta. Dal la fut ura v er i fica p uò d ar s i , ed i l caso e ra stat o p r ev edut o, v en gan fuori
fat t i n uov i i q ual i obb l i gh i n o i l S i l ves tr i a m od i ficar e l e p r op r i e con c lusion i .
96 RIVISTA ITALIANA
TOMMASI A. Spigolature d i paleontologia baldense . Bend .
R. I st. Lamb. d i se. e lett., (2) XLI, p. 601 —61 6. M i lano, 1 908.
Sul M . C imo,nel gruppo del M . Baldo, l
’A. ha potuto racco
gliere nelle cave una ser ie d i fossi li ti ton ian i : B elemn i tes ti ika
n ius Opp .,B . ensifer Opp .
, Phy lloeeras p tyehoi emn Qu. sp., S i
maccrae volanense Opp ., Pher i sphynetes rectefureatus Z itt., P. sene:c
Opp . sp . P. seorsn s Opp . sp. Ap tychus lotus Park .,A.pun
ctatus Voltz, A. Peg/ r i chi Opp .,Inoceramus sp ., Py90p e d iphya
Fab., P . tr iangu lar is Lk .
, P . r ectangu lar is Pict., M etap orhinus
convex as Cat. sp ., Col lyr i tes Verneu i l li Gott.
Nelle cave del M . Croce (sempre sul M . Baldo) , I’ A. trovò
B elemn i tes p i sti l l iform is Blnv. e Phyl loer i nus n . sp . del Cretaceo
infer iore ; Card i aster subtr igonatus Cat. sp ., Ovu laster Z ignoa
nus d’orb. ed E ch inocorys vulgar is Breyn del Cretaceo superiore.
M . GORTARI.
DI PALEONTOLOGIA 97
NOTE GEOLOGICHE E PALEONTOLOGICHE
SUL TRAVERT INO DI ASCOLI PICENO
NOTA DEL DOT T . ALES SANDRO M ART ELL I.
Il travertino ascolano rappresen ta, nella reg ione picena, il principe d e im ateriali da costruz ione , ed a g iustificarne l ’alto preg io nell
’
ed iliz ia, p iù an
cora dei ricch i ed ifici modern i in travertino dei quali Ascoli si abbella, stanno
le mura robuste e le torri , i pon ti , i tem pli e i monumen ti tutti dell’
epocaromana e med ievale , m irab ilmen te conservati nella capitale d el Piceno at
traverso al volger de i secoli .
A seconda della magg iore o m inore com pattezza e delle tin te p iù o
m eno in tense date dag li id rossid i d i ferro che l’
inq ù inano , il travert ino asco
lano v iene localm en te d istin to in p iù varietà corrisponden temente ag li usi
cui può ven ir ad ib ito nelle costruzion i . Così pure si apprezzano molto p iù
le varietà compatte b ianche , cineree , g ialle e brune , attivamente escavate
p er lavori arch ittet ton ici , che non quelle porose , adatte per le costruzion i
o rd inarie , e le altre p iù porose ancora e volgarmen te dette spug ne , usate
per d iv isori in tern i de i fabb ricati . Il travertino cavernose trova applicaz ion iassai m eno estese e non v iene nemmeno adoperato , come le altre varietà ,pe r la preparaz ione d ella calce.
La formaz ione travertinosa ha un grande sv iluppo sulla d estra del T ron to ,
ma dove i deposit i appaiono p iù po ten ti è nei d intorn i d elle località estreme
fra le quali si estendono , e cioè , presso la c ittà d i Ascoli sui fianch i nordocc iden tali e nord -orien tal i d ella Mon tagna de i fiori e ad Acquasan ta, celebre
p er le sue sorgen ti solfuree .
In quest ’
ultima località il travertino sormon ta la serie m iocen ica , e
parallelamen te al T ron to per quasi quattro ch ilometri , con una po tenza che
talora come presso la Madonna d i Paggese ragg iunge e sorpassa i
quaran ta m etri , riveste le pend ici delle alture d iscendendo fino al fium e .
Dirò sub ito che tan to ad Acquasan ta quan to nei d in torn i d i Ascoli , i l de
posito travert inoso è superficialmen te poco acc iden tato . Il carattere d el g ia
c imen to si presen ta in grande molto variab ile , perchè la roccia, talvo lta com
98 RIVISTA ITALIANA
patta e tal’altra interessata da peculiari cavità , costi tuisce d e i grossi ban
ch i orizzon tali che in p iù pun ti e pe r ragguardevoli estension i , si d ifferen
z iano ulteriormen te in un in sieme poten te d i pseudo—straterelli pure essi oriz
zon tal i . In generale però , il trave r tino ascolano presen ta ne i banchi in ferioriuna tessitura compatta fino a rendersi suscettibile d i un d iscre to pulimen to ,
m en tre in quelli prossim i alla superficie tende ad apparire sempre m eno
com patto fino a ridursi una rocc ia spugnosa e tufacea.
La Mon tagna de i Fior i a sud d i Ascoli e costitui ta da calcari compatti ,subcristallin i e magnesiferi , e da scisti del G iuralias e C retacico ( I) , sotto
stan ti a quella successione d i arenarie , sc isti e calcari eocen ici che segna la
transiz ione alla serie m iocen ica d e i calcari marnosi,arenace i , frequen tem en te
fissil i e alternan ti con scist i arg i llos i e arenacei , predom inan te nella costi tu
z ione della valle d el T ron to fra Ascoli e Acquasan ta.
Il d eposito d i travertino che , a nord -est della Mon tagna de i Fiori , riveste le alture d i Ascoli e il lim ite occiden tale del bacino d el torren te Marino ,
prolungandosi subparallelam en te al corso del T ron to per ci rca tre chilometrie con poco m eno d i un ch ilometro in larghezza, v iene in p iù pun ti frazionato dalle incision i torren tiz ie , le quali , pur non lasciando agevolmen te ri
conoscere tutto lo spessore d el deposito , consentono d i g iud icarlo alquan tom inore d i quello , che , sul versan te nord -ovest d i detta M on tagna de i Fiori ,a Castel T rosino e ad iacenze costi tuisce la parte superiore d elle alte rupifra le quali scorre incassato i l C aste llano .
La massa travert inosa d e l Castellano era in orig ine ce rtamen te pm estesa
e con tutta probab ilità si ricollegava al deposito d i travert ino d i Mon te Rosara , sulla d estra d el T ron to ; ma inc isa dal fiume e len tam en te d emol ita,
si andò orig inando l’
imponen te rupe su cui sorge Castel T ros ino , e , succes
I ) Sulla costituz ione della M on tag na d e i F iori e terreni ad iacen t i , possono partico lar
men te consultarsi i lavor i seguen t i
SPADA LAVINI A. e ORS INI A. Sparca g eolog ico dalle F oa del Tron to al la catena de lla
S lb flk l . Atti d e lla V i riun ione deg li sc ienz iat i italian i in M ilano n el IS44. Nole sur la consh'
ta l ian g éolog ique de Ital ie cen trale . Boll. d e la Soc . g éol. de F rance . Paris , 1 845. Quelques
obser vations g éolog iques sur les Appenn i ne de Italie cen trale . Ibid . 1 855,
C ARAVAR I M . I le: ren i de l te re iczr io inferi ore e quell i della C rela super iore ne ll’
Appen
m'
no cen trale . Atti Soc . Tosc . d i Se . Nat. Pr . Verb . vol. VI II. Pisa, 1 892 .
V IO LA C . Appun ti g eolog ia e id : ologsci su i d intorm'
di Teramo. Boll. R. C om itato
Geo log ico ,vo l. XX IV , pag . 2 2 I . Rom a , I 893.
M ODERNI P. Osservazion i g eolog iche f al le ne ll'
Abruzzo teramano duruale l'
anno 1 894.
lb id . vo l . XXVI, pag . 446. Roma, 1 895. Osser vaz ion i g eolog i che fatte a con/ ine dell’Abr uz zo
te ramano con la prov iamo di A scoli ne l l’
anno 1 896 . i b id . vol. XX IX , pag . 82 . Roma, I898 .
BO NARF.LLI G . Relaz ione sulle escu rsi on i de lla Società g eolog i ca I tal iana ne i d in to rn i di
Asco li P lCeno . Boll . della Soc. Geol. Ital. vo l. XVIII, pag . LVIII. Roma, I899 .
DI PALEONTOLOGIA 99
sivam en te , col persistere d ell ’ az ione erosiva, sotto alla rupe d i travertino
vennero posti allo scoperto queg li sc isti arg illos i e quelle marne , che al
con tatto col trave rt ino segnano il livello d i base dell’abbondan te circola
z ione so tterranea la quale trova po i sfogo ne lle ricche scaturig in i de tte ap
pun to d i Cas tel T rosino .
Il travertino ascolano ragg iunge la massima elevaz ione sulla destra del
Castellano , costituendo la somm i tà del Co lle d i S . Marco um . 630 ) con una
potenza massima d i un cen t inaio d i m e tri . Ad altitud in i poco m inori , seb
bene con spessore m eno rilevan te , si ritrova anche a S . G iorg io sulla sin i
stra d el Castellano e all’
Albero de l Piccione sulla destra d el T ron to rim
pe tto a Mozzano .
T enendo pure con to de i lemb i ogg i isolati e d i m inore importanza spo
rad icam en te d issem inati sulle alture de lla d estra de l T ron to , non è arri
sch iato l’
ammettere che i travert in i , attualm en te in terrotti pe r lungh i tratt i
dalle inc ision i de i torren ti e fium i , hanno po tuto orig inariamen te d epositarsi
p er un’
estensione d i una quind icina d i chilom e tri fra le estreme scaturig in i
d i acque in tensam en te calcari fere presso Ascoli e presso Acquasan ta, e su
d i una larghezza che presen ta i l suo mass imo d i due ch ilom etri fra il Colle
d i S . Marco e Cas te l T rosino .
Al Co lle d i S . Marco e al Mon te Rosara, il travertino si è mostrato
p iù che altrove fossilifero , ma men tre i mo llusch i furono stud iati dal M a
scar in i ( I ) non venne ro mai fatt i ogge tto d i stud io nè d e term inat i i pochiden t i e g li scars i frammen ti d i ossa d i mamm ife ri in esso raccolti e ogg i
conservati ne l Museo O rsin i d i Ascoli Piceno Valendom i de l cortese
consen so d el Prof. Alessand ro M ascarin i , d irettore del Museo O rsin i e
de l proprietario Comm . Dott . G iovann i T ranqu illi , m i sono acc in to volen
tieri al riconoscim en to d i tali resti , g iacchè , dopo l’
illustraz ione che
anche delle frequen t issim e filli t i e carpolit i de l travertino ascolano venne a
com plem en to d elle citaz ion i d i Specie d i pian te fatte dal Gaud in e S trozz i (3 )
e dal Ponz i (4) com piuta dal M ascarin i le brevi not iz ie paleon
( I ) .‘IAS C ARIN I A. Lap i s tibur tma apud Ascu lmn . R iv ista sc ien t ifico-industr iale d i G .
V im ercat l . Anno X IV ,F iren ze , I882 .
( z ) M ASC ARIN I A. A n ton io Or sin i e le raccolte da lu i lascrale . Asco li Piceno,
I889 .
(3) GAUDIN C n . a r S r aozz n C . Con ln bn lzon à la flore f ossi le i ta lienne . ZV M ém .
pag . 1 6- IS. Par is , I860 .
(4 ) PO NZ I C ronaca subappenn in ica o abbozzo d i un quad ro g enerale de l peri odo g la
czo le , pag . 57 . Rom a , I875 .
(5) M AS C AR IN I A . Le p ronte fossi l i ne l lrover lm o ascolan o . Bo ll. C om . Geo l. Ital.
vo l. X IX . p ag . 90 . Roma , I888.
1 00 RIVISTA ITALIANA
tolog iche q ui riportate serv iranno , se non altro , ad ampliare le od ierne co
noscenze sulla flora e fauna d el travert ino ascolano , c itato quasi solo inc iden talm en te ne i lavo ri g ta rico rdati d ello Spada e O rs in i , nella re lazione
Bonarelli sulle escursion i de lla Società geolog ica nel suo XVIII C ong ressoe nella m onog rafia d ella carta id rografica d
’
Italia relat iva al bacino d e l
T ron to (M in istero d i Ag ricoltura Ind ustria e C omm ercio , Roma
O ltre alle ossa,quasi tutte d i selenodon ti , esisten ti ne l museo O rsin i ,
il Prof. M ascarin i m i presentò un campione d i travertino con frammen t i d i
un om ero . altre ossa lunge e d i tre vertebre cervicali s icuramen te apparte
nen t i ad un aves , ma troppo mal conservat i per consen t ire una dem ina
z ione at tend ibile .
Ecco , senz’
altro ,un sommario accenno sui resti d i mamm iferi foss ili
racco lti nel travertino presso Ascoli Piceno .
C savvs ELAPHUS Lin . I 766 . (Strongy loceros spelaeas O w en 1 846 Cen ms
barbarus G ray IS50 ) .
Un framm en to spezzato in d ue d i ram o m and ibolare sin istro con
molari ro tt i al colletto . La lunghezza d i tale framm en to con altezza e
spessore massim o nella sua parte poster iore d i mm . 34 e IS , e altezza e
spessore m in imo nell'
an teriore d i mm . 30 e I I ,5 è d i mm . I I 5.
Altro resto d i ramo m and ibolare s in istro con rad ici d i due mo lari , alto
mm . 34 circa e spesso mm . I 9 .
Parte pos ter iore d i ram o mand ibolare destro , con i due ultim i molari
tenacem en te cem en tat i ne l travertino e scoperti solo ne lla parte esterna. Q ue
sta branca m and ibolare parz ialm en te con servata, ha un’
altezza d i mm . 36
e uno spessore mass imo d i mm . L’
altezza coronale d e i molari è d imm . I 6 ,5 e la larghezza al colle tto è d i mm . 1 5 c i rca.
Un altro framm en to appartenen te pure alla m e tà posteriore d i ramom and ibolare d estro a confine con la m età an teriore , è in cattivo s tato d i
conservaz ione , va d im inuendo d i spessore in teriorm en te , e oltre al presentare un
’
altezza d i mm . 34 , mostra due alveo li con m a] d is tin te rad ic i den
tar ie .
F ra i d en t i iso lati , no to
Ult im o mo lare inferiore d estro.
Due premolari in fe riori d estri .
Due m olar i d el m ascellare superiore d estro , d e l quale non ho potutod ist inguere tracc ie s icuram en te riconosc ib ili , fra gli inform i frammen ti com
presi ne l travertino .
RIVISTA ITALIANA
C'
Iansi l io , Cy clostoma e d i Lim naea, Planorbis ed altri m ollusch i stud iati
dal M ascarin i .
A parte le cons id eraz ion i cronolog iche che sul deposito potrebbe sug
gerire la presenza delle pred ette spec ie d i mamm iferi , ricordo che dali’
cun
m eraz ione delle conch ig lie fossili g ià note nel travertino ascolano , s i ri
leva il forte predom in io delle specie tutt’o ra viven ti nel bac ino d e l T ron to
su que lle est in te o che rappresen tano forme ogg i conosciute in localitàimmed iatam en te p iù a nord e p iù a sud de ll
’
Italia cen trale ; cosi che dal
l’
esame d i de tta fauna si dovrebbe ven ire a conclude re che i l bacino del
T ron to , duran te la form az ione del travertino avrebbe man tenuta una tem
peratura med ia uguale all’
od ierna. A conclusion i analoghe condurrebbel’
elenco d elle fillit i de term inate dallo stesso M ascar in i , i l quale , avendo
riconosc iuto ne l travert ino anche d elle impron te d i b ruch i d i lepidotteri e
d i al tri o rgan ism i molli e d i faci le d ecom posizione , ri tiene che i depositi
in paro la s iano l’
e ffetto d i un processo id rochim ico abbas tan za rapido , de
term inato da un abbondan te svolg imen to d i an id ride carbon ica.
Le re liquie d i Corv us g ig an teus fra i resti d e i mamm iferi da m e r ico
nosc iuti ne l travert ino asco lano , consen tono d i chiarire meg lio , per non d ire
mod ificare , tale concet to , g iacchè il loro rinven imen to prova che le cause
che hanno d eterm inato la d eposiz ione d e i travert in i ascolan i , sebbene ap
paiano ogg i straord inariamen te affievolite dopo una probab ile mass ima
in tensità d i formaz ione in tem po geo logicamen te recen te , pure dovettero
incom inciare i loro effe tti fin dal quaternario an tico e non ce rto dopo al
terrazzam en to , g iacchè anche nelle alluv ion i profonde d ella valle del T ron to
presso ad Ascoli , si ritrovano faci lm en te massi e c iotto li d i trave rt ino .
Rimarrebbe cosi accertato che anche i l travert ino ascolano com e la
magg ioranza d eg li analogh i del Laz io , dell’ Umbria e d ella Toscana, com in
ciarono a formars i all’
alba d el postp liocene , con t inuando con in tensi tà var iab ile fino al recen te .
DI PALEONTOLOGIA 1 03
SU D I UNA NUO VA F O R M A D I O S T R IC A
D E L P L I O C E N E I T A L I A N O
N OTA DI G. ROVERE TO
(con Tav. V II) .
Prego i colleghi d i non lasciarsi sfavorevolmen te im press ionare da questo t itolo : ritengo anch ’
io che la l im itaz ione delle specie nel genere Ostrea
sia talmen te incerta, da poterne fare d i nuove a vo lon tà , le quali non hannopoi valore ; ma in questo caso segnalo una forma che r itengo nuova per il
pliocene nostro , e m i servo per segnalarla d i d enom inaz ion i vecch ie .
L’
ostrica da me trovata fra le collez ion i de l Museo d i Genova, e che
i l prof. Isse l m i ha gen t ilmen te permesso d i stud iare , prov iene dal pliocened ella Val d
’
Andona ha l’
aspetto d i una tabacchiera, tan to è ven trosa
e allungata la sua valva inferiore , o sin istra, mentre la sua valva superiore ,0 destra, è in teramen te pianegg ian te .
La valva inferiore e all’esterno tutta fittamen te lamellosa e long itu
d inalmen te ondulata ; ha uno spessore d i 47 mm . su 87 d i d iam etro um
bone—ven trale , e su 46 d i d iametro antero-posteriore . E quind i spessa quan tolunga, e da ciò risulta nel suo in terno una cav ità ristretta, allungata e p ro
fonda, tutt’attorno egualmen te orlata. Quest i orli sono ondulat i , e ing iro «
e vicino all’area card inale presentano d e lle intaccature , cui corrispondono
com e d e i den ti nella valva superiore . L’
impressione muscolare e c ircolare e
a d estra ; la piattaforma cardinale e sporgen te e piatta, con fossetta allungata,
d i poco m eno larga d elle aree laterali . La valva superiore è quasi piana,ha i margin i ondulati che si adattano alle ondulazion i del marg ine in
feriore e sono alquan to rivoltati verso 1’in terno per poter m eg lio comba
ciare . O ltre i falsi d en t i marg inali , i quali specialm en te attorno all’
area
quas i pianeggian te d el card ine, sono numerosi e ben d istin t i , in ternam en te ,
ad una d istanza eguale dai marg in i , e per modo da racch iudere l'
im pres
( 1 ) Un altro. frammen to della stessa forma esiste nelle collez ion i d e l M useo d i Genova,
ed e proven ien te dal p liocene di Savona.
1 04 RIVISTA ITALIANA
sione muscolare , si hanno delle m inute impression i , come p un tegg iatura d ispillo , fitte e allineate ,
verso il card ine profonde , verso il marg ine in feriore
superficiali e alquan to allungate , che debbono essere dovute a inserzion i
d i muscoli , od al marg ine papilloso de l man tello .
I caratteri d ei falsi den ti e d elle in taccature marginali nelle due valve ,
e della pun teggiatura in terna della valva destra, hanno evidente confron to
nelle ostriche v iven t i e fossili d el g ruppo O . cucullata auct. non Born .
H o g ià affermato in un preced en te lavoro ( I ) che se g li autor i consul
tassero la figura tipica del Born s i conv incerebhero che l’O . cuculloto non
esiste nel nostro p liocene ; e con tem poraneamen te il Sacco (z) , ripetendo lastessa afiermaz ione , ri feriva l
’o. m ultata auct. palaeon t . alla 0 . Par l ii
C hem n . Da m ia parte , inquan to ag li esem plari fossili sinora conosciuti , sono
incerto se riferirli alla 0 . F orshd li i o alla 0 . corn ucop ia L., o se queste duespec ie , d i cui l
’una e d el Mar Rosso , l
’altra de l Senegal , siano la stessa
cosa, come d i certo sono almeno rappresen tative ; noto però che col ritro
vamen to della forma qu i descritta, l’affermaz ione che la tipica 0 . cucullala
non esista nel nostro pliocen e rimane molto infirmata.
Infatt i , chiunque vorrà con fron tare con la figura del Born il nostro esem
p lare , riscon trerà grand e som iglianza fra essi , m entre le d istinz ion i dalla
0 . cucullata auct . si scorgono a prima vista. La 0 . cucullota t ipica ha un’area
card inale che è come ne lla fossile appiatt ita, ma tendente a cont inuarsi ap
pun tita oltre il marg ine della conchiglia, e a rivolgersi all’ind ietro , ed è
pure alquan to meno ven trosa ed allungata, per cui considero la fossile una
sua varietà cui do il com e d i var. copsn loidea. Invece la 0 . cucullata dei
paleon tolog i non ha affatto la forma d i tabacch iera, e presenta marg in i p iùondulati .
Non ho trovato ne lle collez ion i d i Genova deg li esemplari v iven ti d i 0 .
cucullata Born , i quali corrispondessero in tutto , e specialmen te per la loroven trosità , al tipo figurato , o che v i corrispond essero quan to il fossile ; horinvenuto però d eg li esemplari appiatt it i , perchè tutti ad eren ti , proven ien tida Maior e da altre località dell
’Oceano Ind iano , i quali , pur avendo per
duto uno dei lori caratteri d istin t ivi , conservavano un orlo in tero , alquan torilevato .
Anche in questo caso , tan to ne l g ruppo della 0 . cucullata, quan to in
que llo della 0 . cornucop ia , le variazion i si ripetono eguali , perchè hanno una
( 1 ) ROVE RETO G . N ole preventive sui pelecipod i del tong r iano ligu re . p. I. Atti Soc. Lig .
d i Sc . Natur… vol. VIII, 1 897 .
( 2 ) Sacco F . M ollusch i terr en i ter ziar i. p . XX III, pag . 1 7 , 1 897 .
RIVISTA ITALIANA
O s tr e a l a m e l l o s a Br . an O . edul is L . var.
Con alcune sue variaz ion i si collega alla 0 . seneg alensis .
O s tr e a n a v i c u l a r i e Br. an . O . cochlear Poli var.Questa e la preced en te , anche cons id erate come g ruppi , presen tano
delle fort i d iffe renze dalle viven t i , per cui inclino a seguire piuttostol’opin ione d e l Pan tanelli , che non quella d el Sacco , il quale s i vale pe r
segnalarle d elle designaz ion i specifiche adoperate per le v iven t i.
O s ta-e a e te n d n a Payr. an O . g erman i tola De Greg . (O . p licolula auc t .
non Gm .)
Anche in questo caso tutti com prendono c iò che si vuole ind icare
ma la d iscord ia è sui nom i e sulla lim itaz ione d ella spec ie. Per me e
certo che il tipo del Gmel in non corr ispond e alla v iven te nel M ed iter
raneo O. slen l ina, che è la d iretta con tinuazione de lla forma foss ile .
Basti osservare che la specie de l Gmelin si r iferisce alle Alectry on ia , e
che non può quind i rien trare nel gruppo della 0 . edul is cui appartien ela 0 . sten tino .
O s t r e a p e d e m o n ta n a Mayer (Journ . d e Conch . , pag . 2 2 9 , tav. X I,
X II, fig . 1 ,
È forma in teressan t iss ima, perchè rappresen ta ne l pliocene la 0 . on
g ulola Lemk. d elle coste atlan t iche d e l Portogallo e d ella Francia. Al
Pan tanelli è sfugg ita, il Sacco dopo averla lungamen te d iscussa cred e
che possa riferirsi alla 0 . Sabbucinae Brugnone ( I ) , nel qual caso questonom e , essendo d i data an teriore , dovrebbe prevalere su que llo del
Mayer.
Un altro g ruppo è quello d e lle ostriche caudate . Il Sacco le con sidera
corrispondent i alla 0 . f rondosa De Serr cui come var ietà riferisce la 0 .
cande la Munst . Il nome p iù s incero sarebbe per me quello d i 0 . oirg ul i
j orsm'
s Mayer (Journ . d e Conch . , vol. XX , pag . 2 28, tav . X IV , fig . che
i l Pan tanelli cred e dato ad una g iovane d i O. cua d lata. È comune nell’
Asti
g iano in Liguria è invece rarissima un solo esemplare raccolto da me a
San Fruttuoso presso GenovaDi San Fruttuoso ho g ia ind icato anche la 0 . Delbosi M ayer (Journ .
de Conch. , vol. XX , pag . 2 2 7 , tav . XIV , fig . della quale i l Pan tane lli
( I) BEL’
ON0 NE Conch ig lie p li ocen i che di Caltan isetta, pag . 1 35 , tav . I, fig . 1 9 , 1 880 .
1 08 RIVISTA ITALIANA
IL DEVONIANO M EDIO
N E L L A G I O G A I A D E L C O G L I A N S
NOTA DI P. V INASSA DE RE ONY
(Con Tav . VIII).
Il Devon iano med io , prima d elle scoperte del Frech n elle Alpi carn iche , era ignoto in Ital ia. Ed anche nelle Carn iche era lim itato ad una
piccola estensione . Difatti il Frech , generalizzando , aveva dato a questopiano una grande d iffus ione , spec ialmen te ne lla g iogaia del Cog lians sul
versan te italiano m a i l Geyer , m olto p iù cosc ienz iosamen te , lo aveva
lim itato ai soli pun t i ove aveva trovato fossili d i tale e tà e cioè al sommo
del p izzo d i Co llina e delle K ellersp itzen
Nelle ricerche , che and iamo da qualche anno facendo ne l nucleo cen
trale delle Alpi carn iche , C o rtan i ed io siamo r iusc it i a scoprire altre loca
lità m esod evon iche . Ricordo quella d el Germule a S tr ing ocephalus B urt in i ,
im portan t iss ima per la conoscenza geolog ica d i quella tan to d iscussa massa
calcarea. Ed ogg i posso agg iungere altre locali tà d ella im portan te g iogaiadel C og lians , che c i ha g ià dato tesori paleon tolog ici inaspe ttati ed altr i
ancora ce ne prom ette .
Sulla geolog ia del versan te italiano del Coglian s svariate sono le op i
n ion i . Il Frech immag inava che il gruppo d el Cog lians fosse costituito da
una pila d i strat i calcarei pend en ti a Sud , sostenuti nel versan te setten
trionale da una massa d i scisti silurian i , e term inan t i a Sud con una faglia
( I ) F REC II F K arm'
schen A lpen , pag . 263.
( 2 ) Gavan G Geolog ische .S'
pecxal [ ( ar te der Oest. un: . M onorch io. P latt Oberdr ou
burg und M aul/aen .
DI PALEONTOLOGIA 109
che li po rta a con tatto con scisti d el C ulm . E , po iché sulla parte p iù al ta
d el Pizzo d i Collina e d elle K ellersp itzen eg li trovò fossili mesodevon ici ,
tutti i calcari del versante italiano d ella g iogaia sono per lui mesodevonici .
Dopo quan to g ià scrissi r ispetto al la età deg li scist i ( 1 ) m i semb ra inu
t ile d iscutere sull’errore del concetto tetton ico de l Frech . E rispet to alla
affermaz ione g ratuita che tutt i i calcari del versante italiano siano meso
d evon ici , ne provano la insussistenza, tra l ’altro , la scoperta dell' Eodevon ico super iore alla C ianavate ( 2 ) e la se rie neosilurico-eodevon ica d el passod i Vo laia alla base d el Cog lians e d el Capolago , da me recen temente
Ch i portò id ee assolutamen te innovatric i ne lla strat igrafia e nella tet
ton ica d ella g iogaia del Co‘
g lians fu il De Angelis d'
Ossat nella sua : Seconda
con tribuz ione allo stud io de l Paleozoico de lle Alpi carn iche che rap
presen ta il primo stud io paleontolog ico italiano sulla g iogaia del Coglians.
Il De Angelis , in base a poch i fossili , aveva d eterm inato i pian i e lezone seguen ti
Zona ad Ortiz. alt icolo .
S°
luriano su eriorepZona ad Or tiz. R ichter z
‘
Zona a Tom oceras i nex peclatum .
De n ia o ferioreParte med ia (Rìfikalk ) .
Parte inferiore (Brach iopodenkalk ) .Devomano superi ore
Calcan a C hmema.
Ven iva cosi escluso il Devon iano med io .
Fatta astraz ione d e l Calcare con C lim en ìa che venne trovato al M . Pri
mos io. e d el quale parlò recen temen te il C ortan i restano d unque sta
b iliti nella sola g iogaia del Cog lians , secondo il De Ange lis , i l Neosilurico ,
l’
Eod evon ico e il Neod evon ico in feriore .
( 1 ) V INASSA P S ull’
estensione del Carbon i/ ero supen'
o re nelle Alpi com iche, Boll . Soc . g .
it 1906 .
(a) C ORTA… M C'
onb 1’
buz iom’
alla conoscenza de l Paleoxoico Com ico, F aune devom'
av .
Palaeon t. i tal., 1 906 .
(3) V trunssa P F ossi li paleozoz‘
a’
de lle A lp i com iche . F an na Rh . M eg a ra. Palaeon togr .
italica, 1 908 .
(4) Da. ANGBUS G R . Accadem ia Lincei , M emorie , 1899 .
(5) C ORTANI G F auna del calcare a C lm em‘
a del M . Pr imosio. M em . Acc . Sc . Bolog na,
RIVISTA ITALIANA
Quest i r isultat i erano d i una straord inaria importanza, e il De Angelis
li pose in evidenza, facendo notare come la tetton ica d ella reg ione dovesse
sub ire una vera e propria instaurat io ab im is fundamen t is. Questa nuova
concez ione te tton ica è stata dall’Autore schematizzata in due sez ion i , poste ,
come conclusione , al term ine d el lavoro . Nella prima d i esse è il concettodel F rech d i tanti strat i un iclinali , penden ti verso Italia e colla testata in
Austr ia, e nella seconda invece è es presso il concetto d el De Angelis d i unacurva sinclinale regolare , per la quale sul versan te italiano a(fiorerebbero
tutt i g li stessi orizzon t i del versan te austriaco .
S ino dalle prime escursion i nella g iogaia d el Cog lians , fatte ann i fa p iu
per orientam en to generale che per stud i spec iali , che erano allora lim itati ai
mon t i attorno a Paularo , m i ero persuaso della incons istenza del concetto
tetton ico d el De Angelis, ev iden tem en te basato sul so lo studio d e i fossi li e
non su osservaz ion i in posto . È d iffici le d i fatt i immag inare una regione in
cui p iù tipicamen te sia sv iluppata la pendenza un icl inale e concord e d i tutta
la massa calcarea verso l’
Italia come in tutta quan ta la giogaia del Co
gl ians. Ogn i e qualunque accenno d i curvatura sinclinale va escluso .
A spiegare dunque la presenza d i tan ti e cosi variati p ian i trovat i dal
De Angelis non si poteva rico rrere alla sinclinale , che fa riaffiorare in Italia
i m ed esim i orizzon t i de l versan te setten trionale . Non rimanevan dunque che
le fag lie : Per esse d ifatti po teva risultare un affioram en to d i terren i in fer io
ri , qualo ra si supponesse ro una o p iù po ten t i d islocaz ion i , che interessasserola m assa calcarea e la d ividesse ro in g rand i scag lion i . La scope rta d ella
fauna con [ ( arpz'
nsky a Consuelo d e ll’
Eodevon ico superiore alla C ianavate
parve confermare una tale id ea. Difatt i alla C ianavate s i trova un orizzon te
che n el versan te austriaco affiora p iù basso , e penden te anche verso Sud .
Questo fatto può forse riportars i ad una fag lia.
Proseguendo pe rò g li stud i sul nucleo cen trale carn ico m i sono semprep iù persuaso che le fag lie han no nella sua tetton ica una parte d e l tutto su
bord inata. La mancanza assoluta d i fag lie nel Germula rendeva perplessiad amme tte re nella giogaia d el Coglians una fag lia così poten te , quale sa
rebbe stata necessaria perchè tra Casera M onum en z x ) e Casera Val d i
Collina affiorassero i l S iluriano e il Devon iano in feriore .
Si rendeva pe rciò necessario uno stud io ex -novo de lla g iogaia del Co
g lian s , e questo venne e ffe ttuato nella campagna geolog ica d ecorsa con ri
sultati insperati , d e i qual i g ià d ied i cenno in altre pubblicaz ion i .
Il De Ang e lis scrive indufi'
eren temen te C asera , Casa . C a‘
e Cava M onumen t , ma il Vero
nome e C asera M onum en z .
RIVISTA ITALIANA
tutt i esemplari d i nessun valore . E con esemplari d i tal fatta non sarebbe
stato forse male d i andare molto guard ingh i nelle conclusion i , tanto p iù
quando esse portavano a risultati profondamen te opposti a quan to comune
m en te era ammesso , e trattandosi d i reg ion i ove avevano eseguite ricerchevaloros i geolog i stran ieri , uno de i quali , il Frech , non aveva nascosto i l
il suo d isprezzo e la sua noncuranza per tutto c iò che fosse stud io ital iano .
Il risultato della revisione è stato grave . Lo riporto qu i documen tan
dolo al p iù possibi le . Non avre i certo des iderato d i fare opera cosi ingrata.
M a era necessario , per la retta in terp re tazione d i una località cosi in teres
san te per tutta la geolog ia d ella reg ione , d i porre su bas i sicure la sua co
noscenza.
O r t h o c e r a s l l i o h t e r i (non Barr.) (Tav . VIII , fig . r-z ).
È un frammen to d i Orthocer as che i l De Angelis ha figurato non del
tutto esattam ente , come risulta dalla fotografia dell’esem plare (Tav . VIII,
fig . e dalla copia della figura ripresa dalla pubblicaz ione citata del De
Angelis (Tav . VIII , fig .
La d eterm inaz ione d eg li Or t/zoreras è d i una d iffi co ltà g rand issima, an
che per il fatto che l’opera classica del Barrande è tuttora priva d i crit ica. A
me non semb ra che i caratteri accennat i dal De Angelis , d i taluni dei qualiperò non son riuscito a trovar tracc ia sull
’
esemplare , possano bastare a dare
asso luta sicurezza d i d eterm inaz ione . C osi ad esempio I'
esemplare in pa
rola potrebbe essere anche con altrettan ta probabi lità r iferito all’Or tkoceras
B ebr ix Hall ( 1 ) che è specie m esodevon ica. La forma generale e l’anda
men to sinuoso de i marg in i d ei setti rispondono anz i ben issim o a questaspecie.
A m io parere quind i questo esemplare non può avere valore cronolog ico .
T o r n a c e r a s i n é x p tec t a t u m (non F rech) (Tav . VIII , fig .
Premetto che la zona a Tor noceras in : .rpa tatum non è devon iana ma
neosilurica superiore . Essa d ifatt i si trova al d isot to de lla zona a Rhyno/xo
nella M ag m a , che il G eyer prima ed io recen temen te abb iamo d imostratoesser t ipicam en te s iluriana.
L’esemplare é in pessimo stato d i conservaz ione , come del resto ri
( r ) HALL Pala/ anthology of Nm l’
ar t , V , pag . 2 76 , tav . 39 , 86 , 9 : e 92 .
DI PALEONTOLOGIA 1 1 3
s ulta anche dal la figura data dal De Ange lis (Op . cit . pag . 1 6 , fig . La
ho fatta rid isegnare accuratamen te dall'
eg reg io Con to li , so tto la sorveg lianza
d iret ta del C ortan i (Tav . VIII, fig .
Il De Angel is trova che g rand i sono le som ig lian ze co l Tor nocer as
i nex per latum . Dice altres ì che ha potuto riconosce re i lobi che sono p iu
acut i d i quelli del T. S tac/re i , e che le pun te non vanno verso l’
estremo
com e in quest ’
ultim a spec ie . Ev id en tem en te una qualche rot tura d el gusc io
d eve ave r indotto in e rrore i l De Ange lis . Difatt i , attaccando leggermen te
con acido clorid rico , è stato m olto fac ile po rre in ev idenza la linea lobalela quale , come s i vede dalla figura (Tav . VIII, fig . 8) è assolutam en te d i
ve rsa da quella de l Tornoceras iner pa tatum del F rech (Tav. V III , fig .
L'
esem plare è forse un m ocer as ma nulla d i p iù s icuro si p uò d ire ,
salvo che non'
e certo l’
in e.zp ectatum . Va d unque esc lusa la presenza d i
questa fo rma, caratterist ica d e l Neos ilur ico superiore , nel M esodevon ico d i
C asera M onum enz .
C y p h a s p i s sp . (Tav . VIII, fig .
Questa forma, insiem e alla seguen te , starebbe a rappresen tare la partem ed ia de ll
’
Eodevon ico . L’
esemplare è anche in pegg iore stato de l preced en te . E il De Ange lis d i fat ti non lo ha d eterm inato che gener icam en te .
La d e term inaz ione non avrebbe alcun valore , anche se fosse esatta, cosa che
non s i può nemm eno asserire .
G o s s e l e t i a . cfr. d i s t i n c t a (non Po ll.) (Tav . V III, fig .
C om e r isulta dalla figura m i sem bra che l’
esemplare non possa rife rirsi
a questa spec ie , caratterizzata dalle coste concen triche molto rilevate che
mancano d el tutto n ell'
esem plare d i Cas . M onum enz . Anche il con torno
non semb ra sia r ispond en te ,m a poco se ne può d ire essendo tutto sman
g iato e ro tto .
De l resto po i anche se si trat tasse d i questa forma non se ne po trebbededurre la presenza de ll ’ Eod evon ico , essendo la spec ie d iffusa anche nel
M esod evon ico .
P r o d u c t e l la cfr. H e r m i n a e (non F rech) (Tav . VIII, fig .
La specie del F rech , com e tut te le I ’roductella , ha la valva magg iore
m olto rigonfia, molto r icurva in alto , e la sua superfic ie è tutta pm 0 m eno
spinosa , e sem pre m un ita d i r iliev i irrego larm en te concen tric i .
I 14 RIVISTA ITALIANA
L’
esem plare che i l De Ange lis r iferisce , s ia pure con d ubb io , a q ue
sta form a, d ed ucend one la presenza d el Neodevon ico in fer iore , pe r quan tos ia al so lito m alissimo conservato pure lasc ia sub ito vedere che non solo
non è la P rod rw tella I l er minae F rech m a che nemmeno è una P roductella.
Le o rnam en taz ion i che s i vedono in talun i pun t i m ostrano com e non
s i abbia alcuna traccia d i coste concen tr iche e nemm eno d i spine , m a che
anz i la supe rfic ie è tu tta ad orna d i strie rad iali . La forma ge nerale po i nOn
è d i P roduc tella ma piut to sto d i Or tizis .
Se l’
esem plare m eri tasse una d eterm inaz ione sare i p er avvicinarlo alla
com une 0 r l /zis str iatula , fo rm a d iffusa in tu tti i g iac imen ti d evon ian i anched e lla C arn ia ,
e pr iva d i og n i e qualunque valore crono log ico .
Non han no qu ind i alcuna rag ione d i suss iste re le sud d ivision i che i l
De Ang el is ha am m esse p e i terre n i post i t ra C as . M onumen z e C as . Val
d i C o llina . Q ui è in vece sv iluppato m olto i l M esod evon ico , perfe ttam en te
con co rdan te e riposan te sull’
Eod evon ico supe r io re d e lla C ianavate .
I foss ili sono quiv i rappresen tat i con una straord inaria r icchezza d i fo rm e
e d i in v id ui . La in te ressan te fauna d i ques ta locali tà sarà in breve i llustratad al C ortan i e da m e . Ogg i m i lim ito a figurare solo talun i fossi li i qual id evono solam en te se rvire d i docum e n taz ione al n uovo r ife rim en to c ronolo
g ico .
S t r i u g o c e p h a l u s B a r b i n i De fr. f
(Tav . VIII, fig . 9 a-d ) .
No n cre do occorrano m olte parole p er parlare d i questa belliss ima e
carat ter ist ica fo rm a. Nè che occorra m olto p iù che la figura p e r m ostrare
che veram e n te s i trat ta d i questa spec ie , caratterizzata dal suo umbone g rifeato ,
spo rg en te . La fo rm a d i C asera M onum en z ha l'
um bone poco r icurvo ;
non p uò qu ind i rife ri rs i alla var . rostr o/a. De l resto , com e osservava g ià lo
S chn ur n , la spec ie è caratte rizzata dalla sua g ran d e variab ilità spec ialm en te n e lla forma d e ll
’
um bone . Il m io esem plare o ffre le m agg ior i som i
g lian ze con que llo figurato dallo S chn ur (O p . c it . tav . XXVIII, fig . 5 ) alla
quale r ispon de anche p er le d imens ion i. T ale form a è la t ipica d e lla spec ie .
( I Sc u x ua Z usamma de llung und Besch r eibung sdmm t. in dz u vor bonun B om l uopd m. Palaeon tog rap h ica ,
Il l , 1854 , p ag . 195 .
1 1 6 RIVISTA ITALIANA
e d un altro esem plare ha una t ipica curvatura m olto r isen t ita. I caratteri
anatom ici sono molto ben v isibil i. I se tti sono assai numerosi , da 36 a 40 ,
d i cui solo i principali arri vano sino al cen tro . Le tavole sono molto estese
ed occupano un poco p iù d ella m e tà d el d iame tro . La forma è d el resto
ben no ta e fac ilm en te d e te rm inabi le .
Ne lla d esc riz ione d ella fauna, che seguirà tra breve e d ella quale Gortan i ed io stiamo ad esso occupandoc i , nuove fo rme saranno d escrit te le
quali pe rme tteranno anche una esatta ind icaz ione d i live llo e confron ti con
altri g iacim en t i . S ino da ogg i però m i credo auto rizzato ad asserire , in
base ai documen ti paleon to log ic i s inora d escritti e che p er la loro conser
vaz ione non possono lasc iare il p iù piccolo d ubb io , che i calcari post i traC asera Monum enz e C ase ra Val d i C ollina sul ve rsan te m erid ionale del
C og lians appartengono al M esod evon ico e p iù spec ialmen te all’
or izzon te
con S tn'
ng ocephalus . Ess i s i addossano regolarm en te con pendenza concor
dan te ai calcari d e ll’
Bod evon ico supe riore , affioran ti p iù in alto , alla C iana
vate , e non occorre ricorre re a nessuna piega o fag lia pe r sp iegare la loropresen za, che è te tton icam en te rego larissima.
Perug ia, Laboratorio d i Geo log ia d el R. Is tituto superiore ag rario. Ap rile , t908.
SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA V III.
Or thoceras sp . Or th . R ich ler i sec . De Angelis‘.
0 r l lzocer as sp . F igura de l De Angelis.
3 . Or t/i i s sp . P r oductella cfr. H em n‘
nac sec . De Angelis).
4 . T Cyp / msp is sp. sec . De Angelis ).
5 . Gossek l ia sp . Gosseletia cfr . d istincta sec . De Ange lis ) .
6 . Tor nareras sp . Tor noceras i nesper tatum sec . De Angelis) .
7 . Linea lobale del Tom ocem s inespectatum F rech .
8. Linea lobale del Toznoceras inesped alum (De Ang . non F rech ) .9 a
-d . S tn'
ng ocs lus B ar tin i Defr. tipico .
t o a-d . S tr ing . Bur t in i var . dorsal is C d fs .
r r a—c . Pen tamem s bip l icatus Schnur.r z a -d . l ’
en tamer us f ormosus Schnur .r3- 1 6 . Cy athop/ry llum coesp i losum C d fs .v
v
#
v
v
v
v
v
v
v
v
1 8 RIVISTA ITALIANA
Per i locul ina M u n i e r —C h a lm a s e S c h l u m b e r g e r ( I ) , Lacaz ina M u
n i e r - C h a l m a s e resulta caratterizzata dall’aver l
’
apertura d el p lasmostraco ch iusa dal ( remoto/ oro , cons isten te d
’una lam ina dotata d i nume
rose perforaz ion i , som ig lian ti a quelle della cipo lla d’
un innaffiatoio , Op
pure d i molte trabeco le p iù o meno spinose e con torte che , partendodall
'
orlo de lla stessa apertura, riun isconsi al cen tro. Come anche dal p re
sen tare i segmen t i costituen t i i l p lasmostraco , completi , ossia provvedutid
’
una so rta‘l’
im pian tito , che manca ne lle M iliolid i non trematoforate
connotato questo , il quale ben potrà rilevarsi dal confron to d e lle fig . 2 2 e 23 ,
tav . IX , riprod otte dallo Schlum berger, d i cui la prima riguarda la formamega
losferica d’una M iliolide trematoforata, la Pen tel! ina chalmasi S c h l um b . (4)
e la seconda, la form a pure m egalosferica della M iliolide non trematoforata
con la quale genericam en te essa converge , detta Quinquelocal ina vulg ar is
d’
O r b i g n y ed è forse prat icam en te il m ig liore per la d istinz ione
de lle d ue so rta d i M iliolid i essendo i l trematoforo un organo assai fra
g i le e quind i d i d iffici le conservazione , tan toche solo in circostanze specialiè dato osservarlo in form e fossili , ossia quando esse si son potute man te
n ere in perfetto stato .
Nelle M iliolid i trematoforate non è po i d iffici le si presen ti no pure altri
carat teri in teressan t i : p. es. la sudd iv isione d elle loro logge con sep im en t i
secondari (F abular ia e Lacazina) , la tessitura arenacea d el n icch io (Sehlumòez;g er ina) ecc ., ma quest i , 0 si lim itano a poche spec ie d i esse (sudd ivi
sione de lle logge ) , ovve ro sono comun i con le M iliolid i prive d i trematoo
( I ) 1 885 ; Bull. Soc . Géol. F rance , ser . 3.a, vo l. X III, pag . 308.
( 2 ) 1 882 : Bull. Soc . Geol. F rance , ser . 3.a,vol. X , pag . 47 2 . I883 ; C . R. Ac. Sc . Pl
ris , vol. XCV I, pag . 86 2 . M un 1 x a-C n ar.mas e Scn w n naacaa , 1 885 ; Bull. Soc. Géol. France ,
ser . 3 .a, vo l. X III, pag . 3 1 4.
( 3 ) C iò va in teso cun g rano solis , perchè in v ia eccezionale si risco n tra qualche M iliolid e
tremato forata sp rovved uta d’imp ian t ito ne
’
p rim i segmen t i , p . es . la Per ilocul ina raim ond i Sca
mun aaaona , forma 8 (vedas i la fig . 1 3 d e ll'autore , a pag . I 24 d e l Bull. Soc . Geo l. F rance ,
ser . 4.a, vo l. V ,come q ualche M iliolide non trematoforata che d i tale imp ian ti to ,
benchè
rud im en tale ,in vece provved uta neg li ult im i segm en ti , p. a . la Qnd nqud oculùm vulgar is D
’
OR
mc ,forma 8 (vedas i la fig . 1 4 d e llo Sch lumberger , a pag . 66 d elle M em . Soc . Z oo l . F rance ,
vo l . V I, IS93 ) .
(4) I90 5 : Bull. Soc . Geo l. F rance ,ser . 4.a,
vo l. V , p ag . I I ? , fig . 3 ; pag . I IS, fig . 4 e 5
tav . II, fig . 3I e 3 1 a.
La fig . 2 2 r iprod o tta n ella un ita tav . IX , corr ispond e alla fig . 3 c itata.
( 5 ) 1893 ; M em . Soc . Z oo l. F rance ,vo l. V I, pag . 65 , fig . I3 ; pag . 66 , fig . 14 ; tav . Il , fig .
65 e 66 .
La fig . 23 r iprod otta n e lla un ita tav . IX ,co rr ispo nd e al la fig . I3 citata.
( 6 ) S I ved a alla prec ed en te an no taz ion e num . 3.
DI PALEONTOLOGIA 1 1 9
foro , laonde , almeno in ogn i caso , non possonsi cons id erare come d ifieren
z iali .
Le poche notiz ie cui ho accennato , concernen ti le lo ro form e fossili
i taliane , si debbono all’eg reg io do tt . P. L. P r e v e r ed all
’i llustre prof. C .
F . Pa r o n a , ambed ue del R . Museo Geolog ico d i T orino ,
'
il primo de i
quali citò nel 1 90 5 , come con tenuta ne i calcari nummul it ici compresi nella
scag lia rossa , nonché nella scaglia rossa nummulitifera del Mon te T ilia
presso Leonessa (Aquila) , una [ ci c l ina sp . ( I ) , ass iem e a
B r ug uier ea Vi rg i l ioi n . f.
sub Vi rg il ioi Prev.
F icheur i n . f.
suòF iclzeur i Prev .
suòH eilp r z'
n i Prev .
Lakozpeia suòBenoisl i Prev.
Defrancei d’
Arch .
Paronaea H eer i d e la Harpeeocen ica n . f.
subeocen ica Prev .
0r lophrag m ina 1 l! ar lhae Sch lumb .
d iscus Rut . sp .
P rotti M ich .
cf. Clmdeaui Sch lumb.
d ispan .ra So w .
patellar is Schlo t .sella d
’
Arch .
Taramell i i M un-C h .
Alveoline: oblong a d’O rb .
fm men l i/orm z'
s Schw ag .
cf. avola» : S techeOper cul ina comp lanata Deft .
ammonea Leym .
G lobig er ina sp ., 0 r6ul ina sp .,B iloculz
’
na sp ., Carpen ter ia sp .,
[ar ia sp ., Nodosar ia sp ., Pullem'
a sp ., Pulvinul ina sp ., Cl ovulina sp .
( I ) 1905 ; Att i R. Acc. Sc . Torino ,vo l. X L , pag . 1 1 es tr .
(2 ) 1 905 ; Atti R. Aoc . SC . Tor ino ,vo l. X L , pag . I I estr.
RIVISTA ITALIANA
Ed anche ne llo stesso 1 90 5 , eg li fece m enzione d’
una [ ci c l ina sp . ( I )
e della Pen tel/ ina stri g i tata d’
O r b i g n y ne i calcari a Lep idocicline
d e i Mon ti d i Bag no (Aqu ila) , con tenen t i pure , secondo l’
autore
Lep idocvr l ina Tonr noner i Lem . e t Douv .
sumatre nsis Bradyd i latata M ich .
B i lan / ina sp .
1 1 1 quan to al prof. Pa ro n a , eg li ind icò ne l 1 90 7 e ne i calcari cerco
chiari , compat t i , con piccoli Gasteropod i e Foram in ife ri d e i Mon ti d i Bagno(Aquila) , l ’ es istenza d e i generi M al ina (4 ) e Lacaz ina , quest ’
ultimo rap
presen tato dalla spec ie [ .acaz z'
na an tique ( d’O r b i g n y ) (5) e Lacaz ina
comp ressa ( d’
o r b ig n y ) (6 1 , un itamen te a forme non spec ificate d iTex tular ia
Cri stellan°
a
Plan isp i r ino
Di ctvoco nus
Li tuonella
a m io avviso g iust ificatamen te , qualche riserva su g li ultim i
( I ) 190 5 : Boll. Soy . Geo l. l t . , vo l . XX IV , pag . 676 .
In q ues to luogo l'autore m i fa un
’osservaz ione critica r ig uard an te il g enere [ cic lina (ne lla
nota in calce a pag . cosi co ncepita : Il g enere Idabn a. co n trar iam en te a q uan to afferma
S ilvestri (ved i in Riv . Ital. d i Paleon t . , vol . X I, fasc . III, la recensione al lavoro : Sulla
fam n nmnm h tica de lla scag lia de ll’
Appenn i no cen tr ale . Prever P . s i trova anche in terren i
eocen ic i (Ved i in Bul l. Soc . Geo l. d e F rance ,vo l. V , se r . 4 .a, Schlumbe rg cr : Denn m a note sur
les M ih'
ohì tì es h én atoplw r i es
Gli ero in d eb ito d'
una risposta , ed ora che m e ne cap ita l’
opportun ità , eccog liela : La
m ia recens io ne cui eg li allud e porta la d ata d i pubb licazione d el 5 agos to 1 905 e fu scri tta ag li
ult im i d e l g iug no d e llo stesso anno : la m emor ia d e llo Sch lumberg er , presen tata alla Socie té
Gdolog iq ue de F rance il 6 marzo 1905 , non comparve in Italia che verso i l settemb re succe sc
s ivo nel Bull . Soc . Geol . F rance : molto p iù tard i in es tratto , perchè il 1 2 lug lio 190 5 mor iva lo
Sch lumbe rger , e la d i lui fam ig lia ebbe ne l tempo immed iatamen te success ivo ben altri pensieri
che q uel lo d i farne inv io d eg li es trat t i ai co rr ispond en t i d ell ’ est in to .
Po tevo io ind ov inare q uand o scrivevo la recens ione d el lavoro de l Prever , indov inare quelche sarebbe s tato pubb l icato p o i
’ M i at ten n i alle conoscen ze d i allora, e per esse avevo per
fettam en te rag io ne .
( 2 ) (Pen te llma stagi / lata) 190 5 : Bo ll . Soc . G eol . l t ., vo l . XX IV , pag . 676 .
(3 ) Ibrdem .
(4) 1 90 7 : Rend ic . R . Acc . L ince i , C l . sc . fis mat . e nat ., ser . 5 .a, vo l. X VI, sem .
pag . 2 3 1 e 2 36 .
( 5 ) Ibrdenr, pag . 2 3 1 e 2 36 .
(6 ) Ib i dem , p ag . 2 3 1 e 2 36 .
( 7 ) Il mtrm . p ag . 2 36 .
1 22 RIVISTA ITALIANA
i neccepib ile , m ed ian te le fo tog rafie o rig inali che prod uco , cui un isco questibrevissim i cenn i descrittiv i .
PENT ELLINA M u n i e r - C h a l m a s e S c h l um b e r g e r
P e n t e l l i at n o h a lm a s i S c h l u m b e r g e r .
(Tav . IX : fig . 1 , 2 , 3. 4. 5 e
Pen tellina Chalmas i S c h l um b e r g e r , 1 90 5 ; Bull. Soc . Geo l. F rance , se
rie vol . V , pag . 1 1 7 , fig . 3 ; pag . 1 1 8 , fig . 4 e 5 ; tav . II , fig . 3 1
e 3 1 a.
S ebbene d iffe ren ti tra loro e dalla fig . 3 , pag . 1 1 7 , dello Sch lumber
g er (loc. q ui riprodotta nella fig . 2 2 , tav . IX ,parm i non possano
s taccars i dalla forma megalosferica della l’entell ina chalznasi , le sezion i tra
sversali delle m ie figure 1 , 2 , 3 e 4 , tav . IX , nessuna delle qual i passacon esattezza pel cen tro d e lla logg ia in iz iale . Quella che magg iorm ente vi
s’
app rossima è la fig . 3 , ed è proprio questa la quale p i u d e lle altre ri
corda la sudde tta, pe rò le carene esterne de i segmenti in tern i non v i si
osservano tronche come ne l tipo .
Un caso favorevole m i ha fatto ottenere anche la sezion e long itud i
n ale d ella fig . 5. e questa , pur non passando con precisione pe l cen tro ind i«c ato , nè co inc id endo col piano d i s imm etria, ritengo con fort i la m ia d ia
gnosi , perchè adattasi non so ltan to alla fig . 3 prec itata dello Schlumber
ger , ma financo alle fig . 3 1 e 3 1 a. tav . II, d i questi (loc .
E la spec ie chalrnasi , la Pen tell ina p iù frequen te ne l calcare p reso in
esam e ; m isura al mass imo la lunghezza d i mm .
S i conosceva tale spec ie ne i calcari senon ian i d ello stagno d i Berrepresso le Mart igues , in F ranc ia.
P e n t e l l i n a . n t r i g i l n t r1 S c h l u m b e r g e r .
(T av . IX : fig . 6 e
Q n inqnelocn l ina str ig il lata d’
O r b i g n y , fide Sch lumberg er , 1 90 5 ; Bull .
Soc . Géol . France , ser . vol. V , pag . 1 24.
Pen tell ina stzi g* itlata d
’
O rb ig ny . S c h l u m b e r g e r , 1 90 5 ; Bull. Soc .
Geo l. France , ser . vol. V , pag . 1 24 ; pag . 1 2 5 , fig . 1 5 ; pag . 1 26 ,
fig . 1 6 e 1 7 ; tav . Il , fig . 35 , 35 a e 35 b . P r e v e r , 1 90 5 : Boll. Soc .
G eo l. It vol. XXIV , pag . 676 .
DI PALEONTOLOGIA 1 23
Lo Schlumberger assegna la patern ità della Pen icil ina str ig ilata al d’O r
b igny , essendo sinon ima, secondo lui , d i Qni nqnelocnl in a str ig itlata
d enom inaz ione la quale , a quan to io sappia, non fu mai adoprata dal se
condo deg li autori nom inat i , cui però deves i l’
altra d i Tn°
locn l ina si r i
g itla ( I ) , mod ificata po i da lui stesso in Tr i local ina strig illata (2 1. Cost
fu man tenuta dal T erq uem quind i corretta g iustamen te dal Fornas in i inTr ilocnl ina str ig ilata Ed è proprio a ques ta spec ie , a g iud icare d alle
figure d el d ’
O rb igny che la riguardano pubblicate dal Fornas in i e da
quelle del T erquem in con fron to con le fig . 35, 35 a e 35 b , tav . 1 1 ,
d e llo Sch lumberger (loc. che ques ti volle alludere , però, a parer m io ,
e rroneamen te . Ed in vero : in primo luogo essa era stata data preced en temen te , e c ioè nel 1 882 , dal M un ier-C halmas , com e tipo d el genere Tr il
l ina d ist in to e pe r il medesimo Sch lumberge r dal Pentell ina , ed in se
condo , le figure del d ’
orb igny ce la d imostrano som ig lian te , s i , pe i carat
teri estern i , i soli d i cui il d’
O rbigny si occupò , alla Pentell ina strig itata
secondo lo Sch lumberger , ma anche dotata d ’orifiz io semplice guarn ito d i
d en te lineare , e non d’
orifiz io trematoforato , oss ia vera Tzi locnl ina e non
Pen t: llina , e neanche Tr i ll ina. Quind i , non potendo , allo stato attuale d e lle
m ie conoscenze , ammettere un errore in iz iale per parte de l d ’
O rb ign y , m i
conv iene attribu irne uno successivo d’
in terpretaz ione al Mun ier-C halmas ,ed un altro ancora allo Schlum be rger ; la Pen i ci l ina str ig i lata del quale g liva attribuita come specie nuova.
Con qualche dubb io , non avendo potuto scorgere in esse le den t icola
z ion i marg inali , d eterm ino pe r Pen tettina str ig i lo ta le sez ion i trasve rsali
riprodotte nella tav . IX , con le fig . 6 e 7 , che , ne lla struttura, m e ne ri
cordano abbas tanza bene la forma m egalosferica , d i cui nella fig . 1 5 , pag .
1 2 5 , dello Schlumberger (loc. La mancanza d elle d en t icolazion i , che
s ign ificano sott ili costo le longi tud inali all’
esterno de l n icch io , non è in ve
( I l Tr i locnl r'
na stn'
g zlla d'
O nanmv , 1 826 ; Ann . Sc . Nat vol . V II, pag . 300 , num . 1 3.
ined i te : , tav . III) .
( 2 ) Tr i locn lma stn'
g i llata d'
O aatc s v . 1 850 ; Pr odr ozne Paléont. vol. II, pag . 409 ,
num . 1 357 .
(3 ) Tn lacnl ina str ig i llata d'
ORBIGNY . T erq uem ,1 882 ; M e
'
In . Soc . Geo l . F rance , ser ie
3 .a , vol. II, mem . 3 .a, pag . 1 69. num . 1 5 , tav . X X V , fig . 2 5 a-c .
f4 i Tn locn lina stn'
g ilala d’
0 aanc nv. Fornas in i , 1 90 5 ; M em . R. Acc . Sc . Bolog na,
ser ie 6.a,vo l. II, pag . 60 , tav . I. fig . 7 , 7 a e 7 b ( dal d
’
ORBIGNY ) .(5) Le sudd ette .
(6 ) Le sop ra c itate .
(7 ) Bull . Soc . Geo l. F rance : ser . 1 .a , vo l. X , pag . 424.
RIVISTA ITALIANA
rosim ile , anz i è probabile sia una semplice apparenza, dovuta alle cond i
zion i d i fossilizzaz ione , trattandosi d i den ticolazion i assai m inute.
Nella m ia fig . 6 si nota un singolare sdoppiamen to in talun i pun ti dellepare ti in terne , per d istacco de ll
’im pian tito d ’
un segmen to dal‘
soffitto d i
segm en ti precedent i e , semb ra, con costituzione d i nuove logge .
Questa specie è med iocremen te frequen te nei m iei materiali , dove rag
g iunge il d iametro d i mm .
In Italia è stata citata ne i calcari ch’
io ritengo sannoisian i , con tenen ti
anche Idatina sp ., Lep idacy d ina tonrnoner i L e m o i n e e Do u v i l l é ,
L . snnzatrensis ( B r ad y ) , L . d i latata ( M i c h e l o tt i ) , ecc., d ei M on ti d i
Bagno nell’
Aqui lano ; in F rancia, nel luteziano d el bac ino d i Parig i , come
a Parnes , C haussy , Grignon , Neauphles , ecc. ( I ).
PABULARIA D e fr a 1 1 c e
3. sp .
Un ica e strana sez ione len ticolare , lunga circa mm ., che sembra lasezione longi tud inale d
’un n icch io dotato d ’
avvolg imen to hiloculinare , ma
portan te tramezzi intern i , e non aven te raddoppiamen to d i pareti . Le con
d izion i d i fossilizzaz ione non son buone , quind i la fotografia avrebbe d etto
poco ; in quan to al d isegno , avre i dovuto me tterv i qualcosa d i m io per
rend erlo intellig ib ile : ho preferito astenerm i dal presen tare e l’una e l
’
al
tro , in attesa che , rinnovando le ricerche , un caso favorevole m i me tta
sott’occh io sezion i con le quali possa completar lo stud io d
’una forma
che spetta certamen te a specie nuova, e forse anche a genere nuovo . Per
ora m i sem bra, tra i gen eri ch’
io conosco , d i doverla avv icinare al F abu
[ar ia.
Desc ritte cosi , succin tamen te , le M il iol id i trematof orate d i cu i m i p re
m eva mettere in chiaro l' es istenza, n el calcare b run icc io ch iaro ad Alveo
l ine sopra ind icato , credere i d i lasciar incomplete queste ricerche se non
m’
in teressassi anche a stab ilire la loro età geologica, che d esumero, g iac
( I ) I sosten itori dell’eocenicità de lle Lep idocicline potranno trovare in quan to sopra un
nuovo argom en to in favore d elle loro ved ute , ma io non cred o doverv i dare pel momen to so
verch in importan za. M i basti per ora il far sapere che non mi è sfugg i to ; in segui to lo discu
tero.
1 26 RIVISTA ITALIANA
non piano , ed i l d en te d i cui è dotato l’
orifiz io , lungo , sotti le , lineare , an
ziehe corto e b ifido .
S e non fosse pe r l’
asimme tria d e l n icch io de lla Sp irolocn l ina inaeqn i la»
teral is S c h l u m b e r g e r ( I ) , stare i ad id en t ificare la m ia sez ione fig . 8 ,
tav . IX , con que lla d ’un suo ind iv iduo m icrosferico , cui corrisponderebbe
perfettamen te ne i dettag li strutturali (cfr . la c itata fig . 8 con la fig . 3 , pa
g ina 60 ,de llo Schlum berger ; loc . m a essendo invece la m ia sezione
s imm e trica, non posso che attribuirla, tenuto con to del lim itato numero d i
logge le quali d imostra, de lle cond iz ion i d elle sue facce , d ella term inaz ione
quas i p iana d e i marg in i , e d ella sua sagoma, alla Sp i rolocnl ina ang nlosa
d el d’
O r b i g n y , quale resulta dalle fig . 8 ed 8 a d el Fornasin i (v . la sino
n im ia) , e da esem plari recen ti in m io possesso che , p er m ezzo d i esse , son
r iusc ito a riconosce re .
È questa specie rarissim a nel calcare cons iderato . dove il suo d iame
tro traverso m agg iore misura mm e d i altri habi tat bene accertat i non
conosco che il recen te d el Mar Med iterraneo .
ORBITOLITES L am a r c It
O r b i t o l i t e -s u o m p l u n a t a L am a r c k .
(Tav . IX : fig . 9 e
O rbi /al ites camp ionata L am a r c k , 1 80 1 ; Sy st . An im . sans Ver t ., pag . 376 .
De france , 1 8 2 5 ; D iet . Sc . N at., vol . XXXVI, pag . 2 94 ; Atlas , Z ooph . ,
tav . XLVIII , fig . 2 . D’
O rb igny , 1 850 ; P rod rom e Paleon t . stra
tig r . , vol. 1 1 , pag . 40 5 , num . 1 2 95 . D’
O rbigny , 1 852 ; Cours . élém .
Pati en t . et Geol . stratig r ., vol. II , fasc . pag . 755 , num . 1 2 95 .
D’
Arch iac e H aim e , 1 854 ; Descr . An im . j oss . g roupe nn nnn . Inde ,
pag . 350 , tav . XXXVI , fig . 1 9 . C arpen ter , 1 856 ; Ph i l. T rans .
Roy . Soc ., vol . CXLV I, pag . 2 24 , tav . V I, fig . 1 0 e 1 1 . Zitte l ,1 883 ; Trai té de Paléon t vo l . 1 , pag . 78 , fig . pag . 79 , fig . 1 5
a-b . M un ien C halmas , 1 89 1 ; Etude Ti th . Crét . et Ter t . dn Vicen t in
pag . 47 , 5 1 e 53 . H . Douv illé , 1 90 2 ; Bull. Soc. Geol . France ,
ser. vol. 1 1 , pag . 2 96 , fig . 6 . F ritel , 1 90 3 ; Patéan tolog ie , pag .
1 8 , num . 1 , fig . 9 e 9 a. C hecch ia—Rispo li , 1 90 7 ; G iorn . Sc . Nat .
( I ) 1 803 : M em . Soc . Z ool . F rance , vo l. V I, pag . 60 ,fig . 3 , tav . IV. fig . 84-86 .
DI PALEONTOLOGIA 1 27
ed Econom Palermo , vol . XXVII, pag . 5 es tr . , num . 28 ( I ). Di
S te fano , 1 90 7 ; Rend ic. R . Acc . Lince i , C l. sc . fis . mat . e nat .; ser .
vol. XV I, sem . pag . 2 69 .
Orbnl ites campionata L am a r c k 1 8 1 6 ; H ist . nat . An im . sans Ver t . , vol. II,
pag . 1 96 . Lamouroux , 1 82 1 ; E x pos . m i t/1 . Gen res ord re Poly
p ier s , pag . 45 , tav . LXXIII, fig . 1 3 e 1 6 .
O rbitn li tes comp lanatns Lam a r c k . Brann , 1 853—56 ; Let/mea Geog no
stica , ed iz . vol . III, pag . 2 54. tav . XXXV , fig . 2 2 a-b .
Orbi toi des comp lanata L am a r c k . Hebe rt e Mun ier-C halmas , 1 878 ; C .
R. Ac . Sc . Paris , vol . LXXXVI, pag . 1 487 .
Orbi tn l ites cf. camp ionata L am a r c k Schw ager , 1 883 ; Palaeon tog ra
ph ica, vol. XXX , pag . 90 , tav . XX IV , fig . 1 0 a-e .
Orbi tnl i tes Pbaraonmn S c h w ag e r , 1 883 ; Palaeon tog raph ica ,vo l. XXX ,
pag . 9 1 , tav . XXIV , fig . 9 a-e .
Orbitol i tes co mp lanatus Lam a r c k . Harris e Burro w s , 1 89 1 ; The Eoceneand 0 l ig . beds Par is bas in , pag . Oppen he im , 1 896 ; Z e itsch r .
deutsch . geo l. G ese llsch . , vol . XLVII, pag .38. H . Douv illé , 1 90 5 ;
Bull . Soc . Geo l . France , ser. 4 .a, vo l . V , pag . 34 , 36 , 38 , 43 , 46 e
5 2 . Schlumberge r ed H . Douv illé , 1 90 5 ; ibidem , ser . vo l. V ,
pag . 2 97 . H . Douv illé , 1 906 ; ibidem , ser . vo l. V pa
g ina 658 . H . Douv illé , 1 906 ; ibidem , ser . vol. V I, pag . 1 7 , 1 8 ,
1 9 , 2 0 , 2 2 , 2 6 , 2 7 , 35 e 50 . R . Douvillé , 1 90 6 ; Ann . Paléon t
Boule , vol . 1 , pag . 6 2 . Mun ier-C halmas , 1 90 7 ; Bull. Soc . Geol.
F rance , ser . vo l . V I pag . 50 8 . Fabian i , 1 908 ; M em .
Soc . It . Sc ien ze (d e i X L) , ser. 3 8 , vol . XV , pag . 7 7 .
Orbi tol i tes sp . T r a b u c c o , 1 895 ; Bo ll. Soc . G eo l. It vol . X IV , pag . 34,
fig . 4.
Orbi tn l itw sp . forma B M a r i n e l l i , 1 90 2 ; Descr . g eol . d in torn i Tar
cen to n el F r iul i , pag . 1 78 .
Di g rand e im portan za e ra pe l problema che m i son propo sto , d i valu
tare l’
età geolog ica della formaz ione con tenen te il calcare brun iccio chiaroad Alveo line , che racch iude le M il iol id i trematof orate sopra d escritte , la
d e te rm inaz ione esatta d e ll’Orbi tol ites in esso m ed iocrem en te com une , e ,
( I ) Il d iamet ro d i 50 mm dato d al C hecch ia-Rispo li p er la fo rma d e i d in torn i d i Bag heria ( Palermo ) , d a lui at tr ibuita a q uesta spec ie , fa nascere q ualche d ubb io sull
’
esat tez za d ella
d iag nozn , non avendo la I'autore figurata
1 28 RIVISTA ITALIANA
per quan to si trattasse d i frammen t i sparsi n ella roccia, de i pm cospicui d eiquali do , con le fig . 9 e 1 0 , tav . IX , le fotografie , med ian te ripe tute se
z ion i litolog iche ed accurato es ame d i queste , m i par d’
esserv i riusci to ,
ident ificandola con la specie complanata de l Lam a r c k . D’
altronde , non
tan to dalla fig . 1 0 , sez ione un po’
ob liqua rispe tto ad un piano merid iano ,
quanto dalla fig . 9 , frammen to d ella equator iale , ben ne risultano i carat
teri d ist in tivi , i quali chiunque potrà verificare a suo ag io . Non essendov i
po i dubbio che le mag lie de term inate dalle loggette de l piano equatorialesiano d
’Orbi tol i tes , e non d i Sor ites o d i Proesor i tes , e che que lle delle
logge tte prossim e alla supe rfic ie non siano d i M arg inoporo , qualora si tengapresen te I’ affe rmaz ione d i H . Douvillé , finora non smen tita in modo p re
c isa , a quan to m i resulta, da nessun autore che del genere Orbitolites
On ne con nai t encore an’
une seule espece l’
O. complanata dn calcaire
g rossier onoy en ne res ta pienam en te con fermata da c iò la m ia d ia
g nosi .
I framm en t i meno incomplet i deg li esemplari d i cui m ’
è capitata sot
t’
occh io la sez ione , attesterebbero per essi un d iametro d i alm eno mm .
G li habitat sin qui conosciuti della spec ie in d iscorso son molti , ma
lim itandom i a quelli o , a m io parere , m eg lio accertati , ovvero magg ior
m en te in teressan ti , li posso riassume re cos ì :
In Italia essa è stata ind icata ne i calcari In i ez ion i de l Mon te Campeon ,
ne i d in torn i d 1 Tarcen to (Friuli) ; ne i calcari e tufi , pure ln tez ian i , del V icen tino , e per prec isare : ad A lveol ina heber ti M u n i e r - C h a lm a s e S c h
l u m b e r g e r ,A . postalensis M u n .
- C h a lm . e S c h l um b . , A . vol lecen
s is M u n .- C h a l m . e S c h l u m b Ampn ll ino cochleata ( H a n t k e n ) , Ce
r i th inm pn lliense M u n .-C h a lm . d el Monte Postale ; ad A lveol ino i lar io
nensis M u n .- C h a lm . , A . g iovann iensis M u n .
- C h a l m . , Or thophrag
m ino patellar is ( S c h l o t h e i m ) , 0 . tenella ( G ti m b e l ) , Gnembelio crasso
( B o u bé e ) (31
, I’aronaeo camp ionata ( L am a r c k , ) P . m n rch ison i ( B ru n
n e r ) , Assil ino sp ira (D e R o i s s y ) , d i Val C iup io ne i d in torn i d i S . G io
( 1 ) In mod o un po’vago , s i , p . es . da O . M ar ine lli , che ne lla sua Descr in one g eolog ica
de i «tin to : n i d i Tarcento in F r iuli ( Pubb l . R. Ist i t. S tudi sup . d i F iren ze , a pag . 1 78 fa
cenno d i due O rbiù drtes sp ., d i cui una, q uella ind icata nel la sinon im ia d i cui sop ra, cred o sia
id en tificabi le al l’
0 rb : tol ite s campionato LAM C K ., ma l’al tra potrebbe esser altra cosa, essendo
sem brata all’
auto re d i spec ie diversa dalla prima.
( 2 ) Bull. Soc . Géol. F rance ,serie 4.a , vo l. II pag . 2 97 ,
(3 ) Q ues to nome è preferito da H . Douv illé p er d es ig nare la forma 8 , cui corr isponde per
forma A la Gnembelia l: :cosona (Daanan c n ) , 0 G . lenh‘
cnlan’
s (F icar ra. e g ià detta
dag li autori : N nm nh'
tes perforato 0 pe rfaratn .r D ’O nmanv , oppure N nrmnul ites o Gnensbelia
spessa ovvero .Vunm n lites 0 Gnembelia ala r ico (1 0 1…v e LRVM IZ RIB ) .
1 30 RIVISTA ITALIANA
F loscnl ino decip ia rs S c h w F . pastici llata S c h w Or thophrag m ina p ratti
( M i c h e l i … . 0 . sella 0 . d ispanso ( S o w e r b y ) , I ’aronaea
comp lonalo P . tch ihatchefiî ( D ’
P . d iscorbina ( S c h
l o t h e i m ) , I’. snbd iscorbino ( D e L a H a r p e ) , P . biar i tzens is ( D
’A r
c h . ) P . g uettard i ( D ’
A r c h . ed H a i m e ) , Bm g uier ia laevig ata
Gne1 nbel ia le n tia vlar is ( F i c h t e l e M o l l ) , G . crasso
G . subg arg an ica ( T e l l i n i ) , Laharpeia mo ll i ( D’
Ass il ino ex
ponens ( S o w . ) A . sp i ra (De R o i s s y ) , A . subsp ira D e La H A .
s icula C h e c c h i a .
In F rancia, I’
Orbitol ites camp ionata , tranne che a Sain t—Estephe , nel
bacino d i Bord eaux , dove pers iste fino ne l barton iano , e ne ll’
Aude e ne l
I’ Herault , in cu i com incia, assieme all
’Alveol ina oblong a d
’
O r b i g n y ed
all’
A . ovoidea d’O r b fin dal lutez iano in feriore o dall
’
ipresiano superiore , p resen tasi costan tem en te nel lutez iano med io , e ne è fossile carat
teristico ; cos ì : nel calcaire g ross ier moyen d i Grignon , C haumon t ,Lattainv ille , Mony , Lierv ille , Pauliac (G i r o n d e ) , d e i d in torn i e d el bac inod i Parig i , dov ’ è molto comune ; ne l calcare a B rug uien
'
a laevig ata ( B r u
g u i è r e ) , A lveolina , F abulor io , ecc ., d i Luzancy ; neg li strati ad Alveolina
larva ( D e fr .) d el Coten t in ; ne i calcari a Gne 1nbelia crasso G .
len ticulor is (F i c h t e l e M o l l ) , Laharpeia bro ng n iar ti ( D’
Paro
naeo camp ionata ( L am c k . P . biar itzensis D’
A r c h Assil ino sp ira
( D e R o i s s y ) , Assi l ina g ranulosa ( D’
Alveoli na larva
Or thoph rag m ina mor thoe S c h l u m b e r g e r Tubulostimn sp irulaem n ( L a 1 1 1
c k . e Velotes schnn'
edel i C h e m n d i Peyreblanque , Barthes ad 0 d i
St . Barthélemy , Peyrehorade , d el fondo del vallone presso Nousse (comune
d i Gamard e ) , d i Donzacq , G ibre t , Bastennes , ecc ., nel bac ino d ell’
Adour .
Neg li strat i a l ’oronoea bior i tzensis della pun ta d elle Vallières .
Ne i calcari ad Idol ina ber the l in i S c h Iu m b Per i locul ino raincour ti S c hl u m b A lveol ina larva A . base: : Litw nelta rober ti
S c h l u m b . abbondan t i Laharpeia brong n iar ti ( D ’
Paranoea
bior i tzensis ( D’
d e lla Basse-Loire . Nel calcare ad Alveolina de l
bacino p rep irene ico in genere , ed in quelli ad Alveol ina larva ( De fr . ) e
L i tuonella rober t i S c h l u m b . d i Suzac ; a M iliolid i , A lveol ina larva
A . bosci i L ituonella rober ti S c h l um b Paranoea
( 1 ) L'or tog rafia esat ta d el nom e spec ifico r iterrei fosse q uesta e non buar r 1 t z ens is come
s i ado tta dai autori m od ern i. E noto che la Paranoea bron tzensxs forma E ,fa
cop pia ne lla sua spec ie con la P . g uetta r i i (D’
Aacn . ed H am a ) , forma A , ed è detta anche
A'
unnn uh tes o Par onoea atac 1co (Leymer ie) .
DI PALEONTOLOGIA 1 8
g uettard i ( D ’
A r c h . ed H a i m e ) d i Sain t—Palais (le—Bureau ) presso Ro
yan (C haren te ) , nel bac ino d’
Aquitan ia. E finalm en te ne i calcari ad A lveo
l ina bosci i B rug uier ia laevig ata ( B r u g u i e r e ) , Laharpeia tubercnlata d el bacino franco—be lga ; come a Foret , Melsbroek , Assche ecc . , nel Belgio.
In Eg itto , è frequen te ne i calcari e calcari marnosi ip resion i (pianol ibico) ad Alveolina d i Él-Guss—Abu-Said , Mer , M in ieh e S in t .
Nell’
Ind ia, è rara nel calcare g iallo eocen ica d ella catena d’
H ala ne l S ind .
ALVEOLINA d’o r b i g n y
A l v o o l i n a o v o i d e a d’
o r bi g n y(Tav . IX : fig . 1 1 , 1 2 , 13, 28 e
N um ismate D e l u c , 1 80 2 ; ] ourn . Ph isiq ue ,vol. LIV , pag . 1 79 , tav . 1 ,
fig . 1 1 e 1 2 .
A lveol ina ovoidea d’
O r b i g n y , 1 82 6 ; An n . Sc . Nat ., vol. V II, pag . 306
num . 3 . D’
O rb ig ny , 1 850 ; P rod rozne Paléon t . stratig r . , vo l. 1 1 ,
pag . 336 , num . 690 . D’
o rbigny , 1 852 ; Cour s Paleont. et
Géot. stratig r . , vol. II, fasc . pag . 732 , num . 690 . F iguie r , 1 873 ;
Ocean Wor ld , pag . 82 , fig . 1 5. Seguenza , 1 873 ; Boll . R. Com it .
Geol. l t ., vol. IV , pag , 2 59 e 2 60 . S tache , 1 899 ; Abhand l . k . k.
geo ] . Re ichsanst. , vo l. XIII, pag . 1 58. Seguenza, 1 880 ; M em .
R Acc . Lince i , C l . Sc . fis., mat. e nat . , ser . 3 8 , vo l. VI , pag . 30 ,
num . 4. Fornasin i , 1 904 ; M em . R . Acc . Sc . Bologna, ser . 6 8 ,
vol . 1 , pag . 1 5 , tav . IV , fig . 1 2 , 1 2 a ( dal d’
O r b i g n y ) . Lemo ine ,
1 90 7 ; Bull. Soc . Geol. F rance , ser . 4 8, vo l. VII, pag . 39 .
Alveolina subpy renaico L e y m e r i e , 1 844 ; Mem . Soc . Geo l. France , se.
r ie 2 8 ,vol. I, pag . 359 , tav . XIII , fig . 9 a
-c . Leym erio , 1 845 ;
Bull. Soc . Geo l. France , ser. 2 3 , vol. 1 1 , pag . 1 8 e 2 2 . H . Dou
v i llé , 1 906 ; Bull , Soc . Geo l. France ,ser. 4 8
, vo l . V I, pag . 26 e 2 7 .
R . Douvillé , 1 906 ; Ann . Paleon t., Boule , vol . 1 , pag . 6 1 e 65.
C erez , 1 90 7 ; Bull . Soc . Geol. F rance , ser . 4 8 , vo l. VII, pag . 2 56 .
Lemo ine , 1 90 7 ; Bull. Soc . Geo l. F rance , ser. vol. V II, pag . 39.
Sono d’
avviso che , avendo il d’
O rb igny m esso il gene re F asciol ites
d el Parkinson , il quale rimon ta al 1 8 1 1 ( 1 ) nella sinon im ia de l proprio d etto
( I ) 1 81 1 ; Org an . Reni . / orme; Wor ld , vol. III, pag . 1 58 , tav . X,fig . 2 8-3 1 . 1 82 2 ; l n
trod . Study / oss. arg on . Reni ., pag . 1 67 , tav . V I, fig . 1 4.
RIVISTA ITALIANA
A lveolina , portan te la data poste rio re , del 1 826 ( I ) , nel citare a propositod ella sua Alveolina oblong o ( 2 ) pe rfino le figure 28 e 3 1 dello stes so Par
kinson s i d ebba rest itu ire a questi la preced enza, ed in tal senso si
rego larono Sow e rby (4 ) e Carter ma essendovi stato dopo d i loro un
ritorno per parte d eg li auto ri alla nomenclatura d el d’O rb igny , grad irei
conoscere , avan t i d’attene rm i a d etto part ito , 1
’
opin ione altrui sull’oppor
tun ita o meno d i rimetter le cose a posto .
M olto scarse son le conoscenze che s i posseggono sul la struttura delle
Alveo line e pertan to la loro d e term inaz ione per mezzo delle sez ion i ,
l’
un ica d i cui m i possa valere nel m io caso , e un po’
aleatoria, perchè.sotto lo stesso nome è probab i le si
.
siano com prese dag li autori forme strut
turalmen te d iverse , e sotto nom i d iversi , forme st rutturalmente iden tiche ,
inoltre poco essi hanno tenuto in cons ide raz ione il d imorfism o specifico ,
che pur ha tan ta parte ne ll’
esatta nomenclatura d e lle spec ie. O rmai s’
im
pone una rev isione delle Alveo line pubb licate .
In attesa essa avvenga, è ne l momen to molto d ifficile d i pronunz iarsiin m erito al valore delle cos id e tte spec ie costi tuen ti quel gruppo d ’
Alveo
line la cui configuraz ione offre tutt i i passagg i dalla forma cilind ro ide a ter
m inazion i tond e , quali p. es . l’
Atveolino oblong a d’
O r b i g n y l’A .
conavor i i C hecch ia—Rispol i (8) ecc ., prima alla ovalare , come p . es. 1’
A .
ovoideo d’
O r b i g n y l’
A . ell ipsoidal is S c h w a g e r ( 1 0 1, l
’A . cfr. ob
tong a d’
O r b ., secondo i l C h ecch ia—Rispoli ( I I ) , l’
A . cio/ ab i C h e c c h i a
( 1 ) Ann. Sc . Nat vol. V II, pag . 306 , gen .
( 2 ) 1 826 : :bide 1n , pag . 306 , num . 4.
(3) Loc . crt.
(4) F osa o l i te s e ll iptico So w aasv , 1 857 : T rans. Geo l . Soc . Lond .,ser. 2 .a,
vol. V
pag . 32 7 , fig . 7 e 9 ; tav . XX IV , fig . 1 7 e 1 7 a. (C orrisponde all’
A lveolzna oblong o d’
O nmon r ) .
5 ) F asa'
colzle : ( per F asab li tes) e lh‘
ptw a PARK INSON. C arter , 1 853 ; Ann . and M ag .Nat.
H ist., se r . 2 .a,vol. X l. pag . 1 7 1 , tav . V II, fig . 1 7 . Carter , 1 853 : Journ . Bombay Br. R.
Asiat ic. Soc vo l. V , pag . 1 34 , tav . Il , fig . 1 7. C arter , 1 857 ; Geol. Papers Western Ind ia,
pag . 452 , tav. XVIII, fig . 1 7 .
(6 ) Un buon lavoro illustrat ivo . morfolog ico e strutturale , dopo 1’ott imo d ello Scuw aoaa
(del 1 883 ; vedasi la b ibliog rafia a pag . 1 47 ) e stato pubblicato ne l 1 905 (ved . la b ibliografia a
pag . 1 43) dal C n acc ma-Rtsnou . ma ambed ue richiederebbero d'
esser completat i. M i p ropongo anz i d i far c iò per quello d e l C hecch ia-Rispoli , possed endo g li stessi mater iali sui q uali
eg li lavorò , ed anche in gran parte preparat i .(7 ) 1 82 6 ; Ann . Sc. Nat ., vol. VII, pag . 306 , num . 4. F ornas in i, 1 90 4 ; M em . R. Acc.
Sc. Bologna , se r . 6 .a. vo l. I, pag . 1 5 , tav . IV , fig . 1 3 e 1 3 a (dal d' O ns ionv ) .
( 8) 1 90 5 ; Palaeontog r. Ital ., vol. X I, pag . 1 59 , tav . X II, fig . 1 9-2 5.
(9 ) Loc . cit. nel la sinon im ia.
( t o ) 1 883 ; Palaeontograph ica,vol. XXX , pag . 06 , tav. X XV , fig . 1 a-g e 2 a—c. C hecch ia
Rispoli , 1 90 5 : Palaeontogr. Ital., vo l. X I, pag . 1 55 , tav. X II, fig . 1 .
( I I ) 1 90 5 ; Palaeon tog r. Ital., vo l. X I, pag . 1 58. tav. X II, fig . 6 e 7 .
1 34 RIVISTA ITALIANA
oblique , fig . 1 2 , ed eq uatoriali , fig . 1 3 , che assegno alla Spec ie m ed esima.
La fig . 1 3 d imostra anche il canale d ella m egalosfera.
Comune tra i fossili esam inati , anz i la p iù comune delle Alveoline cu i
ess i un isconsi , m isura al massimo la lunghezza d i mm .
Le località e le formazion i meg lio accertate dove rinviensi I’
A lveoli na
ozvoidea son fin q u i poche : si ricorda nei calcari inclusi ne lle arg i lle barto
n iano , che trovansi sotto S tilo e ne l territorio d i Brancaleone in Calabria,
con tenen ti A . bosci i ( D e fr a n c e ) , A . sphaeroz'
dea ( L am a r c k ) , Paronaeastr iata ( d
’
O r b i g n y ) e Bm g uierz’
a planutata ( d’O r b . ) ne i fram
m en ti d i calcare nummulit ico sparsi alla superficie delle arg ille variegate
bar tam'
an: della prov inc ia d i Mess ina, come a S . G iovann i presso G iard in i ,fra M istre tta e Con trasto , presso C apizz i , ecc., assiem e ad A lveol ina larva
A . oòlong a d’O r b A . base: : ( D e i n ) , A . sphaeroid eat ( Lam
Or thoph rag m ina d ispanso ( G am b e l ) , 0 . stellata
0 . stella (G il m b Paronaea str iata ( d’O r b P . va: i ol« r ia
B rug w'
erùt p lanutata ( d’
ecc. C iò in Italia.
Ricordas i po i in Francia nel lutez iano i nf eri ore, da alcun i ritenuto
invece ipresiano super iore , dell’H érault , e d i Mon tolieu e Couiza nell
’
Aud e ,
assieme all’A . obtang a d
’O r b . ed all
'
Orbitotites comp lanata L am e kd i Mon t—M arie e d ella Mon tagn e-Noire nelle C orbieres , dov ’ è comun issima
ed in compagn ia d ella Paronaea bùxfi tzens is ( D ’
A r c h i ac e d ell’Haute
Garonne , nelle marne con arenarie e calcari che con tengono anche l ’ Alt rol ina oòtong a d
’
O r b . , la Paranaea bian'
tzensis ( D ’
ecc . Nella
Dalmaz ia esiste nel cosid etto pùmo tz'
òum ico , d i passagg io tra il cretacea
e l’
eocene ; nelle Ind ie O rien tali , nell’eocene d el Capo V icary nel S ind
e de l Bengala. E , finalmen te , nel calcare d uro d el luteziano inf er iore della
baia d i Diego—Suarez e d ella reg ione d i Wind so r-Castle , nel Madagascar ,in un ione con A lveol ina oòtong a d
’O r b . , A . f rumentiform is S c h w a
g e r , O r thoph rag m ina d iscus ( R ut i m e y e r ) , O . arc/ziaci S c h l um b e r
g e r , d ispansa ( S o w e r b y ) , Guemòetz'
a len t icuh n'
s ( F i c h t e l e M o l l ) ,
Assi /ina g ranulo sa A . leymen'
e i (D’
A r c h . ed H a i m e ) ,
A . cfr. sp i ra ( D e R o i s s y ) .
In complesso sembrerebbe che , almeno in Europa, l ’ A . ovoidea appar
( 1 ) L’
habzla t topografico d i q ues ta e d elle success ive spec ie , per q uan to r iguarda la Cala
b ria e S ic ilia, è indubb io , ma non altre ttan to posso ripetere p er i l g eo logico , che richied e d'en
scr verificato . essendom i in varii cas i sospetto . Potrebbe in q uest i esser avvenuto qualche tra
sporto d i foss i li , da terren i p iù ant ich i in p iù recen t i.
( 2 ) Il d’
O rb ig ny scr ive .Sa‘
nde ma m i igno ta una reg ione d i q uesto nome nelle ln
d ie O rien tali : dub ito si trat t i q uind i de l Suede secondo D’
Arch iac ed Haime , ossia del Sind .
DI PALEONTOLOGIA 1 35
tenesse ag li strat i p iu bassi d e l lutez iano , oppure all’
ipresiano e ques tad ed uz ione riceve con ferma dal fatto che essa, forma un po
’
m eno allungata
e di figura un tan tino d ifie ren te dall’
A . obtong a (0 . ante , a pag . ne
de riva, collegandov isi con una serie completa d i forme d i passaggio , per
cui n e d eve avere press ’
a poco l’
habi tat geo log ico , il quale ,pe r la seconda,
s’
estend e generalm en te dall’
:°
presx'
ano al lutez iano , e , in v ia eccez ionale
sembrerebbe pe rfino al bar ton iano inclusivamen te ; not iz ia però , questa,
riguardan te soltan to la S icilia, e che d i conseguenza, e come ho sign ificatone ll
’an notaz ione in calce a pag . 1 34 , stimo necessario accettare col bene
fiz io d i verifica.
7 . A l v e o l i n a u c h w a g e v i C h e c c h i a -R i s p o l i .
(Tav . IX : fig . 1 4 e
A lveol ina Schw ag er i C h e c c h i a R i s p o l i , 1 90 5 ; Palaeon tog r. Italica ,
vo l. X I, pag . 1 62 , tav. X II, fig . 1 1 —1 4. C hecch ia—Rispoli , 1 90 7 ;
G iorn . Sc . Nat . ed Econom . , Palerm o ,vo l . XXVII , pag . 7 estr.,
num . 33.
La specie d ist in ta co l sud de tto nom e dal C hecch ia-Rispo li , e pe r la
prima volta in esemplari de lla C alabria e S icilia, è prossima all’Att ina
ovoidea d’
O r b . all’
A . bosa : ‘D e f r . ) ed all’A . larva ( D e i n ) ; com e
con figuraz ione esterna occupa un posto in term ed io tra I’
A . «um ida e l’
A .
bosci i , d ist inguendosi princ ipalmen te dalla prima (2 per la mancanza d ella
porz ione c ilind rica, essendone il con torno comple tamen te afiusolato , dalla
seconda pe r magg iore rigonfiamen to ; in quan to all’
A . lar va se
n e stacca p er la molto magg ior ven tricosi tà , e pe r la term inazione m eno
acuta e ad apice arrotondato ai due estrem i d e ll’
asse d’
avvolg imen to .
Qualche affin ità ofi'
re pers ino con l’
Alveol ina f rumen ti/ orm is S c h w a
( 1 ) Bosci i DE F RANC E ,1 82 0 ; D ir t. Sc. N at., vol. X VI, p ag . 1 0 1 ; A tlas , Z oop h
tav . XLV III, fig . 4 .
( 2 ) Ved as i la fig . 1 2 (e 1 2 a) , tav . IV ,d e l Fornas in i : 1 004 ; M em . R . Acc. Sc . Bolog na
ser. 6 .a , vol. I, p ag . 1 5.
(3 ) Idem , la fig . 30 ,tav. X ,
d e l Terq uem , 1882 ; M én t. Soc. G eo l . F rance , ser. 3.a, vol. II,
mem . 3.a, pag . 50 . num . 1 .
(4) Idem ,la fig . 34 ( e tav . X II, d el C zj zek : A lveolina long a. C zjzmr , 1 848 ; Naturw .
Abhandl ., Haid ing er. vol. II, pag . 1 43 , num . 1 3. La fig . 3 1 , tav. X , d el Terq uem : Atw otùn
elong ata d’
O nano rw ,1 882 ; M ém . Soc Geol . F rance , ser . 3 .a,
vol. II, mem . 3.a , pag . 50 , n .o 2 .
La fig . 1 4 (e 1 4 a) , tav . IV,del Fornas in i (dal d
'O RBIGNY ) Ab eolina elong ata d
’O umour , 1 90 4
M em . R. Acc . Sc . Bo log na , ser . 6 .a,vo l. I, pag . 1 5.
1 36 RIVISTA ITALIANA
g e r i l g rand e svi luppo long itud inale d ella quale baste rebbe a separarnela.
L’
A . schw ag er i rassom ig lias i po i m o lto , tan to este rnam en te quan tostrutturalm en te , all
’
/ I. d i -stef anoi C h e c c h i a - R i s p o l i ma l'
autore
cred e pote r fare una d ist in z ione tra le due fo rm e o ltre che pe r il mag
g iore sv iluppo de lla lam ina spirale e quind i anche p e l m inor numero de i
g iri su d i un sem iasse quas i sem pre magg iore , anche pel m inore num ero
delle ce llette trasversali e pe l magg iore spessore de i sett i secondari
C iò ne lla seconda , che , in conclusione presen ta un principio d i flosculin iz
zaz ione , cui pe rò a m io avv iso non conv ien dare troppa im portan za ; maessendo anche . sem pre a m io parere ,
I’
A . rti -stef anoz'
cos ì v ic ina all’
A .
bosci i da esser probabile d ebba ad d iri ttura iden t ificarsi con essa , pre ferisco d i man tener pe r ora le separaz ion i che ho t rovato , ond e non p reg iud i
car n ulla finchè non m i sarà dato stab ilire un con fron to tra la struttura delle
d ive rse Alveo lin e c i tate .
G li esemplari d ’
A . sr lzw ag er r'
s tud iat i dal C hecchia-R ispoli e rano m i
crosferic i , e ad essi riferisco le sez ion i p iù g rand i d’
Alveolina che ho potutoesam inare , una d e lle quali assai pross ima ad un p iano mer id iano , riprod ucocon la fig . 1 4 , tav . IX ; v i no to m agg ior ro tond ità ai capi estrem i d i quellache non si osse rv i ne lla fig . 1 2 (loc . c it .) d ell
’
auto re nom inato . M i sono
però cap itate pure so tt’
occh io sez ion i ch e spe ttano ev iden temente ad ind i
v id ui megalosfe ric i , com e p. es . que lla m erid iana d ella m ia fig . 1 5 , d ove
scorges i ben iss imo la sfera in iz iale col suo canale .
La forma in d iscorso è poco frequen te nel m ate riale s tud iato ; i sog
ge tt i con m icrosfe ra possono ragg iungere la lunghezza d i mm . , g li
altri , con m egalosfe ra, quella d i appena mm .
Essa era stata r in venuta preced en tem en te ne i calcari marnos i b iancastri in te rcalat i ne lle marne bar lom
'
rm e (5) d ella con trada Rocca presso T er
m in i-Im e rese (Pale rm o ) , con A lveol ina ell ipsoid al is S ch w ager , A . oblung a
d’O r b i g n y , A . lar va ( D e f r a n c e ) , A . d i -stef anoz
'
C h e c c h i a - R i s p o l i ,
( i ) 1 883 : Palaeon tog rap h ica. vo l. X XX . p ag . 1 0 0 ,tav . X X V ,
fig . 4 a-ì .
( 2 ) S I veda a pag . 1 37 , n um . 8 .
(3 ) Palaeon togr . Ital . , vo l. X I pag . 1 63 .
(4) G io vam i osservare che so tto q uesto nome in tend o la fo rma fossile d e ll’
eocene , tign
rata p . es dallo Z it te l t 883 ; Trai té de Paléon t., trad . Barro is., vo l. I, pag . 78 , fig . 5 e pag . 79 ,
fig . e non la recen te de i mari tropicali , la q uale i llus trarono C arp en te r ( 1856 ; Phi l. T rans .Roy. Soc vol. C XLV I, pag . 552—555 ,
tav . XXV III, fig . 2 3 e 24 : tav . XX IX , fig . 4—9 ) e Brad y
( 1 884 ; Report C halleng er , Z oo l. , vo l. IX , p ag . 2 2 2 , tav . X VII, fig . 7 -1 2 ) co l m ed esimo nome .
( 5 ) S i veda l’
anno taz ione a m g . 1 34 .
RI"ISTA ITALIANA
La massima lunghezza riscon trata ne’
m ie i campion i , treq uen t i tra i
fossili pres i a considerare , è d i mm .
La form a cosi trattata, e che ha i m ed esim i habitat topografici e geolog ici de lla con trada Rocca presso T erm in i-Im erese (Palermo ) e d ’
Agnana in
Calabria, r icordat i pe r I’
A . schw ag er i , comparendo assiem e a questa ed ai
fossi li che l’
accompagnano , la g iud ico mo lto som ig lian te all’
/ I. subdepressa
T r ab u c c o Alveo lina anche questa ofi'
ren te un principio d i flosculi
n izzaz ione , rinvenu ta dal T rabucco ne lla b recciola nummuli tica ad Orbi toli
tes cmnplanatrt L am a r c k , Or thoph rag m ina nunzmul i tica ( G 0 rn b e l Nmu
m ulz'
tes sp . , negli scist i arg illosi d e i Mon t i de l C h ian t i in Toscana , da lu i
attribuit i all ’ ip resiano , da m e al lutez iano .
VALVULINA ( d’
O r b i g n y ) 1 826 .
V a l v u l i n a h u l l o i d @ sn B r a d y .
(Tav . IX : fig .
Valva/ ina b ullo id es B r a d y 1 876 ; and Perm . F or am in if era , pa
g ina 89 , tav . IV , fig . 1 2 - 1 5. C hapman e How ch in , 1 90 5 ; M em .
G eo l. S urvey Ne w South Wales , Paleon t . , num . 1 4 , pag . 1 3 , tav . 1 ,
fig . 9 & C .
H o posto un pun to in te rrogativo al nome spec ifico d e lla fo rma che m i
ha dato la sez ion e long itud inale rappresen tata nella fig . 1 8 , tav . IX , trattan
d osi d i spec ie conosc iuta fin q ui prevalen tem en te se non esc lus ivam en te
ben na-carbon ifera, ma la d ispos iz io ne de i segm en ti d el n icch io e quind id e lle logg e . la so tt ig liezza d e lle pare t i , la tessi tura subarenacea , che ne re
sultano , e soprat tut to i l confron to tra la c itata m ia figura e la 1 4 d el Brad y( loc . m i rendono abbastan za sicuro d
’
aver ben d e te rm inato .
T ra i foss i li esam inat i la fo rma in quest ione , lunga c irca mm . , è
scarsam en te rappresen tata.
C om e lo stesso Brad y osse rvò ne lla pubblicaz ione m enz ionata,la Val
zm lz'
na butto ides , arenacea , presen ta d ivers i pun t i d i som ig lianza con form e
dal p lasmostraco non cost ituito da agg regaz ione d i g ranuli preesisten ti , ma
calcareo omogeneo , assegnate al genere G lobig er ina d’
O r b i g n y .
La sud d e tta è com une neg li strat i carbon ife ri a Fusulina de ll’
Am e rica
se tten trionale , scarsa ne l calcare carbon ifero d i Namur ne l Be lg io , e nell’
al
t ro con tenen te Fusulin e d i M iatschk ovo presso Mosca. rariss ima n el calcare
pe rm o-carbon ife ro , d ecom posto , d i \Vo llong . ne lla Nuo va G alles del Sud .
( 1 ) Bo ll So c . G eo l. l t vo l . X IV . p ag . 34 . fig . 5.
DI PALEONTOLOGIA 1 39
V a l v u l i n a g l o b u la r i d’
O r b i g n y .
(T av . IX : fig . 1 9 , 20 , 24 , 2 5 , 26 e
Valzm l ina g lobulan'
s d’
O r b i g n y , 1 82 6 ; Ann . Sc . Nat. , vol. V II, pag . 2 70 ,
num . 6 . (Plano/tes z'
nédz'
tes , tav . III, fig . 1 D’
O rb ig ny , 1 850 ;
P rodr ome Patéon t . strd tig r . ,vol. II, pag . 408 , num . 1 335 . T er
quem , 1 882 ; Mem . Soc . Geo l. France , ser . vol. II , mem . 38
,
pag . 1 0 2 , num . 3 , tav . X IX , fig . 6 a-b . Fornas in i , 1 90 4 ; M em .
R. Acc . Sc . Bo logna , s er. 6 3 ,vo l. I, pag . 1 4 , tav . IV , fig . 6 , 6 a-b
e 7 ( dal d’
O r b i g n y ) .
S pecie istituita ne l 1 82 6 , ma descri tta dal l’
autore e molto succ in ta
m en te , so ltan to nel 1 850 , con questa frase : E rpèce g lobuleuse com t e
( loc . È al T erq uem , i l quale potè esam inare i d isegn i ined iti d el
d’O rbigny ed id en tificare con ess i esemplari dell ’ eocene de i d in to rn i d i
Par ig i , che se ne d eve la m ig lior conoscenza , ma le d i lu i figure d i tali
es emplari (loc. non sono troppo esatte . Però il Fornasin i ha potutoriprodurre success ivame n te de tti d isegn i orig inal i (loc . e com p le tar
cosi l’
illustraz ione de lla Valzw l i » a g lobular is ; essi , a m ig liore in tel lig ibi litàd elle m ie sez ion i , figurano nell
’
annessa tav . IX , ai num eri 24 , 2 5 , 2 6 e 2 7 .
A questa assegno le sez ion i d’
un n icch io arenaceo quali quelle long i
tud inali d e lle fig . 1 9 e 2 0 , tav . IX , appartenen t i ind ubb iamen te al gene re
Valvutz'
na. La m ia fig . 1 9 d’
ind ivid uo m ia osferico s i adatta alla 7 , ( la 2 7
d ella tav . IX ) , la 2 0 d i m egalosferico , alla 6 (la 24 della tav . IX ) , riprodo tteen trambe dal Fornasin i , come ho d etto .
Non I’ho r iscon trata infrequen te ; m i ha presen tato la lunghezza da
ad mm .
Dalle notiz ie d eg li autori consultat i , ricavo che essa è molto rara nel
luteziano d i Valognes , Vaudancourt , e Mouchy—lo-C hatel , ne i d in to rn i e
n el bac ino d i Parig i .
ORT HOPI-IRAGM INA M 1 1 n i e r C h a l m a s
O r t h o p h r a g m i n a . a r c h î u c i ? S c h l u m b e r g e r .
(Tav . IX : fig .
Or thophrag m ina Arch iaci S c h l u m b e r g e r , 1 90 3 ; Bull. Soc . Geol. France ,
se r. 4 8,vol. II, pag . 2 7 7 , tav . VIII, fig . 5
—7 e 1 1 . H . Douv illé ,
1 906 , Bull. Soc . Géol. France , se r. vol . V I, pag . 24 , 2 7 e 37 .
R . Douvillé , 1 906 ; Ann . Paléon t Bou le , vol. I , pag . 65 .
Lemo ine , 1 90 7 ; Bull. Soc . Geo l . France , ser . 4 3,vol. V II, pag . 39 .
1 40 RIVISTA ITALIANA
C he s i tratt i d’Or thoph rag mi na non ho i l m in imo d ubb io , avendon e
po tuto esam inare , o ltre a sez ion i parallele e p iù 0 m eno pross ime ad u n
piano m erid iano , com e quella d ella fig . 2 1 , tav . IX , la quale v i è quas ico incid en te , anche frammen ti d i sez ion i passan t i in parte pe l piano equato riale , e che d im ostrano loggette equatoriali re ttangolari , non molto allun
gate rad ialm en te . Il d ubb io però nasce , e forte , p e r la de term inaz ione spe
c ifica, pe rchè le sez ion i su cui ho dovuto fare magg ior assegnam en to i n
essa , sono le prim e , e con que lle ,data la circostan za che riguardano tut te
esem plari m icrosfer ici , v’
è poco da conc lud ere d i s icuro . M a dat i i carat
te ri estern i i quali se ne possono d esum ere , d i n icchio len t icolare app iat
t i to , do tato alla supe rfic ie d i numerose e p icco le g ran ulaz ion i , dalla pos iz ione in terna d e i pilas tr i e d e i segm en t i tra cui s i comprendono , med ian te
i l con fron to con la fig . 6 , tav . VIII, d ello Schlumberge r , m i ri tengo auto
rizzato a conclud ere che la m ia Or thoph rag m ina non è po i troppo lon tana
d alla sua 0 . arch iac i . P iuttosto rara ; m isura i l d iam etro d i quasi mm .
S i ricorda questa spec ie ne i calcari post i alla somm ità de l lutez iano
inf er iore , con tenen t i an che l’
Alveol ina larva ( D e fr an c e ) I’
A . oblang a
d’
O r b i g n y , la Laharpc ia tuberculata ( B r u g u i e r e ) , I’
Assil iua sp ira
( D e R o i s s y ) , e l’
A . g ranulosa ( D’
A r c h i a c ) , d i Sm etre (i ) n el Viceat ino . Inoltre : nel lutez iano inf er iore d e i d in torn i d ella staz ione d i Gan
(Ariege ) , d i Bos—d’
Arros , O rignac e Sain t-Barthelem y ,in F rancia, con te
nen ti pure Or thoph rag m ina pratti ( M i c h e l i n ) , 0 . chudcau i S e h l u mb e r g e r , 0 . stellata ( D
’
Paronaca bian'
tzcus is P .
ir reg ular is ( D e s h a y e s ) , P . m urch isou i B r u n n e r ) ; Ass i l iua g ranulosa
A . lcym cr ic i ( D’
A r c h . ed B a i m e ) ; ne l calcare tenero
coe taneo d i W ind sor—C astle nel Madagascar , assiem e ad A lveol ina oblong a
d’
O r b Or thoph rag m ina d ispausa ( S o w e r b y ) , e L i thotlzamuium cfr .
asc/:crsou i S c h w ag e r ; e nel calcare d uro , anche questo della m ed es ima
e tà , d e lla baia d i Diego—Suarez e d ella reg ione d i W ind sor-Cas tle , pure nel
Madagascar , in un ione ad A lveol ina obloug a d’
O r b A . ovoidca d'
O r b
A . f rumcutifon n is S c h w . Or thoph rag m ina d iscus ( R fi t i m e y e r ) , 0 . d i
spausa Gucmbcl iu louticular is ( F i c h t e l e M o l l ) , Assil ina g ra
n ulosa ( D’
A . levm cr ici ( D’
A r c h . e A . cfr. sp i ra ( D e
R o i s s y ) .
C ons iderando ne l com plesso la faunula illustrata , e tenendo con to della
sua fac ies e d eg li habitat geolog ici c itat i volta pe r volta, ritengo non andar
tro ppo lon tano dal vero attribuendole l’
età lutez iano , col r iferim en to al
1 42 RIVISTA ITALIANA
case da lui c itat i com e eocen ici sulla fed e del De G iorg i e di O tran to ,
appartengano , come g li altri d i Gag liano e d i Castro , al Dordon iano anzi
chè all’
Eocene , e che il Numm uli tico non si debba trovare nelle colline
d i Pug lia a mezzogiorno del Gargano ne l D i S t e fa n o l’altra che
una faun ula com e p. es. q uella della Masser ia La Pezza presso Porto Bad isco (a 50 d el Capo d ’
O tran to) , la quale secondo lui con t iene c idocy
ctind sp . n . , Or thophrag m ina stella ta ( D ’
A r c h Or thoph rag m ina sp .,
Opercul ina g ranulosa Le y m 0pcrcutind ammon tato L e y m N ummul i lcs
M olli D’A r c h .Nunrmuli tcs Tch ihatchcfiî D
’
A r c h rappresen ti il
Lutez iano d e Lap paren t anz ichè i l barton iano , o , come io suppongope i fatti paleon tolog ic i fin qui a m ia conoscenza , il sanno isiauo contenen te
foss ili d i trasporto da strati p iù an tich i . Men tre i suddetti lem b i ad Orbi
toidcs credo po ter iden tificare con quelli a Lep idocyd ina , in massima san
no isian i , ma in parte anche probab ilmen te rupclian i e aqui tan ian i pun to ,
quest ’
ult imo , che spe ro sch iar ire pe r m ezzo delle ricerche le quali ho in
corso , su materiali della reg ione , e d i svariatissim e altre proven ienze . Il
loro complesso nell’attualità e pruden te defin irlo come align —miocene , man
cando , ne l m omen to , dati strat ig rafic i e paleon tolog ic i suffic ien t i pe r una
es atta d ist inz ione in sottop ian i .
( 1 ) Ibidem , pag . 1 36 .
( 2 ) Loc . cit., pag . 424 e 425.
(3 ) Ibzdevr, pag . 425. Il modo d i valutare il tutcziauo per parte d el DB Lar n aw r , e
sulla scorta d e i Rizopod i ret icolar i , e d iverso da q uello ammesso dal pro f. DI Sr aw mo , come può
rilevarsi consultando i l Traité dc Géotog ie d el sud detto , ed iz . vol. III. a pag . 1 5 1 3 e
seguen t i .
DI PALEONTOLOGIA 1 43
B I B L I O G R A F I A
Baaov H ENRI BOWM AN A M onog raph of carbon i/ crm and per
m ian Forann'
n i/cra (the g enus Fasulina ex cepted) . Palaeon tog r . Soc .
vol. pel 1 826 , pag . 1 - 1 66 , tav . X II. London , 1 876 .
CAnaz LOU IS Obser vations sur la classification dn Ter t iaire inf i
r ieur dc Ar iég c ct de la H aute-Garonna Bul l. Soc . Geol. France ,
ser . vol . V II, pag . 2 55-2 56 . Paris , 1 90 7 .
CARPENT ER W ILLIAM BENJAM IN Researches o n the Foronrin i/ cr a.
Par t 1 Con tain ing g ene ral in troduction , and M onog raph of the
Genus Orbitolitos. Ph il. T rans . Roy . Soc ., vol . CXLVI, pag . 1 8 1
2 36 , tav . I\'—IX . London , 1 856 .
C HAPMAN F aaosanc e H ow cnm WALTER A M onog raph of the
l ’o mm in i/ era of the pcrmo-carbon iferous limestones of N ew South
Wales. M em . Geo l. Survey New South Wales , Palaeon t. , num . 1 4 ,
pag . I-XVI, 1 - 2 2 , tav . I-IV . Syd ney , 1 90 5.
C n accm a -Rrs eo u G IUSEPPE Sop ra alcune Alveol ina eocen iche
della S i ci l ia. Palaeon tog r . Italica , vo l. X I, pag . 1 47 - 1 68 , tav . X II
XIII. P isa , 1 90 5 .
N ota p r even t iva sulla Scr ie nummul i tica dei
d in torn i d i B ag her ia c d i Term in i —Im erese in p rovincia d i Palermo .
G iorn . Sc . Nat . ed Econom . , vol . XXVII , pag . 3-35 estr . Palermo ,
1 90 7 .
DAINELLI G IO TTO Appunti g eolog ici sulla par te m er id ionale del
Capo d i Lenco . Boll. Soc . Geol . It., vol. XX , pag . 6 1 6—690 , tav . XIIIXV . Roma , 1 90 1 .
Vacciuitos (Pironaea) polystylus P i r o n a nel
cretaceo de l Capo d i Leuca. Bo ll. Soc . Geo l. It vol. XXIV ,
pag . 1 1 9- 1 36 , fig . I-III. Roma , 1 90 5 .
9. D ’
Aacm ac A . ed H am a JULES Descr ip tion des An imaux fossi
lcs du g rope nummul i tit dc l’
Inde , précédée d’
un résum é g éolog i
( 1 ) C omprend e so lam en te le pubb li caz ion i aven t i at t in en za con I’
arg omen to trat tato , e
q uelle che m i sono state d i mag g ior ut ilità ne llo svo lger lo .
1 44 RIVISTA ITALIANA
one et d’
une fl! onog raph ie des N ummul i tes. In pag . I—V I, 1
373 , tav . I—XXXVI. G ide e t Baud ry ; Paris , 1 853- 1 854.
DE G IO RG I Cosm o Note g eolog iche sulla provincia d i Lecce . Vo l . I .
T ipog rafia Gar ibald i ; Lecce , 1 876 ( I ) .
N ote strat ig rafi che e g eolog iche da Fasano
Otran to . Bo ll. R . C om it . G eo l. It . , vol. X II, fasc . e
Roma , 1 88 1 .
Cenn i d i g eog rafia fi sica della provincia d i
Lecce . T ipog rafia ed itrice Salen t ina ; Lecce , 1 884.
Geog rafia fi sica e descr i ttiva del la p rovi n
cia d i Lecce . T ipog rafia ed itrice Salen t ina ; Lecce , 1 897 .
[ …a ser ie g eolog ica dei ter ren i nella Pen isola
Salen tina. M em . Pon t ific . Acc . N . Lince i , vo l. XX , pag . 1 55-2 1 8 .
Roma , 1 90 3 .
DE LAPPAREN ‘
I'
ALBERT Tra i té de Gc'
olog ie . Ed iz . vo l. III .
In pag . 1 289—2 0 1 5 , fig . 584
-883 . M asson C . ; Paris , 1 906 .
DI STEFANO G IO VANN I Sul l’
es istensa dell’
Eocene nella Pen isola
salen t in a. Rend ic . R. Acc . Lincei , C l . sc . fis m at . e nat . , ser. 5 8 ,
vol . XV , sem . pag . 42 3-42 5 . Rom a, 1 906 .
pr etes i g rand i f enom en i d i car regg iamr: n to
in S ic il ia . Rend . R. Acc . Lince i , C l . s . fis . , m at . e nat . , ser . 58
,
vo l . XVI, sem . pag . 2 58—2 7 1 . Rom a, 1 90 7 .
Poche altr e p arole sull’
Eocene della Ter r a
d’
Otran to . Bo ll. Soc . G eo l . It vo l . XXVII, p ag . 1 7- 2 0 ,
fig . A e
B . Rom a,1 90 8 .
DOUVILLÉ H EN RI E ssai d’une r evis ion des Orbi tol i tes . Bull. Soc .
Geol . France , se r . 4 3, vo l. II, pag . 2 89
-30 6 , fig . 1 -7 , tav . IX -X .
Paris , 1 90 2 .
D istr ibut ion des Orbi tolites et des Orbitoides
dans la Craie du Sud -Ouest . Bull . Soc . Geo l. France , serie 4 8,
vol . II, pag . 30 7-3 1 3 . Paris , 1 90 2 .
Sur la str ucture des Orbi tol incs . Bull. Soc .
Géol. France , se r . 4 8,vol. IV , pag . 653
-66 1 , tav . XVII. Paris ,1 904.
Le Ter rain nummul i tit du B assin de
Adour . Bull. Soc . G eol . F ran ce , ser . 4 3, vo l . V , pag . 9
-54 , fig .
1 -4 , 1 quad ro . Par is , 1 90 5 .
( I ) Il seco ndo volum e d i q ues t’op era n on e an cor s tato p ubbhcato .
1 46 RIVISTA ITALIANA
MAR INELLI O LINTO Descr iz ione g eolog ica dei d in tor n i di Tar cen to
in F r iuli . Pubbl. R. Ist . S tud i Sup . Firen ze , Sez . sc . fis. e nat . ,
pag . III—VIII, 1 - 2 56 , 3 tav . geo l. , tav . II-V . F irenze , 1 90 2 .
MUN IER-C HALMAS Etude du Ti thon ique , du Cretacé et du Ter tia ir e
du Vicen tin . In pag . I - 1 84 , fig . 1 -35 . Savy ; Paris , 1 89 1 .
N ote sur la zone a’
Auvers (Bar ton ien inf l
r ieur ) . Boll . Soc . Geo l. France , se r . 4 8 , vol. V I, pag . 50 3-509 .
Paris , 1 90 7 .
MUNIER—C HALM AS e SC HLUM BERG ER C HARLES N ote sur les M il io
lidc‘es trématophor ées . Bull. Soc . Géo l. France , ser . 3 8 , vo l. X III,pag . 2 73
—3 2 3 , fig . 1 —44 , tav . VII—X IV b is. Paris , 1 885.
PARONA CARLO FABRIZ IO R isultati d i uno stud io sul cretacea supe
r ior e dei M ont i d i B ag no presso Aqui la . Rend ie . R . Acc . Lince i ,
C l . sc . fis . , mat . e nat ., ser. 58
, vol . XV I , sem . pag . 2 2 9-2 36 .
Roma , 1 90 7 .
PREVER PIETRO LODO VIC O R icerche sulla F auna d i a lcun i calcar i
n umm uli tic i dell’
Ital ia cen trale e m er id ionale . Bo ll. SOC . Geol. It
vol. XXIV , pag . 66 7—693 . Roma, 1 90 5.
Sulla F auna numm uli t ica della Scag lia ne l
I’
Appen n ino cen tr ale . Atti R . Acc . Sc . Torino , vol. XL , pag . 3- 1 5
estr. , I tav . T orino , 1 90 5 .
R . UFF IC IO G EO LOG ICO Car ta g eoh7g ica d’
Ital ia ,nella scala d i I a
In 2 fog li . Roma, 1 88 1 .
Idem idem , nella scala d i I a
In 2 fog li. Roma, 1 889 .
Idem idem , nella scala d i 1 a F0
g lio num . 2 1 4 Gall ipol i) , fog lio num . 2 1 5 ( Otr an to) , fog lio num . 2 2 3
( Tr icase) . Roma, 1 904.
SC HLUM BERGER C HARLES bl ouog raph ie des bl il iol ide‘es du Golf e
de M arsei lle . Mem . Soc . Zoo l. France ,vol. V I, pag , 57
-80 ,fig . 1
37 , tav . I—IV . Paris , 1 893.
Troisième note sur les Orbitoides. Bull .Soc . Geo l. F rance , ser . 4 a vo l . III , pag . 2 73—289 ,fig . A—F tav. VIIIX I. Paris , 1 90 3 .
Deux ieme note sur les xl[ i liolidees tréma
top horées . Bull. Soc . Geol. France , ser . 4 8, vo l. V , pag . 1 1 5—1 34,
fig . 1 —29 , tav . II-III. Paris , 1 90 5.
S C HLUM BERG ER C HARLES e DOUV ILLE HENR I Sur deux F oram in i
f eres éocènes . Dictyoconus egyptionsis C h a p m et Lituonella Roberti
DI PALEONTOLOGIA 1 47
nov. g en . et sp . Bull. Soc . Geo l. France , serie 4 8,
vol. V ,
pag . 2 9 1—304 , fig . 1 —7 , tav . IX . Par is , 1 90 5.
SCHWAGER C 0 NRAB D ie F oram in if ere n aus den Eocaenab1ag erun
g en der liby schen Waste und Aegyp tens . Palaeon tograph ica, vol . XXX ,
fasc . pag . 8 1 - 1 53 , tav . I—V I. Cassel , 1 883 .
SEGUEN Z A GIUSEPPE B revissim i cen n i in torno la ser ie ter z iari a
de lla provincia d i M essina . Lettera al sig . Ing . L . fl! olino F oti da
B arcellona (Sici l ia). Bo ll. R. C om it . Geo l. It . , vol. IV , pag . 2 3 1
2 38 , 2 59—2 7 1 . Roma, 1 873 .
Le F ormaz ion i terz iar ie nella provinci a
d i Regg io (Calab r ia) . M em . R. Acc . Lincei , Cl. sc. fis ., mat . e
nat. , ser. 3 8 , vo l. V I, pag . 3—446 , tav . I—XVII. Roma, 1 880 .
S ILVESTRI ALF REDO L’Ourphatocy clus m acropora ( Lam c k . ) a
Term in i—[ men se (Palermo) . Atti Pon t if. Acc. N . Lince i , anno LX I
( 1 90 7 pag . 1 7—2 6 , fig . 1 —3 . Roma, 1 908 .
Philippe De la Harpe nella questione de lle
Lep idocicl ine . Att i Pon tif. Acc. N . Lince i , anno LX I ( 1 90 7
pag . 1 —7 estr. Roma, 1 908 .
T ERQUEH O LRY Les F oram in if ères de l’Eocèn e des envi rons de
Paris . M em . SOC . Geol. France , ser. 3 8, VOL I] , m em . 3 8 , pag . 1
1 93 , tav . IX —XXVI II. Paris , 1 882 .
T RABUC CO G IACOMO Sulla vera posi zione de i ter ren i eocen ici dei
M on ti del Ch ian ti . Boll. Soc . Geo l. It . , vol . X IV , pag .—36 , fig . 1 —6 ,
tav . I. Roma, 1 895.
1 48 RIVISTA ITALIANA
SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA IX .
1 , 2 , 3 e 4 Pen tell ina chalmas i S c h lu m b e r g e r ,A , se
5
z ion i trasversali 2 5.
Idem idem , sez ione long itud inale 2 5 ,6 e 7 Pen tell ina strig i lata S c h l u m b e r g e r , A , sez ion i tra
sversali X 2 5 ,8 Sp i rolocul ina ang ulosa d
’
O r b i g n y ,B
, sez ione trasver
sale x 2 5 ,
9 Or bi tol i tes complanizta L am a r c k , A . , framm en to della
1 0
I I
1 2
1 31 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
2 0
2 1
2 2
2 3
242 52 6
2 72 8
2 9
sez ione equatoriale 2 5 ,
Idem idem , sez ione trasversale 2 5 ,
Alveol ina ovoidea d’
O r b i g n y , A , sez ione long i tud inale X 2 5 ,
Idem idem , sez ione obliquax 2 5 ,
Idem i ,dem sez ione equatoriale x 2 5 ,
A lveol ina schw ag er i C h e c c h i a R i s p o l i , B , sez ionelong itud inale x 2 5 ,
Alveol ina schw ag er i C h e c chi a R i s p o l i , A , sez ionem er id iana X 2 5 ,
A lveol ina d i'
—stefano i C h e c c h i a - R i s p o l i , B , sez ionelong i tud inale x 2 5 ,
Ide m idem , sez ione trasversale x 2 5 ,
Valvulina but/o ides B r a d y , A , sez ione long itud inale x 2 5 ,
Valvul ina g lobular is d’
O r b i g n y , B , sez ione long itu
d inale x 2 5 , .
Valvul ina g lobular is d’O r b i g n y , A , sez ione long i tu
d inale x 2 5 ,
Or thoph rag m ina archiac i S c h l u m b e r g e r B , se
z ione quas i m erid iana x 2 5 ,
Pe ntell ina chalma ri S c h l um b e r g e r , A , sez ione tra
z ione trasversale x 47 ,
Quinq uelocul ina vulg ar is d’
O r b i g n y , A , sez ione t ra
sversale x 66 ,
Valvul ina g lobular is d’ Orbi g n y , A, lato orale x
Idem idem , lato supen ore x
Idem idem , lato in feriore xValvulina g lobular is d
’
O r b i g n y B ,lato orale x
Alveol ina ovo idea d’
O r b i g n y A ?, lato magg io
re x 1 1 ?
Idem idem ,lato m inore x I I
?,
1 2 2
1 2 5
1 35
1 38
I 39
1 39
1 40
I Z Z
( I ) Ing rand im en to approssimato ,d esun to d a una figura d e l Terq uem r iguard an te un esem
p lare d e lla spec ie , d i egual form a e proven ie nza.
2 ) Id em Idem,d a ind iv idui d e ll
'
eocene d e ll’H érault.
N . 8 . Le fig ure 1 —2 1 riprod ucono m ie fotog rafie orig inali r icavate dai m ie i preparati li tolog ic i d e l m ateriale esam inato ; le 2 2 -23. d iseg n i d ello Sch lumberg cr : e le 24—2 0 , d iseg n i Ined i t i
dal d’o rb igny , ma fat t i conoscere dal Fornas in i , che g en t i lmen te m i ha permesso d
'
inserir li
in q uesta tavo la.
Anno XIV Fasc. IV
RASSEGNA DELLE PUBBLICAZ ION I ITALIANE
AIBAIIHI l l i un Phol idophorus de l Ital ico lombardo.
Bend . R. Istit. Lamb. d i Sr . e L.,ser. 2 , XLI, pag .
-I,con
1 fig. M i lano, 1 908.
L’A. descr ive la nuova forma Pli ol i rlol ihw us C rt/ii i , Sim i le al
Ph. ! ati nscu lus Ag. e al Ph . p usi l lus Ag.,che le è molto alfine .
Nota. ehe i l c idotus Len t i cch ia i De Z iguo ( in sehed is ), de lla
dolom ia p r inc ipale lmnbnrda,è i nvece sem pre i l Colobod us ar
natus Ag. M . GOR'
I‘
ANI.
HANRSTRELI.I G. Revisione de l la fauna eoceni ca (l i la verda
ne l Vicent ino . Hatr. ( I. Att i S. l.igust ica Se . Nat. e geogr.,
XIX. Vol . in 8 d i p . l — IOS,con 2 tav.
, Genova. 1 908 .
I.’A. i llustra i n que s ta m emor ia i fatt i g ift da lui enunc iat i
III una nota pre l im inare , desc r ivendo i foss i li ol igocen ic i del la
valle d i Laverda ( Vicenza) . Sono 9 1 tra spec ie e var ietà : d i esse
so lo II s i trovano c itate anche in g iac imenti eocen ic i,e 7 in do
posit i m iocen ic i : le altre son tutte prop r ie del l'
Ol igocene . La
fauna, nel suo comp lesso, è m olto affine a quella. de i deposi t i s in
er0m del Piemon te,con la. quale ha comun i ben 39 forme d i ( la
ster0pod i e Lame ll i branch i . Son descritte come nuove
1 50 RIVISTA ITALIANA
Dendrop /zyl l io vicen ti na,Tap es Iavcrdanu . T. l )o- S te/ im i i ,
Tell ina laverdann,Diastoma Opp cuheim i .
Notiamo però che i l nome spec ifico v i c e n t i u a deve essere
corretto in v i c e t i n a (da V i c e t i a ,Vicenza) .
M . GOB'
I‘
ANI.
CAPELLI… G. Mastodont i del Museo Geolog ico d i Bologna.
Ser i e VI Tomo V. J[ emor ie R. Accadem ia So. I st., pag. 1 2,
con 2 tavole. Bologna, 1 908.
In questa interessante memor ia I'
i l lustre Autore descr ive gl i
avanz i d i mastodonti p iemon tesi , già appartenen t i all’Avv. F.
Cantamessa ed ora del Museo bolognese. Si tratta d i alcun i avanz i
d i M astodon aroern cm i s Croiz . e Job. d i C inagl io d’ Asti
,d i un
cran io r invenuto a C it de i Bosch i i n Valle Andona e d i uno sche
letra,della stessa. local i tà.
,che s i amm ira. montato n el Museo
bolognese .
La. memor ia è molto importan te per le not iz ie stor iche ed è
accompagnata da due tavole che i llustrano i l prezioso mater iale.
E. FLORBS.
DALPIAZ G. Verteb rat i de l le arenar ie m iocen iche d i Bel luno .
Atti Accadem ia scien tifica ven cto— tren i in o— i str iano. C lasse
V. anno V, pag. 1 0
,fig. 7 . Padova
,1 908.
L’ A. c i presenta in questa breve memor ia un catalogo rug io
nato dagl i avanz i d i vertebrati delle note arenar ie m iocen iche
bellunes i , r iserbandosi d i cont inuare l’ i l lustraz ione d i quest i
avanzi con monografie spec ial i per c iascun genere, com e ha g ià
fatto egreg iamen te pel Cyr iorh lp hù .m lcatu.< e per gli avanz i d i
Squa lodon .
Ecco l’elenco deg l i avanz i : Mamme l la : Rh inoceros Di cc
ratlmr im n) sp . cfr. Rh . m in ants Inv.,Squalodon bar im se Jourd .
,
1 56 RIVISTA ITALIANA
Sn.vssrm A. Ph i l ippe de la Harpe nel la quest ione del le
Lop ldoclc line Atti Pontific. Aer . N . Lin cei,anno LXI
( 1 907 pag. ITI— 1 79 Roma,1 908.
Il p rof. G. Di Stefano del la R. Un ivers ità d i Palermo,in una
nota dal t ito lo Poche a ltr e p aro le sa l l’
Eb cew de l la Ter r a d’
0
fran to recentemente comparsa nel Bol l. Soc . Geol . It. ha
c reduto poter provare in medo inoppugnab i le l'
eocen ic ità del le
Lep idoc ic l ine d i tip o ol igocen i eo de l la Ter ra d’ Otranto
,e quind i
de lle Lep idoc icl ine in generale , facendo costatare d ’averle tro
vate in un calcare della reg ione, ass ieme a Nummu l i tes Teh i
lm chefii d’ Arch., N . comp lanata Lm k . e N . Guettard i presc ia
dendo da altr i fossi l i eo—o l igo—m iocen ic i . Il S i lvestr i , i l quale g ià
conosceva s im i li ed anche, per gl i eocen ist i , p iù ed ificant i asso
c iaz ion i,ma che per var i m ot ivi non ha mai c reduto dovervi dare
quel l’im portanza assoluta ai tr ibuitav i dal Di Ste fano
,nega valore
ne l lo scr itto c itato al la prova d i questi , sebbene tutt’
altro che
con trar io ad annuotte re l'
eoce n ici ta de llo. Lep idoc ic li ne, tan tocbè
ne l passato e pe rfino g iun to a con trastare i l favore d i essa col
dott. Il . Douvi llè.
E lo nega, perchè, secondo lui,i l Di Ste fano non ha tenuto
conto de l rapporto nume r ico tra i foss i li eocen ic i ed i controvers i,
in r iguardo al l’ età,ne de l la f ac i es de i pr im i e de i second i
,e nem
meno del la poss ibi l i tae p robab i l ità de l trasporto d i fossi li an tich i
in terren i p iù recenti,spec ie colà dove e gl i un i e g li altr i , caso
de l la Terra d’Otranto
,sono rapp resen tat i . Possib i l ità. e probabi l i tà
che egl i sost iene appogg iandosi ad osservaz ion i pubbl icate spec ial
men te da l De la Harpe , ed in tale epoca i n cui non era ancor sorta
la quest ione p resen te , e d i conseguenza l ibere dal l’
in fluen za d i ossa.
Pe r d imostrare poi imme r itato la qualifica datai dal Di
Stefano, nel la nota r ifer ita,d i negatore sistenm t ieo
,i l Si lvestr i
conferma per m ezzo d i un ’an notaz ione i n calce al suo scr i tto l
’
e
s isten za de l lutez iano ne l la Te rra d’Otranto
,stabi l ita dal Di Ste
fano,ma a questi contrastata dal dott . (I. Dain e ll i
A. Sn .vssrm .
( I ) v o l. XXVII , 1908 : pag . fig . A e B .
Q uest'ar gom en t o uta ta p o i svo l t o am p iam en t e n e l fam 8.e , an n o X IV
( l ine) , d i q uesta R i v i st a , pag . i l ? e seg . tav . IX
DI PALEONTOLOGIA 1 57
II.
RASSEGNA DELLE PUBBLICAZ ION I ESTERE
Fonera… M . R. Note sur le Sch izaster g i bherulus L.
Agass . et observat ions sur le gen re Seh izaster L. Agass .
B u l let. de I’
I n st. egg/p t.. 5° ser .
,t. Le Caire, 1 908, 1 fase .
in d i 1 5 pag .
A sost ituire esemp lare tipo de lle S . ;; i bhcru lzm. figurato
g iù. da Savigny e malauguratamente frantumato da Pomel, g iun
gono opportun i due altr i esemp lar i sub- fossi l i
,raccolt i dal Dott.
J . A. Bal l n e lle terrazze p iù recen t i d i Ras Ben nas,
e m inuta
mente i l lustrat i dal Fourtean in questa nota. Da c iò 1’A. prend e
le mosse per fare alcune dettag l iate osservaz ion i su due d ivers i
mod i d i sudd i videre i l genere Sah i rastcr , proposti quas i contem
poraneame n te dal Lam bert e dal Mortensen . Ch i conosce le due
accennate c lass i ficaz ion i non può i nfatt i non esser r imasto colp ito
dal modo d iverso co l quale i due insign i ech inolog i i nterpetrano
g li stess i nom i ge ner ic i . A p ropos ito d e l l’ adoz ione del nome
Spa im zyus per lo .S'ch izastcr cana l i /cm s e sosti tuz ione d i P ro
sp afm tg ns pe r lo S . p urp ur eus , effettuate,come sapp iam o
,dal
Lam bert,i l l“o n rtoau agg iunge i l peso de lla p ropr ia autor ità a
quel la d i Rathe r , d i Mortensen . d i De Lor iol,n e l lamentare la
con fus ione inde tta ne l la nom enc latura degl i ech i n i da quest i d is
seppe ll imen t i d i nom i e d i d iagnos i antiche ; d imostrando in tutto
i l corso della d iscusso ine un fine ed equi l i brato sp ir i to c r itico,
che r ivela in lui i l d iscepolo d i ( ,i anth ier. Il Fourtean r i leva che
la c lassificaz ione preposta dal Mortensen , i l quale . è pure r isa
puto , fonda g ran parte delle sue d ist inz ion i sul le ped icel lar ie, è
stre ttamen te,esclusivamen te zoolog ica e per ciò stesso, secondo
m e, art ific iale.
1 58 RIVISTA ITALIANA
Ma cm che sembra soprattutto plausibi le è la conclusione cui
g iunge i l Fourteau, r i tenendo opportuno d i conservare al gen ere
S ch i zos ! r r l'
esten s ione e i l s ign ificato attr ibu iti i dag l i autor i
antich i,da L. Agass iz a V. Gautb ie r : negando in vece la couve
n ienza d i dare un nome spec iale alle sudd ivision i entro l’
amb ito
de l genere , sudd ivision i cu i i l Lam bert m edes imo non attribu isce
un valore oggettivo , ma p iù che altro I'
uffic io d i fac i l i tare le
r ice rche e lo stud io. E a questo propos ito, trattandos i d i una que
st ione generale d i metodo, m i pare. uti le d i invocare ancora una
volta I’autor ità. d i Iotteau. G. STEFANINI.
Fonnvm u M . R. Sur q ue lq ues Éeh iu ides ceci-nes d’Egypte
nouveaux ou pon comma. l iu / t. dc I’ I nst. Hgyp t, 5° ser
Le Caire,1 908
,1 6 pag. in con 2 tavole.
Le 6 spec ie i llustrate i n questo acc urato stud io p rovengono
dai d ivers i p ian i dell’eocene eg iz iano e sono tutte
, per l’
uno o
per l’altro r ispetto, degne d i spec iale attenzione. Tre sono nuove
Se len i a ar istata la p r ima spec ie d i questo genere trovata i n
Egitto e una de lle poche note n el terz iar io Eu3p atangus C tm
patrac assai affine ad E . ti bi/cus Lor. del le stesse local ità,e l’ in
teressan te B r i sso.9p atzngus H umet. G isopygus Z i ttel i camb ia i l
suo nom e gener ico i n quello d i PIag ioyygus Lamb.,effettivamente
i nteriore. Cade così i l gen . ( ì’
i sop ygns Gautb.
Si hanno infin e due var ietà nuove d i spec ie già ben note
Eclt i notamp os subcy l i nd rù w s Des.,var . rqinn ens ì s Fourteau
,e
Sch tzastcr vi c ina l i 3 Agass. var. ti bi/cus Fourteen . Quest’ ultima èassai notevole
, per essere i n term ed i a l i l certo modo,fra lo S . et
cz'
na lz'
s e lo S . r imos ns,e perchè offre due forme alquan to d i
verse. Questa var iaz ione, per la quale altri p roporrebbe testo una
d istinz ione m agar i spec ifica, sp iegata dal Fourteau com e dovuta
a d imorfismo sessuale,m en tre al la sua m ente si r iaffacc ia i l dub
bio che anche le analoghe d ifferenze fra S . vì cì nal ì s e S . r imo
sus,spec ie assai affin i e ord inar iamente assoc iate
,abbiano qual
che rapporto con lo stesso fenomeno. Il Fonrteau c ita,a con forto
1 eo RIVISTA ITALIANA
dal Gregory , perde una parte de i suoi s inon im i , mentre ad esse
vengono assim i lat i i rad iol i del C . o l igoccn us Greg. l rad iol i
ornati d i cupola . ma con sp ine rade in luogo dei solit i granul i ,
dal Gregor y e successivamente da altr i cons iderate come 0 . ave
n i enm s i s,sono dal l’A. attr ibui te al Lc iocidar is S i smonda i R.Maver .
Anche g l i altr i ech in i regolar i si arr icch iscono d i nuove spec ie,
tra le qual i Phormosoma Lor ì sat0 i Lambert, rappresentata da un
rad iolo e i nteressante spec ialmente per la rar ità. degl i Ech i notu
r id i al lo stato fossi le . L’
A. crede po i d i poter stab i l ire alcune
d ifferenze costant i tra i rad iol i de i d ive rs i gener i d i Diadema
t id i : i n base ad esse eg li cons ide ra come ( !cn tm stcphanus i l Dia
dcma ca larm sc Cott.,e ad esso agg iunge una nuova spec ie , C .
A i rey/zi i . Al t ipo de i rad iol i de l I) . turcarm n appartengono in
vece altr i rad iol i,che i l Lambert considera pure come spec ie
nuova,ded icaudola al Prof. Vinassa de Regny. Ancora una spec ie
nuova apparterrebbe al gene re Acrop c lti s , fi nora ignoto nel ter
z iar io. Malgrado 1’op in ione con trar ia de ll
'
A.,m i semb ra non s ia
de l tutto d iss ipato i l dubbio che possa trattars i de llo stad io gio
van i le d i qualche altra spec ie, forse realm en te appartenen te ag li
Arbac i dn e . Da spec ie nuove sono rapp resen tat i , i n Sardegna, eu
che i gen . Psammcch i im s e .'f nnp csus , ne l la cu i sinon im ia l’ A.
pone anche 0 tigophyw a Penn.
Riguardo agl i ech in i i rregolar i , relati vamente meno numerosi ,
si hanno pure osservaz ion i in te ressanti . L'
A. d i fende qui ancora
una vol ta e con r innovati argom en ti contro nuovi attacch i de l Dot
tor Mortensen la trasposiz ione da lui p roposta altra vo lta dei nom i
I"i bu ln r i a ed Ed vi nocyam us . Due nuove S catena sono descr itte ,
una d e l le qual i , S . .m rd i ca,sombra all
’A. mo lto v ic i na alla S
’. d i
Malta figurata da Sc i l la ; la quale appare senza d ubbio d ive rsa dal la
S . m e l i ten s i s Ai ragh i . 1 ind icat i i n Sardegna dai vari
autor i salgon o a 20,comp rese 8 spec ie nuove descr i tte ma non
figurate da Levisatn : d i queste una so la e rappresentata nel
lavoro del Lambert, po ichè del le altre 7 non gl i e stata data
comun icaz ione . Ambtypygus mc l i tm si s Wr igh t. per i l quale i l
Pomel proponeva già un nuovo genere Pseudohaimea, è un Echi
1 62 RIVISTA ITALIANA
fasc iola,molto vic i no al lo S . Park i nson i
,dal Lambert figurato
nel la stessa tavola. P i ù d i quest’ultimo
, però , som iglia allo S .
Par k i nson i Wr ight, lo S . Se i l lac Lambert. S ch izo3tc9* angusti
stal la Lamb. è una spec ie nuova,troppo succ in tamente descr itta
e molto affine allo S . .vu rd in i cnsi s Cott.,del quale i l Lambert c i
fa nota la var iabi l i tà,e dal quale sembra esser tenuto d istinto
p iù che altro in base ad una p resunta d i fferenza d i età.
O ra è a notare che i l Lambert accetta,e non poteva a meno
,
le d ist inzion i strat igrafiche stab i l i te dal Lovisato,che r i tiene in
Sardegna siano rap presen tat i tutti o quasi tutt i i p ian i de l m io
cene e dell ’ ol igocene : c iò che può essere ben issimo : ma sembra
alq uan to dubb io che degl i ech in i come Amp h i0p c bi eco /ata , C i
dar is rosar ia,Gr egory/e s ter corang uin um ecc. provengano da p ian i
cos ì an tich i come quel l i cui vengono attr ibui ti,mentre nessuna
del le spec ie ad essi caratter ist iche vi è segnalata.
Le spec ie descr itte figurate n el be l lavoro del sig. Lam ber t
sono 47 : d i q ueste ben 25 sono nuove. Gr. STEFANINI.
LAMBERT M . J . Note sur les Éch i n îdes d u calcai re p isol it i
q ue (Ill Bussi n'
de Par is . Comp tes r cm lus (le l’
Associa
tion F ranca ise pour l’
- 1 van cemcn t dc Sci en ces. Congres de
Reims,1 907
,1 ’ar is
,1 908
,1 fase. in 8° d i 1 1 pag.
,con tavola.
E un breve stud io,n el quale l
’A. r i prende i n esame la fan
nula d i questo i nteressante deposi to, conosc iuta da m olto tem po
ma assai imperfettamen te per opera d i Sor ignet . Con l’ aiuto
anche d i nuov i mater ial i da lui stesso e da altri raccolt i , i l Lam
bert ha potuto megl io i llustrare le spec ie non ben note,e descr i
verno due nuove : C idar i s Va lcttoi e C i r cop clti s Peron i . L’
ultima
d i queste è fondata su alcun i rad iol i,al la cu i d eterm inaz ione
gener ica l’A. confessa d i essere g iun to solo per esc lus ione : non
sem bra dunque molto prud e n te trarne d el le d eduz ion i «l ’ indole
stratigrafica. Tra i cam b iam en ti d i s i non im ia e le osse rvaz ion i
nuove de i qual i e… r icco questo lavoro . conv iene accennare alla
proposta d i un nuovo nom e : per ind icare le Py
Bl VISTA ITALIANA
d i fare una revisi one de l le spec ie d i questo genere ind icato nel
l’e lveziane del la Toronna e del l’ Angiò, spec ie che egl i crede d i
dover r idurre a 4,d istinguendo però nel la multiforme S . F auj asz
'
Defr . S .
’
p rop i nqua Agass. ) d iverse varietà, due sole delle
quali var. armor i czm a e var. furoncnsi s sono rappresentate
nel la collez ione Leeoin tre. Non sarebbe possibi le r iassumere con
la necessaria brevità le question i d i s inon im ia sol levate dal Lam
bert a proposito delle Sard el la : c i l im i teremo ad ind icare le inte
ressanti ed accurate osservaz ion i relative al modo d i sutura de i
p i lastri e al decorso dei canal i in tern i delle p lacche ; osservaz ion i
che sono i llustrate da alcune fotografie, ma che avrebbe ro potuto
esser rese anche più ch iare da qualche figura schemat ica. Belle
e c0 p iose le tavole. G. STEFANINI.
Srunvnsun G. Die geo logischcu ( l rund lagen der Abstam
muugslell re. Leip zig, W . Engelmanu , pag. 284 e 1 72 fig .
Prezzo M k .
Con questo l ibro , d i cui sarebbe imposs ib i le d i re in una sem
p l ice recensione quanto d i importante con tie ne. l’ egreg io Pro fes
sore del l’ Un ivers ita d i Bonn p resenta ai geolog i una ser ie d i q ui
stion i d i g rande i nteresse. relative al la evoluz ione . Che i l l ibro
s ia d i grande importanza ed i nd ispensabi le a ch i non vogl ia l i
m i tars i in geologia ed i n paleon tologia al la pura e sem pl ice de
sc r iz ione d i fatt i,ma assurgere a conside raz io n i fi losoficamente
i lto,lo d imostrano le vivac i c r itic al le qual i da parte d i molt i
(e stato sottoposto. E non s i cri t ica se non quel lo c he e ffe ttiva
m en te ha valore, alm eno d i novità..
Se non è fac i le d ifatti daro all'
rag io n e in tutte le sue con
s ideraz ion i , nò io m i sen t i re i d i dargl ie la com p iutauw ntc,è p e rò
indubitato che le ide e d e lle Ste inmann m e r itano d iscuss ione se
rena e seria. V
*
r l flu0u m .… A ( a l w w e…


































































































































































































































































































































































































































































































































































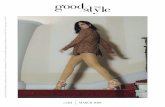




![Nexos sociais e violência. o caso do conflito de 2004-2005 entre os Maxakali [Quaderni di THULE - Rivista italiana di studi americanistici]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631ca29ba906b217b9070cd6/nexos-sociais-e-violencia-o-caso-do-conflito-de-2004-2005-entre-os-maxakali-quaderni.jpg)