Il canto della divisione. Sintassi e struttura in ‘Inferno’, XXVIII, in «Rivista di Studi...
Transcript of Il canto della divisione. Sintassi e struttura in ‘Inferno’, XXVIII, in «Rivista di Studi...
rivista distudi danteschi
periodico semestrale
direzione: Gian Carlo Alessio, Marco Ariani, Corrado Calenda, Enrico Malato (Dir. resp.), Andrea Mazzucchi, Manlio Pastore Stocchi,
Jacqueline Risset, Irène Rosier-Catach, Cesare Segre.
redazione: Luca Azzetta, Vittorio Celotto, Massimiliano Corrado, Gennaro Ferrante,
Marco Grimaldi, Ciro Perna
salerno editriceroma
anno Xi • 2011
Direttori
Gian Carlo Alessio, Marco Ariani, Corrado Calenda, Enrico Malato, Andrea Mazzucchi, Manlio Pastore Stocchi,
Jacqueline Risset, Irène Rosier-Catach, Cesare Segre.
Direttore responsabile
Enrico Malato
Redattori
redazione: Luca Azzetta, Vittorio Celotto, Massimiliano Corrado, Gennaro Ferrante, Marco Grimaldi, Ciro Perna
i saggi pubblicati nella rivista sono vagliati e approvati da specialisti del settore esterni alla direzione (Peer reviewed )
autorizzazione del tribunale di roma n. 375/2001 del 16.8.2001
tutti i diritti riservati - all rights reserved
copyright © 2011 by salerno editrice s.r.l., roma. sono rigorosamente vietati la ri produzione, la traduzione, l’adattamento, anche parziale o per estratti, per qual siasi uso e con qualsiasi mezzo effettuati, senza la preventiva autorizzazione scritta della
salerno editrice s.r.l. Ogni abuso sarà perseguito a norma di legge.
rivista di studi danteschisotto gli auspici della
« edizione nazionale dei commenti danteschi »
3
il canto della divisione. sintassi e struttura in Inferno, XXviii
di fronte al canto xxviii dell’Inferno, certo tra i piú memorabili dell’intera Commedia, i non pochi studi critici dispiegatisi negli ultimi decenni hanno fornito letture che non sembrano aver esaurito le possibilità di una piú am-pia, complessiva e – soprattutto – unitaria interpretazione di tutti i motivi sollecitati dal passaggio del pellegrino dante nella nona bolgia.1 Qui infatti si fondono in maniera particolarmente spiccata non solo una molteplicità di fattori linguistici e stilistico-strutturali, ma anche di temi etico-storici tra i piú rilevanti nel pensiero dantesco, che stanno alla base stessa del poema. L’obiettivo di questo contributo è individuare la piena congruenza poetica di tali fattori, vale a dire riconoscere come ogni singola risorsa espressiva sia sempre a non pleonastico servizio del senso, a tutti i livelli, anche al di là dei confini del canto.
i macro-elementi di cui è intessuto il canto xxviii – l’orrore della pena descritta con straordinaria efficacia; dannati celeberrimi e celeberrime fi-
1. Facciamo riferimento, in obbligata sintesi, a contributi come quello, ormai decisamente superato, di v. Crescini, Il canto xxviii dell’ ‘Inferno’, Firenze, sansoni, s.d. [ma 1907]; o a quelli di M. Fubini, Canto xxviii, in Lectura Dantis Scaligera. Inferno, Firenze, Le Monnier, 1967, pp. 997-1026, centrato sull’aspetto retorico e artistico del canto; e di F. Montanari, Il canto xxviii dell’ ‘Inferno’, in Nuove letture dantesche, vol. iii, Firenze, Le Monnier, 1969, pp. 39-50. O ancora all’importante analisi di P.G. Beltrami, Metrica e sintassi nel canto xxviii dell’ ‘Inferno’, in GsLi, vol. clxii 1985, pp. 1-26; a M. Durante, Sul xxviii dell’ ‘Inferno’, in Studi di filologia e letteratura italiana in onore di Gianvito Resta, a cura di v. Masiello, roma, salerno editrice, 2000, 2 voll., vol. i pp. 143-85; nonché al saggio di P. Allegretti, Canto xxviii, in Lectura Dantis Turicensis. Inferno, a cura di G. Günter e M. Picone, Firenze, cesati, 2000, pp. 393-406, focalizzato pre-valentemente sull’individuazione di modelli stilistico-testuali in fonti classiche e trobadoriche. a questo riguardo andranno citati anche M. Picone, I trovatori di Dante: Bertran De Born, in « studi e problemi di critica testuale », vol. xix 1979, pp. 71-94; e F. Suitner, Due trovatori nella ‘Commedia’ (Bertran de Born e Folchetto di Marsiglia), in « atti della accademia nazionale dei Lincei. classe di scienze morali, storiche e filologiche », s. viii, vol. xxiv 1980, pp. 579-643. non omettibili poi gli studi di e. Sanguineti, Interpretazione di Malebolge, Firenze, Olschki, 1961 (cap. xi, pp. 283-310), e di i. Baldelli, « Lo dolce piano che da Vercelli a Marcabò dichina », ‘Inferno’ xxviii 74-75, in Li, a. xlvii 1995, pp. 193-202. Quanto ai commenti, antichi e moderni, si usano, in sigla: Bosco = Dante Alighieri, La Divina Commedia. Inferno, con pagine critiche, a cura di u. Bo-sco e G. Reggio, Firenze, Le Monnier, 1988; Chiavacci Leonardi = Dante Alighieri, Com-media, con il commento di a.M. Chiavacci Leonardi, vol. i. Inferno, Milano, Mondadori, 1991; Inglese = Dante Alighieri, Commedia. Inferno, revisione del testo e commento di G. Inglese, roma, carocci, 2007; Lana = Iacomo della Lana, Commento alla ‘Commedia’, a cura di M. Volpi, con la collab. di a. Terzi, roma, salerno editrice, 2009, 4 tomi.
mirko volpi
4
gure di dannati (nella non insolita mistione di personaggi famosi e oscuri, antichi e moderni, livellati dalla giustizia divina nell’atemporalità dell’ol-tremondo); i grandi temi dell’unità religiosa e politico-civile – si ritrovano forse qui piú che altrove accumulati in gran copia, uno in fila all’altro, qua-si a richiamare il terribile « fio » che in questa bolgia « si paga » con la lace-razione delle membra. non si tratta però di un crogiolo indistinto e caoti-co: richiami sottili, infatti, attraversano e tengono insieme il canto, o me-glio, il canto piú i vv. 1-36 del successivo xxix, dove compare Geri del Bel- lo, pienamente assorbito nella struttura dell’episodio dei seminatori di di-scordie.
La spesso, e giustamente, evocata “congruenza tra materia e stile” si può rintracciare ben al di là delle notazioni sulle semplici corrispondenze stilisti-che tra violenza della pena e violenza del linguaggio, poiché a un livello piú profondo e capillare troveremo un fitto reticolato che ha nell’espressività lessicale solo una delle trame della tela, la quale ci consegna un’immagine di divisione e frattura delle parti attraverso cui, però, passano fili destinati a tenere insieme il quadro. si considereranno cosí, come moduli precipui di resa della lacerazione, il ricorso a tutta la gamma di espedienti rimici, la sintassi franta, le figure retoriche di separazione (iperbati, chiasmi), le so-spensioni e gli incastri nella disposizione degli elementi; la tensione all’unio-ne si avvarrà invece di lessemi e stilemi ricorrenti (l’alta frequenza del verbo ‘vedere’, le riprese ad verbum, gli attacchi di discorso, ecc.) e di una stringente concatenazione dei fattori narrativi e strutturali, soprattutto evidente nelle connessioni tra dannato e dannato e nel mai meccanico trapasso da episodio a episodio.2
chi accolga e tormenti la nuova bolgia, la nona, viene sinteticamente annunciato da dante al termine del canto xxvii (vv. 133-36), col ricorso al semplice gerundio causale « scommettendo », cioè ‘poiché s-commettono, dividono’.3
noi passamm’ oltre, e io e ’l duca mio,su per lo scoglio infino in su l’altr’ arco
2. È per questo che secondo me nemmeno Fubini, pur stigmatizzando a ragione le letture psicologizzanti precedenti alla sua, coglie l’essenza complessiva del canto quando afferma, ad es., che « la retorica rimane al di qua della poesia assoluta e piena, e piú d’una volta, anche quando raggiunge il compito prefisso, finisce per lasciare qualche segno della sua peculiare insufficienza » (Fubini, Canto xxviii, cit., p. 1016).
3. cfr. Inglese, ad locum.
il canto della divisione. sintassi e struttura in inf., xxviii
5
che cuopre ’l fosso in che si paga il fio a quei che scommettendo acquistan carco.
dopo il dittico dei consiglieri frodolenti e prima di quello dedicato ai falsari, tocca ora a un’altra specie di peccatori di parola, i seminatori di scisma e di scandalo, compressi in un solo (o quasi) canto, che si apre ex abrupto su una duplice costruzione retorica (vv. 1-6, o 1-3 + 4-6, e 7-21), avente per denomi-natore comune il tema dell’ineffabilità.
chi poría mai pur con parole scioltedicer del sangue e de le piaghe a pienoch’i’ ora vidi, per narrar piú volte? Ogne lingua per certo verría menoper lo nostro sermone e per la mentec’hanno a tanto comprender poco seno (vv. 1-6).
La terzina incipitaria è costituita da un’interrogativa retorica il cui modello piú immediato è stato concordemente individuato in Aen., ii 361-62: « Quis cladem illius noctis, quis funera fando / explicet aut possit lacrimis aequare labores? ». al solito, però, l’atteggiamento agonistico che dante mette in cam-po nei confronti delle fonti si apprezza nello scarto rispetto a queste, nel cambio di prospettiva e nella sapiente manipolazione degli elementi di par-tenza, sovente combinati con altri materiali:4 insomma, nella mai pedestre ripresa. Qui, dunque, si compattano nella sola principale (« chi poria…di-cer…a pieno ») i verbi che nel brano virgiliano compongono la coordinata disgiuntiva, cioè « fando explicet » e « possit…aequare »; con quest’ultimo che viene sí obliterato, ma per essere riutilizzato molto dopo, al v. 20, a chiudere la successiva similitudine (« d’equar sarebbe nulla »), con un effetto a eco della citazione che risulta cosí nascosta poiché dilatata.5 e ancora si noti come ven-ga espanso il concetto del ‘dire’ con la specificazione, tutta retorico-espressiva, del « pur con parole sciolte », cioè ‘anche se si ricorresse alla prosa’.6
4. È il caso del rimando a Brunetto Latini, Tesoretto, vv. 411-26, per le « parole sciolte » del v. 1 (cfr. Beltrami, Metrica, cit., p. 3).
5. e appunto a questo passo virgiliano Allegretti, Canto xxviii, cit., p. 393, ne affianca un altro – « Quis mihi nunc tot acerba deus, quis carmine caedes / diversas obitumque ducum, quos aequore toto […] / expediat? » (Aen., xii 500-3) –, che la studiosa, forse con forzatura ec-cessiva nella volontà di scovare ulteriori parallelismi, collega agli eventi narrati da dante pro-prio nella similitudine che occupa i vv. 7-21.
6. sulla questione basti rimandare a Beltrami, Metrica, cit., pp. 1-7, raccogliendo magari uno spunto (p. 5) relativamente alla possibile (ma dallo studioso respinta) interpretazione di « pur » come ‘soltanto’: ricorrendo unicamente alla prosa non si potrebbe rendere pienamente
mirko volpi
6
nei primi tre versi dante pone immediatamente alcuni elementi forma-li e contenutistici che segneranno l’intero canto. dal punto di vista lessicale, compaiono « sangue » e « piaghe » (si veda l’incipit del canto successivo: « La molta gente e le diverse piaghe »), cioè l’orrore visivo che accompagna con tecnica superbamente realistica l’incontro con tutti i dannati; e si impiega il verbo ‘vedere’, frequentissimo e carico, come si dirà, di un significato ancor piú pregnante del consueto. Per altro verso, si nota invece il primo di una serie di iperbati, « dicer…a pieno »,7 che vogliono richiamare – nella non casuale divaricazione degli elementi – la divisione perpetrata dai peccatori e, come correlativo della pena, la lacerazione delle membra che qui si scon-ta. La formulazione sintattica fornisce cosí già in partenza un importante segnale strutturale.
La seconda terzina riprende, ampliandolo, il concetto espresso nella pri-ma e prepara il lungo movimento che occupa i vv. 7-21. Ogni lingua (ogni poeta? ogni linguaggio umano?) verrebbe meno di fronte al tentativo di raccontare compiutamente lo strazio visto là, a causa dei limiti naturali di parola e intelletto (cioè del logos) che sono difettivi e incapaci di esprimere e concepire (o ricordare, come suggerisce inglese) tale spettacolo. né in rima, e nemmeno in prosa, anche se si provasse a raccontarlo ripetutamente, la mente umana saprebbe abbracciare tutto questo: cosí dichiara dante, che però, quasi per sfida, subito dopo l’ammissione che « sermone » e « mente…hanno a tanto comprender poco seno », colloca a illustrazione di tale scem-pio una tra le piú estese similitudini della Commedia, il cui senso sembra centrato sulla quantità, sul numero dei pezzi sparsi, delle membra smozzi-cate, e che invece nella terzina conclusiva piega sul modo, sulla condizione di quei dannati che il poeta si appresta a raccontare – forse con implicita di-mostrazione delle proprie capacità poetiche, superiori, se non ai limiti natu-rali sopra detti, a chi prima di lui vi si cimentò diffusamente.8 che qui dan-
l’orrore visto nella bolgia. sebbene dante, a mio avviso, superi piú volte nella Commedia il li-mite espressivo che egli stesso denuncia come invalicabile (dall’incipit di Inf., xxxii, alle soglie estreme dell’empireo, fino a Par., xxxiii, dove a ogni dichiarazione di ineffabilità segue una descrizione di visionaria e insieme razionalissima efficacia), credo che qui i vv. 4-6 corrobori-no la lettura vulgata del sintagma.
7. come nota Beltrami, Metrica, cit., pp. 2-3, il sintagma « a pieno » (retto da « ritrar ») torna solo un’altra volta nella Commedia, a Inf., iv 145, e proprio in rima con ‘venir meno’, a significa-re l’impossibilità di riferire tutti gli eventi occorsi. Quantità, dunque, e non – come qui – qua-lità, il « modo » (v. 21) della bolgia, come si dirà.
8. Le frequenti dichiarazioni di inadeguatezza degli strumenti espressivi all’interno della Commedia appaiono sempre piú un modulo topico che cela invece la consapevolezza di un primato poetico (nella novità della materia e nella effettiva realizzazione artistica), talora
il canto della divisione. sintassi e struttura in inf., xxviii
7
te entri allora in competizione proprio con quel Bertran de Born cantore delle armi come nella lirica italiana non ce n’erano ancora stati, scoperto modello della similitudine guerresca e ultimo seminatore di scandalo in-contrato? e magari « per narrar piú volte » significherà ‘nonostante si sia va-namente tentato numerose volte di dirne’, con criptico riferimento al trova-tore? Quel che è certo è che dante, muovendo da una canzone di Bertran, Si tuit li dol, che sarà poi ripresa anche nel canto successivo in un’altra simili-tudine (« Qual dolor fora… »: xxix 46-50),9 ricorre a una frase ipotetica di eccezionali lunghezza e complessità sintattica (vv. 7-21):
s’el s’aunasse ancor tutta la genteche già, in su la fortunata terradi Puglia, fu del suo sangue dolente per li troiani e per la lunga guerrache de l’anella fé sí alte spoglie,come Livïo scrive, che non erra, con quella che sentio di colpi doglieper contastare a ruberto Guiscardo;e l’altra il cui ossame ancor s’accoglie a ceperan, là dove fu bugiardociascun Pugliese, e là da tagliacozzo,dove sanz’ arme vinse il vecchio alardo; e qual forato suo membro e qual mozzomostrasse, d’aequar sarebbe nullail modo de la nona bolgia sozzo.
se anche si radunassero tutti i feriti di cinque tra le piú sanguinose battaglie della storia, avvenute nell’italia del sud (per usare le parole del citatissimo, dai commenti moderni, iacomo della Lana: « e fa mentione de cinque gran-de taiade d’omini le qua’ fono tutte in lo terratorio d’Ytalia in la provincia de Pugla »),10 e quindi ciascuno di essi mostrasse le proprie membra diversa-mente lacerate, non si potrebbe in alcun modo pareggiare il « modo sozzo », la ‘turpe condizione’ (inglese, ad locum) dei dannati della nona bolgia, le cui tipoligie di mutilazione vengono qui anticipate da « forato » e « mozzo ».
esplicitamente manifestata, come nel celebre passo di Inf., xxv 94-97 « taccia Lucano […] taccia […] Ovidio ». Ma si veda al riguardo, anche per riferimenti a brani da Inf., xxviii, G. Ledda, La guerra della lingua. Ineffabilità, retorica e narrativa nella ‘Commedia’ di Dante, ravenna, Longo, 2002.
9. La notazione in Allegretti, Canto xxviii, cit., p. 397. L’accostamento col dantesco « s’el s’aunasse… », e accolto unanimemente dalla critica, si deve a natalino sapegno (vd. Dante Alighieri, La Divina Commedia, a cura di n.s., Firenze, La nuova italia, 19853, ad locum).
10. Lana, i pp. 784-86.
mirko volpi
8
si dirà anzitutto che la lunga similitudine presenta una caratteristica che la accomuna alle figure retoriche dei primi sei versi e alle altre che costella-no il canto: cioè, esse sono tutte incomplete, imperfette, insufficienti a rap-presentare ciò che il pellegrino vede (e l’autore narra); sono sempre quindi al negativo, perché nessun artificio riesce a dire tutto.
tale similitudine, ben piú di una topica figura retorica come quella della fonte comunemente individuata, adempie a una triplice funzione: di rap-presentazione dell’evento che maggiormente contribuisce alla divisione politico-sociale, cioè la guerra; di introduzione plastica allo strabiliante pa-norama della bolgia, fatto di corpi incredibilmente straziati;11 e di preludio alla grande storicità del canto.12 dunque, non si tratta soltanto dell’immagi-ne della carneficina che ci si appresta a vedere, ma è il marchio della dimen-sione storica che rappresenta il vero elemento dominante del canto: ossia la condanna delle divisioni e delle scissioni operate nel corso della storia dagli uomini, che hanno causato, e continuano a causare, ferite mortali al corpo della civitas e della chiesa. È la lacerazione, passata e presente, dell’umana con vivenza che opprime il cuore del poeta: ed è a ciò che si dovrà costante-mente guardare nella lettura, ad ogni livello, del canto.
Le cinque “tagliate” (superfluo notare quanto icastico sia, nella bolgia degli squartati, questo lemma usato dal Lana, peraltro piuttosto diffuso in italiano antico) sono disposte in rigoroso ordine cronologico e non a caso ripercorrono momenti cruciali delle vicende dell’impero: dalla guerra nel Lazio di enea, fondatore di ciò che sarà roma e antecessore di tutti gli im-peratori, alla battaglia di tagliacozzo, epilogo del dominio imperiale in ita-lia – passando per quella, centrale e non solo per mera disposizione, che vide il Guiscardo opporsi agli infedeli saraceni.13 tutte, come detto, sono avvenute al sud, mentre i restanti episodi menzionati nel canto si svolgono tra Firenze e il nord, quasi a voler ricomporre una dimensione geografica che fa di necessità il paio con quella storica.14
11. Panorama, osserva Sanguineti, Interpretazione, cit., p. 287 n. 5, di cui però « non si dà descrizione d’insieme in narrato diretto ».
12. Quest’ultima in particolare costituisce la chiave di lettura di Chiavacci Leonardi, che condivido pienamente. e vd. anche, piú estesamente, Ead., Il canto xxviii dell’ ‘Inferno’, in L’a, n.s., a. xxxiv 1993, nn. 1-2 pp. 41-57.
13. tanto da meritarsi un posto in paradiso, nel cielo di Marte con cacciaguida (vd. Par., xviii 48).
14. come è stato notato, l’accumulo topo- e onomastico (otto nomi in dodici versi), con ben tre occorrenze in rima, non fa che conferire ancor piú storicità al canto. né resterà un caso isolato.
il canto della divisione. sintassi e struttura in inf., xxviii
9
e la tensione a una saldatura trapela anche lessicalmente, nell’impiego di « s’aunasse » (v. 7), cui si può affiancare al v. 15 « s’accoglie », per quanto poi la struttura delle terzine riverberi costantemente l’immagine dello smembra-mento: le parti del periodo sono infatti distanziate e spalmate lungo le cin-que terzine.15 Basti cosí rimarcare il forte iperbato sintattico che divide « s’el s’aunasse ancora tutta la gente » (v. 7) a « con quella che » (v. 13) e « l’altra » (v. 15); e quello che, analogamente a quanto avviene al v. 2, dilata il sintagma « modo…sozzo », rilevando in sede di rima l’aggettivo che segna l’avvio (nel-la turpitudine visiva e morale, dove « il valore fisico […] si unisce a quello psicologico »)16 della descrizione vera e propria della bolgia.
senza soluzione di continuità, se non – vistosamente – stilistica,17 e anti-cipo di quel forte accumulo di materiali cui si accennava, fa súbito séguito una nuova, asperrima similitudine (vv. 22-24):
Già veggia, per mezzul perdere o lulla,com’ io vidi un, cosí non si pertugia,rotto dal mento infin dove si trulla.
La sintassi franta, funzionale al sistema etico soggiacente alla colpa punita, trova la sua piú ardua realizzazione in questa terzina, di certo la piú difficile dell’intero poema. La similitudine, imperfetta come la precedente (non è tanto squarciata una botte che perda uno dei suoi pezzi centrali o laterali, quanto uno che vidi spaccato dal mento all’ano), è costituita da membri slegati al limite delle possibilità concesse all’ordo verborum,18 membri che
15. cosí Beltrami, Metrica, cit., pp. 10-11: « i membri della similitudine tutta in negativo sono dilatati al massimo, infarciti di elementi devianti rispetto allo scopo apparente immedia-to, quello di dare un termine di confronto allo spettacolo che si presenta al personaggio poeta, con lo scopo invece di dilatare al massimo il tempo dell’attesa, nella lettura, fino alla brusca conclusione ». e vd. le osservazioni di Sanguineti, Interpretazione, cit., pp. 284-87.
16. Chiavacci Leonardi, p. 835. e vd. Inglese, p. 316: « l’iperbato enfatizza l’attributo, che introduce il lettore a una serie lessicale aspra e sconcia ». nella nostra ottica, che tenta fin dove possibile di rimandare ogni elemento a un’unità interpretativa forte, l’iperbato, accanto alla funzione canonica assegnatagli in retorica, godrà qui di un valore aggiunto in quanto figura della separazione, della rottura dell’ordine naturale e provvidenziale.
17. all’attacco solenne, segnato dalla nascosta competizione instaurata da dante coi mo-delli (in primis, Bertran de Born), segue ora il corpo centrale del canto, caratterizzato (seppur non uniformemente) da un lessico decisamente espressionistico, basso, a tratti triviale, cioè dal v. 22 al v. 111, fino proprio all’arrivo del trovatore, che indurrà un nuovo innalzamento dello stile. a chiudere cosí il cerchio (come annota la chiavacci Leonardi), da dove si era principiato: il cantore dell’armorum probitas impone dunque quei moduli che già avevano ispi-rato l’incipit. il protagonista del canto sembra davvero essere lui.
18. Beltrami, Metrica, cit., p. 14, la definisce una « splendida mixtura verborum ».
mirko volpi
10
sembrano richiamare le singole doghe della botte distrutta. i due iperbati, che separano soggetto e verbo (« Già veggia…non si pertugia ») e, con varia-tio, verbo e oggetto (« io vidi un…rotto »), si incrociano poi nel chiasmo,19 che ha il suo punto cardine nel verso centrale in cui convergono appunto gli elementi fondamentali della comparatio (« com’…cosí » e i due verbi), mentre agli estremi si trovano, nuovamente variate, le espansioni dei due termini di comparazione (« per mezzul perdere o lulla », causale, e « rotto dal men-to… », aggettivale).20
tra le gambe pendevan le minugia;la corata pareva e ’l tristo saccoche merda fa di quel che si trangugia.
il dannato, paragonato e anzi degradato a una botte sfondata, viene cosí descritto al suo apparire (vv. 25-27), ma con termini tanto plebei e svilenti che dall’inanimato lo elevano soltanto a una dimensione puramente vege-tativa: quella di un corpo ridotto all’espletazione delle piú elementari fun-zioni vitali. i vocaboli materiali, cui è affidata la reificazione del dannato, dei vv. 22-24, la « veggia », il « mezzul », la « lulla », assieme al verbo, « pertu-gia », lasciano il posto a voci afferenti alla sfera dell’umano, o meglio, dell’animale (inteso, latinamente, come generico essere vivente): a far da cerniera, segnando il passaggio al nuovo àmbito, il triviale « trulla » in punta di verso.
Questi tre versi si oppongono ai precedenti per linearità sintattica; la di-sgustosa descrizione procede per frasi semplici: allo sforzo di rendere la
19. anche se « a un esame piú attento si rivela un mezzo semplicissimo, un doppio incastro sintattico » (ivi, p. 15).
20. evitando di insistere (poiché ampiamente svolto nei commenti precedenti) sulla mate-rialità del lessico, che virerà ancor piú crudamente sul realistico, scatologico e oscenamente corporeo dei versi successivi, gioverà quantomeno segnalare già qui che dal v. 10 al v. 39 tro-viamo unicamente rime ricche, forti, consonantiche o rare, in una lunga serie che prende lo slancio nel cuore della similitudine bellica per esplodere poi nell’incontro con Maometto. in ordine di frequenza nel poema, abbiamo le uscite in etto, erra, oglie, ardo, ozzo, ulla, la tronca í, e poi acco, propria della sola prima cantica (gli altri tre casi al canto vi; e non si dimentichi ai vv. 47, 49, 51 quella in arlo, unica in Inf.), e le rime uniche ugia e isma. se a queste aggiungiamo la sdrucciola, e unica, olica (vv. 80, 82, 84) e la franta Oh me (v. 123), non potremo non rilevare come il xxviii dell’Inferno si configuri come l’unico canto della Commedia a presentare contem-poraneamente tutte le soluzioni rimiche (cfr. i. Baldelli, s.v. Rima, in ED, vol. iv 1973, pp. 930-49, a p. 943), in particolare quelle che giocano sulla dilatazione e il troncamento (í, olica, oh me), ennesimo correlativo formale della frattura e della divisione ed ennesima conferma della mai gratuita esibizione di perizia tecnica messa in campo da dante.
il canto della divisione. sintassi e struttura in inf., xxviii
11
complessità del dilaniamento, segue la piana esplicazione dell’effetto di es-so, cioè l’esposizione di carne da macello.21 Le budella (« minugia ») spenzo-lano in mezzo alle gambe; appaiono con evidenza gli organi interni (la « co-rata »)22 e lo stomaco stesso, niente piú di un « tristo sacco » che non è prepo-sto alla digestione, ma si fa macchina che trasforma in escrementi il cibo inghiottito « con avidità, bestialmente ».23 tale descrizione ripercorre al con-trario la direzione tracciata dal v. 24, ‘dal mento all’ano’, come chi guardi, per meraviglia, dall’alto in basso e viceversa.
Mentre che tutto in lui veder m’attacco,guardommi e con le man s’aperse il petto,dicendo: « Or vedi com’io mi dilacco! vedi come storpiato è Mäometto!dinanzi a me sen va piangendo alí,fesso nel volto dal mento al ciuffetto. e tutti li altri che tu vedi qui,seminator di scandalo e di scismafuor vivi, e però son fessi cosí. un diavolo è qua dietro che n’accismasí crudelmente, al taglio de la spadarimettendo ciascun di questa risma, quand’ avem volta la dolente strada;però che le ferite son richiuseprima ch’altri dinanzi li rivada. Ma tu chi se’ che ’n su lo scoglio muse,
21. Per queste terzine viene chiamato nuovamente in causa Bertran de Born, con Miei sir-ventes (cfr. almeno Picone, I trovatori, cit., pp. 86-88).
22. il Buti, sempre citato a questo proposito dai moderni commentatori, la definisce: « fe-gato, cuore e polmone »; vd. Commento di Francesco da Buti sopra la ‘Divina Commedia’ di Dante Allighieri, a cura di c. Giannini, Pisa, nistri, 1858-1862, 3 voll. (rist. anast., con premessa di F. Mazzoni, Pisa, nistri-Lischi, 1989), vol. i 1858, p. 719; Benvenuto da imola chiosa: « cor, epar, splen invicem ligata »; vd. Benevenuti de Rambaldis de Imola Comentum super Dantis Aldi-gherij ‘Comoediam’, nunc primum integre in lucem editum sumptibus G.W. Vernon, curante J.Ph. La-caita, Florentiae, Barbèra, 1887, 5 voll., vol. ii p. 354.
23. Chiavacci Leonardi, p. 836. il parallelo tra il « guastamento » del corpo quando le sin-gole membra non ottemperano correttamente al proprio ruolo e il sovvertimento dell’unità nella fede, viene svolto con efficacia da iacomo della Lana, nel proemio (par. 1): « e cussí com-mo un membro che no obedisse a l’ordene naturale è guastamento e corrumpimento del corpo, come la mala despositione del stomego od opilatione del figato, apostemationi in le vene et similia, cussí quelle persone che tegnono altro che la sancta Madre echesia prediga et ordena, si èno guastamento e rumpemento de quella » (Lana, i p. 782). Per queste voci, e per il « canna » del v. 68, vd. P. Bertini Malgarini, Linguaggio medico e anatomico nelle opere di Dante, in sd, vol. lxi 1989, pp. 29-108, alle pp. 78-81.
mirko volpi
12
forse per indugiar d’ire a la penach’è giudicata in su le tue accuse? » (vv. 28-45)
il peccatore piú volgarmente rappresentato, non solo di tutto il canto, ma probabilmente dell’intero Inferno, ha finalmente un nome: si tratta infatti di Maometto. come ben noto, nel Medioevo il profeta dell’islam veniva con-siderato non come il fondatore di una nuova religione, ma come un cristia-no, ora un semplice prelato, ora persino un cardinale, che, deluso o ingan-nato nelle sue aspirazioni al soglio pontificio, si fece scismatico,24 e anzi il peggiore degli scismatici, perché inferse all’unità della fede e della chiesa il colpo piú grave e dannoso, tanto che viene « rappresentato, molto peggio che come eresiarca, come uno scismatico in mala fede (siamo pur sempre nel cerchio della frode), responsabile della piú grave mutilazione patita dal mondo cristiano ».25 Per dante è colpa cosí grave che Maometto non solo merita di aprire la serie dei dannati, ma di portare i ributtanti segni del dila-niamento piú profondo, piú ampio.
tanto che il poeta ce lo presenta eviscerato, esattamente come il piú gran-de traditore della fede, Giuda iscariota, che secondo gli Atti degli Apostoli (diversamente da quanto afferma l’evangelista Matteo, xxvii 5) « comprò un pezzo di terra con i proventi del suo delitto e poi precipitando in avanti si squarciò in mezzo e si sparsero fuori tutte le sue viscere. La cosa è divenuta cosí nota a tutti gli abitanti di Gerusalemme, che quel terreno è stato chia-mato nella loro lingua akeldamà, cioè campo di sangue » (« et hic quidem possedit agrum de mercede iniquitatis et suspensus crepuit medius, et diffu-sa sunt omnia viscera eius. et notum factum est omnibus habitantibus hie-rusalem, ita ut appellaretur ager ille lingua eorum haceldama, hoc est ager sanguinis »: Acta Apost., i 18-19).
Diffusa sunt omnia viscera eius. che dante possa essersi ispirato a questo passo (insieme magari alle diffusissime rappresentazioni pittoriche di Giuda sventrato)26 per raffigurare Maometto – accomunabile senza forzature al traditore per eccellenza –, appare ben piú che probabile, per quanto nessu-no dei commentatori vi abbia mai fatto cenno finora. Ma diventa forse fon-te inoppugnabile se si pensa che all’eresiarca ario – cosí vuole la tradizione – toccò la stessa identica morte per squartamento. tale umiliante sorte (si dice anche che spirò in una latrina) venne da súbito divulgata nella apologe-
24. su questo vd. P. Locatin, Maometto negli antichi commenti alla ‘Commedia’, in L’a, n.s., a. xliii 2002, n. 2 pp. 41-75.
25. Inglese, p. 316.26. ringrazio Giovanni Battista Boccardo per il suggerimento.
il canto della divisione. sintassi e struttura in inf., xxviii
13
tica “ortodossa” e appunto ricollegata a quella di Giuda narrata negli Atti de gli Apostoli, come spiega con chiarezza risolutiva sant’ambrogio, campio-ne nella guerra all’eresia ariana: « effusa sunt enim et arii viscera, pudet di-cere ubi, atque ita crepuit medius, prostratus in faciem […] non est fortuita mors, ubi in sacrilegio pari poenae parilis processit exemplum ».27 e per ci-tare testi assai piú vicini cronologicamente a dante (e che testimoniano nella patristica la persistenza di questo motivo), cosí il teologo Gerhoh di reichersberg (1093-1169) mette in relazione scisma ed effusione delle visce-re: « similiter arius haeresiarca, quia noluit flecti acquiescendo catholicae fidei et veritati, fractus est et effusa sunt omnia viscera eius ».28
ario, dunque, scismatico che attentò pericolosamente all’unità della fede, assume i tratti di un novello Giuda; allo stesso modo Maometto, dopo le feroci contese dottrinali dei primi secoli, raccogliendone per cosí dire la nociva eredità ereticale finisce per condividerne anche, nella rappresenta-zione dantesca ora chiarita nei suoi riferimenti scritturali e patristici, l’igno-miniosa fine.29
È Maometto che autonomamente, come faranno tutti i dannati della bol-gia, s’avanza presentandosi al pellegrino e reclamando la sua attenzione con l’esortazione a ‘vedere’,30 verbo chiave qui piú che altrove e che conta un numero di occorrenze troppo alto per non doverne sottolineare l’importan-za. La triplice iterazione (« veder…vedi…vedi », anticipata dal « vidi » del v. 23, e cui si affianca il guardare, a sua volta, del profeta: « guardommi »)31 a brevissima distanza è tesa a significare l’eccezionalità, non della pena, ma del
27. Ambrosii De fide, in Patrologiae Cursus Completus […]. Series Latina […], accurante J.P. Migne, Paris, Garnier, 1844-1864, 221 voll. (avanti cit. PL), vol. xvi col. 557a. dove non si può non rimarcare la sottolineatura ambrosiana dell’ineluttabilità dell’esemplare contrappasso pa-tito dall’iscoriota prima, da ario poi.
28. Gerhosi Reicherspergensis Commentarius aureus in Psalmos et cantica ferialia, in PL, vol. cxciii col. 746c.
29. non si può tuttavia tralasciare di ricordare che ario verrà poi esplicitamente menzio-nato da dante in Par., xiii 127-29 (« sí fé sabellio e arrio e quelli stolti / che furon come spade a le scritture / in render torti li diritti volti »), nel discorso in cui san tommaso condanna gli stolti eretici, rei di aver pervertito il significato delle sacre scritture. e si veda anche un inte-ressante luogo del Dittamondo di Fazio degli uberti, dove Maometto « con ario se ne va da questo lato » (v 12 87).
30. L’attacco del discorso, « Or vedi…vedi come », verrà chiaramente replicato da Bertran: « Or vedi…vedi s’alcuna » (vv. 130-32).
31. identico atteggiamento di speculare attenzione visiva si trova, oltre che nella massa anonima dei dannati (« s’arrestaron…a riguardarmi », v. 53), in Pier da Medicina (« ristato a ri-guardar », v. 67) e in Bertran (« quel mirava noi », v. 123).
mirko volpi
14
“modo” peculiare della propria scissione, enfatizzata dal cruento gesto di aprirsi il petto: « Or vedi com’io mi dilacco! ». L’espressivo, plastico neologi-smo, che supera in intensità il « rotto » del v. 24, rima con « m’attacco », ‘mi fisso, mi attacco fissamente con lo sguardo’, che è sí « esasperazione dello sguardo »,32 ma non vi si può non scorgere anche una macabra ironia di dan-te che con la vista compatta, riattacca, appunto (si ricordi che il verbo ‘attac-care’ è un hapax nel poema), ciò che si presenta irreparabilmente scisso.
dopo che il suo nome è risuonato in punta di verso, come parecchi dei moltissimi di questo canto, il profeta mostra il cugino alí, a sua volta fautore di una scissione all’interno dell’islam. Questi gli cammina « dinanzi » (forse perché gli fu maestro, come è stato osservato) e completa lo squarcio di Maometto con la fenditura che gli va dal mento all’attaccatura dei capelli (il « ciuffetto »): l’ossimorica ricomposizione delle due spaccature ci consegna l’immagine di un solo uomo interamente « fesso ». La piú ampia ferita possi-bile nel corpo di un uomo si realizza cosí nei due personaggi responsabili della divisione piú grave: lo scisma.
e cosí a Maometto spetta súbito dopo il compito di illustrare a dante chi siano i dannati di questa bolgia e in cosa consista la pena. tutti quelli che « tu vedi qui » (con la quarta occorrenza in sette versi del verbo) sono, e lo si dice per la prima volta al v. 35 (dopo la sintetica rubrica, per cosí dire, nell’ultimo verso del canto precedente), i « seminator di scandalo e di scisma », coloro cioè che operarono per dividere ciò che deve restare unito, coloro che scien-temente separarono « comunità o persone prima fra loro concordi ».33 non si tratta di dittologia sinonimica,34 ma della consueta, esatta nomenclatura con cui dante classifica e suddivide le specie di peccato: lo « scandalo » per-tiene all’ordine politico-civile, lo « scisma » a quello religioso.35 Lo certifica-no, tra gli antichi esegeti, Guido da Pisa, ricordato dalla chiavacci Leonardi (p. 837), e iacomo della Lana, che cosí scrive nel proemio al canto (par. 3): « sono appelladi vulgarmente quigli che deçungeno l’uno homo da l’amore dell’altro, seminaduri de rixa e de scisma e de scandallo, e quî che deçunge-no esi dalla unione della chesia, scismatici ».36 e lo conferma, a livello strut-
32. Beltrami, Metrica, cit., p. 16.33. Chiavacci Leonardi, p. 837.34. Lo sostiene invece Inglese, p. 317: « qui entrambi come sinonimi di ‘discordia’ ».35. si noterà l’ysteron proteron, certo indotto dalla rima, rispetto all’apparire delle differenti
tipologie di seminatori di discordie: i primi a comparire sono infatti gli scismatici propriamen-te detti.
36. Lana, i p. 784. anche se piú avanti, commentando l’ingresso in scena dei dannati d’altra specie, sembra meno rigoroso: « Poi c’ha ditto l’autore d’i scismatici partidi dalla unione della
il canto della divisione. sintassi e struttura in inf., xxviii
15
turale, l’ordine di comparsa dei sei dannati, raggruppabili a coppie di due:37 prima gli scismatici Maometto e alí, poi i quattro colpevoli di scandalo, Pier da Medicina e curione, Mosca e Bertran, quest’ultimo in realtà collocabile – lo si dirà meglio poi – nella sottocategoria di coloro che crearono divisioni tra parenti.
il profeta fornisce nelle tre terzine (vv. 34-42) una spiegazione didascalica, esauriente, dominata da deittici che sembrano indirizzare l’occhio dell’in-terlocutore: « vedi qui », « son fessi cosí » (si intenderà: nei modi che ha visto, su di lui e alí, e sta vedendo, e che nel resto del canto si osserveranno), « è qua dietro », a dire che Maometto è appena reduce dal perpetuo strazio in-flitto dal diavolo ai dannati che, c’è da immaginare, in fila percorrono la circonferenza della bolgia ripassandogli davanti non appena le ferite si siano rimarginate, e pronte cosí al nuovo « taglio de la spada ». una descrizione, dunque, che si direbbe quasi distaccata, imperturbabile, benché un avver-bio, « crudelmente », e un aggettivo, « la dolente strada », diano forse i primi, tenui indizi di quella pietà per gli orribili scempi che trasparirà soltanto piú avanti, dopo che la rappresentazione dei primi dannati incontrati sarà stata condotta senza alcun segno di partecipazione emotiva da parte di dante.
se si è detto che isma è rima unica, si dovrà aggiungere ora che lemmi in attestazione unica nella Commedia sono proprio le tre parole rima scisma, ac-cisma (‘acconcia, concia’, francesismo di non certa filiazione bertrandiana)38 e risma (letteralmente ‘pacchetto di carte’, arabismo qui in prima attestazio-ne in italiano): rarità si somma a rarità. e cosí un altro francesismo, ma con-notato piú realisticamente, « muse » (dall’antico fr. muser, provenz. muzar,
sancta Madre echesia, qui fa mentione d’alcuni seminaduri de scisma e de scandalo tra le persone » (ivi, p. 794). distinguono nettamente tra le due specie anche le Chiose Palatine: « di-mostrata l’autore la prima qualitade de la presente colpa, cioè de la scisma, dell’altra che vol-garmente si chiama scandalo si tratta, lo quale s’intende lo iscommettere maliziosamente male tra uno e altro » (Chiose Palatine. Ms. Pal. 313 della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, a cura di r. Abardo, roma, salerno editrice, 2005, p. 303). anche uguccione da Pisa sembra definire lo scisma solo in senso religioso: « scisma -tis, quasi dictum a scissura animorum, eo-dem enim cultu et eodem ritu credit scismaticus ut ceteri, solo congregationis delectatur dissidio » (Uguccione da Pisa, Derivationes, ed. critica princeps a cura di e. Cecchini, G. Ar-bizzoni, s. Lanciotti, G. Nonni, M.G. Sassi, a. Tontini, Firenze, Sismel-edizioni del Gal-luzzo, 2004, 2 voll., vol. ii p. 1141, s 253 1).
37. cosí Allegretti, Canto xxviii, cit., pp. 400-1, che giustifica tale suddivisione, suggesti-vamente, nella complementarietà delle piaghe.
38. si trova nel sirventese Be·m platz lo gais temps de pascor (A. Pillet, Bibliographie der Trouba-dours, ergänzt, weitergerführt und herausgegeben von H. Carstens, halle, niemeyer, 1933, 80.8a), in contesto bellico: « chascus deu esser acesmatz »; ma l’attribuzione è contestata. Per altri riferimenti e possibili memorie dantesche, vd. Inglese, p. 317.
mirko volpi
16
‘starsene fermo a guardare’, detto di animali), segna un nuovo passaggio nell’episodio: chi sei tu, chiede Maometto che come spesso accade nell’In-ferno scambia dante per un dannato, che te ne stai lí inebetito a guardarci (lo sprezzante « muse » vuole forse colpire il muto stupore del poeta) e non vai alla pena che ti tocca?
« né morte ’l giunse ancor, né colpa ’l mena »,rispuose ’l mio maestro, « a tormentarlo;ma per dar lui esperïenza piena, a me, che morto son, convien menarloper lo ’nferno qua giú di giro in giro;e quest’ è ver cosí com’ io ti parlo » (vv. 46-51).
in modo del tutto inatteso è virgilio a prendere la parola e a replicare a Maometto, e non con le brevi frasi apodittiche cui altre volte ha fatto ricorso (« vuolsi cosí colà dove si puote », Inf., iii 95, e v 23; « vuolsi ne l’alto… », Inf., vii 11; ecc.),39 ma con una risposta insolitamente esauriente, lunga due terzi-ne, in cui spiega che dante non è ancora morto né è colpevole d’alcunché, e che a lui – che invece morto lo è davvero – è toccato il compito di accom-pagnarlo lungo l’inferno (ed è la piú pura verità) affinché ne abbia « esperïen-za piena », completa, totale. due sono a questo riguardo gli interrogativi.
anzitutto, perché virgilio si sostituisce a dante? secondo il Lana, tale sarebbe il disprezzo di dante verso lo scismatico, cioè verso colui che piú gravemente si macchiò del peccato di divisione, che nemmeno si degna di parlargli: « Qui responde virgillio per dante, e nota che dante no i volse parlare per la impieça del so essere malvase ».40 il che è vero, ma solo in par-te. il poeta fiorentino, diversamente dal solito, in questo canto non si rivolge mai per primo a nessuno spirito (sono loro, sempre, a farsi avanti, strana-mente desiderosi di mostrarsi), ma si limita a sollecitare una delucidazione (vv. 91-93) e si lascia scappare una tutt’altro che gratuita maledizione (v. 109); nel primo e nell’ultimo incontro, non profferisce verbo.
39. Per quanto, si noterà, in tali casi virgilio si rivolga ai custodi infernali per vincerne im-periosamente (e col richiamo alla provvidenzialità di quel viaggio voluto dall’alto) le resisten-ze, e mai ai semplici dannati: il che dà ulteriore rilievo alla singolarità di queste due terzine. Le quali sono scandite nei loro versi iniziali (46 e 49) da due figure etimologiche parallele: « mor-te » / « morto », e le parole rima « mena » / « menarlo ».
40. Lana, i p. 794. se iacomo è tra i pochissimi a porsi la domanda, certo è l’unico a rispon-dersi cosí. dice invece Benvenuto: « et subdit responsionem virgilii ad interrogationem Ma-comethi, quia semper assumit partes autoris, quando responsio videtur spectare ad laudem eius ».
il canto della divisione. sintassi e struttura in inf., xxviii
17
e ancora. Perché virgilio si diffonde tanto?41 Perché una spiegazione cosí dettagliata? È evidente che il cuore della risposta sta nell’affermazione che dante deve trarre una « esperïenza piena » del viaggio.42 non può essere casuale che dante senta il bisogno di certificare proprio qui, tra gli attenta-tori al supremo bene politico e religioso (l’unità della comunità civile e della fede cui egli guardava come alla sola possibilità di un vivere concorde nella pace universale), la necessità della propria missione « in pro del mondo che mal vive ».43 Qui infatti convergono, seppur in pezzi sparsi come i disiecta membra dei dannati, tutti gli elementi cardinali del pensiero sotteso all’elabo-razione del poema e della biografia stessa di dante: lacerti che, tenuti insie-me da nascosti, segreti legami (cfr. Bosco, p. 411), solo piú avanti forse si ri-comporranno.
Piú fuor di cento che, quando l’udiro,s’arrestaron nel fosso a riguardarmiper maraviglia, oblïando il martiro. « Or dí a fra dolcin dunque che s’armi,tu che forse vedra’ il sole in breve,s’ello non vuol qui tosto seguitarmi, sí di vivanda, che stretta di nevenon rechi la vittoria al noarese,
41. Già la Chiavacci Leonardi, p. 839, segnala che solo un’altra volta virgilio spende tante parole per spiegare la natura del viaggio dantesco, cioè a Inf., xii 85-90, nel colloquio (piuttosto simile a questo) con chirone. Ma qui c’è una ragione pratica, funzionale narrativamente, e cioè la captatio benevolentiae per ottenere che un centauro li porti oltre il fiume di sangue in cui stanno immersi i violenti contro il prossimo del settimo cerchio. inoltre, virgilio si rivolge a un demone infernale, non a un peccatore cui generalmente non sarebbero dovute troppe delucidazioni (se non l’informazione sulla condizione di vivente di dante).
42. il medesimo sintagma, seppure invertito nell’ordine dei membri e spezzato da un forte enjambement, compare già al limitare delle Malebolge, al canto xvii: « Quivi ’l maestro “acciò che tutta piena / esperïenza d’esto giron porti”, / mi disse, “va, e vedi la lor mena » (vv. 37-39, con identica rima piena: mena). È sempre virgilio, come si vede, a pronunciarlo, mentre le altre due occorrenze del semplice sostantivo nell’Inferno si trovano nella « orazion picciola » di ulis-se (xxvi 116) e in bocca a dante, desideroso di vedere Briareo (xxxi 99). e, io credo, la piú volte notata presenza massiccia del verbo ‘vedere’, oltre che alla strabiliante natura del tipo di pena qui patita, si potrà direttamente collegare anche proprio a questa dichiarazione di virgi-lio. vd. inoltre quanto dice L. Battaglia Ricci, « Perch’ io parti’ cosí giunte persone, / partito porto il mio cerebro, lasso!… »: ‘imagines agentes’ nella nona e nella decima bolgia, in Esperimenti danteschi. ‘Infer-no’ 2008, a cura di s. Invernizzi, Genova-Milano, Marietti 1820, pp. 223-38, a p. 234: « rispetto al generico “mostrare”, che compare altrove, la formula “dare esperienza piena” veicola im-plicazioni non banali per la Commedia in generale ».
43. si citano, credo a proposito (stante quanto appena affermato), le parole con cui Beatrice (Purg., xxxii 103-5) incarica dante di scrivere, una volta terminato il viaggio.
mirko volpi
18
ch’altrimenti acquistar non saria leve ». Poi che l’un piè per girsene sospese,Mäometto mi disse esta parola;indi a partirsi in terra lo distese (vv. 52-63).
solo a non condividere la « maraviglia » dei dannati nell’udire le parole di virgilio, Maometto dimostra di essere interessato unicamente al fatto che dante possa riferire a un altro scismatico la maligna (cosí la giudica inglese, p. 318) profezia, travestita – si potrebbe dire – da consiglio, enunciata nel corto frammento di tempo necessario a fare un passo.
si sottolineerà subito, nella robusta tessitura sintattica del periodo che occupa i vv. 55-60 (con subordinata di terzo grado), un primo iperbato tra la principale, « dí », e la relativa « tu che… » cui l’imperativo si rivolge, separate da « a fra…s’armi », verbo chiave dell’ammonimento consegnato dal profeta a dante, a sua volta interessato da un nuovo, forte iperbato che lo distanzia (di due interi versi: la già vista relativa e la protasi « s’ello non vuol… ») dal complemento « di vivanda ». torna, inoltre, il verbo ‘vedere’ (« vedra’ », v. 56), preceduto da un « forse » (da collegare per altro a quello del v. 44, sempre usato da Maometto nei confronti di dante), la cui interpretazione corrente, « forse…in breve » (cioè, ‘probabilmente tra poco uscirai dall’inferno’), invi-ta soltanto ad annotare l’ennesimo iperbato; ma di cui si può comunque ri-levare l’ambiguità nella disposizione degli elementi: « forse vedra’ », non è certo che tu ne esca. Benché non possa essere cosí, sembra aumentare la sensazione che tutto il discorso sia percorso da intenti maligni: si procuri cibo a sufficienza, fra dolcino, se vuole resistere d’inverno all’assalto dei crociati che lo stanno assediando sui monti, perché altra strada per la vittoria non ci potrebbe essere. ammonimento sarcastico, parrebbe, stante che dell’eretico novarese, morto sul rogo a vercelli nel 1307, Maometto dovreb-be ben conoscere il destino, in virtú di quell’« antiveder » (v. 78) tipico degli spiriti infernali che invece Pier da Medicina evocherà con piú pietose pa-role.44
il grande profeta dell’islam, dunque, chiama in causa l’oscuro leader della piccola setta ereticale degli apostolici che sarà di lí a poco (rispetto alla data
44. tanto piú s’apprezza il mutamento di tono di Piero, se ne consideriamo l’onestà, per cosí dire, nel non mettere vanamente in guardia, ma nel chiedere al pellegrino di rendere semplicemente edotte le vittime, i « due miglior da Fano », dell’ineluttabile sorte che li atten-de. La fosca rappresentazione di Maometto può passare anche attraverso questi chiaroscuri. Gioverà infine ricordare – lo annota Inglese, p. 318, citando la Historia Dulcini – che fra dolci-no, prima di essere bruciato, fu fatto a pezzi dai carnefici.
il canto della divisione. sintassi e struttura in inf., xxviii
19
fittizia del 1300) sgominata: l’antico profetizza sul moderno e anzi contem-poraneo, in quel già da piú parti ampiamente notato sovrapporsi e confon-dersi dei piani temporali, cosí tipico dell’aldilà costruito da dante. in questo caso, poi, si tratta del primo tassello di una serie di incastri che legheranno, ora piú ora meno copertamente, gli incontri di questa bolgia tanto fitta di personaggi.
L’esplicazione dei nessi necessita però prima del repentino ingresso sulla scena del terzo dannato,45 e secondo a parlare (vv. 64-90):
un altro, che forata avea la golae tronco ’l naso infin sotto le ciglia,e non avea mai ch’una orecchia sola, ristato a riguardar per maravigliacon li altri, innanzi a li altri aprí la canna,ch’era di fuor d’ogne parte vermiglia, e disse: « O tu cui colpa non condannae cu’ io vidi su in terra latina,se troppa simiglianza non m’inganna, rimembriti di Pier da Medicina,se mai torni a veder lo dolce pianoche da vercelli a Marcabò dichina. e fa saper a’ due miglior da Fano,a messer Guido e anco ad angiolello,che, se l’antiveder qui non è vano, gittati saran fuor di lor vaselloe mazzerati presso a la cattolicaper tradimento d’un tiranno fello. tra l’isola di cipri e di Maiolicanon vide mai sí gran fallo nettuno,non da pirate, non da gente argolica. Quel traditor che vede pur con l’uno,e tien la terra che tale qui mecovorrebbe di vedere esser digiuno, farà venirli a parlamento seco;poi farà sí, ch’al vento di Focaranon sarà lor mestier voto né preco ».
senza commenti da parte di dante o “terzine-cuscinetto” cosí frequenti nella Commedia tra episodio ed espisodio, si presenta alla ribalta un nuovo
45. il quarto, se consideriamo come fra dolcino sia stato evocato come futuro abitante della nona bolgia.
mirko volpi
20
spirito, anche lui « ristato a riguardar per maraviglia » la presenza di un vivo nell’oltretomba: il v. 67 ricalca quasi ad verbum i vv. 53-54, come a richiamare quello stupore che solo Maometto non pareva avvertire e che però il suo ammonimento all’eretico novarese non non era riuscito a rimuovere. il pec-catore ha la gola forata e mozzati il naso e un orecchio;46 viene raffigurato, come i due precedenti, senza accenni di pietà che temperino l’orrore de-scrittivo di quella « canna » squarciata (ancora una degradazione dell’umano a mera anatomia) da cui parla, e anzi da cui sembrano sgorgare le parole tra fiotti di sangue « vermiglio ».
tale avvento si realizza, ancora, in piena consonanza con la piú significan-te figura retorica del canto: infatti, un forte iperbato (vv. 64 e 68) separa il soggetto, « un altro », dal sintagma verbale « aprí la canna », grazie a tre versi, ciascuno dedicato alla descrizione delle tre ferite (gola, naso, orecchia),47 e a un quarto, quello sopra ricordato in funzione di ripresa, il v. 67. con proce-dimento di complicazione sintattica già osservato altrove, al v. 68 si concen-tra poi anche un chiasmo, « ristato…con li altri » e « innanzi a li altri aprí », giocato per di piú sull’anafora che riecheggia, allungando la catena di ripre-se, l’avvio di periodo: « un altro ».
il fuoco del canto comincia qui a posizionarsi in modo deciso attorno ai motivi che piú coinvolsero il poeta. Ora si parla infatti delle contrade di romagna e con uno che addirittura conobbe dante personalmente: Pier da Medicina, personaggio non altrimenti noto, forse dei « cattani », cioè dei si-gnori di Medicina (località tra Bologna e imola), di cui abbiamo solo pochis-sime e non certe testimonianze riferiteci dagli antichi esegeti.48 non sappia-mo con precisione chi fu né come si adoperò fattivamente per seminare scandalo, ma vediamo che si rivolge a dante con un’autopresentazione (« ri-membriti di Pier da Medicina ») che richiama quella di un altro celebre per-
46. Allegretti, Canto xxviii, cit., p. 400, nota che « è figura di trapasso dai forati ai moz-zi ».
47. si rileverà, in tale descrizione puntuale della pena, l’ennesima variatio al v. 66, « non avea mai ch[e] », dopo l’impiego nei due versi precedenti di due participi passati, « forata » e « tron-co ».
48. il piú prodigo di informazioni, come non mancano di rilevare i commentatori moder-ni, è Benvenuto da imola (basti rimandare a Chiavacci Leonardi, ad locum, e Baldelli, « Lo dolce piano », cit., pp. 198-99). Piú sintetico il Lana che, da bolognese, sottolinea le discordie che interessarono la sua città (e non fa menzione, come si vede, dell’azione malevola che Piero avrebbe condotto per mettere zizzania tra ravenna e rimini): « e ’l primo ch’el vide fo Piero d’i catanii da Medesina, ch’è nel contado de Bologna, lo qual foe molto corrotto in quel vitio sí de seminar scandalo tra i nobili bolognisi, come etiamdeo tra romagnoi e Bolognisi » (La-na, i p. 794).
il canto della divisione. sintassi e struttura in inf., xxviii
21
sonaggio, quasi altrettanto ignoto (per quanto forse non alle cronache dell’epoca), ma immortalato in tutt’altro contesto, ossia Pia de’ tolomei. Piero chiede infatti con cortesi, dolenti parole il ricordo (ed è singolare, ma ancor piú il fatto che non sarà qui caso isolato) e il racconto perde per un attimo il tono aspro e violento che lo domina.
La richiesta del dannato si sviluppa nuovamente, come già avvenuto ai vv. 64-69 e nell’ultima parte del discorso di Maometto (vv. 55-58), attraverso una forte divaricazione sintattica: il verbo principale, « rimembriti » (paralle-lo, si è detto, al « ricorditi » di Pia), si trova separato dal « tu » vocativo e dalla sua apposizione da due versi (vv. 71-72) « che contengono a incastro due subordinate, la seconda subordinata alla prima »;49 e racchiuso da due prota-si all’apparenza sullo stesso piano: se la prima (v. 71), « se troppa… », introdu-ce un’ipotetica della realtà (‘se non mi inganno, ti ho visto quando ero vivo’: cioè, ne sono ben certo), la seconda (v. 73), « se mai torni… », presenta una sfumatura ambigua, eventuale (‘nel caso tu torni…’: e si può riallacciare all’obliquo « forse » del v. 44). altro punto di contatto con le parole usate dal profeta dell’islam, la presenza insistita del verbo ‘vedere’ (vv. 71 e 74), ribat-tuta e amplificata nelle terzine seguenti.
come detto, però, il tono è ben diverso. Pier da Medicina mostra sofferta e direi delicata nostalgia del mondo dei vivi: « lo dolce piano / che da vercel-li a Marcabò dichina ». in questa che si può forse definire la prima definizio-ne in letteratura della Pianura Padana, si noteranno due cose. anzitutto, l’aggettivo « dolce » (ultima presenza infernale in bocca a dannati, penultima assoluta nella cantica),50 di solito usato come attributo per virgilio o, appun-to, per rievocare dolorosamente i luoghi natii: il « dolce mondo » (Inf., vi 88; x 82) o la « dolce terra / latina » di Guido da Montefeltro a Inf., xxvii 26-27, anche qui in clausola, e proprio in riferimento alla romagna (né sarà l’unico collegamento al canto xxvii). La seconda notazione riguarda invece la non scontata perifrasi, « di assoluto realismo geografico-storico »,51 con cui dan-te, per il tramite del seminatore di scandalo, definisce la val Padana; se inu-suali ci appaiono infatti a un primo sguardo gli estremi con cui la designa, assai piú pertinenti ci sembreranno se consideriamo come essi fungano da legame interno alla struttura e intimamente connesso al senso dell’episodio. vercelli infatti si ricollega all’appena sopra ricordato fra dolcino, che fu ap-
49. Beltrami, Metrica, cit., p. 21.50. L’ultima, a xxxi 69, dante la usa, ma in negativo, in riferimento all’oscura parlata di
nembrot, « cui non si convenia piú dolci salmi ».51. Baldelli, « Lo dolce piano », cit., p. 197.
mirko volpi
22
punto giustiziato nella città (oggi) piemontese, mentre Marcabò, località alle foci del Po, vicino a ravenna, oltre che ricondurci con decisione all’area romagnola protagonista di questo e dei seguenti snodi narrativi, ci rimanda alle discordie che interessavano la zona, addirittura in presa diretta: la forti-ficazione, infatti, costruita dai veneziani, era stata assediata e abbattuta dai guelfi romagnoli guidata dai Polentani nel 1309,52 cioè pochissimo prima della stesura di questo canto. il collante geografico, sullo sfondo robusta-mente storico, di nuovo si dispiega tra le lacerazioni con funzionale eviden-za e sempre a vantaggio di quella forte storicità e “contemporaneità” di cui, sulla scorta di chiavacci Leonardi, si diceva.
esaurita la presentazione e la preghiera di ricordo, Pier da Medicina affi-da a dante un avvertimento, un’altra specie di profezia indirizzata « a’ due miglior da Fano », cosí come Maometto aveva fatto per fra dolcino. Ma i parallelismi, come usuale in dante, non sono mai piattamente uniformi né monotonamente rispondentisi: se il profeta si riferiva a chi presto sarebbe giunto tra i peccatori della nona bolgia, il romagnolo vuole rivolgersi alle vittime dell’inganno. Mentre al v. 57, « s’ello non vuol qui tosto seguitarmi », Maometto ispessisce la già notata ombra di malignità fingendo di supporre che ci sia per l’eretico ancora vivo possibilità di vittoria; l’analoga ipotetica del v. 78, « se l’antiveder qui non è vano », non mette subdolamente in dub-bio il tragico delitto destinato a compiersi, ma lo conferma (con la dichiara-zione a chiare lettere, peraltro, della facoltà profetica dei dannati che invece Maometto pareva aver volontariamente obliterato).53
Fa’ sapere (dice dunque Piero) a Guido del cassero e ad angiolello da carignano, di Fano entrambi,54 che, chiamati a convegno nei pressi di cat-
52. cfr. a. Cecilia, s.v. Marcabò, in ED, vol. iii 1971, p. 821; Inglese, p. 319, che cita un’anti-ca cronaca forlivese; e ovviamente ancora Baldelli, « Lo dolce piano », cit.
53. non mi sembra pertanto accoglibile l’interpretazione di v. Rossi, Commento alla ‘Com-media’, con la continuazione di s. Frascíno, a cura di M. Corrado, roma, salerno editrice, 2007, 3 voll., vol. i p. 484, secondo cui « l’animo » di Pier, « cattivo nel fondo, si manifesta […] nel funereo motteggio (vv. 89-90) in cui si risolve il simulato orrore del tradimento (vv. 86-87), e nella malignità sopraffina di un’allusione (vv. 86-87) […] ». né un’altra lettura psicologizzante come quella del Momigliano (Dante Alighieri, La Divina Commedia, commentata da a. Momigliano, Firenze, sansoni, 1957, p. 216): « Pier da Medicina è un dannato d’umor nero; che il ricordo della terra lo punge di tenerezza, e per contrasto gli fa sentire di piú la sua sven-tura; che quindi tutto quello che egli dice in seguito, fermenta dalla sua anima in tempesta e vien fuori in un impetuoso crescendo che culmina in quel disumano dar di piglio alla mascel-la del compagno e metterne a nudo l’orrenda mutilazione ».
54. di questi misteriosi personaggi è il romagnolo Benvenuto da imola, come si sa, a indi-care le due famiglie d’appartenenza; Pietro alighieri, nella prima redazione del suo commen-to, definisce Guido iudex.
il canto della divisione. sintassi e struttura in inf., xxviii
23
tolica, saranno traditi e gettati in mare per opera di un « tiranno fello ». chi sia costui però non viene detto, ma rimandato dopo l’inserzione di una si-militudine geografica (vv. 82-84), come le precedenti insufficiente: nell’in-tero Mediterraneo – indicato con le due isole che ne segnano i confini, ci-pro e Maiorca55 – nessuno vide mai delitto peggiore.
L’identità del traditore viene quindi svelata, ma ecco l’ennesimo incastro: nell’indicare con perifrasi Malatestino da rimini, Pier da Medicina men-ziona in maniera fortemente allusiva un dannato accanto a lui, « tale qui meco », che avrebbe preferito non vedere mai rimini (« vorrebbe di vedere esser digiuno »), ma subito torna a descrivere il modo in cui il « tiranno fel-lo » (che diventa il « traditor » del v. 85, con ripresa in figura etimologica di « per tradimento » del v. 81) ingannerà i due da Fano, attirati nella trappola di un abboccamento per trattare la pace. a quel punto, nemmeno invocare la clemenza dell’insidiosissimo vento che spira da Focara, noto all’epoca per quanto sapesse mettere a repentaglio le navigazioni in quel tratto di mare, servirà a Guido e angiolello a evitare la morte. L’efferato tiranno è dunque quel Malatestino già citato con disprezzo nel canto precedente come il « mastin…nuovo » (xxvii 46; assieme col padre, il « vecchio…da verruc-chio ») e ora invece identificato come colui « che vede pur con l’uno », cioè privo di un occhio: la variatio permette a dante di infittire un’altra volta le occorrenze di ‘vedere’ in pochi versi (sono tre, tra il v. 83 e il v. 87)56 e forse anche di far partecipare il signore di rimini del clima della bolgia ricordan-done la menomazione fisica, che qui è legge divina per il piú esplicito dei contrappassi.57 Manca in effetti, tra la varia mutilazione enumerata, il guer-cio; ma è solo una suggestione: come noto, gli odiati Malatesta sono già destinati da dante al cerchio piú basso, quello dei traditori. e dunque questa reiterata chiamata in causa del tiranno avrà la funzione di mette re ulterior-mente in rilievo il cruciale tema delle faide tra città, della perenne divi-sione.
resta però in sospeso l’identità dell’altro dannato alluso da Piero, il cui fugace cenno non era certo sfuggito a dante (vv. 91-102):
55. La memoria, oltre alla precedente perifrasi della Pianura Padana, corre anche al tragitto di ulisse, che attraversò l’intero bacino del Mediterraneo (la « gente argolica » del v. 84 sono infatti i perfidi e superbi « greci » di Inf., xxvi 75). L’impiego dei poli estremi nelle indicazioni geografiche, per quanto consueto, contribuisce a segnalare la separazione tra i due punti (la divisione, la frattura) e, ad un tempo, la sottesa unità cui mirare.
56. variazione nella variazione, sono gli unici tre casi di ‘vedere’ di tutto il canto il cui sog-getto non sia dante.
57. cosí anche in Montanari, Il canto xxviii, cit., p. 46.
mirko volpi
24
e io a lui: « dimostrami e dichiara,se vuo’ ch’i’ porti sú di te novella,chi è colui da la veduta amara ». allor puose la mano a la mascellad’un suo compagno e la bocca li aperse,gridando: « Questi è desso, e non favella. Questi, scacciato, il dubitar sommersein cesare, affermando che ’l fornitosempre con danno l’attender sofferse ». Oh quanto mi pareva sbigottitocon la lingua tagliata ne la strozzacurïo, ch’a dir fu cosí ardito!
il poeta, tornando con efficacissimo e densissimo sintagma a quello dalla « veduta amara », reclama che glielo si mostri, con la promessa – che riprende il « rimembriti » del v. 73 – di portare « sú di te novella ». Pier da Medicina esegue, spalancando con le mani la bocca del « compagno », il quale « non favella », e parlando dunque in sua vece. La ragione di ciò è lasciata in sospe-so per quattro versi (ancora un ritardo, un incastro), finché si capisce che lo sventurato ha « la lingua tagliata ne la strozza » (v. 101): di nuovo si accampa sulla scena l’orrore dei corpi straziati. Questi è colui che spezzò gli indugi di cesare, inducendolo a varcare il rubicone, atto che avrebbe dato il via alla guerra civile a roma. si tratta di curione, riconosciuto immeditamente dalla frase sentenziosa « ’l fornito / sempre con danno l’attender sofferse » (mutuata, come fu colto già dal Bambaglioli, da Lucano),58 il tribuno della plebe il cui malevolo consiglio viene punito qui col taglio della lingua. co-me fu « ardito », ora è « sbigottito »: e su questa sarcastica e in un certo senso antinomica rima, termina non solo l’episodio, ma la prima, ampia sezione del canto.59
L’incontro con Pier da Medicina induce ora a considerare il parallelismo quasi perfetto con quello con Maometto, in termini di alternanza della di-
58. Lucani Phars., i 681: « tolle moras; semper nocuit differre paratis ». Questa stessa citazio-ne lucanea, è stato altrove notato, viene utilizzata da dante nell’Epistola vii in termini affatto diversi, cioè per spronare l’imperatore enrico vii ad azioni risolutive contro Firenze: « into-net iterum vox illa curionis in cesarem: dum trepidant nullo firmate robore partes, / tolle moras […] » (Ep. vii, 16).
59. si aggiungerà che curione, come da racconto lucaneo, dopo essersi battuto valorosa-mente fu ucciso dai soldati di Giuba e il suo corpo dilacerato dagli uccelli: « Libycas en nobile corpus / pascit aves, nullo contectus curio busto » (Lucani Phars., iv 810-11).
il canto della divisione. sintassi e struttura in inf., xxviii
25
mensione storica e di dialettica all’interno della strutturazione dell’epi-sodio.
infatti, l’antico Maometto profetizza su un moderno, fra dolcino, e mo-stra al contempo un altro antico, alí. il contemporaneo Pier da Medicina mostra a sua volta un antico, curione (muto al pari del proprio corrispettivo alí), quindi profetizza su moderni (cioè i due da Fano e Malatestino). in questo duplice movimento si rimarcherà inoltre la disposizione a chiasmo dei differenti momenti: il primo dannato mostra e poi emette la profezia, il secondo viceversa. tali momenti sono legati – nella dimensione storica che diventa eterna nell’aldilà, col passato (ed è ciò che piú conta) che si fa misu-ra del presente – anche da fattori geografici (e idrografici): vercelli, come detto, che digrada lungo il corso del Po da fra dolcino verso il romagnolo Pier da Medicina; e la rimini di Malatestino, evocato da Piero, che porta da questi a curione, al rubicone (sito in territorio riminese) varcato dietro suo consiglio.
Ma piú denso ancora ci può apparire l’intreccio nella successione dei pec-catori (presenti o evocati, parlanti o solo additati). se infatti consideriamo la serie delle figure, troveremo Maometto (alí)-dolcino + Pier (i due fanesi e Malatestino)-curione, cioè l’antichità e il presente + il presente e l’antichità, con ennesimo chiasmo ribattuto dal fatto che i due agli estremi rimandano a una dimensione universale (l’eresia che spaccò la fede cattolica e la guerra civile all’interno dell’impero romano), mentre i due centrali riguardano fratture minori, discordie locali limitate nello spazio (ma non per questo di minor conto nell’ideale dantesco).
a questo punto del canto è come se un primo blocco fosse perfettamente concluso e si potesse passare ora alle due, anzi tre, figure qui investite di si-gnificati in un certo senso ancor piú pregnanti. nonostante il sopradetto andamento chiastico, a incastri, non si poteva non notare, infatti, la diretta progressione del canto verso ciò che « tocca dante piú acutamente e violen-temente »,60 e cioè la dimensione fiorentina e sua personale, addirittura pa-rentale.
si leggano allora i vv. 103-11:
e un ch’avea l’una e l’altra man mozza,levando i moncherin per l’aura fosca,sí che ’l sangue facea la faccia sozza, gridò: « ricordera’ti anche del Mosca,
60. Chiavacci Leonardi, Il canto xxviii, cit., pp. 53-54.
mirko volpi
26
che disse, lasso!, “capo ha cosa fatta”,che fu mal seme per la gente tosca ». e io li aggiunsi: « e morte di tua schiatta »;per ch’elli, accumulando duol con duolo,sen gio come persona trista e matta.
di nuovo, come fanno tutti in questa bolgia, è il dannato che spontanea-mente si palesa. e la struttura sintattica con cui viene presentato rispecchia quella impiegata per l’ingresso di Pier da Medicina, ossia con un iperbato che separa il soggetto « e un », posto in apertura di terzina e seguito dalla relativa (v. 103), dal verbo « gridò » del v. 106 (come là era stato per « un altro, che… aprí » ai vv. 64 e 68).
La corsa al riconoscimento cercato dal peccatore stesso passa, come già aveva fatto Pier da Medicina, attraverso la richiesta del ricordo: « ricorde-ra’ti » (v. 106), di contro al « rimembriti » del v. 73. analogamente, la frase sentenziosa « capo ha cosa fatta » crea il punto di contatto – e si è visto come ogni segmento del canto sia legato al precedente da elementi formali e strut-turali – col contiguo episodio di curione, di cui appunto si “volgarizza” il tolle moras. e tanto era bastato per un’identificazione che qui invece risuona a fine verso nel nome del dannato che si denuncia: Mosca, ghibellino, della famiglia fiorentina dei Lamberti, infausto suggeritore della vendetta ai dan-ni del giovane Buondelmonte dei Buondelmonti, colpevole di aver rotto un patto matrimoniale, nel 1216. colpa foriera di sviluppi drammatici, ossia le lotte cruente che segnarono in Firenze il resto del secolo, e oltre; colpa di cui è consapevole: « lasso! », esclama Mosca prima di confessare il peccato. al che dante replica con estrema, non gratuita durezza: in lui il poeta fuggia-sco ritrova la radice da cui germinò il suo stesso esilio.
dunque in queste tre terzine irrompe finalmente Firenze, sotto la specie terrificante di uno spirito che, le mani mozzate, levando in alto i « monche-rin » si insozza il viso col sangue che ne esce. se tutti i dannati facilitano a dante la visione delle loro membra straziate, è pur vero che qui il mostrare a quel modo le ferite (necessario, sí, perché il pellegrino le noti) comporta un insudiciamento del volto di forte impatto, turpe sovraccarico di pena, ulteriore accumulo di « duolo ».
Quasi che il Mosca, all’origine dei mali cittadini e dei lutti patiti dalla propria ma anche dalle altre famiglie fiorentine, possa simboleggiare icasti-camente – in questa immagine di colui che per alzare i polsi sanguinanti (memoria del colpo omicida?) non fa che imbrattare sé stesso – la maledi-zione evangelica sui responsabili della morte di cristo: « il suo sangue ricada
il canto della divisione. sintassi e struttura in inf., xxviii
27
sopra di noi e sopra i nostri figli ».61 non incongruo potrà forse sembrare il collegamento se si pensa che l’espressione « mal seme » (v. 108) si trova, di poco variata, a Inf., xxiii 123, a indicare il comportamento ipocrita di caifa che aveva cooperato alla condanna di Gesú: « che fu per li Giudei mala se-menta »; praticamente sovrapponibile a « che fu mal seme per la gente to-sca ». e l’allusione nel canto xxiii alla distruzione del tempio da parte di tito e alla dispersione che gli ebrei patirono riecheggia cosí nella « morte di tua schiatta », nel tragico esito del cattivo consiglio: la sconfitta e la cacciata dei Lamberti e degli uberti e della loro parte politica, ma assieme la condanna di un’intera città devastata da odii intestini che – ultimo, doloroso effetto – avrebbero portato all’esilio dello stesso dante.
Mosca è responsabile di discordia civile, ma allo stesso tempo, si può af-fermare, di divisione tra parenti (avendo scatenato lo scontro tra famiglie): la sua posizione fa dunque da cerniera all’apparizione dell’ultimo dannato, classificabile nella sottospecie di coloro che misero zizzania tra congiunti, in particolare tra padre e figlio. vale a dire, il poeta provenzale Bertran de Born (vv. 112-42):
Ma io rimasi a riguardar lo stuolo,e vidi cosa ch’io avrei paura,sanza piú prova, di contarla solo; se non che coscïenza m’assicura,la buona compagnia che l’uom francheggiasotto l’asbergo del sentirsi pura. io vidi certo, e ancor par ch’io ’l veggia,un busto sanza capo andar sí comeandavan li altri de la trista greggia; e ’l capo tronco tenea per le chiome,pesol con mano a guisa di lanterna:e quel mirava noi e dicea: « Oh me! ». di sé facea a sé stesso lucerna,ed eran due in uno e uno in due;com’ esser può, quei sa che sí governa. Quando diritto al piè del ponte fue,levò ’l braccio alto con tutta la testaper appressarne le parole sue, che fuoro: « Or vedi la pena molesta,tu che, spirando, vai veggendo i morti:
61. Matth., xxvii 25: « sanguis eius super nos et super filios nostros ».
mirko volpi
28
vedi s’alcuna è grande come questa. e perché tu di me novella porti,sappi ch’i’ son Bertram dal Bornio, quelliche diedi al re giovane i ma’ conforti. io feci il padre e ’l figlio in sé ribelli;achitofèl non fé piú d’absalonee di davíd coi malvagi punzelli. Perch’ io parti’ cosí giunte persone,partito porto il mio cerebro, lasso!,dal suo principio ch’è in questo troncone. cosí s’osserva in me lo contrapasso ».
Prima di descrivere l’incredibile mutilazione di Bertran, dante introduce una pausa, due terzine (vv. 112-17) in cui ribadisce la veridicità di ciò cui as-sistette appellandosi alla propria « coscïenza », sicura arma di difesa (« asber-go ») e protezione per chi, come lui, l’ha « pura », retta. Piú volte, è stato os-servato, dante ricorre a simili dichiarazioni in prossimità degli episodi piú portentosi. Bosco, p. 412, collega appunto questi vv. 113-17 ad altre garanzie di veridicità nell’Inf., cioè a xvi 124 sgg., e xxv 46-48: ma sono appelli diretti al lettore, cioè un giuramento e la giustificazione preventiva rivolta a chi avrebbe avuto difficoltà a credere tale meraviglia (concetto che torna in entrambi i luoghi). Qui invece non è cosí, non si tratta di un appello al let-tore, ma di un piú intimo richiamo alla propria coscienza, che il dante-au-tore, nell’atto quindi di riferire del viaggio, mai chiama in causa a sostegno della verità narrata, se non in questo passo. dove torna inoltre ad essere impiegato con insistenza il verbo ‘vedere’ (oltre al sinonimo « riguardar », v. 112): « vidi » (v. 113), « vidi » e « veggia » (v. 118), cui segue un nuovo accumulo nell’attacco di discorso di Bertran, « vedi…veggendo…vedi » (vv. 130-32), al pari di quanto osservato nelle parole di Maometto e Pier da Medicina.62
L’ultima, stupefacente entrata in scena vede protagonista un dannato che porta in mano, « a guisa di lanterna », il proprio capo. O meglio: dante dice di vedere non una figura umana, ma un « busto sanza capo », nemmeno un dannato menomato, ma solo una parte del corpo, un semplice troncone umano; dopo le reificazioni iniziali, torna qui sul finale qualcosa di non umano, di miracolosamente scisso, tanto che come ciò possa accadere lo sa solo dio (v. 126). si tratta di Bertran de Born, celebre trovatore del sec. Xii, che esordisce con un lamento: « Oh me! » (con la sopranotata rima fran-
62. senza dire delle ulteriori figure di disposizione, cioè dei chiasmi in serie ai vv. 118 e sgg.: « vidi certo » e « ancor par…veggia »; « un busto…andar » e « andavan li altri »; « due in uno e uno in due ».
il canto della divisione. sintassi e struttura in inf., xxviii
29
ta),63 dolente preludio alla piena ammissione di responsabilità che segnerà le terzine finali del canto, preceduta, è bene ribadirlo, dal consueto invito ad essere ricordato (« e perché tu di me novella porti »; v. 133). il poeta, se-condo quanto dante desume dalle antiche biografie trobadoriche che lo volevano seminatore di discordia, avrebbe istigato il figlio contro il padre, cioè enrico, detto il « re giovane », contro enrico ii d’inghilterra, di cui Bertran stesso era suddito in quanto feudatario del Périgord.
Lo stile torna a innalzarsi, come ad inizio canto (e proprio sotto il segno dell’ispiratore dell’immagine di carneficina della prima similitudine), e si fa tragico, intessuto di echi biblici, in particolare ai vv. 124-25 (« di sé facea a sé stesso lucerna, / ed eran due in uno e uno in due »), dove si rinverrebbe una struttura del simbolo niceno (« lumen de lumine deum verum de deo ve-ro »),64 o ai vv. 130-32, che richiamano movenze (già presenti nella Vita Nuo-va) proprie delle Lamentationes di Geremia.65 e del medesimo àmbito è l’ul-tima similitudine, imperfetta e insufficiente “a dire”, come tutte le prece-denti, col richiamo veterotestamentario ad achitofèl che aizzò assalonne contro il padre davide.
È nella chiusa del canto (vv. 139-42) che emerge in modo netto la piena coscienza da parte di Bertran del proprio peccato, che culmina nella defini-zione del « contrapasso » (prima e unica menzione, come noto, della ratio che informa la legge penale dell’Inferno),66 che proprio in lui, « cosí », cioè con tale lampante evidenza, « s’osserva » (con finale rimando alla sfera semantica dominante della nona bolgia, quella del ‘vedere’). La « consapevolezza etica
63. Picone, I trovatori, cit., p. 92, individua una riferimento proprio nel già citato sirventese di Bertran, Be·m platz, al v. 43: « a lor! », in rima con sabor.
64. Allegretti, Canto xxviii, cit., p. 404 (cui si rimanda per altri numerosi riferimenti al nuovo testamento), osserva: « La sua colpa, e perciò anche la sua pena, vengono descritte con formule del rapporto di filiazione tra Padre e figlio della trinità »; e sotto questa luce acquisirà maggior senso il riferimento a dio del verso seguente, il 126, « com’ esser può, quei sa che sí governa », cioè il signore (« Quei », maiuscolo, allora) conosce bene il modo in cui tale mera-viglia possa avvenire, ma soprattutto soltanto Lui conosce a pieno il mistero del Figlio, vero dio e vero uomo. Questa notazione scritturale si può cosí aggiungere a quelle proposte per Maometto-Giuda e Mosca-caifa. inevitabile, poi, il rinvio a Inf., xxv 77-78: « due e nessun l’imagine perversa / parea ».
65. cfr. Chiavacci Leonardi, p. 852.66. sono state chiamate qui memorie bibliche, per la legge del taglione, e anche evangeli-
che (come fa Montanari, Il canto xxviii, cit., p. 40), cioè Matth., vii 2, « in qua mensura mensi fueritis remetietur vobis » (questa peraltro già almeno dal commento ottocentesco di raffael-lo andreoli:); e xxvi 52: « omnes enim qui acceperint gladium gladio peribunt ». Ma vd. al ri-guardo la diversa interpretazione di d. Bolognesi, Il contrappasso come chiasma. Appunti su ‘In-ferno’ xxviii, in L’a, n.s., a. li 2010, n. 36 pp. 5-20.
mirko volpi
30
del male commesso e della giustizia della pena subita »67 viene rimarcata, formalmente, nell’esibito ricorso alla figura etimologica e ad anafore ai vv. 139-40 (« parti’…partito porto »), e quindi in quell’esclamazione, « lasso! », che prima era stata profferita da Mosca. solo loro due, infatti, dichiarano la gravità delle loro azioni e prendono atto della colpa: Bertran – tra l’altro l’unico di questi peccatori a parlare di sé in prima persona – con piú piena e articolata confessione, mentre Mosca piú copertamente, piú allusivamente. certo è che gli altri dannati che prendono la parola, lo si è anticipato, nem-meno dicono ciò che commisero.68
eppure tutti, senza eccezioni, si fanno avanti, si mostrano, invitano a os-servare e aiutano il visitatore a vedere meglio, cooperano attivamente a che dante abbia quell’« esperïenza piena », totale, unitaria. contrappasso nel contrappasso, si prodigano per squadernare le proprie ferite e palesare la propria identità, il proprio gravissimo peccato, in un modo affatto unico nel basso inferno. e se tanto si è insistito sulla presenza, piú o meno nascosta, di legami (come quest’ultimo tra i molti sopra rilevati) che connettono le di-verse parti del canto, ne andrà allora messo in luce un altro, che accomuna tre figure, cioè il fatto che tutte e tre in precedenza erano state elogiate e ammirate in varia misura da dante: curione, il cui persuasivo discorso a cesare, lo si è detto, viene sfruttato nell’Epistola vii; Mosca, nominato a Inf., vi 81, tra coloro « ch’a ben far posero li ’ngegni »; e infine Bertran, celebrato sia nel De vulgari eloquentia come sommo cantore delle armi (ii 2 9) sia nel Convivio come esempio di liberalità (iv 11 14).69 il canto (e anzi la serie di canti dedicati in modo speciale ai peccatori di lingua) si chiude dunque sul trovatore, celebrato modello di poesia della salus (la materia bellica su cui proprio qui dante entra in vistosa competizione) e notabile esempio di virtú laiche non bastevoli però, come per tanti altri condannati dall’inappel-labile giudizio dantesco, alla salvezza.
Ma al quadro fino a qui proposto manca un elemento, quello legato in
67. Chiavacci Leonardi, p. 853. andrà poi notato che, a racchiudere circolarmente il can-to anche sotto quest’altro aspetto, al primo e all’ultimo dannato viene affidato il compito di dichiarare apertamente il modo (Maometto) e le ragioni (Bertran) di siffatta pena.
68. vd. Picone, I trovatori, cit., p. 93: « ciò che è piú rilevante ai fini della lettura dantesca è però il fatto che l’immagine globale, sintetica, che la produzione di Bertran veicola è quella di una poesia che non indirizza verso l’unione, ma predilige anzi la divisione. La vida e le razos sono piene di allusioni al potere straordinario che il dire di Bertran esercitava sui potenti ».
69. Lo ha già notato Allegretti, Canto xxviii, cit., p. 403, che osserva: « se si tratta di pali-nodie, non semplificano certo con un semplice cambio di segno problemi assai complessi ».
il canto della divisione. sintassi e struttura in inf., xxviii
31
modo piú stretto alla sfera personale. Manca se ci fermiamo al v. 142, alla potente evocazione del « contrapasso » che induce (come in altri canti chiusi senza piú dalle parole di personaggi di particolare rilievo, come ulisse, o altri poeti quali arnaldo daniello e Folchetto di Marsiglia, per non dire di Giustiniano, o di cacciaguida, addirittura per tutti e tre i canti di cui è prota-gonista) a considerare esaurito l’episodio o il passaggio in questa zona dell’ol-tremondo. cosí però non è, perché la nona bolgia non termina col canto xxviii, come si sa, proseguendo invece per i primi 36 versi del seguente.
La molta gente e le diverse piagheavean le luci mie sí inebrïate,che de lo stare a piangere eran vaghe. Ma virgilio mi disse: « che pur guate?perché la vista tua pur si soffolgelà giú tra l’ombre triste smozzicate? tu non hai fatto sí a l’altre bolge;pensa, se tu annoverar le credi,che miglia ventidue la valle volge. e già la luna è sotto i nostri piedi;lo tempo è poco omai che n’è concesso,e altro è da veder che tu non vedi ». « se tu avessi », rispuos’ io appresso,« atteso a la cagion per ch’io guardava,forse m’avresti ancor lo star dimesso ». Parte sen giva, e io retro li andava,lo duca, già faccendo la risposta,e soggiugnendo: « dentro a quella cava dov’ io tenea or li occhi sí a posta,credo ch’un spirto del mio sangue piangala colpa che là giú cotanto costa ». allor disse ’l maestro: « non si frangalo tuo pensier da qui innanzi sovr’ ello.attendi ad altro, ed ei là si rimanga; ch’io vidi lui a piè del ponticellomostrarti e minacciar forte col dito,e udi’ ’l nominar Geri del Bello. tu eri allor sí del tutto impeditosovra colui che già tenne altaforte,che non guardasti in là, sí fu partito ». « O duca mio, la vïolenta morteche non li è vendicata ancor », diss’ io,« per alcun che de l’onta sia consorte,
mirko volpi
32
fece lui disdegnoso; ond’ el sen giosanza parlarmi, sí com’ ïo estimo:e in ciò m’ha el fatto a sé piú pio ».
il canto xxix – il cui incipit, « La molta gente e le diverse piaghe », ripren-de con funzione ricapitolativa l’inizio del xxviii – si trova immediatamente calato in un clima, anzitutto formale e tonale, affatto differente. nonostante la sporadica presenza iniziale di rime ricche e rare (aghe, unica nell’Inf., olge), la tensione stilistica del canto xxviii – oscillante tra gli estremi del tragico, intessuto di memorie virgiliane e bertrandiane, e del crudamente realistico ed espressivo – cede il campo a un andamento che, nonostante mantenga alta la drammaticità della bolgia in cui ancora ci si trova, si fa piú disteso, piano, in qualche modo funzionale alla pietà che finalmente può prorom-pere dal dante personaggio.
egli ha infatti gli occhi, le « luci…inebrïate », desiderose addirittura di « piangere », e l’eccezionalità del fatto viene sottolineata da virgilio, « tu non hai fatto sí a l’altre bolge » (v. 7), che lo esorta al contempo a non indu-giare oltre. dante si giustifica spiegando che « dentro a quella cava […] cre-do ch’un spirto del mio sangue pianga » (vv. 18-20); vale a dire, come certifi-ca viriglio che ne aveva sentito il nome, Geri del Bello, cugino del padre di dante, morto ammazzato alla fine del ’200. Questi, mentre il poeta era « im-pedito » nell’incontro con Bertran, lo minacciava « forte col dito » (v. 26), perché, si chiarisce piú avanti, « la vïolenta morte…non li è vendicata ancor » (vv. 31-32). dante, illustrando cosí (ma non giustificando) le ragioni per cui il parente era tanto « disdegnoso » da non volergli nemmeno parlare, dichia-ra che ciò lo ha reso addirittura « pio ». La straordinarietà della presenza di un simile aggettivo a questo punto dell’Inferno viene amplificata dal fatto che nella prima cantica il poeta lo usa, parlando di sé, solo qui e nel canto v (« tri-sto e pio », v. 117: il riferimento è ovviamente alla dolorosa vicenda di Fran-cesca da rimini): si tratta quindi, con tutta evidenza, di un segnale di parti-colare importanza.
con escamotage narrativo unico nella Commedia, uno spirito viene presen-tato soltanto dopo la sua effettiva comparsa in scena, che viene cosí prima allusa da un dante turbato e a posteriori perfezionata nel racconto che ne fa virgilio, il quale rende edotto il pellegrino del gesto minaccioso di Geri. tale espediente vuole ribadire il netto distacco tra i due parenti, che risulta-no cosí non essersi né incontrati né parlati (nominandolo al v. 27 dante se ne è già congedato, senza che gli abbia dovuto rivolgere la parola), cosa che consente al poeta, da un lato, di segnare una netta frattura etica rispetto a chi
il canto della divisione. sintassi e struttura in inf., xxviii
33
aderiva alla logica della vendetta privata,70 come appunto Geri (significati-vamente, proprio un membro della sua stessa famiglia), dall’altro, però, di isolare il congiunto dal tragico panorama di sangue e mutilazioni (si noterà che non si dice come Geri sia lacerato, unico tra i protagonisti della bolgia), collocandolo in un clima stilistico piú consono alla manifestazione della propria dolente pietà per lui.71
Geri del Bello costituisce dunque quel tassello mancante di cui si diceva sopra, vale a dire il coinvolgimento personale di dante, che progressiva-mente, nel corso del passaggio nella nona bolgia, si fa piú intenso, lungo una trafila in cui tutto precipita verso una dimensione sempre piú intima: abbia-mo infatti i riferimenti alla vicende fiorentine (Mosca), al suo essere poeta e al ruolo che ciò comporta (Bertran),72 fino ad arrivare al dato biografico, alla propria famiglia (Geri).73
addirittura si potrebbe affermare che il filo (tra gli altri intrecciati nessi) che attraversa praticamente tutto il canto è quello della parentela:74 Mao-metto e alí erano cugini; curione contribuí a dividere cesare e Pompeo, cioè suocero e genero;75 Mosca intervenne in una contesa tra clan familiari; Bertran separò padre e figlio; Geri, parente dell’autore, mise zizzania all’in-
70. La cui sostanziale liceità nella società del tempo è nota e testimoniata da statuti come quelli citati, ad es., in Chiavacci Leonardi, p. 867, e Inglese, p. 327 (che rimanda anche a un interessante passo del Tresor di Brunetto).
71. come dice Sanguineti, Interpretazione, cit., p. 288 n. 5, il canto xxviii « manterrà sino all’ultimo la sua asciutta impostazione di oggettiva cronaca, e scaricherà abilmente sopra il cominciamento del xxix la didascalia sentimentale ».
72. si leggano al riguardo le considerazioni di Picone, I trovatori, cit., pp. 93-94: « se la paro-la trascritta nel libro di Lancialotto unisce […] Paolo e Francesca (sia pure secondo una moda-lità inaccettabile alla programmazione divina e naturale), la parola invece emessa da Bertran separa due persone che, per la stessa legge, avrebbero dovuto rimanere unite. La sua colpa letteraria è quindi quella di aver alterato con la sua poesia l’essenza e la direzione del rapporto amoroso. Bertran tradisce l’eredità della parola, che è quella di unire creatura a creatura, e soprattutto la creatura al creatore: la sua poesia, invece di legare, ha solo diviso »; tanto che « il “busto” viene separato dal “capo”, dalla sede della parola », a rappresentare cosí « l’uomo allon-tanato dalla facoltà stessa che lo rende “uomo”, la parola ».
73. il quale però al contempo si ricollega a Mosca e alla realtà delle contese cittadine due-centesche (benché forse non per motivi propriamente politici): in questo senso bisognerà al-lora considerare come l’episodio di Bertran si incunei tra i due momenti d’ambientazione fiorentina, con ennesimo incastro tra segmento e segmento.
74. Lo accenna anche Bosco, p. 411.75. cfr. Lucani Phars., iv 800-3: « Quid nunc rostra tibi prosunt turbata forumque, / unde
tribunicia plebeius signifer arce / arma dabas populis? quid prodita iura senatus / et gener atque socer bello concurrere iussi? ».
mirko volpi
34
terno delle famiglie. cosí, nel canto xxviii – compresa la propaggine del xxix – ogni elemento tra quelli piú cari a dante sembra presente e riempie, quasi affolla questo quadro composto di molte tessere.
La bolgia della divisione è invasa di pezzi che si accumulano l’uno sull’al-tro: nelle sequenze si susseguono gli episodi senza soluzione di continuità, il disgusto per lo sventramento di Maometto cede il posto all’orrore di altri squarci, che non cessa di essere alimentato, dalle ferite dei mozzati Piero e curione ai moncherini di Mosca, a Bertran autocefaloforo; i fondamentali temi religiosi ed etico-civili si trovano tutti concentrati e mescolati nei piani temporali sfalsati, nella compresenza di figure note e oscure, già dannate e non ancora; sul piano poetico, dopo la dichiarazione di ineffabilità si alter-nano obliquamente i registri, col realismo espressivo, scatologico e materi-co, su cui però si innesta il tono quasi elegiaco con cui principia Piero, e quello cupo successivo, e poi sentenzioso – e il tutto viene contenuto (cioè letteralmente tenuto insieme) all’inizio e alla fine del canto da innalzamen-ti stilistici di cruda ascendenza bertrandiana e virgiliana e scritturale (senza ricordare nuovamente lo spettro pressoché completo degli artifici rimici e le frantumazioni sintattiche, minime e no, di cui s’è detto).
Questa disarticolazione restituisce dunque, come uno specchio scheggia-to, l’immagine del fosso degli “scommettitori”, e ne è la congruente raffigu-razione formale e ideale. tale perfetta costruzione non sembrerebbe, ora, necessitare di qualcosa che possa dare compimento e pienezza definitiva all’episodio della nona bolgia. eppure la sublimazione di questa unità intac-cata (a un primo livello dai seminatori di discordie, a un secondo, da dante stesso con le sue non casuali scelte artistiche) forse può essere comunque rintracciata – questa la suggestione su cui chiudo la lettura – non qui, ma nei canti centrali del Paradiso (xv, xvi e xvii), i canti di cacciaguida.
che in lui si debba rinvenire una figura esemplare, in quanto anima bea-ta e dunque immagine virtuosa da contrapporsi ai peccatori infernali, non-ché un personaggio centrale della Commedia, per la definitiva investitura politico-profetica impartita a dante, è evidenza acclarata e valida in rappor-to all’intero poema (non solo, eventualmente, a questo canto), né quindi bisognosa di sovrainterpretazioni o di letture piegate ad estemporanee (e parziali) esigenze esegetiche. eppure la singolare concentrazione di temi fondanti presenti in Inf., xxviii e in certo qual modo conguagliati in caccia-guida, mi induce non certo a proporre tesi perentorie che leghino in manie-ra esclusiva, e quindi abusiva, questi due passaggi del poema; sí però a illu-strare partitamente le rinvenute tangenze testuali.
il già spesso ricordato addensamento di motivi cruciali nella nona bolgia
il canto della divisione. sintassi e struttura in inf., xxviii
35
suggerisce dunque di considerarli in relazione alle caratteristiche incarnate da cacciaguida. È infatti lui – combattente per la fede messa a repentaglio da Maometto (e si veda la menzione a inizio canto del Guiscardo, che lottò contro i saraceni) – a sancire la necessità della profezia; ed è anche l’unico parente di dante nella Commedia, oltre a Geri del Bello, col quale, però, come detto, non si incontra direttamente.
ancora. se Mosca dei Lamberti rappresenta quasi una prefigurazione dell’esilio che toccherà a dante (la divisione da lui scatenata avrà anche questo effetto), cacciaguida – che quell’esilio profetizza a lungo e in manie-ra definitiva – diventa allora l’emblema di una Firenze non ancora dilaniata dalle lotte intestine, quella Firenze le cui nobili e virtuose famiglie vengono dall’avo di dante rievocate (siamo al canto xvi del Paradiso) proprio fino all’episodio che scatenò l’odio: ma egli si ferma un attimo prima della trage-dia, a quando il giovane Buondelmonte si sta avviando, ancora inconsapevo-le, a quell’oltraggio del patto matrimoniale che gli costerà la vita. ed ecco che qui, a ritroso, avviene la saldatura col racconto di Mosca (o meglio, l’ac-cenno di racconto, bastevole a rammemorare però l’accaduto) e del delitto compiuto. cosí la parabola delle vicende fiorentine si completa, illustrata da due diverse prospettive, della vittima (al limite estremo del periodo di pace a Firenze, nella narrazione di cacciaguida) e del colpevole, cui basta riferire il malevolo consiglio dato (« capo ha cosa fatta ») per evocare la triste sorte che ne sarebbe venuta per la « gente tosca ».
La casa di che nacque il vostro fleto,per lo giusto disdegno che v’ha mortie puose fine al vostro viver lieto, era onorata, essa e suoi consorti:o Buondelmonte, quanto mal fuggistile nozze süe per li altrui conforti! (Par., xvi 136-41)
cosí, infatti, cacciaguida termina il catalogo delle famiglie e delle vicen-de fiorentine, dove si notano due interessanti rimandi alla nona bolgia: cioè, il « giusto disdegno » si aggancia al « disdegnoso » di Inf., xxix 34, con cui dan-te definisce Geri (e ancora di vendette famigliari si tratta, con la ribadita comprensione, da parte del poeta, ma non adesione a tali dinamiche); e « li altrui conforti » (il giovane Buondelmonte si fece convincere a sposare una donati e non, come promesso, una amidei) sono esattamente i « ma’ con-forti » (v. 135)76 dati da Bertran (di nuovo entra in gioco la sfera parentale).
76. e in punta di verso come nel canto paradisiaco, dove torna anche la rima con morti.
mirko volpi
36
nella bolgia degli “scommettitori”, dunque, nel luogo infernale in cui l’evidenza della pena e l’importanza del vedere vengono portate all’estre-mo, confluiscono i grandi temi politici, civili e religiosi che piú stanno a cuore all’autore, in consonanza con Par., xvii, dove è in particolare Firenze a suggerire una dimensione autobiografica e quindi il ruolo profetico del dante ormai esule. cosí assumono ancora piú senso le ultime due figure del canto, Mosca e Bertran: vale a dire, la storia di Firenze, patria rimpianta e mai dimenticata, e il suo essere poeta.
tra costoro fungerà come una sorta di amalgama il parente Geri del Bel-lo (“preludio” narrativo all’altro parente, l’avo da cui discese la stirpe degli alighieri), diretto collegamento alla realtà personale di dante. ecco allora che cacciaguida assomma, per contrasto, in sé (e dunque in una sola perso-na), quei tratti che nella nona bolgia troviamo scissi e distribuiti tra i vari personaggi: cioè, egli, crociato, realizza simbolicamente l’unità combatten-te per la fede (di contro allo scisma impersonato da Maometto e alí, ma anche in misura minore da fra dolcino); è un fiorentino del buon tempo antico (all’inizio di una storia che si interrompe tragicamente con Mosca); si fa ispiratore della Commedia (di contro al Bertran suggeritore delle immagi-ni belliche impiegate nel canto, ma modello insufficiente, e anzi fomenta-tore di discordie); ed è, infine, sangue del sangue di dante (come lo era stato Geri, ormai perduto).
il canto della divisione (e anzi, la nona bolgia) offre molte membra, mol-te parti che si susseguono all’apparenza mischiate e giustapposte, in attesa che l’« esperïenza piena » si traduca nel racconto-profezia di dante: in una parabola figurale che dalla frattura dell’ordine, dallo smembramento, dalla dispersione dovrà giungere a quell’ideale di unità religiosa, politica e civile, necessaria premessa per la salvezza di ogni uomo.
Mirko Volpi
★
Le peculiarità retoriche, sintattiche e strutturali che caratterizzano il xxviii dell’Infer-no non si esauriscono nel mero artificio, ma risultano sempre pienamente funzionali a una piú globale comprensione del canto, configurandosi in modo particolarmente rile-vato come il suo esatto corrispettivo formale; infatti il peccato della divisione, della sepa-razione, qui punito nella lacerazione delle membra dei dannati (i seminatori di discor-die), si riflette nelle divaricazioni della sintassi e nei continui richiami, incastri e legami che tengono insieme i vari segmenti ed episodi del canto. La lettura propone anche l’individuazione di nuove fonti scritturali, in particolare per Maometto, la cui rappresen-
il canto della divisione. sintassi e struttura in inf., xxviii
37
tazione sarebbe stata suggerita a dante dalla morte per sventramento di Giuda iscariota (secondo il racconto degli Atti degli Apostoli), analoga a quella dell’eresiarca ario.
The rhetorical, syntactical and structural patterns of ‘Inferno’, xviii are not merely a result of Dan-te’s stylistic device; indeed, as formal supplements of the Canto, they help to a more comprehensive understanding of it. As a matter of fact, the punishing of the sin of discord by damned men’s limb tearing is here reflected in the distortion of syntax, as well as in the continuous snap-fit references and textual bonds linking together all the episodes of the Canto. Furthermore, such reading displays new scriptural sources, in particular for Mahomet, whose representation was maybe suggested to Dante by Judas’ de-ath by evisceration (according with the ‘Acts of the Apostles’), which is also similar to that of the here-siarch Ario.












































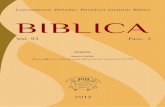


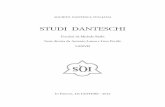
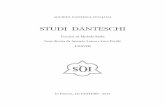
![«Guido da Montefeltro dal Convivio all'Inferno», Nuova Rivista di Letteratura Italiana, XIII (2010) [but 2012] (= Studi danteschi per Alfredo Stussi a cinquant'anni dalla sua laurea),](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6317ff00831644824d03ba62/guido-da-montefeltro-dal-convivio-allinferno-nuova-rivista-di-letteratura.jpg)


