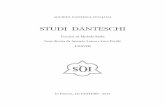«Intorno al cor»: l’allegoria di Tre donne come antecedente dell’allegoria della Commedia
«Una retorica della comunicazione: le strategie autoriali nella "Commedia"», Studi danteschi, 77,...
Transcript of «Una retorica della comunicazione: le strategie autoriali nella "Commedia"», Studi danteschi, 77,...
STUDI DANTESCHI
SOCIETÀ DANTESCA ITALIANA
Fondati da Michele Barbi
Serie diretta da Antonio Lanza e Lino Pertile
LXXVII
IN FIRENZE, LE LETTERE – 2012
INDICE
Nadia Ebani, Necrologio di Domenico De Robertis 1
Antonio Lanza, Ricordo di Guglielmo Gorni 7
Guglielmo Gorni, «Disegnare figure d’angeli» nellaVita nova 23
Robert Hollander, Inferno III 82-136: How did Dante Crossthe Acheron? 45
Antonio Lanza, Il particolare “pianto” di Filippo Argenti:l’ultima provocazione 59
Vittorio Bartoli, La complessione calda di Ulisse. Chiosa alcommento di Benvenuto da Imola a Inf. XXVI 105
Bortolo Martinelli, Dante. Genesi della Commedia: dal‘vetus Infernus’ al ‘novus Infernus’ 115
Paolo Fedrigotti, Risonanze scritturistiche nel prologo dellaDivina Commedia 149
Sabrina Ferrara, Una retorica della comunicazione: le strate-gie autoriali nella Commedia 203
Gino Casagrande, Due note a Paradiso XIII «e se al “surse” drizzili occhi chiari» (106) «acciò che re sufficïente fosse» (96) 235
José Blanco J., Il canto del presente (Paradiso XVI) 249
NOTE
Stefano Gensini, Attraverso il De vulgari eloquentia. A propo-sito di due edizioni recenti 277
INDICEVI
Jelena Todorovic �, «Un’operetta del famosissimo Poeta, e Teo-logo Dante Allighieri»: the editio princeps of the Vita Nova 293
Giuseppe Indizio, Giovanni del Virgilio maestro e dantistaminore 311
MANOSCRITTI DANTESCHI
Federico Sanguineti, Purgatorio XIX 34 343
Angelo Eugenio Mecca, Un nuovo canone di loci per la tradi-zione della Commedia? A proposito di uno studio di LuigiSpagnolo 359
Francesco Velardi, Il manoscritto sulle stelle fisse di Dante 389
SCHEDE E SEGNALAZIONI 445
Notizie della Società Dantesca Italiana per l’anno 2011 467
Indice dei manoscritti 473
Indice dei nomi 485
UNA RETORICA DELLA COMUNICAZIONE:LE STRATEGIE AUTORIALI NELLA COMMEDIA
Sin dall’inizio della riflessione sulla diffrazione tra auctor, narra-tor e agens, la critica ha spesso segnalato un certo numero di ‘luoghiautoriali’ che l’autore, appunto, si riservava per far sentire la propriavoce interferendo direttamente nella compagine narrativa. Si tratta,solitamente, di interventi che si collocano nell’ambito dell’organiz-zazione della narrazione, nella struttura dell’opera o nella composi-zione più propriamente retorica. Il testo che il lettore si trova a leg-gere appare quindi come l’esito del pensiero metalinguistico dell’au-tore il quale pianifica, organizza e dispone la parola poetica. Gli echidi tale operazione sono numerosi e sostanziali, poiché, da un lato,essa coordina un canale diretto di comunicazione tra l’autore e il let-tore, esterno al testo, rispetto al canale interno tra narratore e narra-tario; dall’altro, essa conduce l’autore e il lettore ad un rapporto dicomplicità lettoriale che poggia su una fiducia totale da parte del primonel secondo dando origine, in questo modo, a una ‘coppia modello’.
Nello spazio retorico della Commedia il luogo autoriale per ec-cellenza è stato considerato, a giusto titolo, quello dell’‘appello allettore’ sul quale, proprio per la grande attenzione che gli è statadedicata, non ci attarderemo. Altri luoghi meritano invece la stessaconsiderazione, eredi, alcuni, della retorica antica, come le apostrofio le invettive, figure che si riferiscono alla categoria strutturale delpensiero e che rendono conto di una modalità esplicita di espressio-ne, oppure come le perifrasi, sempre inerenti al pensiero, ma la cuimodalità espressiva si definisce piuttosto come occultatrice.
1. Le figure dell’esplicitazione: l’apostrofe e l’invettiva
La complessità della Commedia in cui la disseminazione concet-tuale stratifica, intrecciandole, le iperisotopie etiche, politiche e te-
SABRINA FERRARA204
ologiche, si estende anche alla retorica. Ora, se il lettore è evidente-mente sempre il destinatario di ogni organizzazione narrativa e a luisono rivolti i diversi procedimenti, negli spazi che l’autore si ritagliaè tanto più sollecitato in quanto quest’ultimo gli attribuisce il ruolodi co-protagonista autoriale e l’interpella direttamente come in certeapostrofi, che fanno rientrare nel rapporto destinatore/destinatarioun certo numero di allocutori, distintamente dichiarati grazie a unaperpetua dialettica con il contesto referenziale. Le apostrofi, ope-rando così una commutazione (aversio) nella situazione del discor-so, giungono a enfatizzarlo, suscitando il pathos con una forte into-nazione allocutiva e esclamativa. Gli strumenti linguistici che lesostengono agiscono, attraverso l’uso del vocativo, dell’imperativo edella seconda persona, in una composizione dialogica che determi-na una variatio intenzionale all’interno della narrazione. La Comme-dia è costellata di apostrofi che Dante-autore usa copiosamente nellesue varianti, elaborando una retorica della polemica che prendesovente la forma dell’invettiva.
Le città italiane costituiscono l’oggetto della maggior parte delleapostrofi-invettive situate, quasi naturalmente, in Inferno.1 Il lega-me con le città italiane diaboliche, Firenze prima di tutte, pone, inmodo immediato, questa figura retorica al cuore stesso della pole-mica politica, coordinando direttamente la parola del poeta e ladisposizione dei canti. Il posto che l’apostrofe occupa condiziona,in questo modo, la lettura di un episodio e ne determina spesso icaratteri. Il trittico infernale costituito dai canti XV-XVI-XVII ne è unesempio significativo. Dante e Virgilio si trovano nella 3a zona delVII cerchio, luogo di punizione dei violenti contro Dio nella natura(i sodomiti) e nell’arte (gli usurai). Il pellegrino vi incontra il suomaestro Brunetto e tre nobili fiorentini, riattivando, sul piano poli-tico, la polemica contro Firenze e la corruzione. I tre canti si orga-nizzano in modo simmetrico: Brunetto (canto XV) e i tre fiorentini(prima parte del canto XVI) sono appartenuti tutti alla stessa genera-zione e rappresentano la buona ‘parte’ di una Firenze ormai predadella «gente nuova» e dei «sùbiti guadagni» che ne hanno fatto ilcentro della corruzione e della decadenza morale e civile. Parallela-
1 Sull’invettiva infernale, vd. M. MARIETTI, Dante: la città infernale, Roma,Aracne, 2007, pp. 153-160.
LE STRATEGIE AUTORIALI NELLA COMMEDIA 205
mente a questa prima sequenza concettuale, una seconda si sviluppanel canto XVII, quando il pellegrino nota tra gli usurai una maggio-ranza di fiorentini (Inf. XVII 58-73). La serie dei tre canti s’organizzain due sequenze che si estendono concettualmente: una prima in cuiappare una Firenze positiva dove il «ben fare» si compie apertamen-te, opposta a una seconda, antitetica, in cui prevale la sete di guada-gno e l’interesse personale. Le due sequenze trovano il loro asse nellacostituente retorica dell’apostrofe: «“La gente nuova e i sùbiti gua-dagni / orgoglio e dismisura han generata, / Fiorenza, in te sì che tugià ten piagni”» (Inf. XVI 73-75).2 L’apostrofe, che si accosta all’allo-cuzione rivolta direttamente a Firenze sotto forma di prosopopea,oppone una duplice coppia di elementi negativi («gente nuova»,«sùbiti guadagni» e «orgoglio e dismisura») a una coppia positiva(«cortesia e valor») evocata da Jacopo Rusticucci al verso 67. Il doppiobinomio negativo si costituisce in una costruzione grammaticale econcettuale parallela: il primo rappresenta il soggetto-causa («gentenuova» e «sùbiti guadagni») e il secondo, l’oggetto-conseguenza(«orgoglio e dismisura»). Anche la strutturazione metrica accompa-gna l’apostrofe visualizzandone la violenza. La prima coppia di pa-role occupa, infatti, un intero verso ed è interrotto dalla cesura inmodo da disporre i due accenti sulla quarta (« nuòva ») e sulla sestasillaba (« sùbiti ») del verso ancipite, cioè sui due aggettivi rivelatoridi nozioni politiche ed economiche. Il sintagma «orgoglio e dismi-sura» occupa il primo emistichio del verso, a maiore, con l’accentoprincipale sulla sesta sillaba («dismisùra») saldando concettualmen-te i due termini. Così i quattro lessemi sono anteposti, pur formandoun blocco unico, al verbo che, sintatticamente, li unisce («han gene-rata») e che annuncia l’allocutario dell’apostrofe, all’inizio del versoseguente, «Fiorenza».
Dopo l’idealizzazione delle virtù dei tre fiorentini temporis acti,l’apostrofe prepara i lettori alla realtà contemporanea personificatadagli usurai. E se il personaggio che parla è un padovano, i due
2 Sulla convergenza tra discorso politico-economico e discorso poetico, vd. S.NOAKES, Dante e lo sviluppo delle istituzioni bancarie a Firenze: «i sùbiti guadagni»,in Dante. Da Firenze all’aldilà. Atti del terzo Seminario Dantesco internazionale(Firenze, 9-11 giugno 2000), a c. di M. Picone, Firenze, Franco Cesati editore, 2001,pp. 249-261.
SABRINA FERRARA206
compagni sono fiorentini, come fiorentino sarà colui che essi aspet-tano. Sono tutti nobili e cavalieri, e, all’opposto dei tre personaggiincontrati nel canto precedente, hanno imbrattato il lignaggio a cuiappartengono con la loro rapacità. L’apostrofe garantisce così latransizione concettuale e assume la funzione narrativa di preparareil lettore a ciò che seguirà.
L’apostrofe-invettiva contro Firenze, prima ma non ultima, aprela lunga serie legata alle città italiane che trova le sue espressioni piùpregnanti nelle prosopopee di Pistoia (Inf. XXV 10-12), di Pisa (Inf.XXXIII 79-90) e in parte, con varie differenze, di Genova (Inf. XXXIII
151-153).3 Si trovano tutte nello spazio topografico e morale dell’in-ganno e del tradimento, nel fondo dell’abisso infernale. Un certonumero di differenze di disposizione e di finalità le definisce tutta-via. L’invettiva contro Pistoia si colloca in una sequenza di enjambe-ments nozionali e narrativi di tre canti, XXIV (a partire dal verso 61),XXV e XXVI, dedicati ai ladri, sequenza che si chiude con l’invettivacontro Firenze (XXVI 1-12). Le due invettive contro Pisa e i Geno-vesi occupano un solo canto il quale, per un procedimento di de-composizione narrativa interna, si trova diviso tra l’Antenora e laTolomea. La posizione dell’invettiva contro Pistoia, all’inizio del canto,le dà un posto di rilievo nell’organizzazione del testo e accentua lacarica emozionale che l’ha provocata, con una visione apocalitticasulla distruzione totale della città. Esattamente la stessa visione saràripresa nell’invettiva contro Pisa, la quale occupa una medesimaposizione di rilievo, sebbene asimmetrica rispetto a quella di Pistoia,poiché chiude la pietosa narrazione del conte Ugolino. Nei due casila città e gli abitanti sono confusi in una abominazione di orgoglioe di iniquità; e se Ugolino è punito come traditore della patria, èproprio la sua patria che, grazie all’intervento autoriale, è punita perla propria iniquità.
Tra le città stigmatizzate, Firenze, lo ripetiamo, simbolo partico-larmente pregnante, occupa un posto particolare. Come la prima,
3 M. Santagata sembra trovare un tratto comune alle invettive-apostrofi con-tro Pistoia, Pisa e Genova nella personale «logica politica» (p. 329) filomalaspinia-na, basata sul ritorno a «posizioni rigorosamente guelfe» (p. 319) nella prospettivache i Malaspina, ospiti del poeta in questa fase della sua vita, potessero aiutarlo arientrare a Firenze, M. SANTAGATA, L’io e il mondo. Un’interpretazione di Dante,Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 328-330.
LE STRATEGIE AUTORIALI NELLA COMMEDIA 207
anche la seconda invettiva infernale destinata alla città toscana èprovocata dall’incontro con cinque fiorentini tra i ladri dell’ottavocerchio, nella settima bolgia (Inf. XXV). Il pellegrino e Virgilio assi-stono alle metamorfosi di quattro dei cinque:4 quella di un serpente(Cianfa Donati) e di un uomo (Agnolo Brunelleschi) in una mostruosafigura, quella di un serpente (Francesco de’ Cavalcanti) in uomo equella di un uomo (Buoso Donati) in serpente. I quattro nobili, che,come i fiorentini usurai, hanno disonorato il loro nome, ispiranoall’autore una fiera apostrofe contro la propria città in incipit delcanto seguente. In un primo momento sembra apparire come inti-mamente contraddittoria, in un miscuglio di amore e di odio che lacomplessa struttura retorica mette in luce:
Godi, Fiorenza, poi che se’ sì grande,che per mare e per terra batti l’ali,e per lo ’nferno tuo nome si spande!
Tra li ladron trovai cinque cotalituoi cittadini onde mi ven vergogna,e tu in grande orranza non ne sali.
Ma se presso al mattin del ver si sogna,tu sentirai, di qua da picciol tempo,di quel che Prato, non ch’altri, t’agogna.
E se già fosse, non saria per tempo.Così foss’ei, da che pur esser dee!ché più mi graverà, com’ più m’attempo.
(Inf. XXVI 1-12)
Il sarcasmo che caratterizza la prima terzina lascia il posto rapi-damente nella seconda terzina a un tono profetico annunciatore dellecalamità per la città, ma non apocalittico. E se contro Pistoia, Pisao Genova, l’autore invocherà l’estinzione totale, per Firenze ci saràuna punizione dolorosa ma misurata. Una misura che rende contodel passaggio dall’esecrazione alla dichiarazione finale d’amore sullaquale si chiude l’apostrofe.
Per la sua posizione metrica nel canto, all’inizio, questa invettiva‘fiorentina’ ne ricorda un’altra che si differenzia per l’assenza diprosopopea. Il canto XIX dell’Inferno si apre, ex abrupto, sulla dupli-
4 Il quinto uomo Puccio Sciancato è il solo a non subire trasformazioni.
SABRINA FERRARA208
ce apostrofe dell’autore a Simon mago e alla saggezza sovrana diDio. Questo canto è, in verità, un unicum, nel poema poiché «è infattiinteramente un’invettiva contro il papato corrotto dalla simonia».5
L’affermazione non può essere più precisa dal momento che il letto-re ritrova nei versi una tensione vituperatrice di una straordinariaintensità. Sette apostrofi costellano questo canto, distribuite tra levoci dei personaggi e quella dell’autore.6 Evidentemente non tuttesono delle invettive la cui prerogativa appartiene, in generale, all’istan-za autoriale; tuttavia il solo concatenamento del ritmo apostrofalebasta per dirigere l’attenzione del lettore verso un contenuto giudi-cato dall’autore degno di un simile sviluppo retorico. Questo cantotestimonia in effetti un cambiamento di prospettiva autoriale dalmomento che il poeta focalizza la sua attenzione non solo sulla pro-pria storia personale strettamente legata a Firenze, ma anche su unorizzonte più largo nel quale rientra l’intera umanità. L’evoluzioneconcettuale è allora segnata dalla composizione di un dispositivoretorico che allea l’efficacia oratoria e l’intensità nozionale. L’usodell’apostrofe in questo canto è notevole almeno per due ragioni: laprima è che lo scambio tra il pellegrino e il personaggio, il papaNiccolò III, si svolge in uno scenario di interrogazioni e contro-in-terrogazioni unicamente sotto la forma dell’invettiva dando così aldialogo una nota di acrimonia e alla scrittura un carattere performa-tivo. La seconda ragione è che l’episodio è uno dei rari in cui l’apo-strofe viene pronunciata da Dante-pellegrino. Questi, dopo un’ap-parenza di excusatio («Io non so s’i’ mi fui qui troppo folle, / ch’i’pur rispuosi lui a questo metro» Inf. XIX 88-89), esplode in una vio-lentissima invettiva che occupa i versi 90-117 e che si conclude conuna forte esclamazione nominativa rivolta a Costantino. La violenzadel canto è così determinata non solo dal numero inconsueto diapostrofi e di invettive, ma anche dall’alternanza delle istanze vocaliche le pronunciano, l’auctor (1a e 2a), l’agens (3a, 6a e 7a), il personag-gio-attore dell’episodio (4a e 5a). L’intervento invettivale dell’agens ètanto più significativo in quanto racchiude la chiave di decrittaggiodella posizione di Dante-autore verso il papato: in effetti, l’apparen-te contraddizione tra la «follia» che ha determinato la violenza del-
5 MARIETTI, La città infernale, cit., p. 156.6 La prima occupa i versi 1-6; la seconda i versi 10-12; la terza i versi 46-48; la
quarta e la quinta i versi 52-57; la sesta e la settima occupano i versi 90-117.
LE STRATEGIE AUTORIALI NELLA COMMEDIA 209
l’espressione e il rispetto mostrato qualche terzina dopo («“E se nonfosse ch’ancor lo mi vieta / la reverenza delle somme chiavi / che tutenesti ne la vita lieta, / io userei parole ancor più gravi”» Inf. XIX
100-103) si risolve nella distinzione operata dall’autore tra il perso-naggio reprensibile e la funzione che ha occupato o l’istituzione cherappresenta.7 La separazione è fondamentale nel pensiero dantescopoiché unicamente alla luce di questa il lettore può decodificare ildiscorso politico-religioso dell’autore e leggere i numerosi attacchiche pronuncia o fa pronunciare contro il papato, la Chiesa o anchel’imperatore. Quest’ultima categoria entra, d’altronde, nel quadrodella vasta invettiva, una delle più conosciute, veementi e vaste delpoema, del canto VI del Purgatorio che, in questo senso, si può av-vicinare al canto XIX dell’Inferno tanto per l’importanza della strut-tura retorica, quanto per la forte carica concettuale.
Nessuno degli incontri del pellegrino con fiorentini o toscani haprovocato le reazioni che l’evocazione da parte di Virgilio del nomedi Mantova suscita in Sordello nel canto VI del Purgatorio. Comeogni volta che la diegesi è abbandonata e la narrazione sospesa, l’ir-ruzione dell’auctor nell’opera vuole sottolineare un nodo nozionaleparticolarmente decisivo che, d’altronde, lui stesso attesta in modochiaro dando i limiti metalinguistici esatti della sua intrusione con iltermine «digressione» (Purg. VI 128). La ricerca di un contatto diret-to con i lettori si esprime con l’evocazione fatica in forma di proso-popea («Ahi serva Italia»; «la tua Roma che piagne vedova e sola»;«Fiorenza mia, ben puoi esser contenta / di questa digression chenon ti tocca» Purg. VI 76, 112 e 127-128) e con l’appello preciso aidestinatari dell’invettiva. La disposizione e l’organizzazione dellediverse apostrofi acquista un’importanza particolare sul piano dellatrasmissione del pensiero politico del poeta, intessendosi progressi-vamente. Il punto di partenza è l’apostrofe all’Italia che prende leforme di un planh provenzale nel quale si deplorano le miserie e letristi condizioni della Penisola annunciando, senza definirli con esat-tezza, i responsabili di una tale situazione: «nave sanza nocchiere ingran tempesta» (Purg. VI 77) e «Che val perché ti racconciasse il freno
7 Sull’analogia tra il linguaggio evangelico e quello dell’episodio, vd. M.CORTI, Percorsi dell’invenzione. Il linguaggio poetico e Dante, Torino, Einaudi,1993, pp. 50-74.
SABRINA FERRARA210
/ Iustinïano, se la sella è vòta?» (Purg. VI 88-89). Due sono i respon-sabili di questo stato di cose, gli uomini di Chiesa da un lato, che,dopo aver indebolito l’autorità imperiale, approfittano dell’incuriadell’imperatore («Ahi gente che dovresti esser devota, / e lasciar sederCesare in la sella» Purg. VI 91-92),8 e l’imperatore dall’altro, il cuigrave errore, lasciare la nave abbandonandola alla grande tempestadi lotte e di guerre intestine, è fortemente stigmatizzato. Su Albertod’Asburgo, sovrano fustigato, e sulla sua discendenza, Dante lancial’anatema («giusto giudicio da le stelle caggia / sovra ’l tuo sangue,e sia novo e aperto, / tal che ’l tuo successor temenza n’aggia!» Purg.VI
100-102);9 Alberto, regnante colpevole dei conflitti incessanti cheagitano l’Italia («Vieni a veder Montecchi e Cappelletti, / Monaldie Filippeschi, uom sanza cura: / color già tristi, e questi con sospetti!/ Vien, crudel, vieni, e vedi la pressura / d’i tuoi gentili, e cura lormagagne; / e vedrai Santafior com’è oscura!» Purg. VI 106-111)10 edell’abbandono di Roma («Vieni a veder la tua Roma che piagne /vedova e sola, e dì e notte chiama: / “Cesare mio, perché non m’ac-compagne?”» Purg. VI 112-14).11 Ora, l’imperatore interamente as-
8 L’uso congiunto di diversi strumenti retorici è notevole: l’interrogazione, neiversi precedenti, l’esortazione in questi. Il lettore ritroverà lo stesso trinomio apo-strofe-esortazione-interrogazione, per esempio, in Purg. X 121-26: «O superbi cri-stian, miseri lassi, / che, de la vista de la mente infermi, / fidanza avete ne’ retrosipassi, / non v’accorgete voi che noi siam vermi / nati a formar l’angelica farfalla, /che vola a la giustizia sanza schermi?»; ovvero in Purg. XIV 86-87: «o gente umana,perché poni ’l core / là ’v’è mestier di consorte divieto?». La semplice apostrofe-esortazione in Par. V 73-75: «Siate, Cristiani, a muovervi più gravi: / non siate comepenna ad ogne vento, / e non crediate ch’ogne acqua vi lavi», e l’apostrofe-inter-rogazione in Purg. XX 13-15: «O ciel, nel cui girar par che si creda / le condiziondi qua giù trasmutarsi, / quando verrà per cui questa disceda?».
9 L’effetto retorico e la portata performativa del messaggio sono tanto piùarticolati ed evidenziati dall’uso dell’esclamazione.
10 I versi sono sottolineati dalla forte apostrofe organizzata intorno ai verbi«venire» e «vedere» usati nella forma dell’annominatio.
11 È stata notata varie volte la corrispondenza tra il verso 113, le Lamentazionidel profeta Geremia e le Ep. VI ai Fiorentini e XI ai Cardinali italiani che si apre,quest’ultima, esattamente sul binomio «vidua et deserta» (cf. Lam. I, 1); cfr. M.PERUGI, Canto VI, in Lectura Dantis Turicensis a c. di M. Picone e G. Güntert,Firenze, Franco Cesati editore, 2001-2003, 3 voll., in particolare II, Purgatorio, pp.85-91. Noi vogliamo invece evidenziare l’ordito di figure retoriche che acceleranoil ritmo con l’anafora annominativa (vieni/vien/vieni) e con la ripetizione nel verso109, intensificata dal poliptoto (veder/vedi/vedrai/veder).
LE STRATEGIE AUTORIALI NELLA COMMEDIA 211
sorbito dai propri interessi nazionali, abbandonando Roma, lascia lavia aperta alle mire temporali, già manifeste, della Chiesa di Roma.In questo modo il secondo punto cardinale del pensiero politicodantesco prende posto nella costruzione che il poeta edifica gradual-mente prima di dargli la sua espressione definitiva, politica e poeti-ca, nel canto di Marco Lombardo. È una professione di fede prov-videnziale nell’Impero, regolatore di lotte partigiane, ma anche unacondanna netta del potere temporale illegittimamente esercitato dallaChiesa, fonte di disordine quanto l’assenza della figura imperiale.
Se ci si sofferma attentamente sulla costruzione di questa partedell’invettiva, essa completa, nei contenuti, lo schema annunciatodall’episodio di Manfredi, nel III canto; nessuna evocazione dell’Im-pero è espressa, ma unicamente suggerita, grazie al sottocodice re-ferenziale riferito al sovrano svevo; al contrario, la condanna dei cattivipastori è chiaramente formulata. Nel canto VI le due problematiche,le responsabilità ecclesiastiche e quelle imperiali sono, non solorecuperate, ma incrementate rispetto al canto III, mentre il legameche raccorda le due condanne ecclesiastiche è fatto, nei due canti,dall’uso della metafora della ‘lettura’ scorretta («“Se ’l pastor diCosenza, che a la caccia / di me fu messo per Clemente allora, /avesse in Dio ben letta questa faccia”» Purg. III 124-26; «Ahi genteche dovresti esser devota, / e lasciar seder Cesare in la sella, / se beneintendi ciò che Dio ti nota» Purg. VI 91-93). Le conseguenze di questadecodificazione errata sono visibili ed è quindi necessario fornireun’ermeneutica esatta dei disegni divini e delle loro leggi, ermeneu-tica che permette, d’altronde, di precisare il duplice ruolo del poeta,lettore e autore; prima dell’atto di scrittura, prima di avere destina-tari e lettori, lo stesso Dante occupa, difatti, un posto nella categorialettoriale. Ora, la scrittura della Commedia non è un’azione autoria-le d’inventio, ma una riscrittura narrativa di ciò che Dante-pellegri-no ha visto, sentito e compreso nel suo viaggio e di quello che Amore-Dio gli ha dettato, il che richiede una decifrazione corretta. Per que-sta via il suo statuto esemplare si rinforza, poiché prima di essere unviator esemplare trasformato in seguito in narrator esemplare, sipresenta come lector esemplare. Lo schema attanziale elaborato perla Commedia modifica dunque i ruoli dei destinatari e se questi re-stano gli uomini, nella tassonomia collettiva dell’opera, il destinata-rio originario del viaggio è il poeta che, unicamente dopo un’esattainterpretazione della lettura, può diventare lo scriba Dei. Ma, essere
SABRINA FERRARA212
scriba di Dio suppone assumere anche la funzione di guida, e in qualeitinerario Dante-autore può condurre i suoi discepoli se non in unitinerario poetico? Il significato della Commedia risiede esattamentein questo, dare agli uomini-lettori una giusta lettura della realtà,sconosciuta, di Dio. Dante-autore svolge in questo modo nella suaopera e per i suoi lettori il ruolo che Virgilio svolge per Dante-pel-legrino, secondo delle modalità strettamente letterarie, in un siste-ma di comunicazione che si fraziona permettendo al lettore di avvi-cinarsene gradualmente. Così, nel canto VI del Purgatorio, seguendoil filo della riflessione politica legata all’Impero e alla Chiesa e rico-nosciuta la causa della condotta biasimevole degli ecclesiastici, l’au-tore si rivolge direttamente all’istanza politica smarrita, l’imperato-re. Per questo destinatario dichiarato, l’auctor adatta la sua funzionedi mentore morale per diventare consigliere politico e incitarlo aoccuparsi del «giardino de lo ’mperio» (Purg. VI 105),12 veste cheindosserà in tutte le epistole datate del periodo di Arrigo VII.
Inserita subito dopo gli appelli solenni in forma di anafora ri-guardanti altre città italiane, che richiamano i conflitti municipalievocati in Inferno e riecheggiano quelli rapportati da Jacopo delCassero e Bonconte da Montefeltro nel canto precedente, la partedell’invettiva dedicata a Firenze si distingue subito per il sarcasmocon cui è presentata la sua ‘eccezione’. Violenza e passione diventa-no qui sofferenza come in quella che apre il canto XXVI dell’Inferno,mentre la condanna della situazione di discordia, di corruzione e diingiustizia, tema ricorrente nel Purgatorio, mobilita i grandi canti‘fiorentini’ della prima cantica (Inf. VI, XV, XVI, ecc.). Il poeta evitadi fustigare i falli della propria città per evocare soltanto i mali chela gravano, mettendo in risalto il suo accecamento con una forteantifrasi («Or ti fa lieta, ché tu hai ben onde: / tu ricca, tu con pacee tu con senno!» Purg. VI 136-37),13 in cui l’anafora è sostenuta dauna esclamazione sarcastica. Man mano che il pensiero del poeta siformula e si esteriorizza, i ruoli nel processo di comunicazione siprecisano tanto per l’emittente quanto per i riceventi. Se il campodei lettori ipotetici resta coerente con la visione generale, politica e
12 La reiterazione etica del ruolo del sovrano supremo è resa poeticamente esemicamente dal termine «vieni» ripetuto sei volte.
13 L’antifrasi ricalca quella infernale («Godi, Fiorenza»).
LE STRATEGIE AUTORIALI NELLA COMMEDIA 213
etica, quello dei destinatari diretti si conferma. Le apostrofi rendo-no conto della loro identità: sono gli ecclesiastici, l’imperatore, Fi-renze e più generalmente i governi ‘popolari’ delle città italiane dove«un Marcel diventa / ogne villan che parteggiando viene» (Purg. VI
125-26).14 Grazie a questa individuazione, la denuncia delle loromanchevolezze viene ad essere chiaramente formulata, come la lororesponsabilità verso il paese.
Questa esemplificazione mostra come le apostrofi della Comme-dia si definiscono invariabilmente, nel legame tra retorica e signifi-cato, per la posizione che occupano nell’economia della scrittura.La loro disposizione permette al lettore di decifrarne la funzionegrazie alla diversa intensità fatica di cui l’auctor le carica. La funzio-ne fatica maggiore e l’autorità retorica più intensa si realizzano quandol’autore colloca l’apostrofe in apertura di canto in modo immediatoponendo il lettore in medias res. Un posto, quello all’inizio del can-to, che non rende tuttavia conto della grande varietà delle finalitànozionali e che si articola su diversi livelli semici. L’apostrofe puòquindi sostenere una riflessione morale come in Par. XI 1-12, nellaforma dell’esclamazione, ma senza la violenza dell’invettiva:
O insensata cura de’ mortali,quanto son difettivi silogismiquei che ti fanno in basso batter l’ali!
Chi dietro a iura, e chi ad amforismisen giva, e chi seguendo sacerdozio,e chi regnar per forza o per sofismi,
e chi rubare, e chi civil negozio,chi nel diletto de la carne involtos’affaticava e chi si dava a l’ozio,
quando, da tutte queste cose sciolto,con Bëatrice m’era suso in cielocotanto glorïosamente accolto.
L’inizio, ex abrupto, può e deve essere letto e colto nel sistema dienjambement narrativo che lo lega al canto precedente. Questo siera chiuso sull’immagine liturgica della campana che chiamava i fratellia cantare mattutino e sul movimento coordinato degli spiriti della
14 Qui è l’antonomasia che viene sollecitata.
SABRINA FERRARA214
prima corona; il canto XI si apre, con un’opposta simmetria, suun’immagine corale, ma questa volta terrestre. Dante-autore si ap-propria l’opposizione tra homo spiritalis e homo carnalis, un toposdella letteratura medievale, per accentuare il processo d’individua-lizzazione sottolineando la propria elevazione a un cielo superiorecon un rifiuto sdegnoso delle occupazioni mondane dalla più nobi-le, il sacerdozio, alla più condannabile, il furto. Questa elevazione èmetricamente evidenziata dall’avverbio che accoglie la cesura e i dueaccenti del verso sulle «o» e sulle «e» (« glorïósaménte »); per la suascansione questo avverbio segna il distacco del poeta dalle vicendeterrestri, ma per la sua posizione centrale, dà rilievo all’assunzionedel poeta al cielo del Sole. Tanto più che la simmetria con il cantoX è accentuata dal gioco di sguardi che sono rivolti verso l’alto, ilcielo, nel canto X,15 e verso il basso, la terra, nel canto XI.16
Di notevole efficacia oratoria sono le apostrofi-preghiere tra lequali si distingue sicuramente, tanto per le finalità emozionali enozionali di cui si fa latrice quanto per i numerosi studi di cui è stataoggetto, la preghiera alla Vergine del canto XXXIII del Paradiso.17
L’esordio del canto XI del Purgatorio, canto centrale del trittico deisuperbi, con il Pater Noster, ne costituisce un esempio non menointeressante per i vari moduli tematici che trasmette. In effetti, se alivello della comunicazione più semplice, essa esteriorizza una vo-
15 Par. X 7-21: «Leva dunque, lettore, a l’alte rote / meco la vista, dritto a quellaparte / dove l’un moto e l’altro si percuote; / e lì comincia a vagheggiar ne l’arte /di quel maestro che dentro a sé l’ama, / tanto che mai da lei l’occhio non parte. /Vedi come da indi si dirama / l’oblico cerchio che i pianeti porta, / per sodisfareal mondo che li chiama. / Che se la strada lor non fosse torta, / molta virtù nel cielsarebbe in vano, / e quasi ogne potenza qua giù morta; / e se dal dritto più o menlontano / fosse ’l partire, assai sarebbe manco / e giù e sù de l’ordine mondano».
16 Cfr. anche Par. XVI 1-6: «O poca nostra nobiltà di sangue, / se glorïar di tela gente fai / qua giù dove l’affetto nostro langue, / mirabil cosa non mi sarà mai:/ ché là dove appetito non si torce, / dico nel cielo, io me ne gloriai».
17 Par. XXXIII 1-39; vd. E. AUERBACH, La preghiera di Dante alla Vergine e altrielogi anteriori, in IDEM, Studi su Dante, Milano, Feltrinelli, 19852, pp. 271-301; A.VALLONE, La preghiera, in IDEM, Studi su Dante medievale, Firenze, Olschki, 1965,pp. 83-109; M. CASELLA, Canto XXXIII, vol. III, Paradiso, in Lectura Dantis Scali-gera, Firenze, Le Monnier, 1967-1968, 3 voll., pp. 2021-2038; E. ESPOSITO, Il cantodell’ultima visione («Paradiso» XXXIII), in «Letture Classensi», 7, 1979, pp. 13-26; P. A. PEROTTI, La preghiera alla Vergine (Par. XXXIII 1-39), in «L’Alighieri», 6,1995, pp. 75-84, ecc.
LE STRATEGIE AUTORIALI NELLA COMMEDIA 215
lontà fatica certa, a livello autoriale è l’emblema di un’affermazionedell’auctor sempre più forte e riconosciuta, tradotta nelle numerosemodifiche apportate al testo originale della preghiera.18
Una variante dell’apostrofe-preghiera è la sermocinatio,19 formadi dialogismo con ibridazione linguistica (latino/volgare) impernia-ta su citazioni bibliche che apre i canti XXXIII del Purgatorio e VII delParadiso. Le due referenze veterotestamentarie si integrano nellastruttura grazie all’enjambement narrativo di cui costituiscono ilcontrorigetto. Le prime parole («“Deus, venerunt gentes”») del Salmo78 cantate da sette donne, simbolo delle virtù cardinali e teologali,nel Paradiso Terrestre hanno una duplice funzione; da una partesviluppano la polemica politica del canto precedente caratterizzatodalle visioni apocalittiche della trasformazione del carro; dall’altraattestano la variazione del panorama verso una distensione annun-ciatrice delle sfere celesti, in contrasto con la violenza del finale delcanto XXXII. In questo modo, se il canto latino richiama il primomomento di purificazione nelle acque del Leté,20 il suo posto e la suafunzione compongono l’esordio non solo del canto, ma di un nuovomodo di espressione. Le rappresentazioni pittografiche del canto XXXII
cedono il posto a un tono più solenne che annuncia, sul piano con-cettuale, la mutazione dei tempi attraverso le parole della promessae di redenzione pronunciate da Beatrice;21 parole che si ricolleganoall’apostrofe di apertura con la ripresa della stessa alloglossia latinae, su un piano personale e escatologico, con la conferma del supe-ramento di una visione municipale e la polarizzazione della solleci-tudine verso l’intero dramma umano. L’apostrofe in latino, congiun-ta alle lacrime delle donne-virtù, racchiude così una molteplicità di
18 Questo sottolinea anche la differenza rispetto alla preghiera alla Verginepronunciata da San Bernardo che resta, per le analogie che sono state notate conl’Ave Maria nota ai fedeli, conforme alla preghiera ‘originale’. Il Pater Noster costi-tuisce invece una modificazione essenziale della preghiera liturgica.
19 A. MARCHESE, Dizionario di retorica e di stilistica, Arte e artificio nell’uso delleparole, Milano, Mondadori, 19844, p. 291.
20 Purg. XXXI 97-99: «Asperges me» intonano gli angeli che riproducono fedel-mente un versetto del Miserere (Salmo L 9).
21 Purg. XXXIII 10-12: «Modicum, et non videbitis me; / et iterum, sorelle miedilette, / modicum, et vos videbitis me»; vd. Z. BARA�SKI, Dante e i segni. Saggi peruna storia intellettuale di Dante Alighieri, Napoli, Liguori, 2000, cap. 2 I segni diDante e particolarmente cap. 3. «Modicum, et non videbits me», pp. 57-65.
SABRINA FERRARA216
significati, poiché ha, in realtà, il ruolo di suggellare la terrificanterappresentazione del carro di cui esprime l’ultimo pannello grazieall’enjambement narrativo. Nello stesso tempo, per il tono grave, essaprepara la predizione profetica della redenzione etico-politica delmondo che si concretizza, qualche verso dopo, nell’annuncio del«cinquecento diece e cinque» (Purg. XXXIII 43). Assume dunque lafunzione sia di principio che di conclusione, di rottura e di rinnova-mento. Nello stesso modo è concepita dall’autore l’apostrofe che faufficio di prologo del canto VII del Paradiso: «Osanna, sanctus Deussabaòth, / superillustrans claritate tua / felices ignes horum mala-còth!». In questa terzina la diglossia è accresciuta dall’uso simulta-neo del latino e dell’ebraico secondo un uso liturgico assai esteso; ebenché si tratti di una pratica frequente, annuncia tuttavia la solen-nità che caratterizza il canto VII, costituendosi, nello stesso tempo,come un imponente epilogo del canto precedente. Nello stesso mododell’esempio purgatoriale, l’inno del Paradiso si configura come unelemento di continuità tra la visione storica presentata dall’animanel canto VI e la conclusione teologica del canto VII. All’epoca dellaredazione del Paradiso, l’evoluzione della riflessione politica del poetasi era, in effetti, rivolta verso una dimensione sempre più trascen-dente che includeva l’istituzione imperiale, spingendo l’autore a darerisalto alla funzione sacra dell’Impero romano che aveva preparatol’Incarnazione. Mentre nel canto VI l’autore aveva presentato la mortedi Cristo riprendendo i concetti del diritto romano, nel canto VII nefornisce la spiegazione teologica giustificandola con l’immenso amoredi Dio verso gli uomini. La giunzione tra la storia imperiale e l’arca-no della Redenzione, una volta l’atto di amore divino preparato daRoma grazie all’unità dell’Impero, si effettua allora attraverso lacitazione biblica che suggella il discorso di Giustiniano e anticipa,nei concetti e nella terminologia, l’argomento del canto VII, con unsusseguirsi d’immagini legate alla luce e riprese dalla retorica.22 Ancorauna volta, l’autore propone ai lettori un procedimento retorico che,sotto la semplice apparenza dell’apostrofe, si rivela in realtà moltopiù ambivalente e complesso, essendo epilogo e prologo nello stessotempo, riunendo in sé i campi nozionali di ciò che lo ha precedutoe di ciò che seguirà.
22 Par. VII 6 («doppio lume»), 8 («faville»), 60 («fiamma d’amor»), 65 («arden-do in sé, sfavilla»), ecc.
LE STRATEGIE AUTORIALI NELLA COMMEDIA 217
Tra gli altri numerosi usi dell’apostrofe, nelle forme più eteroge-nee,23 un suo impiego ci sembra meritare un’attenzione particolarea causa principalmente della sofisticazione retorica. Il vigore con-cettuale del pensiero incita sovente l’auctor a una condensazioneretorica di effetto sicuro sul lettore, che si trova costretto a fermarsiper ritrovare la struttura formale ed è mosso in seguito ad interro-garsi sui propositi tenuti. L’esempio più evidente è senza dubbio quellodell’acrostico del canto XII del Purgatorio, la cui disposizione com-plessa s’articola a un livello superiore poiché si fonde con un sistemad’apostrofi. La sequenza poetica che comprende le quattro apostro-fi (Purg. XII 25-63, soprattutto 37-48) si costruisce in una sorta dicerchio chiastico tra una prima intuizione visiva del pellegrino,imperfetta, seguita dall’esortazione morale dell’auctor, e una secon-da visione più netta delle anime e del loro castigo, da cui erompe laseconda, più violenta, invettiva di Dante. A questa corrisponde unaterza, preparata dalla serie di esempi di superbia punita; si ritrova,infine, l’ultima esortazione sotto la forma di un’interrogazione reto-rica. Il processo di comunicazione non è quindi lo stesso. Nella primae nella terza sequenza, Dante-autore interviene per accompagnare ilpersonaggio e i lettori che lo seguono nel viaggio morale verso lasalvezza avvertendoli ed esortandoli ad essere saldi nel loro slancioverso Dio («o gente umana, per volar sù nata» Purg. XII 95). Laposizione dell’autore è sempre dominante, ma resta affabile e quasipaterna verso il lettore. Al contrario, evolve e assume i contorni diuna minaccia dopo l’apparizione distinta e la rappresentazione qua-si inumana delle anime ovvero come dopo la visione degli esempi disuperbia. Procedendo dalla medesima istanza autoriale, la funziona-lità poetica e etica si personalizza in modo fondamentalmente diver-so: di incoraggiamento e di avvertimento verso gli uomini di buonavolontà, di disapprovazione e di veemente biasimo verso i «superbicristiani» (Purg. X 121), obnubilati dai beni caduchi del mondo enon coscienti della giustizia divina. Il rapporto che l’autore instaura
23 Ricordiamo a titolo d’esempio la funzione più semplice d’apostrofe, quellache il pellegrino o Virgilio rivolgono alle anime e viceversa (Inf. V 80, 88; Inf. VI 40;Inf. X 22; Inf. XIV 63, ecc.; Purg. III 73; Purg. IV 127; Purg. XIII 85, 94; Purg. XVI 31;Purg. XX 34, ecc.; Par. III 37; Par. V 115; Par. XXVI 91, 92, ecc. ovvero quella con-giunta con l’invocazione alle Muse, all’intelligenza, ecc. (Inf. II 7, 8; Purg. I, 8; Purg.XXIX 37; Par. I 13, 22, ecc.).
SABRINA FERRARA218
con il proprio lettore si differenzia per una duplice disposizionerelazionale, di affinità o di distanza, che dà luogo a una duplicesoluzione poetica, invisibile tuttavia nella forma retorica.24
2. La figura dell’occultazione: la perifrasi autoriale
Accanto a un linguaggio libero, autonomo ed esplicito, nel qualela presenza autoriale o narratoriale si impone e la comunicazionecon il lettore è regolata da una struttura spesso iussiva, ma sempreperformativa, la Commedia stringe con il lettore una comunicazionepiù ‘silenziosa’ che mette in evidenza chiaramente i due piani paral-leli di comunicazione: il primo, immediato e diretto, proprio di ogniopera letteraria, il secondo, dissimulato e latente, affidato all’acumedel lettore. Alla costituzione di questo secondo piano, muto ed el-littico, concorre anche la retorica. Nello stesso modo in cui avevasostenuto il primo grazie all’uso di figure come l’apostrofe e l’invet-tiva, così, in perfetta opposizione, ma anche, talvolta, in simbiosicon le figure dell’esplicitazione, Dante si serve della categoria dellefigure occultatrici, come la preterizione o la perifrasi. La scelta diconcentrarci particolarmente su quest’ultima sta nel fatto che costi-tuisce l’immagine speculare, nell’occultazione, dell’apostrofe, tantoper le finalità quanto per gli usi.
Impiegata a profusione dal poeta fiorentino, la perifrasi dislocail nodo nozionale dal campo lessicale a quello sintattico. In questomodo riflette la posizione del locutore rispetto al contenuto enun-ciato. Dispone, inoltre, rispetto all’allocutario una prospettiva dienunciazione che è quella di un’adesione referenziale ideale. In ef-fetti, piuttosto che sviluppare per esplicitare meglio, la perifrasi sicolloca dalla parte della reticenza, dell’allusione, poiché in realtà cripta
24 Sottoscriviamo alla precisa asserzione di N. SAPEGNO che nel suo commentoal canto dice: «Tutto l’episodio della cornice dei superbi è così costruito come unasorta di poetico sermone sulla vanità delle glorie mondane, sapientemente alterna-to di esempi e di eloquenti didascalie». Per di più le apostrofi che si intercalanonella narrazione devono essere lette nel senso della percezione immediata dal let-tore, grazie a una giunzione diretta con la tecnica della predicazione; vd. anche C.DELCORNO, Dante e il linguaggio dei predicatori, in «Letture Classensi», 25, 1996,pp. 51-75 e soprattutto p. 59 ss.
LE STRATEGIE AUTORIALI NELLA COMMEDIA 219
dei dati il cui significato è lasciato alle conoscenze referenziali dellettore, tanto a livello extradiegetico quanto a quello interdiegetico.Queste conoscenze gli permettono di istaurare una serie di legamitra la parola del poema e le realtà storiche e concettuali che, a lorovolta, aiuteranno il lettore a situare le diverse rappresentazioni, geo-grafiche, astronomiche o altro, e i diversi personaggi storici o mitici.Benché la finalità generale sia l’accentuazione, e dunque la stimola-zione dell’attenzione del lettore, resta che le perifrasi rispondono asollecitazioni diverse del poeta. Come per le apostrofi, le perifrasi acarattere polemico-politico sono accompagnate, talvolta, da un tonodisdegnoso e pungente. La più nota in questa tipologia è sicuramen-te quella che designa «l’ombra di colui / che fece per viltate il granrifiuto» (Inf. III 59-60). La modalità dell’enunciato autoriale si attuanella scelta di una perifrasi denotativa in cui il personaggio è spo-gliato del proprio nome per un ‘non-nome’ performativo. L’innomi-natio esplicita quindi non solo la posizione dell’auctor di fronte aquesta dimissione di coscienza, ma la scelta dei lemmi, fra tutti ilfortemente denotato «viltade», definisce concettualmente il perso-naggio indegno di essere designato se non per i suoi atti. Il discorsoè diverso per quanto riguarda l’identificazione, oggetto di curiositàda parte di numerosi commentatori moderni, mentre era certo facil-mente intelligibile per un lettore contemporaneo. Quest’ultima con-siderazione permette di svelare un fattore costitutivo della perifrasi,cioè la condivisione di un contesto referenziale, storico, abituale,geografico o altro tra il locutore e l’allocutario, che talvolta sfuggeal lettore di oggi. Più spesso, tuttavia, le circonlocuzioni appaionochiare anche al lettore moderno. L’attenzione allora, non essendopiù concentrata sull’enigma del riconoscimento, si sposta dalla sferaaneddotica alla sfera nozionale la quale induce il lettore a un altrogenere di decodificazione cognitiva che consiste nel rintracciare ri-ferimenti interdiegetici i quali, a loro volta, permettono di tracciaree di ricostruire la storia ‘etica’ del personaggio. La perifrasi «mal diFrancia» riferita a Filippo il Bello (Purg. VII 109), pur riprendendole modalità osservate a proposito di Inf. III (l’innominatio, la carat-terizzazione morale del personaggio segnata da un uso sapiente dellessico, lo scopo iussivo, ecc.), costituisce un semplice elemento delquadro globale del re di Francia. Al lettore resta il compito di ripo-sizionare i diversi frammenti che ritroverà nel corso della lettura. Lafigura di Filippo non potrà quindi essere pienamente intesa nella
SABRINA FERRARA220
sua integralità senza avere in mente i suoi rapporti con la Chiesa, eparticolarmente, con il papa Clemente V, illustrati in Inf. XIX 82–87(«“ché dopo lui verrà [...] un pastor sanza legge, / tal che convienche lui e me ricopra. / Novo Iasón sarà, di cui si legge / ne’ Macca-bei; e come a quel fu molle / suo re, così fia lui chi Francia regge”»),in Purg. XXXII 152-153 («vidi di costa a lei [la puttana sciolta] drittoun gigante; / e baciavansi insieme alcuna volta»); o i suoi contrasticon Bonifacio VIII («“Perché men paia il mal futuro e ’l fatto, / veggioin Alagna intrar lo fiordaliso, / e nel vicario suo Cristo esser catto./ Veggiolo un’altra volta esser deriso; / veggio rinovellar l’aceto e ’lfiele, / e tra vivi ladroni esser anciso”» Purg. XX 85-90) e la sua azio-ne contro i Templari, in Purg. XX 91-93 («“Veggio il novo Pilato sìcrudele, / che ciò nol sazia, ma sanza decreto / portar nel Tempio lecupide vele”»). La lettura di questi versi in successione palesa unacapacità estremamente varia di usare figure retoriche riferite al per-sonaggio reale (metafora – gigante, fiordaliso – ; perifrasi – chi Fran-cia regge, il novo Pilato – ; anafora – Veggio [...] veggiolo [...] veggio[...] veggio –), che hanno tuttavia in comune il silenzio che avvolgeil nome del re di Francia, silenzio reiterato dall’antenato Ugo Cape-to,25 riprendendo quasi gli stessi termini del canto VII del Purgatorio,e riproposto dall’aquila nel contesto assai parlante di Par. XIX. Enun-ciando il principio secondo cui la fede può salvare l’individuo chel’associa ad opere buone, l’emblema imperiale indica certi esempi,tutti di sovrani, nei quali la fede proclamata, si accompagna, al con-trario, di cattive azioni. Ora, tra questi sovrani, l’aquila designa sen-za possibilità di dubbio re Filippo con una perifrasi particolarmentesprezzante: «“Lì [nel libro della vita] si vedrà il duol che sovra Sen-na / induce, falseggiando la moneta, / quel che morrà di colpo dicotenna”» (Par. XIX 118-20).26
25 Purg. XX 43-44: «Io fui radice de la mala pianta / che la terra cristiana tuttaaduggia», cfr. «il mal di Francia» di Purg. VII 109.
26 Rilevante e fortemente incisiva la metonimia «cotenna» per «cinghiale» che,se secondo i primi commentatori era uso fiorentino frequente per indicare la pelledel cinghiale (cfr. Benvenuto da Imola: «“di colpo di cotenna”, idest, dente apri.Nam in vulgari florentino cotenna solum appellatur cutis porci grossa et setolosa»;Cristoforo Landino: «“da colpo di cotenna”, perché cotenna chiamono e Fiorentinila pelle del porcho») è tuttavia prova di un volitivo dileggio verso il re di Franciadegno, non di morire in guerra o da cavaliere nobilmente, ma spregevolmente ferito
LE STRATEGIE AUTORIALI NELLA COMMEDIA 221
Un anonimato analogo e altrettanto eloquente definisce la figuradel papa Clemente V, il quale si trova evocato nello stesso contestoinfernale (quello dei simoniaci, Inf. XIX) di Filippo, e designato dallaperifrasi biblica rovesciata «“un pastor sanza legge”».27 Filippo eClemente sono così uniti da uno stesso silenzio ammonitore, ancorapiù eloquente nel caso del papa, poiché si oppone alla parola formu-lata e palese che designa, invece, l’imperatore Arrigo di Lussembur-go, il suo avversario politico, in Par. XXX 133-38.28
L’auctor si avvale quindi della retorica per lasciare apparire lapropria concezione etica, palesata nella polemica contro il papato especialmente contro il tanto aborrito Bonifacio VIII. Questi è «“ilgran prete”» (Inf. XXVII 70) a cui augura tutto il male e «“lo principed’i novi Farisei”» (Inf. XXVII 85) che combatte i cristiani come sefossero saraceni o ebrei. È l’uomo che a causa della sua «“superbafebbre”» (Inf. XXVII 97) di potere, ha perso l’anima di Guido daMontefeltro non indietreggiando davanti ad alcun ostacolo ingan-nandolo con la promessa della salvezza.29 Bonifacio è colui che, es-
solo dalla parte più vile del cinghiale, la grossa pelle. Per la sineddoche su Filippo,cfr. M. MARIETTI, Le «desordre» terrestre, in «Chroniques Italiennes», Paris, Uni-versité de la Sorbonne Nouvelle – Paris III, 65, 2001, pp. 7-25 e particolarmentep. 13, ora in M. MARIETTI, L’umana famiglia. Studi sul Paradiso, Roma, Aracne, 2011,pp. 187-208.
27 La retorica del silenzio (l’espressione è presa in prestito al titolo del libro diD. COFANO, La retorica del silenzio nella «Divina Commedia», Bari, Palomar, 2003)nelle sue diverse manifestazioni è applicata dall’autore al papa Clemente V, maidenominato con il suo nome, ma sempre designato da sostituzioni; cfr. le antono-masie di Par. XVII 82: «ma pria che ’l Guasco l’alto Arrigo inganni», dove è tantopiù rilevata grazie alla prossimità con l’imperatore, il quale è, invece, chiaramentenominato; oppure di Par. XXVII 59-60: «Del sangue nostro Caorsini e Guaschi /s’apparecchian di bere», in cui il guasco Clemente è associato al caorsino Giovan-ni XXII, altro papa indegno. Od anche dal pronome indefinito «tal» cfr. Par. XXX
142-144: «E fia prefetto nel foro divino / allora tal, che palese e coverto / non anderàcon lui per un cammino», dove l’indeterminazione è messa in evidenza dall’accen-to e dall’assoluta precisione qualificativa del sintagma aggettivale antitetico «pale-se e coverto».
28 «E ’n quel gran seggio a che tu li occhi tieni / per la corona che già v’è sùposta, / prima che tu a queste nozze ceni, / sederà l’alma, che fia giù agosta, / del’alto Arrigo, ch’a drizzare Italia / verrà in prima ch’ella sia disposta»: queste ter-zine devono essere lette in relazione alla terzina 142-144.
29 Inf. XXVII 103-105: «Lo ciel poss’io serrare e disserrare, / come tu sai; peròson due le chiavi / che ’l mio antecessor non ebbe care».
SABRINA FERRARA222
sendo l’Impero vacante, se ne arroga il potere unendo «“la spada /col pasturale”» (Purg. XVI 109-10), è il simoniaco atteso da NiccolòIII («Ed el gridò: “Se’ tu già costì ritto, / se’ tu già costì ritto, Boni-fazio?”» Inf. XIX 52-53,30 in cui l’apostrofe accompagnata dalla ripe-tizione non fa che accrescere l’attesa del lettore, attesa che diminui-rà solo con la forte agnizione in chiusura),31 la cui predizione saràreiterata nel canto XXX del Paradiso dalla profezia di Beatrice cheassocia in un unico peccato Bonifacio e Clemente: «“ch’el [scil.Clemente V] sarà detruso / là dove Simon mago è per suo merto, /e farà quel d’Alagna intrar più giuso”» (vv. 146-148). Ancora unavolta il poeta alimenta il tono tagliente della propria parola di ripro-vazione con un complesso sistema di figure retoriche che si intrec-ciano tra di loro. Così la bolgia dei simoniaci è designata con la si-neddoche che rinvia all’origine del peccato, in cui si trova incorpo-rata l’antifrasi «merto», mentre la terzina si chiude su un’ulterioreperifrasi in cui Bonifacio è identificato, questa volta, dall’evocazioneumiliante e degradante dell’affronto subito ad Anagni. La terzinaassume quindi un ruolo esemplare grazie al modo in cui il temapolitico è sorretto da un dispositivo retorico fortemente allusivo chelascia la parola al solo elemento caratterizzante l’intero episodio,«Simon mago». Ora, è proprio Bonifacio che dà la misura della vi-sione etica dell’autore; infatti, mentre il lettore è continuamente messodi fronte all’abiezione morale di questo papa dall’autore, che non siè privato di sottolineare la propria avversione, leggendo il canto XX
del Purgatorio, si trova davanti alla difesa dello stesso papa sempreda parte dell’autore: «“veggio in Alagna intrar lo fiordaliso, / e nelvicario suo Cristo esser catto”» (vv. 86-87); il papa perde, in questoepisodio, la propria individualità peccatrice, incarnando, al contra-rio, il Cristo, nella sua funzione universale di vicario. Attraverso questo
30 La rilevanza è sostenuta anche dall’accentuazione dei due versi: il primo aminore con l’accento principale sul verbo significante del grido del dannato (gridò)e l’accento secondario, nel secondo emistichio, sull’avverbio di tempo (già), che di-venta l’accento principale nel secondo verso, ugualmente a minore, per sottolinearela dannazione del papa ancora in vita nel 1300 e il giudizio impietoso del poeta.
31 La designazione di Bonifacio con il suo nome è il solo caso nella Commediain cui un papa contro il quale si rivolge il biasimo autoriale è chiaramente designa-to. Il risultato è lo stesso della reticenza: l’insistenza e la sollecitazione dell’atten-zione del lettore.
LE STRATEGIE AUTORIALI NELLA COMMEDIA 223
episodio, l’autore incoraggia così il lettore a distinguere all’internodella propria costruzione morale tra il personaggio e la sua funzio-ne. Il contrasto è tanto più codificato in quanto i mezzi retoriciimpiegati non differiscono per nulla: così Bonifacio è ancora desi-gnato con una perifrasi, ma questa volta positiva («vicario suo»),laddove la negatività rappresentata da Filippo è resa con la metoni-mia del «fiordaliso».
Le circonlocuzioni analizzate fin qui, oltre ad entrare nella stes-sa iperisotopia retorico-politica, perifrastica e condannatrice, pre-sentano come altra caratteristica comune il fatto che riguardano di-rettamente gli uomini. Ma la stessa iperisotopia etica definisce, ugual-mente, l’altra categoria di perifrasi, le perifrasi geografiche.
Tra i numerosi riferimenti alla difficoltà dell’ascensione dellamontagna del Purgatorio, aspetto del percorso esemplare dell’agens,la salita alla seconda cornice, degli invidiosi, si effettua da una scalache ricorda a Dante quella che conduce al Monte delle Croci dovesi trova la chiesa di San Miniato:
Come a man destra, per salire al montedove siede la chiesa che soggiogala ben guidata sopra Rubaconte,
si rompe del montar l’ardita fogaper le scalee che si fero ad etadech’era sicuro il quaderno e la doga;
così s’allenta la ripa che cadequivi ben ratta da l’altro girone;ma quinci e quindi l’alta pietra rade.
(Purg. XII 100-108)
Le tre terzine, come sovente, si prestano a una lettura polisemicae fortemente denotativa. La più immediata interpretazione, che nonè per la sua immediatezza meno autentica e veridica, riporta allapreoccupazione, sempre presente nel poeta, di rendere accessibileai propri lettori ciò che non lo è. Giacché la salita del Purgatorionon fa parte delle esperienze ordinarie degli uomini, il narratore lariporta a una conoscenza più quotidiana e consueta, all’immagineusuale legata alla chiesa di San Miniato. L’argomentazione fa tutta-via nascere, spontaneamente, l’interrogazione su quale fosse il pub-blico a cui Dante intendeva rivolgersi; se infatti la similitudine po-
SABRINA FERRARA224
teva essere familiare e compresa facilmente dai fiorentini, potevaugualmente restare ermetica per la maggior parte dei lettori, almenocoloro che non si erano recati a Firenze. La conclusione, forse unpo’ affrettata, ma non per questo meno attendibile, che i destinatariprincipali del poema fossero i fiorentini, merita tuttavia delle preci-sazioni. Per ragioni personali, legate al proprio esilio e al propriostatuto sociale e artistico, Dante-autore prefigurava effettivamentecome destinatari della propria opera i suoi concittadini, e servendo-si della memoria dei luoghi che gli erano usuali incoraggiava l’usoemozionale dei ricordi.32 Questi, nondimeno, apportano l’amarosarcasmo verso la propria città natale, designata con un’antifrasi («laben guidata»), e più particolarmente lasciano emergere il contrastotra l’antica Firenze, che i magistrati avevano a cuore e di cui cura-vano gli interessi, e la nuova Firenze nella quale essi tramano le frodidel «quaderno» e della «doga». La reminiscenza e la menzione dellacittà toscana rientrano, ancora una volta, nella tonalità dominanteche caratterizza l’evocazione di Firenze, il biasimo e l’ammonimen-to. E se questi sono, in primo luogo, rivolti contro i governanti, controla classe politica, il contesto referenziale storico che si rapporta airegistri e alle misure, dunque a episodi strettamente municipali,interpellava anche un pubblico cittadino più vasto, identificato,dapprima, come risolutamente toscano, in seguito esteso a quellodell’Italia settentrionale.
Le perifrasi politiche integrano perciò la tipologia propria del-l’auctor, la quale comporta diverse sottocategorie tematiche. Ancheuna lettura non esaustiva permette al lettore di isolare altri nodiperifrastici emananti sempre dall’istanza autoriale. Così il nome diDio risponde a diverse sollecitazioni nozionali; in Inferno, l’impos-sibilità di pronunciarne il nome, indicato senza eccezione con una
32 Cfr. Benvenuto da Imola: «Nunc poeta describit ipsum ascensum ad secun-dum circulum per unam comparationem domesticam patriae suae»; Umberto Boscoe Giovanni Reggio: «era del resto naturale che Dante istintivamente pensasse so-prattutto a lettori fiorentini. Ma con la scala gli balza subito alla memoria il paesag-gio di quella parte di Firenze: il monte che sovrasta la città, con la bella chiesa; aisuoi piedi il fiume col ponte: un’apertura della fantasia su un panorama tipico dellacittà: è questa improvvisa visione che suscita un improvviso (e non necessario nelcontesto) moto di nostalgia, e con la nostalgia l’amarezza e il rimpianto per il buontempo antico».
LE STRATEGIE AUTORIALI NELLA COMMEDIA 225
circonlocuzione,33 coincide con lo scarto ontologico tra la volontà diDio e le azioni degli uomini che contraddistingue questo regno, ri-conducendo il lettore alle nozioni della libertà umana e del liberoarbitrio. Le anime infernali sono dannate per non avere fatto le loroscelte in conformità con la volontà divina, e quindi non solo nonpossono opporsi a questa come hanno fatto in vita, ma per di piùsono prive anche solo di sentir proferire l’appellativo di Dio. Que-sto stesso procedimento di non-denominazione nozionale non èunicamente applicato alla parola emanante dalle anime34 o rivoltaloro, e dunque al dispositivo mimetico, ma costituisce uno deglielementi strutturanti della narrazione diegetica della cantica; talvol-ta è il pellegrino che usa un sintagma perifrastico all’inizio del viag-gio,35 oppure Virgilio nell’esposizione sulla natura dell’amore divinonel Purgatorio 36 ovvero ancora direttamente la voce autoriale nellaprima terzina del canto I del Paradiso. Interessante perifrasi, questadel Paradiso, poiché introduce un nuovo aspetto delle circonlocu-zioni divine. Il prologo della terza cantica inizia con l’esaltazionedella gloria di Dio: «La gloria di Colui che tutto move / per l’univer-so penetra e risplende / in una parte più e meno altrove» (Par. I 1-3). La cantica si apre non su Dante, personaggio o autore, come erail caso per le due precedenti, ma sull’immagine solenne di un Dioche regge e governa l’universo come motore supremo,37 che penetraogni creatura di una vita specifica e opera non come una forza do-minatrice, ma come una luce che illumina le creature. La perifrasiincipitaria si afferma subito come caratterizzata da una molteplicitàsemica, poiché, da una parte esprime la profonda concezione spiri-tuale sulla quale è fondata l’esistenza ontologica di Dante-uomo, valea dire la costante tensione verso la perfezione umana e quella di ogniuomo verso il Creatore; d’altra parte assume un valore funzionale poiché
33 Inf. III 95-96: «vuolsi così colà dove si puote / ciò che si vuole, e più nondimandare». Virgilio si serve di un’espressione identica nel canto V (vv. 22-24)dell’Inferno per obiettare a Minosse e di una formula simile contro Pluto nel cantoVII: «vuolsi nell’alto, là dove Michele / fé la vendetta del superbo strupo», vv. 11-12.
34 Cfr. per esempio Francesca nel V: «se fosse amico il re dell’Universo / noipregheremmo lui de la tua pace», vv. 91-92.
35 Inf. II 16: «l’avversaro d’ogne male», che canalizza l’attenzione sulla bontàcome facoltà distintiva della divinità, cfr. anche Purg. XXVIII, 91: «Lo sommo bene».
36 Purg. XV 67-68: «Quello infinito ed ineffabil bene / che là su è».37 Cfr. Purg. XXV 70: «lo motor primo».
SABRINA FERRARA226
riassume l’essenza modellizzante della poesia del Paradiso, annunciandola modificazione poetologica dell’ispirazione ormai metafisica.
Il lettore ritrova uno stesso meccanismo autoriale in una sequen-za fortemente connotata concettualmente. Nel terzo canto del Pur-gatorio, Dante-pellegrino incontra Manfredi al quale l’autore dà laparola tanto per principiare l’isotopia strutturale delle preghiere,quanto per proseguire la polemica politico-ecclesiastica. Questa è,d’altronde, nutrita delle perifrasi divine («“quei che volontier per-dona”», v. 120, «“la bontà infinita”», v. 122) che si inseriscono nel-l’affabulazione del re svevo. Scomunicato dalla Chiesa, Manfredi eradannato agli occhi del mondo, dannazione resa tanto più inequivo-cabile dall’affronto che gli uomini di Clemente IV avevano inflittoal suo corpo. Ora, all’inizio della narrazione, dopo l’agnizione e primadel ricordo della sorte serbata al corpo, Manfredi evoca, con unasola parola «piangendo» la propria contrizione e il destino spiritualeche lo attende: «“io mi rendei, / piangendo, a quei che volentierperdona. / Orribil furon li peccata miei; / ma la bontà infinita ha sìgran braccia, / che prende ciò che si rivolge a lei”» (Purg. III 119-23).Il forte contrasto tra gli «orribili peccati» e la bontà infinita di Diodà la tonalità di questi versi che acquisiscono una valenza esempla-re, non solo perché sottolineano la bontà divina, ma più di ogni altracosa perché, grazie alla perifrasi («quei che volentier perdona»), sioppone, a contrario, agli uomini che invece non perdonano, nel casospecifico agli ecclesiastici. La figura retorica è preposta all’enuncia-zione dell’antinomia tra i disegni divini e le azioni umane, antinomiatanto più efficace in quanto gli uomini a cui Manfredi si riferiscesono uomini di Chiesa.
3. Un intreccio efficace di figure opposte: Purgatorio XIV 1-66
La presa di parola diretta dell’autore, nella maggioranza delleapostrofi, lascia il posto alla parola che i personaggi trasmettono ailettori, come si nota nella ripresa concettuale della decadenza delmondo provocata dalla perdita delle virtù e dei valori morali. Que-sta ripresa è affidata, nel canto XIV del Purgatorio, a Guido del Ducail quale reitera la polemica, in particolare contro Firenze, ma ingenerale contro la Toscana attraverso la creazione di un vero e pro-prio ‘bestiario’:
LE STRATEGIE AUTORIALI NELLA COMMEDIA 227
Tra brutti porci, più degni di galleche d’altro cibo fatto in uman uso,dirizza prima il suo povero calle.
Botoli trova poi, venendo giuso,ringhiosi più che non chiede lor possa,e da lor disdegnosa torce il muso.
Vassi caggendo; e quant’ella più ’ngrossa,tanto più trova di can farsi lupila maladetta e sventurata fossa.
Discesa poi per più pelaghi cupi,trova le volpi sì piene di froda,che non temono ingegno che le occùpi.
(Purg. XIV 43-54)
La forza della parola si annuncia nella singolarità della voce cheapre, ex abrupto, questo canto sotto la forma mimetica del dialogotra due anime che si riveleranno quelle di Guido e di Rinieri daCalboli. Innovazione assoluta, e tale resterà nella sua unicità, dal puntodi vista comunicativo nel poema. Originalità dovuta al fatto eccezio-nale di un uomo vivo che attraversa il Purgatorio, e che, per di più,nella cornice degli invidiosi le cui palpebre sono cucite con un fil diferro «apre li occhi a sua voglia e coverchia» (Purg. XIV 3). Ora, poichél’osservazione dell’aspetto straordinario del viaggio di un uomo vivonei regni dell’aldilà non era una novità per il pellegrino ed era giàstato oggetto di curiosità per le anime, ci si domanda che cosa puògiustificare questa innovazione. Se la reticenza di Dante a nominarsipuò apparentarsi alla problematica presente nel poema, legata allanozione di orgoglio, essa insinua ugualmente una tonalità differenteper l’eccezionalità evocata. Tanto più che il viator proviene da quelpaese di cui si fa bene a tacere il nome, in una struttura volontaria dipreterizione («ma degno / ben è che ’l nome di tal valle pera» Purg.XIV 29-30), che suscita immediatamente la reazione emotiva dell’ani-ma nella forma dell’invettiva. Questa, presentandosi come la conti-nuazione ideale dell’apostrofe del canto VI, costituisce uno stadiosuperiore nella diffrazione nozionale, nel nostro caso politico-morale,che il poeta opera nel poema. Una perfetta simmetria numerica38 rit-
38 Il discorso si compone di dodici terzine: le prime quattro descrivono la valledell’Arno e i suoi abitanti in generale; le quattro seguenti precisano in quattro
SABRINA FERRARA228
ma la desolante progressione del male che si diffonde nella valledell’Arno, «misera valle» (Purg. XIV 41), culminante in Firenze, «tri-sta selva» (Purg. XIV 64), e che non manca di ricordare la «selvaselvaggia», la selva oscura della dannazione infernale. Il lettore sitrova così davanti a una disumanizzazione degli abitanti che sonotrasformati in bestie. Una parte dei codici interpretativi di questametamorfosi, che non interessa unicamente l’aspetto esteriore, mapiù profondamente la vera natura («hanno sì mutata lor natura / liabitator de la misera valle» Purg. XIV 40-41), non è lasciata alla ca-pacità di comprensione dei lettori, ma è chiaramente annunciata inun’epigrafe morale di forte pregnanza: «vertù così per nimica si fuga/ da tutti come biscia, o per sventura / del luogo, o per mal uso cheli fruga» (Purg. XIV 37-39). Il campo semantico orienta il lettore versoun’angolazione esplicitamente etica di lettura che riprende il dialo-go concettuale e intertestuale già cominciato. Il declino dei Toscanisi lega concettualmente alla reiterazione del peccato originale, nellasua accezione più vasta, come rifiuto della virtù e come scelta delvizio. I termini tradizionali della metafora sono capovolti: i Toscanidisertano i valori morali come se fossero nemici, come altri fuggi-rebbero invece il serpente, in un accostamento che sembrerebbe quasifare di quest’ultimo un simbolo di virtù; mentre il serpente, sotto lastessa denominazione di «biscia»39 è associato all’antico avversario,il demonio, e alla tentazione edenica, associazione che non può sfug-gire al lettore. Ci si può allora domandare se la ripresa dello stessocampo semantico legato al peccato non voglia ricondurre al signifi-cato originale mostrando dunque che i Toscani sono sconfitti dalla«biscia», dall’«avversario» (Purg. XIV 38 e Purg. VIII 95), immaginedella tentazione già poeticamente sfruttata nella valle fiorita (Purg.VIII 95-99) e ripresa naturalmente nel Paradiso Terrestre (Purg. XXXII
130-35). Per di più, la disumanizzazione e la degradazione dei trattiumani, distintivi delle anime infernali, ritrovano il loro posto, non inPurgatorio, ma sulla terra e appunto in Toscana dove prendono unadimensione interamente morale e spirituale. La Toscana non solo fa
emblemi animalieri (uno per terzina) gli abitanti dal Casentino a Pisa; le ultimequattro si risolvono in una profezia che trova il proprio punto di partenza nelladescrizione dell’operato di Fulceri da Calboli a Firenze.
39 Cfr. Purg. VIII 97-99: «Da quella parte onde non ha riparo / la picciola vallea,era una biscia, / forse qual diede ad Eva il cibo amaro».
LE STRATEGIE AUTORIALI NELLA COMMEDIA 229
così «figura» d’Inferno, di cui il poeta ha forse voluto riprodurre ladisposizione morale, ma è l’Inferno stesso su terra poiché si è sotto-messa al serpente e si è eretta contro la saggezza divina. Letti allaluce dell’intertestualità metaforica e polemica e degli emblemi ani-mali e infernali, questi versi illustrano gli argomenti dell’aspra invet-tiva del canto VI attraverso elementi referenziali d’accesso immedia-to per un largo pubblico, come il ‘bestiario’, mettendo così semprepiù in rilievo la grazia accordata al pellegrino toscano.
Il territorio toscano costituisce appunto l’oggetto della perifrasimediante la quale Dante rivela la propria identità a Guido e a Rinie-ri: «Di sovr’esso rech’io questa persona: / dirvi ch’i’ sia, saria parlareindarno, / ché ’l nome mio ancor molto non suona”». Il dialogo inizialetra le due anime ricomincia:
“Se ben lo ’ntendimento tuo accarnocon lo ’ntelletto”, allora mi rispuosequei che diceva pria, “tu parli d’Arno”.
E l’altro disse lui: “Perché nascosequesti il vocabol di quella riviera,pur com’om fa de l’orribili cose?”
(Purg. XIV 22-27)
L’ultima domanda posta da Rinieri presenta un interesse parti-colare poiché si tratta, senza dubbio, di una replica autoriale meta-linguistica. L’auctor attraverso un personaggio incita il lettore a ri-flettere sul procedimento narrativo adottato e sulle ragioni che han-no potuto determinare il suo uso in un contesto che si svela, rapida-mente, come polemico. A partire da una riflessione congetturale,l’incontro di Guido e Ranieri appunto, l’autore offre al lettore indi-cazioni più globali sulla finalità della perifrasi politica. Benvenutoaveva commentato la terzina sottolineando unicamente la circonlo-cuzione, senza operare una differenziazione nozionale rispetto adaltri usi della stessa figura;40 in realtà, il commento di Benvenuto,
40 Benvenuto da Imola: «Nam res inhonestae et infames solent velari sub aliaforma verborum; sicut poeta noster pulcre et honeste facit Inferni capitulo XXV,ubi volens nominare virile membrum, dicit: Lo membro che l’uom cela; et infra XXVcapitulo Purgatorii, volens dicere quod sperma descendit ad testiculos, dicit: scen-de ov’è più bel tacer che dire; et ita de multis. Et ponit responsionem socii, qui dicitse ignorare causam veram, sed interpretatur quae causa potuit illum movere».
SABRINA FERRARA230
pur adattandosi perfettamente alla definizione teorica della perifra-si, occupa, in una tela a sfondo politico, un ruolo di forte connota-zione concettuale. La questione, che, a prima vista, potrebbe appa-rire ridondante al lettore poiché nella terzina precedente Guido avevadecifrato prontamente il «fiumicel» di cui il pellegrino aveva parla-to, è, al contrario, essenziale, non solo per l’intelligibilità dell’episo-dio seguente e del pensiero dell’autore, ma anche come elementodelle modalità di lettura auspicate. Nello stesso tempo fornisce laspecificità della figura retorica di cui si è appena servito, visto chesi tratta sicuramente di ‘nascondere’ il nome di qualcosa. E se nellacontingenza l’interrogazione riguardava l’Arno, essa soddisfa altresìl’esigenza autoriale di spingere il lettore a porsi una tale domandaogni volta c’è codificazione nel testo. Evidentemente se la rispostanon può essere simile in tutte le circostanze di occultazione dellaparola, resta tuttavia identica, nelle modalità, per quanto riguarda leperifrasi politiche, che si definiscono con denotazioni talmente ne-gative che ne rendono impossibile l’espressione manifesta, «purcom’om fa de l’orribili cose».41 La chiave di lettura di queste è cosìfornita dallo stesso autore; al lettore non resta che indagare sulla naturadella ‘cosa orribile’ e innominabile che viene celata. In questa otticala perifrasi descrittiva dei versi 16-18 di Purg. XIV («Per mezza Tosca-na si spazia / un fiumicel che nasce in Falterona / e cento miglia dicorso nol sazia») è già una metafora morale, tanto più se il lettore ritrovale corrispondenze interdiegetiche a proposito dell’Arno, che era il «belfiume d’Arno» in Inf. XXIII 95 e il «fiume real» in Purg. V 122.
Dopo avere notificato il principio generale, Dante presta la pro-pria voce a Guido che dà vita a una violenta apostrofe-invettivainteramente organizzata nella forma di un susseguirsi di perifrasiriguardanti la Toscana. L’abile costruzione autoriale della parola diGuido mostra che la ripartizione stilistica si articola in una succes-sione di perifrasi che segnano non solo i limiti geografici, ma anchequelli temporali. Esse non introducono solo in modo completamen-te criptato la valle dell’Arno e i suoi abitanti, ma focalizzandosi sullosviato tempo presente, si risolvono in una profezia (Io veggio...)
41 Non è ininteressante notare che l’endecasillabo a minore, nel secondo emi-stichio, presenta un raro accento sulla 7 sillaba corrispondente all’accento tonicodel lemma «orríbili».
LE STRATEGIE AUTORIALI NELLA COMMEDIA 231
annunciante un futuro ‘sanguinoso’ che lo sarà altrettanto (vv. 55-66). Attraverso la potente evocazione del nipote di Rinieri da Calbo-li, antica belva, Guido disloca con la propria parola, geograficamen-te, il biasimo morale alla propria terra, la Romagna, menzionata conuna perifrasi racchiusa in un sol verso dove sono indicati con grandeprecisione le frontiere dell’epoca, tra il Po, l’Appennino, il mareAdriatico e il Reno: «tra ’l Po e ’l monte e la marina e ’l Reno» (Purg.XIV 92). La reiterazione di questa tecnica allusiva pone il lettore inuna posizione di attesa negativa, poiché dopo la Toscana, anche laRomagna sembra essere indegna; e se Firenze è la «trista selva», laRomagna è una foresta di «venenosi sterpi» (Purg. XIV 95). La ri-prensione e l’indignazione cedono il posto al rimpianto per il tempopassato quando Guido risale agli uomini che sono stati l’onore e lagloria della sua terra. Le modalità enunciative della trasmissionecambiano e l’intransigenza del moralista verso il proprio paese (Purg.XIV 37-39, 41), si trasforma in desiderio di liberarlo facendo appelloalle virtù del passato «cortese». Questo passato, degno di esseremenzionato, fa abbandonare all’autore la reticenza indignata dietrola quale aveva occultato il proprio disprezzo, per addentrarsi nellaretorica esplicita delle apostrofi, delle interrogative dirette, nomi-nando ogni volta gli uomini che fecero l’onore dell’antica Romagna.
L’esemplificazione delle due strutture retoriche dell’apostrofe edella perifrasi, parallele ma divergenti, nella loro concezione mostraun uso della retorica che non si risolve in una soluzione estetica, inuna ricerca di raffinamento stilistico, ma che si singolarizza per ilforte valore semico e etico, come le altre formule retoriche che so-stengono quasi invariabilmente l’ordito etico del poema. L’intrecciotra retorica e dialettica emerge in tutta evidenza quando Dante-au-tore interviene in modo esplicito rivolgendosi direttamente al letto-re negli appelli o in certe apostrofi che, sovente, prendono la formadell’invettiva incorporando l’iperisotopia politica. Non è quindiinaspettato constatare che la maggior parte delle invettive politicherinviano a città italiane e che sono articolate nella cantica infernale,come, ad esempio, le invettive contro Pistoia (Inf. XXV 10-12), con-tro Pisa (Inf. XXXIII 79-90) e contro i Genovesi (Inf. XXXIII 151-53).Firenze, oggetto di uno stesso tono profetico, occupa un posto aparte (Inf. XVI, Inf. XXVI; Purg. VI, Purg. XIV); tono tuttavia sfumatodall’amore che il poeta porta alla propria città, ed espresso sovente
SABRINA FERRARA232
con sarcasmo. Su un piano parallelo, tematico questa volta, il campopolitico e il campo religioso sono anch’essi fortemente intrecciati. Ilcanto XIX dell’Inferno vincola a una lettura facilmente accessibile ditali propositi, poiché è costituito da sette apostrofi che alternano ilritmo dell’invettiva con quello dell’esortazione, e che presentano lasingolarità di distribuirsi tra la voce autoriale e quella dei personag-gi. Tanto più che, fenomeno quasi unico, l’invettiva dei versi 90-117è pronunciata dallo stesso agens. Tutt’altro che anodino, questoprocedimento invita a una riflessione maggiore essendo latore delladistinzione fondamentale nella costruzione concettuale dantesca trail personaggio del pontefice, che occupa una funzione ed è eventual-mente condannabile, e l’istituzione ch’egli rappresenta, alla quale sideve portare il più grande rispetto. Nel canto XIX dell’Inferno era ilcaso per il papa Niccolò III e per la Chiesa, nel canto VI del Purga-torio la stessa distinzione è operata a proposito degli imperatoricolpevoli di avere trascurato la loro responsabilità e dell’istituzioneimperiale. Sempre strettamente coordinate all’elemento politico, leapostrofi-preghiere alloglotte distinguono il canto XXXIII del Purga-torio e il VII del Paradiso comportando la particolarità di offrire allettore, grazie alla loro posizione metrico-narrativa, un’apertura disperanza, preparando l’evocazione del DXV e la spiegazione dellagiunzione tra la storia imperiale di Roma e la storia di Cristo.
La loro posizione nel contesto metrico di un canto contraddi-stingue altri usi della figura dell’apostrofe di cui Dante si avvale conun’assodata sicurezza. Le apostrofi così possono aprire un canto, inenjambement con il canto precedente (Par. X-XI), e indurre a unapostilla morale che la narrazione del canto precedente aveva susci-tato. Sempre in apertura di canto, in forma di orazione, possonomanifestare uno sfogo dell’animo, come nel canto XXXIII del Paradi-so la preghiera consacrata alla Vergine, ovvero svelare un’audaciafiduciosa dell’auctor grazie alle modifiche apportate alla forma ori-ginale del Pater Noster nel canto XI del Purgatorio.
La reticenza ‘vocale’ individualizza, ex contrario, la modalitàretorica della perifrasi. Non dire per dire meglio, lasciare nell’om-bra per chiarire meglio: la perifrasi inquadra la triade concettual-mente intrecciata poetica/etica/politica. Se le prime due parole pre-cisano la celebre perifrasi di Inf. III in cui la posizione dell’autore èsottolineata non solo dalla discrezione, ma anche da una sapientescelta lessicale, la concezione tricefala si rivela nel disprezzo con cui
LE STRATEGIE AUTORIALI NELLA COMMEDIA 233
l’autore tratta i principali attori politici del suo tempo, Filippo il Bello,re di Francia (Inf. XIX 82-87, Purg. VII 109, ecc.), il papa ClementeV (Inf. XIX 82-87, Par. XXVII 58-60, ecc.) sovente insieme, ovveroBonifacio VIII (Inf. XXVII 70, 85, 97, Par. XXX 145-148). La caratte-rizzazione negativa di questi personaggi non lascia alcun dubbio allettore sulla posizione di Dante e sulla carica comunicativa che at-tribuisce agli strumenti, poetici, retorici e lessicali a propria dispo-sizione, tanto più che essa si coordina con l’affermazione nominaledel protagonista positivo della congiuntura politica, l’imperatoreArrigo VII.
Un caso a parte, singolare e insolito, è costituito dal canto XIV
del Purgatorio, in cui il dialogo tra Guido del Duca e Rinieri da Calbolioffre al lettore la direzione da seguire per interpretare, dal punto divista della ricezione, la perifrasi. Sembrerebbe, infatti, che ciò che sinasconde dietro il silenzio appartenga alla sfera delle «cose orribili»e dunque innominabili. Ora, se l’osservazione di questa figura reto-rica, nella Commedia, non può sostenersi incondizionatamente suquesta asserzione, poiché si trovano esempi di reticenza puramenteestetici, resta tuttavia valida per la sua caratteristica politica. E, inogni circostanza, essa è consustanziale alle modalità autoriali di let-tura; se quindi la soluzione non è sempre «orribile», ogni circonlo-cuzione della parola esige l’attenzione del lettore e rende necessarioporsi la questione del senso recondito. Nello stesso tempo l’ordituraautoriale di perifrasi e di apostrofi fa di questo canto uno specimenin cui la vena polemica occupa a tal punto l’ispirazione del poeta dafar ricorso a tutti gli accorgimenti retorici perché possa manifestaretutta la sua forza. È proprio l’accostamento di queste due figure,opposte nelle intenzioni retoriche, ma complementari nelle finalitàautoriali, che dà risalto alla disumanità delle immagini veicolate e aigiudizi espressi presentando un quadro complessivo di una degene-razione inarrestabile.
SABRINA FERRARA
FINITO DI STAMPARENEL MESE DI DICEMBRE 2012
PER CONTO DELLACASA EDITRICE LE LETTERE
DALLA TIPOGRAFIA ABCSESTO FIORENTINO - FIRENZE
Impaginazione: Stefano Rolle
DirezioneAntonio Lanza – Lino PertilePaola Allegretti (vicedirettore)
Comitato scientificoMarcello Ciccuto (Pisa) – Domenico Cofano (Foggia) – Massimo Fanfani(Firenze) – Francesco Furlan (Paris) – Robert Hollander (Princeton, NJ –USA) – Claire Honess (Leeds, UK) – Antonio Illiano (Chapel Hill, NC –USA) – Ruedi Imbach (Paris) – Christopher Kleinhenz (Madison, WI – USA)– Bernard König (Remagen, D) – Richard Lansing (Waltham, MA – USA) –François Livi (Paris) – Marina Marietti (Paris) – Bortolo Martinelli (Milano)– Rosetta Migliorini Fissi (Perugia) – Gabriele Muresu (Roma) – John A.Scott (Perth, West Australia) – Karlheinz Stierle (Konstanz, D) – WinfriedWehle (Eichstätt, D)
I volumi per recensione ed i testi per la pubblicazione, in formatocartaceo ed elettronico, vanno inviati a:
Società Dantesca ItalianaPalagio dell’Arte della Lana - I - 50123 Firenze
tel. 055 287134 - www.dantesca.it
Casa Editrice Le LettereVia Duca di Calabria, 1/1 - I - 50125 FIRENZE
tel. 055 2342710 - www.lelettere.it
Amministrazione, distribuzione, abbonamenti, vendite estero:LI.CO.SA.
Via Duca di Calabria, 1/1 - I - 50125 FIRENZE
tel. 055 64831 - www.licosa.com
Direttore responsabile: Giovanni GentileAutorizzazione del Tribunale di Firenze n. 1306 del 01.05.1959Periodico associato all’USPI, Unione Stampa Periodica Italiana
ISSN 0391-7835









































![«Guido da Montefeltro dal Convivio all'Inferno», Nuova Rivista di Letteratura Italiana, XIII (2010) [but 2012] (= Studi danteschi per Alfredo Stussi a cinquant'anni dalla sua laurea),](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6317ff00831644824d03ba62/guido-da-montefeltro-dal-convivio-allinferno-nuova-rivista-di-letteratura.jpg)