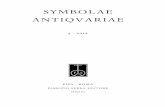P. Trovato, Un problema editoriale: il colorito linguistico della "Commedia". In: Storia della...
Transcript of P. Trovato, Un problema editoriale: il colorito linguistico della "Commedia". In: Storia della...
Paolo Trovato
UN PROBLEMA EDITORIALE:IL COLORITO LINGUISTICO DELLA COMMEDIA*
1. Nella prefazione alla sua edizione del Saint Alexis (1872), dopo averesposto in modo tutt’altro che ingenuo l’allora recentissimo metodo degli er-rori comuni, Gaston Paris osserva:
Quel che ho detto finora riguarda tuttavia uno solo degli aspetti della questione, eforse il meno arduo. La restituzione critica di un testo comprende infatti due parti chesono ben distinte e non devono essere affrontate né con gli stessi mezzi né con gli stessiprocedimenti. Ho parlato solo della prima [sc. la sostanza, le leçons]; rimane da direqualcosa della seconda [sc. le forme]. Le opere copiate all’alba della letteratura france-se, lette e copiate sino alla fine del Medioevo, hanno subito [...] continui ringiovanimen-ti formali. Senza parlare qui dei rifacimenti propriamente detti, notiamo che la linguaè stata avvicinata dai diversi copisti a quella del loro tempo e del loro paese [....]. Comearrivare a determinare il linguaggio di x? Poco importa, per sapere se bisogna scriverechevalchier o cevaucier, enveiot o envoioit, amoros o aimereous, che b e c, a e d siano in-dipendenti l’uno dall’altro o derivino da una stessa copia, poiché i fatti di ortografia epronuncia sono essenzialmente propri di ciascun copista ecc 1.
Ed è significativo che, a distanza di un secolo, uno dei maestri della no-stra filologia, Gianfranco Contini, ribadisca: «E certo che in linea generalemaggiori difficoltà sorgono attualmente dalla ricostruzione formale che daquella sostanziale» 2. Il monito di tono diciamo pure quaresimale che proma-
* Ringrazio per le loro utili osservazioni Giancarlo Breschi, Giorgio Inglese, Lino Leo-nardi, Paola Manni, Pier Vincenzo Mengaldo, Marzio Porro e gli altri partecipanti alle discus-sioni del Galluzzo e della Normale (ottobre e dicembre 2008) e, in particolare, Luca Serianni.Come è giusto dire, mia è la responsabilità degli errori rimasti.
1 Gaston Paris, Preface à La vie de saint Alexis, poème du XI e siècle et renouvellementsdes XII e, XIII e et XIV e siècles, [...] par Gaston Paris et Léopold Pannier, Paris, Franck, 1872,pp. 1-138, a p. 14 ss.; cito dalla trad. it. (parziale) in Fondamenti di critica testuale, a cura di Al-fredo Stussi, Bologna, il Mulino, 1998 (2004), pp. 59 ss. (il corsivo nelle prime righe è mio).
2 Gianfranco Contini, Postilla 1985 a Filologia (1977), in Breviario di ecdotica, Torino,
73
na dalla duplice allegazione servirà solo a confermare all’uditorio, del restonon sprovveduto, la persistenza di una condizione problematica, nella qualele variabili in gioco sono molte e spesso non facilmente razionalizzabili. Men-tre per il caso, certo meno complesso, della Vita Nuova si è appena ripropo-sta con buoni argomenti la soluzione, pulitissima e spesso suggerita dai ma-nuali, del ritorno al ms. base unico (identificato, ovviamente, nel più che affi-dabile Chigiano L VIII 305) 3, per la Commedia non sono per ora alle vistenovità sensazionali, ma piuttosto – anche in conseguenza della sua genealo-gia, ancora in corso di accertamento e però già irreversibilmente terremotatarispetto alla vulgata petrocchiana – dubbi, esitazioni, perplessità.
2. Negli ultimi anni ho progettato e finalmente curato una raccolta di sag-gi danteschi di autori vari, pubblicata nel maggio 2007 con il titolo Nuoveprospettive sulla tradizione della Commedia (Firenze, Cesati; d’ora in avantianche: NP) che è stata presentata e discussa in varie istituzioni universitarie(in ordine cronologico: Torino, Napoli, Pisa, Venezia, Roma La Sapienza,Udine) e sulla quale è già apparsa una prima serie di segnalazioni e recensio-ni, grazie a Dio non molto severe e a volte fin troppo benevole (nello stessoordine: Matteo Motolese, «Il Sole-24 ore», 9 settembre 2007, p. 33; EnricoMalato, in «Rivista di studi danteschi», VII, 2 [2007], pp. 384-405; GiuseppeLedda, in «Ecdotica», 4 [2007], pp. 331-340; Paolo Cherchi, in «Annali diitalianistica», 26 [2008], pp. 413-421; Lino Leonardi, in «Medioevo Roman-zo», 32 [2008], pp. 460-463; Sandro Bertelli, in «Lettere italiane», 60 [2008],pp. 434-444) 4. In NP si sostiene, tra l’altro, la necessità di una nuova classifi-
Einaudi,19923, pp. 3-66, a pp. 64-65. Sulla stessa linea, Contini, Rapporti fra la filologia (comecritica testuale) e la linguistica romanza (1970), in Breviario di ecdotica, cit., p. 173 ( = Idem,Frammenti di filologia romanza. Scritti di ecdotica e linguistica (1932-1989), a cura di GiancarloBreschi, Tavarnuzze (fi), sismel-Edizioni del Galluzzo, 2007, I, p. 97): «Mentre solo un lach-mannismo affinato è adeguato per ciò che è della restituzione sostanziale, la problematica dellarestituzione formale resta più aperta: non certo per mancato progresso ma in obbedienza a unasituazione storica assai molteplice».
3 Stefano Carrai, Quale lingua per la «Vita nova»? La restituzione formale di un testo pa-radigmatico, in «Filologia italiana», iv, 2007 (ma 2008), pp. 39-49.
4 Fa eccezione la stroncatura o meglio il rifiuto totale di Massimo Seriacopi, in «Rassegnadella letteratura italiana», 112, s. IX (2008), pp. 190-193: che si segnala purtroppo per l’impres-sionante assenza di argomentazioni o dati di fatto e insieme per la difficoltà a capire il contenu-to dei lavori in discussione così come il significato di singoli enunciati. Si legga ad es. il suo“riassunto” del capitolo di Camilla Giunti, che – per la cronaca – offre, sulla base di 23 mss.per lo più anteriori al 1355, la prima edizione scientifica del capitolo di Jacopo Alighieri e insie-me un ricco commento continuo del testo: «Si appunta [sc. Giunti] sull’ipotesi che quest’ope-ra, “non avendo conosciuto il successo del poema dantesco [...], possa essere meno contamina-ta rispetto a quella della Commedia e possa perciò rendere più agevole la classificazione dei te-stimoni”, benché a volte i due testi presenti in uno stesso codice risultino di tempi diversi e didiverse mani». O si consideri la sintesi del mio cap. 16 sugli stemmi della Commedia, presentatocome un saggio che «aggiorna in definitiva quanto aveva detto Petrocchi» – ma allora perché
Paolo Trovato
74
cazione genealogica e si propone, pur sul fondamento di una collazione par-ziale, uno stemma della tradizione lontanissimo da quello di Petrocchi e di-verso, nel dettaglio, se non nelle ricadute testuali, anche da quello di Sangui-neti. Nonostante la mole della raccolta, il problema della veste linguistica nonviene però affrontato: per la buona ragione che di cose del genere si ragiona,di regola, solo dopo aver concluso o portato a buon punto la classificazione.Autorevolmente sollecitato, ho cominciato, contro la regola, a discuterne aFirenze il 15 ottobre 2008 a un seminario su La lingua degli autori (Chrétien,Dante, Llull), organizzato dalla Fondazione Ezio Franceschini in collabora-zione con la Rivista «Medioevo Romanzo», secondo la formula, più frequenteall’estero, di una relazione seguita dagli interventi di 2 discussants. Non po-tendo produrre, e tanto meno inventare, a poche settimane di distanza, dati ecommenti significativamente diversi da quelli presentati in quella sede ripro-porrò qui la sostanza delle mie proposte di allora, integrandole con quel chemi pare di aver ricavato dalla discussione, a mio giudizio molto istruttiva 5.
3. Un eccellente punto di partenza per una discussione sul colorito lin-guistico della Commedia è costituito da un saggio recente dell’amico Luca Se-rianni, in cui lo studioso tira amabilmente le orecchie agli «zelatori dell’urbi-nate» (tra i quali senza dubbio mi trovo) e conferma la sua «fiducia per T [ =Triv] che rispetto agli antichi fasti rischia ora a quanto pare di precipitare inbasso e di essere considerato come un testimone linguisticamente poco atten-dibile: ciò che a suo parere non merita» 6.
I fasti di Triv (il più antico codice fiorentino datato) sono acquisiti aglistudi danteschi almeno dai tempi di Vandelli, che dedicò al ms. lavori ancoroggi rilevanti (specialmente Vandelli 1922). Lo stesso Petrocchi (di qui inavanti anche P) si attiene molto largamente agli esiti del ms., scostandoseneperò disinvoltamente tutte le volte che la fonomorfologia di Triv non coinci-de con il fiorentino tardo-duecentesco o con la sua idea del fiorentino (lette-rario) tardoduecentesco. Si veda per es. lo specchietto che segue, costruito su
tanta furia? – e contestualmente «difende le due successive proposte di Sanguineti» – e la pro-spettata conciliazione di opposita come Petrocchi e Sanguineti ci allontana di colpo tanto dalleangustie della critica testuale quanto dalla logica classica -; mentre la contigua presa di distanzadi S. dalle «considerazioni che attengono strettamente all’àmbito del calcolo statistico probabi-listico» proprie di chi scrive – come se la ricostruzione di testi a tradizione multipla non fosse,per tutti, un problema in larga misura statistico probabilistico – conferma che la scrittura di S.trascende ogni vincolo disciplinare e ogni coerenza, come si fa (ma con altra capacità di forma-lizzazione) nelle logiche polivalenti o, in forma più libera, nella terra dei cachi.
5 Come accennato sopra, tengo conto anche di una densa lettera di Luca Serianni, che haavuto la gentilezza di leggere con la consueta acribia, nel gennaio 2009, una redazione ancoraprovvisoria di questo saggio, aiutandomi a renderlo meno imperfetto.
6 Luca Serianni, Sul colorito linguistico della Commedia, in «Letteratura italiana antica»,VIII (2007), pp. 141-150, a p. 150.
75
Un problema editoriale: il colorito linguistico della commedia
pochi vv. di If IV e V. Con le sigle L e I si indicano rispettivamente le edizio-ni Lanza (19962) e Inglese (2007) 7. Contrassegno con un asterisco /*/ una va-riante che direi di confine, tra forma e contenuto
Triv ed. P Eventuali varianti di L e IIf IV 7 su la L ’n su la I8 della L I de la9 che ntrono che ’ntrono I che ttrono L11 affondo L a fondo affondo I (avverbio)18 dubbiar esser L I dubbiare e.19 delle L I de le22 Andian L I Andiam28 avenia L avv- I*29 molto grandi L molte e grandi I
(nella trad. è attestataanche la var. molte grandi)
49 uscici L I uscicci51 coperto L I coverto57 obbediente L I ubidente60 Rachel L Rachele Rachelle I64 lasciavan L I # perch e L I lasciavam # perch’ei65 passavan L I passavam75 delli L I de li77 nella L I ne la[...]
If V 90 ti(n)gnemo tignemmo I tignemo L92 pregheremo L pregheremmo I97-99 fuoi: suoi (: voi) fui: sui (: voi) fui: suoi (: voi) L I101 della I L de la105 abandona L I abbandona
Tra gli “scarti” più frequenti rispetto a Triv, nella direzione di una linguail più possibile normalizzata, si rafforza la consonante dei prefissati con AD –(avvenia, abbandona); si eliminano le prime plurali in -n (andiàn, lasciavàn,passavàn); si generalizza il tipo analitico e, per i lettori dal Cinquecento inpoi, “poetico” di preposizione articolata; si ortopedizza in direzione “petrar-chesca” la prosodia (dubbiar esser > dubbiare esser, Rachel > Rachele); e viadicendo.
7 Dante Alighieri, La Commedìa, Testo critico secondo i più antichi manoscritti fiorenti-ni. Nuova edizione, a cura di Antonio Lanza, Anzio, De Rubeis, 1996 (I ed. 1995); Dante Ali-ghieri, Commedia. Inferno, Revisione del testo e commento di Giorgio Inglese, Roma, Carocci,2007.
Paolo Trovato
76
Si attiene programmaticamente a Triv, anche se in modi troppo approssi-mativi per offrire una ragionevolmente affidabile base di lavoro, l’ed. Lanza,pressoché ignorata al suo apparire, ma recuperata e citata (a volte con ecces-so di riguardi) nella discussione recente sull’ed. Sanguineti. Occorrerà preci-sare quindi che l’ed. Lanza, sottotitolata «testo critico secondo i più antichimanoscritti fiorentini», sarebbe potuta servire almeno per una miglior cono-scenza del Trivulziano (magari con sobria annotazione dei tanti luoghi dovela lezione di Triv, pur storicamente notevole, è a norma di stemma – di qual-siasi stemma, passato, presente, futuro – indifendibile); ma rappresenta, pur-troppo, un’occasione perduta: tanto per i troppo frequenti refusi nel testodantesco quanto, nella fascia del commento, per i rilievi banali o inesatti mistia reticenza o disinvoltura nell’occultare o minimizzare i dati problematici. Esi aggiunga anche la fluviale, sistematica discussione del troppo e del vano,ossia di varianti tipicamente adiafore. Come si sa, di fronte all’adiaforia insa-nabile che caratterizza di norma larghe zone dei testi classici e medioevalisolo due soluzioni sono praticabili e insomma non autoerotiche: quella neo-lachmanniana di arrivare a costruire uno stemma e applicare di conseguenzala legge della maggioranza e quella bédieriana di attenersi fin dove possibileal testimone prescelto, documentandone l’accettabilità (ma senza millantarnela presunta o sicura genuinità) 8.
Una più che decorosa, utile trascrizione diplomatico-interpretativa diTriv è disponibile nel sito della Societa dantesca italiana (www.danteonli-ne.it).
Disponiamo, infine, di dettagliate analisi linguistiche di Triv, del suo col-laterale Mart e degli altri manufatti firmati di Francesco di ser Nardo 9.
Ad ogni buon conto, nessun dubbio da parte mia che Triv non sia, sulpiano linguistico, una buona “esecuzione” della Commedia da parte di un co-pista nato a qualche decina di chilometri da Firenze presumibilmente unaquarantina o cinquantina d’anni dopo Dante. Ma se il criterio deve essereuna fiorentinità purchessia, non si capisce (se si prescinde dal feticismo per ledate e dalla leggenda petrocchiana di Francesco di ser Nardo padrone del-l’officina del Cento) perché non guardare allora all’anonimo copista di Cha-Vat e famiglia o al copista di Parm o meglio al copista pure anonimo identifi-cato da Gabriella Pomaro come la «mano principale» del Cento (lo scriba,responsabile del Chigiano di rime antiche, oltre che di 19 Commedie super-
8 Una pur sommaria documentazione dei limiti dell’ed. è stata prodotta al seminario diottobre e apparirà su «Medioevo Romanzo».
9 Francesca Geymonat, Tendenze correttorie di rilevanza fonomorfologica nell’Aldinadantesca collazionata da Luca Martini, in Storia della lingua e filologia. Per Alfredo Stussi nel suosessantacinquesimo compleanno, a cura di Michelangelo Zaccarello e Lorenzo Tomasin, Tavar-nuzze (Firenze), SISMEL-Edd. del Galluzzo, 2004, pp. 263-289; Eadem, Sulla lingua di France-sco di ser Nardo, in NP, pp. 331-386.
77
Un problema editoriale: il colorito linguistico della commedia
stiti in tutto o in frammenti, è forse più anziano, certo linguisticamente piùconservatore di Francesco) 10.
4. Non insisterò sul facile gioco delle alternative toscofiorentine a TrivAmmesso e non concesso che Triv sia, oltre che il più conosciuto, il miglioredei mss. fiorentini disponibili, ci sono motivi che rendono conveniente o al-meno scientificamente istruttivo tentare soluzioni diverse? Direi di sì. A giu-dicare dalle presentazioni e recensioni ricordate sopra, nelle quali pure sonostate mosse a NP (e anzi ai capitoli finali, da me firmati, di NP) interessanticritiche di vario genere, i tempi sembrano maturi per guardare allo stemma ealla classificazione di Petrocchi come a costruzioni nel complesso poco atten-dibili. Inattendibile è, in particolare, l’idea che sia esistita una tradizionetosco-fiorentina indipendente da quella settentrionale. La presunta famigliatosco-fiorentina a è in realtà una sottofamiglia del ramo più folto. Pur confi-gurandosi sempre come bipartita, come accade normalmente di fronte a unalto tasso di decimazione delle testimonianze 11, la prima tradizione dellaCommedia fu – come anche la storia esterna (cioè la biografia di Dante) sug-gerisce – esclusivamente settentrionale. E ci sono indizi non trascurabili chetutte le testimonianze superstiti finora analizzate da questo rispetto (chesono, ahimè, solo 1/20 di quelle esistenti) discendano da un archetipoemiliano-romagnolo (NP, pp. 703-707). La veste linguistica di Triv e del suocollaterale Mart (e insomma di a) continua dunque, come avviene in gradi di-versi anche per le altre copie toscane note, un’opera collettiva e progressivadi ritraduzione in tosco-fiorentino di forme settentrionali o settentrionaleg-gianti, fortemente dipendenti da perduti antigrafi transappenninici giunti inToscana nel corso degli anni ’20 (vistosissimo il caso dell’Antichissimo, cioè ilpisano Ash, con i suoi avverbi in -mentre e altri tratti inequivocabilmente pa-dani 12, mentre come anche gli studi recenti confermano la rifiorentinizzazio-ne è in a molto più avanzata).
Ora, se si trattasse di un’opera appena meno importante della Commediapotremmo appagarci della circostanza che il potenziale testimone base siastato vergato solo 16 anni dopo la conclusione dell’opera (e la morte dell’au-tore), ma è il caso di ricordare che Dante, nato nel 1265, lasciò Firenze nel1301, e rimase quindi immune, nella stesura della sua opera maggiore, dalgrosso delle innovazioni linguistiche che porteranno, dal tardo Trecento, alcosiddetto fiorentino argenteo (ottimamente descritte da Paola Manni nel
10 Gabriella Pomaro, Ricerche d’archivio per il “copista di Parm” e la mano principale delCento. (In margine ai «Frammenti di un discorso dantesco»), in NP, pp. 243-279.
11 Mi permetto di rinviare a Vincenzo Guidi-Paolo Trovato, Sugli stemmi bipartiti. De-cimazione, asimmetria e calcolo delle probabilità, in «Filologia italiana», I (2004), pp. 9-48.
12 Fabrizio Franceschini, Stratigrafia linguistica dell’Ashburnhamiano e dell’Hamiltonia-no, in NP, pp. 281-330.
Paolo Trovato
78
1979) 13; mentre Francesco di ser Nardo, che ancora nel ’37 ricorda orgoglio-samente le sue origini extrafiorentine e sarà nato, congetturo, verso i primidel Trecento (Ga, datato 1347, non pare opera senile) è testimone di un siste-ma diverso, ossia di «una fiorentinità più tarda e probabilmente non immuneda interferenze di contado» 14.
Quanto profonda sia la distanza linguistica tra questa ritraduzione e lagenuina veste della Commedia è un problema (impensabile ai tempi del Bem-bo e forse anche a quelli del Barbi) verosimilmente non risolvibile per larghitratti del testo, ma che oggi, dopo la conoscenza dettagliata delle varietà to-scane antiche procurataci da Castellani e dalla sua bella scuola, dovremo pro-vare a porci. E qui farei entrare nel discorso U e con lui altri mss. settentrio-nali, che mi sembrano, allo stato attuale della classificazione, stemmaticamen-te più alti della vulgata toscofiorentina.
Per amore di precisione provo a “falsificare” (ovvero verificare la tenutadi) un’osservazione della stessa Manni, che rileva, a proposito dell’ed. S:
E chiaro però che l’aver assunto come testo-base un codice non toscano aumenta,proprio sul piano della fisionomia linguistica, le difficoltà e i dubbi, moltiplicando vi-stosamente il ricorso all’emendazione e facendo approdare a un testo che, sotto que-sto punto di vista, offre un minor grado di approssimazione all’originale dell’edizionePetrocchi (Manni, Il Trecento cit., p. 138).
In questa frase, all’ingrosso condivisibile, disturba il riferimento all’origi-nale, giacché (uso ancora parole della Manni, più in linea con la citazione diGaston Paris con cui ho avviato questo consuntivo)
è evidente che la lingua della Commedia si sottrae a un’analisi esaustiva: non soloniente si può dire della fisionomia grafica del testo, ma anche l’originario aspetto fo-nomorfologico resta in parte occultato. Un doveroso atteggiamento di cautela haquindi tradizionalmente indotto la critica [...] ad attribuire particolare valore alle pa-role in chiusura di verso, laddove il vincolo della rima offre garanzia di rispetto del-l’originale (Manni, Il Trecento cit., p. 139).
Insomma fino ad ora dell’originale, non sappiamo molto, salvo il casodelle forme in rima, che appunto dai tempi di Paris (il rinvio è di nuovo alSaint Alexis, 1872), offrono alla romanistica servizi preziosi. Possiamo peròfar tesoro di un dato genealogico che sembra ormai assodato e di un criterio
13 Paola Manni, Ricerche sui tratti fonetici e morfologici del fiorentino quattrocentesco, in«Studi di grammatica italiana», VIII (1979), pp. 115-171.
14 Cito dal manuale doppiamente aureo, per l’argomento e per la qualità scientifica, dellastessa Manni, Il Trecento toscano (Bologna, Il Mulino, 2003, p. 138): che fornisce tra l’altro unottimo bilancio-aggiornamento di tutto quel che sappiamo sulla lingua di Dante, da Parodi aCastellani e oltre.
79
Un problema editoriale: il colorito linguistico della commedia
sottile e ben collaudato, salvo errore introdotto nella letteratura dantesca dalBarbi.
Per quanto riguarda il settentrionale U, non meno di 5 classificazionicondotte negli ultimi 50 anni indipendentemente l’una dall’altra (quelle diPetrocchi, 1966-1967 e riedizioni, Sanguineti, 1994 e 2001, Trovato, 2007,Inglese, 2007 15, e quella della recentissima, e ancora inedita, tesi di dottoratobolognese di Riccardo Viel, tutore Luciano Formisano) concordano sul fattoche la tradizione di U è diversa e indipendente da quella toscana. Inoltre,Vincenzo Guidi (lavorando per lo più su localizzazioni a campione forniteglida chi scrive, per la loro natura certamente correggibili, ma in misura, si osasperare, non superiore al 10% / 15%) ha potuto concludere che la produzio-ne di manoscritti toscana del secondo quarto del Trecento era una cinquanti-na volte più numerosa di quella settentrionale coeva 16.
Dal punto di vista linguistico U, che discende da un ms. vicino alle (ossia:meno lontano degli altri dalle) prime copie ravennati diffuse dai figli di Dan-te (ma con la lentezza del caso: ci volevano 4-6 mesi per copia!) presenta unapatina emiliano-romagnola. Non sappiamo quante copie separino U (e altrimss. settentrionali risultati autorevoli) dalle belle copie messe in circolo nel1322. Ma considerando che l’attività di copia fu nell’area molto meno intensache in Toscana e soprattutto a Firenze, il 1352 del settentrionale U è, da varipunti di vista, più promettente del 1337 di Triv. Tutte le volte che U conser-va, «nonostante la spinta dell’uso nativo» (faccio mia un’osservazione di Bar-bi sui mss. umbri della Vita Nuova), una forma fiorentina la sua «testimo-nianza è preziosa» 17. In questo caso non può trattarsi di una ritraduzione, piùo meno accettabile, come nei mss. pisani o fiorentini, ma, necessariamente, diconservazione di forme che si trovavano nell’originale ravennate (a scanso di
15 Mi limito a citare il saggio, molto recente, di Giorgio Inglese, Per lo ‘stemma’ della«Commedia» dantesca. Un tentativo di statistica degli errori significativi, in «Filologia italiana»,iv (2007, ma 2008), pp. 51-72.
16 Vincenzo Guidi, I numeri della tradizione dantesca. Qualche considerazione di statisticadescrittiva, in NP, pp. 215-241.
17 Dante Alighieri, La Vita Nuova, per cura di Michele Barbi, Firenze, Società DantescaItaliana, 1907, pp. CCLVII-CCLVIII ( = La Vita Nuova di Dante Alighieri, edizione critica percura di Michele Barbi, Firenze, Bemporad, 1932, p. CCLXXVIII). Il criterio è riconosciuto va-lido anche per la Commedia da Afredo Stussi, Filologia e storia della lingua italiana (1991), inLingua, dialetto e letteratura, Torino, Einaudi, 1993, pp. 214-234, a p. 225 («una forma fiorenti-na presente in un manoscritto linguisticamente meridionalizzato sarà con ogni verosimiglianzauna conserrvazione, forse uno stato originario, non certo un’innovazione introdotta da quel co-pista»). E Trovato (Storia della lingua e filologia: i testi letterari, in Storia della lingua italiana estoria letteraria, Atti del I Convegno ASLI, a cura di Nicoletta Maraschio e Teresa Poggi Salani,Firenze, Cesati, 1998, pp. 73-98, poi in Il testo della Vita Nuova e altra filologia dantesca, Roma,Salerno Editrice, 2000, pp. 23-49, a p. 48, ne ripropone l’applicazione in termini più generali,concludendo: «Se c’è un criterio lachmanniano che possa servire anche per le forme (ben inte-so: con discrezione) è quello della lectio difficilior di ragione linguistica»
Paolo Trovato
80
equivoci, con la formula originale ravennate intendo l’ ‘insieme delle carte, dimano di Dante o da lui controllate, presenti in bella o brutta copia a Ravennanel 1321 e utilizzate dagli eredi del poeta per la diffusione organica dellaCommedia’).
5. Provo a offrire qualche esempio di questa variantistica contrastiva, chepuò permetterci di illuminare qualche altro particolare del perduto e sfug-gente originale dantesco. E tengo conto della giusta osservazione di Serianni(Sul colorito linguistico cit., p. 145) che, «per testimoniare un fenomeno lin-guistico alieno dalla varietà di riferimento [...]. non si può far conto di unaforma che sia altrimenti interpretabile in quella varietà» (per es., vidi, che infiorentino è interpretabile come un perfetto, non vale come prova di metafo-nesi).
A Pd XIV 18 e a Pd XIV 58 la maggior parte dei mss. toscofiorentini leg-ge porà, a Pd XIX 112 poran.. Ora, a parte Dante, il TLIO dà per i futuri po-rà, poran solo riscontri settentrionali con l’eccezione di Francesco da Barberi-no, la cui autografia sembra oggi revocata in dubbio da alcuni paleografi. Ap-punto queste forme dantesche – a testo in P nel primo e nel terzo caso, in Lanche nel secondo – sono ritenute «meno sicure» di altre, tra cui il porà dell’i-diografo petrarchesco, da Castellani 18. Ad ogni modo, per la Commedia, U ealtri settentrionali, tra cui Mad e Rb, offrono esiti fiorentini impeccabili: po-trà, potran.
La stessa solo apparentemente curiosa distribuzione si rileva nei mss. ri-guardo alle coppie ternaro / ternaio e cavrara / capraia: la forma fiorentina èserbata da U, mentre i codici toscofiorentini, compreso Triv, dipendono daantigrafi con più forti incrostazioni settentrionali (NP, p. 709).
Altro materiale notevole si ricava verificando il comportamento di U incasi nei quali Manni segnala l’apertura del testo Petrocchi a «forme non fio-rentine». Al solito, qualche esempio: «Tra le forme con la sonorizzazione cheesulano dal tipo toscano spicca per frequenza sovra prevalente sul toscano so-pra» (Manni, Il Trecento cit., pp. 147-148).
Ben inteso sovra (idiosincraticamente prevalente in Triv) 19 può spiegarsicome forma illustre, come tale non ignota ai lirici tosco fiorentini, ma Manniha perfettamente ragione sulla questione della frequenza, del tutto abnorme:nell’ed. Petrocchi, i sovra sono 73, contro 47 sopra. Dante sarebbe cioè piùschifiltoso di Petrarca, che nell’autografo-idiografo dei RVF presenta 18 trasovra e sovr’ e 23 sopra. Ora, stando ai dati LIZ (e pur avvertendo che si tratta
18 Grammatica storica della lingua italiana, I. Introduzione, Bologna, il Mulino, 2000, p.447. Aggiungo, per Petrarca, che, se le forme sicilianeggianti poria, porian non fanno problema,gli isolati porà e poresti di RVF, 60 9 e 126 67, sono di mano del copista, settentrionale.
19 Geymonat, Sulla lingua, cit., p. 349.
81
Un problema editoriale: il colorito linguistico della commedia
dunque, per lo più, di forme ricostruite dagli editori), nelle Rime di Dante ilrapporto tra forma esotica e forma toscana è prossimo a quello petrarchesco,4 a 5, nella Vita Nuova, è pari a 2 (entrambi in poesia) contro 12, nel tardo eenciclopedico Convivio, 6 a 146 (cioè 24,3333). Non posso fare a meno di no-tare che nell’ed. Sanguineti, che riflette la distribuzione del settentrionale U, isovra sono solo 4. contro 116 sopra (cioè il rapporto è 23, prossimo a quellodel trattato). Tra i sovra che non figurano più c’è anche l’unica occorrenza inrima, If XVI 119-123: dove l’ed. Petrocchi reca ovra: sovra: scovra (per l’ulti-mo rimante Petrocchi si distacca, con il consueto eclettismo, da Triv, che leg-ge, con Eg Fi e con il collaterale Mart, scuovra) 20: U + Mad (+ vat e altri neiprimi 2 casi), opra: sopra: scuopra. La forma citata per ultima è, com’è ovvio,quella normale nel fiorentino due-trecentesco (i non numerosissimi allotropimonottongati di scuopro / scuopre ecc. si trovano tutti all’interno di testi poe-tici).
Passiamo a un altro tratto segnalato da Manni: «Spiccano nella morfolo-gia verbale alcune forme non fiorentine che, con la loro eccezionalità, assu-mono un forte rilievo stilistico-espressivo, spesso sottolinato dal ricorrere inposizione di rima» (Il Trecento cit., p. 143). Tra queste forme Manni citacome verosimili occidentalismi 3 casi di enno o en ‘sono’, l’ultimo dei quali inrima (enno If V 38, en Pg XVI 121, enno Pd XIII 97 r). Salvo errore, le formeenno / en (vive oggi nel toscano occidentale, ma di cui, a dispetto dell’altafrequenza di sono e del modulo analogistico di formazione, non trovo alcunesempio nel Libro memoriale di Donato né nell’ed. Giannini del Buti, cheavevo sotto mano, e che, con grande cortesia, uno dei massimi conoscitoridella tradizione pisano-lucchese, l’amico Fabrizio Franceschini, ha cercatoinvano in vari altri testi occidentali antichi) sono, nel Due-Trecento, formediffuse solo nel settentrione, lombarde, venete (anzi prevalentemente verone-si) e emiliano-romagnole (bolognesi, modenesi, ecc.; grazie a Sanfilippo pos-siamo aggiungere anche ravennati) 21. I riscontri forniti dal sempre utileMonaci-Arese e dalle banche dati testuali (TLIO, LIZ, i Commenti danteschidi Procaccioli) confermano le indicazioni fin qui disponibili. La forma è neicosiddetti versi d’amore ravennati A, in più testi lombardi, cioè Uguccione eBonvesin e Pietro da Bescapé, nel Lucidario veronese, in vari testi bolognesi,modenesi e umbro-emiliani, tra cui Guido Fava, il Serventese dei Lambertazzie dei Geremei e tanto Guinizelli. Quindi, oltre alle occorrenze in Dante e aquelle del bolognese Lana (con decine di esempi), la si ritrova in due toscaniprovinciali, il già ricordato Francesco da Barberino e Giovanni Gherardi da
20 Confrontabile nell’ingente corpus TLIO solo con lo scuovri di Giovanni Querini, ami-co e cultore veneziano di Dante. (Ma, come si ricorderà, Triv legge, tra l’altro, anche fuori).
21 Carla Maria Sanfilippo, Primi appunti sul volgare di Ravenna nel secondo Trecento, inNP, pp. 411-456.
Paolo Trovato
82
Prato, nel tardo Ristorato di Ristoro Canigiani (1363) e, nel secolo della “cri-si” linguistica, anche, ma in un solo caso, in Lorenzo lirico. Ma è ancora vita-le a Nord degli Appennini (in Agostino Beccari, nell’Innamoramento diBoiardo, in Niccolò da Correggio...). Per la precisione sono entrambi conget-turali da è (e verosimilmente modellati sull’en dantesco di Pg XVI) i due e[n]per è di Chiaro XLIII 14 e Monte, canz. VII 18. Ed è di tradizione non in-controvertibile anche il ch’en di Le dolci rime 95, ricordato da Ambrosini nel-l’Enciclopedia dantesca 22. Al solito, i mss. settentrionali della Commedia sicomportano in modo singolare, cioè conservano (com’era da prevedere) l’en-no in rima, che figura, quasi a metà Paradiso, in un discorso diretto di sanTommaso, ma offrono negli altri luoghi soluzioni indiscutibilmente toscofio-rentine (qui e in seguito, mi servo per le famiglie delle sigle introdotte in NP).
If V 38 eran dannati U E F + Bol Est. 196 Franc + Ash2 Co Ham La] sono d. Pal+ Laur, sono dananti Est, enno d. Ott. Pad. 2 x1 + Pad. 9 Pad. 67 Parm. 1060 + a (–b Co La Laur)
Pg XVI 121. ben ve (vee Pad. 9 Pad. 67) tre (tra Pad. 2) vecchi U E F + Pad. 2Pal x1 + Pad. 9 Pad. 67 Parm. 1060 + Po] ben va tre vecchi Co Ham Laur Pr, benv’en tre vecchi Est Est. 196 (bem viem) Franc + a (-Co Ham Laur Po Pr)
Alla luce di questa documentazione l’osservazione di Petrocchi che enno«è lectio difficilior, inattaccabile rispetto alle varianti eran e sono», è insosteni-bile o, se si preferisce, accettabile per i soli mss. fiorentini. Se le prime copieemiliano-romagnole della Commedia avessero letto enno, non si capisce per-ché mss. settentrionali di rami indipendenti tra loro avrebbero dovuto cor-reggere in senso fiorentino. Semmai, si può dire che, rispetto a eran, attesta-to in b e nei piani alti di g, enno / sono sia correzione banalizzante, che con-guaglia al presente un’alternanza imperfetto (eran) / presente (sommetto-no) 23.
6. A mio giudizio l’utilità dei migliori mss. settentrionali o, se si preferi-
22 In Riccardo Ambrosini-Franca Brambilla Ageno-Mario Medici-Ugo Vignuzzi,Morfologia e sintassi della proposizione, in ED, App., pp. 135-368, a p. 217b.
23 Mi rifaccio al mio stemma provvisorio, NP, p. 702, dove è però “saltato” in bozze, e mene scuso, Ph, che è rimasto invece al suo posto in Paolo Trovato, Per il testo della «Comme-dia». Varianti poziori di tradizione settentrionale, in Studi in onore di Pier Vincenzo Mengaldoper i suoi settant’anni, a cura degli allievi padovani, Tavarnuzze (fi), sismel-Edizioni del Galluz-zo, 2007, pp. 263-278, a p. 265. Di passata, non mi pare decisiva (in un canto dove il perfetto eil presente storico alternano continuamente) il rilievo di un partecipante alla discussione che ilussuriosi sono dannati in eterno. L’incipit al passato Intesi che ecc. avrà favorito la scelta del-l’imperfetto, che non osta all’eternità della pena (e vd. anche If III 61-62 «Incontanente intesi ecerto fui / che quel’era la setta d’i cattivi...»).
83
Un problema editoriale: il colorito linguistico della commedia
sce, la scarsa affidabilità di Triv (e già di a), si riscontra anche in altri casi, neiquali non sono in gioco forme fiorentine verso forme non fiorentine, ma for-me fiorentine due- e primo trecentesche contro forme fiorentine sostanzial-mente argentee, per cui basta costeggiare il prezioso lavoro sul fiorentino ar-genteo di Paola Manni.
Togliamo subito di mezzo l’isolato e potenzialmente fuorviante duo che isoli Mart e Triv recano a If XX 44 (li duo serpenti) – antifiorentino ancora nelprimo Trecento e vitale a Firenze solo «alla fine del secolo XIV» (Manni Ri-cerche, cit., p. 136) – mentre U e gli altri leggono due, con l’eccezione di Mad(doi). Come osserva a ragione Luca Serianni, di fronte a un possibile culti-smo, non è il caso di applicare a un testo poetico le categorie interpretativeche funzionano per i ‘testi pratici’.
Triv e altri mss. toscani recano varie forme di perfetto, I pers. plur., conm desinenziale scempia. Un controllo sulla banca dati pisana DanteWeb, checonsente interrogazioni grammaticali e sintattiche piuttosto comode, rivelache le occorrenze del perfetto alla I pers. plur. sono in tutto 120. Un successi-vo controllo delle prime 60 su Triv mi ha consentito di raccogliere 16 formecon -m-. La tabella che segue mostra che, a differenza di Petrocchi e di Ingle-se, che abbandonano sistematicamente il ms. base, Lanza tesaurizza con en-tusiasmo questi esiti. Notevole, per contro, il comportamento pressoché im-peccabile di U, donde l’ed. Sanguineti 2001 (in seguito S.). Il tratto orizzon-tale indica accordo con la prima colonna.
ed. Petrocchi Triv U
If IV 106 venimmo (I) giugnemo (L) – (S)If IV 109 passammo (I) passamo (L) – (S)If IV 111 giugnemmo (I) venimo (L) – (S)If V 90 tignemmo (I) ti(n)gnemo (tignemo L) – (S)If VII 130 venimmo (I) venimo (L) – (S)If VIII 76 giugnemmo (I) giungnemo (giugnemo L) – (S)If IX 54 vengiammo (I) vengiamo L – (S)If IX 104 movemmo (I) movemo L – (S)If IX 133 passammo (I) passamo L – (S)If XII 76 ci appressammo (I) c’appressamo L sappressammo
(ci appressammo S)If XIII 2 ci mettemmo (I) ci mettemo L – (S)If XIII 111 fummo (S, I) fumo L fommoIf XIV 4 venimmo (I) venimo L – (S)If XIV 12 fermammo (I) fermamo L – (S)If XVI 19 restammo ei restam ei L (restamm’ei I) ristammo ei (S)If XXI 4 restammo (L, I) restamo ristemmo (S)
Paolo Trovato
84
Anche se nella stragrande maggioranza delle 44 forme con -mm- da meriscontrate in Triv è presente il titulus (If IV 103 anda(m)mo, If V 133 leg-ge(m)mo, 138 legge(m)mo, If VI 100 trapassa(m)mo, 112 aggira(m)mo, 114 ve-ni(m)mo, 115 trova(m)mo, If VII 16 scende(m)mo, 100 ricide(m)mo, 105 in-tra(m)mo, 121 fu(m)mo (:), 127 gira(m)mo, If VIII 4 vede(m)mo, 64 lascia(m-)mo, 80 veni(m)mo, If IX 106 entrammo, If X 134 lascia(m)mo, gi(m)mo, IfXI 3 veni(m)mo, If XI 6 raccosta(m)mo, XII 2 veni(m)mo, 28 prende(m)mo,100 ci move(m)mo, If XIII 37 fummo, If XIV 8 arriva(m)mo, 76 diveni(m)mo,86 entra(m)mo, XV 16 incontra(m)mo, XVI 94 sare(m)mo, 105 trova(m)mo,If XVII 31 scende(m)mo, 32 fe(m)mo, XVIII 68 diveni(m)mo, 70 sali(m)mo,72 parti(m)mo, 73 fummo, 103 senti(m)mo, 112 veni(m)mo, XIX 40 ueni(m-)mo, 41 uolge(m)mo (et) discende(m)mo, XXI 3 veni(m)mo, If XXII 151 la-scia(m)mo, If XXIII 58 trova(m)mo), la percentuale dei casi con degemina-zione (il 26,6%) sembra troppo elevata per pensare a mere omissioni di titu-lus, né si può dire che il Trivulziano sia, in contesti diversi, altrettanto prodi-go di incertezze nella rappresentazione dell’intensità consonantica. Sedunque, come pare, il fenomeno ha rilievo fonetico, si deve ricordare che –mentre il tipo con -m – «è attestato fin dall’epoca più antica» a Prato o a Sie-na –, la forma degeminata comincia a emergere a Firenze solo nella «secondametà del secolo XIV» (Manni, Ricerche, cit., p. 150); quindi, anche alla lucedel fatto che la tendenza è ancora più accentuata in Ga e pressoché inesisten-te in Mart (NP, p. 368 e nota), è lecito interpretare la presenza del fenomenoin Triv come una tra le più probabili «interferenze di contado» della scriptadi Francesco.
Per quando riguarda l’imperfetto indicativo, Manni, che per ovvi motivicronologici riflette la distribuzione dell’ed. Petrocchi (cioè, come già avverti-to, prevalentemente di Triv), avverte:
Una considerazione a parte richiede l’imperfetto in -ia dei verbi della 2a e 3a clas-se, rappresentato da vincia Inf IV 69 r e avia Par XXIX 23, più spesso da forme di 3a
pers. sing. in -ie ( < -ia) seguite da enclitiche (cresciemi Inf XXXI 39, dovieti PurgXXXI 48, potiesi Purg XXIX [corr. XIX] 110 ecc.) e da un numero ancora più altodi forme plurali in -ieno ( < iano) sia in rima che fuori rima ([...] avieno If IX 39, fa-cieno Inf XII 102, parieno Inf XXXIII 34, ecc.): Il Trecento cit., pp. 146-147.
Come si ricorderà, si tratta di forme che nei NTF, p. 44 e nota 6, veniva-no registrate tra i Caratteri comuni al senese e all’aretino-cortonese. Un minu-scolo sondaggio, limitato prevalentemente alle forme non in rima citate a tito-lo esemplificativo da Manni, Il Trecento cit., mostra che in U (e, in misura va-riabile, in molti altri settentrionali) la polimorfia verbale della Commedia si ri-duce significativamente rispetto alla distribuzione di Triv (Francesco di serNardo era di Barberino in Val di Pesa, tra Firenze e Siena):
85
Un problema editoriale: il colorito linguistico della commedia
ed. P Triv UPd XXIX 23 avia – (L) avea (S)Pd XIV 90 conveniesi – (L) conveniasi (S) + cento* Eg Fi Gv Ham La
Parm Po (coveniasi) Vat, conveniassi Mad PaPg XXXI 48 dovieti – (L) – (S)Purg XIX 110 potiesi – (L) poteasi (S) + x1 + cento Ham PoIf IX 39 avieno – (L) aveano (S)Inf XXXIII 34 parieno – (L) parean (S)If IV 117 potien – (L) potean (S) x1 + b cento* Eg Fi La Laur Pa PoPd VII 88 potiensi – (L, S) poteasi (corr. potea[n]si?)
Ma per es.:
Inf XII 102 facieno – (L) – (S)Pd XIV 110 si movien(movean Ash cento ecc.)
– (L) – (S)
La stessa Manni (Il Trecento cit., p. 146 nota) osserva opportunamenteche, nella Commedia,
la forma movieno è in rima con pieno e freno; moviensi è in rima con pensi e spensi. Inentrambi i casi è dunque avvalorata una pronuncia con la e tonica. Un simile sposta-mento di accento, che di fatto si produce in posizione protonica all’interno di frase,costituisce il presupposto per spiegare le forme del tipo doveno, aveno che compaio-no talora nei testi trecenteschi (cfr. Manni 1979: 156 nota 1) cui si assimilano i dante-schi crescémi Inf XXXI 39 e traéli Purg XXXII 6 accolti nell’edizione Petrocchi.[l’ed. P legge però cresciemi; la ’21 e Vandelli, crescìemi].
Vediamo se e come questo ulteriore sviluppo, frequente solo nel fiorenti-no argenteo, anche se attestato due volte in rima nella Commedia e non igno-to al fiorentino duecentesco, si riflette nei nostri mss.
ed. Petrocchi Triv UPg X 81 movieno (:) – (L) – (S)If XII 29 moviensi (:) – (L), movensi Cha – (S)
Ma, fuor di rima:
ed. Petrocchi Triv Ufuggiemi If XXXI 39 – (L), fuggìemi (L), molti mss.
toscofiorentini fuggemi o fuggimmifugiami (fug[g]iami S)
cresciemi If XXXI 39(sulla base dei sett. Eg Pa)
crescêmi (L, con quasi tutti i mss.fiorentini)
cresceami (S)
traéli Pg XXXII 6 traeli trahelli (traelli AshHam, ma traèli S)
Paolo Trovato
86
Anche in questo caso (altri dati, relativi anche a Ga, in NP, p. 366, § 32)le forme più lontane dalle basi latine, si riducono drasticamente in U, i cuiesiti sembrerebbero, di nuovo, attribuibili a un autore fiorentino nato nel1265 e di buona formazione culturale. Con tutti i limiti che l’operazione haquando si ragioni sulle forme di testi a tradizione multipla, necessariamentericostruite, un controllo delle altre opere volgari di Dante condotto sulla LIZrivela che tanto nella Vita Nuova e nelle Rime quanto nel Convivio le formedi imperfetto in -ie, -ieno, -iensi, -èno, -ènsi non sono mai attestate. Col sennodi poi (di chi cioè ragioni con rispetto sulle lezioni di un testimone di regolamolto autorevole) andrà inoltre sottolineato, nell’ultima variante di U, tra-(h)elli un acquisto sostanziale, sfuggito anche all’attento Sanguineti: il perfet-to (puntuativo) è senz’altro preferibile all’imperfetto (durativo).
Un ultimo tratto notevole, l’imperfetto in -àvaro, -èvaro. La forma è atte-stata nei luoghi seguenti:
11) If XVII 126 s’appressavar Urb + Franc Mad + cento Eg Fi La2 Pa Po ] s’ap-pressavan b ( – cento Eg Fi Pa Po)
If XXVIII 25 pendevar Urb + cento* Fi La2 Pa Triv] pendevan Franc x1 + b (–cento* Fi Pa Triv)
Purg IV 84 vedevar Franc R + a Ash cento La] vedevan b (– a Ash cento La) Purg XXV 134 gridavaro (cridavaro U) U + x1 + a] gridavano Franc + b (– a)
La desinenza, evidentemente analogica sul perfetto, è tipicissimamentefiorentina, come nota anche Lanza 24. Una ventina di esempi tra le 1069 strin-ghe in -avaro del TLIO. Ma c’è di più: si tratta di un fiorentinismo documen-tato solo in un giro d’anni abbastanza ristretto, tra il secondo ’200 e i primis-simi anni del ’300.
7. Come questa serie di varianti, certo non ugualmente significative, sug-gerisce, i testimoni settentrionali della Commedia lasciano intravedere un te-sto dalla polimorfia molto meno accentuata di quella testimoniata dalle edi-zioni, nell’intenzione massimamente monolinguistiche, di Petrocchi o di Lan-za. Per le parti che i codici settentrionali consentono di restaurare con ragio-nevole sicurezza vale, e può forse essere precisato in senso fiorentino, ilrilievo del Parodi, spesso citato dagli studiosi, che Dante sembra aver seguito«l’uso toscano di poco più che una generazione innanzi alla sua, attingendoin quel moderato arcaismo nobiltà e solennità di linguaggio» 25.
24 Dante Alighieri, La Commedìa, cit., p. xxvi. Ma già NTF, pp. 44-45 n. 6; Ambrosini ea., Morfologia e sintassi, cit., p. 218b.
25 Ernesto Giacomo Parodi, La rima e i vocaboli in rima nella “Divina Commedia”(1896), rist. in Lingua e letteratura. Studi di Teoria linguistica e di Storia dell’italiano antico, acura di Gianfranco Folena, con un Saggio introduttivo di Alfredo Schiaffini, Venezia, Pozza,1957, II, pp. 203-284, a p. 253.
87
Un problema editoriale: il colorito linguistico della commedia
Qualcuno obietterà che si tratta di minuzie, trascurabili di fronte allaquantità e qualità francamente inaccettabile dei settentrionalismi di U e deglialtri mss. transappenninici (o meglio, in buona misura, dell’archetipo dellaCommedia). Personalmente – forse perché, come ha suggerito qualcuno, ho«una percezione scolastica e un gusto un po’ nostalgico dei fatti di lingua»– 26 non credo che i tratti discussi sopra siano minuzie. E tuttavia: che fare, inconcreto, per ridurre in una nuova edizione il numero dei settentrionalismidei piani alti, certo non attribuibili che in minima parte all’autore? 27
Come si ricorderà, Petrocchi ha “migliorato” Triv ricorrendo, senza faretroppa pubblicità, a questo o a quel ms. tra gli altri 26 mss. del suo testimo-niale; mentre Sanguineti, con una franchezza ammirevole, ma che rasental’autolesionismo, ha usato le quadre persino per informare su interventi scon-tati, come l’introduzione di una h diacritica in o[h]i. Per quanto mi riguarda,almeno come prima ipotesi di lavoro, mi propongo di continuare a controlla-re il comportamento di U su altri “settentrionali” a lui molto vicini, per es. ilsuo quasi gemello F oppure Pal. XIII.G.1 o Bol. Un. 589 (ma anche eventualialtri testimoni copiati nel Settentrione che non ho avuto finora modo di stu-diare, neanche parzialmente). Per i quali valgono le osservazioni già fatte perU (quando recano un fiorentinismo la testimonianza è preziosa ecc.). Tutte levolte che i mss. assunti come base (certo non 27, ma uno o due al massimo ol-tre a U, e scelti appunto tra i meno remoti dall’archetipo) divergono, scelgovolta a volta per il massimo della fiorentinità consentita dai manoscritti. Hoparafrasato, come è a tutti evidente, un luogo famoso di Contini, alla cuiprassi di editore dei Siciliani mi attengo: e non è quasi il caso di aggiungereche si tratta di un’applicazione sistematica del criterio contrastivo discussopiù sopra, già impiegato con sicurezza da Barbi per le sue edizioni della VitaNuova 28.
A titolo puramente sperimentale vi propongo un assaggio, cioè il V canto,che ricostruisco, limitatamente alla sola veste linguistica, sulla base di U + Bol(non registro, intenzionalmente, grafie comunissime e poco significativecome le h etimologiche e non, le oscillazioni e/7/et, le ç; i nessi latineggianti-ct – e -ps – o il tipo ti + voc.: gratioso ecc.; mentre le novità di sostanza, se cisaranno, saranno riservate ad altre sedi) (qui, comunque, le poche varianti so-stanziali di Bol sono in grassetto nell’apparato):
26 Guglielmo Gorni, Restituzione formale dei testi volgari a tradizione plurima, Il casodella «Vita nova», in «Studi di filologia italiana», LVI (19XX), pp. 5-30, a p. 25.
27 Tra i rari settentrionalismi – morfologici – danteschi andrà registrato anche l’enno in ri-ma del Paradiso discusso più sopra.
28 «Le poesie dei Siciliani sono qui offerte nella veste tradizionale [sc. quella toscanizzatadei canzonieri duecenteschi], al massimo della sicilianità attestata direttamente nei codici»(PD, I, p. 47).
Paolo Trovato
88
Così discesi del cerchio primaiogiù nel secondo, che men luogo cinghia
3e tanto à più dolor che punge a guaio.Stavvi Minòs orribilmente, e ringhia:
examina le colpe ne l’intrata;6giudica e manda secondo ch’avinghia.
Dico che quando l’anima mal natali vien dinanzi, tutta si confessa;
9e quei, conoscitor delle peccata,vede qual luogo d’inferno è da essa:
cingesi con la coda tante volte,12quantunque gradi vuol che giù sia messa.
Sempre dinanzi a llui ne stanno molte:vanno a vicenda ciascuna al giudizio;
15dicono e odono, e poi son giù volte.«O tu che vieni al doloroso ospizio»,
disse Minòs a me quando mi vide,18lasciando l’atto di cotanto offizio,
«guarda com’entri e di cui tu ti fide:non t’inganni l’ampiezza de lo ’ntrare»
21E ’l duca mio a llui: «Perché pur gride?Non impedir lo suo fatale andare:
vuolsi così colà dove si puote24ciò che si vuole, e più non dimandare».
Or incomincian le dolenti notea farmisi sentire; or son venuto
27là dove molto pianto mi percuote.Io venni in luogo d’ogne luce muto,
che mugghia come fa mar per tempesta,30se da contrarii venti è combattuto.
La bufera infernal, che mai non resta,mena li spirti colla sua rapina;
2 luogo Bol] luoco U 3 tanto à più U] tanto più Bol 4 stavvi Bol] stavi U5 exa – Bol U] essa – Sang # nell’e. Bol] ne l’i U 8 si confessa U] se c. Bol 9 e queiU] et quel Bol # delle U] dele Bol 10 luogo Bol] luoco U # d’i. è U] dinferne Bol11 cingesi con la U] cignese colla Bol 12 vuol Bol] vol U 13 a llui Bol] a lui U14 ciascuna al U] ciascun al Bol 18 cotanto Bol] cottanto U 19 di cui tu ti fide U]in cui tu te fide Bol 20 lo ’ntrare Bol] l’intrare U 21 a llui Bol] a lui U 23 vuolsiBol] volsi U 25 Or incomincian U] oran comincian ( = ora ‘nc.) Bol 26 farmisiBol] farmesi U 28 luogo Bol] luoco U 29 mugghia Bol] mughia U, mug[g]hiaSang 31 bufera Bol] buffera U 32 spirti colla U] spiriti con la Bol
89
Un problema editoriale: il colorito linguistico della commedia
33voltando e percotendo li molesta.Quando giungon dinanzi a la ruina,
quivi è le strida, il compianto e ’l lamento;36biasteman quivi la vertù divina.
Intesi ch’a così fatto tormentoeran dannati i peccator’ carnali,
39che la ragion somettono al talento.E come li stornei ne portan l’ali
nel freddo tempo, a schiera larga e piena,42così quel fiato li spiriti mali
di qua, di là, di giù, di sù li mena;nulla speranza li conforta mai,
45non che di posa, ma di minor pena.E come i gru van cantando lor lai
acendo in aere di sé lunga riga,48così vid’io venir, traendo guai,
ombre portate da la detta briga;per ch’io dissi: «Maestro, chi son quelle
51genti che l’aura nera sì castiga?»«La prima di color di cui novelle
tu v uo’ saper» mi disse questi allotta,54«fu imperatrice di molte favelle.
A vizio di luxuria fu sì rotta,che libito fé licito in sua legge,
57per tòrre il biasmo in ch’era condotta.Ell’è Semiramìs, di cui si legge
che succedette a Nino e fu sua sposa:60tenne la terra che ’l Soldan corregge.
L’altra è colei che s’ancise amorosa,e ruppe fede al cener di Sicheo;
63poi è Cleopatràs luxuriosa.Elena vedi, per cui tanto reo
tempo si volse, e vedi il grande Achille
34 dinanzi U] deventi Bol 35 quivi è U] quivi Bol # il compianto U] ilpianto Bol36 biasteman U] bestemian Bol 41 freddo U] fredo Bol 47 aere Bol] aer U 48vid’io Bol] vidd’io U 49 decta Bol] ditta U 51 aura Bol] aer U # castiga U] ghasti-gha Bol 53 vuo’ Bol] vòi U # questi U] quelli Bol 54 imperatrice U] imperadriceBol 55 luxuria U Bol] luss – Sang 57 biasmo U] biasimo Bol 58 Ell’è Bol] El’èU # si legge Bol] se l. U 61 L’altra è U] laltre Bol 62 cener di Sicheo U] gener disicceo Bol 63 Cleopatràs Bol] Cleopatrà U # luxu – U Bol] lussu – Sang 64 ve-diU] vidi Bol 65 si volse Bol] se v. U # vedi U] vidi Bol # Achille U] accille Bol
Paolo Trovato
90
66che con Amore al fine combatteo.Vedi Parìs, Tristano»; e più di mille
ombre mostrommi, e nominommi, a dito,69ch’amor di nostra vita dipartille.
Poscia ch’io ebbi il mio dottore uditonomar le donne antiche e i cavalieri,
72pietà mi giunse, e fui quasi smarrito.Io cominciai: «Poeta, volontieri
parlerei a quei due che ’nsieme vanno,75e paion sì al vento esser leggieri».
Ed elli a me: «Vedrai quando sarannopiù presso a nnoi; e tu allor li priega
78per quel’amor che i mena, e quei verranno».Sì tosto come ’l vento a nnoi li piega,
mov’i’ la voce: «O anime affannate,81venite a noi parlar, s’altri nol niega!»
Quali colombe dal voler chiamatecon l’ali alzate e ferme al dolce nido
84vengon per l’aere, dal disio portate;cotali uscîr de la schiera ove è Dido,a noi venendo per l’aere maligno,
87sì forte fu l’affettuoso grido.«O animal grazioso e benigno
che visitando vai per l’aere perso90noi che tignemmo il mondo di sanguigno,
se fosse amico il re de l’universo,noi pregheremmo lui della tua pace,
93da ch’ài pietà del nostro mal perverso.Di quel ch’udire e che parlar ti piace,
noi udiremo e parleremo a voi,96mentre che ’l vento, come fa, ci tace.
Sede la terra, dove nata fui,
67 vedi U] vidi Bol 70 Poscia Bol] possia U # dottore U] doctor Bol 71 e i cavalie-ri U] e kavalieri Bol 72 smarrito Bol] smarito U 73 cominciai Bol] cominzai U75 leggieri Bol] legieri U, leg[g]ieri Sang 76 elli U] egli Bol # saranno Bol] seranno U77 a nnoi Bol] a noi U # allor Bol] alor U # li U Bol2] l Bol1 79 a nnoi li Bol] a noi leU 80 muov’i Bol] mov’i U 82 dal voler U] dal desio Bol 83 con U] cum Bol# dolce U] dolçe Bol 84 aere Bol] aer U # dal disio U] dal voler Bol 85 ove è U]ove ( = ov’è) Bol 86 aere Bol] aer U 89 aere Bol] aer U 90 tignemmo U] tigne-mo Bol 92 pregheremmo U] pregaremo Bol # della U] dela Bol 95 parleremo U]parlaremo Bol 96 ci tace Bol] se tace U 97 fui Bol (rima sic.)] foi U, f[u]oiSang
91
Un problema editoriale: il colorito linguistico della commedia
su la marina dove ’l Po discende99per aver pace coi seguaci sui.
Amor, ch’al cor gentil ratto s’aprende,prese costui de la bella persona
102che mi fu tolta, e ’l modo ancor m’offende.Amor, ch’a nullo amato amar perdona,
mi prese del costui piacer sì forte,105che, come vedi, ancor non m’abandona.
Amor condusse noi ad una morte...Caino attende chi ’n vita ci spense».
108Queste parole da lor ci fuòr porte.Dach’io intesi quell’anime offense,
chinai il viso, e tanto il tenni basso,111fin che ’l poeta mi disse: «Che pense?
Quando risposi, cominciai: «Oh lasso,quanti dolci pensier’, quanto disio
114menò costoro al doloroso passo!»Poi mi rivolsi a loro e parlai io,
e cominciai: «Francesca, i tuo’ martìri117a lagrimar mi fanno tristo e pio.
Ma dimmi: al tempo de’ dolci sospiria che e come concedette amore
120che conosceste i dubbiosi disiri?»E quella a me: «Nullo è maggior dolore
che ricordarsi del tempo felice123nella miseria, e ciò sa il tuo dottore.
Ma s’a conoscer la prima radicedi nostro amor tu ài cotanto affetto,
126dirò come colui che piange e dice.Noi leggiavamo un giorno per diletto,
di Lancialotto, come amor lo strinse;
98 su la U] sulla Bol 99 seguaci sui Bol] sequaci soi U 101 prese costui de la bellapersona U] mi prese di costui la b. p. Bol 102 fu U] fo Bol # modo U] mondo Bol104 prese del U] porse di Bol 107 Caino U] Cayn Bol # chi Bol] che U # ’n vita ci s.U] da v. ci aspense Bol 109 Dach’io intesi Bol] Possia ch’e’ ntesi U 112 risposi,cominciai Bol] resp – cominzai U # Oh(O[h] Sang)] o U Bol 113 disio U] desio Bol115 a loro U] a llor Bol 116 cominciai Bol] cominzai U # tuo’Bol] toi U, t[u]oi Sang118 de’ Bol] di ( = d’i) U 120 conosceste U] -scesti Bol 121 Nullo è maggior U]nesun magior Bol 122 che Bol] ca U 123 nella U] ne la Bol 124 conoscer U]conosciar Bol 125 di nostro U] del n. Bol # cotanto Bol] cottanto U 126 dirò Bol]dirrò U 127 diletto Bol] deletto U 128 di Bol] de U
Paolo Trovato
92
129soli eravamo e sanza alcun sospetto.Per più fiate gli occhi ci sospinse
quella lettura, e iscolorocci il viso;132ma solo un punto fu quel che ci vinse.
Quando leggemmo il disiato risoesser basciato da cotanto amante,
135questi, che mai da me non fie diviso,la bocca mi basciò tutto tremante.
Galeotto fu il libro e chi lo scrisse:138quel giorno più non vi leggemmo avante».
Mentre che l’uno spirto questo disse,l’altro piangea, sì che di pietade
141io venni meno sì com’io morisse;e caddi como corpo morto cade.
129 sanza Bol] senza U 131 iscolorocci U] scolorocci Bol 132 solo Bol] sol U #fu Bol] fo U 133 leggemmo Bol] legemmo U, leg[g]emmo Sang 134 basciatoBol] basiato U, bas[c]iato Sang 135 fie U] fia Bol 136 basciò Bol] basio U, ba-s[c]iò Sang 138 leggemmo U] legemo Bol 139 l’uno spirto Bol] l’un spirto U,l’un [i]spirto Sang 141 morisse U] morissi Bol
Può darsi che io sia stato particolarmente fortunato nella scelta del cam-pione, ma mi pare che la fiorentinità del testo sia ampiamente salvaguardatasenza bisogno di ricorrere a un testimone come Triv, che si discosta dall’ar-chetipo in centinaia di lezioni.
8. Fin qui, spesso ripreso alla lettera, il mio intervento alla Certosa. Ma laparte, almeno per me, più istruttiva sta, come ho anticipato, nelle osservazio-ni dei discussants, Giancarlo Breschi e Giorgio Inglese, vale a dire un romani-sta e un italianista filologicamente competentissimi, e degli altri partecipantial dibattito, ben pilotato da Lino Leonardi. Mi pareva, a torto, che la miaesemplificazione non potesse non suggerire che, quando mss. stemmatica-mente alti e di diversa area linguistica esibivano tratti fiorentini, il grosso diquesti tratti dovesse risalire, di necessità, all’archetipo. Ma gli amici Breschi eInglese hanno sottolineato che le forme per me settentrionaleggianti erano,per quanto minoritarie, attestate in questo o quel rimatore fiorentino; che al-cune forme fiorentine di U e compagni potevano spiegarsi supponendo che icopisti settentrionali di Dante fossero ormai adusati alla lingua di Petrarca eBoccaccio (come avviene, e con tante incertezze, solo a certi scrittori fiorenti-neggianti); che qualcuna delle forme fiorentine duecentesche da me segnalatesi trovava d’altra parte anche nel più antico ms. datato fiorentino, il già ricor-dato Triv: che, come si è ricordato, da quasi un secolo svolge per il dantismo
93
Un problema editoriale: il colorito linguistico della commedia
un ruolo privilegiato, nonostante sia, dichiaratamente, il risultato di un’ambi-ziosa operazione contaminatoria condotta su non meno di 3 fonti 29.
In nome della tradizionale superiorità dei mss. fiorentini antichi, i mieioppositori d’ufficio erano disposti ad accettare che Dante incorresse in qual-che fiorentinismo verosimilmente anacronistico (cioè di generazioni più tar-de) e in qualche settentrionalismo non giustificabile con il suo scrupolo di ca-ratterizzazione linguistica dei personaggi (criterio del conveniens applicatoalla couleur locale), nonché a supporre che, come Manzoni, i copisti setten-trionali della Commedia avessero provveduto a risciacquare i loro panni inArno prima di intraprendere il lavoro di copia (suscitando, su questo secon-do punto, la ferma opposizione di un altro linguista-filologo presente al Gal-luzzo, Marzio Porro). Per contro, io davo per scontato che, con le parole diIgnazio Baldelli, la Commedia fosse «nel suo insieme l’opera più fiorentina diD., nella sua struttura fonetica, morfologica e sintattica e nel suo lessico fon-damentale, forse per un ricupero del fiorentino, anche sul piano teorico» 30.
Almeno in questa sede, non conta tanto stabilire chi abbia ragione (cioèquale sia l’ipotesi più economica) quanto riconoscere che, a ben guardare, siaio sia i miei oppositori incorporavamo nelle nostre argomentazioni scientifi-che delle valutazioni a priori, insomma ideologiche, rispettivamente su un’in-cognita come la lingua di Dante e su una scelta antitradizionale come quelladi ricorrere a testimoni settentrionali.
In altre parole: dopo aver passato ampiamente il mezzo del cammino e sipuò dire tutta la mia vita lavorativa pensando che la critica testuale fosseun’attività rispettabile perché si basava su dei fatti e conteneva al minimo in-dispensabile le chiacchiere degli operatori, ho scoperto di colpo, lavorandosu Dante (cioè un testo sentito, a ragione, fondante per la nostra identità na-zionale), che, se nei casi più semplici le soluzioni, in un certo senso, si impon-gono da sole, in situazioni ingarburgliate finiamo per farci guidare, dopo uncerto numero di verifiche, da una sorta di “giudizio globale” (la formula è diFrancisco Rico, che ha descritto con la consueta sagacia il clic dei filologi) 31.E non saprei come meglio concludere questa relazione dichiaratamente in-concludente se non condividendo con voi questa, per me tardiva, ma in gene-
29 Qualche indicazione sulle “fonti” di a, in NP, pp. 639-640 (Tav. 5); 698-700. Giacché,lentamente, ma inesorabilmente, la ricerca procede, posso precisare che, piuttosto che un affinedi Mad, una delle “fonti” sarà stata un affine di Pal. XIII.G.1 (del resto a Mad vicinissimo).
30 La nota diagnosi di Ignazio Baldelli (Lingua e stile delle opere in volgare di Dante, inED, App., pp. 55-112, a p. 93) è ripresa, per ultimo, da Serianni, Sul colorito linguistico, cit., p.146.
31 «E chiaro che non si può mai sapere in quale punto dell’eterno circolo vizioso di ogniermeneutica la somma delle osservazioni particolari si converte in giudizio globale che finisceper orientare le osservazioni posteriori» (Francisco Rico, “Lectio fertilior” tra la critica testualee l’ecdotica, in «Ecdotica», 2 [2005], pp. 23-42, a p. 30).
Paolo Trovato
94
rale intrigante, scoperta dell’intrusione di elementi ideologici anche all’inter-no di procedure che si considerano di solito oggettive e scientifiche come laricostruzione linguistica dei testi antichi 32.
Postille 2009. Un autorevole partecipante alla discussione pisana ritiene che ilpasso di Contini sui Siciliani da me citato al § 7 vada inteso nel senso che si deve se-guire per la veste linguistica u n s o l o codice, il più sicilianeggiante. Che non sia così(nel qual caso la formulazione risulterebbe inspiegabilmente macchinosa, anche perun autore difficile come Contini), emerge con chiarezza dai seguenti luoghi parallelicontiniani (miei i corsivi nelle citazioni): «Quanto alla forma, è adottata la più arcaicae siciliana che sia volta per volta fornita dalla tradizione»: Le rime di Guido delle Co-lonne (1954), ora in Frammenti di filologia romanza cit., I, pp. 235-264, a p. 235;«Poiché la ritraduzione in siciliano illustre, quale fu esperita dal Tallgren, dal Santan-gelo e dal Panvini, lascia forti incertezze singole, e d’altra parte i Siciliani hanno agitosulla cultura italiana nella veste toscaneggiata assegnata loro pochi decenni più tardi,la forma adottata è solo la più siciliana che sia direttamente documentata nei canzonie-ri»: PD, II, p. 801; «Giusta la formula media del Tallgren, la sicilianità, in rima e fuordi rima, risulta acquistita, quando l’alterazione si mantenga in limiti puramente for-mali, al massimo della documentazione diretta»: Esperienze d’un antologista del Due-cento poetico italiano (1961), poi in Breviario d’ecdotica cit., pp. 175-210, p. 192 ( =Frammenti di filologia romanza cit., I, p. 171): «Il Tallgren si attiene saggiamente almetodo 3 (specificato in “langue détoscanisée autant que le permettent les mss.”),mentre le applicazioni di quello che press’a poco si può chiamare il metodo 1 [sc.“Texte critique retraduit en ancien sicilien”] anche da parte di studiosi siciliani (San-tangelo, Panvini) hanno un intento meramente sperimentale e indicativo»: Rapportifra la filologia cit., p. 173 ( = Frammenti di filologia romanza cit., I, p. 97).
Per quanto riguarda la veste della Vita Nuova, di cui al § 1, Carrai ha avuto mododi mettere in pratica le sue a mio giudizio ragionevoli proposte nell’ed. Dante Ali-ghieri, Vita Nuova, introduzione, revisione del testo e commento di Stefano Carrai,Milano, Rizzoli, 2009 («BUR Classici»).
Quanto alle discussioni svoltesi al Galluzzo nell’ottobre 2008 (§§ 2 sgg.), la miarelazione (sostanzialmente identica alla versione orale e spesso coincidente con i §§centrali del presente saggio), è apparsa in «Medioevo Romanzo», XXXIII, 2009, pp.29-48; la controrelazione dell’amico Inglese (raddoppiata nella mole e con il titolo Fi-lologia dantesca: note di lavoro), è stata pubblicata nel fascicolo successivo della stessarivista, pp. 402-414.
Come mostrerò in altra sede, la replica di Inglese – che, trascinato forse dalla fogadel controargomentare, mi attribuisce spesso, per poi confutarle, posizioni da me nonsostenute (per es., a p. 407: traelli come esito di trae(no)li; a p. 408: Bol come “testi-mone ostile” ai toscanismi; a p. 410: l’obiettivo di ripristinare una indefinibile pro-porzione “ottima” tra forme diverse; a p. 411: l’intenzione di valutare punto per pun-
32 Solo per completezza di informazione aggiungo che, nel tentativo di esorcizzare questapotenzialmente minacciosa irruzione di soggettività, ho cercato di analizzarne alcune fattispeciein un recentissimo convegno (Storicità del testo, storicità dell’edizione, Trento, 15-17 dicembre2008).
95
Un problema editoriale: il colorito linguistico della commedia
to la “cronologia” delle forme) – non sembra da annoverare tra i suoi contributi piùfelici. In particolare, risulta sconcertante (perché fa pensare che Inglese non riesca,ancora, a prendere atto della reale dimensione del problema dopo Petrocchi, nonchédelle implicazioni delle indagini in corso) il § finale, intitolato Uno sguardo alla tradi-zione dei testimoni, in cui lo studioso ripropone un tentativo (parziale in tutti i sensi)di razionalizzare la tradizione, che si esaurisce all’interno del rispettabile, ma circo-scritto, apparato di Pertrocchi (27 mss. su 600): come se, in barba a Pasquali e a Tim-panaro, per il solo fatto di non essere registrati da Petrocchi nella fascia di variantidell’Edizione Nazionale, gli altri ca 570 testimoni non frammentari della Commedianon esistessero o dovessero essere eliminati come descripti.
Paolo Trovato
96