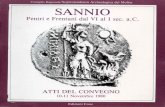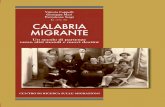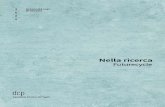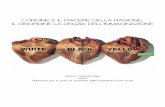«Parve cieco al mondo». Su un recente studio linguistico dell’«Italia liberata da’ Gotthi»
Transcript of «Parve cieco al mondo». Su un recente studio linguistico dell’«Italia liberata da’ Gotthi»
115
L’Italia liberata da’ Gotthi di Giovan Giorgio Trissino con ininterrotta saltua-rietà continua ad attirare l’interesse di un ridotto nucleo di studiosi. È un te-sto famigerato nella nostra storia letteraria, un poema epico in endecasillabi sciolti, scritto nel secondo quarto del Cinquecento e pubblicato in tre tomi di nove libri ognuno: il primo fu èdito nel 1547 a Roma, per Valerio e Luigi Dorico, gli altri due nel 1548 a Venezia, presso Tolomeo Gianicolo, lo stesso stampatore bresciano che aveva pubblicato molte opere di Trissino nel 1529 1.
Il poema è apparso da subito problematico ai lettori; ciò che è ben visibile, la grandiosità della progettazione e dello svolgimento narrativo all’interno del codice classicistico, si oppone a una «forma e disposizione poetica» che, a detta di tutti, difetta soprattutto per mancanza di discre-zione e misura, e che finisce per essere indicata come la prova dell’inade-guatezza del prodotto ultimato rispetto agli obiettivi e modelli dichiarati. Nei Discorsi dell’arte poetica Tasso indicò le ragioni del fallimento di Tris-sino nel connubio tra l’imitare religiosamente Omero e l’imprigionarsi nei precetti di Aristotele 2; ed in effetti l’omerismo dell’intellettuale vicentino è un punto centrale della sua riflessione teorica e un nodo fondamentale per la valutazione critica del poema.
Nella sesta parte della Poetica 3 Trissino rivendica «la grandezza me-diocre [‘mediana’] e mescolata di molte varietà» del poema epico greco
1 Si cita da queste edizioni, indicando il volume (I, II o III) e il numero di pagina o, se assente, il fascicolo e la carta.
2 T. Tasso, Discorsi dell’arte poetica, in Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico, a c. di L. Poma, Bari, Laterza, 1964, pp. 22-23.
3 G.G. Trissino, Poetica, VI, p. 46; si cita da Trattati di poetica e retorica del Cinque-cento, a c. di B. Weinberg, 4 voll. Roma-Bari, Laterza, 1970-1974, I, pp. 23-158 (div. I-IV [1529]); II, pp. 5-90 (div. V-VI [1562]).
Francesco Montuori
«Parve cieco al mondo». Su un recente studio linguistico dell’«Italia liberata da’ Gotthi»
lingua e stile, XlVii, giugno 2013
Francesco Montuori
116
come il modulo ideale su cui ha fondato il proprio progetto letterario; e nella dedica dell’Italia a Carlo V dichiara che, proprio seguendo Omero, si è formato l’idea motrice della narrazione e la modulazione della trama: «di tante [...] gloriose aczioni [di Giustiniano], n’elessi una, e non più», cioè «la liberazione ch’egli fece de la Italia da la servitù d’e Gotthi»; poi «ho inserite in molti luoghi aczioni formidabili e misericordiose, e [...] ho posto recognizioni, revoluzioni e passioni, che sono le parti necessarie de le favole» 4. Resta deluso, però, chi si aspetta di trovare, nelle molte varietà di una tale grandezza, personaggi potentemente delineati nel ca-rattere e nella condotta, simili a eroi omerici rivisitati in chiave rinasci-mentale. La vitalità dei personaggi è invece effimera, schiacciata com’è in una narrazione compulsivamente lineare in cui l’autore, avendo scelto l’unità d’azione come misura ideale dell’enunciazione epica, intende evi-tare la dispersività romanzesca del Furioso in nome di una rigida applica-zione delle norme della Poetica di Aristotele. Uomini e donne dell’Italia sembrano protendersi verso virtù medievali, cavalleresche e guerresche, ma sono anche condizionati da un realismo letteralmente sopraffatto dal verosimile, nei cui angusti confini tende a vincolarsi ogni fictio, in-clusi il meraviglioso e le storie d’amore. Così Belisario non riesce a esi-bire solennità nemmeno nel IX libro, dove è narrata la sua straordinaria visione del passato e del futuro, durante la quale sia gli eventi venturi della guerra gotica sia «l’ombre | de’ Poeti, de’ Sofi e de’ Guerrieri | illu-stri un tempo, a lui si fanno innanzi» 5. Al termine del lungo elenco (un canone molto significativo 6 e nemmeno troppo monotono), a Belisario
4 La Italia, vol. I, 1547 dedica a Carlo V, cc. *2v-*3r. Nella trascrizione, la grafia del testo è adattata alle consuetudini moderne, secondo i criteri adottati per l’edizione del vol-garizzamento del De vulgari eloquentia di Dante (vd. nota 27).
5 L’Italia liberata da’ Goti di Gian Giorgio Trissino, Venezia, G. Antonelli, 1835, col. 133 (dall’Argomento del IX libro).
6 «[...] quando a Belisario è concesso di incontrare in sogno il padre Camillo e di ve-dere anche lui, grazie all’angelo Erminio, i protagonisti della storia passata e futura, gli si presenta un Oltremondo dove, contrariamente alla tradizione cristiana, le anime dei tra-passati sono divise non con criteri di colpa o merito, ma a seconda del ruolo sociale che hanno avuto in terra [...]. L’assenza nella visione trissiniana della storia dell’idea di con-flitto si traduce, in altre parole, in un aldilà che non è altro che riproduzione di gerarchie terrene, vagheggiate come immobili ed eterne» (C. Gigante, Epica e romanzo in Trissino, in La tradizione epica e cavalleresca in Italia (XII-XVI sec.), a c. di C. Gigante e G. Palumbo, Bruxelles, Peter Lang, 2010, pp. 291-320, a p. 299). Né sembra meno interessante che l’elencazione degli scrittori antichi avviene per rigida scansione dei generi letterari: prima
Su uno studio linguistico dell’«Italia liberata da’ Gotthi»
117
vengono mostrate le macchine che hanno cambiato il mondo nel corso del XV secolo, cioè i torchi delle tipografie e le armi da fuoco. Sono proprio queste ultime, e non le appena apparse tre corone del nostro Trecento, che attirano l’attenzione del generale bizantino, ma per una sorta di ingenuo utilitarismo che viene prontamente censurato dall’an-gelo accompagnatore:
A questo Belisario alzò la fronte,e risguardando assai quel nuovo ingegno,desiderava di portarlo secogiù ne la vita a dibellare i Gotthi;di che s’avvide il messaggier del cielo,e disse a lui queste parole tali:«Capitanio gentil, volgi la mentead altro, perché Dio non ha permessoanchora al mondo quel flagello orrendo,che, se indugiasse a darlo ben mill’anni,e mille e mille, fia troppo per tempo».
(I, p. 174r)
L’omerismo di Trissino si attiva su più dimensioni e si manifesta in più temi, che lasciano scorgere, almeno in teoria, lo spazio per una più am-pia variazione dei modi della narrazione: «Ancora Omero ci ha inse-gnato come si denno dire le menzogne, e questo è col paralogismo, il quale è cosa che mena i pensier nostri fuori della dritta ragione. [...] E simili paralogismi usa molto Omero, attribuendo quasi sempre le cause delle nostre azioni alli dèi, i quali dèi furono da quelli antiqui e sa-pientissimi filosofi quasi tutti con bellissimi figmenti dalle cose naturali formati» 7. Tuttavia, scegliendo di riprodurre in chiave cristiana quell’in-terazione fra cielo e terra che tanta parte ha nella narrazione omerica, Trissino traduce meccanicamente le relazioni tra uomini e divinità olim-piche e trasferisce ruoli e azioni per analogia: così, con sconcertante ingenuità, l’ira e il desiderio di vendetta passano da Giunone alla Ma-
Omero e Virgilio («che seguì prima Syracusa et Ascra | per selve e campi [cioè Teocrito ed Esiodo per le Bucoliche e le Georgiche], e poi divenne a l’arme [cioè all’Eneide]»), poi la «tragica caterva», i commediografi («quell’altra gente, che ridendo | pigliano l’acqua»), «la lyrica famiglia», «la Elegia», «l’Egloga» (I, pp. 160v-161r).
7 Poetica, VI, p. 50.
Francesco Montuori
118
donna e gli angeli si schierano tra i contendenti proprio come gli dèi antichi 8.
Anche l’obiettivo, perseguito con tenacia, di ricalcare Omero sin nei suoi tratti formali, istituzionalizzati nei trattati della scuola aristotelica, non manca di provocare effetti controversi nel rinnovato impianto epico. L’ammirabile, «di sua natura cosa suave», si ottiene con le comparazioni, e queste «si fanno per tre effetti, o per augumentazione, o per chiarezza, o per enargia, che è un ponere la cosa quasi avanti gli occhi» 9. Proprio l’enargia è un ingrediente omerico rivendicato nella dedica dell’Italia: «E se ben non mi sono potuto approssimare a la excellenza di così divino Poeta [cioè di Omero], pur ho tentato di seguitarlo da la lunga, imitando et adorando le sue pedate, e cercando, a mio potere, essere come lui cop-pioso e largo, et introducendo quasi in ogni loco persone che parlino, e descrivendo assai particularità di vestimenti, di armature, di palazzi, di castrame[n]tazioni e di altre cose; perciò che, come dice Demetrio Pha-lereo, la enargia, che è la efficace rappresentazione, si fa col dire dili-gentemente ogni particularità de le aczioni, e non vi lasciar nulla; e non troncare nè diminuire i periodi che si dicono» 10. La dimensione formale dell’omerismo di Trissino è l’aspetto del poema che apparve veramente moderno già ai lettori cinquecenteschi 11 e che, al contempo, lascia inter-detti per i toni soprendentemente informali che impone al racconto sul piano discorsivo. Non sempre nel testo epico è opportuno avvalersi delle «belle et ornate parole», «perciò che le troppo splendide et ornate pa-role (come dice Aristotele) ascondeno i costumi e le sentenzie e non la-sciano apparere la lor bellezza, la quale dee per tutto il poema lasciarsi benissimo vedere» 12. E così le innovazioni della poesia epica rilanciano il coinvolgimento e la partecipazione del lettore alla storia attraverso l’ab-
8 Vd. A. Quondam, La poesia duplicata. Imitazione e scrittura nell’esperienza del Tris-sino, in Convegno di studi su Giangiorgio Trissino, Vicenza, 31 marzo-1 aprile 1979, Odeo del Teatro Olimpico, a c. di N. Pozza, Vicenza, Accademia Olimpica, 1980, pp. 67-109, alle pp. 93-95; C. Gigante, Un’interpretazione dell’«Italia liberata dai Goti», in Id., Esperienze di filologia cinquecentesca. Salviati, Mazzoni, Trissino, Costo, Il Bargeo, Tasso, Roma, Salerno Ed., 2003, pp. 46-79, alle pp. 66-69.
9 Poetica, VI, pp. 48-49; e vd. p. 85: «la enargia non è altro che lo esplicare particolar-mente le cose e quasi ponerle avanti gli occhi».
10 La Italia, I, 1547, dedica a Carlo V, c. *3v. 11 Vd. C. Gigante, Un’interpretazione, cit., p. 60. 12 Poetica, VI, p. 52.
Su uno studio linguistico dell’«Italia liberata da’ Gotthi»
119
bassamento del registro 13, per ottenere il quale sommamente necessarie appaiono le convinzioni storico-linguistiche di Trissino.
L’episodio relativo all’amore di Giustino e Sofia, che occupa intera-mente il III libro dell’Italia, è, a questo riguardo, emblematico: il ni-pote dell’imperatore Giustiniano parte con Belisario per l’Italia al fine di dimenticare l’amata Sofia; la donna diviene consapevole dei suoi sen-timenti nei confronti del giovane proprio nel momento in cui questi si assenta; richiamato indietro, Giustino è vittima di un naufragio e So-fia si avvelena per il dolore; entrambi però, adeguatamente assistiti, si riprendono e si uniscono in matrimonio. Sarebbe possibile enfatizzare alcuni momenti vagamente danteschi del racconto, quando Sofia mani-festa «tema d’infamia» 14 o quando la gioia dell’amante viene comparata coi legami affettivi che il mercante prova per i parenti e la roba 15, e così contribuire a promuovere la lettura del racconto come un episo-dio di «storia borghese» 16. Ma, ancora una volta, conviene soffermarsi sul versante espressivo. La naturalezza poco immaginativa della lingua
13 Vd. E. Musacchio, Il poema epico ad una svolta: Trissino tra modello omerico e mo-dello virgiliano, in «Italica», 80/3, 2003, pp. 334-352: 342.
14 Sofia «[...] volea gettarsi | da una fenestra e terminar la vita, | ma per tema d’infa-mia si ritenne» (I, p. 54r): vd. Inf. XXVII, 66. Sceglie allora il veleno, ma la sorella Asteria reagisce con spirito fattivo e, al contempo, accorto: «Come hebbe inteso Asteria il caso amaro | de la sorella sua che amava tanto, | non stette a lacrimar, nè a far lamenti, | come fanno le donne alcuna volta; | ma se n’andò con fretta a ritrovare | il bon Elpidio e poi narrolli il bere | di quel venen, ma la cagion si tacque, | fingendo che l’havea bevuto in fallo» (I, p. 55v).
15 Giustino accorre, certo di trovare l’amata morente, e invece può abbracciarla in sa-lute: «E venne per veder la donna estinta, | e quivi appresso lei finir la vita. | Ma giunto in quella stanza, ritrovolla | già liberata e fuor d’ogni periglio, | onde gli nacque al cuor tanta dolceza, | che quasi non sapea dove si fosse. | E come il mercatante, il quale ha nuova | che ’l ricco suo naviglio è in mar sommersso, | ove ha il figliuolo et ogni sua sustanza, | corre sul lito e si lamenta e plora: | ma quivi poi lo vede entrar nel porto | con le persone e con la robba salva, | onde s’admira e dentr’al cuor si sente | diletto e gioia fuor d’ogni misura; | così facea quel giovinetto amante, | vedendo viva e fuor d’ogni periglio | la donna sua, che già tenea per morta» (I, pp. 56r-v). Vd. Cv. IV XIII 11.
16 E. Bonora, Il Classicismo dal Bembo al Guarini, in Storia della letteratura italiana, a c. di E. Cecchi e N. Sapegno. IV. Il Cinquecento, Milano, Garzanti, 1976 (I ed. 1966), pp. 127-597: 424. Per una valutazione critica della storiografia che, ai primi del Novecento, estendeva alla classe borghese diversi caratteri “spirituali” come l’ipocrisia e l’individuali-smo, vd. B. Croce, Di un equivoco concetto storico: la “borghesia”, in «La critica», 26, 1928, pp. 261-274 (già in «Atti dell’Accademia di Scienze morali e politiche della Società Reale di Napoli», LI, 1927, pp. 106-124).
Francesco Montuori
120
si manifesta nella ricorrenza pervicace di ripetizioni letterali a breve di-stanza 17, con un eccesso di ragionevolezza che si manifesta anche nel ricorso alla medietà dei toni, da cui Trissino non deroga mai. Tali scelte stilistiche si mostrano evidenti quando si confronti il testo dell’Italia liberata con il Giustino di Metastasio (1712), adolescenziale tragedia a lieto fine ispirata alla storia narrata nel terzo libro del poema 18. Spinto da Gravina, suo maestro e isolato ammiratore di Trissino, il giovanis-simo Metastasio ridisegna la storia dei due amanti con buon mestiere. Prevedibilmente vengono eliminati i collegamenti tra gli affetti dei per-sonaggi e le convenzioni sociali, perché tutto rinvia alla complessità (fi-siologica e già sentimentale) della natura umana. Ma quel che conta di più è che Metastasio abbandona alcuni strumenti formali che abbiamo visto ricorrere nel poema di Trissino: evita quelle ripetizioni ravvicinate che nel modello si devono attribuire a una formularità intransigente e forse malintesa, e soprattutto, parafrasando, rimodula il lessico dell’ori-ginale e introduce un’aulicità un po’ ingenua ma efficace. Nell’Italia li-berata Filebo si impegna a far riprendere i sensi agli sventurati amanti; prima a Giustino: «Onde lo pose con i piedi in alto, | e con la bocca in giù, perché gli uscisse | l’acqua del petto, e risvegliasse i spirti»; e poi anche a Sofia:
Il medico gentil vi venne, e tolseolio con acqua tiepida e gliel porse,ed ella il hebbe e vomitò il veneno.Poscia un perfetto antidoto le diede,che ogni maligna qualità rimosse,e nel suo primo stato la ripose.
Nel Giustino i versi sopra citati sono così riformulati:
17 Sofia decide di bere del veleno che trova nella stanza della sua ancella: «[...] e vide | acqua con sullimato in un fiaschetto, | che la donçella sua, per esser bruna, | l’adoperava a far la faccia bianca» (p. 54r); le stesse parole rioccorrono dopo pochi versi, quando la sventurata racconta la drammatica risoluzione alla sorella: «volgendo gl’occhi, vidi in un fiaschetto | acqua con sullimato, ch’ella usava, | perch’era bruna, a far la faccia bianca» (p. 55r).
18 La tragedia fu pubblicata in Poesie di Pietro Metastasio Romano, Napoli, Muzio, 1717, pp. 33-144; da qui si cita modernizzando parcamente maiuscole, punteggiatura e se-gni diacritici.
Su uno studio linguistico dell’«Italia liberata da’ Gotthi»
121
Egli dal falso umor, che bevve, oppressomorto parea. Ma poiché il buon Cleonevolgere il fe’ co’ piedi inverso il Cielo,e là col capo, onde levò le piante,l’umor soverchio dal suo peso trattouscìo di là, dond’ebbe pria l’ingresso
(a. IV, sc. 7)
E, in relazione a Sofia, con le parole del medico:
Una bevanda tepida le porsi,che provocò lo stomaco, e le fecerendere al suol l’avvelenato umoreche avrebbe l’alma dal suo nodo sciolta,se maggior tempo in lei facea dimora.Prese poscia un antidoto possente,che ricercando ogni riposta parterimosse, e consumò, col suo vigore,ogni rimasta qualità mortale;talché ora vive, e viverà felice.
(a. V, sc. 3)
I segnali di autonomia stilistica si affastellano: nel Giustino, Sofia non vo-mita il veneno ma rende al suol l’avvelenato umore; l’aggettivazione si in-fittisce a scapito dell’originale abbondanza dei sostantivi e amplifica, con dolcezza, i moduli sintagmatici; le parole dei personaggi ricercano peren-nemente il senso della storia e lo formalizzano non in comparazioni ma in dittici sentenziosi 19. E così, nel passaggio dal Rinascimento all’Arcadia e dall’epica alla tragedia, il più diretto ricettore dell’Italia liberata sembra amputare il poema proprio dei segni della sua più grande audacia, quelli che provengono dall’adesione all’«Idea di Omero».
Effettivamente, vista attraverso il filtro delle forme epiche vincenti nel Cinquecento o quello della tragedia di impostazione già melodrammatica, l’opera di Trissino appare davvero mutilata al lettore moderno, priva di senso e irriconoscibile rispetto ai modelli orgogliosamente rivendicati. Ep-
19 È sufficiente un solo esempio. Sofia, ingannata dalla vista dell’amato che aveva cre-duto morto, ha assunto «un mortifero veleno» e corre verso la morte: «Oh mio Giustin, non mio, che ’l Ciel non vuole, | s’io vivo per averti a morte corri, | s’io muojo per seguirti in vita resti?» (a. IV, sc. VIII).
Francesco Montuori
122
pure proprio la damnatio, che codifica l’Italia come una sorta di «rovina archeologica» della nostra letteratura, ne rafforza il fascino agli occhi di chi vuole restituirle un senso storico, fortificandone così il ruolo di te-stimone del passato 20. Ma perché il testo possa svolgere ancora la fun-zione di reperto, il lettore moderno ha bisogno di sussidio, di strumenti per meglio comprendere: tale è uno studio apparso di recente per mano di Maurizio Vitale, che costituisce, soprattutto sul versante linguistico, un’approfondita indagine dell’omerismo di Trissino 21.
Nell’ultimo quarto di secolo Maurizio Vitale ha tessuto una solida trama di studi monografici sulla lingua di personalità di spicco della storia lette-raria d’Italia e ha potuto così delineare una sorta di ordinato database per chi voglia conoscere la prassi dei singoli autori nell’uso letterario dell’ita-liano e per chi intenda ricostruire tendenze e orientamenti in diacronia, anche in relazione a usi linguistici formalizzati in modo diverso rispetto a quelli letterari. Gli studi sul Canzoniere di Petrarca (1996), sulle redazioni del Decameron di Boccaccio (2002), sulla prima edizione dell’Orlando fu-rioso di Ariosto (2012), sulla Gerusalemme liberata di Tasso (2007), sulle Operette morali di Leopardi (1992), sulle correzioni di Manzoni ai Pro-messi Sposi (1986) e alle tragedie (2000), sul Mulino del Po di Bacchelli (1999), quindi, formano una rete di informazioni fondamentale per chiun-que intenda studiare la lingua italiana. Il primo pregio di un così fitto si-stema di monografie consiste nell’essere coerente con alcune convinzioni condivise: la consapevolezza che l’importanza della letteratura nella sto-ria linguistica d’Italia va ben al di là del registro strettamente letterario e la convinzione che tutte le acquisizioni sulla lingua degli autori servono per stilizzare un quadro completo degli usi linguistici in diacronia. D’altra parte vi sono ragioni interne, cioè motivi di metodo, che rendono molto
20 «Secondo la tradizione occidentale, le rovine segnalano al tempo stesso un’assenza e una presenza: mostrano, anzi sono, un’intersezione fra il visibile e l’invisibile. Ciò che è invisibile (o assente) è messo in risalto dalla frammentazione delle rovine, dal loro carattere “inutile” e talvolta incomprensibile, dalla loro perdita di funzionalità (o almeno di quella originaria). Ma la loro ostinata presenza visibile testimonia, ben la di là della perdita del valore d’uso, la durata, e anzi l’eternità delle rovine, la loro vittoria sullo scorrere irrepara-bile del tempo» (S. Settis, Futuro del “classico”, nuova ed., Torino, Einaudi, 2004, p. 85).
21 M. Vitale, L’omerida italico: Gian Giorgio Trissino. Appunti sulla lingua dell’«Italia liberata da’ Gotthi», Venezia, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, 2010.
Su uno studio linguistico dell’«Italia liberata da’ Gotthi»
123
utili i lavori di Vitale: gli spogli fono-morfologici e lessicali, che costitui-scono la sezione più ampia dei suoi saggi, sono condotti tenendo conto delle peculiarità e delle particolari finalità della scrittura letteraria, sono corredati di riscontri con repertori lessicografici e grammaticali e con opere coeve, e sono caratterizzati da una grande attenzione alla cronolo-gia delle varianti d’uso dei vari autori, anche in altri testi, autografi (se disponibili) e non letterari. La limpidezza nell’esposizione dei dati lin-guistici, che facilita la consultazione dei saggi, e la rapidità di giudizio, fondata su una competenza storiografica provata in oltre sessant’anni di attività di ricerca, si manifestano, in tutti gli studi di Vitale, in pagine di presentazione che forniscono al lettore un quadro completo dei risultati del lavoro di spoglio e di analisi.
Anche il saggio su Trissino appartiene a questo filone di ricerca. All’inizio Vitale informa sul testo e su alcune caratteristiche sostanziali e formali delle cinquecentine (cap. I, pp. 3-7); poi, fornito un rapido pa-norama sugli Orientamenti culturali e intenti poetici di Trissino (cap. II, pp. 9-18), documenta La forma espressiva dell’«Italia liberata», eviden-ziando prima una serie di scelte retoriche, di consuetudini stilistiche e di ricorrenze lessicali e poi documentando l’elocutio dell’opera, in relazione agli usi linguistici dell’autore e dei suoi contemporanei. Dopo un breve capitolo riassuntivo (Il sistema linguistico trissiniano nel quadro del dise-gno omerico, cap. IV, pp. 209-214) e prima del prezioso Indice delle voci e delle cose notevoli (pp. 243-254), vi è un’interessante appendice che ri-porta il testamento e un codicillo autografi di Trissino, rispettivamente del 1543 e del 1549 (pp. 215-228).
L’impostazione del saggio privilegia un punto di vista inatteso sul te-sto e sull’autore. Gian Giorgio Trissino è noto soprattutto per le sue teo-rie linguistiche, pubblicate in scritti èditi fra il 1524 e il 1529: dall’autore della più completa rassegna delle discussioni sulla lingua in Italia 22 ci si attendeva uno studio che mettesse in relazione il poema con gli scritti teorici di Trissino e con i fondamenti (e le debolezze) delle norme in con-correnza fra loro nella prima metà del Cinquecento. Invece, Vitale si è in-teressato innanzitutto a un elemento che caratterizza Trissino da un punto di vista molto più generale, relativo alla storia della cultura in Italia: come
22 M. Vitale, La questione della lingua, Palermo, Palumbo, 1978 (I ed. 1960).
Francesco Montuori
124
lascia intendere il titolo, infatti, largo spazio è riservato alla documenta-zione dell’influsso omerico su Trissino. Citato esplicitamente nella dedica all’imperatore Carlo V, il poeta greco è posto come blasone del rinnova-mento della poesia epica rinascimentale, esempio sublime di quei princìpi che in seguito erano stati formalizzati da Aristotele: «Nè solamente nel constituire la favola di una azione sola e grande che habbia principio, mezzo e fine, mi sono sforzato servare le regole d’Aristotele, il quale elessi per maestro, sì come tolsi Homero per duce e per idea; ma anchora, se-condo i suoi precetti, vi ho inserite in molti luoghi aczioni formidabili e misericordiose [...]» (I, c. *3r). Ma la grecità di Trissino, avverte Vitale, non è solo il modello sul quale prende forma il poema, elaborato su se-quenze di scene giustapposte, secondo prescrizione classica, sullo sfondo di un’azione ininterrotta. Anche molti espedienti espressivi risultano mu-tuati dallo stile omerico: quindi, tutto il capitolo secondo del saggio di Vi-tale e la prima parte del capitolo terzo, dedicata alla sentenza del poema (pp. 16-64), documentano o citano tali influssi. In queste pagine vi sono lunghi elenchi di formule dalle varie funzioni, allocuzioni, epiteti, intro-duzioni del discorso diretto, similitudini, perifrasi, che risentono di tutta la classicità disponibile all’uomo rinascimentale, quindi anche di quella la-tina (Virgilio e Orazio su tutti) e di quella italiana (Dante, in particolar modo), ma che soprattutto sono una testimonianza di quanto profonda sia l’influenza dell’Iliade sulla lingua dell’Italia liberata.
Il resoconto dell’omericità di Trissino fornito da Vitale è davvero im-pressionante, nella sua cruda letteralità. Tra i tanti particolari riferiti, vi è anche un cenno ai nomi di persona: «è notabile che l’onomastica degli episodi romanzeschi riconduca per lo più alla grecità» (p. 10, n. 7). Una rapida ispezione dell’indice dei nomi dell’edizione Antonelli (Vicenza, 1835) conferma pienamente il giudizio di Vitale e consente ulteriori ap-profondimenti: è possibile osservare, sul terreno della grecità di fondo, quali siano i settori dell’onomastica che si sottraggono alla patina elleniz-zante e che mostrano le stravaganti stratificazioni che Trissino ha operato sull’idea di Omero, indotto dalla sua ansia di riportare una forma restau-rata di epica in Italia. Nel II libro (vv. 132-458) e nel X libro (vv. 425-839) due lunghi elenchi riportano rispettivamente il catalogo delle truppe imperiali pronte per la spedizione in Italia e il repertorio dell’esercito dei Goti in procinto di marciare contro Belisario asserragliato in Roma. Il modello comune è l’episodio del III libro dell’Iliade in cui Elena dall’alto
Su uno studio linguistico dell’«Italia liberata da’ Gotthi»
125
delle mura di Troia indica a Priamo l’esercito greco; vi sono anche ampie differenze, a cominciare dall’abbandono della drammatica conversazione a più voci dell’originale greco, sostituito da una lunga e monotona elenca-zione. Soprattutto, in entrambi i luoghi dell’Italia liberata, messi da parte i consueti ritmi dialogici della narrazione, Trissino mostra di essere indi-pendente non solo da Omero, ma anche dalla sua principale fonte storica, Procopio di Cesarea 23: e tale autonomia si manifesta anche nell’onoma-stica. Il versante greco è ricco di innovazioni e neocomposizioni, una pro-cedura che vale qui per i condottieri dell’esercito bizantino come altrove per le ninfe o altri personaggi 24. La lunga esposizione dell’esercito dei Goti nel X libro, dove si passano ordinatamente in rassegna i capitani ger-manici e le relative località su cui esercitavano il loro potere, riserva qual-che sorpresa. Il lungo passo mostra che lo sforzo compositivo di Trissino ha l’intento di compilare un repertorio di guerrieri, non tanto per esal-tarne le doti guerresche o l’esemplarità morale, elementi che non possono emergere da figure così sbiadite e da nomi solo in minima parte condivisi dal suo potenziale pubblico. Invece lo scopo dell’autore sembra quello di tessere un minuzioso e ordinato reticolo di toponimi d’Italia, e per far questo utilizza un’antroponimia germanica che solo in una dozzina di casi deriva da La guerra gotica di Procopio. Non è una soluzione di comodo per Trissino: egli, nella sua tensione verso il verosimile, contempera nomi reali che provengono da diverse fonti; in più, ne inventa altri, talvolta mi-rando a una verosimiglianza del significante, talaltra mostrando in modo più scoperto la simulazione del nome germanico: e tutto questo, secondo quanto riferito dal suo maggior biografo Vincenzo Morsolin, per stilizzare dietro la ferocia dei barbari non solo personaggi dell’Iliade ma anche co-noscenti e familiari, come l’inviso figlio Giulio, nascosto sotto il composto Agrilupo, «perfido e rapace», che aveva «il padre | buono e indulgente, e la natura ingrata» (II, p. 13). Ma, come detto, il principale obiettivo di Trissino in un elenco di tal genere era quello di formare un repertorio delle località dell’Italia centro-settentrionale, con una nomenclatura fitta e cinquecentesca («[...] erano terre allor senza quei nomi | come molt’altre ancor, ch’abbiam nomate, | e che nominerem sovr’altri luoghi», II, p. 11)
23 Vd. C. Gigante, Un’interpretazione cit., alle pp. 53-65. 24 Vd. V. Gallo, Paradigmi etici dell’eroico e riuso mitologico nel V libro dell’Italia di
Trissino, in «Giornale storico della Letteratura Italiana», 181, 2004, fasc. 595, pp. 373-414.
Francesco Montuori
126
che sembra rinviare a un prospetto cartografico a grana fine. La serialità dei nomi impone alla pazienza del lettore lo stesso tributo di altri elenchi celebri, come le famiglie fiorentine di If. XXXII e Pd. XVI o le sfilate dei personaggi nei Triumphi di Petrarca. Ma questa volta il memorandum non è punteggiato, come in Dante, dal linguaggio crudo per rivendicare l’iden-tità ideale della puritas urbana, né si profila nel ricorso anche iconogra-fico che Petrarca opera sulla classicità, riconquistata e rimodellizzata nelle rassegne di uomini illustri: il reticolo geografico di Trissino costituisce un profilo dell’Italia centro-settentrionale all’inizio dell’età moderna, il cui in-teresse risiede nella nettezza dei confini verso l’esterno e nell’articolazione interna tra città e campagna 25. Si intravedono quei medesimi elementi co-stitutivi dell’idea di Italia che si manifestano in certo Umanesimo italiano da Biondo Flavio a Leandro Alberti 26. Non è un caso, allora, che Trissino abbia dato un contributo, sia pur piccolo, proprio alla Descrizione di tutta l’Italia di Alberti, facendo un sopralluogo tecnico (con relative misura-zioni) alle Cave di Costozza per fornirne un’articolata descrizione in una lettera inviata da Cricoli il 5 maggio 1537.
La nomenclatura del territorio è solo un minimo segno della rilevanza che l’idea di Italia aveva assunto nel programma culturale e nell’attività editoriale di Trissino. Con l’intellettuale vicentino riemerge dall’oblio il più significativo preliminare della questione della lingua, il trattato dante-sco De vulgari eloquentia, mai circolato in Italia fino a quando Trissino ne ritrovò un esemplare, da cui fece approntare una copia per Pietro Bembo e dal quale trasse la traduzione pubblicata nel gennaio del 1529 27. Ed è Trissino a teorizzare, in forma pubblica e ampiamente dibattuta, la con-tinuità del policentrismo e del plurilinguismo dell’italiano dalle origini al Cinquecento, concretizzandola in un modello storico e grammaticale al-ternativo a quello arcaizzante, classicista e modulare di Bembo. Trissino, quindi, nel 1529 pubblicò opere di riforma ortografica, di grammatica, di
25 «Non esiste, che io sappia, altra opera poetica del Cinquecento, da cui si possa ri-cavare, sommando i riferimenti, una così ampia e particolareggiata carta storico-geografica dell’Italia» (C. Dionisotti, L’Italia del Trissino, in Atti cit., pp. 11-22: 21).
26 Vd. F. Bruni, Italia. Vita e avventura di un’idea, Bologna, il Mulino, 2010, pp. 147-188.
27 Vd. ‘De la volgare eloquenzia di Dante’. Volgarizzamento di Giovan Giorgio Trissino, a c. di F. Montuori, in Dante Alighieri, De vulgari eloquentia, a c. di E. Fenzi, con la colla-borazione di L. Formisano e F. Montuori, Roma, Salerno Ed., 2012, pp. 443-596.
Su uno studio linguistico dell’«Italia liberata da’ Gotthi»
127
storia dell’italiano e del modello colto (ma non solo scritto) da seguire, e rifondò il panorama teorico della sua poetica. Ma al contempo fornì esempi di scrittura letteraria nella tragedia La Sofonisba (già diffusa ma-noscritta nel 1518 con dedica a Leone X) e nella lirica con le Rime. Così, alla funzione speculatrice e sistematrice l’intellettuale vicentino affiancò esempi concreti di applicazione delle sue teorie ortografiche, linguistiche, retoriche ed estetiche, completate con la prosa di servizio della traduzione del De vulgari eloquentia e poi con il poema epico dell’Italia liberata. Non una grammatica silenziosa, quella di Trissino, ma loquace nei testi dello stesso teorizzatore e riformulata in modelli moderni. Finora era mancata una lettura linguistica delle sue opere, che verificasse la reale applicazione delle teorie grammaticali nei testi letterari. Si era fermi alla postilla di Al-berto Castelvecchi in appendice agli Scritti linguistici 28, dove, con l’aiuto dei ricchi Errata corrige delle opere a stampa del vicentino, si procedeva alla ricerca di un orientamento utile per valutare le oscillazioni ortoepi-che testimoniate dai testi: le correzioni consentono infatti di discriminare tra il disordine delle interpolazioni inserite in tipografia per la pressione della lingua dei compositori e l’ordine dei mutamenti di idea che l’autore ha maturato nel tempo, abbandonando una delle varianti compresenti per adottarne un’altra. Il lavoro da fare sembra ancora molto, sotto questo punto di vista, ma con il libro di Maurizio Vitale si compie decisamente un passo in avanti nello studio delle consuetudini linguistiche di Trissino, anche grazie ai riscontri (forniti in nota) tratti dalla tragedia e dalle liri-che: le informazioni che se ne traggono sono preziose, ad esempio, per discriminare fra forme isolate e altre consuete (sebbene idiosincratiche) nel raddoppiamento consonantico dovuto a ipercorrettismo (pp. 149-150 nota 506).
La caratteristica che spicca sopra tutte dallo spoglio è la medietà delle scelte linguistiche di Trissino. La sua moderazione nella ricerca di una norma condivisa era riconosciuta da (quasi) tutti i polemisti del Cinque-cento: né il protopurismo fiorentino né il classicismo di Bembo potevano condividere l’eclettismo che l’intellettuale vicentino teorizzava nei suoi trattati; aggirati tutti gli ostacoli fono-morfologici (messi in risalto invece da Machiavelli nel suo Discorso) e impostata la questione sul piano so-
28 Vd. G.G. Trissino, Scritti linguistici, a c. di A. Castelvecchi, Roma, Salerno Ed., 1986.
Francesco Montuori
128
stanzialmente lessicale, nella teoria italianista di Trissino la lingua comune si concretizza in un genere gerarchicamente superiore a diverse specie lo-cali e va denominato, come già aveva fatto Dante, italiano. Di qui la par-ticolare avversità manifestata contro le sue posizioni teoriche, che però si dissolveva di fronte alle prove pratiche, molto meno scandalose delle sue idee storiografiche. Le numerose censure accumulate dalle opere di Tris-sino, a cominciare da quella più celebre per mano di Torquato Tasso, non riguardavano la lingua ma globalmente l’equilibrio tra formulazione del discorso e ritmo della narrazione; del resto l’ingloriosa fama dell’Italia li-berata è certamente eccessiva, anche in relazione alla facilità di lettura del testo per un italofono di oggi. Questa caratteristica sarà un significativo effetto anche dell’abbandono del vincolo rimico in seguito all’adozione dell’endecasillabo sciolto, che priva il poeta della restrizione e della guida della rima nella scelta degli allofoni e degli allotropi, che qui, prima di entrare nella disponibilità del poeta, sono selezionati a monte dal gram-matico. Proprio su questo aspetto si concentra il giudizio di Gian Vin-cenzo Gravina, solidale con Trissino, perché «volle [...] disciogliere in tutto le violente leggi della rima [...]. E dar volle nella sua Italia liberata alla nostra favella, per quanto ella fosse capace d’abbracciarla, un ritratto dell’Iliade, seguendo co’ versi sciolti il natural corso di parlare, e conser-vando senza la nausea delle rime la gentilezza dell’armonia» 29.
Trissino aspira a un cultismo d’altro genere rispetto a quello di Bembo, quasi primitivo, non perché popolare (accusa che lui stesso rivol-geva al poema di Ariosto: p. 213), ma perché linguisticamente comune. Trissino nella Poetica (I, p. 25) individua nella mutua comprensione dei parlanti il fondamento dell’unità linguistica: e nel Castellano dimostra che tale unità in Italia si manifesta nella capacità di ordinare razionalmente l’innegabile plurilinguismo attraverso la rimozione dei tratti locali e la me-scolanza di quelli condivisi da più lingue. Con ragione, dunque, nel capi-tolo sull’elocutio Vitale individua due componenti significative nella lingua del poema: «I due estremi che connotano [...] nella perspicuità espressiva e nella moderata presenza di tratti canonici e usuali della lingua poetica, la particolare coloritura linguistica dell’Italia liberata sono il dialettismo e il cultismo latineggiante (e grecizzante)» (p. 66). Ed è chiaro che per
29 Di Vincenzo Gravina giureconsulto Della ragion poetica libri due, in Roma, presso Francesco Gonzaga, 1708, II 17, p. 189.
Su uno studio linguistico dell’«Italia liberata da’ Gotthi»
129
Vitale i tratti sintomatici dell’italianità della lingua di Trissino finiscono per essere i termini di origine dialettale, le «forme migliori e men proprie dei dialetti italiani» (p. 65), segno tangibile che la concreta realizzazione linguistica non può essere limitata a un’area specifica ma dev’essere rela-tiva all’intera comunità dei lettori che usufruiscono degli scritti letterari. Perciò è del tutto giustificato il forte squilibrio, che si osserva sfogliando il libro di Vitale, nell’analisi dei due ingredienti: a latinismi (e grecismi) sono dedicate una ventina di pagine (pp. 67-87), mentre sui dialettismi ci si sofferma per quasi metà dell’intero volume (pp. 87-195).
D’altra parte, per spiegare tale differenza vi sono anche ragioni di metodo: indagando sui dialettalismi usati consapevolmente da un autore nella sua opera, Vitale riprende un percorso di ricerca che aveva già pio-neristicamente inaugurato nel 1992, quando per la Rivista italiana di dia-lettologia aveva compilato un articolo intitolato Il dialetto ingrediente in-tenzionale della poesia non toscana del secondo Quattrocento, un repertorio di tratti locali nella poesia tardoquattrocentesca del Nord e del Sud, fra i quali un ruolo aggregante era riconosciuto ai ventotto elementi comuni antifiorentini. In quel caso la documentazione era massiccia, e alla grande quantità dei dati veniva affidato l’onere di provare la presenza del loca-lismo come frutto della volontarietà di una scelta d’autore e non come effetto di una inadeguata consapevolezza linguistica. Riscontri esterni di diversa natura sono invece possibili nei testi dei primi decenni del Cin-quecento, quando la riflessione sulla storia e l’uso della lingua e la discus-sione pubblica delle relative convinzioni non erano meno rari dei concreti esercizi letterari: e la tendenza a svincolarsi dal fiorentino, seppure per-dente in prospettiva futura, non era né involontaria né isolata, come è stato dimostrato di recente anche per Olimpo da Sassoferrato 30.
E infatti, per spiegare l’importanza del dialettismo nell’Italia liberata, Vitale ricorda anche le ragioni poetiche: «ne lo heroico» la «varietà delle lingue si ricerca» (Poetica, I, p. 28) e le parole «particulari di una lingua [...], se sono belle e tali che si possano intendere facilmente da tutti, si ponno sicuramente usare, siano di che lingua si voglia» (ibid.), purché siano nell’uso e anche se non sono negli autori. Infatti, come si è detto, nel poema epico, «dove intervengono i costumi e le sentenzie, [il poeta]
30 Vd. L. Severi, «Una mia operetta cupidinea». Appunti sul plurilinguismo di Olimpo da Sassoferrato, in Studi linguistici italiani, 33, 2007, pp. 191-258.
Francesco Montuori
130
le dee dire con parole non così ornate et elaborate. Perciò che le troppo splendide et ornate parole (come dice Aristotele) ascondeno i costumi e le sentenzie e non lasciano apparere la lor bellezza, la quale dee per tutto il poema lasciarsi benissimo vedere» (ibid., VI, p. 52). Ciò consente l’accet-tabilità di parole prive di tradizione colta, caratterizzate da una diffusione solo locale e orale, ma che la poesia epica rende ammissibili. Nel suo stu-dio, per esempio, Vitale, documentando una lunga sequenza di dialetta-lismi (pp. 88-97), dà testimonianza anche dell’uso seriale di geosinonimi, come moglie e moglier, o mattarasso e stramazi, che entra come lemma solo nella quarta edizione del Vocabolario della Crusca (pp. 91 e 93).
Non è difficile trovare conferme all’attenta consapevolezza con cui Trissino si muoveva nel campo delle scelte lessicali. In Poetica V, p. 40, si legge che una parola o è «propria» o è «lingua»: è «propria» se il poeta adopera una parola della sua zona d’origine, è «lingua» se il vocabolo si usa in un luogo diverso da quello da cui proviene l’autore. Questo crite-rio è poi applicato per difendere termini danteschi attaccati da Bembo, come il rimante signorso 31, giudicata parola fiorentina e popolare dai clas-sicisti, e quindi da eliminare, ma della quale Trissino riconosceva la sicilia-nità linguistica e rivendicava la continuità storica e la dignità poetica. La teoria della mescolanza non prevale però sulla rimozione dei tratti troppo locali: Trissino prima di altri aveva riconosciuto la geosinonimia di quat-traro ‘ragazzino’ (Dve I 19) con il toscano fanciullo e il veneto fantolin (Poetica V, p. 40); nell’Italia liberata non usa la parola che per lui sarebbe «propria» (fantolin) ma sceglie fanciullo (e derivati), che vanta una più si-gnificativa diffusione, scartando anche il quattraro stigmatizzato da Dante.
Si comprende quindi come mai, opportunamente, nel discorso di Vi-tale resti un po’ sullo sfondo il ruolo del volgare fiorentino. In Trissino la teorizzazione dell’italiano comune esposta nel Castellano è accompa-gnata dalla dimostrazione che la lingua degli auctores (Dante e Petrarca, in particolare) non poteva essere definita fiorentina, perché costituita in gran parte da tratti comuni a più volgari. Nella pratica, però, e anche ne-gli scritti linguistici, il volgare fiorentino ha un ruolo attivo nelle scelte del grammatico, sia quando le sue forme vengono accolte nell’uso o nella norma, sia quando sono respinte come troppo locali. Vitale ha scelto di
31 If. XXIX, 77; vd. anche Poetica, VI, p. 53.
Su uno studio linguistico dell’«Italia liberata da’ Gotthi»
131
esporre i dati del suo spoglio linguistico attraverso una lente a due fuo-chi, per osservare il precipitato del latino e quello dei dialetti veneti, pre-scindendo dalla fiorentinità: però ha disseminato nei vari paragrafi osser-vazioni che tocca al lettore raccogliere (ed eventualmente integrare) per valutare l’atteggiamento di Trissino verso il fiorentino. Qualche volta esso appare attraverso una di quelle forme comuni e consuete che il poeta usa per dare chiarezza al suo dettato: a tale gruppo andranno ascritti i ditton-gamenti di è, ò in sillaba libera. L’effetto di trascinamento del fiorentino è minimizzato da Vitale in nome di una tendenza originata dal sostrato dialettale: ipotesi accettabile per gli scrittori veneti, però improbabile per altri autori portati a riscontro, come i quattrocentisti meridionali, che sa-ranno giunti a quei dittongamenti in posizione non metafonetica per ef-fetto di imitazione toscana. E in questo senso progressivamente fioren-tinizzanti (più che dialettizzanti) appaiono anche le opzioni di Trissino, che in poesia e in prosa, nelle opere stampate nel 1529, dittonga tutte le toniche medio-basse in posizione debole: così al costante cuore per core delle Rime, che, come dice Quondam, ha un «rilievo emblematico asso-luto», si affiancano anche altri esiti meno ovvi, come huomo, sebbene an-cora nel 1524 Trissino scrivesse: «in molti vocaboli mi parto dall’uso fio-rentino e li pronuntio secondo l’uso cortigiano: com’è homo dico, e non huomo [...]» 32. Altre volte l’elemento linguistico fiorentino va messo nel gruppo dei tratti giudicati troppo locali e quindi inaccoglibili in italiano, almeno nella sua varietà epica: tale è il caso dell’anafonesi, con gli esiti non condizionati che sono veramente panitaliani e quindi accolti nel te-sto, con uno spirito che però va quasi sempre diviso tra antifiorentinismo e antilatinismo. Resta ancora da riempire la casella delle forme fiorentine adoperate come cultismi: all’uopo si può richiamare l’apocope vocalica, veramente dominante in tutto il poema, incluse forme come saracin, fedel, orribil ecc., e comunque ben al di là delle influenze del sostrato dialettale indicate da Vitale (p. 119). Ma una puntuale calibratura delle scelte fono-morfologiche di Trissino potrà essere compiuta solo quando sarà disponi-
32 Vd. G.G. Trissino, Rime, a c. di A. Quondam, nota metrica di G. Milan, Vicenza, Neri Pozza, 1981, p. 23; Id., Epistola del Trissino de le lettere nuovamente aggiunte ne la lin-gua italiana, in Trattati sull’ortografia del volgare, 1524-1526, a c. di B. Richardson, Exeter, University of Exeter, 1984, pp. 1-12.
Francesco Montuori
132
bile un maggior numero di dati in diacronia in relazione alla Sofonisba e alle Rime.
Naturalmente il libro di Vitale, tenendo sempre ben visibili sullo sfondo le questioni di largo respiro pur nella minuzia dello spoglio lin-guistico, suscita anche molte curiosità e spunti di ulteriore riflessione. Vi sono, per esempio, differenze di comportamento tra i due diversi stampa-tori del 1547 e del 1548? Vitale, in una lezione tenuta all’Accademia dei Lincei (e qui preannunciata a p. 5) 33, dimostra che alcuni versi anticleri-cali, che appaiono nel sedicesimo libro (quindi nel secondo tomo) solo in un piccolo numero di esemplari, dipendono da emissioni differenti desti-nate a diversi destinatari e mercati. La procedura fu messa in pratica dal collaudato Tolomeo Gianicolo e forse era rischiosa da attuare a Roma; ma allora sorge il desiderio di sapere se fra i due editori non ci sia stata una diversa cura nella composizione del testo dell’Italia liberata. Per alcune caratteristiche sembra di no: entrambi gli stampatori scandiscono i turni di conversazione nei dialoghi e le parti narrative evidenziando i capoversi con sporgenze a sinistra; e in tutti e tre i tomi non si usa più la ⟨e⟩ maiu-scola per rappresentare [e], che ancora appariva nelle prime stampe del 1529, ma neppure occorre indifferentemente ⟨E⟩ (vd. p. 4): sembra che a ⟨E⟩ (che ha il valore di [e]) si opponga ⟨℮⟩ ([e]), come avveniva già in quasi tutte le edizioni del 1529. Tuttavia vi sono anche indizi di compor-tamenti disomogenei tra gli stampatori. L’opposizione di che comparativo contro che relativo o congiunzione, evidenziata già da Castelvecchi, è rap-presentata in modo apparentemente più coerente nel primo tomo rispetto ai secondi due; e del resto già autorevoli studiosi hanno avuto parole di censura per la qualità delle stampe di Tolomeo Gianicolo. Se ne vorrebbe sapere di più, anche perché il sistema ortografico di Trissino, nonostante le critiche dei contemporanei e l’intolleranza dei posteri, fornisce molte informazioni: sia direttamente, sia indirettamente (cioè grazie agli stimoli provocati dalla reazione degli avversari) si finisce con l’avere molte notizie sulla fonetica della lingua cinquentesca, che possono essere utili per vari motivi, anche per valutare la profondità cronologica e la distribuzione
33 Vd. M. Vitale, Gian Giorgio Trissino e una polemica anticuriale (‘Italia liberata da’ Gotthi’ libro XVI: rimozione e conservazione della polemica anticuriale), in «Memorie (Ac-cademia nazionale dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filologiche)», s. IX, a. XXVI, 2010, pp. 663-670.
Su uno studio linguistico dell’«Italia liberata da’ Gotthi»
133
areale di alcune pronunce tuttora diversificate nell’italiano contempora-neo delle varie regioni 34.
D’altra parte anche la sintassi dell’Italia liberata meriterebbe una disa-mina seria e attenta come quella che Vitale ha compiuto nel suo spoglio sul lessico, sulla fonologia e sulla morfologia del poema. E lo dimostrano chiaramente proprio le annotazioni che Vitale ha dedicato alle strutture della frase, all’ordine delle parole e ai fenomeni macrosintattici. Trissino mostra di condividere con altri autori del Cinquecento alcuni aspetti di quella svolta che modernizza la sintassi dell’italiano. Conserva co-strutti come l’infinito con soggetto proprio, reso fortunato dal contatto con il latino e da esso dipendente: Trissino lo usa con abbondanza tra-ducendo il De vulgari eloquentia, sempre in corrispondenza di un accu-sativo e infinito del testo dantesco; non meraviglia, quindi, la scarsità di riscontri nell’Italia liberata, dove Vitale ne documenta la rara ricorrenza (pp. 85-86). Non è solo nella prosa, invece, che Trissino utilizza la dislo-cazione a sinistra e la conseguente ripresa pronominale, o altri costrutti marcati, per mantenere la linearità della distribuzione delle informazioni senza ricorrere a inversioni, anacoluti, costrutti passivi. E ancora, Tris-sino mostra anche di tendere verso soluzioni moderne in alcune strutture macrosintattiche, distinguendo, in modo meno vago rispetto al passato, e in modo diverso rispetto alla «coazione all’ornatus» di Bembo 35, il con-fine fra la subordinata prolettica e la principale: nell’italiano antico po-teva mancare un discrimine netto ed esservi un trapasso graduale e sfu-mato tra le frasi, mentre altre volte l’inizio della frase principale poteva essere marcato lessicalmente con il sì preverbale, con un procedimento, arcaico, molto diffuso in certa prosa toscana trecentesca 36, ancora usato da Bembo («Il che aviene perciò che, quantunque di trecento anni e più
34 Vd. M. Barbato, Pronuncia napoletana e pronuncia fiorentina, in La variazione nell’italiano e nella sua storia. Varietà e varianti linguistiche e testuali. Atti dell’XI Con-gresso SILFI, Napoli, 5-7 ottobre 2010, a c. di P. Bianchi et al., 2 voll. Firenze, Cesati, 2012, I, pp. 53-64. Una redazione più ampia del lavoro è ora in «Bollettino Linguistico Campano», 19-20, 2011, pp. 1-29.
35 Vd. P. Zublena, Coazione all’ornatus. La sintassi del periodo nelle Prose della vol-gar lingua, in ‘Prose della volgar lingua’ di Pietro Bembo. Atti del Convegno di Gargnano del Garda, 4-7 ottobre 2000, a c. di S. Morgana, M. Piotti e M. Prada, Milano, Cisalpino, 2000, pp. 335-371.
36 Vd. C. De Caprio, Paraipotassi e “sì” di ripresa. Bilancio degli studi e percorsi di ri-cerca (1929-2010), in «Lingua e Stile», XLV, 2010, pp. 285-327.
Francesco Montuori
134
per adietro infino a questo tempo, e in verso e in prosa, molte cose siano state in questa lingua scritte da molti scrittori, sì non si vede ancora chi delle leggi e regole dello scrivere abbia scritto bastevolmente», I 1), oltre che imitato da Leopardi nel produrre i suoi falsi trecenteschi 37. A parte casi cristallizzati, come le risposte nei dialoghi del Castellano («Non sa-pete voi [...]?» – «Sì so» ecc.), e che non si ritrovano nel poema, Trissino non sembra utilizzare mai il sì; però, pur di perseguire l’obiettivo di una razionalizzazione del discorso, è sempre molto attento a segnare lessical-mente il confine fra subordinata e principale, anche a costo di apparire ridondante. Ciò è evidente in modo speciale nella traduzione del De vul-gari eloquentia, sia perché non sono rari i casi in cui l’introduttore della principale è nel testo italiano ma manca in quello latino, sia perché il trat-tato dantesco si predispone bene, per sua stessa natura, a una sintassi che esponga quanto più analiticamente possibile le argomentazioni.
È un comportamento del tutto coerente con quanto Trissino diceva in altre sedi per contrastare quelle tendenze tutte cancelleresche, eredi-tate dalla scrittura cortigiana, allo schiacciamento dei piani sintattici, sia nell’ipotassi sia nelle strutture correlative. Avverso alla semplice giustap-posizione, quindi, Trissino raccomandava all’Equicola, che gli inviava il manoscritto del Libro de natura de amore per una correzione linguistica, uno stile meno soluto: «Ben dirovi alcune cose generali: l’una de le quali è ch’io desidererei che ’1 stile vostro fusse manco soluto che ’1 non è, cioè havesse più congiontioni, il che vedrete in quel principio ch’io ho racconcio essere stato per me considerato, perciò che v’ho aggiunte molte congiontioni». Sarà proprio questa sensibilità a una disposizione razionale degli elementi del discorso, promossa anche dall’imitazione della lingua greca, a dare quell’impressione di facile leggibilità dell’Italia liberata di cui si diceva all’inizio. E si spera che la sensibilità mostrata da Vitale nello scegliere un tale oggetto di studio e la limpidezza del profilo linguistico ricostruito possano contribuire a rimettere in circolazione un reperto ri-mosso dalla nostra storia.
37 Vd. S. Covino, Giacomo e Monaldo Leopardi falsari trecenteschi. Contraffazione dell’antico, cultura e storia linguistica nell’Ottocento italiano, 2 voll. Firenze, Olschki, 2009, II, p. 70.