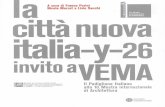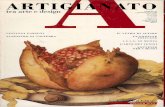Il multiversum del mondo: segno, grafia, scrittura e architettura
Transcript of Il multiversum del mondo: segno, grafia, scrittura e architettura
IN DICE
Presentazione
Maria Antonella Fusco
Architettura Incisa Sandra Suatoni
Ritorno al futuro Alessandro Anse/mi
Una scrittura misteriosa. Brevi note su un laboratorio di incisione Franco Purini
Il multiversum del mondo: segno, grafia, scrittura e architettura Francesco Moschini
Aquaforcis Gianfranco Neri
Dalla cornice alla città Roberto de Rubertis
Incidere l'architettura Livio Sacchi
Dall'Architettura disegnata all'Architettura incisa 1979-2009 Pasquale Ninì Santoro
Architetti incisori Guido Strazza
ARCH IT ETTURA INCISA Tavole
ARC HITETTI INC ISORI Relazioni
Biografie
Bibliografia
7
8
16
18
24
30
34
40
42
45
99
n9
123
FRANCESCO M OSCHINI
Il multiversum del mondo: segno, grafia, scrittura e architettura
Mi piace immaginare che come avvio di questo la
boratorio grafico, sia agli architetti di chiara fama,
sia ai giovani allievi che si accingevano ad elabora
re su una lastra di rame, secondo le tecniche, gli stru
menti e le matrici più tradizionali, un'autonoma ri
flessione sullo spazio e non solo, sia stato loro mo
strato il prezioso dittico piranesiano dedicato alla "Ca
duca di Fetonte", custodito presso lo stesso Iscicuco
Nazionale per la Grafica-Calcografia, nella sua de
licatezza, preziosità, opulenza di segno e nella sua ra
rità per essere stato cosl poco "avvicinabile" e "visi
bile" nel corso degli anni, proprio perché in quel
l'opera apicale di G . B. Piranesi si insinua e si inscena,
più che in ogni altra, l'idea della magnificenza come
risultato della molteplicità quasi ad indicare la
straordinarietà del "mulciversum" del mondo.
Un'opera quella d i Piranesi che si colloca in un raro
equilibrio, lontana dalla drammaticità delle Carce
ri e dalla loro irrappresencabilicà, era nostalgia e man
canza assoluta di speranza, se non vera e propria malinconia.
Nmeno a questo sorprendente equilibrio sembra
no soccoscare gli esiti degli elaboraci di cucci gli au
tori coinvolti: dal librarsi aereo delle iperboloidi, se
non lamine plastiche di Nessandro Anselmi, alle pre
cipitazione stratigrafiche di Valerio Palmieri di una
natura che si fa corpo; dalla dimensione geometri
ca e volumetrica con cui è descritta l'astratta com
posizione a barre di Franco Purini in cui le archi
tetture, in una sorca di sciacciaco donacelliano, sono
compresse su una superficie scandita da "emergen
ze" e "dissonanze", alla scomposizione e deformazione
dei piani di Massimiliano Fuksas condotti verso una
dimensione leggera e aleatoria coerente con una sma-
cerializzazione ideologica, alla totalizzante resa, on
nicomprensiva anche nel caglio d'immagine, d i quel
naturalismo ficomorfico, stemperato in una vera e
propria "compenetrazione irridescente", memore de
gli intrecci borrominiani e degli intarsi di Giacomo
Balla, in cui crova rifugio e appaesamento "Il lecco
di Ulisse" di Paolo Portoghesi, fino alla ritrovata ar
monia del fronte disseminato del teatro di Avellino,
inciso da Carlo Aymonino, che pare ricucire que
gli elementi disarticolaci nella compostezza fugge
vole delle figure di Atalanta e Ippomene; cosl come
accade in quelle degli allievi pit1 direttamente lega
ti a Franco Purini e ad Alessandro Anselmi. Nei pri
mi si ritrova una coerenza sviluppata attorno ai temi
della composizione spaziale delle figure piane e tri
dimensionali: insieme a questa forma di analisi si ri
scontra la capacità di ricercare le valenze luminose
delle forme in grado di riflettere contemporanea
mente una profondità e superficialità degli elementi.
Nei secondi, sembra, al contrario, evidente il rap
porto con un carattere p iù impressionistico del se
gno; la componente geometrica e informale si sin
tetizza in una ambivalenza spaziale governata da una
costante capacità di esaltazione tecnica del disegno.
In tutte le opere presentate prepotente sembra im
porsi il senso dell' infinito, una ricercata incertezza
se non ambiguità dimensionale tra misura e dismi
sura, era eccessivamente ridotto ed esasperatamen
te ingigantito e in tutte pare aleggiare la censione
vibrazione degli elementi, delle figure, dei corpi nel
la rarefatta atmosfera. Anche il frequente ricorso al
l'isolamento delle varie parei, pur se collocare in for
zaci tentativi di ricomposizione, alludono ad un loro
disporsi secondo un sistema paratattico, secondo una
ARCHITETIURA INCISA ARCHITETIURA INCISA ARCHITETIURA INCISA ARCHITETIURA INCISA ARCHITETIURA INCISA ARCHI
TETIURA INCISA ARCHITETIURA INCISA ARCHITETIURA INCISA ARCHITETIURA INCISA ARCHITETIURA INCISA ARCHJTETIURA
25
poetica dell'elenco e sicuramente attorno a plurimi
sistemi di attrazione gravitazionale. Tra frammen
tarietà e ricomposizione sembrano riconducibili tut
ti gli esiti di questo certamen che sembra piranesia
namente suggerire che solo attraverso un'opera di di
sintegrazione possa esserci una possibile rigenerazione.
Questa occasione progettuale ed espositiva promossa
dall'Istituto Nazionale per la Grafica sembra quin
di ricercare una sorta di continuità con quanto si è
andato sperimentando a partire dagli anni Settan
ta, almeno in Italia, da parte degli architetti più at
tenti, che nella tecnica dell'incisione si sono cimentati
come momento di riflessione teorica in cui la len
tezza dei tempi di elaborazione li portava a tramu
tare quel loro lavoro non tanto in termini di resti
tuzione di immagini accattivanti, quanto in una sor
ca di medicazione sulla magia e la bellezza dell' im
prevedibile dopo le mediazioni delle morsure.
Il decennio 1970-80, infatti, ha visto nel mondo del-
1' architetcura e in particolare era gli architetti italiani
la ripresa di una tecnica come quella dell'incisione
che era andata ormai scomparendo. Ma anziché sul
versante della riproduzione dell'immagine, così
come si era andata caratterizzando l'incisione di ar
chitettura nell'800, l'assunzione di questa tecnica ha
puntato sulla ricerca di una autonomia di proget
to, così come il disegno di architettura in questi anni
ha cercato una propria collocazione nella dialettica
era realtà e visionarietà. Il riferimento più diretto
quindi per gli architetti che in questi anni hanno la
vorato all'incisione è cerco Piranesi: ma anziché al
Piranesi piì.1 visionario delle carceri e dei capricci il riferimento va a quello più di mestiere rintracciabile
nelle vedute o nelle ossessive analisi della "forma ur
bis" vagheggiata più che reale. La stessa aspirazione
al progetto insita nelle tavole del Campo Marzio pi
ranesiano, ognuna delle quali è costruita come ve
rifica e nello stesso tempo messa in crisi di ogni pre
sunta unità spaziale, diventa nel decennio '70/'80
l'idea di un solo e unico grande frammento come
risultato finale. Questo è paradossalmente l'elemento
unificatore delle tavole incise dagli architetti in que
sti anni.
Tra i tempi lunghi del progetto architettonico e quel
li più brevi del disegno si colloca l'esperienza del
l'incisione che, a partire dall'ultimo scorcio della se
conda metà del Novecento, ha visco protagonisti ar
chitetti come: Carlo Aymonino, Alessandro Ansel-
mi (G.R.A.U.), Arduino Cantafora, Costantino Dar
di, Paola D'Ercole (Studio Labirinto), Vittorio De
Feo, Massimiliano Fuksas, Paolo Martellotti (Stu
dio Labirinto), Bruno Minardi, Dario Passi, Fran
co Pierluisi (G.R.A. U.), Attilio Pizzigoni, Paolo Por
toghesi, Franz Prati, Franco Purini, Ltrca Scacchet
ti, Massimo Scolari, Ettore Sottsass e Aldo Rossi.
I tempi rallentati della tecnica incisoria, se hanno di
luito il «valore terapeutico di un'autoanalisi e il sen
so di una trasgressione salutare dallo specifico» che
si affidava al disegno più immediato, hanno tutta
via permesso un continuo ritorno alla grafia incisa
su lastra in modo tale che quello «specchiarsi, mi
surarsi e sdoppiarsi» che si attuava nei disegni più
minuti, in cui si accumulavano classificazioni di ma
teriali piì.1 diversi, è diventata un'operazione così con
trollata da risultare un rigoroso progetto mentale che
nulla ha concesso alla memoria più involontaria.
Le incisioni da un lato racchiudono un'intenziona
lità progettuale attraverso la sperimentazione di spa
zialità e superfici come assunto più propriamente pro
gettuale, dall'altro evidenziano gli elementi di un «rac
conto» e di una «scoria» a cui questi autori sono ri
corsi rielaborando i materiali dell'architettura, da
quelli più personali della propria biografia a quelli
più consueti e mitologici della tradizione dell'ar
chitettura antica e moderna. Ma non si tratta di «due
vie» che procedono in modo separato, stabilendo una
cesura tra un fatto privato, di «libero arbitrio» e quel
lo più vincolante dell'occasione progettuale, ma piut
tosto si sottopongono ad un paziente lavoro di li
matura, d i smussatura di ridondanze, sino ad una
sorca di asettica astrazione in cui, immerse con una
evidente ambiguità, non siano più scindibili tra loro.
Così come diventa inscindibile l'ambivalente diffe
renza tra il luogo che «si spazia e si dissemina» e il
tempo che «si scandisce, s'interrompe» . D ifferenza
teorizzata da Jacques Derrida e definita da Blanchot
come «gioco del tempo e dello spazio», gioco si
lenzioso dei rapporti: lo «sprigionamento multiplo»
governato dalla scrittura. In questa d iscontinuità, si
attua il confronto tra l'amor vacui d i quella estrema
semplificazione formale, che spesso caratterizza i pro
getti grafici e l'ingombrante presenza da ready made di vere e proprie fissazioni architettoniche. [al
lusione al «doppio sogno» di Schniczler e ad i suoi
impossibili ritorni, dove ciò che al massimo si può
evocare è il «cadavere pallido della notte passata, de-
ARCHITETIURA INCISA ARCHITETIURA INCISA ARCHITETIURA INCISA ARCHITETIURA INCISA ARCHITETIURA INCISA ARCHI
TETIURA INCISA ARCHITETTURA INCISA ARCHITETIURA INCISA ARCHITETIURA INCISA ARCHITETTURA INCISA ARCHITETIURA
scinaco irrevocabilmente alla decomposizione», for
nisce la chiave incerprecaciva.
Altre vie si contrappongono legandosi al tema del
la coincidentia oppositorum. Se alla compattezza si op
pone la frammentarietà, allo stesso modo allo smi
suratamente grande si contrappone lo smisurata
mente piccolo, alla carica ascensionale la precipita
zione a terra, al la lettura in primo piano quella in
affondo, alla chiarezza dell'immagine, il piacere del
l'inganno visivo, infine all'integrità del racconto che
sembra procedere con una logica consequenziale, il
gusto di un pensiero più frammentario, di un pen
siero «vagabondo», errante, che il bricolage degli ele
menti sospesi era reale collocazione e continuo spiaz
zamento sembra accentuare. Ma il discontinuo, l'in
terruzione e la dispersione presentaci contempora
neamente al continuo, alla pienezza ed all'aggrega
zione dicano la loro lontananza da quello spezzet
tamento, da quella spaccatura in cui «il divenire si
scopre in rapporto con il discontinuo e quasi come
suo gioco». E quello che si avverte è allora lo sfor
zo dell'acro poetico, di portare insieme e di condurre
il tutto all'unità per il timore della parola unica, so
litaria e frammentata.
Molti disegni si snodano sul filo di un'esibica con
trapposizione era polarità opposte sia sul piano del
l'immagine, sia su quella della struttura narrativa. Ed
è proprio qui che si confrontano il crudo realismo
con il livello mitico del racconto, con il suo spiaz
zamento continuo di luoghi ed oggetti carichi di se
dimentazioni storiche, ridotte ad una inconsueta fa
migliarità, anch'esse in bilico era affettuosa quoti
dianità e irritante banalità. Allo stesso modo, l'ap
parato visivo, viene esibito nella sua contrapposizione
che non è solo di quei grandi vuoti abbacinaci o di
quelle cupe profondità in cui l'occhio intrigante si
insinua, a cercare chissà quali segreti. Assistiamo così
ad un compiaciuto contrapporsi di spazialità aper
te con altre pit1 intime e quasi indecenti. La razio
nalità d'impianto dell' incero sistema viene fatta scon
trare con distorsioni e stravolgimenti che, esibiti come
enigma, creano un clima di incertezza, di instabili
tà, nell'impossibilità di suggerire qualsiasi soluzio
ne. Così come i modi della rappresentazione, nel loro
succedersi pacato facto di vedute frontali e zenitali
subiscono continue sollecitazioni pur nella loro ele
mentarità, con il ricorso a fughe prospettiche slic
cace, ad ombre innaturalmente proiettare, con una
sorca infine di slittamento semantico che toglie al
l'intero ciclo l'apparente e rassicurante ovvietà per
collocarlo in un clima inquietante di riappacifica
zione solo apparente.
Laddove scompare ogni forma di schematismo, fi
nalizzata ad una intenzionalità progettuale che
spesso si sofferma in una continua verifica della pro
pria verità di assunto, l' immagine rende a farsi as
soluta nella propria perentorietà. In questa viene al
lora «aiutata» da una bicuminosicà del fondo che nel
suo vellutato rapprendersi si dà come spalancamento
su un vuoto abissale da cui l' immagine fuoriesce qua
si respinta, quasi come dall'addensarsi di coni
smorzaci, pur densi ma pieni di cangiantism i che trat
tengono la luce fino a corroderla ed a restituirla, or
mai rappresa, raggelata, sospesa in un instabile equi
librio era una luminosità negata ed una illuminazione
improvvisa, craccenuca appena dall'impenetrabilità
dei luoghi descritti.
[osservazione analitica e scientifica mescolata con
le sensazioni di ogni tipo, più immediate, con una
memoria scorica collecciva e pur così intima e pri
vata, fanno brulicare quel mondo non solo negli at
timi di ascolto di quella liquidità celata. Una socci
le malinconia che permea ogni cosa a ridare unità
ai frammenti. Quella stessa malinconia dureriana esi
bita però attraverso i simboli di un colto esoterismo.
Si possono allora rintracciare cucce le fasi alchemi
che, in un succedersi lento ma inequivocabile dei di
versi stadi dell' incisione: ciò che manca però è la tra
smutazione finale, che suonerebbe però enfaticamente
come spiraglio su un futuro possibile e migliore.
I tempi stessi di elaborazione, in taluni casi sembrano
riassorbici in una contenuta sequenza che accencua
quel senso di compattezza che, la libera grafia, il ri
corso all'immagine immediata, pur nella sua com
plessità, rendono ancor pit1 evidente, nonostante la
discontinuità di un lavoro come quello dell'incisione,
fatto di passaggi obbligaci, dalla preparazione della
lastra, all'incisione sulla stessa del segno, alle successive
morsure nell'acido, all'inchioscracura quindi, sino alla
scampa fìnale con il corchio, dove, solo dopo aver
sollevato il feltro, affioreranno gli inevitabili e im
previsti arricchimenti del segno cracciaco. Ed è pro
prio la serrata sequenza visiva, nella didatticità del
l'immagine, a conferire una scruccura narrativa ad un
discorso che sembra reggersi, nella versione più pro
gettuale destinata a confluire nelle tavole dipinte, sul-
la frantumazione, sullo sconvolgimento di ogni or
dine apparente, infìne, sulla messa a fuoco di
aspecci particolari.
Il segno si declina in una gamma di variazioni che
vanno da una pastosa corposità, ottenuta come stra
ti fìcazione recicolare, al naturalistico se non im
pressionistico sfilacciamento dello stesso segno at
traverso una mediazione continua. Questa, si arcua
attraverso una vera e propria progressione che va dal . . . .
segno-coscruz1one 111 senso macenco a geomecnco,
al segno-linea; dalla traccia schematica di un'ordi
tura incisa come base di riferimento, al segno-gra
fìa, elemento di caratterizzazione e differenziazione
dei diversi partiti architettonici, infìne al scgno
ombra che, più dell'informe stesura all 'acquatinta,
conferisce una tenebrosa matericità. Ed é ancora il
segno nella sua esilità, in questo caso esasperata, a
inserirsi come elemento di decoro, quasi a ricondurre
ad una dimestichezza, altrimenti difficile a definir
si, quei luoghi, così segnaci dal rigore dell'elimina
zione di ogni ridondanza.
Gli architetti hanno puntato su un contrasto per dis
sonanza era i piani in estensione, occenuci con un la
voro a strati, per successive morsure ali' acquatinta,
e il chiaro segno strutturan te, costitutivo d'imma
gine, all'acquaforte. Questa permette di tracciare
un' immagine concisa e pregnante che rivela imme
diatamente il proprio carattere e la propria qualità.
All'immediatezza del segno, all'acquaforte si con
trappone cosl il ritmo estenuante dell'acquatinta, di
cui solo alla fìne ci si può rendere conto; esiste quin
di un largo margine di impreved ibilità, che tuttavia
nulla ha di casuale e dà al paziente lavoro di elabo
razione uno stato di incertezza per la difficoltà di con
trollare, momento per momento: la riuscita di un
segno, di un gesto, o per la impossibilità di rivede
re una scelta. Dalla preparazione bituminosa della
lastra, con la sapiente scelta degli attimi di precipi
tazione della polvere per far depositare, secondo le diverse esigenze, pulviscolo di dimensioni diverse,
che solo un lavoro di tipo artigianale può permet
tere, alla copertura delle zone della lastra da man
tenere meno incise, da preservare cioè dall'acido e
via via ai successivi bagni della lastra nell'acido, alle
rapide asciugature, agli ulteriori interventi dell'ar
tista per arrestare la corrosione da una parte ed ac
centuarla in altre zone, l'artista si trova in un con
tinuo staro di sospensione, di accesa del risultato fì
nale che si dà come simultanea conclusione di un
lavoro su tutti i fronti. Quando alla fine il torchio
preme sulla carta inumidita, togliere il panno di fel
tro che protegge la lastra di mecallo ed il foglio dal
rorchio, è come cogliere il velo di Maya: l'incisione
sollevata come una conquista si dà come rivelazio
ne compiuta, nella sua intoccabile completezza, sen
za possibilità di ripensamenti, o ulteriori interven
ti e correzioni: o l'accettazione completa del risul
tato o il ripudio.
Il filamento allora che pervade il campo visivo, vol
ta a volta, traccia, legamento, gesto i nterrorto,
spezzato, frantumato, o soltanto mosso, così come
il segno, colpo preciso di bulino, traiettoria, pulvi
scolo attratto da imperscrutabili campi magnetici,
segno-mandala che si ispessisce, si rarefa, s'aggrovi
glia sino a farsi brulichio hodleriano, parlano della
loro vocazione alla costimzione d'immagine più che
della loro figuratività. E se il loro violento proiettarsi
oltre pare rovesciare in avanti, con irruenza, la stes
sa smisurata interiorità, é solo per esplicitare l'arti
ficialità della loro costruzione, per cogliere il velo a
quella loro suadente ed ambigua naturalità. È pro
prio lo spazio pittorico scompaginato a denuncia
re così, con il massimo di finzione pittorica, con l'as
senza assoluta di ogni intima costruttività, reso cioè
come disossato, l'inganno visivo, ed a ricondurre nel
puro valore di smaliziata costruzione mentale l'ac
cattivante bellezza di ogni ormai improbabile lavo
ro proiettato cosl en plein air che non si dia come
intricato percorso era labirinti della ragione e de
terminazioni emozionali.