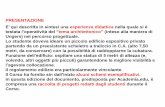Conformazioni. La ricerca attraverso il progetto di architettura.
-
Upload
uniromatre -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Conformazioni. La ricerca attraverso il progetto di architettura.
L’azione del conformare rimanda al significato del conferire forma a qualcosa ponendo particola-re attenzione agli elementi che entrano in gioco e alle reciproche relazioni.Nella costruzione di un luogo l’atto del conformare si traduce nel far corrispondere, nell’adattare una forma ad un sito, attività che richiede una imprescindibile conoscenza topografica attraver-so la quale far emergere dal palinsesto del territorio figure già espresse o segni interrotti.Il progetto di architettura inteso come esercizio conformativo acquisisce una valenza conosciti-va traducendosi in strumento ricognitivo e interpretativo dei territori antropizzati. Secondo tale approccio, la pratica del progetto costituisce una possibile modalità di fare ricerca in architettu-ra e il risultato raggiunto, espresso in forma disegnata o realizzata, si offre come ulteriore mate-ria di indagine su cui soffermare l’attenzione, sollevando sempre nuovi spunti di riflessione.
conformazioni
luigi coccia
luigi coccia conformazioni la ricerca attraverso il progetto di architettura
t ,
www.gangemieditore.it
DISTRIBUZIONE ITALIA - ESTEROVERSIONE DIGITALE EBOOK /APP:
Coccia copertina 13/11/12 09.51 Pagina 1
impaginazione e ideazione graficaLuigi CocciaAlessandro Gabbianelli
elaborazioni graficheLuigi CocciaAlessandro Gabbianelli
in copertinaLuigi Coccia, studio per la sistemazionedel lungofiume di Pescara, 2003(rielaborazione grafica)
©Proprietà letteraria riservata
Gangemi Editore spaPiazza San Pantaleo 4, Romawww.gangemied i to re . i t
Nessuna parte di questapubblicazione può esserememorizzata, fotocopiata ocomunque riprodotta senzale dovute autorizzazioni.
Le nostre edizioni sono disponibiliin Italia e all'estero anche inversione ebook.
Our publications, both as bookand ebooks, are available in Italyand abroad.
ISBN 978-88-492-2497-9
www.gangemieditore.it
Finito di stampare nel mese di settembre 2012
SPA – ROMA
COCCIA-colophon-libro27F.indd 2 13/11/12 09.49
a cura di Alessandro Gabbianelli
conformazionila ricerca attraverso il progetto di architettura
luigi coccia
COCCIA-colophon-libro27F.indd 3 13/11/12 09.49
129
Pianta e foto dell’allestimento al secondo livello.Sezione della cartiera papalecon l’individuazione dei tre livelli di allestimento, foto dell’allestimento al primo livello.
130
Allestimento della mostra “Borghi Alti di Mare”Ascoli Piceno, 2008
I tre livelli della Cartiera Papale di Ascoli Piceno ospitano contempora-neamente tre mostre che si propon-gono di fornire nuovi orientamenti alla interpretazione dei Borghi Alti di Mare nell’attuale condizione metropolitana adriatica.Opere fotografiche, mappe, disegni e modelli raccontano le trasformazioni del paesaggio costiero adriatico ed offrono spunti per una riflessione sul rapporto tra conservazione e trasfor-
mazione, sul ruolo delle preesistenze e sulle modalità di intervento nelle aree storicamente sensibili.La prima mostra descrive le condizio-ni del paesaggio costiero adriatico at-traverso i lavori fotografici condotti da Eriberto Guidi e Peppe Maisto. La seconda mostra è incentrata sulla ricognizione dei centri collinari lungo la costa adriatica: 14 profili di acciaio sagomati, sospesi sull’Adriatico tran-sfrontaliero, e una collezione di “re-
perti” fotografati da Daniele Maurizi fissano il sistema italiano dei borghi alti di mare e idealmente indirizzano lo sguardo verso altrettanti borghi sul-la costa croata. La terza mostra apre una finestra sull’Europa: 14 interven-ti in ambito europeo sono presentati attraverso una installazione di “grand lumière”, inconsueti espositori sospe-si che descrivono criticamente alcune opere architettoniche realizzate in borghi antichi d’Europa.
133
Foto dell’allestimento dedicato alla ricognizione fotografica e ai borghi alti nel territorio europeo.
138
Progetto di riconversione di Villa DelficoMontesilvano, 2009
La scelta fondamentale che ha indiriz-zato l’intervento è stata quella di con-siderare il corpo della villa esistente come unico oggetto emergente dal sito e di lavorare al nuovo ampliamen-to attraverso operazioni di manipola-zione del suolo. Il progetto si propone di sperimentare una strategia che sia in grado di mettere a sistema le tre ri-chieste del programma (restauro del-la palazzina esistente, sistemazione delle aree verdi, nuovo centro cultu-rale), di cui si prevede una attuazione in tempi diversi. A questo proposito si sono prefigurati due dispositivi formali estesi a tutta l’area.1° dispositivo: topografia. A partire dai condizionamenti altimetrici del sito, il progetto cerca di definire in sezione una nuova linea di terra, estesa ad una fascia di suolo che viene ma-nipolata prendendo a riferimento la misura della villa e la scansione dei suoi spazi interni. Questo nuovo suolo artificiale si manifesta sotto forma di “zolle”: alcune di esse risolvono il di-
slivello tra le diverse parti del proget-to, costituendo delle soglie di passag-gio tra i vari ambiti; altre, sotto forma di parterre verdi o di masse compatte di vegetazione, disegnano il giardino; altre ancora si trasformano in piatta-forme predisposte ad ospitare i nuovi servizi del centro culturale. 2° dispositivo: interferenze. Le esi-genze di collegamento tra le stanze di verde introduce il tema della mi-croconnessione: un sistema di cam-minamenti trasversali alle fasce in-terferisce con il disegno del parterre, spingendosi anche all’interno della villa tramite l’intromissione di elementi parassitari, cromaticamente ricono-scibili, che introducono un segno di contemporaneità nell’edificio restau-rato. Nella zona di ampliamento del nuovo centro culturale, gli elementi di connessione sono piccoli ponti di at-traversamento delle piattaforme che lasciano tracce anche sulla copertu-ra, dove si traducono in piccoli patii di illuminazione per gli spazi interni.
139
Foto della Villa Delfico.Planimetria generale di progetto, pianta dell’attacco a terra e sezione longitudinale.
146
Progetto di ricostruzione del borgo e della nuova chiesaTempera, 2009-2011
La ricostruzione dei luoghi dell’aqui-lano colpiti dal terremoto pone alcuni interrogativi incentrati sul come in-terpretare le rovine generate dal si-sma, sul come affrontare il rapporto tra vecchio e nuovo, in definitiva sul come intervenire nel progetto di rico-struzione.La sperimentazione progettuale con-dotta sulla frazione di Tempera si pro-pone di tracciare una metodologia di intervento. Il progetto si fonda su una lettura topografica, risalendo attraver-so di essa allo studio della costruzione storica del luogo. Come in molti centri appenninici, le ragioni della forma del piccolo centro di Tempera sono ricon-ducibili a due elementi, uno naturale e l’altro artificiale. Il primo rimanda alla geografia del sito, alla sua conforma-zione orografica ; il secondo rimanda all’antropizzazione del territorio che si manifesta nella divisione ed uso del suolo. Tali elementi possono costitui-re il supporto principale nell’opera di ricostruzione dei luoghi distrutti dal
sisma.La proposta progettuale, inserita in un piano di ricostruzione esteso all’intero borgo, è incentrata su due aggrega-ti residenziali e sulla chiesa dedicata alla Madonna del Rosario. La tessitu-ra agricola, confermata dalle giaciture delle costruzioni originarie, è stata as-sunta come traccia di riferimento nel-la riconfigurazione architettonica del luogo. Le trame murarie delle vecchie case sono state conservate nell’attac-co a terra dei nuovi fabbricati residen-ziali che, salendo in altezza, subisco-no una progressiva razionalizzazione formale. I resti delle antiche murature permangono nella cripta della nuova chiesa che ricalca l’ingombro plani-metrico della vecchia riaffermando una posizione dominante rispetto al borgo. La canonica, originariamen-te affiancata alla chiesa, viene spo-stata più a valle, nel corpo di testata dell’oratorio che delimita uno spazio pubblico all’aperto, nuovo luogo d’in-contro del borgo ricostruito.
147
Foto del sito della chiesa dopo il sisma.Schema interpretativo dell’area di progettoe planivolumetrico generale.
167
«La divisione del continuo non deve essere considerata come quella della sab-bia in granelli, ma come quella di un foglio di carta o di una tunica in pieghe, di modo che si possa formare un’infinità di pieghe, le une più piccole delle altre, senza che il corpo si dissolva mai in punti o in minima.»1
L’opera progettuale di Luigi Coccia costituisce l’esito di una ricerca ventennale e investe sia la scala territoriale che quella domestica; tuttavia non è difficile ritrovare alcuni temi d’indagine ricorrenti, uno dei quali è il tema della continuità. Analizzando il lavoro qui raccolto si è coscienti che il concetto di continuità può essere declinato in diversi modi ed acquisire molteplici significati.In primo luogo la continuità topografica. Distaccandosi dall’eredità lasciata dal Movimento Moderno che assume il suolo come entità fisica autonoma rispetto agli edifici che lo occupano, l’atto progettuale prende le mosse da una lettu-ra critica del territorio andando a riscoprire attraverso uno sguardo analitico i segni delle stratificazioni che si sono succedute all’interno dell’area con la consapevolezza che «il suolo urbano come piano astratto e infinito bene co-mune indivisibile, pienamente disponibile a qualsiasi forma d’intervento è pura utopia»2. Questa indagine viene condotta con occhio attento, in modo capillare e analitico: «la ricerca di indizi si esplica con maggiore attenzione laddove i segni sono meno evidenti, dove è più difficile scorgere tracce di qualsivoglia disegno preordinato»3. La volontà non è quella di trasformare il sito in una tabula rasa per poi calare l’oggetto architettonico in maniera indifferente, ma piuttosto è quella di cercare una continuità con le tracce del luogo, testimonianze di una vita precedente. La parola continuità deve essere intesa, in questo caso, nella sua accezione letterale di «tenere assieme» (cum tenere). Il progetto ingloba, elabora e rilegge la stratigrafia del sito che diventa matrice della nuova confor-
1 G. W. Leibniz, Pacidius Philalethi, in G. Delauze, La piega. Leibniz e il Barocco, Einaudi, Torino, 2004, p. 10
2 L. Coccia, L’architettura del suolo, Alinea Editrice, Firenze, 2005, p. 19
3 L. Coccia, Op. Cit., p. 16
168
mazione architettonica. Questa strategia caratterizza la quasi totalità dei pro-getti a grande scala ed è esplicitata in modo estremamente chiaro nel progetto di sistemazione dell’Arco Occidentale a Salonicco, dove la trama dei tracciati urbani si relaziona con gli edifici esistenti e organizza la nuova edificazione e le aree verdi, oppure nei progetti per i complessi scolastici di Giulianova e di Sarno, dove la tessitura dei campi agricoli definisce il posizionamento dei nuovi edifici stabilendo un nuovo dialogo tra territorio agricolo e urbano.In secondo luogo si può parlare di continuità architettonica. Attraverso l’azio-ne del piegare4, muri, rampe, nastri, ricalcando la topografia del sito, si fanno elementi strutturanti l’architettura in due modi differenti: costruendo il recinto, l’involucro dell’edificio oppure diventando elemento d’intrusione nell’edificio per strutturarne lo spazio interno. Nel teatro all’aperto di Maracalagonis il suolo si sfalda, si piega, si solleva trasformandosi in copertura per la discoteca mentre al di sopra vengono posizionate le sedute del teatro. Negli edifici residenziali in viale Primo Vere il nastro è una superficie esterna che si sviluppa parallelamen-te alle facciate laterali dell’edificio, dal basso all’alto, fino a diventare copertura. L’elemento architettonico questa volta costituisce una sorta di facciata masche-ra, di elemento filtro tra spazio pubblico e spazio privato rimarcando la distanza tra strada e superficie muraria. In questo primo caso «la piega non soltanto concerne ogni materia, che diventa così materia d’espressione, secondo sca-le, velocità e vettori differenti (montagna e acqua, carta, stoffa, tessuti viventi, cervello), ma determina e fa apparire la Forma, ne fa una forma d’espressione, Gestaltung, elemento genetico...»5. Differente è il ruolo dei percorsi nel progetto di riconversione alla Casa Turà: essi si insinuano nell’edificio esistente dove ripiegandosi generano spazialità insolite e garantiscono i collegamenti interni. La questione si fa ancora più complessa in quello che si potrebbe considerare
4 Piegare é «la prima azione compositiva capace di dar luogo a uno spazio [...]. “Piegare” significa usare l’immensa energia che si annuncia nello spazio - o che si svela come spazio originario - perché dia luogo ad un “abitare”.» Vedi F. Purini, Una lezione sul disegno, Gangemi Editore, Roma, 1996, p. 60
5 G. Delauze, La piega. Leibniz e il Barocco, Einaudi, Torino, 2004, p. 58
ALESSANDRO GABBIANELLI
169
il progetto più maturo: la «Città della Musica» a Pescara. Nella mediateca della musica la rampa che si solleva dal suolo acquista spessore, diventa architettura e basamento, si trasforma in nastro ed entra nell’edificio dell’ex inceneritore, si piega per definire gli ambienti, esce dal lato opposto sottolineando i volumi inter-ni per poi discendere nuovamente a terra sul retro dell’edificio. Un segno netto, preciso che rimarca quel rapporto indissolubile che esiste tra suolo ed edificio, tra territorio e architettura, «la piega infinita separa o passa tra la materia e l’anima, la facciata e la stanza chiusa, l’esterno e l’interno»6.Una terza declinazione del concetto di continuità è quella espressa dal rap-porto esterno-interno, sperimentata nel progetto per la riconversione di Villa Delfico dove le stesse regole compositive sottintendono l’organizzazione dello spazio interno alla villa preesistente e dello spazio esterno destinato a giardino generando una fluidità spaziale senza soluzione di continuità. Accade diversa-mente nel piccolo progetto di ristrutturazione della casa sul mare a Pescara: dopo esser entrati nella palazzina e aver attraversato verticalmente lo spazio semipubblico, superando la soglia d’ingresso si entra nell’appartamento e si è accolti da una leggera rampa che conduce nella zona giorno. La rampa si dilata trasformandosi in piattaforma, luogo di affaccio verso l’esterno, un belvedere domestico da cui indirizzare lo sguardo sul paesaggio costiero.Per ultima, ma non meno rilevante, la continuità del tempo. Se, come detto in principio, il territorio viene guardato come palinsesto di una terra di antica cul-tura dove permangono i segni del tempo, la ricerca condotta attraverso l’eser-cizio del progetto si inserisce attivamente in questo processo di stratificazione, includendo all’interno delle sue pieghe tutta la complessità della città contem-poranea e registrandone formalmente le contraddizioni in un’architettura che «proviene dalla terra»7.
6 G. Delauze, Op. Cit., p. 58
7 F. L. Wright, The living city, New York, 1958; trad. it. a cura di E. Labò, La città vivente, Torino, 1991, p. 58
SPERIMENTARE LA CONTINUITÁ
171
1991Tesi di laurea: Una Porta per Veneziarelatori prof. A. Carnemolla, prof. Carlo Pozzi.Pubblicato in: AAVV, Aree dismesse e Vuoti urbani, Sala Editore, Pescara 1992; AAVV, La cultura del progetto, PPC 14, Ed’A Editore, Avezzano 1994.
1992Concorso ad inviti per la progettazione di un museo in piazza Luca da Pennecon A. Capone, G. Scatigna, D. Cappelletti, I. Cipolla, C. Varone.Pubblicato in: AAVV, Arte e Architettura, Editoriale d’Architettura, Avezzano 1992; AAVV, Lo spazio aperto nei piccoli centri, 9 progetti per Penne, D.A.U., Pescara,1993; «Segno», 121, U. Sala Editore, Pescara 1993; AAVV, Lo spazio mostre, Di Rico Editore, San Salvo 1994.
Concorso “Quale sala per il cinema”, progetto di una sala cinematografica all’aperto nella masseria Calderoni nel territorio di Gravina di Pugliaprogetto segnalato.
1993Progetto di una casa quadrifamiliare in località Iacone a Pescaracon A. Campanella.
Progetto di ampliamento di una casa rurale in località Fonte Coppella a Loreto Aprutinocon A. Carnemolla.
Concorso per la progettazione di un nuovo terminal in piazza Matteotti a Materacon C. Pozzi, A. Conte, A. Di Giulio (consulente), R. Antezza, D. Catalano, S. Bidetti, F. de Filippis, L. Labate, D. Patricelliprogetto segnalato.Pubblicato in: AAVV, Progetti italiani per Matera, Gangemi Editore, Roma 1994; «Controspazio», 3/94, Gangemi Editore, Roma 1994.
1994Concorso per la valorizzazione del sito naturale Monte e progettazione un osservatorio a Penna San Giovanni
con M.L. Gravina, D. Cappelletti, I. Cipolla, R. Compare.
1995Concorso per l’ampliamento e il recupero del cimitero comunale di Morano Calabrocon A. Capone, G. Scatignaprogetto quarto classificato.Pubblicato in: «Controspazio», 4/96, Gangemi Editore, Roma 1996; AAVV, Premio Nazionale di Architettura Luigi Cosenza 1996, Clean, Napoli 1996.
Concorso per il riuso della rocca di San Casto a Soracon A. Capone, G. Scatigna.Pubblicato in: AAVV, Proposte progettuali per il riuso dei castelli, Edizione E.P.T., Frosinone 1996; AAVV, Architettura, lo stato dell’arte, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2000.
Progetto di un parco giochi nella pineta Martuscelli a Pescaracon A. Capone, G. Scatigna.Pubblicato in: AAVV, Architettura, lo stato dell’arte, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2000.
Palazzina sul lungomare a Pescaracon M. D’Urbano.
1996Concorso per la sistemazione di piazza Garibaldi a Lericicon A. Capone, G. Scatigna, D. Cappelletti, I. Cipolla.
Progetto di un teatro all’aperto nella villa comunale a Chieticon A. Carnemolla (consulente), A. Capone, G. Scatigna.Pubblicato in: AAVV, Forme e luoghi dell’architettura nella città contemporanea, C.I.A.S., Camerino 1996; «Metamorfosi», 34/35, Edizioni Strambi, Alatri 1997.
Progetto di sistemazione di piazza Malta a Chieticon A. Carnemolla (consulente), A. Capone, G. Scatigna.Pubblicato in: AAVV, Forme e luoghi
dell’architettura nella città contemporanea, C.I.A.S., Camerino 1996; «Metamorfosi», 34/35, Edizioni Strambi, Alatri 1997.
Progetto di sistemazione del sagrato di San Francesco Caracciolo a Chieticon A. Carnemolla (consulente), A. Capone, G. Scatigna.Pubblicato in: AAVV, Forme e luoghi dell’architettura nella città contemporanea, C.I.A.S., Camerino 1996; «Metamorfosi», 34/35, Edizioni Strambi, Alatri 1997.
Concorso Europan 4 per la sistemazione dell’area di Vydrica a Bratislavacon A. Capone, G. Scatigna.Pubblicato in: AAVV, Architettura, lo stato dell’arte, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2000.
Concorso per la sistemazione di piazza Carlo Maria Carafa a Grammichelecon A. Carnemolla (consulente), A. Capone, G. Scatigna.Pubblicato in: AAVV, Grammichele. Una città plurale, Skira, Milano 1998.
1997Concorso Europan per la sistemazione dell’Arco Occidentale a Saloniccocon A. Capone, G. Scatigna.
Concorso ad inviti per la progettazione di una stazione ferroviaria a Torregavetacon A. Capone, G. Scatignaprogetto segnalato.Pubblicato in: AAVV, Architettura, paesaggio e archeologia, Clean, Napoli 1997; «Il progetto», 6, Stella Arti grafiche, Trieste 2000.
Demolizione e ricostruzione di un fabbricato rurale in località Fosso Mazzocco a PescaraPubblicato in: AAVV, Almanacco 2004, Sala Editori, Pescara 2004; S. Ciranna (a cura), Dall’Adriatico al Gran Sasso, Gangemi, Roma 2009; O. Buonamano, D. Potenza (a cura), Ad’A 2012, Carsa Edizioni, Pescara 2012.
1998Concorso Europan 5 per la progettazione di
172
2001Progetto di riconversione dell’area Ex-Corradini a Napolicon V. Pezza (coordinatore), C. Orfeo.Pubblicato in: V. Pezza, La costa orientale di Napoli, Electa, Napoli 2002; C. Orfeo (a cura), Valeria Pezza. Progetti per l’architettura della città, Electa Napoli, Napoli 2009.
2002Progetto di un edificio residenziale sulla Strada Parco a Pescaracon I. Cipolla.
Concorso per la progettazione del nuovo municipio di Altinocon R. Mennella, R. Di Fabio.
Concorso per la progettazione della risalita al borgo e recupero di Casa Varani a Castelbassocon U. Cao, S. Degano, A. Malavolta, F. Nasini, R. Novelli, F. Sicuranzaprogetto menzionato.Pubblicato in: AAVV, Recupero del borgo di Castelbasso, Edizioni Tercas,Teramo 2003.
2003Concorso Europan 7 per la progettazione di residenze e servizi sul lungofiume di Pescaracon I. Cipolla, C. Di Gregorio, G. De Cata, R. Di Ceglie, P. Di Filippo, A. Malavolta, R. Sansoniprogetto primo classificato.Pubblicato in: AAVV, Europan 7. Risultati in Italia, Roma 2004; AAVV, Europan 7, European results, Paris 2004; «Il giornale dell’architettura», 14, Edizioni Allemandi, Torino 2004.
Città della Musica sul sito dell’ex-inceneritore a Pescaracon I. Cipolla, C. Di Gregorio; collaboratori: V. Di Biase, S. Pasquini (strutture), FLV workshop (esecutivi), Beta Progetti s.r.l. (impianti meccanici), Europroject Engineering s.r.l. (impianti elettrici), P. Di Filippo (plastici) M. Mario/M. Palermo (modellazione 3d).Pubblicato in: LABItalia ottobre 2004. Come si riqualifica una città, Edizioni Professionali Italia,
residenze e servizi a Turkucon I. Cipolla, C. Orfeo.Pubblicato in: «Il progetto», 6, Stella Arti grafiche, Trieste 2000.
1999Concorso ad inviti per la progettazione di uno stabilimento balneare a Misenocon L. D’Apoteprogetto primo classificato.Pubblicato in: AAVV, Architettura, paesaggio e archeologia, Clean, Napoli 1999.
Progetto di un teatro all’aperto nel Calaserena Village a Maracalagoniscon L. D’Apote.
Concorso per la progettazione della nuova sede dell’Istituto Professionale a Giulianovacon E. Ciampoli, I. Cipolla, V. Fratini.Pubblicato in: AAVV, Premio Tercas architettura XIII 1999, Deltagrafica, Teramo 1999; «Il progetto», 6, Stella Arti grafiche, Trieste 2000.
Concorso per la progettazione di un campus scolastico a Sarnocon E. Ciampoli, I. Cipolla, V. Fratini.
Edifici residenziali in viale Primo Vere a Pescaracon R. Ferrini.Pubblicato in: «L’architettura cronaca e storia» 578, Mancosu Editore, Roma 2003; AAVV, Almanacco 2004, Sala Editori, Pescara 2004; AAVV, Sguardi Contemporanei, Biennale di Venezia, 2004; S. Ciranna, Abruzzo. Architetture a confronto, Gangemi, Roma 2005; R. Ferrini, Edildada due, E2, Pescara 2006; c.a.p. comitato abruzzese del paesaggio (rivista in rete), 2008; S. Ciranna (a cura), Dall’Adriatico al Gran Sasso, Gangemi, Roma 2009; C. Pozzi (a cura), Visiting Architecture, Sala Editori, 2009; O. Buonamano, D. Potenza (a cura), Ad’A 2012, Carsa Edizioni, Pescara 2012.
2000Restauro della chiesa di San Roccocon I. Cipolla, A. D’Alò, M. Zuccarini.
Milano 2004; «L’espresso», 48, dicembre 2005; «presS/Tmagazine», n.07 (rivista in rete), 2006; F. Purini (a cura), La città nuova italia-y-26, articolo di A. Clementi, Editore Compositori 2006; «Creativeclass 0» (rivista in rete), gennaio 2006; «Interrupt» (rivista in rete), 2007; «Nii Progetti» (rivista in rete), 2007; «Skyscaper City» (rivista in rete), 2008; C. Pozzi, D. Potenza ( a cura), Pescara una città in trasformazione, Carsa Edizioni, Pescara 2008; S. Ciranna (a cura), Dall’Adriatico al Gran Sasso, Gangemi, Roma 2009. M. Borrelli, A. Santacroce (a cura), Aree di scavo e spazi urbani, Edizioni Kappa, Roma 2009;G. Corbellini, A. Marin, 97+104=dieci, EUT, Trieste 2010; E. Turilli (a cura), Il cielo in una città,Edizioni Byblos, Pescara 2010; «Europan Italia» (rivista in rete), 2012; AAVV, Ideas Changing, Europan Europe, Paris, 2012; art app n.8: il suono, Edizioni Archos, Bergamo 2012; «Il giornale dell’architettura», 107, Edizioni Allemandi, Torino 2012.
2004Progetto di riconversione dell’ex-mattatoio a Manfredoniacon S. delli Carri, D. Imperatore, L. Pellegrino.
Progetto di un complesso turistico in località Papone a Mattinatacon S. delli Carri, D. Imperatore, L. Pellegrino.
Progetto di un porto turistico a Manfredoniacon S. delli Carri, D. Imperatore, L. Pellegrino.
Progetto di residenze e sistemazione di piazza G. di Vittorio a Maltignanocon U. Cao, S. Degano.
Concorso per la valorizzazione del teatro romano di Spoletocon U. Cao, S. Degano.
2005Casa sul mare a Pescaracon I. Cipolla.Pubblicato in: «Progetti Pescara», 2, Gruppo Quid, Pesaro 2008; S. Ciranna (a cura), Dall’Adriatico al Gran Sasso, Gangemi, Roma 2009.
173
2006Concorso per la progettazione del “parco della memoria” a San Giuliano di Pugliacon F. Trigiani, D. Tronca, C. Corfone.Pubblicato in: L. Centola (a cura), Parco della Memoria, Stampa Arti Grafiche, Pomezia 2007.
Concorso per la progettazione di un parco urbano e di una risalita meccanizzata a Roseto degli Abruzzicon M. D’Annuntiis, Avventura Urbana, Architettura Quotidianaprogetto primo classificato.Pubblicato in: H.J. Cavone Felicioni, G. Vallesi (a cura), Segni di paesaggio urbano, Sala Editori, Pescara 2006.
Casa unifamiliare a SergyPubblicato in: S. Ciranna (a cura), Dall’Adriatico al Gran Sasso, Gangemi, Roma 2009.
Progetto di riconversione dell’area Ex-Carbon ad Ascoli Piceno: studio planimetrico e studio di un edificio residenziale. La proposta si inserisce in una ricerca condotta dal Dipartimento ProCam dell’Università di Camerino: U. Cao, A. Dall’Asta (responsabili), L. Coccia, M. D’Annuntiis, E. Ippoliti; con M.T. Cusanno, G. Foti, A. Gabbianelli, A.L. Petrucci, S. Vespasiani.Pubblicato in: AAVV, “UNI.CITY”, «Spazioricerca», 8, Edizioni Kappa, Roma 2007.
2007Progetto del nuovo polo universitario piceno ad Ascoli Picenocon U. Cao, L. Coccia, M. D’Annuntiis.Pubblicato in: AAVV, “UNI.CITY”, «Spazioricerca», 8, Edizioni Kappa, Roma 2007.
Allestimento della mostra “La città postindustriale. Nuovi destini per le aree dismesse” nella Cartiera Papale ad Ascoli Picenocon M. D’Annuntiis, N. Flora, E. Corsaro, G. Foti, A. Gabbianelli, E. Marcotullio, G. Menzietti, L. Romagni, I. Virgili. Allestimento della mostra“Paesaggi Postindustriali”nell’Ex-
Carbon ad Ascoli Piceno, con M. D’Annuntiis, N. Flora, M.T. Cusanno, E. Ippoliti, A.L. Petrucci, D. Rossi. Le due mostre, promosse dalla Provincia di Ascoli Piceno, sono inserite nel festival Saggi Paesaggi 2007.Pubblicato in: L. Coccia e M. D’Annuntiis, Paesaggi post-industriali, Quodlibet, Macerata 2008; M. Valeri, BAM Borghi Alti di Mare, in «Progetti Ancona», 24, Quid, Pesaro 2009.
Allestimento della mostra “Borghi Alti di Mare: Paesaggi di costa e di frontiera” nella Cartiera Papale ad Ascoli Picenocon M. D’Annuntiis, E. Ippoliti, A. Gabbianelli, E. Marcotullio, L. Romagni, M. Valeri. La mostra, promossa dalla Provincia di Ascoli Piceno, è inserita nel festival Saggi Paesaggi 2008.
Concorso per la riconversione della Casa Turà ad Olivadicon F. Armillotta, I. Cipolla, D. D’Agostino, C. Palmieri, M. Santomauro.Pubblicato in: S. Ciranna (a cura), Dall’Adriatico al Gran Sasso, Gangemi, Roma 2009.
2009Concorso per la riconversione di Villa Delfico a Montesilvanocon F. Armillotta, I. Cipolla, D. D’Agostino, A. Gabbianelli, C. Palmieri, G. Regnicoli, M. Santomauro, progetto terzo classificato.Pubblicato in: AAVV, Centro culturale Villa Delfico, Publish, Sambuceto 2010
Concorso per la progetto di una scuola per l’infanzia e servizi a Biscegliecon F. Armillotta, I. Cipolla, D. D’Agostino, M. Palermo, C. Palmieri, M. Santomauro, F. Trigiani.
Progetto di ricostruzione del borgo e nuova chiesa a Temperacon A. Mammoli, A. Mancini, E. Muci, R. Panata. Il progetto si inserisce nel Piano di Ricostruzione del borgo di Tempera redatto dalla Scuola di Architettura e Design di Camerino: U. Cao (responsabile scientifico), M. D’Annuntiis (coordinamento), V. Borzacchini,
P. Ciorra, L. Coccia, A. Dall’Asta, G. Leoni, R. Mennella, M. Perriccioli, S. Salvo, S. Cipolletti (segreteria tecnica).Pubblicato in: «Il giornale dell’architettura», 105, Edizioni Allemandi,Torino 2012.
2010Progetto di riconversione dell’area Ex-Cofa a Pescaracon M. D’Annuntiis, F. Ottone, S. Cipolletti, C. Luongo, D. Mahmoud, S. Medori, S. Ursini Casalena.
Progetto di un interno urbanoa Manfredoniacon F. Trigiani.
2011Concorso per la progettazione di residenze e servizi a Frosinonecon M. Bottini, I. Cipolla, F. Corsi, A. Mammoli, E. Muci, F. Petrucci, F. Trigiani.
Concorso per la ricostruzione della chiesa di San Gregorio Magno a San Gregoriocon V. Borzacchini, M. D’Annuntiis, E. Petrucci, C. Belli, D. Diamanti, A. Palmieri.
Crediti fotografici
Raniero Carloni, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133Luigi Coccia, 39,75, 93, 95, 97Antonello Di Mauro, 119, 121Nicola Flora, 126Peppe Maisto, 57, 58, 59, 71, 109, 111Silvia Mazzotta, 91, 94, 96Ivano Villani, 72,73