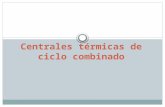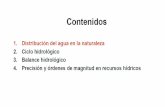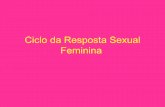I "Reali" dell'Altissimo. Un ciclo di cantari fra oralità e scrittura
Transcript of I "Reali" dell'Altissimo. Un ciclo di cantari fra oralità e scrittura
centro di studi «aldo palazzeschi»Università degli Studi di Firenze
Facoltà di Lettere e Filosofia
quaderni aldo palazzeschinuova serie
20
La collana ospita ricerche di area italianisticacompiute da allievi della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Firenze, giudicate meritevoli di pubblicazionedal Consiglio Direttivo del Centro di Studi «Aldo Palazzeschi».
La Facoltà fiorentina intende in questo modo onorare la memoriae la patria sollecitudine di Aldo Palazzeschi, che l’ha costituita
erede del suo patrimonio ed esecutrice della sua volontà.
Luca Degl’Innocenti
I «Reali» dell’Altissimo
Un ciclo di cantari fra oralità e scrittura
Società Editrice Fiorentina
© 2008 Società Editrice Fiorentinavia Aretina 298 - 50136 Firenze
tel. 055 5532924fax 055 5532085
isbn 978-88-6032-080-3
Proprietà letteraria riservataRiproduzione, in qualsiasi forma, intera o parziale, vietata
In copertinaCanterino in piazza San Martino
(dal frontespizio de La rapresentatione di dieci mila martiri, Firenze, 1558; già in Luigi Pulci, Morgante, Firenze, Piero Pacini, 1500)
Indice
Introduzione 9
Avvertenza 17
I. Vita e opere di Cristoforo fiorentino 19 Premessa 191. Notizie e documenti 22 La generazione dell’Altissimo 22 Il periodo fiorentino: primi trionfi e silenzi 24 Secondi trionfi e silenzi: il periodo veneziano 282. Stampe delle opere minori 32 La «Rotta di Ravenna» 32 Edizioni delle rime 38 Primi sondaggi sulla tradizione manoscritta delle rime 423. Data, luogo e paratesti della prima raccolta di rime 45 Firenze o Venezia? Ancora una questione di date 45 La prefazione della princeps 49 Il fascicolo encomiastico veneziano 53
II. Un ciclo di cantari da Firenze a Venezia 611. Venezia, Nicolini, 1534 61 Il manufatto tipografico: descrizione bibliografica 61 Il corredo silografico e il vero editore del Primo libro de’ Reali 632. Dalla piazza alla tipografia 72 La prefazione Alli lettori: i cantari cavallereschi dell’Altissimo
e il loro approdo alla scrittura 72 Conteggio e struttura dei cantari: il problema
degli “Inframessi” 853. Firenze, giugno 1514 - luglio 1515 92 Un ciclo di cantari, recita dopo recita. Ottave di repertorio,
contraddizioni interne e trascrizioni dal vivo 92 La datazione del Primo libro e il calendario delle recite 103
III. Cantare il primo libro dei «Reali di Francia» 115 Premessa 1151. I Reali di Francia. Autorità ed emulazione 117
2. Gli errori del Primo libro de’ Reali. Mende dell’antigrafo e disinvoltura canterina 124
3. Strategie di adattamento in ottave 139
IV. Oltre i «Reali»: moralità e oralità nel «Primo Libro» 1731. Appunti sulle cose notabili nei cantari dell’Altissimo 1732. Margini di improvvisazione e marche di oralità 190
APPENDICIAppendice A I capitoli dei Reali di Francia nei cantari del Primo libro de’ Reali 213
Appendice B Tavola delle cose notabili del Primo libro de’ Reali del poeta Altissimo 231
Appendice C Calendario delle recite del Primo libro de’ Reali 235
Appendice D Pezzi di repertorio 241 Parte I. Repliche interne al Primo libro de’ Reali 242 Riutilizzo di ottave esordiali 242 La Tempesta del cantare LVI (e quella dei cantari XX-XXII) 243 Lamento di Reale assediato: LXXXIX 7-19 e XXIII 14-24 248 Cantare XC 251 Cantari LXXXIX e XCI 261 Altri riciclaggi 262 Parte II. Il Primo libro de’ Reali e le opere minori 264 Strambotti 264 Bellezze di un uomo 265 Stanze del medesimo 266 Invocazioni fatte in san Martino 267 La Rotta di Ravenna 268
Appendice E Opera dello Altissimo, Venezia, s.d., fascicolo I. Componimenti in lode del poeta e dell’opera 273
Bibliografia 279
Indice dei nomi 313
Introduzione
Cristoforo Fiorentino detto l’Altissimo, canterino improvvisatore ec-cellente e in quanto tale poeta laureato, onorato a Firenze e Venezia d’una fugace quanto eclatante celebrità nel secondo decennio del Cin-quecento, è autore cui gli odierni studi sulla narrativa in ottave e sulla lirica cortigiana non ricusano qualche riga di menzione o una nota a pie’ di pagina, ove si riferiscono d’abitudine pochi cenni ormai accla-rati, distillati dai rari volumi che in luogo di qualche riga gli han ri-servato parecchie pagine, quasi tutte però vecchie d’almeno un secolo. Quando siano più recenti, fanno parte normalmente di lavori dedicati alla rimeria amorosa dell’ultimo Quattro e del primo Cinquecento, cui l’Altissimo arrecò con buona lena e larga vena il suo proprio contributo di strambotti, sonetti, capitoli ed epigrammi. Quasi che sull’opera sua di maggior mole ed importanza, il “poema” cavalleresco sul Primo libro de’ Reali, tutto quello che interessa fosse stato già chiarito, e per darne adeguato conto bastasse sunteggiare i centenari contributi offertigli da illustri maestri come Rajna o Renier. Tanta fiducia nello storicismo e nell’erudizione positivisti è certamente ben riposta, ma non sarà certo motivo di scandalo constatare che le pur scarne informazioni vulgate sui Reali dell’Altissimo domandano alcune risposte che importerebbe ben più divulgare, se non fossero state in parte dimenticate e in parte – la maggior parte – semplicemente mai cercate.
L’Altissimo, si ripete, è autore d’una versione in ottava rima del primo libro dei Reali di Francia, che egli recitò pubblicamente in un lungo e acclamato ciclo di performances cavalleresche allestito a Fi-renze in un anno imprecisato compreso fra il 1486 ed il 1514. Questo suo Primo libro de’ Reali fu poi pubblicato in un’edizione a stampa impressa postuma a Venezia nel 1534.
Considerato separatamente, ciascuno di tali eventi non è di per sé
10 I «Reali» dell’Altissimo
stesso eccezionale. Lungo tutto il Quattrocento, si conoscono infatti molti nomi di poeti «canterini» famosi per aver deliziato le folle e i signori con una ricca produzione orale che annoverava le narrazioni cavalleresche tra i propri generi di punta; ma di norma ci mancano i testi da associare a tali nomi d’autore. Sono molti anche i cantari e i poemi cavallereschi trasmessi da codici e stampe; ma sono, simme-tricamente, quasi tutti anonimi e svincolati da una verificabile de-stinazione recitativa, concepiti o trasformati in vista d’una fruizione scritta. Non è raro neppure il caso di versioni duplici e concorrenti d’una stessa storia, in prosa e in rima; ed è nota la netta preferenza accordata dal mercato tipografico alle redazioni versificate vecchie e nuove, a discapito di quelle prosastiche, preferenza che consacra la già egemone ottava rima quale metro per eccellenza dell’epica italiana.
Cosa c’è dunque di eccezionale nei Reali dell’Altissimo? C’è il fatto che, per quanto lascia intuire la vulgata critica, fra il testo immortalato dal torchio e quello cantato in piazza intercorrono rapporti oltremodo diretti. Se così stanno le cose – e le nostre analisi lo confermano – i 94 cantari del Primo libro de’ Reali si profilano come il maggior reperto di letteratura orale del nostro Rinascimento: non soltanto un note-vole attestato della persistente vitalità, almeno a Firenze, della poesia cavalleresca canterina, “di piazza”, nell’epoca delle tipografie e dei ca-polavori d’autore, ma anche un’occasione straordinaria per studiare in vivo le tecniche e il repertorio sedimentati dalla secolare arte dei cantimpanca, un documento prodigo di indicazioni chiarificatrici su numerosi aspetti di quella tradizione, tali da cominciare a colmare l’imbarazzante silenzio che paradossalmente avvolge, negli studi no-strani sull’oralità, il principale filone di poesia orale nell’Italia del Me-dioevo e del Rinascimento, qual è appunto quello dei cantari.
Nella sostanza, tale eccezionalità era già stata asserita dai nostri eruditi settecenteschi ed assodata dalle generazioni del secondo Otto-cento, tanto che il nome dell’Altissimo ricorre più volte negli studi di Francesco Flamini su La lirica toscana del Rinascimento e di Ezio Levi su I cantari leggendari del popolo italiano; studi entrambi tuttora au-torevoli, che attinsero dall’opera del fiorentino una corposa messe di informazioni e deduzioni rilevanti per i rispettivi oggetti di indagine: la produzione di rime amorose, morali e politiche nel Quattrocento toscano e la tradizione poetica delle ottave canterine. Nel corso del Novecento, tuttavia, il Primo libro è scivolato lentamente nell’oblio,
Introduzione 11
forse anche a causa della cronologia tarda o della mole scoraggiante del testo, talché alcune delle nozioni acquisite si perpetuano immemori della fonte onde sgorgarono, altre invece quasi non si perpetuano af-fatto, come quelle concernenti la prassi di trascrivere dal vivo i com-ponimenti orali di canterini e poeti estemporanei: per chi ne afferma l’esistenza, tali reportationes sono poco meno che un’araba fenice, ma non manca chi ormai le giudica alla stregua d’una chimera partorita dall’ingenua fantasia di qualche studioso del passato.
Eppure, è proprio nella pratica collaudata della reportatio che si individua l’unico tramite possibile tra scaturigini performative ed esiti tipografici, tra recita e stampa, del Primo libro de’ Reali. Svariate peculiarità altrimenti inspiegabili di questo testo demoliscono infat-ti, come potremo dimostrare, tutte le ipotesi alternative, compresa quella dei «copioni» d’autore formulata a suo tempo da Renier, le cui analisi avevano sì messo in luce alcuni caratteri insoliti dell’opera – quali il nesso evidente con le occasioni della performance e l’inte-razione del poeta con un pubblico fisicamente presente – ma non avevano raggiunto molti traguardi definitivi, e forse non ambivano a farlo, destinate com’erano ad introdurre una scelta di strambotti e sonetti dell’Altissimo, e non un’edizione di suoi cantari. Senza con-tare che dal 1886 ad oggi gli strumenti della critica si sono sensibil-mente modificati ed affinati.
Ecco dunque spiegato perché “riscoprire” i Reali dell’Altissimo abbia significato ben presto scoprire non poche cognizioni nuove e interessanti su quest’opera e sulla tradizione onde nasce ed entro cui si definisce. Che finora nessuno abbia colto l’occasione della risco-perta è certo deplorevole, ma il fatto stesso che essa ci sia toccata in sorte durante una ricerca dottorale originariamente rivolta altrove ci pare un esempio incoraggiante di quanto si possa ancora lavorare con profitto attorno ai molti oggetti testuali non identificati avvista-bili nei vasti cieli delle nostre sintesi di storia letteraria.
Considerata la scarsità delle notizie sul nostro autore, il primo capi-tolo del presente studio si premura di raccogliere, ordinare e commen-tare tutti i documenti utili ad assemblarne un minimo profilo biogra-fico ed artistico. Il rinnovato scrutinio delle testimonianze coeve sulla sua attività poetica, dei pochi documenti d’archivio al momento noti, delle edizioni delle sue opere e dei loro paratesti permette di definire con maggior esattezza gli estremi cronologici della vita di Cristoforo
12 I «Reali» dell’Altissimo
l’Altissimo (più “cinquecentista” di quanto non si credesse), le tappe della sua breve carriera e della sua lunga fortuna fiorentina e veneziana (affidata anche ad alcuni testimoni manoscritti ignoti prima d’ora), i connotati dei generi letterari che praticò e degli amici e colleghi che frequentò. In particolare, il negletto manipolo di rime encomiastiche che correda la princeps veneziana delle sue liriche, qui ripubblicato nell’Appendice E, si rivela prezioso per confermare alcuni tasselli della sua biografia (soprattutto l’incoronazione poetica) e per identificare alcune sue relazioni letterarie: se il mondo degli improvvisatori fio-rentini trova un emblema nel nome del Bièntina, ultimo Araldo della città, quello dei professionisti padani dell’ottava rima si incarna in Niccolò degli Agostini, primo continuatore del Boiardo.
L’indagine bibliografica sconfina nel secondo capitolo, appun-tandosi sull’edizione del Primo libro de’ Reali e sul contesto socio-culturale nel quale fu prodotta. Dietro ai tipografi Nicolini, in veste di incognito editore dell’opera, emerge qui il nome di un altro degli encomiasti: Giovanni Manenti, enigmatico mercante e «filosofo» senese, appaltatore di lotterie e allestitore di commedie, nelle cui mani erano a quanto pare pervenuti i materiali manoscritti conte-nenti le ottave dell’amico defunto. Secondo la prefazione a stampa, tali materiali si identificherebbero in massima parte con meticolose trascrizioni della viva voce dell’Altissimo effettuate da alcuni suoi ammiratori durante le esibizioni fiorentine. Il nucleo centrale del capitolo si impegna pertanto a verificare nel corpo del testo l’atten-dibilità di siffatte asserzioni. Contro lo scetticismo di antichi e mo-derni, e contro la nostra stessa precauzionale diffidenza, il teorema delle reportationes fedelmente sottoposte al torchio si rivela a poco a poco come l’unico in grado di spiegare organicamente un vasto complesso di fenomeni caratteristici dei cantari dell’Altissimo, quali gli “errori d’ascolto” imputabili a fraintendimenti uditivi, le incer-tezze editoriali nel trattamento di macroscopiche anomalie strut-turali (il rompicapo degli «inframessi» gnomici anteposti ai primi cantari, riflesso d’una morfologia spettacolare in divenire), il rici-claggio di numerosi e corposi brani di repertorio replicati nel corso del ciclo (documentati nell’Appendice D), e soprattutto l’emergere di contraddizioni, ripensamenti in corso d’opera, errori di memoria ed altri accidenti tipici dello spettacolo “in diretta”. Un’eclatante riprova della conformità fra testo cantato e stampato è addotta in-
Introduzione 13
fine dagli esordi e dai congedi dell’Altissimo. Alcuni dei primi e gran parte dei secondi conservano infatti indicazioni molto precise circa il giorno (e persino l’ora) degli spettacoli: in sinergia con certe dirimenti allusioni alla storia contemporanea sfuggite a Renier, tali indicazioni ci hanno permesso di ricostruire nel dettaglio l’intero calendario delle 94 recite del ciclo sul Primo libro de’ Reali (si veda l’Appendice C), che dominò il cartellone di piazza San Martino dal 4 giugno 1514 all’8 luglio 1515.
Le prove della registrazione dal vivo dei cantari continuano ad emergere nei due capitoli successivi, che si inoltrano nella caratteriz-zazione delle tecniche e del repertorio del celebre canterino. Il terzo capitolo studia in particolare il rapporto intertestuale con l’antigrafo prosastico dei Reali di Francia, il cui primo libro è trasposto integral-mente nelle esibizioni in ottava rima dell’Altissimo (la sinossi com-pleta è fornita dall’Appendice A). La sua versione del popolarissimo romanzo non soltanto assolve pienamente l’obbligo convenzionale di conformarsi all’autorevole fonte scritta, della quale incamera spesso pericopi intatte e non trascura quasi mai i più minuti dettagli (talché abbiamo addirittura potuto collocare il testimone utilizzato dall’Altis-simo nello stemma codicum del romanzo), ma soprattutto lo travalica, giacché ne amplifica il dettato con abbondanti ornamenti retorici, ne arricchisce la narrazione di molteplici episodi inediti micro e macro-scopici, e infine ne modifica gli equilibri e trasforma gli statuti costel-lando i cantari del Primo libro di un gran numero di digressioni mo-rali e dottrinali. Commentando alcuni brani emblematici dei diversi aspetti della riscrittura, si è cercato di comprendere “come lavorava l’Altissimo”, portandone in luce le strategie ricorrenti, gli artifici, i sotterfugi, i trucchi e i rischi del mestiere, e al contempo badando a far affiorare i modelli di riferimento del suo poetare in pubblico, che si identificano in generale nella tradizione «popolare» fiorentina del Quattrocento, onde eredita anche il metodo di fabbricazione del linguaggio poetico sulle corone trecentesche, e si incarnano in par-ticolare nelle creazioni cavalleresche di Luigi Pulci, cui l’Altissimo si conforma senza sforzo apparente non solo sul piano della lingua e del-lo stile (collezionismo ed espressivismo, comicità ed iperbolicità) ma anche su quello dell’eclettismo tematico, della concezione del cantare carolingio come contenitore potenzialmente aperto ad ospitare inter-mezzi moraleggianti, lezioni filosofiche o discussioni teologiche.
14 I «Reali» dell’Altissimo
La prima parte del quarto capitolo si propone appunto di saggia-re, sostando brevemente su alcuni campioni sintomatici, il poliedrico repertorio didascalico profuso nei cantari del Primo libro de’ Reali con una frequenza e una incidenza strutturale (se ne veda il regesto nell’Appendice B) incomparabili con quelle delle occasionali digres-sioni pulciane, e che tuttavia traggono la propria linfa vitale dall’an-tica arte poetica canterina, forgiatrice di rime storiche, politiche, morali, filosofiche e religiose, oltreché liriche o narrative. Nell’enci-clopedico zibaldone dell’Altissimo sono appunto rubricati soggetti pertinenti alle materie più disparate, dalla storia antica e contempo-ranea alla teologia, dalla morale all’arte militare, dalla politica all’ana-tomia e all’astrologia (cioè alla medicina). Quando ci sia riuscito di rintracciarne la fonte, abbiamo riscontrato i medesimi meccanismi di riscrittura azionati nei confronti dell’ipotesto romanzesco. La me-tamorfosi in ottave di una scrittura preesistente si accampa come momento centrale della professione del poeta di piazza, istrione e mediatore culturale, poeta divertente ed oratore sapiente, che si vor-rebbe onnisciente, la cui funzione civica è quella di delectare e docere, di intrattenere e ammaestrare i concittadini. La natura delle fonti fagocitate e divulgate dall’Altissimo, dichiaratamente tutte volgari, è alquanto variabile, poiché egli si incarica di aggiornare i florilegi tar-domedievali tanto coi cartigli di una silografia astrologica quanto con le ardue carte vergate nell’ultimo culmine dell’Umanesimo fiorenti-no: se per impreziosire il suo variegato campionario cavalleresco di vessilli pittorici non aveva esitato a saccheggiare le raffinate Stanze del Poliziano, per sbandierare un’eccellenza di predicatore teologo non si fa scrupolo di impadronirsi dei trattati neoplatonici del Ficino.
Tutto ciò accade a beneficio di un composito pubblico presen-te e interagente, raccolto attorno al canterino per godersi il suo spettacolo. La seconda parte del quarto capitolo è appunto dedi-cata alle circostanze e modalità di questo spettacolo, cioè al conte-sto comunicativo in cui si attuava la mise en rime dei Reali nonché alle tecniche che ad essa presiedevano. Le ottave dell’Altissimo ci regalano infatti numerosi riferimenti al concreto svolgimento delle sue “serate”, cui assisté una platea rumorosa ed entusiasta, talvolta polemica ma sempre generosa nel premiare il suo performer durante la colletta condotta dagli aiutanti a fine recita, quando la magia del canto, del mimo e della musica sta per svanire e si avvicina il mo-
Introduzione 15
mento di sgombrare le panche. Tanti indizi sono il portato di una pratica viva di poesia orale che di norma siamo indotti a dimentica-re, lavorando su testi che affrontiamo come mere scritture giacché mancano perlopiù di quegli indizi, oppure paiono riecheggiarli per pura convenzione. Il caso dell’Altissimo, sia epico che lirico, ci ram-menta invece con persuasiva intensità che i piani dell’oralità e della scrittura non corrono affatto paralleli e separati nei primi grandi secoli della nostra letteratura, ed anzi si intersecano e rispecchiano a vicenda in una civiltà della parola la cui comunicazione, spontanea o artistica che sia, è svolta prioritariamente in presenza, e la voce della poesia si armonizza con musiche e immagini. Soltanto grazie alla sopravvivenza di trascrizioni dalla viva voce (paradossalmente favorita proprio dai mezzi tipografici di moltiplicazione mecca-nizzata della scrittura) abbiamo l’occasione di osservare fenomeni “estremi” come quello dei deittici irrelati che costellano i cantari del Primo libro e segnalano altrettanti punti di sutura con la loro dimensione scenica, mimica e teatrale, che enfatizzava anche il ri-corso frequente al discorso diretto, alle scenette comiche, ai lazzi d’effetto o alle onomatopee prelinguistiche. La complessità di uno spettacolo allestito in un’epoca priva dei nostri strumenti di registra-zione audiovisiva è inevitabilmente mutilata delle sue componenti non verbali; tuttavia, benché privato dell’intonazione, della musica, dei gesti, delle carrellate su piazza San Martino e dei primi piani sul volto del poeta, il nudo testo consegnatoci dalla stampa è in grado di sorreggere fruttuosamente un’indagine rivolta ad acclara-re i metodi di composizione che generavano la struttura portante di quel complesso spettacolo, cioè quella verbale. Se l’esecuzione e fruizione orale coinvolgono ancora, nel primo Rinascimento, mol-ta parte della poesia prodotta in Italia, l’antica scuola dei canterini professionisti (cioè dei poeti cantori e musici, che in tale accezione include anche figure come quelle dei lirici “cortigiani”) si distingue in particolare per il vanto della composizione «all’improvviso» dei propri testi. In un contesto di oralità secondaria, cioè in connubio con una solida tradizione letteraria scritta, l’improvvisazione si rivela fondata proprio sul rapporto con una scrittura d’appoggio, intesa come testo singolo, trattato da antigrafo letterale o da canovaccio, ma anche come ipertesto ramificato nell’intera tradizione poetica volgare, memorizzata e introiettata per corredarsi di una padronanza
16 I «Reali» dell’Altissimo
della lingua e del metro e una ricchezza di formulario poetico che variano molto fra l’uno e l’altro autore, ma che nell’Altissimo sono entrambe di notevole livello. Studiando i suoi cantari, il vanto del verseggiare all’improvviso si scopre insomma pienamente legittimo, e si precisa nei termini di una riscrittura estemporanea che assembla endecasillabi, ottave e sequenze di ottave combinando attorno al te-sto di riferimento una collezione di componenti testuali stratificata su livelli di crescente complessità, dagli emistichi formulari ai lun-ghi brani di repertorio preconfezionati e premeditati. Non importa quante parti del cantare preesistessero alla recita: quel che importa è che non volesse né potesse preesisterle il loro effettivo assemblaggio, certamente progettato in anticipo, ma con una congenita vocazio-ne a mutare e calibrarsi in funzione delle imprevedibili contingenze dell’esecuzione, ove entrano in gioco persino le condizioni meteo-rologiche ma soprattutto la composizione e gli umori del pubblico e lo stato di forma del poeta, che deve far appello, non sempre con successo, tanto alla memoria quanto all’estro creativo, a quel «furor» più volte invocato dal nuovo rapsodo con impressionante consape-volezza teorica.
Questo dell’improvvisazione è uno dei temi cardine della nostra ricerca, che al pari di altri fin qui richiamati non trova soltanto un luogo deputato nei capitoli, ma percorre anche una trama ortogo-nale alla loro orditura. Confidiamo che l’avventuroso lettore non fatichi ad orientarsi in questa trama, così come ci auguriamo che sia indulgente con gli squarci aperti da alcune note a piè di pagina su direzioni di ricerca ulteriori ma non completamente esplorate. Sono molti gli approfondimenti e i supplementi d’indagine raccoman-dabili sul Primo libro de’ Reali e a partire da esso, sia per i dati che la “funzione Altissimo” proietta sugli assi specifici della storia della poesia orale e della letteratura cavalleresca, sia per i tratti che essa di-segna sul piano più generale della civiltà italiana del Rinascimento, come documento di storia della lingua, ad esempio, o come referto di storia della cultura, non soltanto popolare. Molti di questi temi potranno essere affrontati in funzione o in virtù di un’edizione criti-ca commentata dell’opera; per il momento ci contentiamo di aver-ne indagata o delineata una buona parte, riportando all’attenzione degli studiosi un autore che di attenzione ci è sembrato meritarne molta, come Cristoforo Fiorentino detto l’Altissimo.
Accolti, Bernardo (detto l’Unico Aretino) 22, 39, 43n, 193 e n
Accorsi, Maria Grazia 80nAgeno, Franca 157n, 169nAgli, Pellegrino 110nAgostini, Niccolò degli 12, 56, 57 e
n, 64n, 78n, 117n, 276Albanzani, Donato degli 177nAlderotti, Taddeo 66nAlessandri, Baldassarre Olimpo de-
gli vedi Olimpo da SassoferratoAlessandro Magno 66n, 176, 219,
232Alfani, Lucantonio 55, 273Alvarotti, Marco Aurelio 68Aragona, Alfonso I di 177n, 232Alighieri, Dante 22, 24n, 43n, 58,
110-111nn, 121n, 175n, 188, 273, 277
Allaire, Gloria 118nAlonge, Roberto 58nAltieri Biagi, Maria Luisa 182n,
186nAndrea da Barberino 20n, 51n, 78n,
84, 116, 118-119nn, 120 e n, 123n, 146, 149 e n, 155n, 164, 173, 213
Ankli, Ruedi 156nAnnibale 176, 177n, 217, 231-233Antonio di Guido 80n, 177n, 191nAntonio di Meglio 177nAquilano, Serafino (Ciminelli, Se-
rafino de’) 39
Aretino, Pietro 37n, 43n, 68 e n, 70, 71 e n, 72, 98n, 138n, 193
Ariosto, Ludovico 43-44nn, 113Aristotele 66n, 81n, 93n, 180,
202nAscarelli, Fernanda 66n
Balduino, Armando 79nBanchi, Luciano 176nBandini, Angelo Maria 25nBaraballo, Cosimo 70 e nBarberi, Francesco 63Barbiellini Amidei, Beatrice 187nBarboni, Michelangelo 66nBelcalzèr, Vivaldo 66nBembo, Pietro 31nBénéteau, David P. 176nBenivieni, Girolamo 26nBenvenuto, Francesco di Giovanni
42n, 56nBeolco, Angelo (detto Ruzante) 58,
68 e nBernardino da Siena, santo 79 e n,
204nBertelli, Sergio 69 e n, 70nBessi, Rossella 157nBettin, Giancarlo 20n, 32n, 168nBianco, Simone 68nBièntina vedi Del Polta IacopoBindoni, Agostino 69nBindoni, Francesco 63, 64 e n, 65nBisticci, Zanobi 42n
indice dei nomi
314 I «Reali» dell’Altissimo
Boccaccio, Giovanni, 20n, 22, 43n, 110-111nn, 166n, 168n, 175n, 188
Boiardo, Matteo Maria 12, 57, 78n, 92n, 113, 119 e n, 135n, 140n, 168n, 202
Boll, Franz 182nBolzoni, Lina 79n, 189nBoni, Marco 117-118nnBorghini, Vincenzio 80nBrown, Rawdon 29nBrunelleschi, Filippo 178 e n, 218,
232Bruni, Leonardo 109nBruni, Raoul 111nBruscagli, Riccardo 55n, 119n, 135n,
140nBurchiello vedi Domenico di Gio-
vanni
Cabani, Maria Cristina 33n, 115-116nn, 132n, 140n, 156n, 192n, 201n
Calmeta, Vincenzo 195nCampani, Niccolò (detto lo Stra-
scino) 58nCannata, Nadia 39 e n, 40n, 46n,
53nCanova, Andrea 63nCappelli, Adriano 108, 235Cardona, Giorgio Raimondo 79n,
198n, 201nCarrai, Stefano 56n, 165nCasadei, Alberto 57n, 63nCastelli, Bartolomeo di Matteo 39 e
n, 40n, 56nCastiglione, Baldassarre 43n, 193 e
nCastracani, Castruccio 117nCataudella, Michele 175nCavalcanti, Guido 43n, 188Cecioni, Giorgio 66nCecchi, Giovanni Maria 167nCei, Francesco 39
Cesare, Caio Giulio 176 e n, 217, 221, 231-234
Cesareo, Giovanni Alfredo 70-71nn
Chiti, Jacopo 40n, 242Cian, Vittorio 29n, 30-31nnCinelli, Giovanni 42n, 43nClemente, Pietro 118nCoppini, Donatella 109nCorreggio, Niccolò da 43nCorti, Maria 201-202nnCrescimbeni, Giovan Mario 19 e n,
22, 23Croce, Benedetto 175nCursietti, Mauro 118nCurtius, Ernst Robert109nCutolo, Alessandro 112n
D’Ancona, Alessandro 20n, 33 e n, 79, 121n, 175n
Davanzati, Bartolomeo 148nDati, Gregorio 43nDe Gregori, Gregorio 181-182nnDelcorno, Carlo 79nDella Barba, Zanobi 105nDella Vedova, Gaspare 29Dell’Ottonaio, Giovanbattista 42n,
80n, 97n, 175, 195Del Polta, Iacopo (detto il Biènti-
na) 12, 42-43nn, 45, 55, 56 e n, 175 e n, 195, 275
De Robertis, Domenico 79n, 90n, 112, 115n, 187n
Diamanti, Donatella 35nDionisotti, Carlo 20n, 26n, 175n,
184nDi Pietro, Giovanni 32nDi Ricco, Alessandra 194nDolce, Lodovico 117nDolfi, Teresa 65n Domenichi, Lodovico 65nDomenico di Giovanni (detto il
Burchiello) 43n, 98n, 138n, 166n
indice dei nomi 315
Doni, Anton Francesco 37nDovizi da Bibbiena, Bernardo 70
Empedocle 110nEraclito 110nErspamer, Francesco 71n
Fanti, Mario 108nFassò, Andrea 148nFederico III, imperatore 54nFerrajoli, Alessandro 70-71nnFerrario, Giulio 19nFicino, Marsilio 14, 109-110nn, 179
e n, 180, 182n, 183Flamini, Francesco 10, 80 e n, 176 e
n, 179, 192n, 196nFòffano, Francesco 32n, 63nFoix, Gaston de, duca di Nemours
108Folengo, Teofilo 117nFontana, Luigi 35nForteguerri, Francesco 58nFrancesco Cieco da Firenze 196nFranchi, Saverio 194nFresta, Mariano 118nFulin, Rinaldo 57n, 74n
Gamba, Bartolomeo 41nGambara, Veronica 43nGambarin, Giovanni 118nGarin, Eugenio 184nGentili, Bruno 194nGiamboni, Bono 66nGiannelli, Luciano 118nGiogante, Michele del 80 e n, 196nGiordano da Pisa 79Giovanni Fiorentino 121nGiunta, Bernardo 24-28, 31, 39, 51,
53Giunta, Filippo 24, 25 e nGrazzini, Antonfrancesco (detto il
Lasca) 36-37nn, 55, 128nGritti, Andrea, doge 63, 66n
Guarino, Raimondo 69-71nnGuasti, Cesare 27nGuglielmo da Fontaneto 48Guicciardini, Francesco 107 e n,
108Guidiccioni, Giovanni 43n
Haar, James 191nHarris, Neil 27n, 36-37nn, 57n,
65n, 118n, 120n
Ianuale, Raffaella 193nInfelise, Mario 118nInglese, Giorgio 44nInnamorati, Isabella 55n, 175nInnocenti, Piero 69-70nnIvaldi, Cristina 33n
Kemp, Martin 182nKetham, Johann 180, 181n, 182Kezich, Giovanni 97nKristeller, Paul Oskar 179n
Lancetti, Vittorio 54nLandino, Cristoforo 109-110nnLanza, Antonio 176-177nnLasca vedi Grazzini Antonfrance-
scoLatini, Brunetto 66nLeonardo da Vinci 182 e n, 183,
184nLeone X, papa 22, 58n, 70 e n, 71Leopardi, Giacomo 111nLevi, Ezio 10, 32n, 36Limentani, Alberto 140nLiompardi, Zuan Polo 58 e n, 68Livio, Tito 175-176nnLodovici, Francesco dei 63 e n,
64n
MacArthur, Douglas 75nMachiavelli, Niccolò 43-44nn, 69 e
n, 117n, 175 e n
316 I «Reali» dell’Altissimo
Macianghini, Tommaso 46-51 e nn, 52, 59
Magliabechi, Antonio 42nManenti, Giovanni 12, 18, 21, 46 e
n, 47n, 48, 58 e n, 59, 65-72 e nn, 74 e n, 78, 81, 92, 108n, 113-114, 277
Manenti, Iacomo 67nManetti, Antonio 178 e nManetti, Giovanni 69 e nManilio, Sebastiano 181nMantovani, Lilia 193nMarchesi, Concetto 66nMarcolini, Francesco 67nMargarito, Paola 69nMarroni, Sergio 176nMartelli, Mario 117n, 175n, 177nMasaro, Carla 36n, 128n, 176nMascheroni, Carla 66nMasi, Giorgio 23, 32nMassimiliano I, imperatore 54nMatarrese, Tina 156n, 168nMaufer, Petrus 118Mazzuchelli, Giovanni Maria19 e
n, 20Mazzuoli, Giovanni (detto lo Stra-
dino) 36-37nn, 128n, 176nMedici, Cosimo I de’, granduca di
Toscana 36-37nnMedici, Cosimo de’, detto il Vec-
chio 105, 178Medici, Lorenzo de’, detto il Ma-
gnifico 169Medici, Lorenzo de’, detto il Gio-
vane 70 Medici Orsini, Alfonsina 70 e nMegna, Paola 109nMelfi, Eduardo 21, 23, 45n, 46 e n,
47, 51n, 104nMelzi, Gaetano 75n, 118nMenato vedi Alvarotti Marco Au-
relioMenato, Marco 66n
Michelangelo di Cristofano da Vol-terra 128n, 176n
Milani, Matteo 66nMilchsack, Gustav 175nMolini, Giuseppe 32nMolza, Francesco 43nMoncallero, Giuseppe Lorenzo
70nMondino dei Liucci 182 e n, 183,
184nMoreni, Domenico 35nMorgiani, Lorenzo 32nMussini Sacchi, Maria Pia 193n
Nardi, Iacopo 44n, 175nNavarra, Pedro 107-108, 183nNegri, Giulio 19 e n, 42 e n, 43nNiccolò Cieco da Arezzo 80 e n,
97n, 196nNicolini da Sabbio, Cornelio 67nNicolini da Sabbio, Giovanni An-
tonio 12, 59, 61 e n, 64n, 65 e n, 66, 67 e n, 69n, 82, 85, 112, 184
Nicolini da Sabbio, Pietro 64n, 67 e n
Nicolini da Sabbio, Stefano 67nNotturno Napoletano 39
Olimpo da Sassoferrato 39Omero 58, 277Ong, Walter J. 189n, 201n, 206Orazio Flacco, Quinto 110nOriolo, Filippo 31 e nOrvieto, Paolo 168-169nn, 177nOvidio Nasone, Publio 175n
Pacini, Bernardo 38 e n, 46 e n, 47n
Padoan, Giorgio 68nPaitoni, Jacopomaria 66nPalmieri, Matteo 23, 24n, 104-105,
178, 232Panciatichi, Gualtieri 57-58n, 277
indice dei nomi 317
Paoli, Sebastiano 167nPapini, Gianni A. 176nParodi, Ernesto Giacomo 176nParrochi, Alessandro 70nPasini, Matteo 63, 64 e n, 65Passerini, Luigi 58nPeri, Marco 40n, 47nPeirone, Claudia 176n Perrotta, Annalisa 196nPetrarca, Francesco 22, 165n, 175n,
188, 196Pieri, Marzia 196nPiero di Simone 67nPiscini, Angela 57nPitagora 110nPoliziano, Angelo Ambrogini detto
il 14, 109n, 165n, 168n, 169 e n, 170, 172, 177n
Pozzi, Giovanni 155nProcaccioli, Paolo 80n, 148n, 196nPucci, Antonio 20n, 44n, 175, 187
e nPulci, Luca 43nPulci, Luigi 13, 41 e n, 43n, 45,
56n, 120, 138, 148n, 156n, 157, 165-166nn, 168 e n, 169n, 175n, 177n, 179
Quadrio, Francesco Saverio 19 e n, 20n, 194, 195n
Rajna, Pio 9, 19 e n, 75n, 77-78nn, 85, 87, 117-118nn, 119 e n, 121n, 123n, 135n, 145n, 195 e n
Renier, Rodolfo 9, 11, 13, 20 e n, 21-23, 24n, 29n, 30n, 31, 39 e n, 40 e n, 41n, 45n, 46 e n, 47, 48, 51n, 53, 55, 59, 68, 74n, 75n, 81 e n, 85 e n, 100, 103, 104 e n, 105, 173, 176n, 178n, 242
Rhodes, Dennis E. 32n, 45n, 58nRoggero, Marina 118nRohlfs, Gerhald 74n
Romei, Danilo 43n, 71n, 193nRoncaglia, Aurelio 120nRosselli, Alessandro di Francesco
32Rossi, Antonio 39 e n, 46nRossi, Vittorio 68n, 70n, 71nRiccò, Laura 58n, 80-81nnRidolfi, Roberto 69nRusconi, Roberto 80nRuzante vedi Beolco Angelo
Sacchetti, Francesco 166nSalviati, Leonardo 164nSandal, Ennio 66, 67nSannazaro, Iacopo 24, 25 e n, 26 e
n, 192Sanudo, Marin 29 e n, 30 e n, 49n,
55n, 58, 68 e n, 70n, 187n, 191, 193
Sasso, Panfilo 22, 39, 43nSavonarola, Girolamo 79 e n, 80n,
93n, 109n, 111n, 189n, 204nSaxl, Fritz 182nScala, Bartolomeo 105, 178, 232Scarabello, Giovanni 69nSchizzerotto, Giancarlo 33-35nn,
37-38nn, 108n, 242Scipione, Publio Cornelio 176,
177n, 232Seneca, Lucio Anneo 175nSercambi, Giovanni 138nSermartelli, Bartolomeo 40n, 47nSessa, Melchiorre 67nSforza, Francesco 177n, 232Sforza, Galeazzo Maria 177nSingleton, Charles Southward 55nSoderini, Giovan Vittorio 138nSolmi, Edmondo 182nSorci, Giacomo de’ 107nSordi, Cristoforo da Forlì 20nStazio, Publio Papinio 110nStefani, Luigina 44n, 175nSteppich, Christoph J. 109n
318 I «Reali» dell’Altissimo
Stradino vedi Mazzuoli GiovanniStussi, Alfredo 118n
Tacuino, Giovanni 66 e n, 67Tavoni, Mirko 204nTebaldeo, Antonio 22, 43n, 195nTesta, Enrico 204nTiraboschi, Girolamo 19 e nTizi, Marco 92nTorrentino, Lorenzo 35 e n, 38n, 55Tosi, Paolo Antonio 75n, 118nTrifone, Paolo 204nTrovato, Paolo 25n, 112nTubini, Antonio 39, 40n
Unico Aretino vedi Accolti Bernar-do
Vaccaro, Emerenziana 65nValenti, Cristina 58nVandelli, Giuseppe 118n, 127 e n,
130n, 132n, 134nVarchi, Benedetto 22 e n, 43-44,
97n, 164n, 167nVàrvaro, Alberto 187n
Vasari, Giorgio 184nVentrone, Paola 55n, 80n, 97n,
148n, 175n, 177n, 196 e nVerino, Michele 80nVianello, Daniele 58n, 68-69nn,
71nVilloresi, Marco 28n, 32n, 57n, 78n,
105n, 118-119nn, 128n, 176nVioli, Lorenzo 70nVirgilio Marone, Publio 58,
276-277Visani, Oriana 75nVitoni, Ventura 58n
Winger, Howard 65n
Zappella, Giuseppina 65nZeno, Apostolo 24Zinelli, Fabio 66nZoppino, Niccolò 57Zuan Polo vedi Liompardi Zuan
PoloZucchetta, Bernardo 38 e n, 46nZumthor, Paul 191n, 196n, 201n,
203n