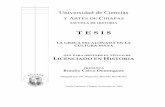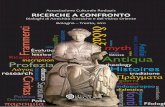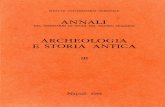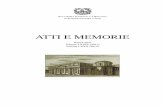I GIS nella ricostruzione e valorizzazione del paesaggio antico
Origini dell’architettura greca, in Architettura del mondo antico
Transcript of Origini dell’architettura greca, in Architettura del mondo antico
IntroduzioneLa parola «architettura» risale all’antica Grecia e fu considerata da Plato-
ne «la più esatta e scientifica delle arti», perché fondata sulla misura. Comeunico testo specifico sopravvissuto, il De architectura di Vitruvio è tuttora fon-damentale nel comprendere l’architettura antica, documentando la ripresadella trattatistica greca a Roma e precisando, tra l’altro, l’essenziale doverosolegame tra costruzione e ragione («ex fabrica et ratiocinatione»). La termino-logia vitruviana da secoli è stata recepita in tutte le lingue europee, soprattut-to per gli ordini architettonici, trattati nei libri III e IV insieme agli edifici sa-cri, che costituirono l’impegno primario per gli architetti, che poi ne utilizza-rono le norme progettuali anche nelle altre tipologie.
Il tempio antico faceva parte del recinto sacro (temenos), in gran parte acielo aperto. Almeno fin dal VII secolo a.C. la posizione dell’altare – elemen-to essenziale del culto – è attestata di fronte a quello che noi definiamo tem-pio e che invece, per i Greci, era la cella (naos), o casa (oikos), del dio, corri-spondente all’abitazione con focolare (aedes) dei Romani. Il temenos era dun-que distinto dal naos, che ospitava la statua di culto ma non i sacrifici, diver-samente dalle chiese cristiane che, non a caso, hanno in genere orientamentoopposto ai templi e l’altare all’interno, sempre però rivolto a oriente verso ilsole che nasce, allora considerato simbolo di resurrezione. Da temenos (tèm-no: tagliare) derivano i termini latini templum, per un terreno dedicato ad unadivinità o il suo santuario (fanum, opposto a profanum), e tempus, per il tem-po misurabile legato alla vita umana, distinto da quello infinito e continuo(Aion o Aeternitas)1. Molti spazi sacri erano delimitati da semplici cippi in pie-
5
1 Gruben 1962; Lawrence 1996; Rocco 1994; Gruben 1996; D. Mertens, Tempio, in EAA; Roc-co 2002; Hellmann 2002; Rocco 2003. Con il termine greco architecton Plauto (Poenulus, 1100) in-dicava il tessitore d’inganni, interpretando la diffidenza italica per la raffinata cultura greca. Templumdeum in Virgilio (Georg., II, 148) era il Campidoglio. Anche la «curia, templum publici consilii» (Ci-cerone; Virgilio, Aen., VII, 174), era così definita perché consacrata dall’augure. Aedes o aedis era ilfocolare (da aestus, calore), abitazione, o vano della casa (Plauto, Casina, 662). Domus indica casa co-me sede, mentre aedes indica piuttosto l’edificio materiale, da cui aedifico, aedificator; G. Ortolani,
1. Ordine dorico del tempio di Egina, particolare (da A. Furtwangler, Aegina: Das Heilig-tum der Aphaia, München 1906).2. Tipologie dei templi secondo Vitruvio (ed. a cura di P. Gros, Torino 1997): in antis, pro-stilo, anfiprostilo, periptero, pseudodiptero, diptero.
6 Parte prima. L’architettura greca
sima rampante mutuli lacunari
sima
triglifo
metopa
regula
taenia
abaco
anuli
hypotrachelion
guttaeechino
crepidoma
stilobate
Parte prima. L’architettura greca 7tra (oroi), come ad Atene possiamo trovare sull’Agorà: uno spazio di incontroal centro della città, destinato al commercio e poi alla vita pubblica, equiva-lente al Foro dei Romani. L’ingresso al santuario poteva essere evidenziato dapropilei di ingresso, come sull’Acropoli di Atene, e all’interno erano costruitiedifici sia votivi, come i thesàuroi per i doni delle diverse città-stato (poleis),sia funzionali, come le sale per banchetti (hestiatòria o andrònes) e i portici(stoai).
Anche per definire le planimetrie dei templi, il De architectura rimane untesto fondamentale. Vitruvio (III, 2) inizia dal tempio in antis, con le colonne(styloi) poste tra le testate (ante) dei muri laterali della cella, prolungate a latodel vano di accesso (pronao). Nei templi prostilo e anfiprostilo si ha un’ulte-riore protezione e decorazione del vano rettangolare della cella, con un co-lonnato (prostòon) sulla fronte d’ingresso o simmetrico sulle due fronti. Il tem-pio periptero è la forma più diffusa per gli edifici di grandi dimensioni, pre-sentando il colonnato (peristasi o ptèron) tutt’intorno, mentre lo pseudodip-tero è una variazione del periptero, con il colonnato posto a doppia distanzadalla cella, e l’hypaethros è così grande da rendere impossibile la copertura del-la cella. Solo tra le tipologie anomale, Vitruvio (IV, 8,6) ricorda il tipo pseu-doperiptero, diffusissimo in età ellenistica e romana, dove le pareti della cellasono poste tra le colonne per ampliarne lo spazio: «removentes parietes aediset adplicantes ad intercolumnia pteromatos». Il tipo a semplice sala (oikos),sviluppato dalla casa originaria e con eventuali colonne interne, era quasiscomparso all’epoca di Vitruvio, che non lo menziona. La tipica reiterazionedi queste rigorose tipologie era compensata dalla varietà dei colori applicati,contrastanti con l’uniforme tonalità di marmo o pietra che oggi viene perce-pita nei resti di templi e sculture antiche2.
L’immagine del tempo e dello spazio nella Roma di Augusto, in Via del Corso: una strada lunga 2000anni, Roma 1999, pp. 47-56.
2 F.M. Billot, Recherches aux XVIIIe et XIXe siècles sur la polychromie de l’architecture grecque,in Paris-Rome-Athenes: Le voyage en Grèce des architectes français aux XIXe et XXe siècles, Paris 1982,pp. 61-125; I colori del bianco 2004.
8
Capitolo primo Origini dell’architettura greca
La prima architettura monumentale in Europa: Creta e MiceneConsiderando le origini dell’architettura europea, riscontriamo come il mi-
to, riportato da Apollodoro (Bibl., III, 1,1), di Europa figlia del re di Tiro, ra-pita da Zeus e portata a Creta, dove generò Minosse, faccia riferimento al rea-le percorso della civiltà che, attraverso le rotte commerciali del Levante, avreb-be raggiunto per poi diffondere sul continente, dopo averli recepiti, prodottie maestranze dall’Oriente. La ricerca della sorella Europa portò poi il fenicioCadmo fino a Tebe in Beozia, ove avrebbe costruito le mura ciclopiche e in-trodotto l’alfabeto (allusione al ruolo svolto dai Fenici nella rinascita dellaGrecia dal X secolo a.C.)1. Già dal 2600 a.C., però, scambi di merci testimo-niano contatti tra Creta e l’Egitto, distante circa 500 km2.
Della civiltà cretese, denominata minoica, si conservano soprattutto i restidi grandiose residenze in cui i sovrani raccoglievano il surplus della produzio-ne agricola, essenziale in un clima a precipitazioni irregolari. Lo sviluppo del-l’agricoltura, sfruttando non solo i terreni pianeggianti per i cereali ma anchequelli in pendenza per produrre olio e vino, incrementò risorse e popolazionedella montuosa Creta. I palazzi cretesi, centri di potere e culto, dopo ripetutiterremoti furono grandiosamente ricostruiti nel periodo di maggiore ricchez-za, detto neopalaziale (1640-1530 a.C.). Somiglianze con palazzi egizi o meso-potamici, ad esempio a Mari, sono evidenti nelle planimetrie accentrate su cor-tili, con magazzini e laboratori che ne sottolineano il ruolo di raccolta e redi-stribuzione dei beni3. Anche bagni, affreschi e rivestimenti parietali o pavi-
1 Il mito di Europa e Cadmo (Plinio, VIII, 196), di cui dubitava anche Erodoto (IV, 45), riflettepiù recenti commerci fenici: G. Boffa, Erodoto (V 57-59) e I Gefirei, in «Studi di Antichità», 11, 1998,pp. 9-23; A. Di Vita, I Fenici a Creta: Kommos, i «troni di Astarte» a Phalasarna e la rotta delle isole,in «Annuario Scuola Archeologica Italiana di Atene», 70-71, 1998, pp. 175-203; L’universo fenicio,a cura di M. Gras, P. Rouillard, F. Teixidor, Torino 2000; N. Cocuzza, Palazzo, Creta e mondo mi-ceneo, in EAA; Id., Mondo Egeo, in Enciclopedia Archeologica, II, Roma 2002, pp. 64-69.
2 In estate il vento meltèmi favoriva la navigazione diretta, altrimenti si costeggiava la Palestina ela Siria. L’esteso sviluppo costiero incoraggiò la marineria nell’Egeo fin dall’VIII millennio a.C., conil commercio dell’ossidiana di Milo, fondamentale prima della metallurgia.
3 P.M. Day, D.E. Wilson, Landscapes of memory, craft and power in Prepalatial and Protopalatial
I. Origini dell’architettura greca 9mentali, in calcare o gesso alabastrino, trovano confronti in Oriente, come pu-re l’uso di registrare con sigilli e poi testi scritti ogni atto amministrativo4.Un’iscrizione di Amenhotep III (1390-1351 a.C.) nel tempio di Kom-el-Hetanricorda un viaggio dei sovrani fino a Micene (Mukanu), dove sono stati ritrova-ti loro cartigli in faïence (ceramica vetrificata). Nel palazzo dello stesso faraonea Malkata, a ovest di Tebe, i soffitti erano decorati a spirali intrecciate analoghea quelle del palazzo di Cnosso e che saranno riprese, intorno al 1300 a.C., sulsoffitto di un vano sepolcrale del «tesoro dei Mini» a Orchòmenos in Beozia5.
Tra i palazzi di Creta spiccano quelli di Mallià (7.600 mq), Festòs (6.500mq) e, soprattutto, quello di Cnosso (13.000 mq), vicino all’attuale Herakleion(Candia veneziana e Chandax saracena). Tra i segni di cava sui blocchi mura-ri si riconosce l’ascia bipenne (labrys), simbolo orientale di potere che sugge-risce l’etimologia del labirinto, legato al mito di Minosse6. Ampi piazzali gra-donati, configurati come spazi teatrali e con percorsi cerimoniali messi in ri-salto sulle pavimentazioni in pietra, davano accesso ai palazzi, confermando-ne il ruolo come centri di aggregazione ‘politica’ e sacrale, e non solo di resi-denza dei sovrani. Il «teatro» di Cnosso, posto a conclusione della strada pro-veniente dall’abitato, sembrerebbe destinato ai sudditi piuttosto che ai visita-tori esterni, che dovevano invece provenire dal porto di Poros (odierna He-rakleion). A Cnosso era forse casuale l’orientamento a est della sala del tronoche, come l’annesso bacino d’acqua e la cripta a pilastri, poteva essere desti-nata al culto, esercitato da una sacerdotessa o da un re-sacerdote. Da un af-fresco di Cnosso, come da un vaso (rython) da Zakro e da lamine d’oro da Mi-cene, forse relative ad altari, fu ipotizzata una tripartizione dei vani sacri, co-me nei templi etruschi. Piuttosto che a strutture architettoniche, però, la reli-gione minoica sembrerebbe intimamente legata alla natura, come nelle grottesacre o nei «santuari delle vette»7.
Quando l’isola era ormai dominata dall’aristocrazia guerriera micenea, allacui conquista allude il mito del Minotauro ucciso da Teseo, a ovest di Festòsfu realizzata la ‘Villa’ di Haghia Triada, dove nella seconda metà del XIV seco-lo a.C. un porticato a due piani sembra anticipare la stoà greca. L’architetturadomestica è illustrata anche da modelli in terracotta, ora al museo di Hera-kleion, tra i quali il «mosaico» con facciate di abitazioni e quello da Arkhanes(ca. 1600 a.C.) di una casa a due piani con loggia a colonna e balcone8. L’imma-
Knossos, in Labyrinth Revisited: Rethinking ‘Minoan’ Archaeology, a cura di Y. Hamilakis, Oxford2002, pp. 143-166.
4 Gli affreschi nella tomba di Rekhmire, visir di Tuthmosis III (1490-1436 a.C.), mostrano tri-butari cretesi e cicladici: W. Stevenson Smith, The Art and Architecture of Ancient Egypt, Har-mondsworth 1988, pp. 244-245.
5 Ivi, p. 289; Lawrence 1996, pp. 19, 41; Pausania, IX, 38,2.6 Knossos: Palace, City, State («BSA» Studies, 12), a cura di G. Cadogan et al., London 2005; Ciot-
ta 2005, pp. 105-118. Oltre che come sigla dei tagliapietre, con valore sacrale la bipenne era ripro-dotta in scala monumentale o in amuleti.
7 Ivi, pp. 174-180. Arthur Evans ipotizzò re-sacerdoti, come il wanax nei testi micenei (anax inOmero), e figure femminili legate agli animali, denominate con l’epiteto di Artemide pòtnia theron(signora delle belve, Iliade, XXI, 470).
8 Lawrence 1996, pp. 16-17; Ciotta 2005, pp. 125-126. I modelli integrano i resti di comuni abi-
gine di un centro abitato minoico, con case a più piani e in buono stato di con-servazione, si può avere negli scavi di Akrotiri, nell’isola di Santorini-Thera.Verso il 1520 a.C. una violenta eruzione, forse origine della leggenda di Atlan-tide, ha conservato una «Pompei» minoica, con abitazioni servite da strade ac-ciottolate larghe 2-3 m, vicoli pedonali e condotti coperti per lo scarico delleacque: un insediamento legato ai traffici marittimi e diverso dalle aree a pro-duzione agricola, ove il potere era concentrato nelle mani dell’aristocrazia deipalazzi9. La violenta eruzione, con ondate di tsunami, la probabile distruzio-ne della flotta e la salinizzazione dei terreni costieri, fece ipotizzare a Spiro Ma-rinatos un legame con il declino di Creta e, quasi un secolo dopo, la conqui-sta micenea, forse favorita anche dalla prepotente supremazia di Cnosso suglialtri centri. Ritrovamenti archeologici documentano anche in Italia frequenticontatti commerciali con l’Egeo, celebrati negli antichi miti, soprattuttonell’Odissea. Oltre alle più vicine coste di Puglia e Lucania, i commercianti mi-cenei privilegiarono le zone minerarie in Sicilia, Eolie, Sardegna ed Etruria,come poi avvenne nella colonizzazione dell’VIII-VII secolo a.C.10.
L’architettura micenea prosegue quella minoica introducendo costruzionia grandi blocchi di pietra, soprattutto nelle fortificazioni, assenti a Creta per-ché già padrona dei mari11. Particolarmente ricchi furono i ritrovamenti nel-l’Argolide, soprattutto a Micene «ricca in oro», come confermarono gli scavidi Heinrich Schliemann nel 1876. La tradizione antica, nata nella povertà tec-nologica dell’età «eroica», attribuiva all’opera dei Ciclopi le mura di Micenee Tirinto «con massi non lavorati, [...] di dimensioni tali che due buoi non riu-scirebbero a spostarne il più piccolo» (Pausania, II, 16,5; 25,8). Le cittadelleaccoglievano residenze accentrate sul mègaron, centro della vita familiare e uf-ficiale del sovrano, preceduto da vestibolo, pronao con colonne in antis e cor-te antistante. A Tirinto, dove fu trovato un fregio in alabastro (probabilmen-te da Creta) con inserti in vetro azzurro, il mègaron accoglieva il trono, che aMicene era nella sala antistante12.
Nel mègaron (11,20 x 12,90 m) del palazzo di Nestore a Pylos, in Messenia,quattro colonne in legno a 32 scanalature, poste attorno al grande focolare cir-colare (eschàra), sostenevano un lucernaio. Le dimensioni dell’eschàra, e pic-
tazioni scavati a Creta, come a Mallia (quartiere «mu») o a Gournià, messa in luce nel 1901-1904, ivi,pp. 82-83, 160-162.
9 Ivi, pp. 225-238; C.G. Doumas, Thera, in EAA. Akrotiri fu coperta da un primo strato di po-mice di 3-4 m – che protesse gli affreschi, in parte al Museo nazionale di Atene e legati anche alleesplorazioni nel Nord Africa – e poi sepolta da cenere vulcanica, tipo pozzolana (tephra).
10 L. Vagnetti, Minoico-Micenea, civiltà e arte, in EAA; Ead., Primi contatti fra il mondo minoico-miceneo e il Mediterraneo occidentale, in I Greci in Occidente 1996, pp. 109-116.
11 «Minosse fu il primo [...] ad avere una flotta e dominare il mare (talassocrazia) ora greco [...]eliminando per quanto poté la pirateria, per meglio ricevere i tributi. [...] e la navigazione tra i po-poli si sviluppò» (Tucidide, I, 4; I, 8).
12 K. Kilian, Tirinto, in EAA; J. Maran, Das Mègaron im Mègaron. Zur Datierung und Funktiondes Antenbaus im Mykenischen Palast von Tiryns, in «AA», 2000, pp. 1-16; J.C. Wright, A Survey ofEvidence for Feasting in Mycenaean Society, in «Hesperia», 73, 2004, pp. 133-177; Ciotta 2005, pp.256-284.
10 Parte prima. L’architettura greca
3. Lamina d’oro da Micene con altareo tempietto tripartito.4. Haghia Triada, resti della «stoà»,(disegno di S. Zenatello, SAIA).5. Micene, planimetria del palazzo (darilievo «BSA»).
I. Origini dell’architettura greca 11
9-10. Micene, colonna con felini affrontati in posa araldica su sigillo in corniola nel museoe sulla Porta dei Leoni.
7. Atena e Ciclope (da Furtwangler e Rei-chold).
8. Tirinto, «casamatta» a sud-est della cit-tadella.
6. Herakleion, museo, «mosaico» con facciate di abitazioni minoiche (da A.J. Evans, ThePalace of Minos at Knossos, London 1921-1936).
12 Parte prima. L’architettura greca
I. Origini dell’architettura greca 13cole conche per libagioni accanto al trono, suggeriscono il ruolo religioso delsovrano e, di fatto, la cella dei templi greci manterrà lo schema del mègaron,che esaltava il ruolo di aggregazione del focolare, cuore della comunità, ovegià Vitruvio (II, 1,2) ritrovava l’origine della società. L’appartamento della re-gina era fornito di sala da bagno con due pithoi (giare alte 1,20 m) sulla pare-te e una vasca (larnax) in terracotta, mentre a Tirinto un vano dal fondo mo-nolitico era destinato al bagno. Le murature in pietrame erano irrobustite datravi lignee, come a Creta e nell’architettura ittita, richiamata a Tirinto anchedai tagli con seghe a pendolo dei conci in calcare13.
Nelle mura di Micene, attorno all’acropoli naturale (m 278) stretta tra imonti Hagios Elias e Zara, la Porta dei Leoni e la posterla a nord furono pro-tette sulla destra da un bastione, realizzato in modo da colpire gli attaccantidal lato ove impugnavano l’arma, non protetto da scudo. La Porta dei Leonie il Tesoro di Atreo, realizzati forse da uno stesso sovrano intorno al 1240 a.C.,presentano apparati decorativi di particolare interesse. La porta, infatti, sulmassiccio architrave in breccia è sormontata da una lastra triangolare in calca-re, decorata con una colonna affiancata da due leonesse disposte in posa aral-dica, come nei sigilli in pietre dure, mentre le teste erano probabilmente inmarmo colorato. La colonna, con la caratteristica rastrematura verso il bassoe il capitello doricheggiante sormontato dalle testate di quattro travetti cilin-drici, richiama quelle dei palazzi minoici o le loro raffigurazioni votive in mi-niatura, simbolo di forza e stabilità.
Il Tesoro di Atreo, così chiamato dall’accenno di Pausania (II, 16, 6), co-stituisce la più imponente tomba micenea, del tipo a tholos già diffuso anchea Creta, realizzata con filari in breccia regolarizzati con il martello e, sulla por-ta, anche con la sega. Una camera circolare sotterranea (thalamos) del diame-tro di 14,5 m, chiusa da una copertura ogivale a massi aggettanti e fiancheg-giata da un vano minore, era accessibile da un corridoio (dromos) scoperto.Un portale rastremato, alto 5,40 m, era arricchito con marmi colorati da Ky-prianon, sulla costa orientale del Tenaro, con due semicolonne in marmo ver-de rastremate in basso e riccamente decorate sul fusto e sul capitello, raccor-dato alla colonna da una corona di foglie. Un’apertura triangolare alleggerivail carico sul massiccio architrave (di circa 100 t) ed era chiusa da una lastra inmarmo rosso decorato a spirali e posta su un fregio con decorazione a semi-rosette, motivo orientale diffuso nel mondo cretese e miceneo14.
La conoscenza del mondo miceneo fu rivoluzionata nel 1952 dalla decifra-zione della scrittura lineare B da parte dell’architetto Michael Ventris, che du-rante la guerra aveva lavorato alla decrittazione dei codici tedeschi. La scoper-
13 Ivi, pp. 291-298; P. Neve, The Great Temple in Bogazköy-Hattusa, in Across the Anatolian Pla-teau: Readings in the Archaeology of Ancient Turkey, a cura di D.C. Hopkins (ASOR, 57, 2000), Bo-ston 2002, pp. 77-98. Anche nel primo palazzo di Festòs sono state riconosciute impronte di travid’olivo, poi poco usate per il maggior uso di pietra tagliata. Se tali rinforzi saranno usati nel Medioevoe oltre, non dipende certo dalle raccomandazioni di Vitruvio, I, 5,3.
14 Lawrence 1996, pp. 30-40, 20, 48-52. Perni sulla pseudo cupola interna suggeriscono decora-zioni con rosette in bronzo.
14 Parte prima. L’architettura greca
13-14. Londra, British Mu-seum, restituzione grafica eframmenti del portale del Te-soro di Atreo a Micene.
11-12. Semi-rosetta su batti-loro contemporaneo dall’In-dia e su fregio dal Palazzo diCnosso (da A.J. Evans, ThePalace of Minos at knossos,London 1921-1936).
ta accertò l’appartenenza della lingua al ceppo greco, sminuendo il ruolo dellamigrazione dorica dal nord della Grecia sul crollo della civiltà micenea che, purnelle concause dei mutamenti negli armamenti in ferro e nella strategia, con lafine dei carri da guerra dell’aristocrazia dell’Età del bronzo15, ebbe origine dalcollasso dell’impero ittita intorno al 1200 a.C. I Frigi e altre genti sulle coste diSiria e Asia Minore, i «popoli del mare» ricordati dalle cronache egizie, ormaisvincolati dal potere centrale, sciamarono per il Mediterraneo e, oltre alle di-struzioni dirette, ostacolando le rotte commerciali strozzarono una delle prin-cipali fonti di benessere. Proprio lo studio dei testi ittiti, come il trattato traMuwattalli II (ca. 1290-1272 a.C.), gran re di Hattusa, e Alaksandu, sovrano diWilusa, ha portato a identificare quest’ultima città periferica con quella chia-mata da Omero Ilios-Wilios o Troia, che da allora ha goduto di fama assai su-periore alla sua reale importanza16. Tucidide (I, 11-12) lucidamente vide nellaguerra di Troia un segnale di decadenza del mondo miceneo: «per la mancanzadi denaro queste epoche erano deboli e questi avvenimenti, assai più celebri deiprecedenti, si mostrano in realtà inferiori alla fama e alle tradizioni nate a ope-ra dei poeti».
L’architettura della fase più antica di Troia è meglio documentata a Polioch-ni, nell’antistante isola di Lemnos, dove gli scavi della Scuola archeologica ita-liana di Atene hanno messo in luce il più antico insediamento urbano sul terri-torio europeo, strategicamente posto sulle rotte commerciali tra Egeo e MarNero. Dal 3000 al 1500 a.C. l’agglomerato protetto da mura fu organizzato at-torno a due piazze pavimentate, con magazzini per cereali, uno spazio con se-dili in pietra e tribuna per oratori che sembrano suggerire una precisa organiz-zazione sociale17.
Origini del tempio grecoCome suggeriva Vitruvio (II, 1,3), l’architettura monumentale ebbe origi-
ne da edifici in argilla e legno derivati dalla primitiva capanna dell’epoca eroi-ca. Proprio le precarie strutture abitative del Medioevo ellenico, subentrate aipalazzi minoici e micenei dove a volte erano già usate tegole, avevano neces-sità di coperture a falde inclinate (proclinatis tectis) per allontanare la pioggia(stillicidia) in occasione delle tempeste invernali18. Alcuni templi, in effetti, fu-
I. Origini dell’architettura greca 15
15 Tucidide, I, 12; R. Drews, The End of the Bronze Age: Changes in Warfare and the Catastropheca. 1200 B.C., Princeton 1995, pp. 174-208; A. Schnapp-Gourbeillon, Aux origines de la Grèce: XIIIe-VIIIe siècles avant notre ère, la genèse du politique, Paris 2002.
16 F. Kolb, Troy VI: A Trading Center and Commercial City?, in «AJA», 108, 2004, pp. 577-613.Perfino il re Serse, alla vigilia dell’invasione della Grecia, si emozionò alla vista delle rovine di Troia(Erodoto, VII, 43).
17 L. Bernabò Brea, Poliochni: città preistorica nell’isola di Lemnos, I, II/1, Roma 1964, 1976.18 Rocco 2002, pp. 125-126. Omero descrive coperture piane (Od., X, 552) e a spioventi (Il.,
XXIII, 712). Secondo Varrone, i templi più antichi erano «modo testudinis facta» (Servio, Aen., I,505), come il tetto curvo delle capanne riprodotte nelle urne cinerarie di età villanoviana. Il terminetestudo indicherà poi la volta.
rono realizzati su più antichi fabbricati a terminazione curvilinea, indice diuna copertura a capanna. Sotto il tempio di Apollo Dafnephòros a Eretria,nell’isola di Eubea, furono identificate le fondazioni con basi in pietra di untempietto lungo 11 m, forse in rami di alloro, sacro al dio. Potrebbe però trat-tarsi di una delle case che poi, come nel resto del mondo greco, dal 700 a.C.ebbero una più funzionale pianta rettangolare. A questa capanna, anteriore al750, verso il 720-700 a.C. fu affiancata una monumentale struttura di 100 pie-di ionici (35 m), absidata e con sostegni centrali19.
L’origine del tempio greco è stata meglio precisata dallo scavo della tombamonumentale di Lefkandi, in Eubea, datata all’inizio del X secolo a.C. Lagrande capanna (10 x 45 m), poi coperta da un tumulo in terra, terminava adabside ed era suddivisa in cinque vani, con 67 sostegni esterni per il tetto, ade-guatamente distanziati per proteggere dagli agenti atmosferici le pareti in mal-ta argillosa e telaio in legno. Al centro di quella che appariva come una resi-denza reale, forse realizzata solo per i riti funerari, fu sepolta una coppia dalricco corredo e quattro cavalli20. Questo memoriale, o heroon, per un capo poiconsiderato protettore della comunità, costituisce il primo esempio certo diperistasi a colonne (columnarum circum aedem dispositio), la prestigiosa ca-ratteristica (aspectus habeat auctoritatem) dei templi antichi (Vitruvio, III, 3,9).
I resti dei più antichi edifici di culto in Grecia continentale mostrano la dif-fusione del tipo absidato o «a forcina», come a Lefkandi, mentre in Asia e a Cre-ta troviamo edifici quadrangolari a copertura piana, come nel VII secolo a.C. aDreros e Priniàs. Il tempio A di Priniàs (6 x 10 m) fu edificato verso il 625-620a.C. sulla fortezza naturale della Patela, lungo il percorso tra la costa nord equella sud di Creta. Senza peristasi né ordine architettonico, nell’edificio furo-no inserite sculture in pietra, ora al museo di Herakleion, come parte integran-te dell’architettura: due dee sul portale e un fregio, forse sugli ortostati di base,con cavalieri in parata21. Con sedili e focolare (eschàra) all’interno, questi primitempli accoglievano riti destinati ad una cerchia ristretta. Lo sviluppo dell’alta-re sollevato da terra (bomos) e posto di fronte al tempio riflette l’evoluzione del-la società greca verso la comunità della pòlis, con una prima partecipazione po-litica dei cittadini e una religione non più esclusiva del capo-eroe ricordato daOmero, il cui culto domestico era esercitato in rappresentanza dei sudditi22.Dopo le offerte «vegetariane» del mondo minoico-miceneo, sopravvissute nei
16 Parte prima. L’architettura greca
19 Gruben 1996, p. 392. La sacralità del sito fu confermata, nella prima metà del VII secolo a.C.,da un periptero di 6 x 19 colonne e, nel 509, da un tempio dorico (6 x 14 colonne; 19,15 x 46,40 m),distrutto dai Persiani nel 490 a.C.
20 Gruben 1996, pp. 390-391; J. de Waele, The Layout of the Lefkandi ‘Heroon’, in «BSA», 93, 1998,pp. 379-384. La sepoltura rivela i commerci, se non addirittura l’origine del defunto, dall’Oriente.
21 Gruben 1996, p. 404; L.W. Watrous, Crete and Egypt in the Seventh Century B.C.: Temple Aat Prinias, in Post Minoan Crete, a cura di W.G. Cavanagh et al. («BSA» Studies, 2), 1998, pp. 75-79;D. Palermo, Luoghi di culto sulla Patela di Priniàs, per la storia della città fra la tarda età del bronzo eil VII sec. a.C., in «Creta Antica», 2, 2001, pp. 159-167.
22 B. Fehr, The Greek temple in the early archaic period: meaning, use and social context, in«Hephaistos», 14, 1996, pp. 165-191. Dal 750 a.C. furono venerate antiche tombe attribuite ad eroi,originando culti locali diversi da quelli olimpici: C.M. Antonaccio, An Archaeology of Ancestors:
I. Origini dell’architettura greca 1715. Restituzione della reggia-sepolcro diLefkandi (da J.J. Coulton, in Lefkandi II: TheProtogeometric Building at Toumba, 2. The Ex-cavation, Architecture and Finds, in «BSA»,London 1993).16. C. Cesariano, Como 1521, illustrazione aVitruvio (II, 1): origini dell’architettura.
18 Parte prima. L’architettura greca
culti misterici, furono introdotti sacrifici di animali seguiti dal banchetto sacro,che rimase parte essenziale del culto: «Non è l’abbondanza del vino e dell’ar-rosto che crea la gioia [...] in un tempio, ma la speranza e la fiducia che il dio siapresente e gentilmente accetti le offerte» (Plutarco, Moralia). Dall’VIII secoloa.C., i templi ebbero in genere planimetrie rettangolari, raggiungendo anche i100 piedi (hekatonpedon) come a Samo, Eretria o all’Artemision scoperto adAno Mazaraki23. Il termine hekatonpedon fu usato da Omero per la gigantescapira funeraria di Patroclo (Iliade, 23, 164), le cui grandezza non volevano indi-care una precisa misura, ma una dimensione straordinaria, come il numero dicento buoi (ecatombe) nei sacrifici. Un’immediata continuità con il passato siritrova, a metà dell’VIII secolo a.C., nel tempio di Hera sul mègaron di Tirintoe alla fine del VII secolo in quello sul punto più elevato del palazzo di Micene,senza peristasi e con tetto a tegole24.
Nella solida precisione della pietra e poi del marmo, la capanna dei sovranidi età eroica fu quindi nobilitata ad ideale abitazione della divinità, richiama-ta dall’immagine di culto interna che, dai primi idoli in legno (xoana) e bronzosbalzato (sphyrelata), passò alla scala umana e al colossale25. In Mesopotamiao nell’impero ittita, la casa della divinità era invece inserita entro enormi com-plessi simili ai palazzi26, con corte antistante e copiosi depositi. Muri in mat-toni crudi su fondazioni in pietra erano ricoperti di affreschi, stucchi, basso-rilievi, o addirittura in bronzo, con grandi blocchi di base posti in verticale (or-tostati). Le architetture dei secoli VIII-VII a.C. trovano riscontri anche neimodelli votivi in terracotta, fin da quello del IX secolo a.C. da Archànes a Cre-ta, con un vano circolare a tetto conico, presentando però dubbi sulla loro na-tura templare o domestica, come quelli da Sellada27, dal santuario di Hera Ak-raia a Perachora (750-725 a.C.) o dall’Heraion di Argo, già considerato il pri-mo tempio dorico28.
Tomb Cult and Hero Cult in Early Greece, Lanham 1995; S. Alcock, Archaeologies of the Greek Past:Landscape, Monuments, and Memories, Cambridge 2002.
23 Nel periptero, in una gola a 1300 m vicino a Patrasso, lo schema absidato (ca. 27,50 x 7,50 m)appare anche nel pronao, con sei pali a semicerchio: Gruben 1996, p. 394; Barletta 2001, p. 34; M.Petropoulos, The Geometric Temple of Ano Mazaraki (Rakita) in Achaia during the Period of Coloni-zation, in Gli Achei 2002, pp. 143-164.
24 Barletta 2001, pp. 30-31; N.L. Klein, Evidence for the Archaic and Hellenistic Temples at My-cenae, in Peloponnesian Sanctuaries 2002, pp. 99-105. A Micene nel XIII secolo a.C., accanto ad unmègaron a sud del circolo di tombe reali, fu realizzato un tempietto con focolare centrale e un ripo-stiglio con idoli e serpenti in terracotta.
25 Xoanon rimase a indicare immagini sacre, come la statua di Zeus a Olimpia in oro e avorio:Strabone, VIII, 3,30. A.A. Donohue, The Greek images of the gods: considerations on terminology andmethodology, in «Hephaistos», 15, 1997, pp. 31-45. L’originalità dell’arte greca fu individuata nell’in-tegrare la mimesis egizia o assira con la phantasia: Filostrato, Vita di Apollonio di Tyana, VI, 19.
26 Cook 2004, nella descrizione del palazzo di Alcinoo (Od., VII, 81-102), riconosce richiami aipalazzi assiri.
27 Barletta 2001, pp. 40-46. Sul modello di Sellada (Thera), nel locale Museo archeologico, datatoal 650-625 a.C.: Storia Oxford 2003, p. 40; T.G. Schattner, Griechische Hausmodelle. Untersuchungenzur frühgriechischen Architektur («Athenische Mitteilungen», Beiheft 15), 1990, pp. 89-91, 210-217.
28 Ivi, pp. 22-26, 33-35. Verso il 650 a.C., quando il re Fidone, inventore di pesi e misure (Plinio,VII, 198), rese Argo la più forte polis del Peloponneso, un periptero (Vitruvio, IV, 1,3) di 5 o 6 x 14 co-
I. Origini dell’architettura greca 19
17. Priniàs, tempio A, restituzione del pro-spetto e planimetria (da L. Pernier, in«AJA», 1934).18. ????19. Origine lignea dell’ordine dorico (da J.Durm, Die Baukunst der Griechen, Leipzig1910).20. Thermo, tempio di Apollo, restituzionedella trabeazione (da G. Kawerau, 1908-1912).
Evoluzione dell’ordine architettonico: da Corinto a Corfù«Corinto, opulenta per i commerci marittimi, si trova sull’Istmo e control-
la due porti [Kenkreai e Lechaion], uno verso l’Asia, l’altro per l’Italia; facili-tando il commercio [...] senza la non facile navigazione attorno al capo Ma-lea» (Strabone, VIII, 6,20). La vocazione commerciale e artigianale di Corin-to contribuì, dopo il 680 a.C., all’introduzione delle tegole in terracotta, conuna maggiore solidità delle strutture architettoniche. Il sistema oggi detto«protocorinzio», a tegole piatte rialzate in un unico pezzo sulle giunture, ap-parve per primo in Grecia e confermerebbe antiche tradizioni che ricordava-no l’origine del frontone triangolare e della scultura in terracotta a Corinto29.
Per la scomparsa del primo santuario, distrutto verso il 560 a.C. per realiz-zare l’attuale tempio di Apollo, gli studi sulla più antica architettura di Corin-to si sono concentrati su quello di Isthmia30, sul passaggio per la Grecia con-tinentale ove, nel 582 a.C., furono istituiti giochi panellenici in onore di Posei-don. Del tempio (14 x 39 m), costruito prima del 650 a.C. e incendiato intor-no al 470 a.C., rimane il 20% dei blocchi e il 40% delle tegole. Già la cella pre-sentava proporzioni più massicce (rapporto di 1:4) degli hekatonpeda di Ere-tria o Samo (1:5), ma nella peristasi di 7 x 18 colonne le proporzioni della pian-ta si allargavano a 1:2,8. Alle colonne corrispondevano pilastri addossati almuro della cella a due navate, realizzato in regolari blocchi di pietra calcarea(poros) stuccati in superficie, tagliati in filari di uguale altezza (0,27 m), o iso-domi, larghi quanto il muro (0,55 m) e lunghi in media 0,82 m, con propor-zioni di circa 1:2:3; mentre nell’Età del bronzo i paramenti in pietra celavanofacce interne irregolari. Le tegole in stampi modulari (0,69 x 0,65 x 0,05 m),pesanti complessivamente circa 53 t, resero necessario rafforzare la strutturamuraria e i sostegni, passando così dal palo alla colonna in legno31. Negli ele-menti standard dei muri e in copertura, realizzati ante operam su un precisoprogetto, si precorreva il rigoroso razionalismo dell’architettura classica32. Nelsantuario è stato ritrovato anche un coevo bacino lustrale in marmo (pe-rirrhanterion), con vasca sostenuta da quattro fanciulle su leoni che preannun-cia i successivi sostegni architettonici figurati, quali cariatidi e telamoni.
Per un’area di scambio come la Corinzia appaiono naturali i legami conl’architettura fenicia ed egizia, come già Creta. Costruzioni con muri a filari
20 Parte prima. L’architettura greca
lonne fu costruito su un terrazzamento a grandi massi di età geometrica, già considerato miceneo: C.M.Antonaccio, Terraces, Tombs, and the Early Argive Heraion, in «Hesperia», 61, 1992, pp. 85-105.
29 Pindaro, Olimpiche, XIII, 21-22; Plinio, XXXV, 151; R.F. Rhodes, The earliest Greek archi-tecture in Corinth and the 7th century temple on Temple Hill, in Corinth 2003, pp. 85-94. Le tegolelaconiche (Hellmann 2002, pp. 306-308) appaiono dal 625 a.C. nel tempio di Artemis Orthia a Spar-ta, poi nell’Heraion a Olimpia, curve e con coppi e antefisse semicircolari.
30 Scoperto nel 1952, il tempio fu ricostruito nel V secolo a.C. Gruben 1996, pp. 406-408; E.R.Gebhard, The Archaic Temple at Isthmia: Techniques of Construction, in Archaische Griechische...2001, pp. 41-61.
31 Hellmann 2002, pp. 298-301.32 E. Østby, Der Ursprung der griechischen Tempelarchitektur und ihre Beziehungen mit Ägypten,
in Archaische Griechische... 2001, pp. 17-33.
regolari e capitelli proto-eolici, attestate nel Levante dal X secolo a.C., conva-lidano la fama degli artisti fenici immortalata da Omero e dalla Bibbia33. Giànel complesso funerario per il faraone Zoser (2630-2611 a.C.) a Saqqara, lapietra riprese a grande scala forme costruttive in mattoni crudi e legno espri-mendo, da allora, l’idea di duratura stabilità ispirata dalla volontà di memoriadel committente, legata a impegno fisico, intelligenza tecnologica e capacitàorganizzativa. Proprio in Egitto poi, per ridefinire i confini dopo le inonda-zioni del Nilo, sarebbe nata la geometria (Erodoto, II, 109).
La diffusione della tecnologia delle tegole tramite maestranze itineranti co-rinzie è accertata nel VII secolo a.C. solo nei santuari di Perachora e Delfi.Procedendo per percorsi autonomi nelle diverse aree, parallelamente allo svi-luppo degli ordini architettonici, le novità di Corinto furono invece elaborateda manodopera locale. In Grecia settentrionale, l’introduzione di terrecottearchitettoniche fu legata dalla tradizione ai figli di Dedalo che, emigrati daCreta a Sicione, 20 km a ovest di Corinto, si sarebbero poi trasferiti in Eto-lia34. L’artefice dell’Età del bronzo fu confuso con l’artista, o un gruppo di ar-tisti cretesi, presi a simbolo dello stile «dedalico», che nel VII secolo a.C. ma-nifestò la rinascita della scultura in Grecia35.
Nel santuario di Apollo a Thermo, in Etolia, sono stati riconosciuti edificisacri dall’Età del bronzo fino alle distruzioni (218 o 206 a.C.) di Filippo V diMacedonia. Del tempio periptero realizzato intorno al 625 a.C. rimangono lefondazioni della cella (7 x 32 m), in mattoni crudi su un crepidòma (base in pie-tra) a un solo gradino, con appoggi per colonne in legno larghe 0,70 m. All’in-terno correva una fila centrale di colonne, allineate con quelle della peristasi (5x 15) e distanziate di 2,60 m tra loro e dalla cella. Il tempio fu costruito senzapronao e con un profondo opistòdomo, ovvero la retrostante facciata cieca del-la cella che dava simmetria all’edificio. Il fregio in lastre di terracotta dipinta,conservate al Museo archeologico nazionale di Atene e già considerate comeprimo esempio certo di ordine dorico, sono ora però ipotizzate sulla cella36.
I. Origini dell’architettura greca 21
33 L’artista Hiram fu inviato dall’omonimo re di Tiro a Salomone per il tempio di Gerusalemme(I Re, VII, 13-46; Cron. II, 2-7, 15-17; Cron. IV, 1-17). La pietra squadrata (caput anguli) fu presa asimbolo di perfezione, durata e perfino del Messia (Salmo 117, 22-23). Il fenicio Cadmo fu conside-rato (Plinio, VII, 197) inventore delle cave. E. Stern, The Phoenician Architectural Elements in Pale-stine during the Late Iron Age and the Persian Period, in The Architecture of Ancient Israel from thePrehistoric to the Persian Period, a cura di A. Kempinski e R. Reich, Jerusalem 1992, pp. 302-309.
34 I miti su Dedalo e allievi (Plinio, XXXVI, 9) alludono al tragitto dell’arte da Creta alla Corin-zia, all’Etolia e in Sicilia. Diodoro Siculo (I, 97,5), citando le visite in Egitto di Solone, Platone, Pita-gora e Democrito ricordava come «le proporzioni delle antiche statue d’Egitto sono le stesse delleopere di Dedalo presso i Greci».
35 S.P. Morris, Daidalos and the Origins of Greek Art, Princeton 1995, pp. 153-154, rileva comeDedalo e Cadmo incarnassero gli aggettivi relativi a manualità e origini orientali. Dedalo, autore delLabirinto (Plinio, XXXVI, 85) e dello scudo di Achille (Iliade, XVIII, 590-92), discendente del reateniese Eretteo, fuggì a Creta e di lì a Camico in Sicilia, presso il re Kokalos (Pausania, VII, 4, 5-7;Apollodoro, Bibl., III, 15, 8).
36 Al mègaron A absidato (6 x 23 m), verso il X secolo a.C. fu affiancato il mègaron B (7 x 21,5m). Gruben 1962, p. 116; Id., 1996, pp. 392-394, 409; C. Antonetti, Il santuario apollineo di Termoin Etolia, in Mélanges Pierre Léveque, 4, a cura di M.-M. Mactoux, Paris 1990, pp. 1-27; I. Papapo-
21-22. Thermo, resti del tempio di Apollo da nord e planimetria (da Gruben 1962).
22 Parte prima. L’architettura greca
23-24. Corfù (Korkyra), restituzione di pianta e prospetto dell’Artemision (da G. Ro-denwaldt, H. Schleif, Korkyra I, Berlin 1939-1940).25-26. Corinto, tempio di Apollo, planimetria (da Lawrence 1996) e vista da sud-ovest.
I. Origini dell’architettura greca 23
Una significativa tappa degli influssi verso l’Adriatico, la Magna Grecia el’Etruria, è rappresentata dall’Artemision di Korkyra (Corfù), colonia fondatada Corinto nel 734 a.C. insieme a Siracusa, e che divenne poi cardine delle rot-te commerciali. Il tempio in pietra (22,4 x 47,6 m), realizzato verso il 580-570a.C. e studiato in base ai blocchi recuperati, fu impostato su una planimetriaquasi modulare di 8 x 17 colonne (alte 5 volte il diametro) poste a interassi di 3m, con i muri esterni della cella allineati sull’asse delle terzultime colonne, conil colonnato distaccato di due intercolumni che anticipa la tipologia poi defini-ta pseudodiptera. La cella, divisa in tre navate da un doppio ordine di colonnea sostegno della copertura, si concludeva in un ambiente chiuso definito ady-ton. Il capitello dorico, con l’abaco quadrangolare per l’appoggio dell’archi-trave e l’echino troncoconico rigonfio, presentava una corona di foglie a rac-cordo con la parte superiore (sommoscapo) della colonna. Il contrasto della tra-beazione in pietra con il tetto, ornato da una sima in terracotta policroma, eracompensato dai vivaci colori, come nelle sculture del frontone occidentale, conuna Gorgone (o Medusa) alta 3 m fiancheggiata da pantere e figure laterali37.
Le radicali novità apportate a Corinto trovarono a Korkyra pieno compi-mento in un’architettura in pietra coperta in terracotta, con l’ordine dorico or-mai codificato nei legami tra gli elementi canonici, con triglifi e mutuli (a quat-tro guttae sui triglifi e a tre sulle metope) che, in corrispondenza con gli assidelle colonne, determinavano una rigorosa interrelazione tra planimetria eprospetto. Dai primi edifici a capanna si passò ai mattoni crudi e legno (a ma-teriatura fabrili), le cui forme influenzeranno – per razionale citazione e nonderivazione diretta come, invece, nell’architettura della Licia – molti dettaglidegli ordini architettonici in pietra e marmo (in lapideis et marmoreis). Vitru-vio (IV, 2,2), poi, attribuiva l’originaria policromia degli elementi della tra-beazione all’esigenza di proteggere e decorare le terminazioni delle travi deitetti (uti nunc fiunt triglyphi) con cera colorata (cera caerulea). Nel VII secoloa.C. l’architettura templare si distacca nettamente dagli immediati preceden-ti, non distinguibili dalla capanna primitiva, richiamando semmai i prestigio-si modelli orientali o egizi. Per la teoria vitruviana, nei triglifi sopra l’architra-ve il fregio dorico ricorderebbe le testate delle travi trasversali poste sulla pe-ristasi. La triplice suddivisione verticale ha fatto pensare che i triglifi ricor-dassero travi realizzate con tavole legate tra loro, le trabes compactiles (Vitru-vio, IV, 7,4), ma sembrano ora prevalere ipotesi decorative. Ai triglifi si alter-nano le metope, decorate a rilievo o piane, forse destinate ad essere dipinte,come attestano i più antichi esempi in terracotta38. L’influenza dell’Artemision
24 Parte prima. L’architettura greca
stolou, Thermos, in EAA; Barletta 2001, pp. 38, 51, 67-69. Le metope (0,87 x 0,98 m), opera di mae-stranze locali, se non copie arcaizzanti, furono reintegrate in età ellenistica.
37 Gruben 1996, pp. 412-415; Barletta 2001, pp. 58, 62, 77; N. Marinatos, Medusa on the templeof Artemis at Corfu, in Archaische Griechische... 2001, pp. 83-88.
38 G. De Angelis d’Ossat, L’origine del triglifo, in «Rendiconti Pontificia Accademia Romana diArcheologia», XVIII, 1941-1942, pp. 117-133; Barletta 2001, pp. 63-75, 125-133, 130-133; Hellmann2002, pp. 130-142; H. Kienast, Zum dorischen Triglyphenfries, in «Athenische Mitteilungen», 117,2002, pp. 53-68; M. Wilson Jones, Tripods, Triglyphs, and the Origin of the Doric Frieze, in «AJA»,106, 2002, pp. 353-390. Le guttae ricorderebbero i perni di fissaggio.
di Corfù, nell’ordine architettonico e nello schema planimetrico con ampi spa-zi coperti, è riconoscibile soprattutto nelle colonie occidentali, da Siracusa, aSelinunte, a Paestum. Nei centri occidentali, infatti, si diffusero culti legatiall’agricoltura e al mondo sotterraneo che, rispetto a quelli olimpici, utilizza-vano maggiormente i vani interni, quali la cella con l’adyton, caratteristica deitempli siciliani, e l’ampia peristasi.
Un ritorno in patria delle esperienze maturate nelle colonie avvenne versoil 550 a.C. a Corinto, con la costruzione del tempio di Apollo sui resti di quel-lo del 680-670 a.C. Nonostante le distruzioni del console Lucio Mummio nel146 a.C., rimangono ancora in piedi sette colonne doriche monolitiche, alte6,40 m (4,15 volte il diametro) su un basamento (crepidoma) a quattro gra-doni, con prime tracce di curvatura del piano di appoggio delle colonne (sti-lobate). Le fondazioni, scavate nel poros in cui fu realizzato l’edificio (21,49 x53,82 m), rivelano un periptero di 6 x 15 colonne e due celle contrapposte, en-trambe con pronao distilo in antis. Il sistema di copertura, del tipo corinzio aembrici (kalyptères) triangolari terminanti in antefisse a palmetta e tegole pia-ne (strotères) con orlo rialzato, dagli inizi del V secolo a.C. avrà il maggior suc-cesso nell’architettura classica39. Le forme rigorose di Corinto porteranno, so-prattutto nel Peloponneso e nella Grecia continentale, ad una certa uniformitàdell’ordine dorico, riducendo gradualmente gli ornamenti.
I. Origini dell’architettura greca 25
39 Gruben 1962, pp. 151-152; Hellmann 2002, pp. 301-305; Ch.A. Pfaff, Archaic Corinthian ar-chitecture ca. 600 to 480 B.C., in Corinth 2003, pp. 95-140; N. Bookidis, R.S. Stroud, Apollo and theArchaic Temple at Corinth, in «Hesperia», 73, 2004, pp. 401-426.