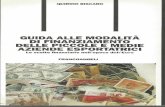Funzioni e modalità di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca:...
Transcript of Funzioni e modalità di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca:...
Copyright copy Universitagrave degli Studi di Cassino (Italy)ISSN 2037-0245ISBN 978-88-8317-073-7
Direttore Oronzo Pecere
Comitato scientificoMassimiliano Bassetti Daniele Bianconi Franco De Vivo Lucio Del CorsoJoseacute Antonio Fernaacutendez Delgado Paolo Fioretti Anatole Pierre FuksasAnna Maria Guerrieri Jacqueline Hamesse Alfredo Mario Morelli Paolo Odorico Inmaculada Peacuterez Martiacuten Filippo Ronconi Francesco Santi Francesco StellaAntonio Stramaglia Michael Winterbottom
EditingMaddalena Sparagna (coordinamento editoriale)Stella Migliarino
laquoSegno e Testoraquo egrave una rivista peer reviewed
Edizioni Universitagrave di CassinoCentro Editoriale di AteneoCampus Folcara ndash via SantrsquoAngelo in TheodiceI-03043 Cassino (FR)E-mail segnoetestounicasitTel +39 0776 299 3289
DistribuzioneBrepols PublishersBegijnhof 67 ndash B-2300 Turnhout (Belgium)E-mail infobrepolsnetwwwbrepolsnetTel +32 14 44 80 20 ndash Fax +32 14 42 89 19
Periodico annuale Autorizzazione del Tribunale di Cassino nr 7503 del 9-6-2003Direttore responsabile Oronzo Pecere
Finito di stampare nel mese di dicembre 2013presso Tipografia Tuderte srlLoc Torresquadrata 202I-06059 Todi (PG)
Funzioni e modalitagrave di trasmissionedelle notazioni numeriche
nella trattatistica matematica grecadue esempi paradigmatici
Fabio Acerbi
1 Il maestro il suo allievo il copista il correttore
Lo scopo di questo lavoro egrave presentare due passi dei Prolegomena ad Almagestum una compilazione anonima tuttora inedita nella sua inte-rezza1 redatta non prima dellrsquoinizio del VI secolo nella cerchia degli al-lievi del filosofo neoplatonico Ammonio Essa contiene lrsquounico lsquomanuale di logisticarsquo pervenutoci dallrsquoantichitagrave greca una descrizione dettagliata di come effettuare le operazioni aritmetiche elementari fra numeri non interi espressi nel sistema sessagesimale Si tratta se dobbiamo dar credito al loro autore del primo scritto che contenesse unrsquoesposizione compatta esclusivamente dedicata a tecniche di calcolo2 Lrsquoopera costituiva in tutta
1 Edizione di ciograve che precede il manuale di logistica con introduzione generale in Acerbi et al 2010 Quella del manuale saragrave approntata al termine del seminario di lettura in corso presso il Centre Alexandre Koyreacute di Parigi Un terminus post quem per la datazione del manuale egrave costituito dallrsquoattribuzione di un particolare metodo di calcolo a Siriano (morto ca 437) λέγεται δὲ ἡ εὕρεσις Συριανοῦ τοῦ μεγάλου φιλοσόφου laquosi dice che la scoperta sia di Siriano il grande filosoforaquo la sfumatura dubitativa fa supporre che non sussista una continuitagrave dottrinaria stretta fra la scoperta e la sua menzione nel manuale per quanto questrsquoultimo sia indubitabilmente un prodotto di scuola neoplatonico (ibid pp 59-66) ciograve suggerisce pertanto di spostarci da Atene ad Alessandria e di far passare almeno un paio di generazioni Personalmente sono convinto che nei Prolegomena leggiamo la trascrizione della parte iniziale di un corso di Ammonio sullrsquoAlmagesto di cui fa menzione Damascio apud Fozio Bibliotheca codex 181 127a8-10 Egrave registrata anche unrsquoosservazione astrono-mica di Ammonio (morto dopo il 517) effettuata con il fratello Eliodoro il 21 febbraio 503 essa fa parte di una serie trascritta immediatamente dopo i Prolegomena in tutti i manoscritti piugrave antichi vd Jones 2005
2 Le fonti riportano titoli di opere dedicate alle tecniche di moltiplicazione e divisione di grandi numeri come i Logistica di Magno menzionati da Eutocio (AOO III pp 25830-2601) Dello stesso argomento si occupava un trattato di Apollonio di Perge epitomato e commentato da Pappo in Collectio II che non abbiamo elementi per identificare con i Logistica attribuiti ad un Apollonio ed il cui 3ordm libro egrave citato a proposito del volume della sfera nella compilazione metrologica edita da Heiberg come Stereometrica II 34 1 (HOO
Fabio Acerbi124
evidenza un primer allrsquoesecuzione di queste operazioni di cui lrsquoAlmagesto fornisce sempre e soltanto i risultati egrave stata trasmessa a morsquo di introdu-zione al trattato tolemaico da uno solo dei rami della tradizione testuale di questrsquoultimo I Prolegomena non beneficiarono di una redazione defini-tiva anzi a tratti si ha lrsquoimpressione che quanto leggiamo sia poco piugrave che la trascrizione usci-ta dalle mani del tachigrafo Piugrave recensioni bizantine di cui una eseguita da un matematico competente e trasmessa da un grup-petto di codici i piugrave antichi dei quali riferibili al pieno del XIV secolo restituiscono un testo migliore specialmente dal punto di vista sintattico
I passi che discuterograve costituiscono due dei rarissimi esempi in cui possiamo seguire lrsquointera traiettoria delle interazioni fra notazione ma-tematica auctor che la impiega e la descrive tachigrafo che la trascrive in vivo copista che la riproduce a freddo recensore che la modifica discente che dovragrave necessariamente apprenderla con lrsquoaiuto di una rap-presentazione grafica (non sempre) conforme alla descrizione Lungo lo snodarsi di questa traiettoria si generano malintesi ed errori che tro-vano sfogo in zone di irrimediabile ambiguitagrave come le abbreviazioni e le unitagrave paratestuali (diagrammi tabelle liste numeriche organizzate) Inoltre uno dei due passi contiene un termine pertinente al lessico paleografico non attestato altrove con questo significato il participio perfetto medio-passivo ἐξεσμένον per designare unrsquolaquoabbreviazioneraquo
Nella prossima sezione propongo una suddivisione tipologica dei paratesti che accompagnano o completano gli scritti matematici Nella sezione successiva mi concentro sulle disposizioni tabellari delle opera-zioni aritmetiche elementari elencando le opere e i manoscritti dove siano reperibili descrivo anche i tratti salienti del sistema sessagesimale della notazione numerica associata e degli algoritmi di moltiplicazione e di divisione Queste due sezioni presentano materiale preliminare necessario per una comprensione piena delle testimonianze la sezione finale contiene la loro analisi specifica
2 Paratesti matematici una tipologia
La classificazione qui proposta dei paratesti matematici (o suppo-sti tali) egrave preliminare e strettamente funzionale a delineare un conte-
V p 11411-12) Ancora Eutocio (AOO III p 25816-18) menziona lrsquoὨκυτόκιον unrsquoopera in cui Apollonio di Perge otteneva unrsquoapprossimazione del rapporto tra la circonferenza di un cerchio e il suo diametro migliore di quella archimedea Lo studio piugrave completo sulla logistica greca resta Vogel 1936 che perograve ebbe solo accesso ad un segmento iniziale dei Prolegomena (le parti denominate a e b nella sezione 3 infra)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 125
sto grafico in cui collocare le testimonianze saragrave opportuno ritornare sullrsquoargomento se non altro per ampliare la gamma degli esempi o raf-finare la casistica
Intendo con lsquoparatesto matematico primariorsquo ogni sistema orga-nizzato di segni contenuto originariamente in unrsquoopera matematica e differente dalla stringa di lettere alfabetiche denotative o numerali3 che si struttura in discorso di senso compiuto Questrsquoultimo costituisce il lsquotestorsquo propriamente detto Tale sistema organizzato ha normalmente un significato ed unrsquoimportanza nellrsquoeconomia dellrsquoopera e li assume in riferimento implicito o esplicito al testo Possiamo in prima battuta distinguerne tre tipologie diagrammi tavole tabelle operazionali Le descriverograve brevemente con particolare attenzione al loro formato e alla messa in pagina che ne consegue
1) Diagrammi Un lsquodiagrammarsquo egrave una figura di norma dotata di lettere denotative che rappresenta la configurazione geometrica speci-fica di una proposizione matematica Si tratta di un ente grafico dalla funzione puramente referenziale egrave descritto allrsquoinizio della proposi-zione come entitagrave individuale4 e a sua volta raffigura la configurazione geometrica egrave impossibile trarne indicazioni deduttive univoche senza la guida del testo I manoscritti piugrave antichi presentano i diagrammi tracciati in indentazioni (lsquospecchirsquo) del testo di norma poste allrsquoinizio della proposizione seguente Abbiamo motivo di supporre che questo stato di cose rifletta la convenzione di mise en rouleau originaria ndash la descrizione della configurazione geometrica non egrave piugrave lsquosottrsquoocchiorsquo man mano che il rotolo viene svolto con il procedere della dimostrazione ed occorre rivolgersi alla figura Questi fatti confermano che i diagrammi sono dei genuini paratesti
2) Tavole Una lsquotavolarsquo egrave una disposizione ordinata di lettere numerali e altri segni grafici che rappresenta i valori assunti da una determinata gran-
3 Le lettere denotative isolate o a gruppi sono i lsquonomirsquo degli enti di cui tratta una proposizione matematica sono sempre precedute da un articolo dello stesso genere dellrsquoog-getto designato (ad esempio ἡ ΑΒ per una retta) o da unrsquoespressione preposizionale intro-dotta da un articolo (ad esempio ἡ ὑπὸ ΑΒ ΒΓ per un angolo) Le lettere numerali denotano numeri di norma sono precedute dallrsquoarticolo solo a partire dalla loro seconda occorrenza in un determinato algoritmo Nessuna di queste combinazioni alfabetiche costituisce una parte del discorso in linguaggio (greco) naturale assumono una funzione sintattica (sostan-tivi) solo nellrsquoidioletto matematico Le qualificazioni lsquoprimariorsquo e lsquooriginariamentersquo nella mia definizione escludono altri tipi di paratesti come gli scolii Un discorso a parte merita-no invece le titolazioni ma non egrave il caso di affrontarlo in questa sede
4 Ciograve avviene nelle parti specifiche della proposizione denominate ἔκθεσις laquoesposi-zioneraquo e κατασκευή laquocostruzioneraquo dove al tempo stesso sono assegnate le lettere denotative
Fabio Acerbi126
dezza in funzione di un insieme discreto di valori di un parametro Una tavola-tipo egrave composta di due colonne a sinistra i valori del parametro a destra quelli della grandezza Il parametro non egrave necessariamente nume-rico5 Le colonne possono essere piugrave di due a) se piugrave grandezze omologhe oppure no legate allo stesso parametro sono per economia di spazio ri-portate su colonne affiancate b) se una grandezza ha una rappresentazione numerica complessa ad ogni ordine essendo associata una colonna6
Le tavole sono sia costruite che descritte La lsquocostruzionersquo di una tavola consiste nellrsquoesposizione delle dimostrazioni ed operazioni neces-sarie a produrre lrsquoinsieme dei suoi valori senza che questi ultimi siano calcolati singolarmente La tavola presenta dunque in modo sintetico il risultato di una serie di operazioni questa serie puograve anche essere molto lunga e complessa ed egrave quasi sempre impossibile ricavare in tempi brevi una tavola dalla sua costruzione una tavola egrave costruita una volta per tutte si rende in questo modo indipendente dalla costruzione e non egrave univocamente determinata dalla sua lsquodescrizionersquo che si limita ad indi-care quale ente costituisca il parametro e quale la grandezza tabulata ed eventualmente a fornire indicazioni di formato Una tavola egrave collocata dopo la propria costruzione e la propria descrizione ed occupa quasi sempre per intero lo spazio grafico unitario (pagina colonna di rotolo) Una tavola insomma egrave un vero e proprio testo dal formato particolar-mente perspicuo di questo testo fanno anche parte gli altri segni grafici necessari ad un suo corretto utilizzo le linee orizzontali e verticali che separano righe e colonne la titolazione che ne identifica il tipo
Esempio la lsquotavola delle cordersquo nellrsquoAlmagesto Essa contiene i va-lori delle corde inscritte in un cerchio (seconda colonna) e dei loro incrementi parziali (terza colonna) tabulati in funzione dellrsquoarco di cerchio che esse sottendono (prima colonna)7 questrsquoultimo egrave il para-metro fornito con incrementi di mezzo grado da 0ordm a 180ordm nella tavola vi sono pertanto 360 righe La costruzione della tavola occupa quasi tutto il capitolo I 10 dellrsquoAlmagesto 15 pagine e mezzo nellrsquoedizione di Heiberg la descrizione prende 11 righe scarse includendo anche le istruzioni per lrsquouso dei valori nella terza colonna la tavola stessa si estende su 16 pagine8 Egrave particolarmente importante osservare che la
5 Esempio la lsquotavola delle cittagrave illustrirsquo nelle Tavole facili tolemaiche a sinistra il nome della cittagrave a destra le sue coordinate geografiche
6 Si veda infra la sezione 3 per questa terminologia nel caso del sistema sessagesimale7 I valori delle corde sono calcolati fino al secondo ordine sessagesimale quelli dei
loro incrementi parziali in sessantesimi fino al quarto ordine la lsquoseconda colonnarsquo consiste quindi in realtagrave di 3 colonne la lsquoterzarsquo di 4
8 Rispettivamente POO I 1 pp 319-4620 ivi p 472-13 κανόνια ὑποτάξομεν ἀνὰ
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 127
mise en rouleau dellrsquooriginale era differente come Tolomeo stesso spiega nella sua descrizione le 360 righe erano ripartite διὰ τὸ σύμμετρον laquoper motivi di simmetriaraquo9 in 8 tavole affiancate di 45 righe lrsquouna che nel rotolo figuravano probabilmente con una soluzione di continuitagrave minore di un intercolumnio standard in guisa di macrocolonna I ma-noscritti medievali rispettano questa disposizione ma devono ripartire le 8 tavole su 4 pagine10 Date le dimensioni della pagina a stampa cui egrave confinato Heiberg non puograve farlo e sdoppia ogni tavola poicheacute 45 egrave dispari e a causa della presenza dellrsquoapparato critico le sue tavole per-dono tutta la simmetria iniziale Nel caso delle tavole dunque rotolo e codice comportano mises en texte differenti per una volta egrave il rotolo e non il codice il supporto ideale per questo tipo di testi
Altro esempio tavole del moto medio del sole nellrsquoAlmagesto De-notando rispettivamente con a g o m e c i valori del tempo di ritorno annuale in giorni e loro parti e dei moti (in gradi per appropriate unitagrave di tempo) giornaliero orario mensile per mese di 30 giorni annuale per lrsquoanno egiziano di 365 giorni e infine su un ciclo di 18 anni la determinazione dei restanti a partire dal valore di a ammonta alla se-guente catena di operazioni a rarr 360a = g rarr g24 = o 30g = m 365g = e rarr 18e = c Ognuno di questi valori forma la base della costruzione per addizioni successive11 delle tavole12 che denoto con le stesse lettere
στίχους με διὰ τὸ σύμμετρον ὧν τὰ μὲν πρῶτα μέρη περιέξει τὰς πηλικότητας τῶν περιφερειῶν καθ᾽ ἡμιμοίριον παρηυξημένας τὰ δὲ δεύτερα τὰς τῶν παρακειμένων ταῖς περιφερείαις εὐθειῶν πηλικότητας ὡς τῆς διαμέτρου τῶν ρκ τμημάτων ὑποκειμένης τὰ δὲ τρίτα τὸ λʹ μέρος τῆς καθ᾽ ἕκαστον ἡμιμοίριον τῶν εὐθειῶν παραυξήσεως ἵνα ἔχοντες καὶ τὴν τοῦ ἑνὸς ἑξηκοστοῦ μέσην ἐπιβολὴν ἀδιαφοροῦσαν πρὸς αἴσθησιν τῆς ἀκριβοῦς καὶ τῶν μεταξὺ τοῦ ἡμίσους μερῶν ἐξ ἑτοίμου τὰς ἐπιβαλλούσας πηλικότητας ἐπιλογίζεσθαι δυνώμεθα laquodisporrograve le tavole su 45 righe per motivi di simmetria la prima parte di lsaquoognuna dirsaquo esse conterragrave i valori degli archi incre-mentati di mezzo grado alla volta la seconda i valori delle rette corrispondenti agli archi (il diametro essendo posto di 120 gradi) la terza la 30ordm parte dellrsquoincremento delle rette per ciascun lsaquointervallo dirsaquo mezzo grado di modo che sia possibile calcolare facilmente avendo in questa maniera a disposizione il valore intermedio lsaquodellrsquoincrementorsaquo corrispondente ad un singolo sessantesimo (esso egrave differente da quello esatto in maniera impercettibile) anche i valori delle frazioni intermedie tra i lsaquovalori limitati airsaquo mezzi gradiraquo Alm I 11 ivi pp 48-63
9 Non dobbiamo sopravvalutare la componente estetica implicita nel nostro termine laquosimmetriaraquo Tolomeo si limita a far riferimento alla laquocongruenzaraquo di 45 con 360 in quanto suo divisore esatto
10 Si vedano Par gr 2389 (sec IX in Tolomeo Almagestum) ff 17r-18v Vat gr 1594 (Prolegomena ad Almagestum Tolomeo Almagestum et opera minora) ff 20v-22r Marc gr 313 (Prolegomena ad Almagestum Tolomeo Almagestum) ff 46r-47v Vat gr 180 (sec X Tolomeo Almagestum) ff 18v-20r per la datazione del secondo e del terzo codice si veda la sezione 4
11 Tolomeo accorda alla menzione di questrsquooperazione di addizione una mezza riga proprio alla fine della sua esposizione κατὰ τὰς οἰκείας ἑκάστων ἐπισυναγωγάς laquoper opportune addizioni successive dei lsaquovalorirsaquo di ciascunoraquo Alm III 1 in POO I 1 p 20924-25
12 Alm III 1 ivi pp 2091-16 e 20922-25 descrizione ivi p 20917-22
Fabio Acerbi128
maiuscole ovviamente la tavola A egrave assente Per esempio la tavola G ha come prima riga il valore g (colonna di destra) accompagnato dalla cifra α laquo1raquo (colonna di sinistra) le altre righe hanno a sinistra i numerali da 2 a 30 e a destra i multipli corrispondenti di g il valore registrato a destra nellrsquoultima riga deve evidentemente coincidere con m In omaggio al principio delle 45 righe13 troviamo dunque una prima tavola C su 45 righe (corrispondente a un periodo di 18times45 = 810 anni avente come epoca il primo anno di regno di Nabonassar) una seconda su 42 righe che combina le 18 righe di E seguite dalle 24 di O una terza ancora su 42 righe che contiene le 12 di M seguite dalle 30 di G14 ndash nella seconda
13 διὰ τὸ φανησόμενον σύμμετρον τῆς κανονογραφίας laquoper una presentazione simme-trica del tracciato delle tavoleraquo ivi p 20914-15 allusione analoga in Alm I 10 ivi p 472-3 lrsquoabbiamo letta sottolineata nella nota 8 supra
14 Per la mise en page di queste tre tavole nei manoscritti medievali si vedano Par gr 2389 ff 69v-70r Vat gr 1594 f 63r-v (in questi due codici scritti su due colonne le tavole occupano unrsquointera pagina piugrave la prima colonna della successiva) Marc gr 313 f 98r-v (questo codice vergato a tutta pagina adotta momentaneamente una disposizione su due colonne al f 98v la prima contiene la tavola la seconda lrsquoinizio del capitolo successivo) Vat gr 180 ff 60v-61v Nelle Tavole facili dello stesso Tolomeo che passano a cicli di 25 anni e allrsquoepoca di Filippo le tavole appena descritte sono presentate con precisione ridotta rispetto a quelle dellrsquoAlmagesto nellrsquoordine C (periodo di 25times59 = 1475 anni) E (ciclo di 25 anni) M (direttamente con i nomi dei mesi del calendario egiziano mentre lrsquoAlmagesto ripartisce il parametro in multipli di 30 giorni fino a 360) G O Ogni tavola egrave suddivisa in unitagrave colonnari di non piugrave di 30 righe + titolazione La lsquotavola delle cordersquo non egrave inclusa nelle Tavole facili per le tavole del moto medio del sole e della luna nei manoscritti medievali di questrsquoopera si vedano Leiden Bibliothek der Rijksuniversiteit BPG 78 ff 91r-93v Laur Plut 2826 ff 71r-73v Vat gr 1291 ff 38r-40v Marc gr 331 ff 45r-47v ndash le parti in maiuscola di tutti questi codici contengono unicamente le Tavole facili e si datano sulla base dellrsquoultimo imperatore di cui il copista principale abbia riportato gli anni di regno nel cosid-detto canon regius nellrsquoordine Leiden BPG 78 copiato sotto il regno di Leone V 813-820 Vat gr 1291 copiato poco dopo il regno di Niceforo I 802-811 (Janz 2003) Laur Plut 2826 copiato sotto il regno di Leone VI 886-912 Marc gr 331 privo del canon regius e forse copiato anchrsquoesso sotto il regno di Leone VI si veda anche Tihon 2011 pp 19-41 per una sintesi e per ulteriori indicazioni bibliografiche Ovviamente anche le Tavole facili erano state concepite per il rotolo Tra lrsquoaltro Tolomeo sembra trascrivere nella stessa tavola i moti medi di Sole Luna Cor Leonis (la stella Regolo) e dei cinque pianeti cosa impossibile a farsi su una sola pagina di codex si legga la descrizione che ne dagrave nella parte iniziale del lsquomanuale di istruzionirsquo alle Tavole facili stesse in POO II p 1607-19 Nei manoscritti medievali questa tavola egrave smembrata poco dopo lrsquoinizio della sequenza di tavole si trovano i moti medi di Sole e Luna piugrave avanti quelli di Regolo e dei cinque pianeti Piugrave in generale il passaggio al codice comportograve una riorganizzazione delle lsquotavole facilirsquo dal piano originario in cui tutte quelle di longitudine erano molto verosimilmente raggruppate insieme e precedevano quelle di latitudine ad un ordinamento per corpi celesti (Tihon 2011 pp 12-14) Le Tavole facili furono copiate molto presto su codice i lsquopapirirsquo di questrsquoopera sono quasi unicamente su codex di pergamena (Jones 1999 I pp 102-108 e 160-168 edizione dei POxy LXI 4167-4173a contenenti frammenti delle Tavole facili ivi II pp 118-161 solo il primo di essi proviene sicuramente da un rotolo) Giagrave in pieno IV secolo Teone di Alessandria nel suo lsquoPiccolo commentariorsquo alle Tavole facili afferma che alcune di esse possono estendersi su πλειόνων πτυχίων laquopiugrave pagineraquo (PC p 2016 allinterno dellunica definizione di lsquotavolarsquo rintracciabile nel corpus antico) cosigrave le leggiamo attualmente nei manoscritti
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 129
e nella terza tavola il numero di righe egrave piugrave basso percheacute occorre pre-vedere uno spazio per il titolo addizionale Per mantenerne il formato tripartito Heiberg egrave costretto a stampare le tavole ruotate di 90ordm
Che le tavole siano dei testi egrave confermato da due fatti aggiuntivi e strettamente connessi15 Primo il lsquomanuale di istruzionirsquo alle Tavole facili che Tolomeo stesso redasse fu scritto ed ha circolato come opera a parte Secondo dalla descrizione delle tavole dettagliata ma priva di costruzione contenuta nello stesso lsquomanualersquo egrave impossibile ricavarne il contenuto numerico e la maniera drsquoimpiego16 a illustrare questrsquoultima provvederagrave una ricchissima tradizione di commentari di cui leggiamo ancora quelli di Teone il lsquoPiccolo Commentariorsquo spiega come usarle per scopi specifici il lsquoGrande Commentariorsquo come dedurle dallrsquoAlmagesto17 Le Tavole facili sono insomma unrsquoopera il cui testo egrave interamente strut-turato in formato tabulare
3) Tabelle operazionali Una lsquotabella operazionalersquo egrave una disposi-zione ordinata di lettere numerali e altri segni grafici che rappresenta lrsquoalgoritmo di unrsquooperazione aritmetica Ci troviamo in realtagrave di fronte a due modi di eseguire lrsquooperazione la tabella intende in qualche mi-sura riprodurre la dinamica operazionale dellrsquoalgoritmo questrsquoultimo si risolve a sua volta in una descrizione della tabella che senza tale de-scrizione risulterebbe incomprensibile e quindi non adattabile ad una differente operazione una tabella operazionale ha in questo caso una funzione paratestuale Si presuppone perograve che il discente apprenda a ri-produrre lrsquooperazione direttamente nel formato tabellare non in quello algoritmico In questo secondo caso una tabella operazionale assume una funzione testuale piena18 Lo statuto (para)testuale delle tabelle operazionali egrave pertanto oscillante nei commentari teonini allrsquoAlmagesto e soprattutto nei Prolegomena ad Almagestum di cui andremo ad occu-parci esse sono descritte in dettaglio e si configurano pertanto come genuini paratesti in Eutocio in Circ esse sono semplicemente eseguite e quindi assumono un ruolo testuale Nei manoscritti medievali la col-locazione di una tabella operazionale originaria egrave variabile e dipende dalle sue dimensioni e dalla capacitagrave del copista di identificarla come
15 Per un argomento ulteriore si veda la sezione 4 punto b16 POO II pp 159-18517 Nessuno dei due titoli ha fondamento nella trasmissione manoscritta la seconda
opera era detta realizzare una συμφωνία tra lrsquoAlmagesto e le Tavole facili Entrambi i com-mentari sono stati editi criticamente PC GC I-III
18 Resta il fatto che la quasi totalitagrave delle tabelle operazionali che rintracciamo nei manoscritti egrave relegata nei margini dellrsquoattivitagrave di annotazione degli scoliasti
Fabio Acerbi130
tale di solito le troviamo nei margini ma possono occupare lrsquointero specchio di scrittura e ciograve indipendentemente dalla determinazione del loro statuto paratestuale sulla base del criterio della presenzaassenza di una descrizione
Lo statuto meno elevato dei genuini paratesti (diagrammi e tabelle) rispetto ai testi (catene algoritmico-argomentative e tavole) indusse un atteggiamento differenziato in copisti ed editori attenti a rispettare lrsquointegritagrave dei secondi ma non dei primi ciograve che conta sono le informa-zioni veicolate dalle strutture discorsive e dalle porzioni alfanumeriche di diagrammi tavole e tabelle il resto egrave ritenuto adattabile alle esigenze dellrsquoedizione moderna19 o semplicemente ignorato nel corso del pro-cesso di copia in questa maniera si perdono perograve informazioni e strut-tura Come vedremo puograve avvenire che una parte della descrizione di unrsquooperazione resti senza relato nella resa grafica tabellare lrsquooperazione eseguita in forma algoritmica non corrisponde piugrave a quella eseguita in forma di tabella
3 Testi logistici e disposizione tabellare delle operazioni
Nessun testo matematico primario di etagrave ellenistica o imperiale contiene operazioni aritmetiche eseguite con una sola eccezione la de-scrizione che non ammette una rappresentazione tabellare del procedi-mento di estrazione approssimata di radice quadrata in Erone Metr I 8 Drsquoaltro canto abbiamo giagrave osservato che lrsquoAlmagesto di Tolomeo for-nisce il risultato di migliaia di operazioni ma nessuna di esse egrave eseguita Attestazioni di questi procedimenti sono pertanto legate ad iniziative editoriali di secondo livello come i commentari alla loro prima occor-renza oppure in casi paradigmatici gli algoritmi di calcolo omessi nel testo primario vi sono resi espliciti Di fatto e con una sola eccezione la nostra documentazione consiste in commentari allrsquoAlmagesto quello di Teone e i Prolegomena ad Almagestum
19 Abbiamo giagrave visto alcuni esempi di modifiche del formato delle tavole Quanto ai diagrammi quelli tracciati nelle edizioni moderne rappresentano il caso piugrave generale pos-sibile Le figure che troviamo nei manoscritti greci hanno invece la caratteristica opposta illustrano spesso casi particolari e sono metricamente scorrette Sono in effetti tracciati triangoli rettangoli isosceli cerchi uguali rette perpendicolari dove tutto ciograve non egrave richiesto dallrsquoenunciato e inoltre rettangoli invece di parallelogrammi segmenti uguali quando sia-no disuguali addirittura linee rette al posto di curve (in Archimede Meth 14 un arco di parabola egrave rappresentato da un angolo rettilineo) e in generale figure con proprietagrave di simmetria non richieste
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 131
LrsquoAlmagesto e con esso tutta la tradizione astronomica adotta il sistema sessagesimale per esprimere la parte non intera di un nu-mero che siano valori angolari o lineari non fa differenza20 come noi scriviamo 36524 e intendiamo 365 + 2 decimi + 4 centesimi (cioegrave 4102) cosigrave nel sistema sessagesimale 365 14 48 significa21 365 + 14 sessantesimi + 48 tremilaseicentesimi (cioegrave 48602) ovverosia nel lessico antico e nostro 365 14 πρῶτα λεπτά laquominuti primiraquo 48 δεύτερα λεπτά laquominuti secondiraquo dove laquoprimoraquo e laquosecondoraquo sono le laquodenominazioniraquo degli ordini (sono cioegrave numeri ordinali) 14 e 48 i lsquonumerali di molteplicitagraversquo relativi ai due ordini numerale di mol-teplicitagrave e relativa denominazione costituiscono insieme una lsquoparte sessagesimalersquo di un numero Drsquoaltronde per gli antichi come per noi lrsquoespressione di una parte non intera (ovvero di una frazione)
20 Trascuro il fatto ai nostri fini irrilevante che essendo i numerali greci lettere alfabetiche la notazione che ne risulta per i numeri interi non egrave posizionale nonostante le cifre scagravelino di un posto ad ogni potenza di dieci il segno μ per 4 (decine) non egrave identico al segno δ per 4 (unitagrave) Drsquoaltra parte una volta adottata la notazione decimale per i numerali di molteplicitagrave la notazione complessiva per la parte non intera espressa nel sistema sessa-gesimale non egrave posizionale neanche introducendo un segno di lsquoposto vuotorsquo una cui parte egrave nel caso greco analoga in forma al nostro 0 (su questo segno si veda ancora la sezione 4 punto c) occorre avvalersi di accorgimenti ulteriori quali lrsquointroduzione di spaziature fra le differenti parti sessagesimali (come viene fatto nei manoscritti greci ed in questrsquoarticolo) o di segni tipografici (come suggerito da Otto Neugebauer che avrebbe scritto 3651448 il numerale che leggeremo tra un attimo nel testo) Il problema egrave che altrimenti lrsquoordine associato ad un numerale di molteplicitagrave di una parte sessagesimale puograve non risultare uni-vocamente determinato dalla sua posizione Esempio scrivendo 0129 per un numero non intero nel sistema sessagesimale il numerale di molteplicitagrave 129 potrebbe rappresentare 1 minuto primo e 29 secondi oppure 12 minuti primi e 9 secondi ecc e la stessa difficoltagrave si presenta nella notazione greca (per la nozione di lsquonumerale di molteplicitagraversquo si veda infra nel testo) Il problema scomparirebbe se adottassimo singoli segni differenti per tutti i nu-merali da 1 a 59 ndash ma neacute noi neacute i greci siamo stati disposti a introdurre una complicazione siffatta Si ricordi infine che al di fuori dei contesti astronomici il sistema di numerazione greco egrave decimale
21 Scriverograve i numerali in cifre arabe sempre in questo modo parte intera seguita dalle parti sessagesimali (minuti primi secondi ecc) con ogni ordine separato da uno spazio bianco Se la parte intera egrave assente il numerale inzia con uno 0 Nella trascrizione dei numerali in greco ogni numerale di molteplicitagrave sessagesimale o frazione unitaria saragrave identificato come nei manoscritti piugrave antichi dei Prolegomena da un opportuno numero di apici (uno per ogni unitagrave dellrsquoordine avendo le frazioni unitarie un solo apice come vedremo nellrsquoAlmagesto contenuto negli stessi codici troviamo barre non apici con questa funzione) mentre la parte intera saragrave priva della barra che la sormonta invariabilmente nei manoscritti In questo modo 365 14 48 egrave la conversione in cifre arabe di τξε ιδ´ μη´´ La pratica dei manoscritti medievali egrave di collocare gli apici (quando presenti) sopra le lettere numerali per ragioni tipografiche li porrograve di seacuteguito al gruppo di lettere cui si riferiscono Si noti che nella notazione greca il segno ιδ´ per 1460 in sessagesimale egrave identico a quello per 114 in decimale Nel caso delle frazioni unitarie la presenza dellrsquo(unico) apice egrave la traduzione semiotica della trasformazione che a livello grammaticale egrave effettuata con il pas-saggio dal cardinale allrsquoordinale (ad esempio da τὰ τρία laquotreraquo a τὸ τρίτον laquoun terzoraquo) si veda anche la sezione 4 punto 1 e note 82 e 86 ivi incluse
Fabio Acerbi132
richiede sempre lrsquointroduzione di due numerali il lsquonumeratorersquo e il lsquodenominatorersquo
Il motivo della scelta del sistema sessagesimale che fu mutuato dallrsquoastronomia matematica babilonese egrave presto detto lrsquoelevato numero di divisori di 60 e cioegrave 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 Poicheacute i divi-sori di 10 sono un sottinsieme di quelli di 60 molti piugrave numeri hanno una rappresentazione finita nel sistema sessagesimale che in quello deci-male Calcolare in sessagesimale lungi dal creare difficoltagrave offre quindi un vantaggio cruciale22 che risulta piugrave facilmente comprensibile sulla base dellrsquoesempio seguente La lunghezza dellrsquoanno solare egrave stabilita da Tolomeo in 365 giorni + 14 ndash 1300 di giorno Per calcolare il moto giornaliero del sole si rende necessario dividere 360 per questo numero Noi avremmo due opzioni se non potessimo usare la calcolatrice ri-durre il divisore ad una singola frazione tramite passaggio al denomi-natore comune invertire questa frazione e moltiplicarla per 360 sem-plificare gli eventuali fattori comuni e finalmente eseguire la divisione a piugrave cifre tra numeri interi (nel nostro caso 5400054787) oppure scrivere il divisore come numero decimale periodico (365246666 hellip) e poi eseguire la divisione Nel sistema sessagesimale egrave tutto molto piugrave semplice 365 + 14 ndash 1300 ha una rappresentazione finita cioegrave 365 14 48 come eseguire la divisione lo vedremo tra un attimo
Passiamo dunque in rassegna il contenuto del lsquomanuale di logisticarsquo incluso nei Prolegomena ad Almagestum riportando in nota per ogni item anche esposizioni parallele in altri commentatori23
a) Costruzione del sistema sessagesimale24
22 E uno svantaggio se le molteplicitagrave dei singoli ordini vengono espresse in no-tazione decimale (come facciamo noi e facevano i greci) il numero di cifre necessario per raggiungere una precisione assegnata egrave maggiore nel sistema sessagesimale in quanto per esprimere i numerali da 10 a 59 occorrono due cifre mentre per quelli da 1 a 9 (o da α a θ e le decine da ι a ν nel caso greco) ne basta una e ciograve indipendentemente dal fatto che la notazione sia posizionale oppure no La differenza si fa perograve sentire solo a partire dal quinto ordine sessagesimale
23 Trascuro la parte finale del lsquomanualersquo dove sono esposte le regole di interpolazione (cui era legata la lsquoterza colonnarsquo della tavola delle corde tolemaica) e il procedimento di lsquosottrazionersquo di rapporti cioegrave la divisione di un rapporto per un altro
24 Per a-b cf Teone in Alm I 10 in iA pp 44919-45814 PC pp 2007-2014 GC I pp 10910-11124 e le definizioni e regole diofantee di manipolazione delle varie specie numeriche in Arithmetica prefazione in DOO I pp 214-1218 Le porzioni a-b sono giagrave state pubblicate da Paul Tannery in DOO II pp 318-1517 sulla base del Par gr 453 apografo ad opera di Giovanni Santamaura di un Vat gr 1594 giagrave mutilo (RGK II nr 238 ma lrsquoautore trascritto vi egrave indicato come lsquoPtolemaiosrsquo) Evidentemente il committente non fu soddisfatto della prima trascrizione (ff 67-76) che crivella di tratti rossi a segnalarne gli errori di copia Ne fu dunque eseguita una seconda (ff 78-86) cui Santamaura antepose
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 133
b) Regole di moltiplicazione e divisione degli ordini sessagesimali defini-zione generale di moltiplicazione moltiplicazione di ordini come somma delle loro laquodenominazioniraquo Definizione generale di divisione divisione di ordini uguali e di un ordine per quello che lo precede immediata-mente divisione di ordini come sottrazione delle loro laquodenominazioniraquo divisione per 60 come divisione per 1 accompagnata dallo slittamento di un posto dellrsquoordine
c) Problemi che sorgono nella divisione di una parte sessagesimale per una di quelle che seguono divisione breve per riduzione allo stesso ordine (metodo laquoper analisiraquo) due algoritmi differenti il secondo con riduzione dei fattori comuni attribuito a Siriano
d) laquoAltroraquo metodo di divisione breve in realtagrave divisione tra somme di parti sessagesimali appartenenti ad ordini differenti per riduzione allo stesso ordine e applicazione dei metodi precedenti esempio della divisione di 0 2 0 4 per 0 0 2 0 240
e) Metodo di moltiplicazione tra numeri con parti non intere disposizione tabellare dei termini esempio della moltiplicazione di 5 4 6 per 8 0 3 0 525
f ) Primo metodo di divisione lunga descrizione della disposizione tabellare ed esempio di algoritmo applicato alla divisione di 50 48 26 30 per 8 16 28 5426
g) Metodo di divisione lunga tratto da Pappo in Alm III descrizione della disposizione tabellare ed esempio di algoritmo applicato alla divisione di 360 per 365 14 48 come verifica del valore 0 59 8 17 13 12 31 fornito nellrsquoAlmagesto per il moto medio giornaliero del sole27
h) Metodo di approssimazione di una radice quadrata secondo Erone Metr I 8 con giustificazione geometrica di Teone (attualmente non attestata in suoi scritti)
i) Verifica tramite moltiplicazione della correttezza del valore tolemaico28 di 67 4 55 come radice quadrata approssimata di 4500 Metodo di estrazio-ne di radici quadrate secondo Teone basato su applicazioni successive di Elementi II 4 la procedura termina dopo un numero finito di passi nel caso di quadrati perfetti Applicazione al calcolo della radice quadrata di 450029
unrsquoannotazione spazientita laquoIl texto di questo 2do quinterno egrave stato recopiato fidelmente dallrsquooriginale a chi volesse vedere la prova lo potragrave conferire con detto originale le pagine del qual texto corrispondono con quelle dellrsquooriginale tanti versi che pagine [hellip]raquo (Moge-net 1962 p 200)
25 Teone in Alm I 10 e I 14 in iA pp 45815-4604 e 57911-5811026 Teone in Alm I 10 in iA pp 4611-46217 applicato alla divisione di 1515 20
15 per 25 12 1027 Teone in Alm III 1 e IV 3 in iA pp 84112-84422 (stesso calcolo dei Prolego-
mena) e 102916-10327 idem in Alm IX pp 377-378 dellrsquoedizione di Basilea del 1538 approntata dai tipografi di Walderus Lrsquooriginale pappiano non ci egrave pervenuto
28 Alm I 10 in POO I 1 p 341129 Teone in Alm I 10 in iA pp 46916-4738
Fabio Acerbi134
Lrsquounico testo non elencato qui sopra o nelle note e che contenga tabelle operazionali egrave il commentario eutociano a Circ 3-4 Il testo ar-chimedeo che Eutocio e noi con lui leggeva egrave particolarmente conciso ed egli verifica esplicitamente il sussistere di certe relazioni numeriche Si tratta in ognuno dei nove casi presenti di mostrare che il lsquoteorema di Pitagorarsquo egrave verificato con ottima approssimazione dai valori numerici di opportune terne di rette Eutocio esegue le tre moltiplicazioni dei valori per se stessi e mostra che la somma o la differenza di due dei risultati si discosta di poco dal terzo30 I numeri in questione sono interi seguiti o no da una parte non intera espressa come somma di frazioni unita-rie31 I nove gruppi di tre moltiplicazioni una a fianco allrsquoaltra sono organizzati in forma tabellare ma senza lrsquoausilio di linee separatrici32 le operazioni sono eseguite disponendo lsquoin colonnarsquo i risultati delle mol-tiplicazioni parziali e sommandoli esattamente come facciamo oggi poicheacute sono in gioco numeri interi con parti frazionarie unitarie e la notazione non egrave posizionale non egrave necessario che gli incolonnamenti siano esatti (unitagrave di un risultato parziale sotto le decine del precedente ecc) Sono inclusi nella tabella istruzioni e commenti in linguaggio corrente33 le prime relative allrsquooperazione da affettuare sui risultati delle
30 Eutocio non calcola radici quadrate approssimate per quanto ciograve si renda piugrave volte necessario fornisce il risultato e verifica la sua correttezza moltiplicandolo per se stesso Egli dichiara che il lettore interessato a questo procedimento di calcolo puograve rivolgersi Ἥρωνι ἐν τοῖς μετρικοῖς [hellip] Πάππῳ καὶ Θέωνι καὶ ἑτέροις πλείοσιν ἐξηγουμένοις τὴν μεγάλην σύνταξιν τοῦ Κλαυδίου Πτολεμαίου laquoa Erone nei Metrica [hellip] a Pappo e Teone e a svariati altri inter-preti della Grande composizione di Claudio Tolomeoraquo (AOO III p 23213-17)
31 Troviamo ad esempio ͵αωλη θ´ ια´ cioegrave 1838 + 19 + 111 notare il singolo apice per le frazioni unitarie
32 Essi sono editi in AOO III pp 234-256 La tradizione medievale del commentario eutociano che coincide con un ramo di quella archimedea e deriva da un codice appar-tenuto a Giorgio Valla perduto in etagrave rinascimentale ma riprodotto a volte con fedeltagrave assoluta negli apografi (si veda ad esempio nella tav 1a la riproduzione dellrsquoerronea di-sposizione di cifre e parte algoritmica nel primo gruppo di moltiplicazioni offerta dal Laur Plut 284 f 160r) egrave costituita da Marc gr 305 ff 142v-146v Laur Plut 284 ff 159r-164r Par gr 2360 ff 109v-113v Par gr 2361 pp 410-421 Nel codice veneziano in cui la disposizione per righe e colonne egrave irrimediabilmente alterata dal copista le operazioni sono cancellate con tratti di penna Il primo manoscritto fu esemplato per Bessarione da Giorgio Trivizias tra il 1455 e il 1468 (Mioni 1976 pp 309-312) il secondo fu vergato da Giovanni Scutariota in scrittura di imitazione (Martinelli Tempesta 2010 p 173 n 7 Rollo 2012) ca 1491-1492 il terzo fu trascritto per il cardinale di Firenze Niccolograve Ridolfi dopo che la biblioteca di Valla era stata acquistata a seacuteguito della sua morte avve-nuta il 23 gennaio 1500 per 800 scudi drsquooro da Alberto Pio di Carpi (nota del copista al f 120v) il quarto fu terminato per mano di Christopher Auer su commissione di Georges drsquoArmagnac il primo gennaio 1544 (sottoscrizione a p 474 del codice si veda RGK II nr 525)
33 A questi va aggiunto posto davanti al risultato finale di ogni moltiplicazione il segno convenzionale per ὁμοῦ laquoinsiemeraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 135
prime due moltiplicazioni34 i secondi alla bontagrave dellrsquoapprossimazione ottenuta35 Ogni gruppo di operazioni che chiude unrsquounitagrave esegetica ed egrave seguito dalla citazione che apre la successiva egrave trascritto come se facesse parte del testo a tutta pagina e preceduto dallrsquoindicazione οἱ δὲ πολλαπλασιασμοὶ ὑπόκεινται laquole moltiplicazioni sono poste qui sottoraquo Questi due fatti suggeriscono che tutte le operazioni cui Eutocio non fa alcun riferimento nel corpo del suo commentario siano unrsquoaggiunta editoriale risalente a Isidoro di Mileto che si occupograve della revisione del testo36
Gli incolonnamenti esatti sono invece necessari quando siano moltiplicati numeri con parti non intere espresse nel sistema sessage-simale in quanto la somma finale dei prodotti parziali va effettuata ordine per ordine Tale somma eccederagrave di norma il valore di 60 per un ordine dato nella tabella occorre pertanto trovare posto anche per i riporti che vanno sommati ai prodotti parziali dellrsquoordine preceden-te e quindi incolonnati con essi I testi ci offrono alcuni esempi di tabelle operazionali moltiplicative di questo tipo Teone afferma espli-citamente che la prima moltiplicazione che va a descrivere ha una rap-presentazione tabellare la cui disposizione ritroviamo pesantemente ingarbugliata nel Laur Plut 2818 f 35r37 Alla seconda occorrenza di una moltiplicazione eseguita (tav 1b Laur Plut 2818 f 65r) gli incolonnamenti sono meglio rispettati anche se il risultato finale egrave fatto erroneamente slittare di un posto verso destra i riporti (con un errore) si trovano nella penultima riga38 Nei Prolegomena ad Alma-gestum alcune moltiplicazioni sono accompagnate da tabelle quella meglio attestata egrave associata alla moltiplicazione di 67 4 55 per se stesso (sezione i nel riassunto fornito supra) ed egrave descritta additando sempli-cemente ad un ente materiale oramai inaccessibile forse tracciato in loquendo lsquoalla lavagnarsquo
34 Come λοιπὸν τὸ ἀπὸ ΕΓ laquoresta quello su ΕΓraquo seguito dal risultato della sottrazione di due quadrati
35 Come λείπει ἄρα μο β εἰς τὸ ἀκριβές laquomancano quindi 2 u(nitagrave) al risultato esattoraquo36 Si legga la sottoscrizione spuria ad AOO III p 26010-1237 Si legga la frase ἐκτίθεμαι αὐτὴν καὶ πάλιν αὐτὴν ὑφ᾽ αὑτὴν ὡς ὑπογέγραπται laquolo [scil il
valore del lato da moltiplicare per se stesso] dispongo lsaquouna voltarsaquo e di nuovo al sotto di se stesso come trascritto qui sottoraquo in iA p 45817 Il Laur Plut 2818 (Teone e Pappo Commentaria in Almagestum) egrave uno dei piugrave antichi manoscritti in minuscola sicuramente assegnabile alla prima metagrave del IX secolo (Follieri 1977 p 144 n 23 Maas 1927 p 76 n 17 riteneva che fosse piugrave antico del Tetraevangelo Uspenskij) per una sua analisi si veda Rome 1938
38 In nessuno dei due casi i numerali di molteplicitagrave sono segnalati con apici sono tutti sormontati da una barra si veda la sezione 4 punto b
Fabio Acerbi136
προκείσθω δὶς τὸ μῆκος αὐτῆς ὀφεῖλον τὴν τάξιν τοῦ κατὰ τοὺς πολλαπλασιασμοὺς κανόνος ἀποδοῦναι καὶ ἐκκείσθω ἐπὶ σελιδίων διαγεγραμμένων οὕτω καὶ δὴ αὐτῆς ἐφ᾽ ἑαυτὴν πολ-λαπλασιασθείσης γεγονέτωσαν τὰ ἐν τοῖς οἰκείοις σελιδίοις εἴδη ταῦτα δὴ συναγόμενα καθ᾽ ἣν ὑπεδείξαμεν τάξιν ποιήσει τὰς ὑπογεγραμμένας μοίρας ἢ καὶ λεπτά τινα εἴσι ͵δυϙθ νθ´ ιδ´´ ι´´´ κε´´´´ ὡς λείπειν τοῦ ἐπιμερισθῆναι ŏ ŏ με´´ μθ´´´ λε´´´´
che sia prescritto che la sua lunghezza debba figurare due volte nella disposizione della tavola delle moltiplicazioni e che lsaquoquestrsquoultimarsaquo sia disposta su colonne delimitate da linee cosigrave mdash E pertanto una volta moltiplicato lsaquoil latorsaquo per se stesso che le specie trovino posto nelle colonne appropriate quelle che vengono cosigrave raccolte secondo la disposizione che abbiamo indicato produrranno dunque i gradi o anche i minuti qui sotto trascritti 4499 59 14 10 25 in modo che dalle divisioni successive resti39 0 0 45 49 35
La tabella associata (tav 2a Marc gr 313 f 19v) contiene una sola svista grossolana reca 51 invece di 55 in ognuno dei due fattori posti affiancati sopra di essa Al di sotto preceduto dal segno convenzionale per ὁμοῦ egrave collocato il risultato incongruamente sfalsato di un paio di colonne e con la lettera numerale ͵δ priva di barra sormontante in-naturalmente disconnessa da υϙθ I riporti sono indicati dai numerali ι ρκγ´ η´´ ν´´´ posti al fondo delle prime quattro colonne Il calcolo egrave corretto in ogni sua parte
Il clou in questo piccolo spaccato delle interazioni testo-paratesto matematico risiede nella descrizione contenuta nei Prolegomena della disposizione tabellare di due procedimenti di divisione il primo ano-nimo e quindi da supporre tradizionale il secondo piugrave efficiente ed attribuito al matematico del IV secolo Pappo
Il primo metodo di divisione egrave sostanzialmente analogo a quello che usiamo attualmente Dividendo e divisore questrsquoultimo preceduto da un segno su cui ritorneremo nella prossima sezione sono posti uno sotto lrsquoaltro intervallati da una riga inizialmente vuota Primo passo viene reperito il massimo multiplo del divisore che sia minore del di-videndo esso viene trascritto sotto il dividendo nella prima lsquocasellarsquo della riga vuota recante in testa un segno per laquosottrairaquo il fattore mol-tiplicativo (o quoziente parziale) viene trascritto in una lsquocasellarsquo pre-ceduta da un segno per laquorisultaraquo sotto il divisore Secondo passo il massimo multiplo viene sottratto dal dividendo il resto cosigrave ottenuto egrave trascritto preceduto da un segno per laquorestoraquo in una casella posta
39 Lrsquoautore concettualizza il procedimento di estrazione di radice quadrata come una forma di divisione
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 137
accanto al dividendo40 I due passi precedenti sono quindi ripetuti con la sola differenza che il resto appena ottenuto prende il posto del divi-dendo il quoziente parziale scala di un ordine sessagesimale ad ogni passo41 E cosigrave via aggiungendo ogni volta due caselle La debolezza di questo metodo come di quello che utilizziamo attualmente risiede nel fatto che il reperimento dei quozienti parziali (ovverosia dei massimi multipli) viene effettuato per tentativi non riuscire a farlo al primo colpo appesantisce notevolmente i calcoli successivi e costringe ad un lavoro di riordino e addizione dei quozienti parziali stessi La tabella risultante dove appunto osserviamo questo fenomeno in parallelo con identiche inaccuratezze nella descrizione ha la forma riprodotta unico tra i manoscritti della recensione antica nel Marc gr 313 f 13r (tav 2b invito il lettore a non rivolgersi alle tavole se non dopo aver termi-nato questa sezione sarebbe anzi auspicabile che tentasse di ricostruire questa tabella e le due successive a partire dalla mia descrizione)42
Il secondo metodo di divisione attribuito a Pappo egrave congegnato in modo da rendere non aleatoria la ricerca dei quozienti parziali Come altrove nei Prolegomena la descrizione della procedura di calcolo si riag-gancia esplicitamente a una frase di Tolomeo laquouna volta dimostrato che il periodo di una singola rivoluzione lsaquodel solersaquo egrave di 365 giorni 14 48 se di-vidiamo per essi i 360 gradi di un singolo cerchio avremo il moto medio giornaliero del sole circa 0 gradi 59 8 17 13 12 31raquo43 Questrsquoaffermazione si trova nel terzo libro dellrsquoAlmagesto si tratta della prima occasione in cui viene effettuata una divisione in cui il divisore egrave maggiore del dividendo e i commentatori del trattato tolemaico non si fecero sfuggire lrsquooccasione di mostrare come eseguirla Ora il terzo libro del commentario di Pappo non ci egrave pervenuto Ci resta dunque come testo parallelo a quello dei Prolegomena la descrizione rigidamente formulare in Teone sicuramente un calco di quella pappiana Teone qui come nelle altre applicazioni del metodo (Laur Plut 2818 ff 136v [tav 3] e 190r) descrive brevemente ed espone esplicitamente la stessa tavola dei sottomultipli del divisore che
40 Esempio nella divisione di 378 per 17 il massimo multiplo egrave 374 il quoziente parziale egrave 22 il resto 4 e in effetti 378 = 374 + 4 = 17times22 + 4 Si noti che il segno per laquorestoraquo non egrave apposto in testa di riga ma davanti a ogni resto parziale e in effetti il dividendo che si trova in prima posizione in questa riga non egrave un resto
41 Analogamente nellrsquoalgoritmo moderno poniamo la virgola o scaliamo la cifra di un posto
42 Nei Prolegomena la descrizione della tabella associata al metodo anonimo egrave pre-ceduta da una breve sinossi dellrsquooperazione in stile procedurale (cioegrave senza riferimenti alla tabella) e seguita dalla sua esecuzione accurata ma con pochi riferimenti alla tabella se non quello ai due segni da apporre ai resti parziali e ai massimi multipli
43 Alm III 1 in POO I 1 p 2091-4
Fabio Acerbi138
troviamo nei Prolegomena ma non offre alcuna descrizione della disposi-zione tabellare della divisione stessa neacute vi fa riferimento
A questa procedura sono in effetti associate una tavola e una tabel-la costruite come segue (tavv 4 e 5 Marc gr 313 ff 17r e 17v il co-pista era ndash giustamente ndash insoddisfatto della prima versione) La tavola le cui righe e colonne sono delimitate da linee contiene sottomultipli44 del divisore 365 14 48 9 righe che riportano i valori da 160 a 960 piugrave altre 6 con i valori per decine da 1060 a 6060 la prima colonna elenca le 15 parti sessagesimali omettendo come drsquoabitudine la laquodenomina-zioneraquo dellrsquoordine (i numerali elencati sono quindi α β γ δ ε ϛ ζ η θ ι κ λ μ ν ξ) la seconda i sottomultipli corrispondenti organizzati su quattro colonne per tener conto dei tre ordini sessagesimali (il primo sottomultiplo egrave quindi ϛ ε´ ιδ´´ μη´´´ cioegrave 160 di τξε ιδ´ μη´´) La tabella priva di linee delimitanti espone la vera divisione Nella prima colonna troviamo i resti parziali ognuno preceduto dallrsquoindicazione del proprio ordine sessagesimale e da un segno per laquorestoraquo Nella seconda preceduti da un segno per laquosottrairaquo i sottraendi ognuno coincide ovviamente con uno dei sottomultipli nella tavola La terza colonna contiene se-guiti dallrsquoindicazione del proprio ordine sessagesimale i quozienti par-ziali ottenuti trascrivendo dalla prima riga della tavola il numerale corrispondente al sottraendo affiancato ed assegnando come ordine sessagesimale il successivo a quello posto in testa di riga Il risultato preceduto da un segno per laquorisultaraquo e posto al di sotto della tabella si ottiene sommando i quozienti parziali il procedimento non permette in generale di determinare lrsquointero quoziente parziale relativo ad un ordine sessagesimale fissato se non dopo due passi Una linea spezzata unisce i resti parziali successivi e i relativi sottraendi per evidenziare la laquoprogressione della proceduraraquo la spezzata lsquosaltarsquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore (le cui righe sono per il resto vuote) e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue di conseguenza anche il quoziente parziale relativo a questo resto appartiene allrsquoordine sessagesimale successivo
A questo punto possiamo rivolgerci alle tavv 4-5 e verificare se le immagini che ci siamo formati sulla base della mia descrizione corri-spondono a quelle che troviamo nel Marc gr 313 Non si tratta di un giochetto sterile egrave al contrario il cuore di un intrico di problemi Un primo ordine di problemi deriva dal fatto che nei Prolegomena lrsquoalgo-
44 Sottomultipli e non multipli in quanto il divisore egrave maggiore del dividendo Drsquoaltronde nel sistema sessagesimale come in quello decimale un sottomultiplo si ottiene dal multiplo corrispondente semplicemente scalando tutte le cifre di un posto (ad esempio 1360 di 365 14 48 si ottiene in questa maniera da 13 volte 365 14 48)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 139
ritmo della divisione lsquoalla Papporsquo non egrave mai eseguito (cioegrave formulato verbalmente) in maniera indipendente dalla descrizione della tabella Comrsquoegrave dunque possibile descrivere una tabella operazionale che non ha uno statuto testuale indipendente sulla base di un algoritmo in corso di esecuzione E drsquoaltro canto come non rilevare unrsquoanomalia in un algoritmo eseguito nella sua forma primaria sotto forma di descrizione di una tabella Ci potremmo chiedere se viene descritto lrsquoalgoritmo o la tabella La tensione fra i due enti grafici egrave acuita dal fatto che nei nostri testi tutto ciograve (esposizione o descrizione di un algoritmo o della tabella associata) avviene sempre e solo sulla base di un esempio numerico para-digmatico Per questo motivo la tabella in quanto struttura (cioegrave privata dei dati numerici accidentali) non puograve fare a meno della descrizione45 Dal canto suo Teone come forse Pappo ancor prima descrive ed espone la tavola dei (sotto)multipli ma non la tabella di divisione lrsquoalgoritmo relativo a questrsquoultima egrave espresso come per controbilanciare in maniera eccezionalmente trasparente e formulare Se ciograve comporta un guada-gno a livello verbale-argomentativo sorge un problema operativo grave come e dove sistemare i resti e i quozienti parziali ndash cioegrave tutti i numeri in output dellrsquoalgoritmo differenti dai (sotto)multipli ndash che la tabella si incarica di disporre in modo lsquonaturalersquo Teone prescrive soltanto di confrontare i resti con la seconda colonna della tavola dei sottomultipli e di trascrivere via via il quoziente ottenuto dopo ogni passo Insomma come eseguire materialmente una divisione Non certo adattando ad un nuovo caso specifico la formulazione dellrsquoalgoritmo che Teone propone
Un secondo ordine di problemi e una trappola micidiale per il co-pista egrave interno alla dialettica lsquotabellarsquolsquosua descrizionersquo ed egrave in assenza di simbolismo quello dei riferimenti linguistici da adottarsi nella seconda agli enti grafici che figurano nella prima Occorre ricercare la massima generalitagrave fornita da una descrizione definita di un ente numerico (ad esempio impiegando il termine laquorestoraquo o la perifrasi laquomassimo sotto-multiplo minoranteraquo) o basta assumere direttamente il suo valore speci-fico come esempio paradigmatico E in che modo risolvere il conflitto tra uso e menzione se come nel nostro caso la tabella contiene segni convenzionali ed occorre fornirne una descrizione Si rende ad esempio necessario introdurre un lsquooperatore di citazionersquo noi useremmo le virgo-lette la lingua greca premette lrsquoarticolo neutro Drsquoaccordo ma nel caso
45 Questa caratteristica non egrave connaturata alla matematica degli algoritmi la risorsa dello lsquostile proceduralersquo serve esattamente ad aggirare questo problema al di lagrave di un certo livello di dettaglio perograve essa condurrebbe ad un appesantimento insostenibile della for-mulazione dovuto alla pluralitagrave dei riferimenti agli oggetti matematici in gioco sulla que-stione dei diversi stili della matematica greca si veda Acerbi 2012
Fabio Acerbi140
greco qual egrave il suo range E come distinguerlo nei casi ambigui da un semplice articolo che precede un sostantivo quando questrsquoultimo lo ri-chieda Nel corso del processo di copia del testo della descrizione infine possono generarsi tensioni tra enti grafici interpretabili vuoi come segno convenzionale vuoi come abbreviazione Ambiguitagrave relative a questi punti opacizzano la descrizione Un problema analogo si porrebbe a priori nella dialettica tra uso delle lettere denotative per designare enti geometrici e loro menzione nella costruzione di un diagramma ma esso egrave risolto con lrsquoazzeramento della seconda funzione le lettere denota-tive sono sempre usate allrsquointerno del testo (sono cioegrave il referente degli oggetti geometrici di cui tratta il discorso matematico) mai menzionate (come accadrebbe se fossero il referente di oggetti grafici posti nel dia-gramma) Insomma il codice adottato per la costituzione dei diagrammi geometrici egrave condiviso (cioegrave canonizzato) semplice e perspicuo mentre quello per le tabelle operazionali non lo egrave da qui le sviste dei copisti e le trascuratezze di correttori ed editori
Infine chi vuole apprendere da questi testi come eseguire una divi-sione a cosa deve prestar fede se ad esempio a causa di errori di copia la descrizione finisce per non coincidere con la tabella operazionale visto che sono entrambe due maniere valide di eseguire lo stesso algoritmo Dopo tutto lo scopo di tutta questa macchina grafico-argomentativa egrave di insegnare a eseguire divisioni in formato tabellare Questo problema si fa particolarmente acuto se la tabella non egrave trasparente nel metodo di Pappo lo egrave quasi completamente in quello anonimo no E gli errori che riscontreremo nella (doppia) tabella ai ff 17r-v del Marc gr 313 a chi sono attribuibili Allrsquoautore al trascrittore o al copista medievale
Questo groviglio di problemi riceve alcune risposte sorprendenti dalla tradizione manoscritta come andiamo finalmente a vedere
4 Analisi delle testimonianze
I codici che ho adibito per lrsquoedizione sono i seguenti M = Marc gr 31346 C = Marc gr 314 (Tolomeo Tetrabiblos et opera minora cum commentariis Vezio Valente Anthologiae)47 Z = Vat gr 2326 (fattizio
46 Riferibile al sec IX ex-X in accolgo la datazione suggeritami per litteras il 522005 da Nigel G Wilson si veda anche Agati 1992 pp 141-142 La presenza non sistematica degli accenti che fa anticipare a Wilson la datazione di laquosaec X medraquo fornita in Mioni 1985 p 24 indusse Boris Fonkič (2005 non vidi) ad assegnare il codice allrsquoinizio del IX secolo
47 Il manoscritto riferibile alla seconda o terza decade della prima metagrave del XIV secolo fu vergato da Michele Clostomalle olim lsquoMetochitesschreiberrsquo Bianconi 2005a pp 428-430 Il titolo dei Prolegomena in questa trascrizione identico in grafia ma non in formulazione a
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 141
e mutilo Tolomeo Almagestum) S = Vat gr 184 (varia astronomica scholia miscellanea ad Almagestum Tolomeo Almagestum) P = Par gr 2390 (varia astronomica) gli ultimi tre riferibili allo scorcio del XIII secolo48 e apografi sicuri del Vat gr 159449 attualmente mutilo di due fascicoli che ci privano dei due terzi finali dei Prolegomena M e il Vat gr 1594 ammettono un modello comune il resto della tradizione (25 trascrizioni in tutto) dipende dagli apografi appena citati del Vat gr 1594 Le varianti della recensione bizantina che leggiamo tra lrsquoaltro nei Vat gr 198 Marc gr 310 (Tolomeo Almagestum cum commentariis Pappi Theonis et Cabasilae) e con ulteriori modifiche Laur Plut 89 sup 48 (varia astronomica Tolomeo Almagestum Barlaam Logistica) sono identificate dal siglum K e si trovano punteggiatura originale in-clusa nel secondo apparato50 Lrsquoanalisi delle testimonianze51 costituite ovviamente anche dalle tabelle associate saragrave condotta nella forma di una sequenza di osservazioni indicizzate da numerali o lettere oltre che di alcune note a piersquo di pagina
Iniziamo dalla descrizione del metodo di divisione anonimo
quello che leggiamo nel Vat gr 1594 (questrsquoultimo coincide con quello adottato nella recen-sione bizantina) fu apposto da Niceforo Gregora e successivamente corretto da Bessarione
48 Sto studiando il primo e il terzo codice in collaborazione rispettivamente con Daniele Bianconi e Inmaculada Peacuterez Martiacuten
49 Su questo codice risalente alla seconda metagrave del IX secolo e sulla sua collocazione nella lsquocollezione filosoficarsquo per prima proposta in Follieri 1977 pp 145-146 si vedano almeno Perria 1991 pp 82-88 Ronconi 2013 Che il titolo dei Prolegomena nel Vat gr 1594 sia stato apposto da Niceforo Gregora egrave stato riconosciuto per la prima volta in Mazzucchi 1994 p 211 n 196 si veda Bianconi 2005a p 418 per altri interventi di Gregora nello stesso manoscritto
50 Il Vat gr 198 egrave stato vergato dal copista Malachia nel corso del terzo quarto del XIV secolo Mondrain 2004 pp 278-290 e 292 Allo stesso copista (denominato non a caso prima dellrsquoidentificazione anonymus Aristotelicus) dobbiamo un buon numero di trascrizioni aristoteliche con i relativi commentari in margine Gli dobbiamo anche il Par gr 2342 secondo tomo di un quadrivium quasi completo di cui il Vat gr 198 egrave il primo nellrsquoordine aritmetica armonica astronomia (Almagesto e commentari relativi) nel codice vaticano geometria ed ancora astronomia (corpus astronomico minore) in quello parigino le opere trascritte sono sempre accompagnate in margine dai relativi commentari Il copista del Marc gr 310 egrave Isacco Argiro (ca 1300-1375) Mondrain 2007 p 166 Allo stesso Argiro dobbiamo il codice laurenziano (Daniele Bianconi per litteras) Poicheacute la recensione modificata che leggiamo nel Laur Plut 89 sup 48 egrave senza alcun dubbio basata su quella nel Marc gr 310 e non viceversa ci troviamo di fronte ad un copista che trascrive due volte lo stesso testo in due versioni leggermente differenti la conclusione naturale egrave che la seconda recensione egrave dovuta ad Argiro stesso la questione andragrave studiata in dettaglio
51 Nei manoscritti citati i Prolegomena si trovano ai fogli seguenti Vat gr 1594 ff 1r-8v (mutilo mancano due fascicoli su tre) Marc gr 313 ff 1r-28r (incompleto man-cano due fogli allrsquoinizio e il f 6 attualmente rimpiazzato da uno bianco) Marc gr 314 ff 235r-255r Vat gr 2326 ff 19r-40v e 43r-v (incompleto e con i fascicoli in disordine) Vat gr 184 ff 10r-23v Par gr 2390 ff 1r-13v Vat gr 198 ff 127r-136v Marc gr 310 ff 1r-13r Laur Plut 89 sup 48 ff 7r-19r
Fabio Acerbi142
ἐκθέμενοι οὖν διάγραμμα τῶν ἀριθμῶν ὡς ὑπόκειται προτάσσομεν τὸν μεριζόμενον καὶ μικρὸν ὑπ᾽ αὐτὸν τὸν μερίζοντα ὡς ἔχει τὸ διάγραμμα ἐν στίχοις διοριζομένοις ὑπὸ γραμμῶν [hellip] καὶ τὰ μὲν γινόμενα ἐγγὺς ἐλάττονα ἐν τῇ μεταξὺ θέσει τοῦ μεριζομένου καὶ τοῦ μερίζοντος ἐν στίχοις παρασημειοῦσθαι πρὸς τὸ ἀσύγχυτον εἶναι τὴν τάξιν τὰ δὲ μεθ᾿ ὧν ὁ μερίζων ἐποίει τοὺς ἀεὶ ἐλάσσονας ὑπὸ τὸν μερίζοντα σημειοῦσθαι προγράφοντας ἐπὶ τοῦ στίχου αὐτῶν τὸ γίνεται οὕτως γι ἐν δὲ τῷ στίχῳ τῶν μεριζόντων τὸ παρὰ ἔχον οὕτως oslash ἀντὶ τοῦ παρ᾿ ἃ δεῖ τὸν μερισμὸν γίνεσθαι ἐν δὲ τῷ στίχῳ τῶν ἐλασσόνων τὸ αφ διὰ τὸ τούτους ἀεὶ ἀφαιρεῖσθαι ἀπὸ τῶν ἐπάνω τῶν μεριζομένων ἐν δὲ τοῖς τοῦ μεριζομένου λοιπάσμασι τοῖς καὶ ἐπιοφείλουσι τὸ λ κατὰ τὸ ἴδιον τῶν διαστάσεων ἑκάστης ndash λέγω δὴ λοιπάδος ndash ἀντὶ τοῦ λοιποὶ οἱ μέλλοντες ἐπιμερίζεσθαι
2 post τὸν suprascr τὸν ἐλάττονα m 2 S 5 πρὸς] MP et ex corr Z κατὰ S om C | ἀσύγχυτον] MSPC -χητον Z 6 ἀεὶ] MZPC ὡσεὶ S 7 γίνεται οὕτως γι ] γι τ οὕτως γι τ M γί οὕτως γί Z γι οὕτως γί SC τὸ γινόμενον οὕτως γίνεται P 8 τὸ παρὰ ἔχον οὕτως] scripsi τὸ παρέχον οὕτως M et π(αρ-) comp Z οὕτως τὸ περιέχον S προγράφοντας οὕτως ex corr m 2 P τὸ περιέχον οὕτως C | oslash] MZSC (sed ο fecit | Z) ἐλάττων comp ex corr m 2 P | παρ᾿ ἃ] scripsi παρα M π(αρα) comp ZSC ex παρα fe-cit παρὰ et τοῦτον suprascr m 2 P 9 γίνεσθαι] comp C | αφ ] αφ ε M ἀφ ZSC ἀφαί P | ἀεὶ] om M 11 ἐπιοφείλουσι] MZSC ex ἐπιο- fecit ἐπο- m 2 P | λ] MZPC λ´ S 12 λοιποὶ] PC λοιποῦ MZS
3 στίχοις] στίχῳ K 5 πρὸς] διὰ K 7 ἐπὶ mdash γι ] τὸ γίνεται διὰ τοιούτου σ(ημείου) γί K 8 τὸ παρὰ ἔχον mdash παρ᾿ ἃ] τὸ παρᾱ διὰ σ(ημείου) τοιούτου καὶ τοῦτο oslash δηλοῦντος τοῦ παρᾱ ὅτι παρὰ τὸν τοιοῦτον (ἀριθμὸν) K 9 αφ διὰ τὸ τούτους] ἀφ δηλοῖ δὲ τοῦτο ἀφαίρεσ(ιν) ὅτι τούτους ἀεὶ δεῖ K 11 ἐπιοφείλουσι] ἐπιμερίζεσθαι ὀφείλουσι K | λ] λ οι` K 12 ἀντὶ τοῦ] δηλοῦντος τοῦ σ(ημείου) τὸ K
lsquoRendendo esplicito un diagramma numerico come lo troviamo qui sotto disponiamo in primo luogo il dividendo e un poco al di sotto di esso il divisore come li ha il diagramma in righe delimitate da linee [hellip] e lsaquooccorreragraversaquo nella posizione tra il dividendo e il divisore annotare lrsquouno accanto allrsquoaltro i piugrave vicini lsaquodei numerirsaquo minori che risultano affincheacute la disposizione non sia confusa quelli con cui il divisore faceva ogni volta i lsaquonumerirsaquo minori annotarli sotto il divisore scrivendo in prima posizione sulla loro riga laquorisultaraquo cosigrave Ris nella riga dei diviso-ri52 invece laquoperraquo fatto cosigrave53 P in luogo di laquoquelli per cui deve farsi la divisioneraquo nella riga dei lsaquonumerirsaquo minori laquosottrraquo in quanto questi sono sempre sottratti dai dividendi che si trovano sopra nei residuli del dividendo (occorre ben farlo anche per loro) laquoReraquo in accordo con ciograve
52 I laquodivisoriraquo sono al plurale ma siamo semplicemente di fronte a un tratto idioma-tico della lingua greca nel caso di espressioni generalizzanti crsquoegrave soltanto un divisore che occupa lrsquounica colonna di cui si compone la sua riga
53 Si intenda ἔχον οὕτως = ita se habens
1
5
10
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 143
che egrave proprio agli scarti di ciascuno ndash intendo qui lsaquociascunrsaquo residuo54 ndash in luogo di laquoresti che vanno a essere divisi ulteriormenteraquorsquo
a) Operatori di citazione e segni convenzionali I segni introdotti sono quattro la mia discussione egrave condotta dando per scontato che essi siano identici a quelli impiegati dallrsquoautore dei Prolegomena anche se si tratta di unrsquoipotesi non corroborabile neacute falsificabile
i Segno per il risultato Lrsquoabbreviazione convenzionale per γίνεται egrave identica al segno introdotto dallrsquoautore e i copisti si dividono tra i due errori possibili scrivere due abbreviazioni o risolverle entrambe Un fenomeno del tutto analogo si riscontra nel Matr 4678 il manoscritto alla base di tutta la tradizione degli Arithmetica di Diofanto al momen-to della definizione dellrsquoἀριθμός (lrsquolsquoincognitarsquo nel nostro linguaggio) ὁ δὲ μηδὲν τούτων τῶν ἰδιωμάτων κτησάμενος ἔχων δὲ ἐν ἑαυτῷ πλῆθος μονάδων ἄλογος ςο` καλεῖται ς` ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον τὸ ς` laquoil lsaquonumerorsaquo che non possiede nessuna di queste proprietagrave ma che ha in seacute una molteplicitagrave indefinita di unitagrave egrave chiamato lsquonumerorsquo e il suo segno egrave ς`raquo Qui solo il terzo dei tre ς ha una barra a sormontare per segnalarne il carattere puramente denotativo (cioegrave di segno convenzionale e non di abbreviazione si veda il punto successivo)55 il primo egrave una delle abbreviazioni piugrave diffuse per ἀριθμός (e infatti egrave dotato del compendio per la desinenza e dellrsquoaccento grave) il secondo egrave una delle piugrave comu-ni per καὶ () Giovanni Cortasmeno autore di capillari annotazioni infra lineam agli Arithmetica nel codice madrileno scioglie il primo ςο`
54 Doppia variatio che impiega al posto di λοιπόν laquorestoraquo i due termini decisamente non canonici τὸ λοίπασμα e ἡ λοιπάς (piugrave oltre leggiamo anche il participio λοιπασθέντα) Una ricerca sul TLG in rete non ha fornito occorrenze del primo si tratta dunque di uno hapax Quanto al secondo che ricorre anche nella sezione sulla divisione lsquoalla Papporsquo lo si rintraccia giagrave nei papiri documentari il termine diventeragrave perograve canonico nelle esposizioni bizantine drsquointroduzione allrsquoAlmagesto ricalcate sul modello dei Prolegomena (si veda la nota 87 infra) Questi due termini designano i resti parziali prodotti nel corso di una divisione lunga li ho tradotti rispettivamente con il neologismo laquoresiduloraquo e con il sostantivo pari-menti non canonico laquoresiduoraquo
55 Il copista interpreta erroneamente il terzo segno come unrsquoabbreviazione e qui ag-giunge un apice inverso (cioegrave un accento grave) altrove lo scioglie direttamente in forme opportune di ἀριθμός Matr 4678 f 58v La frase come la leggiamo nel manoscritto egrave cor-rotta sulla base di una parafrasi in Psello (edita in DOO II p 3710-12) Tannery emendograve ἄλογος in ἀόριστον DOO I p 64-5 et app Il Matritensis vergato da due copisti differenti (cambio di mano a tre righe dalla fine del f 62r) contiene lrsquoIntroductio arithmetica di Nicomaco e le opere diofantee oltre ad alcuni brevi opuscoli musicali la sua data egrave stata recentemente corretta dal XIII al secolo XI pm in Peacuterez Martiacuten 2006 (una riproduzione digitale del manoscritto si trova allrsquoindirizzo httpbdhbneesbnesearchbibliotecaDio-fanto20de20AlejandrC3ADa)
Fabio Acerbi144
in ἀριθμός ed aggiunge un altro segno56 sopra il terzo anteponendovi lrsquoindicazione καὶ ἔστιν αὐτοῦ σ(ημεῖον) τόδε Va da seacute che non abbiamo nessuna garanzia che il segno originariamente introdotto da Diofanto coincidesse realmente con unrsquoabbreviazione convenzionale per ἀριθμός Lrsquoevidenza del PMich III 144 (sec II in) suggerisce drsquoaltronde che il Matritensis e con esso tutta la tradizione medievale di Diofanto ripro-duca fedelmente pur accentuandone la sinuositagrave il segno originario
ii Segno per il divisore Un cerchiolino sbarrato da non confondere con il segno per ὁμοῦ che nei manoscritti matematici ha di norma due barre trasversali (cf tav 2a) Non sono riuscito a rintracciarne ulteriori occorrenze in altre opere la forma che esso assume nel Vat gr 2326 e la correzione apportata nel Par gr 2390 lasciano aperta la possibilitagrave per quanto a mio avviso remota che la forma originaria non fosse lon-tana da unrsquoabbreviazione di παρά registrata nei repertori57 Il correttore del Par gr 2390 trasforma in effetti il segno oslash nellrsquoaffine abbreviazione canonica per (forme di) ἐλάσσων laquominoreraquo58 e si incarica diligente-mente di farlo notare ricapitolando i segni nella porzione superiore del margine esterno del f 7v Nello stesso margine egli traccia anche uno lsquoscolio tabellarersquo ed egrave lrsquounico a porre il (proprio) segno dove indicato dalla descrizione (tav 6 Par gr 2390 f 7v) Oltre a ciograve adattando la tabella al margine ristretto lo scoliaste trascrive come colonne affian-cate le due righe dei resti parziali e dei massimi multipli e aggiunge le indicazioni ὁ μεριζόμενος laquodividendoraquo e ὁ μερίζων laquodivisoreraquo ma vi introduce alcune incongruenze di formato il risultato scritto in verti-cale e la linea verticale di sinistra che separa il divisore dal segno che lo dovrebbe precedere direttamente
iii Segno per i massimi multipli Corrisponde alla semplice abbre-viazione per sospensione della forma verbale ἄφελε laquosottrairaquo in questo
56 Si tratta del segno di ampio uso praticamente identico allrsquoabbreviazione canonica per οὖν
57 Si tratta di un pi a forma di gancio sbarrato da uno slash di troncamento Ce-reteli 1904 tav IX item 7 sub ΠΑΡΑ che rinvia al PVindRain 423 cf anche la forma π` nel POxy LXI 4142 edito in Jones 1999 II pp 26-34 In generale nei papiri e nei manoscritti matematici in maiuscola le preposizioni sono abbreviate facendo seguire un lsquoapostroforsquo alla loro prima lettera Α᾽ Υ᾽ ecc Per la seconda fattispecie di supporto libra-rio si veda in particolare il cosiddetto fragmentum mathematicum Bobiense scriptio inferior databile al V-VI secolo del palinsesto Milano Biblioteca Ambrosiana L 99 sup (Isidoro di Siviglia Etymologiae datazione Cavallo 1977 p 100) pp 113-114 che sono stampate in riproduzione apografa conforme in Belger 1881 (la p 114 egrave riprodotta anche nella tav 10 di Acerbi 2010)
58 Se questa era lrsquointenzione si tratta ovviamente di una forzatura il divisore puograve ben essere maggiore del dividendo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 145
caso lo slash di troncamento taglia orizzontalmente il tratto verticale del phi I copisti offrono molteplici varianti apponendo chi uno spirito dolce chi un ε chi un αί accentato a sormontare Tutti questi segni svolgono la funzione di abbreviazioni vere e proprie (e cosigrave doveva essere anche per lrsquoautore si veda il punto 1 di p 153 infra) la forma originale si ottiene a mio avviso incrociando i dati del Marc gr 313 e dei tre apografi del Vat gr 1594 αφ anche se lrsquoassenza dello spirito potrebbe essere semplicemente dovuta alla pratica del copista del codice veneziano di economizzare nei diacritici
iv Segno per i resti Un lambda completato da una barra a sormon-tare o da un apice che rinvia alle abbreviazioni per sospensione di una forma opportuna di λοιπός laquorestoraquo In realtagrave la forma che troviamo nella tabella egrave differente (tav 2b) e coincide con quella offerta quasi unanimemente dai manoscritti nella descrizione e in almeno un caso nella tabella del metodo di divisione attribuito a Pappo (tav 4) un lambda che accoglie al di sotto una legatura omicron-iota () sbarrata da uno slash di troncamento Qualcosa di simile si trova nel PVindob G 19996 (sec I) una specie di lambda maiuscolo molto aperto e dal vertice arrotondato che include un circoletto interpretato dagli editori come segno per περίεστιν o per λοιπόν59 Lo stesso segno si rintraccia ad esempio in un medesimo scolio tabellare di prima mano ad Alma-gestum nel Vat gr 1594 f 93v e nel Marc gr 313 f 135r ma stavolta la forma del lambda egrave molto ben definita
Fin qui i segni Ma il gioco egrave piugrave complesso La descrizione si muo-ve pericolosamente sulla linea di confine non sempre ben definita tra segno convenzionale e abbreviazione il primo ndash e il repertorio grafico matematico-astronomico ne egrave particolarmente fornito60 ndash puograve anche
59 Ho consultato lrsquoedizione Gerstinger ndash Vogel 1932 pp 46 e 48 la porzione rilevante del papiro egrave riprodotta nella tav 11 di Fowler 1999 Si veda ancora ivi pp 253-257 per la trascrizione di questo segmento di testo (con correzioni rispetto alla princeps) e per una messa a punto recente inclusa la proposta di datazione che ho riportato qui sopra Il verso del papiro che contiene una tavola aritmetica del tutto scorrelata dalla tematica del recto egrave edito come PRain Unterricht 151
60 La pratica di ridurre lo spazio occupato da un testo tecnico per mezzo di abbreviazioni e segni convenzionali era molto diffusa nei manoscritti in maiuscola contrariamente a quanto avviene per altri generi letterari vedremo tra breve cosa accade negli Arithmetica di Diofanto ma si leggano in proposito anche le considerazioni di Hei-berg nei prolegomena alla propria edizione dellrsquoAlmagesto in particolare riguardo al ricorso massiccio ad espedienti brachigrafici nel modello del Vat gr 180 POO II pp lxxxiv-xciii civ-cv cxxvii cxxxviii-cxxxix Agli elenchi dettagliati forniti da Heiberg possiamo aggiungere il piccolo prontuario stampato in Hultsch 1876-1878 III 2 pp 126-132 e basato sul testo e sugli scolii alla Collectio di Pappo nel Vat gr 218 (sec X in) Si vedano infine le osservazioni del copista del Par gr 2360 f 120v trascritte da Heiberg in AOO III pp x-xi sulle laquonotazioni tipiche a scopo di tagliar corto nello scrivereraquo impiegate nel pro-
Fabio Acerbi146
derivare dalla seconda (un caso egrave appunto il segno per ἐλάσσων che probabilmente trae origine da una legatura epsilon-lambda) ma poi il rapporto referente-relato si fissa convenzionalmente Quelli definiti nel testo che abbiamo letto sono appunto segni convenzionali non ci sarebbe bisogno di spiegarne forma e funzione se fossero intesi come abbreviazioni assumono nella tabella una funzione denotativa non esplicativa o discorsiva (come accade invece nella tav 1a) Ma come vengono descritti questi segni
I referenti delle descrizioni sono i segni sono introdotti da οὕτως (item i-ii) o in alternativa da un τό con il ruolo di lsquooperatore di citazionersquo (item iii-iv) che corrisponde esattamente alle nostre virgolette In entram-bi i casi gli enti sono menzionati e svolgono una funzione metalinguistica sono collocati materialmente nel testo ma egrave come se si trovassero fuori e la loro descrizione li additasse ndash in effetti i segni convenzionali scritti nel testo sono a loro volta i relata di quelli che si trovano nella tabella
I relata dei segni scritti nel testo sono di due tipi singoli vocaboli (item i-ii) o descrizioni della funzione dei segni per mezzo di clausole sintaticamente complesse (item ii e iv) I singoli vocaboli sono γίνεται e παρά e sono entrambi preceduti dal τό lsquocitazionalersquo in quanto relata di segni convenzionali le forme abbreviate con cui sono tracciati nei manoscritti vanno forzatamente sciolte Bisogna ammettere che la per-spicacia e le risorse grafiche dei copisti ndash di cui tutto si puograve dire fuor che commettano qui degli errori ndash sono messe a dura prova con lrsquointrodurre segni identici ad abbreviazioni o con lrsquoattivare un gioco metalinguistico particolarmente serrato in un contesto meno lsquonaturalersquo di come potreb-be esserlo ad esempio quello di un trattato grammaticale Lrsquoitem iii che presenta direttamente un segno identico ad unrsquoabbreviazione non egrave sorretto da una descrizione ma da una giustificazione in διὰ τό Lrsquoartico-lo τό vi assume una funzione metalinguistica anche se non lsquocitazionalersquo poicheacute al tempo stesso genera un infinito sostantivato e lo singolarizza per questo ho scritto laquosono sottrattiraquo in corsivo nella mia traduzione
prio modello archimedeo (nota 32 supra) egli ne compila anche una breve lista Un elenco antico di laquosegni della geometriaraquo sicuramente redatto per assistere il copista si trova anche al f 3v del ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 vergato da Efrem negli anni 950-960 (tav 8 in Acerbi 2010) Possiamo farci unrsquoidea quantitativa del guadagno di spazio in rapporto ad un testo privo di abbreviazioni e con le parole separate da spazi sulla base del fragmentum mathematicum Bobiense il testo vi egrave disposto a tutta pagina su 36 righe di circa 30 segni ciascuna nelle due pagine in questione figurano 2038 segni con 15 mezze righe occupate dalle due figure Ora nel testo dellrsquoedizione stabilita in Heiberg 1927 pp 87-90 le stesse pagine contano 4455 segni spazi compresi Ne risulta che la dimensione in caratteri di un testo matematico puograve essere ridotta di piugrave della metagrave con lrsquoimpiego di compendi e segni convenzionali
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 147
Negli item ii e iv il segno si collega ad una descrizione nel secondo caso in via esclusiva le descrizioni pertanto rinforzano o sostituiscono lrsquoidentificazione con lrsquoente linguistico denotato Le clausole descrittive sono precedute da ἀντί e dallrsquoarticolo τό con funzione di lsquooperatore di citazionersquo esse sono παρ᾿ ἃ δεῖ τὸν μερισμὸν γίνεσθαι (item ii) e λοιποὶ οἱ μέλλοντες ἐπιμερίζεσθαι (item iv) Nella descrizione della divisione lsquoalla Papporsquo che leggeremo tra breve i segni negli item iii e iv rice-vono lo stesso trattamento degli altri due il loro relatum egrave un singolo vocabolo e non una clausola descrittiva rispettivamente nelle espres-sioni τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε (sul participio ritorneremo nel punto 1 infra) e τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά (la forma del segno notato con λ οι egrave descritta supra nellrsquoitem iv) La descrizione del segno oslash per il divisore merita una discussione piugrave dettagliata In origine si trovava probabilmente scritto Π(ΑΡΑ)ΕΧΟΝ successivamente letto come π(αρ[α])έχον ndash dato che lrsquoabbreviazione per il preverbo egrave identica a quella per la preposizione (che sia Π᾽ o un pi seguito dal segno per ἄρα a sormontare) ndash invece di π(αρὰ) ἔχον I copisti e i correttori si dettero a tutte le possibili contorsioni per restituire un testo dotato di senso leggere appunto una forma verbale con preverbo modificare il preverbo (ma forse il segno per ἄρα era insidiosamente simile ad uno epsilon) correggere il testo rileggiamo lrsquoapparato sub τὸ παρὰ ἔχον οὕτως τὸ παρέχον οὕτως M et π(αρ-) comp Z οὕτως τὸ περιέχον S τὸ περιέχον οὕτως C προγράφοντας οὕτως ex corr m 2 P Nella clausola descrittiva seguente la presenza liminare di παρὰ (che ho corretto in παρ᾿ ἃ nella speranza di restituire una frase che abbia un senso senza intervenire sul testo) innesca un bel corto circuito il Π(ΑΡΑ) che sicuramente figu-rava nellrsquoarchetipo egrave un sintagma complesso una preposizione unrsquoab-breviazione o un segno per unrsquoabbreviazione Se lrsquoeditore si trova in conflitto con la propria inclinazione alla critica conservativa i copisti si rifiutarono di mettere mano ad un testo che doveva stridere anche per loro essendo il compito demandato al ritocco del revisore del Par gr 2390 o alla riscrittura radicale del recensore bizantino Il problema egrave che ci troviamo di fronte ad unrsquoespressione che descrive la funzione dellrsquooggetto denotato non lrsquooggetto stesso ma che lo contiene al suo interno per soprammercato qui il Π(ΑΡΑ) egrave usato per giustificare una menzione a sua volta relatum di un segno
Evidentemente questa maniera di procedere che giagrave aveva attirato interventi da parte di copisti e correttori della recensione di base parve insostenibilmente opaca allrsquoautore della recensione bizantina61 Egli
61 Uno dei manoscritti di questa recensione propone anche una tabella di divisione
Fabio Acerbi148
modifica tutte le descrizioni diluendo lrsquoidiomatismo dellrsquoarticolo lsquocita-zionalersquo con lrsquointroduzione sistematica del verbo δηλόω e di frasi atte a chiarire quale sia il segno denotante e quale il vocabolo (o il segno) denotato Egli introduce allo scopo di rendere esplicita la funzione de-notativa dei segni introdotti il termine σημείου curiosamente in tutte le sue tre occorrenze esso compare a sua volta nella forma dellrsquoabbrevia-zione per sospensione σΗ´ Egli traccia il segno per i massimi multipli ἀφ e quello per i resti λ οι` in modo che non vi siano ambiguitagrave quanto al loro carattere di abbreviazione Si faccia infine attenzione al residuo di barra sul παρᾱ con funzione denotativa (2 occorrenze) contenuto nella descrizione del segno per il divisore sostituita dallrsquoaccento grave nel παρὰ con funzione discorsiva (la differenza egrave nettissima nei manoscritti da me consultati) Questa osservazione ci permette di passare direttamente allrsquoitem seguente
b) Le barre sui numerali e sulle lettere denotative Egrave opportuno discutere questo punto adesso esattamente percheacute di barre siffatte che pure troviamo in tutti i manoscritti i nostri testi non fanno mai menzione si tratta infatti di una pratica condivisa sin dallrsquoantichitagrave La barra identifica una stringa di lettere dellrsquoalfabeto che non svolge una funzione grammaticale o sintattica propria allrsquointerno del discorso Ciograve avviene in particolare e si tratta della fattispecie piugrave frequente se la stringa di lettere non dagrave origine a un vocabolo della lingua greca lette-re denotative e numerali certo ma anche termini provenienti da altri idiomi e contrazioni di parole greche come i nomina sacra62 tali termi-ni possono essere o no preceduti da un articolo lsquocitazionalersquo a seconda dellrsquouso che ne viene fatto allrsquointerno del discorso Ma non si tratta dellrsquounica fattispecie i papiri grammaticali ed i manoscritti piugrave antichi dei trattati dello stesso argomento segnalano gli esempi delle parti del discorso (cioegrave di lsquoverersquo parole greche) per mezzo di barre sormontanti63 La differenza insomma egrave tra menzione e uso (come parte del discorso in atto) di una stringa di caratteri tra il porre le lsquovirgolettersquo e il non porle tra funzione denotativa e non Apparentemente la convenzione si limi-
corredata dei segni opportuni e contrariamente alle indicazioni della descrizione svilup-pata lsquoin verticalersquo ma per motivi misteriosi non completa (tav 7a Laur Plut 89 sup 48 f 13r)
62 Tutto ciograve egrave spiegato con estrema chiarezza giagrave in Traube 1907 pp 45-4763 Si veda il Par gr 2548 codex vetustissimus e testimone unico delle lsquoopere minorirsquo
di Apollonio Discolo il f 106v con le barre ben visibili egrave riprodotto come tav 19 in De Gregorio 2000 (ivi pp 137-138 per la datazione) Per la testimonianza dei papiri grammaticali si veda Wouters 1979 passim essi contengono di norma elenchi di parti del discorso nessuna delle quali egrave preceduta dallrsquoarticolo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 149
tava in questo secondo caso a segnalare con la barra singoli vocaboli le menzioni di frasi o di sintagmi complessi sono di norma identificate dallrsquoarticolo lsquocitazionalersquo Drsquoaltra parte le abbreviazioni convenzionali non rientrano nella casistica percheacute la loro resa grafica che contiene elementi non alfabetici come compendi per desinenze lettere supra li-neam marche di contrazione o sospensione quali slashes o barre sotto-poste o sormontanti eventualmente solo un sottinsieme della stringa di segni alfabetici le esclude automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
Venendo al discorso matematico una barra sormonta senza ecce-zione le lettere denotative64 che sia in papiri o in manoscritti in maiu-scola65 o minuscola ma solo allrsquointerno del testo comrsquoegrave da attendersi nei diagrammi esse la perdono per il semplice motivo che non crsquoegrave alcun testo ambiente un diagramma ha unicamente una funzione denotati-va Drsquoaltra parte le lettere numerali che a volte figurano nei diagrammi della tradizione metrica66 allo scopo di indicare la lunghezza dei seg-menti mantengono la barra in un diagramma il contesto denotativo geometrico egrave prevalente e i numerali vengono percepiti come entitagrave grafiche lsquoesternersquo al discorso Va da seacute a fortiori che le lettere numerali inserite in un testo dovranno essere segnalate da barre che a loro volta non servono nelle tavole67 in quanto queste ultime sono come abbiamo visto un vero e proprio testo che perograve funge da ambiente a quello al-fabetico limitato alle titolazioni e non a caso tracciato in unrsquoopportuna lsquomaiuscola distintivarsquo allo scopo di segnalarne il carattere denotativo e non discorsivo68 Una tabella operazionale egrave invece un paratesto e quindi le barre sulle lettere numerali che rappresentano gli interi sono
64 La notazione per le lettere denotative subigrave unrsquoevoluzione (il cui risultato finale egrave descritto per sommi capi nella nota 3 supra) di cui non mette conto occuparsi qui
65 I papiri di contenuto geometrico (o astronomici ma che presentano argomenti geometrici) sono rari si vedano il PHerc 1061 (sec II aC Demetrio Lacone De geome-tria) e il PFay 9 (sec II ex Elementi I 39 e 41) Gli importanti ostraka OBerl 12002 e 12609 (sec III aC m Elementi XIII) non pongono le barre sopra le lettere denotative Per i manoscritti in maiuscola si veda ad esempio passim nel Par gr 2389 una cui riproduzione digitale egrave consultabile in rete allrsquoindirizzo httpgallicabnffrark12148btv1b8470171d o il fragmentum mathematicum Bobiense
66 Si veda ancora il ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 codex unicus dei Metrica di Erone e contenente una raccolta importante di problemi del corpus metrologico
67 Si vedano come esempio le tavole citate alle note 10 e 14 supra Discorso a parte per il segno di lsquoposto vuotorsquo si veda il punto c che segue
68 Queste regole generali vanno prese cum grano salis si dagrave naturalmente un certo dominio di variabilitagrave legato verosimilmente al grado di cultura grafica del copista nel PMich III 144 i numerali sono quasi tutti senza barra sia nel testo che nelle tabelle ope-razionali
Fabio Acerbi150
necessarie esse mancano invece sui segni convenzionali che ho descrit-to nel punto precedente e fatto rilevante sulle lettere numerali relative agli ordini sessagesimali quando esse siano identificate da uno o piugrave apici la presenza di questo segno grafico non alfabetico69 le esclude ancora una volta automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo Unrsquoultima osservazione che ci saragrave utile nel seacuteguito la descrizio-ne di una stringa di lettere lsquoagrammaticalersquo non puograve prevedere la men-zione della presenza della barra che le pertiene in quanto tale si tratta di una pratica denotativa che egrave possibile formulare soltanto ad un livello di discorso superiore sia a quello dellrsquouso che a quello della menzione70
c) Il segno di lsquoposto vuotorsquo Si noti nella tav 2b la forma ŏ per il segno di lsquoposto vuotorsquo in un ordine sessagesimale coerentemente con la propria notazione il copista del Marc gr 313 lo scioglie talvolta allrsquoin-terno del testo principale come unrsquoabbreviazione per οὐδέν laquonienteraquo Altre convenzioni di scrittura del tratto che accompagna il circoletto e che si badi bene fa parte integrante del segno di lsquoposto vuotorsquo ndash e infatti nelle tavole troviamo sempre il segno completo mentre tutti gli altri numerali sono come abbiamo visto nel punto precedente privi di barra o di apice a causa del fatto che i vari ordini sessagesimali sono univocamente determinati dalle linee di giustificazione ndash un tratto an-golare anteposto (tav 3 Lar Plut 2818 f 136v)71 o una semplice barra a sormontare (tavv 4-9) si produce in questo modo il segno 65926 che sembra essere stata la forma di base72
69 Occorre dunque supporre come testimoniano papiri e manoscritti in maiuscola che la convenzione relativa allrsquouso della barra si sia consolidata ben prima dellrsquointroduzione di segni diacritici quali accenti e spiriti
70 Si veda il punto 2 infra per maggiori dettagli sulla questione delle barre e degli apici e per le indicazioni in merito che leggiamo in Diofanto
71 Come accennato questa tavola dei sottomultipli coincide con quella descritta ed esposta nei Prolegomena Fatto molto rilevante i numerali nella prima non recano neacute barre neacute apici contrariamente a quanto accade a tutte le istanze della seconda nei manoscritti Quella del Laur Plut 2818 preserva a mio avviso la forma originaria come abbiamo visto una tavola non richiede segni aggiuntivi sulle lettere numerali
72 Si vedano come esempio ancora le tavole citate alle note 10 e 14 supra oppure per una rassegna delle forme che il segno assume nei manoscritti piugrave antichi delle Tavole facili Tihon 2011 pp 58-59 e per quelle che assume nei papiri Jones 1999 I pp 61-62 Ovviamente non possiamo leggere il segno 65926 come un omicron con una barra in quanto ο = 70 nella notazione greca e la barra egrave di rigore quando il numerale figuri allrsquointerno di un testo Occorre ammettere che si dagrave origine ad un bel corto circuito notazionale con il concepire un segno con funzione di lsquoposto vuotorsquo ma che lsquosomigliarsquo ad una lettera dellrsquoalfabeto sormontata da una barra cioegrave ad un numerale in piugrave quando il lsquoposto vuotorsquo non corrisponda ad un intero ma ad una specie sessagesimale la presenza della barra a priori indistinguibile da quella che sormonta gli interi introduce unrsquoincongruenza con la notazione a mezzo di apici vista nellrsquoitem precedente
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 151
d) Errori di copia La tabella riprodotta nella tav 2b ha una forma simmetrica ma si tratta di una forzatura il grande rettangolo in basso a destra drsquoaltronde assente nella descrizione contiene uno scolio che fa notare come lrsquoultimo resto parziale ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ͵γτνζ´´´´´ κζ´´´´´´ cioegrave 0 0 0 0 0 3357 27 siano ἔγγιστα λ´λ´ δ´δ´ ξ laquocon ottima approssimazione 60 minuti quartiraquo dove si notino gli apici semplici per indicare il pas-saggio allrsquoordinale e il raddoppiamento del sistema segno + apice per significare il plurale Lo scolio debitamente accompagnato dal segno di rimando in forma di simbolo solare egrave stato probabilmente incluso nella tabella proprio allo scopo di renderla simmetrica A sua volta un errore precedente spiega lo spazio eccessivo accordato al rettangolo contenente lo scolio il secondo massimo multiplo ŏ λβ´ ξδ´´ ριβ´´´ σιϛ´´´´ egrave trascritto anche al di sotto del risultato
Passiamo ora alla descrizione del metodo di divisione attribuito a Pappo
ἵνα οὖν ταῦτα συναχθῇ τὰ ἐκ τοῦ μερισμοῦ ὁ εἰρημένος Πάππος εὐδιατύπῳ τινὶ καὶ πρὸς τοῦτο τάξει χρησάμενος ποιεῖται τὴν τῆς συλλήψεως τοῦ ζητουμένου ἀνεύρεσιν οὕτως ἐκθέμενος γὰρ τὸν μέλλοντα μερίζεσθαι τουτέστι τὰς τξ μοίρας ἐν ἀρχῇ ἀφαιρεῖ ἀπ᾽ αὐτῶν τὸν ἐν τῇ σελίδι τυγχάνοντα ἐλάττονα τουτέστι τὸν τδ κβ´ κ´´ ὄντα τῶν ἐγγὺς ἐλασσόνων ὡς πρὸς τοὺς ἐκκειμένους διὸ καὶ γράφει αὐτὸν προγράφων αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε καὶ εὑρίσκων τὰ παρακείμενα αὐτῷ τῷ ἀπογραφέντι ἐν τῷ σελιδίῳ λεπτὰ πρῶτα ν´ συναπογράφεται παρατιθῶν αὐτοῖς τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον ἀνατείνουσαν σημαῖνον τὸ εἶδος ὅτι πρῶτα λεπτά εὑρίσκει οὖν οὕτως τὸ τῶν τξ μέρος τὸ τδ κβ´ κ´´ ὃ μεριζόμενον παρὰ τὰς τξε ιδ´ μη´´ ἡμέρας καὶ ποιοῦν τὸν ἐκ τοῦ μερισμοῦ ἀριθμὸν πρῶτα λεπτὰ ν´ καὶ τὸν λοιπὸν ἀπογραφόμενος τὸν νε λζ´ μ´´ προτάσσει αὐτοῦ τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά τάσσει δὲ καὶ ἁπλῆν τινα διατείνουσαν γραμμὴν ὡς ἀπὸ τοῦ τξ ἐπὶ τὸν ἑξῆς ἐκτεθειμένον ἐγγὺς
1
5
10
1 εὐδιατύπῳ] ZSPC εὐδιατύπωτ M 4 ἀφαιρεῖ] MZSP ἀφ ι C 5 ἐλάττονα] P comp MZSC 6 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | αφ ] αφ ε M ἀφ ZS ἀφαί P ἄφ C | ἀντὶ] om C | ἄφελε] MZSP ἄφ C 8 ἀπογραφέντι] MZSP ἐγγραφέντι C | λεπτὰ πρῶτα] P λε πρωτα SC λεπτῶν πρωτ MZ | παρατιθῶν] MZS παρατιθεὶς C et ex corr m 2 P 9 ᾱ] Z αο P α´ MS α C | ἔχον] MPC ἔχων ZS 9-10 πρῶτα λεπτά] ZP πρωτ λ´λ´ M πρωτα λε S αα λε C 11 ἡμέρας] comp codd | ἀριθμὸν] P et comp MZ καὶ C et comp S 12 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M πρωτ λεπτ(α) Z πρωτ λ εᾱ S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C | ἀπογραφόμενος] MZSP ἐγγραφόμενος C | νε λζ´] MZSP λζ νζ C 13 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | λ οι] MZSC ex λ fecit λ οι P | προσσημαῖνον] MC et προσ- comp ZS προση- P | τὸ] MZC τὰ S et fecit m 2 P 14 ἀπὸ] MZSP πρὸς C ἐλάττονα] P comp MZSC
1 εὐδιατύπῳ] εὐδιατυπώτω K 6-7 αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ] τὸ ἀφ K 8 παρατιθῶν mdash 10 λεπτά] τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ σημαίνουσαν τὸ εἶδος αὐτῶν ὅτι ᾱ λεπτά εἰσιν K | τὸ (sec)] τὰ K 12 πρῶτα] πρώτων K | τε λ ] λ οι` K | προσσημαῖνον mdash
Fabio Acerbi152
ἐλάττονα τὸν τδ κβ´ κ´´ ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις καὶ ταύτην ἐπιδεικνύουσαν τὴν τάξιν τῆς προόδου τῆς ἐκθέσεως ἧστινος κλωμένης γραμμῆς πρὸς τῷ ἐγγὺς ἐλάσσονι ἡ ἀντανάκλασις ἐπὶ τὸν λοιπὸν γέγραπται φερομένη ὡς εἴρηται διὰ τὸ εὔτακτον τῆς προκοπῆς οὕτως τε ποιήσας ἑξῆς τὸ αφ ποιῶν ὃ προσσημαίνει ὡς εἴρηται τὸ ὅτι δεῖ ἀφελεῖν ὁμοίως ἀπὸ τοῦ λοιποῦ καὶ δὴ τὸν ἐγγὺς πάλιν ἐλάσσονα ὡς πρὸς τὴν ἐν τῷ σελιδίῳ ἔκθεσιν εὑρισκόμενον λαμβάνων ἑξῆς προγράφει αὐτὸν ὄντα νδ μζ´ ιγ´´ ιβ´´´ καὶ εὑρίσκει αὐτοῖς παρακείμενα ἐν τῷ σελιδίῳ πρῶτα λεπτὰ θ´ ἅτινα καὶ αὐτὰ προσαπογράφεται σὺν τῇ παρασημειώσει τῶν πρώτων γράφων τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον τὴν ἀνατείνουσαν καὶ ὡς εἴρηται τὴν γραμμὴν πάλιν διὰ τὴν τάξιν κλωμένην κατὰ δευτέραν κλάσιν προσέλκει γινομένου τοῦ μέρους αὐτῆς τούτου παραλλήλου τῷ ἐξ ἀρχῆς
16 ante κλωμένης add ἐπὶ C 18 τε] MZP om SC | αφ ] M ἀφ ZSC ἀφαί P 19 προσσημαίνει] MS προση- ZC et ex corr P | ὅτι] ZP comp MSC 20 δὴ] MZSC διὰ fecit m 2 P 21 πρὸς] MSP et supra lineam C ex ἀπὸ fecit m 2 Z | ιγ´´] MZSP νγ´´ C 22 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M ᾱᾱ λεπτὰ Z άάα λε S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C 23 προσαπο- γράφεται] απο suprascr in comp M 24 ᾱ] ZP α´ MS α C 25 κλάσιν] MP τάξιν ZSC | τοῦ] ZSPC τούτου M 26 τούτου] τοῦ bis ZSPC sed prius erasit m 2 P τοῦ M
mdash 18 προκοπῆς] om K | τε ποιήσας] ποιήσας καὶ K | αφ ] ἀφ K 19 τὸ] om K 21 προ-γράφει] γράφει K 22 σελιδίῳ] α´ σελιδίῳ K | ἅτινα] ἃ K 23 προσαπογράφεται] ἀπογράφεται K | τῶν πρώτων mdash 26 ἐξ ἀρχῆς] om K
lsquoAllo scopo di raccogliere ciograve che risulta dalla divisione il detto Pappo utilizzando anche in questo caso una certa disposizione ben strutturata determina nel modo seguente il lsaquonumerorsaquo cercato preso nel suo insieme collocando73 in testa il lsaquonumerorsaquo che sta per essere diviso cioegrave i 360 gradi iniziali sottrae loro tra i piugrave prossimi dei lsaquonumerirsaquo minori rispetto a quelli esposti quello che si trova essere minore nella colonna (cioegrave 304 22 20) Questo egrave il motivo per cui lo trascrive scrivendogli davanti lrsquoabbreviazio-ne laquosottrraquo per laquosottrairaquo e trovando che 50 minuti primi sono collocati accanto a quello stesso lsaquonumerorsaquo che egrave stato trascritto nella colonna li trascrive al tempo stesso collocando accanto74 ad essi la lettera A con un lsaquotrattorsaquo75 sopra che significa la specie minuti primi Trova dunque in que-sto modo la parte di 360 che egrave 304 22 20 la quale divisa per 365 giorni 14 48 fa il numero lsaquoche risultarsaquo dalla divisione 50 minuti primi Trascrivendo
73 La descrizione egrave strutturata come una procedura Acerbi 201274 Il purismo del correttore del Par gr 2390 di Clostomalle nel Marc gr 314 e
dellrsquoautore della recensione bizantina impone loro di modificare la terminazione ma forme tematiche e contratte di τιθεῖν sono correnti nel greco tardivo
75 Il testo greco ha solo il participio con γραμμήν sottinteso Per il significato del participio si veda il punto 2
15
20
25
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 153
poi il resto 55 37 40 gli pone altresigrave76 a prefisso laquoReraquo che significa laquorestiraquo e dispone anche una certa linea semplice77 che va da 360 al piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori che egrave esposto di seacuteguito 304 22 20 come nello lsaquoschemarsaquo esposto linea che mostra lrsquoordine del percorso dellrsquoesposizione Questa linea spezzata lagrave dove si trova il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori egrave tracciata inflessa allrsquoindietro lsaquoersaquo punta verso il resto come egrave stato detto in vista di una progressione ordinata E cosigrave facendo prendendo di seacuteguito il laquosottrraquo che significa come egrave stato detto laquoche occorre similmente sottrarre dal re-storaquo e ovviamente prendendo di nuovo il lsaquonumerorsaquo che egrave trovato essere il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori in relazione alla disposizione nella colonna ndash 54 47 13 12 ndash lo scrive di seacuteguito e trova che 9 minuti primi sono posti loro accanto nella colonna trascrive78 anche questi con la segnaletica dei primi scrivendo la lettera A con un lsaquotrattorsaquo sopra e come egrave stato detto prolunga di nuovo la linea spezzata in vista di una buona disposizione tramite una seconda inflessione essendo questa sua parte parallela a quella inizialersquo
La descrizione continua con una serie di laquoe cosigrave viaraquo e non fa ulte-riore riferimento alla tabella
1) La forma verbale ἐξεσμένον Egrave il neutro del participio perfetto medio-passivo di ξέω lett laquopialloraquo laquolevigoraquo Si danno tre possibilitagrave si tratta di un termine canonico per quanto non altrove attestato per designare unrsquoabbreviazione oppure lrsquoautore anonimo improvvisa sul piano metaforico come se unrsquoabbreviazione non fosse altro che la paro-la completa lsquoaccorciata a colpi di piallarsquo in maniera opportuna oppure il testo egrave corrotto e srsquoimpone una correzione ad esempio τὸ ἑξῆς μένον laquociograve che sta di seacuteguitoraquo Questrsquoultima strada mi pare chiusa dal senso delle frase lrsquoabbreviazione non lsquosta di seacuteguitorsquo a niente ma anzi precede la perifrasi τὸ ἑξῆς μένον se impiegata semplicemente per rimandare al segno αφ immediatamente seguente costituirebbe un intollerabile solecismo Se accettiamo la prima di queste letture considerando quin-di lrsquoabbreviazione αφ in posizione predicativa abbiamo a che fare con
76 Rendo in questo modo il τε isolato77 La linea egrave laquosempliceraquo in quanto egrave una retta la precisazione intende evidenziare per
anticipazione il carattere lsquonon semplicersquo che essa assumeragrave alla prima inflessione quando diventeragrave una spezzata linee siffatte erano in effetti concepite dallrsquoanonimo e prima di lui da tutta la tradizione matematica greca come una singola linea spezzata nei punti drsquoinfles-sione I due segmenti paralleli menzionati al termine del passo sono orizzontali
78 Il verbo egrave al medio in variatio rispetto ai due che precedono e che seguono egrave il matematico che lsquosirsquo trascrive le cifre
Fabio Acerbi154
uno hapax semantico nella grecitagrave superstite come egrave facile verificare con una ricerca sul TLG in rete La recensione bizantina risolve il pro-blema sopprimendo semplicemente τὸ ἐξεσμένον
2) La notazione per le specie numeriche Nella terminologia matema-tica greca gli ordini sessagesimali sono εἴδη laquospecieraquo numerici essi corri- spondono agli ordini di grandezza nel nostro sistema decimale e indica-no in analogia con il caso geometrico la lsquoformarsquo che assume un numero quadrato cubo ecc Centinaia e migliaia sono quindi degli εἴδη rispet-tivamente quadrati (100 egrave il quadrato di 10) e cubi (1000 egrave il cubo di 10) sono specie numeriche ma non numeri particolari e drsquoaltronde 300 non egrave un quadrato ma 3 item dellrsquoεἶδος lsquoquadratorsquo 100 3 egrave il numerale di molteplicitagrave della specie quadrata lsquocentinaiarsquo i due 0 che seguono il 3 segnalano esattamente questo fatto che la notazione greca per gli interi non posizionale fa scomparire al livello denotativo Ciograve non vale soltan-to per i numeri interi ma anche per le loro parti i minuti secondi appar-tengono alla specie lsquoquadratorsquo in quanto 13600 egrave il quadrato di 160
La concezione appare interamente dispiegata nellrsquointroduzione degli Arithmetica diofantei79 che si rivela giova farlo rimarcare un te-stimone fondamentale per la ricostruzione della notazione matematica antica Alle specie usate in questrsquoopera vengono assegnati una denomi-nazione ed un segno convenzionale costituito dallrsquoiniziale (di ognuno dei componenti) della denominazione al quadrato o δύναμις il segno ΔΥ al κύβος il segno ΚΥ alla lsquoquarta potenzarsquo o δυναμοδύναμις il segno ΔΥΔ ecc La descrizione di tali segni egrave del tipo καὶ ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον Κ ἐπίσημον ἔχον Υ ΚΥ κύβος laquoe il suo segno egrave un Κ che ha come indice un Υ ΚΥ cuboraquo dove in accordo con quanto abbiamo visto nel punto b supra e pur nel comprensibile imbarazzo del copista della prima parte del Matritensis (o di un suo passato collega) a districarsi in questo formidabile ginepraio notazionale80 le due lettere Κ e Υ ricevono una barra mentre ΚΥ non la richiede a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον il quale ancora una volta esclude automaticamente il segno dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
79 In particolare a DOO I pp 214-62180 Nel Matr 4678 riscontriamo i seguenti fenomeni nelle poche righe a cavallo dei ff
58r-v 1) accento acuto posto su tutti i segni come se fossero abbreviazioni 2) ripetizione sistematica segnodenominazione come in ΚΥ κύβος appena letto dovuta sicuramente allrsquointrusione di glosse interlineari esplicative dei segni ndash e successivo pentimento (δύναμις e κύβος sono in effetti cancellati dalla prima mano il primo con un tratto il secondo con dei punti supra lineam poi il copista si stanca di correggere) 3) nella descrizione del segno per la δυναμοδύναμις menzione di un δέλτα δύο che saragrave molto probabilmente stato ΔΔ subito dopo nella descrizione del κυβόκυβος si legge un incongruo δύο KK
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 155
Diofanto introduce poi dei segni anche per le specie delle parti dellrsquounitagrave (le nostre frazioni) che egli chiama ὁμώνυμα μορία laquoparti omonimeraquo di cui quelle sessagesimali sono casi particolari81 Egli spie-ga appunto che le loro denominazioni sono ottenute da quelle delle specie degli interi per sinonimia passando ad un lsquoordinalersquo82 formato semplicemente aggiungendo il suffisso -στον δυναμοστόν κυβοστόν δυναμοδυναμοστόν ecc (sott μόριον) I loro segni convenzionali sono invece ottenuti da quelli per le specie degli interi aggiungendo una γραμμὴν διαστέλλουσαν τὸ εἶδος laquolinea che distingue la specieraquo83 Una linea sui segni delle specie delle parti egrave richiesta si badi bene per distinguerli dai segni di quelle degli interi come giagrave osservato questi ultimi sono giagrave lsquoagrammaticalirsquo a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον a fortiori lo saranno anche i primi Si tratta della traduzione semio-tica del passaggio dal cardinale allrsquoordinale che a livello grammaticale egrave effettuato con il suffisso -στον Che forma ha questa linea Barra o apice (Egrave cervellotico pensare a forme piugrave complesse) La domanda non ammette una risposta immediata in quanto delle specie diofantee nessuno piugrave si occupa nellrsquoantichitagrave84 Se egrave vero che la prima risposta darebbe origine ad un conflitto tra due convenzioni denotative diffe-renti la barra lsquocitazionalersquo e la barra che distingue la specie lrsquoevidenza grafica del Matritensis lascia lievemente sgomenti (ricordiamoci che giagrave i segni di base sono indebitamente dotati di un accento dal copista) Le poche occorrenze del segno per le specie delle parti85 vedono lrsquoaggiunta di uno slash di sospensione di un doppio apice inverso ndash in tutta evi-
81 Questo fatto era giagrave chiaro nellrsquoantichitagrave Teone in Alm I 10 in iA p 45310-1682 Il parallelo con i cardinali e gli ordinali relativi agli interi egrave reso esplicito da Dio-
fanto ὥσπερ δὲ τῶν ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια παρομοίως καλεῖται τοῖς ἀριθμοῖς τοῦ μὲν τρία τὸ τρίτον τοῦ δὲ τέσσαρα τὸ τέταρτον οὕτως καὶ τῶν νῦν ἐπονομασθέντων ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια κληθήσεται παρομοίως τοῖς ἀριθμοῖς laquocome le parti omonime dei numeri sono chia-mate per assonanza con i numeri di lsquotrersquo lsquolsaquounrsaquo terzorsquo di lsquoquattrorsquo lsquolsaquounrsaquo quartorsquo cosigrave le parti omonime dei numeri appena nominati saranno chiamate per assonanza con i numeriraquo (DOO I p 69-13 si noti lrsquoarticolo lsquocitazionalersquo al singolare in τοῦ τρία e τοῦ τέσσαρα) Il parallelo prosegue anche al livello dei segni che rappresentano queste specie come vedremo tra un attimo
83 Diofanto Arithmetica prefazione in DOO I p 620-21 un passaggio maltrattato in questa edizione occorre espungere il participio ἔχον senza introdurre segni ulteriori oppure eliminare un precedente ἐπί come fa un correttore del Matritensis f 58v
84 Unica parzialissima eccezione lrsquoaccenno di Teone menzionato nella nota 81 supra85 Al f 59r e per di piugrave nel margine per sanare un lungo saut du mecircme au mecircme La
collocazione in margine egrave il motivo per cui troviamo una notazione abbreviata nel resto del trattato il primo copista scioglie tutti i segni prendendoli per abbreviazioni mentre il secondo elimina sistematicamente il tratto aggiuntivo delle specie delle parti dellrsquounitagrave Drsquoaltronde egli scrive ad esempio ΔΥ invece di ΔΥ ed egrave quindi indotto a porre la barra al di sopra della stringa di lettere risultante (passim ma si veda ad esempio il f 72r)
Fabio Acerbi156
denza il compendio per la desinenza -ον accentata il copista interpreta il segno come unrsquoabbreviazione ndash e di una barra a sormontare lo Υ Potremmo forse interpretarlo come il segno di contrazione del grafema -στ- lrsquounico tassello mancante in unrsquoabbreviazione come ad esempio (δυναμοδυναμο)(στ)(ὸν) ma uno scolio di prima mano al f 58v rela-tivo alle specie degli interi inficia questrsquoipotesi esse sono dotate di slash di sospensione accento acuto in un caso del compendio canonico per la terminazione -ον hellip ma tutti gli Υ a esponente sono a loro volta sormontati da una barra
Meno legata al singolo manoscritto ma nondimeno non uniforme si presenta la pratica di notazione dei segni che rappresentano gli enti numerici sessagesimali86 da una parte sta lrsquoevidenza del testo dei Pro-legomena e delle sue tabelle apici ndash drsquoaltronde come abbiamo visto la notazione universalmente impiegata per i numerali ordinali e per le fra-zioni unitarie ndash dallrsquoaltra sta lrsquoevidenza del testo dellrsquoAlmagesto in tutti i manoscritti piugrave antichi e lo stesso si dica del commentario teonino a questrsquoopera o del suo lsquoGrande commentariorsquo alle Tavole facili e dei testi astronomici su papiro barre87 Sembra insomma che la nostra docu-
86 Sia le molteplicitagrave che le specie ahimeacute entrambe rappresentate da lettere dellrsquoalfabeto Come osservato allrsquoinizio della sezione 3 ci sono in effetti due tipi di lettere numerali in gioco se facciamo astrazione da apici o barre lsquo4 minuti secondirsquo si trova scritto δ β la prima lettera numerale denota la molteplicitagrave degli item di una certa specie la se-conda la specie nei Prolegomena entrambe sono accompagnate da un doppio apice il che rende inutile la presenza delle seconde Si noti che la descrizione della tabella non fa parola della notazione da usare per le lettere numerali che denotano la molteplicitagrave barre o apici e quanti apici hellip In questo caso fa interamente fede la tabella cioegrave la pratica grafica condivisa instauratasi non egrave chiaro quando
87 I manoscritti piugrave antichi dellrsquoAlmagesto sono menzionati nella nota 10 supra quelli dei due commentarii teonini sono il Laur Plut 2818 e il celeberrimo Vat gr 190 (sec IX in Euclide Elementi Data Teone lsquoGrande commentariorsquo) per la notazione dei pa-piri astronomici si veda Jones 1999 II passim La notazione non sembra lsquoinquinatarsquo dalla pratica dei copisti bizantini e pare dipendere soltanto dalla data di composizione Tro-viamo ad esempio barre sopra tutti i numerali di molteplicitagrave (interi o sessagesimali) nel frammento di un commentario alle Tavole facili contenente un calcolo relativo al 24 aprile 213 (Par gr 2841 sec XIII ex-XIV in oltre al frammento ai ff 32r l 11-34v l 23 contiene Arato Phaenomena ed Efestione Apotelesmatica edizione in Jones 1990) Nel commentario alle Tavole facili composto ca 610-617 ed attribuito a Stefano di Alessandria la situazione egrave la seguente (Jean Lempire per litteras per lrsquoedizione si veda Lempire 2014 ho controllato il Vat gr 304 ff 135r-171v sec XIV am contiene in aggiunta Teone in Almagestum I-II lsquoPiccolo commentariorsquo alle Tavole facili Diofanto Arithmetica e De polygo-nis numeris varia astronomica tabulae) barre sopra gli interi sporadicamente rimpiazzate da apici apici sopra le parti sessagesimali in numero uguale alla denominazione doppio () apice per le frazioni unitarie Sono impiegate barre sopra gli interi e apici sopra le parti sessagesimali nei manoscritti principali di tutti i trattati di introduzione allrsquoAlmagesto o comunque di argomento logistico redatti in epoca bizantina Giorgio Pachimere (1242-ca 1310) Quadrivium (autografo nel manoscritto Roma Biblioteca Angelica gr 38 [RGK III nr 115] si veda Tannery ndash Steacutephanou 1940 per lrsquoedizione) Teodoro Metochita (1270-
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 157
mentazione si faccia testimone di un cambio notazionale avvenuto nel periodo intercorrente fra Teone (sec IV pm) e la scuola alessandrina di Ammonio e dei suoi allievi (sec VI in) e probabilmente innescato da questrsquoultimo ambiente lrsquoaspetto paradossale egrave che nello stesso codice si rintraccino due notazioni differenti per gli enti numerici sessagesimali e lrsquouna (apici) sia adottata sistematicamente e coerentemente in uno scritto (i Prolegomena) che si presenta esattamente come unrsquointroduzione tecnica alla pratica numerico-algoritmica del trattato (lrsquoAlmagesto) in cui egrave adottata lrsquoaltra (barre che ritroviamo senza eccezioni anche negli scolii)
Torniamo ai Prolegomena la descrizione del segno da porre a fianco di ogni singolo quoziente parziale e denotante la sua specie numerica (minuti primi minuti secondi ecc) solleva tre problemi
Primo problema Ci vuole una barra o un apice su τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquola lettera A [hellip] che significa la specieraquo quando lo scriviamo nella tabella Tutta la nostra discussione precedente fa pro-pendere per lrsquoapice e si ricordi anche la forma verbale ἀνατείνουσαν che suggerisce qualcosa che si lsquoestende verso lrsquoaltorsquo (la mia traduzione egrave volutamente neutra) se fosse apposta una barra la cosa dovrebbe passare
1231332) Compendium astronomicum (copia lsquoautorizzatarsquo coeva nei Vat gr 182 e 181 da parte del copista che integrograve le parti mancanti del Par gr 2389 [ff 207-210 255-270 374-375] Bianconi 2005a pp 425-427 Peacuterez Martiacuten 2008 p 436 e n 177) Teodoro Meliteniota (morto lrsquo831393) Tribiblos astronomica (autografo nel Vat gr 792 si vedano Leurquin 1991 per unrsquoanalisi del manoscritto Leurquin 1990 per lrsquoedizione) una com-pilazione anonima (per cui ho consultato il Par gr 2396 ff 87r-92v limitatamente a questi fogli manu Costantino Trivoli [RGK II nr 318 ma ovviamente questo codice non vi egrave segnalato] terzo quarto del XV secolo il resto del codice annotato da Niceforo Gregora egrave di etagrave planudea e parzialmente [ff 33v-76v] un autografo di Planude stesso contiene Teone in Almagestum I II IV Mondrain 2002 il codice va completato ndash limitatamente a stralci dei libri VIII-X XII-XIII del commentario teonino la cui parte intermedia si egrave persa ndash con 26 carte [ff 123-147] inserite nel Vat gr 1087 anchrsquoesso contenente anno-tazioni di Gregora Rome 1927 per la figura del copista dei ff 77r-86r del Par gr 2396 e dei ff appena nominati del Vat gr 1087 un anonimo collaboratore di Gregora si veda in ultimo Bianconi 2006a pp 147-151) si veda anche il calcolo effettuato da Niceforo Gre-gora (12921295-13581361) dellrsquoeclisse di sole del 16 luglio 1330 (attestata unicamente ai ff 1r-8v della miscellanea astronomica Marc gr 325 databile ca 1324-1329 in parte vergata e ovunque fittamente annotata da Gregora stesso edizione del testo in Mogenet et al 1983 annotazioni di Gregora elencate in Bianconi 2005a p 413) Unrsquoeccezione apparente il lsquoPiccolo commentariorsquo di Teone alle Tavole facili le parti sessagesimali sono segnalate da apici (ad esempio nel Vat gr 175 vergato da Giovanni Catrario e completato nel 1321-1322 sulla figura di Catrario si vedano in ultimo Bianconi 2005b pp 141-156 e 2006b) lrsquoopera egrave antica ma la sua tradizione non rimonta oltre la fine del XIII secolo a parte un frammento nel Leiden BPG 78 ff 156r-161v (minuscola del IX-X secolo) e in effetti in questo manoscritto tutti i numerali di molteplicitagrave sono sormontati da barre Unrsquoeccezione effettiva egrave il De hypotesibus planetarum nel Vat gr 1594 barre sugli interi e apici sulle parti sessagesimali
Fabio Acerbi158
sotto silenzio e la presenza dellrsquoapice la rende inutile88 Si tratta della stessa convenzione diofantea e coincide ancora con la notazione per i numerali ordinali e per le frazioni unitarie che egrave corrente nei mano- scritti matematici greci per questo motivo non percheacute la descrizione sia particolarmente perspicua nessuno dei copisti della recensione an-tica ha incertezze apici Ma questi apici si rintracciano soltanto sulle indicazioni di specie non contemplate dalla descrizione che sono ante-poste ai resti parziali a fianco dei quozienti parziali i segni di specie sono invece trasformati in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordi-nali corrispondenti del tipo πρωτ tavv 5 e 7b-8 Il recensore bizantino taglia invece la testa al toro elimina dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali elimina la seconda menzione della laquolet-tera Araquo contestualmente allrsquoazzeramento dellrsquoespediente della linea a zig-zag (si veda il punto seguente) modifica la descrizione che contiene la prima menzione in quella dellrsquoapice associato direttamente ai nume-rali di molteplicitagrave riciclando addirittura lrsquoalpha per adibirlo a desi-gnare un numero cardinale (come sorprendersi) τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ laquoponendo al di sopra di essi [scil dei 50 minuti primi] 1 solo lsaquoaccentorsaquo acutoraquo La scelta del recensore egrave assennata che rechi una barra o un apice in una tabella un alpha denota un numero non un numero drsquoordine
Secondo problema da tenere ben distinto dal precedente Cosa ci vuole sul segno α per la lettera alpha menzionata nella frase τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquolettera A [hellip] che significa la specieraquo89 Unrsquooc-chiata allrsquoapparato critico rivela una bella incertezza nei manoscritti Z scrive sempre ᾱ e in un caso lo fa anche P MS optano sempre per α´ C per α P scrive nellrsquoaltro caso αο Per quanto solo la barra sia congrua con il senso della frase in quanto la lettera alpha egrave qui menzionata (si tratta di un oggetto che compare nella tabella) e non cambia niente se essa egrave accompagnata dal suo nome di genere στοιχεῖον ad un livello grafico lrsquoincertezza fra il segno ᾱ che denota laquola lettera αraquo e il segno α´ (o lrsquoabbreviazione αο) per una forma di πρῶτος egrave per piugrave versi giustificata
88 Detto in altri termini la barra egrave uno strumento grafico non matematico e quindi la sua presenza non va segnalata mentre un apice lo egrave e la sua presenza lo deve
89 Notare che in questa frase il primo α non vuole la barra (egrave menzionato allrsquointerno di una frase che impiega convenzioni moderne) il secondo sigrave (idem ma con convenzioni antiche) ndash e nella traduzione la scelta di denotarlo con A (senza virgolette) e non con lsquoArsquo (con virgolette) egrave del tutto arbitraria ndash si noti inoltre che le necessarie precisazioni laquosenzacon virgoletteraquo mostrano che le lingue moderne palesano difficoltagrave analoghe a quelle del greco antico per quanto riguarda i livelli denotativi in ambito metadiscorsivo per non usare le due parentetiche avrei dovuto scrivere rispettivamente lsquoArsquo e lsquolsquoArsquorsquo (doppie virgolette semplici)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 159
ᾱ coincide con il numerale 1 α egrave la prima lettera dellrsquoalfabeto ed inoltre α´ egrave esattamente quello che va scritto nella tabella Potremmo dirci che il sostantivo στοιχεῖον chiude la questione la sua presenza congiunta ad un ipotetico α´ renderebbe la descrizione ridondante o inappropriata90 Ma a parte il fatto che α egrave proprio τὸ πρῶτον στοιχεῖον il segno α´ cat-tura in fondo il cuore della descrizione di uno στοιχεῖον ἔχον lsaquoγραμμὴνrsaquo ἀνατείνουσαν
Terzo problema Lrsquoautore dei Prolegomena che si arresta allrsquoesem-pio dei minuti primi non dice quanti apici occorre mettere sulle lettere numerali che identificano gli ordini superiori al primo se uno soltanto come nel caso diofanteo e delle frazioni unitarie o in numero uguale alla loro denominazione (cioegrave pari al numero denotato dal numerale stesso su cui vanno posti) come effettivamente avviene nei mano-scritti dei Prolegomena La tabella egrave quindi sottodeterminata dalla sua descrizione anzi in un certo senso prende il sopravvento su di essa la pratica di marcare i numerali di molteplicitagrave con gli apici che compe-tono allrsquoordine cui appartengono viene trasferita ai segni per gli ordini stessi per supplire ad una descrizione carente di questi ultimi E la tabella egrave sottodeterminata dalla descrizione in quanto egrave la descrizione di una tabella reale ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις laquocome nello lsaquoschemarsaquo espostoraquo leggiamo a un certo punto del testo
3) La linea a zig-zag Non possiamo che applaudire a questo geniale espediente grafico lo troviamo messo in opera solo nel Marc gr 313 Per quanto lrsquoautore non faccia parola di ciograve nel corso della sua descrizione la linea spezzata egrave intesa dover lsquosaltarersquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue Il copista del codice marciano effettua correttamente due salti nella prima delle sue tabelle (tav 4) ma inserisce un lsquodentersquo in piugrave in quella che considera corretta (tav 5) La linea a zig-zag egrave incompatibile con la presenza di linee di giustificazione nella tabella che in effetti mancano nel Marc gr 313 ciograve induce gli errori di allineamento dei primi 5 quozienti parziali di cui egrave vittima il copista Probabilmente per questo motivo in nessuno degli apografi del Vat gr 1594 la linea a zig-zag figura nella tabella inquadrata come si conviene da una (doppia) cornice esterna e le cui colonne sono appunto separate da linee verticali (tav 7b Vat gr 184 f 17v e tav 8 Par gr 2390 f 9v cui egrave sostanzialmente identica la tabella del Marc gr 314 che si trova
90 Trascuro lrsquoabbreviazione αο = πρῶτος percheacute la desinenza non egrave quella richiesta neacute nella frase (egrave richiesto πρῶτον) neacute nella tabella (πρῶτα)
Fabio Acerbi160
al f 248r ndash ma la mancanza di linee orizzontali causa un gigantesco pa-sticcio nel codice vaticano) Alla recensione bizantina che dipende per il suo testo di base dal Vat gr 1594 e quindi non trova la linea a zig-zag nella tabella non resta che sopprimere la sua descrizione ndash ma proprio per questo motivo e finalmente diventa possibile tracciare un apparato completo di linee di giustificazione (tav 9 Laur Plut 89 sup 48 f 14v) Dato che la descrizione di Teone di questo procedimento di divi-sione non fa cenno allrsquoesistenza della linea a zig-zag viene da chiedersi se essa non costituisca un espediente escogitato dallrsquoautore dei Prolegomena per vivacizzare la procedura originale di Pappo
4) Discrepanze tra descrizione e tabella Il gioco delle minime va-rianti mostra che la divisione era stata eseguita (e trasmessa) corret-tamente tutti i valori numerici sono esatti La tabella nel Marc gr 313 presenta perograve alcune discrepanze con la propria descrizione Essa omette (ma non nella versione lsquoscorrettarsquo lrsquoomissione non si riscontra neanche nel Par gr 2390) il segno per laquorestoraquo di fronte ai resti par-ziali ma aggiunge lrsquoindicazione della loro specie Essa trasforma invece come abbiamo visto le indicazioni di specie che seguono i quozienti parziali in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordinali corri-spondenti La descrizione prevede di chiudere la tabella con il risultato καὶ συνάγων ἅπαντα τὰ ἐκ τῶν μερισθέντων μερῶν λεπτὰ σημειοῦται ὑπὸ πάντας οὕτως γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoe raccogliendo tutti i minuti che provengono dalle parti divise lsaquoPapporsaquo nota sotto tutto cosigrave Ris 0 59 8 17 13 12 31raquo ma sotto la tabella tutta la tradizione ci consegna qualcosa di piugrave articolato ὁ ζητούμενος καθ᾽ ὃν μερίζεται ὁ τξε ιδ´ μη´´ π(αρὰ) τὸν τξ γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoil lsaquonumerorsaquo cercato secondo cui 365 14 48 egrave diviso per 360 risulta 0 59 8 17 13 12 31raquo frase che del resto contiene due errori lrsquoinversione del dividendo e del divisore e la confusione tra segno convenzionale (iuxta descrizione) e abbreviazione (come nella frase) nel caso di γι Oltre ad eliminare la linea a zig-zag91 la recensione bizantina sopprime dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali e modifica come abbiamo visto al punto 2 le loro descrizioni in quelle di apici associati diretta-mente ai numerali di molteplicitagrave
91 Le due righe che nella recensione di base contengono solo i resti parziali minori di 160 del divisore ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue sono in parte completate con lrsquoindicazione abbreviata ἀνάλ(υσις) laquoanalisiraquo il termine greco per questa procedura di riduzione In un sussulto di ipercorrettismo matematico tali resti parziali ridotti non sono preceduti dal segno per laquorestoraquo come nel Par gr 2390 ma da quello per laquorisultatoraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 161
Gli esempi che abbiamo discusso mostrano come i problemi di notazione pesino e non poco sullrsquoespressione discorsiva di un algorit-mo matematico lrsquoente di riferimento per lsquoformularersquo il procedimento di divisione fu considerata la tabella cioegrave un oggetto la cui costitu-zione egrave legata piugrave ad una pratica grafica che a considerazioni logico- algoritmiche non la sua descrizione che in effetti finisce per determi-nare la tabella in maniera non univoca Di questa sottodeterminazione si fa testimone la traiettoria che abbiamo cercato di seguire nelle mani di copisti e revisori il procedimento di divisione si modifica a volte in aspetti secondari a volte in punti piugrave sostanziali ndash fino a rendere neces-saria una radicale revisione della sua descrizione per renderla conforme alla tabella ndash in ogni caso mai per ragioni squisitamente matematiche92
Abstract
The article presents and discusses in detail two passages from the anonymous Prolegomena to the Almagest a VIth century primer to the elementary procedures of calculation needed in Ptolemyrsquos Almagest In the two passages we may follow the complex interplay between mathematical notation the auctor who employed and described it the tachygrapher who transcribed it in vivo copyists who reproduced it correctors who modified it Along this path misgivings and errors arise in the transmission of abbreviations and paratextual units such as diagrams tables operational schemes
Fabio AcerbiCNRS UMR8560 Centre Alexandre Koyreacute
fabacerbigmailcom
92 Sono grato a Daniele Bianconi Lucio del Corso Jean Lempire per alcune preziose indicazioni
AOO = Archimedis opera omnia cum commentariis Eutocii ed J L Heiberg I-III Lipsiae 1910-1915
DOO = Diophanti Alexandrini opera omnia cum Graecis commentariis ed P Tannery I-II Lipsiae 1893-1895
GC = Le laquoGrand Commentaireraquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Mogenet ndash A Tihon I-III Cittagrave del Vaticano 1985-1999
iA = Commentaires de Pappus et de Theacuteon drsquoAlexandrie sur lrsquoAlmageste ed A Rome I-III con paginazione continua Cittagrave del Vaticano 1931-1943
HOO = Heronis Alexandrini opera quae supersunt omnia ed G Schmidt ndash L Nix ndash W Schmidt ndash H Schoene ndash J L Heiberg I-V Lipsiae 1899-1914
PC = Le ldquoPetit Commentairerdquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed A Tihon Cittagrave del Vaticano 1978
POO = Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia ed J L Heiberg I-II in 3 parti Lipsiae 1898-1907
RGK = Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600 I Handschriften aus Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln II Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs und Nachtraumlge zu den Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln III Handschriften aus Bibliotheken Roms mit dem Vatikan A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg unter Mitarbeit von D Harlfinger und P Eleuteri B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln Wien 1981-1997 (Oumlsterreichische Akademie der Wissenschaften Veroumlffentlichungen der Kommission fuumlr Byzantinistik III1-3 A-C)
Sigla
Acerbi 2010 = F Acerbi Il silenzio delle sirene La matematica greca antica Roma 2010
Acerbi 2012 = F Acerbi I codici stilistici della matematica greca dimostrazioni procedure algoritmi laquoQUCCraquo 1012 (2012) pp 167-214
Acerbi et al 2010 = F Acerbi ndash N Vinel ndash B Vitrac Les Proleacutegomegravenes agrave lrsquoAlmageste Une eacutedition agrave partir des manuscrits les plus anciens Introduction geacuteneacuterale ndash Parties I-III laquoSCIAMVSraquo 11 (2010) pp 53-210
Agati 1992 = M L Agati La minuscola laquoBouleteacuteeraquo Cittagrave del Vaticano 1992
Belger 1881 = C Belger Ein neues Fragmentum mathematicum Bobiense laquoHermesraquo 16 (1881) pp 261-284
Bianconi 2005a = D Bianconi La biblioteca di Cora tra Massimo Planude e Niceforo Gregora Una questione di mani laquoSampTraquo 3 (2005) pp 391-438
Bianconi 2005b = D Bianconi Tessalonica nellrsquoetagrave dei Paleologi Le pratiche intellettuali nel riflesso della cultura scritta Paris 2005
Bianconi 2006a = D Bianconi Le pietre e il ponte ovvero identificazioni di mani e storia della cultura laquoBizantinisticaraquo 8 (2006) pp 135-181
Bianconi 2006b = D Bianconi Qualcosa di nuovo su Giovanni Catrario laquoMEGraquo 6 (2006) pp 69-91
Cavallo 1977 = G Cavallo Funzione e strutture della maiuscola greca tra i secoli VIII-XI in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Colloque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 95-137
Cereteli 1904 = G F Cereteli De compendiis scripturae codicum Graecorum praecipue Petropolitanorum et Mosquensium anni nota instructorum Sankt-Petersburg 1904
De Gregorio 2000 = G De Gregorio Materiali vecchi e nuovi per uno studio della minu-scola greca fra VII e IX secolo in G Prato (a cura di) I manoscritti greci tra riflessione e dibattito Atti del V Colloquio Internazionale di Paleografia Greca Cremona 4-10 ottobre 1998 Firenze 2000 pp 83-151
Follieri 1977 = E Follieri La minuscola libraria dei secoli IX e X in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Col-loque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 139-165
Fonkič 2005 = B Fonkič Venecianskaia rukopisrsquo laquoAlrsquomagestaraquo Ptolemeja (Marc gr 313690) o datirovke i proischoždenii kodeksa laquoVDIraquo s III 254 (2005) pp 162-167
Fowler 1999 = D H Fowler The Mathematics of Platorsquos Academy A New Reconstruction Second Edition Oxford 1999
Bibliografia
Fabio Acerbi164
Gerstinger ndash Vogel 1932 = H Gerstinger ndash K Vogel Eine stereometrische Aufgaben-sammlung im Papyrus Graecus [sic] Vindobonensis 19996 laquoMitteilungen aus der Papy-russammlung der Nationalbibliothek in Wienraquo Neue Serie Folge 1 Griechische literarische Papyri 1 Wien 1932 pp 11-76
Heiberg 1927 = Mathematici Graeci Minores ed J L Heiberg Kjoslashbenhavn 1927
Hultsch 1876-1878 = Pappi Alexandrini Collectionis quae supersunt ed F Hultsch I-III Berlin 1876-1878
Janz 2003 = T Janz The Scribes and the Date of the Vat gr 1291 in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae X Cittagrave del Vaticano 2003 pp 159-180
Jones 1990 = Ptolemyrsquos First Commentator ed A Jones Philadelphia 1990
Jones 1999 = Astronomical Papyri from Oxyrhynchus ed A Jones I-II Philadelphia 1999
Jones 2005 = A Jones Ptolemyrsquos Canobic Inscription and Heliodorusrsquo Observation Reports laquoSCIAMVSraquo 6 (2005) pp 53-97
Lempire 2014 = Steacutephanos drsquoAlexandrie Le commentaire aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Lempire Louvain 2014
Leurquin 1990 = Theacuteodore Meacuteliteacuteniote Tribiblos astronomique Livre I ed R Leurquin Amsterdam 1990
Leurquin 1991 = R Leurquin Un manuscrit autographe de la Tribiblos Astronomique de Theacuteodore Meacuteliteacuteniote le Vaticanus graecus 792 laquoScriptoriumraquo 45 (1991) pp 145-162
Maas 1927 = P Maas Griechische Palaeographie in A Gercke ndash E Norden (hrsg von) Einleitung in die Altertumswissenschaft I9 Leipzig 1927 pp 69-80
Martinelli Tempesta 2010 = S Martinelli Tempesta Il codice Milano Biblioteca Am-brosiana B 75 sup (gr 104) e lrsquoevoluzione della scrittura di Giovanni Scutariota in A B Garciacutea ndash I Peacuterez Martiacuten (ed by) The Legacy of Bernard de Montfaucon Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting Proceedings of the Seventh Inter-national Colloquium of Greek Palaeography Madrid-Salamanca 15-20 September 2008 Turnhout 2010 pp 171-186
Mazzucchi 1994 = C M Mazzucchi Leggere i classici durante la catastrofe (Costantino-poli maggio-agosto 1203) le note marginali al Diodoro Siculo Vaticano gr 130 Parte prima stratigrafia laquoAevumraquo 68 (1994) pp 164-218
Mioni 1976 = E Mioni Bessarione scriba e alcuni suoi collaboratori in Miscellanea marcia-na di studi bessarionei Padova 1976 pp 263-323
Mioni 1985 = Codices graeci manuscripti Bibliothecae Divi Marci Venetiarum II Thesaurus Antiquus Codices 300-625 recensuit E Mioni Roma 1985
Mogenet 1962 = J Mogenet Une scholie ineacutedite du Vat gr 1594 sur les rapports entre lrsquoastronomie arabe et Byzance laquoOsirisraquo 14 (1962) pp 198-221
Mogenet et al 1983 = Niceacutephore Greacutegoras Calcul de lrsquoeacuteclipse de soleil du 16 juillet 1330 ed J Mogenet ndash A Tihon ndash R Royez ndash A Berg Amsterdam 1983
Mondrain 2002 = B Mondrain Maxime Planude Niceacutephore Greacutegoras et Ptoleacutemeacutee laquoPa-laeoslavicaraquo 10 (2002) pp 312-322
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 165
Mondrain 2004 = B Mondrain Lrsquoancien empereur Jean VI Cantacuzegravene et ses copistes in A Rigo (a cura di) Gregorio Palamas e oltre Studi e documenti sulle controversie teologiche del XIV secolo bizantino Firenze 2004 pp 249-296
Mondrain 2007 = B Mondrain Les eacutecritures dans les manuscrits byzantins du XIV e siegravecle Quelques probleacutematiques laquoRSBNraquo n s 44 (2007) pp 157-196
Peacuterez Martiacuten 2006 = I Peacuterez Martiacuten Maxime Planude et le Diophantus Matritensis (Madrid Biblioteca Nacional ms 4678) un paradigme de la reacutecupeacuteration des textes anciens dans la ldquorenaissance paleacuteologuerdquo laquoByzantionraquo 76 (2006) pp 433-462
Peacuterez Martiacuten 2008 = I Peacuterez Martiacuten El lsquoestilo Hodegosrsquo y su proyeccioacuten en las escrituras constantinopolitanas laquoSampTraquo 6 (2008) pp 389-458
Perria 1991 = L Perria Scrittura e ornamentazione nei codici della laquocollezione filosoficaraquo laquoRSBNraquo n s 28 (1991) pp 45-111
Rollo 2012 = A Rollo LrsquoArchimede di Giorgio Valla in V Fera ndash D Gionta ndash A Rollo (a cura di) Archimede e le sue fortune Atti del Convegno di Siracusa-Messina 24-26 giugno 2008 Messina 2012 pp 99-147
Rome 1927 = A Rome Membra disjecta laquoRBenraquo 39 (1927) pp 187-188
Rome 1938 = A Rome Un manuscrit de la bibliothegraveque de Boniface VIII agrave la Meacutediceacuteenne de Florence laquoACraquo 7 (1938) pp 261-268
Ronconi 2013 = F Ronconi La collection philosophique un fantocircme historique laquoScripto-riumraquo 67 (2013) pp 119-140
Tannery ndash Steacutephanou 1940 = Quadrivium de Georges Pachymegravere ed P Tannery ndash E Steacutephanou Cittagrave del Vaticano 1940
Tihon 2011 = Πτολεμαίου Πρόχειροι Κανόνες Les Tables faciles de Ptoleacutemeacutee vol Ia Tables A1-A2 ed A Tihon Leuven 2011
Traube 1907 = L Traube Nomina Sacra Versuch einer Geschichte der christlichen Kuumlrzung Muumlnchen 1907
Vogel 1936 = K Vogel Beitraumlge zur griechischen Logistik laquoSBAWraquo Mathematisch-natur-wissenschaftliche Abteilung Jahrgang 1936 pp 357-472
Wouters 1979 = A Wouters The Grammatical Papyri from Graeco-Roman Egypt Contri-butions to the Study of the lsquoArs Grammaticarsquo in Antiquity Brussel 1979
F ACERBI Tav 1
b Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 65r
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 284 f 160r
F ACERBITav 2
b Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 13r
a Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 19v
F ACERBI Tav 3
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 136v
F ACERBITav 4
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17r
F ACERBI Tav 5
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17v
F ACERBITav 6
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 7v
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
Funzioni e modalitagrave di trasmissionedelle notazioni numeriche
nella trattatistica matematica grecadue esempi paradigmatici
Fabio Acerbi
1 Il maestro il suo allievo il copista il correttore
Lo scopo di questo lavoro egrave presentare due passi dei Prolegomena ad Almagestum una compilazione anonima tuttora inedita nella sua inte-rezza1 redatta non prima dellrsquoinizio del VI secolo nella cerchia degli al-lievi del filosofo neoplatonico Ammonio Essa contiene lrsquounico lsquomanuale di logisticarsquo pervenutoci dallrsquoantichitagrave greca una descrizione dettagliata di come effettuare le operazioni aritmetiche elementari fra numeri non interi espressi nel sistema sessagesimale Si tratta se dobbiamo dar credito al loro autore del primo scritto che contenesse unrsquoesposizione compatta esclusivamente dedicata a tecniche di calcolo2 Lrsquoopera costituiva in tutta
1 Edizione di ciograve che precede il manuale di logistica con introduzione generale in Acerbi et al 2010 Quella del manuale saragrave approntata al termine del seminario di lettura in corso presso il Centre Alexandre Koyreacute di Parigi Un terminus post quem per la datazione del manuale egrave costituito dallrsquoattribuzione di un particolare metodo di calcolo a Siriano (morto ca 437) λέγεται δὲ ἡ εὕρεσις Συριανοῦ τοῦ μεγάλου φιλοσόφου laquosi dice che la scoperta sia di Siriano il grande filosoforaquo la sfumatura dubitativa fa supporre che non sussista una continuitagrave dottrinaria stretta fra la scoperta e la sua menzione nel manuale per quanto questrsquoultimo sia indubitabilmente un prodotto di scuola neoplatonico (ibid pp 59-66) ciograve suggerisce pertanto di spostarci da Atene ad Alessandria e di far passare almeno un paio di generazioni Personalmente sono convinto che nei Prolegomena leggiamo la trascrizione della parte iniziale di un corso di Ammonio sullrsquoAlmagesto di cui fa menzione Damascio apud Fozio Bibliotheca codex 181 127a8-10 Egrave registrata anche unrsquoosservazione astrono-mica di Ammonio (morto dopo il 517) effettuata con il fratello Eliodoro il 21 febbraio 503 essa fa parte di una serie trascritta immediatamente dopo i Prolegomena in tutti i manoscritti piugrave antichi vd Jones 2005
2 Le fonti riportano titoli di opere dedicate alle tecniche di moltiplicazione e divisione di grandi numeri come i Logistica di Magno menzionati da Eutocio (AOO III pp 25830-2601) Dello stesso argomento si occupava un trattato di Apollonio di Perge epitomato e commentato da Pappo in Collectio II che non abbiamo elementi per identificare con i Logistica attribuiti ad un Apollonio ed il cui 3ordm libro egrave citato a proposito del volume della sfera nella compilazione metrologica edita da Heiberg come Stereometrica II 34 1 (HOO
Fabio Acerbi124
evidenza un primer allrsquoesecuzione di queste operazioni di cui lrsquoAlmagesto fornisce sempre e soltanto i risultati egrave stata trasmessa a morsquo di introdu-zione al trattato tolemaico da uno solo dei rami della tradizione testuale di questrsquoultimo I Prolegomena non beneficiarono di una redazione defini-tiva anzi a tratti si ha lrsquoimpressione che quanto leggiamo sia poco piugrave che la trascrizione usci-ta dalle mani del tachigrafo Piugrave recensioni bizantine di cui una eseguita da un matematico competente e trasmessa da un grup-petto di codici i piugrave antichi dei quali riferibili al pieno del XIV secolo restituiscono un testo migliore specialmente dal punto di vista sintattico
I passi che discuterograve costituiscono due dei rarissimi esempi in cui possiamo seguire lrsquointera traiettoria delle interazioni fra notazione ma-tematica auctor che la impiega e la descrive tachigrafo che la trascrive in vivo copista che la riproduce a freddo recensore che la modifica discente che dovragrave necessariamente apprenderla con lrsquoaiuto di una rap-presentazione grafica (non sempre) conforme alla descrizione Lungo lo snodarsi di questa traiettoria si generano malintesi ed errori che tro-vano sfogo in zone di irrimediabile ambiguitagrave come le abbreviazioni e le unitagrave paratestuali (diagrammi tabelle liste numeriche organizzate) Inoltre uno dei due passi contiene un termine pertinente al lessico paleografico non attestato altrove con questo significato il participio perfetto medio-passivo ἐξεσμένον per designare unrsquolaquoabbreviazioneraquo
Nella prossima sezione propongo una suddivisione tipologica dei paratesti che accompagnano o completano gli scritti matematici Nella sezione successiva mi concentro sulle disposizioni tabellari delle opera-zioni aritmetiche elementari elencando le opere e i manoscritti dove siano reperibili descrivo anche i tratti salienti del sistema sessagesimale della notazione numerica associata e degli algoritmi di moltiplicazione e di divisione Queste due sezioni presentano materiale preliminare necessario per una comprensione piena delle testimonianze la sezione finale contiene la loro analisi specifica
2 Paratesti matematici una tipologia
La classificazione qui proposta dei paratesti matematici (o suppo-sti tali) egrave preliminare e strettamente funzionale a delineare un conte-
V p 11411-12) Ancora Eutocio (AOO III p 25816-18) menziona lrsquoὨκυτόκιον unrsquoopera in cui Apollonio di Perge otteneva unrsquoapprossimazione del rapporto tra la circonferenza di un cerchio e il suo diametro migliore di quella archimedea Lo studio piugrave completo sulla logistica greca resta Vogel 1936 che perograve ebbe solo accesso ad un segmento iniziale dei Prolegomena (le parti denominate a e b nella sezione 3 infra)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 125
sto grafico in cui collocare le testimonianze saragrave opportuno ritornare sullrsquoargomento se non altro per ampliare la gamma degli esempi o raf-finare la casistica
Intendo con lsquoparatesto matematico primariorsquo ogni sistema orga-nizzato di segni contenuto originariamente in unrsquoopera matematica e differente dalla stringa di lettere alfabetiche denotative o numerali3 che si struttura in discorso di senso compiuto Questrsquoultimo costituisce il lsquotestorsquo propriamente detto Tale sistema organizzato ha normalmente un significato ed unrsquoimportanza nellrsquoeconomia dellrsquoopera e li assume in riferimento implicito o esplicito al testo Possiamo in prima battuta distinguerne tre tipologie diagrammi tavole tabelle operazionali Le descriverograve brevemente con particolare attenzione al loro formato e alla messa in pagina che ne consegue
1) Diagrammi Un lsquodiagrammarsquo egrave una figura di norma dotata di lettere denotative che rappresenta la configurazione geometrica speci-fica di una proposizione matematica Si tratta di un ente grafico dalla funzione puramente referenziale egrave descritto allrsquoinizio della proposi-zione come entitagrave individuale4 e a sua volta raffigura la configurazione geometrica egrave impossibile trarne indicazioni deduttive univoche senza la guida del testo I manoscritti piugrave antichi presentano i diagrammi tracciati in indentazioni (lsquospecchirsquo) del testo di norma poste allrsquoinizio della proposizione seguente Abbiamo motivo di supporre che questo stato di cose rifletta la convenzione di mise en rouleau originaria ndash la descrizione della configurazione geometrica non egrave piugrave lsquosottrsquoocchiorsquo man mano che il rotolo viene svolto con il procedere della dimostrazione ed occorre rivolgersi alla figura Questi fatti confermano che i diagrammi sono dei genuini paratesti
2) Tavole Una lsquotavolarsquo egrave una disposizione ordinata di lettere numerali e altri segni grafici che rappresenta i valori assunti da una determinata gran-
3 Le lettere denotative isolate o a gruppi sono i lsquonomirsquo degli enti di cui tratta una proposizione matematica sono sempre precedute da un articolo dello stesso genere dellrsquoog-getto designato (ad esempio ἡ ΑΒ per una retta) o da unrsquoespressione preposizionale intro-dotta da un articolo (ad esempio ἡ ὑπὸ ΑΒ ΒΓ per un angolo) Le lettere numerali denotano numeri di norma sono precedute dallrsquoarticolo solo a partire dalla loro seconda occorrenza in un determinato algoritmo Nessuna di queste combinazioni alfabetiche costituisce una parte del discorso in linguaggio (greco) naturale assumono una funzione sintattica (sostan-tivi) solo nellrsquoidioletto matematico Le qualificazioni lsquoprimariorsquo e lsquooriginariamentersquo nella mia definizione escludono altri tipi di paratesti come gli scolii Un discorso a parte merita-no invece le titolazioni ma non egrave il caso di affrontarlo in questa sede
4 Ciograve avviene nelle parti specifiche della proposizione denominate ἔκθεσις laquoesposi-zioneraquo e κατασκευή laquocostruzioneraquo dove al tempo stesso sono assegnate le lettere denotative
Fabio Acerbi126
dezza in funzione di un insieme discreto di valori di un parametro Una tavola-tipo egrave composta di due colonne a sinistra i valori del parametro a destra quelli della grandezza Il parametro non egrave necessariamente nume-rico5 Le colonne possono essere piugrave di due a) se piugrave grandezze omologhe oppure no legate allo stesso parametro sono per economia di spazio ri-portate su colonne affiancate b) se una grandezza ha una rappresentazione numerica complessa ad ogni ordine essendo associata una colonna6
Le tavole sono sia costruite che descritte La lsquocostruzionersquo di una tavola consiste nellrsquoesposizione delle dimostrazioni ed operazioni neces-sarie a produrre lrsquoinsieme dei suoi valori senza che questi ultimi siano calcolati singolarmente La tavola presenta dunque in modo sintetico il risultato di una serie di operazioni questa serie puograve anche essere molto lunga e complessa ed egrave quasi sempre impossibile ricavare in tempi brevi una tavola dalla sua costruzione una tavola egrave costruita una volta per tutte si rende in questo modo indipendente dalla costruzione e non egrave univocamente determinata dalla sua lsquodescrizionersquo che si limita ad indi-care quale ente costituisca il parametro e quale la grandezza tabulata ed eventualmente a fornire indicazioni di formato Una tavola egrave collocata dopo la propria costruzione e la propria descrizione ed occupa quasi sempre per intero lo spazio grafico unitario (pagina colonna di rotolo) Una tavola insomma egrave un vero e proprio testo dal formato particolar-mente perspicuo di questo testo fanno anche parte gli altri segni grafici necessari ad un suo corretto utilizzo le linee orizzontali e verticali che separano righe e colonne la titolazione che ne identifica il tipo
Esempio la lsquotavola delle cordersquo nellrsquoAlmagesto Essa contiene i va-lori delle corde inscritte in un cerchio (seconda colonna) e dei loro incrementi parziali (terza colonna) tabulati in funzione dellrsquoarco di cerchio che esse sottendono (prima colonna)7 questrsquoultimo egrave il para-metro fornito con incrementi di mezzo grado da 0ordm a 180ordm nella tavola vi sono pertanto 360 righe La costruzione della tavola occupa quasi tutto il capitolo I 10 dellrsquoAlmagesto 15 pagine e mezzo nellrsquoedizione di Heiberg la descrizione prende 11 righe scarse includendo anche le istruzioni per lrsquouso dei valori nella terza colonna la tavola stessa si estende su 16 pagine8 Egrave particolarmente importante osservare che la
5 Esempio la lsquotavola delle cittagrave illustrirsquo nelle Tavole facili tolemaiche a sinistra il nome della cittagrave a destra le sue coordinate geografiche
6 Si veda infra la sezione 3 per questa terminologia nel caso del sistema sessagesimale7 I valori delle corde sono calcolati fino al secondo ordine sessagesimale quelli dei
loro incrementi parziali in sessantesimi fino al quarto ordine la lsquoseconda colonnarsquo consiste quindi in realtagrave di 3 colonne la lsquoterzarsquo di 4
8 Rispettivamente POO I 1 pp 319-4620 ivi p 472-13 κανόνια ὑποτάξομεν ἀνὰ
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 127
mise en rouleau dellrsquooriginale era differente come Tolomeo stesso spiega nella sua descrizione le 360 righe erano ripartite διὰ τὸ σύμμετρον laquoper motivi di simmetriaraquo9 in 8 tavole affiancate di 45 righe lrsquouna che nel rotolo figuravano probabilmente con una soluzione di continuitagrave minore di un intercolumnio standard in guisa di macrocolonna I ma-noscritti medievali rispettano questa disposizione ma devono ripartire le 8 tavole su 4 pagine10 Date le dimensioni della pagina a stampa cui egrave confinato Heiberg non puograve farlo e sdoppia ogni tavola poicheacute 45 egrave dispari e a causa della presenza dellrsquoapparato critico le sue tavole per-dono tutta la simmetria iniziale Nel caso delle tavole dunque rotolo e codice comportano mises en texte differenti per una volta egrave il rotolo e non il codice il supporto ideale per questo tipo di testi
Altro esempio tavole del moto medio del sole nellrsquoAlmagesto De-notando rispettivamente con a g o m e c i valori del tempo di ritorno annuale in giorni e loro parti e dei moti (in gradi per appropriate unitagrave di tempo) giornaliero orario mensile per mese di 30 giorni annuale per lrsquoanno egiziano di 365 giorni e infine su un ciclo di 18 anni la determinazione dei restanti a partire dal valore di a ammonta alla se-guente catena di operazioni a rarr 360a = g rarr g24 = o 30g = m 365g = e rarr 18e = c Ognuno di questi valori forma la base della costruzione per addizioni successive11 delle tavole12 che denoto con le stesse lettere
στίχους με διὰ τὸ σύμμετρον ὧν τὰ μὲν πρῶτα μέρη περιέξει τὰς πηλικότητας τῶν περιφερειῶν καθ᾽ ἡμιμοίριον παρηυξημένας τὰ δὲ δεύτερα τὰς τῶν παρακειμένων ταῖς περιφερείαις εὐθειῶν πηλικότητας ὡς τῆς διαμέτρου τῶν ρκ τμημάτων ὑποκειμένης τὰ δὲ τρίτα τὸ λʹ μέρος τῆς καθ᾽ ἕκαστον ἡμιμοίριον τῶν εὐθειῶν παραυξήσεως ἵνα ἔχοντες καὶ τὴν τοῦ ἑνὸς ἑξηκοστοῦ μέσην ἐπιβολὴν ἀδιαφοροῦσαν πρὸς αἴσθησιν τῆς ἀκριβοῦς καὶ τῶν μεταξὺ τοῦ ἡμίσους μερῶν ἐξ ἑτοίμου τὰς ἐπιβαλλούσας πηλικότητας ἐπιλογίζεσθαι δυνώμεθα laquodisporrograve le tavole su 45 righe per motivi di simmetria la prima parte di lsaquoognuna dirsaquo esse conterragrave i valori degli archi incre-mentati di mezzo grado alla volta la seconda i valori delle rette corrispondenti agli archi (il diametro essendo posto di 120 gradi) la terza la 30ordm parte dellrsquoincremento delle rette per ciascun lsaquointervallo dirsaquo mezzo grado di modo che sia possibile calcolare facilmente avendo in questa maniera a disposizione il valore intermedio lsaquodellrsquoincrementorsaquo corrispondente ad un singolo sessantesimo (esso egrave differente da quello esatto in maniera impercettibile) anche i valori delle frazioni intermedie tra i lsaquovalori limitati airsaquo mezzi gradiraquo Alm I 11 ivi pp 48-63
9 Non dobbiamo sopravvalutare la componente estetica implicita nel nostro termine laquosimmetriaraquo Tolomeo si limita a far riferimento alla laquocongruenzaraquo di 45 con 360 in quanto suo divisore esatto
10 Si vedano Par gr 2389 (sec IX in Tolomeo Almagestum) ff 17r-18v Vat gr 1594 (Prolegomena ad Almagestum Tolomeo Almagestum et opera minora) ff 20v-22r Marc gr 313 (Prolegomena ad Almagestum Tolomeo Almagestum) ff 46r-47v Vat gr 180 (sec X Tolomeo Almagestum) ff 18v-20r per la datazione del secondo e del terzo codice si veda la sezione 4
11 Tolomeo accorda alla menzione di questrsquooperazione di addizione una mezza riga proprio alla fine della sua esposizione κατὰ τὰς οἰκείας ἑκάστων ἐπισυναγωγάς laquoper opportune addizioni successive dei lsaquovalorirsaquo di ciascunoraquo Alm III 1 in POO I 1 p 20924-25
12 Alm III 1 ivi pp 2091-16 e 20922-25 descrizione ivi p 20917-22
Fabio Acerbi128
maiuscole ovviamente la tavola A egrave assente Per esempio la tavola G ha come prima riga il valore g (colonna di destra) accompagnato dalla cifra α laquo1raquo (colonna di sinistra) le altre righe hanno a sinistra i numerali da 2 a 30 e a destra i multipli corrispondenti di g il valore registrato a destra nellrsquoultima riga deve evidentemente coincidere con m In omaggio al principio delle 45 righe13 troviamo dunque una prima tavola C su 45 righe (corrispondente a un periodo di 18times45 = 810 anni avente come epoca il primo anno di regno di Nabonassar) una seconda su 42 righe che combina le 18 righe di E seguite dalle 24 di O una terza ancora su 42 righe che contiene le 12 di M seguite dalle 30 di G14 ndash nella seconda
13 διὰ τὸ φανησόμενον σύμμετρον τῆς κανονογραφίας laquoper una presentazione simme-trica del tracciato delle tavoleraquo ivi p 20914-15 allusione analoga in Alm I 10 ivi p 472-3 lrsquoabbiamo letta sottolineata nella nota 8 supra
14 Per la mise en page di queste tre tavole nei manoscritti medievali si vedano Par gr 2389 ff 69v-70r Vat gr 1594 f 63r-v (in questi due codici scritti su due colonne le tavole occupano unrsquointera pagina piugrave la prima colonna della successiva) Marc gr 313 f 98r-v (questo codice vergato a tutta pagina adotta momentaneamente una disposizione su due colonne al f 98v la prima contiene la tavola la seconda lrsquoinizio del capitolo successivo) Vat gr 180 ff 60v-61v Nelle Tavole facili dello stesso Tolomeo che passano a cicli di 25 anni e allrsquoepoca di Filippo le tavole appena descritte sono presentate con precisione ridotta rispetto a quelle dellrsquoAlmagesto nellrsquoordine C (periodo di 25times59 = 1475 anni) E (ciclo di 25 anni) M (direttamente con i nomi dei mesi del calendario egiziano mentre lrsquoAlmagesto ripartisce il parametro in multipli di 30 giorni fino a 360) G O Ogni tavola egrave suddivisa in unitagrave colonnari di non piugrave di 30 righe + titolazione La lsquotavola delle cordersquo non egrave inclusa nelle Tavole facili per le tavole del moto medio del sole e della luna nei manoscritti medievali di questrsquoopera si vedano Leiden Bibliothek der Rijksuniversiteit BPG 78 ff 91r-93v Laur Plut 2826 ff 71r-73v Vat gr 1291 ff 38r-40v Marc gr 331 ff 45r-47v ndash le parti in maiuscola di tutti questi codici contengono unicamente le Tavole facili e si datano sulla base dellrsquoultimo imperatore di cui il copista principale abbia riportato gli anni di regno nel cosid-detto canon regius nellrsquoordine Leiden BPG 78 copiato sotto il regno di Leone V 813-820 Vat gr 1291 copiato poco dopo il regno di Niceforo I 802-811 (Janz 2003) Laur Plut 2826 copiato sotto il regno di Leone VI 886-912 Marc gr 331 privo del canon regius e forse copiato anchrsquoesso sotto il regno di Leone VI si veda anche Tihon 2011 pp 19-41 per una sintesi e per ulteriori indicazioni bibliografiche Ovviamente anche le Tavole facili erano state concepite per il rotolo Tra lrsquoaltro Tolomeo sembra trascrivere nella stessa tavola i moti medi di Sole Luna Cor Leonis (la stella Regolo) e dei cinque pianeti cosa impossibile a farsi su una sola pagina di codex si legga la descrizione che ne dagrave nella parte iniziale del lsquomanuale di istruzionirsquo alle Tavole facili stesse in POO II p 1607-19 Nei manoscritti medievali questa tavola egrave smembrata poco dopo lrsquoinizio della sequenza di tavole si trovano i moti medi di Sole e Luna piugrave avanti quelli di Regolo e dei cinque pianeti Piugrave in generale il passaggio al codice comportograve una riorganizzazione delle lsquotavole facilirsquo dal piano originario in cui tutte quelle di longitudine erano molto verosimilmente raggruppate insieme e precedevano quelle di latitudine ad un ordinamento per corpi celesti (Tihon 2011 pp 12-14) Le Tavole facili furono copiate molto presto su codice i lsquopapirirsquo di questrsquoopera sono quasi unicamente su codex di pergamena (Jones 1999 I pp 102-108 e 160-168 edizione dei POxy LXI 4167-4173a contenenti frammenti delle Tavole facili ivi II pp 118-161 solo il primo di essi proviene sicuramente da un rotolo) Giagrave in pieno IV secolo Teone di Alessandria nel suo lsquoPiccolo commentariorsquo alle Tavole facili afferma che alcune di esse possono estendersi su πλειόνων πτυχίων laquopiugrave pagineraquo (PC p 2016 allinterno dellunica definizione di lsquotavolarsquo rintracciabile nel corpus antico) cosigrave le leggiamo attualmente nei manoscritti
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 129
e nella terza tavola il numero di righe egrave piugrave basso percheacute occorre pre-vedere uno spazio per il titolo addizionale Per mantenerne il formato tripartito Heiberg egrave costretto a stampare le tavole ruotate di 90ordm
Che le tavole siano dei testi egrave confermato da due fatti aggiuntivi e strettamente connessi15 Primo il lsquomanuale di istruzionirsquo alle Tavole facili che Tolomeo stesso redasse fu scritto ed ha circolato come opera a parte Secondo dalla descrizione delle tavole dettagliata ma priva di costruzione contenuta nello stesso lsquomanualersquo egrave impossibile ricavarne il contenuto numerico e la maniera drsquoimpiego16 a illustrare questrsquoultima provvederagrave una ricchissima tradizione di commentari di cui leggiamo ancora quelli di Teone il lsquoPiccolo Commentariorsquo spiega come usarle per scopi specifici il lsquoGrande Commentariorsquo come dedurle dallrsquoAlmagesto17 Le Tavole facili sono insomma unrsquoopera il cui testo egrave interamente strut-turato in formato tabulare
3) Tabelle operazionali Una lsquotabella operazionalersquo egrave una disposi-zione ordinata di lettere numerali e altri segni grafici che rappresenta lrsquoalgoritmo di unrsquooperazione aritmetica Ci troviamo in realtagrave di fronte a due modi di eseguire lrsquooperazione la tabella intende in qualche mi-sura riprodurre la dinamica operazionale dellrsquoalgoritmo questrsquoultimo si risolve a sua volta in una descrizione della tabella che senza tale de-scrizione risulterebbe incomprensibile e quindi non adattabile ad una differente operazione una tabella operazionale ha in questo caso una funzione paratestuale Si presuppone perograve che il discente apprenda a ri-produrre lrsquooperazione direttamente nel formato tabellare non in quello algoritmico In questo secondo caso una tabella operazionale assume una funzione testuale piena18 Lo statuto (para)testuale delle tabelle operazionali egrave pertanto oscillante nei commentari teonini allrsquoAlmagesto e soprattutto nei Prolegomena ad Almagestum di cui andremo ad occu-parci esse sono descritte in dettaglio e si configurano pertanto come genuini paratesti in Eutocio in Circ esse sono semplicemente eseguite e quindi assumono un ruolo testuale Nei manoscritti medievali la col-locazione di una tabella operazionale originaria egrave variabile e dipende dalle sue dimensioni e dalla capacitagrave del copista di identificarla come
15 Per un argomento ulteriore si veda la sezione 4 punto b16 POO II pp 159-18517 Nessuno dei due titoli ha fondamento nella trasmissione manoscritta la seconda
opera era detta realizzare una συμφωνία tra lrsquoAlmagesto e le Tavole facili Entrambi i com-mentari sono stati editi criticamente PC GC I-III
18 Resta il fatto che la quasi totalitagrave delle tabelle operazionali che rintracciamo nei manoscritti egrave relegata nei margini dellrsquoattivitagrave di annotazione degli scoliasti
Fabio Acerbi130
tale di solito le troviamo nei margini ma possono occupare lrsquointero specchio di scrittura e ciograve indipendentemente dalla determinazione del loro statuto paratestuale sulla base del criterio della presenzaassenza di una descrizione
Lo statuto meno elevato dei genuini paratesti (diagrammi e tabelle) rispetto ai testi (catene algoritmico-argomentative e tavole) indusse un atteggiamento differenziato in copisti ed editori attenti a rispettare lrsquointegritagrave dei secondi ma non dei primi ciograve che conta sono le informa-zioni veicolate dalle strutture discorsive e dalle porzioni alfanumeriche di diagrammi tavole e tabelle il resto egrave ritenuto adattabile alle esigenze dellrsquoedizione moderna19 o semplicemente ignorato nel corso del pro-cesso di copia in questa maniera si perdono perograve informazioni e strut-tura Come vedremo puograve avvenire che una parte della descrizione di unrsquooperazione resti senza relato nella resa grafica tabellare lrsquooperazione eseguita in forma algoritmica non corrisponde piugrave a quella eseguita in forma di tabella
3 Testi logistici e disposizione tabellare delle operazioni
Nessun testo matematico primario di etagrave ellenistica o imperiale contiene operazioni aritmetiche eseguite con una sola eccezione la de-scrizione che non ammette una rappresentazione tabellare del procedi-mento di estrazione approssimata di radice quadrata in Erone Metr I 8 Drsquoaltro canto abbiamo giagrave osservato che lrsquoAlmagesto di Tolomeo for-nisce il risultato di migliaia di operazioni ma nessuna di esse egrave eseguita Attestazioni di questi procedimenti sono pertanto legate ad iniziative editoriali di secondo livello come i commentari alla loro prima occor-renza oppure in casi paradigmatici gli algoritmi di calcolo omessi nel testo primario vi sono resi espliciti Di fatto e con una sola eccezione la nostra documentazione consiste in commentari allrsquoAlmagesto quello di Teone e i Prolegomena ad Almagestum
19 Abbiamo giagrave visto alcuni esempi di modifiche del formato delle tavole Quanto ai diagrammi quelli tracciati nelle edizioni moderne rappresentano il caso piugrave generale pos-sibile Le figure che troviamo nei manoscritti greci hanno invece la caratteristica opposta illustrano spesso casi particolari e sono metricamente scorrette Sono in effetti tracciati triangoli rettangoli isosceli cerchi uguali rette perpendicolari dove tutto ciograve non egrave richiesto dallrsquoenunciato e inoltre rettangoli invece di parallelogrammi segmenti uguali quando sia-no disuguali addirittura linee rette al posto di curve (in Archimede Meth 14 un arco di parabola egrave rappresentato da un angolo rettilineo) e in generale figure con proprietagrave di simmetria non richieste
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 131
LrsquoAlmagesto e con esso tutta la tradizione astronomica adotta il sistema sessagesimale per esprimere la parte non intera di un nu-mero che siano valori angolari o lineari non fa differenza20 come noi scriviamo 36524 e intendiamo 365 + 2 decimi + 4 centesimi (cioegrave 4102) cosigrave nel sistema sessagesimale 365 14 48 significa21 365 + 14 sessantesimi + 48 tremilaseicentesimi (cioegrave 48602) ovverosia nel lessico antico e nostro 365 14 πρῶτα λεπτά laquominuti primiraquo 48 δεύτερα λεπτά laquominuti secondiraquo dove laquoprimoraquo e laquosecondoraquo sono le laquodenominazioniraquo degli ordini (sono cioegrave numeri ordinali) 14 e 48 i lsquonumerali di molteplicitagraversquo relativi ai due ordini numerale di mol-teplicitagrave e relativa denominazione costituiscono insieme una lsquoparte sessagesimalersquo di un numero Drsquoaltronde per gli antichi come per noi lrsquoespressione di una parte non intera (ovvero di una frazione)
20 Trascuro il fatto ai nostri fini irrilevante che essendo i numerali greci lettere alfabetiche la notazione che ne risulta per i numeri interi non egrave posizionale nonostante le cifre scagravelino di un posto ad ogni potenza di dieci il segno μ per 4 (decine) non egrave identico al segno δ per 4 (unitagrave) Drsquoaltra parte una volta adottata la notazione decimale per i numerali di molteplicitagrave la notazione complessiva per la parte non intera espressa nel sistema sessa-gesimale non egrave posizionale neanche introducendo un segno di lsquoposto vuotorsquo una cui parte egrave nel caso greco analoga in forma al nostro 0 (su questo segno si veda ancora la sezione 4 punto c) occorre avvalersi di accorgimenti ulteriori quali lrsquointroduzione di spaziature fra le differenti parti sessagesimali (come viene fatto nei manoscritti greci ed in questrsquoarticolo) o di segni tipografici (come suggerito da Otto Neugebauer che avrebbe scritto 3651448 il numerale che leggeremo tra un attimo nel testo) Il problema egrave che altrimenti lrsquoordine associato ad un numerale di molteplicitagrave di una parte sessagesimale puograve non risultare uni-vocamente determinato dalla sua posizione Esempio scrivendo 0129 per un numero non intero nel sistema sessagesimale il numerale di molteplicitagrave 129 potrebbe rappresentare 1 minuto primo e 29 secondi oppure 12 minuti primi e 9 secondi ecc e la stessa difficoltagrave si presenta nella notazione greca (per la nozione di lsquonumerale di molteplicitagraversquo si veda infra nel testo) Il problema scomparirebbe se adottassimo singoli segni differenti per tutti i nu-merali da 1 a 59 ndash ma neacute noi neacute i greci siamo stati disposti a introdurre una complicazione siffatta Si ricordi infine che al di fuori dei contesti astronomici il sistema di numerazione greco egrave decimale
21 Scriverograve i numerali in cifre arabe sempre in questo modo parte intera seguita dalle parti sessagesimali (minuti primi secondi ecc) con ogni ordine separato da uno spazio bianco Se la parte intera egrave assente il numerale inzia con uno 0 Nella trascrizione dei numerali in greco ogni numerale di molteplicitagrave sessagesimale o frazione unitaria saragrave identificato come nei manoscritti piugrave antichi dei Prolegomena da un opportuno numero di apici (uno per ogni unitagrave dellrsquoordine avendo le frazioni unitarie un solo apice come vedremo nellrsquoAlmagesto contenuto negli stessi codici troviamo barre non apici con questa funzione) mentre la parte intera saragrave priva della barra che la sormonta invariabilmente nei manoscritti In questo modo 365 14 48 egrave la conversione in cifre arabe di τξε ιδ´ μη´´ La pratica dei manoscritti medievali egrave di collocare gli apici (quando presenti) sopra le lettere numerali per ragioni tipografiche li porrograve di seacuteguito al gruppo di lettere cui si riferiscono Si noti che nella notazione greca il segno ιδ´ per 1460 in sessagesimale egrave identico a quello per 114 in decimale Nel caso delle frazioni unitarie la presenza dellrsquo(unico) apice egrave la traduzione semiotica della trasformazione che a livello grammaticale egrave effettuata con il pas-saggio dal cardinale allrsquoordinale (ad esempio da τὰ τρία laquotreraquo a τὸ τρίτον laquoun terzoraquo) si veda anche la sezione 4 punto 1 e note 82 e 86 ivi incluse
Fabio Acerbi132
richiede sempre lrsquointroduzione di due numerali il lsquonumeratorersquo e il lsquodenominatorersquo
Il motivo della scelta del sistema sessagesimale che fu mutuato dallrsquoastronomia matematica babilonese egrave presto detto lrsquoelevato numero di divisori di 60 e cioegrave 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 Poicheacute i divi-sori di 10 sono un sottinsieme di quelli di 60 molti piugrave numeri hanno una rappresentazione finita nel sistema sessagesimale che in quello deci-male Calcolare in sessagesimale lungi dal creare difficoltagrave offre quindi un vantaggio cruciale22 che risulta piugrave facilmente comprensibile sulla base dellrsquoesempio seguente La lunghezza dellrsquoanno solare egrave stabilita da Tolomeo in 365 giorni + 14 ndash 1300 di giorno Per calcolare il moto giornaliero del sole si rende necessario dividere 360 per questo numero Noi avremmo due opzioni se non potessimo usare la calcolatrice ri-durre il divisore ad una singola frazione tramite passaggio al denomi-natore comune invertire questa frazione e moltiplicarla per 360 sem-plificare gli eventuali fattori comuni e finalmente eseguire la divisione a piugrave cifre tra numeri interi (nel nostro caso 5400054787) oppure scrivere il divisore come numero decimale periodico (365246666 hellip) e poi eseguire la divisione Nel sistema sessagesimale egrave tutto molto piugrave semplice 365 + 14 ndash 1300 ha una rappresentazione finita cioegrave 365 14 48 come eseguire la divisione lo vedremo tra un attimo
Passiamo dunque in rassegna il contenuto del lsquomanuale di logisticarsquo incluso nei Prolegomena ad Almagestum riportando in nota per ogni item anche esposizioni parallele in altri commentatori23
a) Costruzione del sistema sessagesimale24
22 E uno svantaggio se le molteplicitagrave dei singoli ordini vengono espresse in no-tazione decimale (come facciamo noi e facevano i greci) il numero di cifre necessario per raggiungere una precisione assegnata egrave maggiore nel sistema sessagesimale in quanto per esprimere i numerali da 10 a 59 occorrono due cifre mentre per quelli da 1 a 9 (o da α a θ e le decine da ι a ν nel caso greco) ne basta una e ciograve indipendentemente dal fatto che la notazione sia posizionale oppure no La differenza si fa perograve sentire solo a partire dal quinto ordine sessagesimale
23 Trascuro la parte finale del lsquomanualersquo dove sono esposte le regole di interpolazione (cui era legata la lsquoterza colonnarsquo della tavola delle corde tolemaica) e il procedimento di lsquosottrazionersquo di rapporti cioegrave la divisione di un rapporto per un altro
24 Per a-b cf Teone in Alm I 10 in iA pp 44919-45814 PC pp 2007-2014 GC I pp 10910-11124 e le definizioni e regole diofantee di manipolazione delle varie specie numeriche in Arithmetica prefazione in DOO I pp 214-1218 Le porzioni a-b sono giagrave state pubblicate da Paul Tannery in DOO II pp 318-1517 sulla base del Par gr 453 apografo ad opera di Giovanni Santamaura di un Vat gr 1594 giagrave mutilo (RGK II nr 238 ma lrsquoautore trascritto vi egrave indicato come lsquoPtolemaiosrsquo) Evidentemente il committente non fu soddisfatto della prima trascrizione (ff 67-76) che crivella di tratti rossi a segnalarne gli errori di copia Ne fu dunque eseguita una seconda (ff 78-86) cui Santamaura antepose
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 133
b) Regole di moltiplicazione e divisione degli ordini sessagesimali defini-zione generale di moltiplicazione moltiplicazione di ordini come somma delle loro laquodenominazioniraquo Definizione generale di divisione divisione di ordini uguali e di un ordine per quello che lo precede immediata-mente divisione di ordini come sottrazione delle loro laquodenominazioniraquo divisione per 60 come divisione per 1 accompagnata dallo slittamento di un posto dellrsquoordine
c) Problemi che sorgono nella divisione di una parte sessagesimale per una di quelle che seguono divisione breve per riduzione allo stesso ordine (metodo laquoper analisiraquo) due algoritmi differenti il secondo con riduzione dei fattori comuni attribuito a Siriano
d) laquoAltroraquo metodo di divisione breve in realtagrave divisione tra somme di parti sessagesimali appartenenti ad ordini differenti per riduzione allo stesso ordine e applicazione dei metodi precedenti esempio della divisione di 0 2 0 4 per 0 0 2 0 240
e) Metodo di moltiplicazione tra numeri con parti non intere disposizione tabellare dei termini esempio della moltiplicazione di 5 4 6 per 8 0 3 0 525
f ) Primo metodo di divisione lunga descrizione della disposizione tabellare ed esempio di algoritmo applicato alla divisione di 50 48 26 30 per 8 16 28 5426
g) Metodo di divisione lunga tratto da Pappo in Alm III descrizione della disposizione tabellare ed esempio di algoritmo applicato alla divisione di 360 per 365 14 48 come verifica del valore 0 59 8 17 13 12 31 fornito nellrsquoAlmagesto per il moto medio giornaliero del sole27
h) Metodo di approssimazione di una radice quadrata secondo Erone Metr I 8 con giustificazione geometrica di Teone (attualmente non attestata in suoi scritti)
i) Verifica tramite moltiplicazione della correttezza del valore tolemaico28 di 67 4 55 come radice quadrata approssimata di 4500 Metodo di estrazio-ne di radici quadrate secondo Teone basato su applicazioni successive di Elementi II 4 la procedura termina dopo un numero finito di passi nel caso di quadrati perfetti Applicazione al calcolo della radice quadrata di 450029
unrsquoannotazione spazientita laquoIl texto di questo 2do quinterno egrave stato recopiato fidelmente dallrsquooriginale a chi volesse vedere la prova lo potragrave conferire con detto originale le pagine del qual texto corrispondono con quelle dellrsquooriginale tanti versi che pagine [hellip]raquo (Moge-net 1962 p 200)
25 Teone in Alm I 10 e I 14 in iA pp 45815-4604 e 57911-5811026 Teone in Alm I 10 in iA pp 4611-46217 applicato alla divisione di 1515 20
15 per 25 12 1027 Teone in Alm III 1 e IV 3 in iA pp 84112-84422 (stesso calcolo dei Prolego-
mena) e 102916-10327 idem in Alm IX pp 377-378 dellrsquoedizione di Basilea del 1538 approntata dai tipografi di Walderus Lrsquooriginale pappiano non ci egrave pervenuto
28 Alm I 10 in POO I 1 p 341129 Teone in Alm I 10 in iA pp 46916-4738
Fabio Acerbi134
Lrsquounico testo non elencato qui sopra o nelle note e che contenga tabelle operazionali egrave il commentario eutociano a Circ 3-4 Il testo ar-chimedeo che Eutocio e noi con lui leggeva egrave particolarmente conciso ed egli verifica esplicitamente il sussistere di certe relazioni numeriche Si tratta in ognuno dei nove casi presenti di mostrare che il lsquoteorema di Pitagorarsquo egrave verificato con ottima approssimazione dai valori numerici di opportune terne di rette Eutocio esegue le tre moltiplicazioni dei valori per se stessi e mostra che la somma o la differenza di due dei risultati si discosta di poco dal terzo30 I numeri in questione sono interi seguiti o no da una parte non intera espressa come somma di frazioni unita-rie31 I nove gruppi di tre moltiplicazioni una a fianco allrsquoaltra sono organizzati in forma tabellare ma senza lrsquoausilio di linee separatrici32 le operazioni sono eseguite disponendo lsquoin colonnarsquo i risultati delle mol-tiplicazioni parziali e sommandoli esattamente come facciamo oggi poicheacute sono in gioco numeri interi con parti frazionarie unitarie e la notazione non egrave posizionale non egrave necessario che gli incolonnamenti siano esatti (unitagrave di un risultato parziale sotto le decine del precedente ecc) Sono inclusi nella tabella istruzioni e commenti in linguaggio corrente33 le prime relative allrsquooperazione da affettuare sui risultati delle
30 Eutocio non calcola radici quadrate approssimate per quanto ciograve si renda piugrave volte necessario fornisce il risultato e verifica la sua correttezza moltiplicandolo per se stesso Egli dichiara che il lettore interessato a questo procedimento di calcolo puograve rivolgersi Ἥρωνι ἐν τοῖς μετρικοῖς [hellip] Πάππῳ καὶ Θέωνι καὶ ἑτέροις πλείοσιν ἐξηγουμένοις τὴν μεγάλην σύνταξιν τοῦ Κλαυδίου Πτολεμαίου laquoa Erone nei Metrica [hellip] a Pappo e Teone e a svariati altri inter-preti della Grande composizione di Claudio Tolomeoraquo (AOO III p 23213-17)
31 Troviamo ad esempio ͵αωλη θ´ ια´ cioegrave 1838 + 19 + 111 notare il singolo apice per le frazioni unitarie
32 Essi sono editi in AOO III pp 234-256 La tradizione medievale del commentario eutociano che coincide con un ramo di quella archimedea e deriva da un codice appar-tenuto a Giorgio Valla perduto in etagrave rinascimentale ma riprodotto a volte con fedeltagrave assoluta negli apografi (si veda ad esempio nella tav 1a la riproduzione dellrsquoerronea di-sposizione di cifre e parte algoritmica nel primo gruppo di moltiplicazioni offerta dal Laur Plut 284 f 160r) egrave costituita da Marc gr 305 ff 142v-146v Laur Plut 284 ff 159r-164r Par gr 2360 ff 109v-113v Par gr 2361 pp 410-421 Nel codice veneziano in cui la disposizione per righe e colonne egrave irrimediabilmente alterata dal copista le operazioni sono cancellate con tratti di penna Il primo manoscritto fu esemplato per Bessarione da Giorgio Trivizias tra il 1455 e il 1468 (Mioni 1976 pp 309-312) il secondo fu vergato da Giovanni Scutariota in scrittura di imitazione (Martinelli Tempesta 2010 p 173 n 7 Rollo 2012) ca 1491-1492 il terzo fu trascritto per il cardinale di Firenze Niccolograve Ridolfi dopo che la biblioteca di Valla era stata acquistata a seacuteguito della sua morte avve-nuta il 23 gennaio 1500 per 800 scudi drsquooro da Alberto Pio di Carpi (nota del copista al f 120v) il quarto fu terminato per mano di Christopher Auer su commissione di Georges drsquoArmagnac il primo gennaio 1544 (sottoscrizione a p 474 del codice si veda RGK II nr 525)
33 A questi va aggiunto posto davanti al risultato finale di ogni moltiplicazione il segno convenzionale per ὁμοῦ laquoinsiemeraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 135
prime due moltiplicazioni34 i secondi alla bontagrave dellrsquoapprossimazione ottenuta35 Ogni gruppo di operazioni che chiude unrsquounitagrave esegetica ed egrave seguito dalla citazione che apre la successiva egrave trascritto come se facesse parte del testo a tutta pagina e preceduto dallrsquoindicazione οἱ δὲ πολλαπλασιασμοὶ ὑπόκεινται laquole moltiplicazioni sono poste qui sottoraquo Questi due fatti suggeriscono che tutte le operazioni cui Eutocio non fa alcun riferimento nel corpo del suo commentario siano unrsquoaggiunta editoriale risalente a Isidoro di Mileto che si occupograve della revisione del testo36
Gli incolonnamenti esatti sono invece necessari quando siano moltiplicati numeri con parti non intere espresse nel sistema sessage-simale in quanto la somma finale dei prodotti parziali va effettuata ordine per ordine Tale somma eccederagrave di norma il valore di 60 per un ordine dato nella tabella occorre pertanto trovare posto anche per i riporti che vanno sommati ai prodotti parziali dellrsquoordine preceden-te e quindi incolonnati con essi I testi ci offrono alcuni esempi di tabelle operazionali moltiplicative di questo tipo Teone afferma espli-citamente che la prima moltiplicazione che va a descrivere ha una rap-presentazione tabellare la cui disposizione ritroviamo pesantemente ingarbugliata nel Laur Plut 2818 f 35r37 Alla seconda occorrenza di una moltiplicazione eseguita (tav 1b Laur Plut 2818 f 65r) gli incolonnamenti sono meglio rispettati anche se il risultato finale egrave fatto erroneamente slittare di un posto verso destra i riporti (con un errore) si trovano nella penultima riga38 Nei Prolegomena ad Alma-gestum alcune moltiplicazioni sono accompagnate da tabelle quella meglio attestata egrave associata alla moltiplicazione di 67 4 55 per se stesso (sezione i nel riassunto fornito supra) ed egrave descritta additando sempli-cemente ad un ente materiale oramai inaccessibile forse tracciato in loquendo lsquoalla lavagnarsquo
34 Come λοιπὸν τὸ ἀπὸ ΕΓ laquoresta quello su ΕΓraquo seguito dal risultato della sottrazione di due quadrati
35 Come λείπει ἄρα μο β εἰς τὸ ἀκριβές laquomancano quindi 2 u(nitagrave) al risultato esattoraquo36 Si legga la sottoscrizione spuria ad AOO III p 26010-1237 Si legga la frase ἐκτίθεμαι αὐτὴν καὶ πάλιν αὐτὴν ὑφ᾽ αὑτὴν ὡς ὑπογέγραπται laquolo [scil il
valore del lato da moltiplicare per se stesso] dispongo lsaquouna voltarsaquo e di nuovo al sotto di se stesso come trascritto qui sottoraquo in iA p 45817 Il Laur Plut 2818 (Teone e Pappo Commentaria in Almagestum) egrave uno dei piugrave antichi manoscritti in minuscola sicuramente assegnabile alla prima metagrave del IX secolo (Follieri 1977 p 144 n 23 Maas 1927 p 76 n 17 riteneva che fosse piugrave antico del Tetraevangelo Uspenskij) per una sua analisi si veda Rome 1938
38 In nessuno dei due casi i numerali di molteplicitagrave sono segnalati con apici sono tutti sormontati da una barra si veda la sezione 4 punto b
Fabio Acerbi136
προκείσθω δὶς τὸ μῆκος αὐτῆς ὀφεῖλον τὴν τάξιν τοῦ κατὰ τοὺς πολλαπλασιασμοὺς κανόνος ἀποδοῦναι καὶ ἐκκείσθω ἐπὶ σελιδίων διαγεγραμμένων οὕτω καὶ δὴ αὐτῆς ἐφ᾽ ἑαυτὴν πολ-λαπλασιασθείσης γεγονέτωσαν τὰ ἐν τοῖς οἰκείοις σελιδίοις εἴδη ταῦτα δὴ συναγόμενα καθ᾽ ἣν ὑπεδείξαμεν τάξιν ποιήσει τὰς ὑπογεγραμμένας μοίρας ἢ καὶ λεπτά τινα εἴσι ͵δυϙθ νθ´ ιδ´´ ι´´´ κε´´´´ ὡς λείπειν τοῦ ἐπιμερισθῆναι ŏ ŏ με´´ μθ´´´ λε´´´´
che sia prescritto che la sua lunghezza debba figurare due volte nella disposizione della tavola delle moltiplicazioni e che lsaquoquestrsquoultimarsaquo sia disposta su colonne delimitate da linee cosigrave mdash E pertanto una volta moltiplicato lsaquoil latorsaquo per se stesso che le specie trovino posto nelle colonne appropriate quelle che vengono cosigrave raccolte secondo la disposizione che abbiamo indicato produrranno dunque i gradi o anche i minuti qui sotto trascritti 4499 59 14 10 25 in modo che dalle divisioni successive resti39 0 0 45 49 35
La tabella associata (tav 2a Marc gr 313 f 19v) contiene una sola svista grossolana reca 51 invece di 55 in ognuno dei due fattori posti affiancati sopra di essa Al di sotto preceduto dal segno convenzionale per ὁμοῦ egrave collocato il risultato incongruamente sfalsato di un paio di colonne e con la lettera numerale ͵δ priva di barra sormontante in-naturalmente disconnessa da υϙθ I riporti sono indicati dai numerali ι ρκγ´ η´´ ν´´´ posti al fondo delle prime quattro colonne Il calcolo egrave corretto in ogni sua parte
Il clou in questo piccolo spaccato delle interazioni testo-paratesto matematico risiede nella descrizione contenuta nei Prolegomena della disposizione tabellare di due procedimenti di divisione il primo ano-nimo e quindi da supporre tradizionale il secondo piugrave efficiente ed attribuito al matematico del IV secolo Pappo
Il primo metodo di divisione egrave sostanzialmente analogo a quello che usiamo attualmente Dividendo e divisore questrsquoultimo preceduto da un segno su cui ritorneremo nella prossima sezione sono posti uno sotto lrsquoaltro intervallati da una riga inizialmente vuota Primo passo viene reperito il massimo multiplo del divisore che sia minore del di-videndo esso viene trascritto sotto il dividendo nella prima lsquocasellarsquo della riga vuota recante in testa un segno per laquosottrairaquo il fattore mol-tiplicativo (o quoziente parziale) viene trascritto in una lsquocasellarsquo pre-ceduta da un segno per laquorisultaraquo sotto il divisore Secondo passo il massimo multiplo viene sottratto dal dividendo il resto cosigrave ottenuto egrave trascritto preceduto da un segno per laquorestoraquo in una casella posta
39 Lrsquoautore concettualizza il procedimento di estrazione di radice quadrata come una forma di divisione
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 137
accanto al dividendo40 I due passi precedenti sono quindi ripetuti con la sola differenza che il resto appena ottenuto prende il posto del divi-dendo il quoziente parziale scala di un ordine sessagesimale ad ogni passo41 E cosigrave via aggiungendo ogni volta due caselle La debolezza di questo metodo come di quello che utilizziamo attualmente risiede nel fatto che il reperimento dei quozienti parziali (ovverosia dei massimi multipli) viene effettuato per tentativi non riuscire a farlo al primo colpo appesantisce notevolmente i calcoli successivi e costringe ad un lavoro di riordino e addizione dei quozienti parziali stessi La tabella risultante dove appunto osserviamo questo fenomeno in parallelo con identiche inaccuratezze nella descrizione ha la forma riprodotta unico tra i manoscritti della recensione antica nel Marc gr 313 f 13r (tav 2b invito il lettore a non rivolgersi alle tavole se non dopo aver termi-nato questa sezione sarebbe anzi auspicabile che tentasse di ricostruire questa tabella e le due successive a partire dalla mia descrizione)42
Il secondo metodo di divisione attribuito a Pappo egrave congegnato in modo da rendere non aleatoria la ricerca dei quozienti parziali Come altrove nei Prolegomena la descrizione della procedura di calcolo si riag-gancia esplicitamente a una frase di Tolomeo laquouna volta dimostrato che il periodo di una singola rivoluzione lsaquodel solersaquo egrave di 365 giorni 14 48 se di-vidiamo per essi i 360 gradi di un singolo cerchio avremo il moto medio giornaliero del sole circa 0 gradi 59 8 17 13 12 31raquo43 Questrsquoaffermazione si trova nel terzo libro dellrsquoAlmagesto si tratta della prima occasione in cui viene effettuata una divisione in cui il divisore egrave maggiore del dividendo e i commentatori del trattato tolemaico non si fecero sfuggire lrsquooccasione di mostrare come eseguirla Ora il terzo libro del commentario di Pappo non ci egrave pervenuto Ci resta dunque come testo parallelo a quello dei Prolegomena la descrizione rigidamente formulare in Teone sicuramente un calco di quella pappiana Teone qui come nelle altre applicazioni del metodo (Laur Plut 2818 ff 136v [tav 3] e 190r) descrive brevemente ed espone esplicitamente la stessa tavola dei sottomultipli del divisore che
40 Esempio nella divisione di 378 per 17 il massimo multiplo egrave 374 il quoziente parziale egrave 22 il resto 4 e in effetti 378 = 374 + 4 = 17times22 + 4 Si noti che il segno per laquorestoraquo non egrave apposto in testa di riga ma davanti a ogni resto parziale e in effetti il dividendo che si trova in prima posizione in questa riga non egrave un resto
41 Analogamente nellrsquoalgoritmo moderno poniamo la virgola o scaliamo la cifra di un posto
42 Nei Prolegomena la descrizione della tabella associata al metodo anonimo egrave pre-ceduta da una breve sinossi dellrsquooperazione in stile procedurale (cioegrave senza riferimenti alla tabella) e seguita dalla sua esecuzione accurata ma con pochi riferimenti alla tabella se non quello ai due segni da apporre ai resti parziali e ai massimi multipli
43 Alm III 1 in POO I 1 p 2091-4
Fabio Acerbi138
troviamo nei Prolegomena ma non offre alcuna descrizione della disposi-zione tabellare della divisione stessa neacute vi fa riferimento
A questa procedura sono in effetti associate una tavola e una tabel-la costruite come segue (tavv 4 e 5 Marc gr 313 ff 17r e 17v il co-pista era ndash giustamente ndash insoddisfatto della prima versione) La tavola le cui righe e colonne sono delimitate da linee contiene sottomultipli44 del divisore 365 14 48 9 righe che riportano i valori da 160 a 960 piugrave altre 6 con i valori per decine da 1060 a 6060 la prima colonna elenca le 15 parti sessagesimali omettendo come drsquoabitudine la laquodenomina-zioneraquo dellrsquoordine (i numerali elencati sono quindi α β γ δ ε ϛ ζ η θ ι κ λ μ ν ξ) la seconda i sottomultipli corrispondenti organizzati su quattro colonne per tener conto dei tre ordini sessagesimali (il primo sottomultiplo egrave quindi ϛ ε´ ιδ´´ μη´´´ cioegrave 160 di τξε ιδ´ μη´´) La tabella priva di linee delimitanti espone la vera divisione Nella prima colonna troviamo i resti parziali ognuno preceduto dallrsquoindicazione del proprio ordine sessagesimale e da un segno per laquorestoraquo Nella seconda preceduti da un segno per laquosottrairaquo i sottraendi ognuno coincide ovviamente con uno dei sottomultipli nella tavola La terza colonna contiene se-guiti dallrsquoindicazione del proprio ordine sessagesimale i quozienti par-ziali ottenuti trascrivendo dalla prima riga della tavola il numerale corrispondente al sottraendo affiancato ed assegnando come ordine sessagesimale il successivo a quello posto in testa di riga Il risultato preceduto da un segno per laquorisultaraquo e posto al di sotto della tabella si ottiene sommando i quozienti parziali il procedimento non permette in generale di determinare lrsquointero quoziente parziale relativo ad un ordine sessagesimale fissato se non dopo due passi Una linea spezzata unisce i resti parziali successivi e i relativi sottraendi per evidenziare la laquoprogressione della proceduraraquo la spezzata lsquosaltarsquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore (le cui righe sono per il resto vuote) e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue di conseguenza anche il quoziente parziale relativo a questo resto appartiene allrsquoordine sessagesimale successivo
A questo punto possiamo rivolgerci alle tavv 4-5 e verificare se le immagini che ci siamo formati sulla base della mia descrizione corri-spondono a quelle che troviamo nel Marc gr 313 Non si tratta di un giochetto sterile egrave al contrario il cuore di un intrico di problemi Un primo ordine di problemi deriva dal fatto che nei Prolegomena lrsquoalgo-
44 Sottomultipli e non multipli in quanto il divisore egrave maggiore del dividendo Drsquoaltronde nel sistema sessagesimale come in quello decimale un sottomultiplo si ottiene dal multiplo corrispondente semplicemente scalando tutte le cifre di un posto (ad esempio 1360 di 365 14 48 si ottiene in questa maniera da 13 volte 365 14 48)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 139
ritmo della divisione lsquoalla Papporsquo non egrave mai eseguito (cioegrave formulato verbalmente) in maniera indipendente dalla descrizione della tabella Comrsquoegrave dunque possibile descrivere una tabella operazionale che non ha uno statuto testuale indipendente sulla base di un algoritmo in corso di esecuzione E drsquoaltro canto come non rilevare unrsquoanomalia in un algoritmo eseguito nella sua forma primaria sotto forma di descrizione di una tabella Ci potremmo chiedere se viene descritto lrsquoalgoritmo o la tabella La tensione fra i due enti grafici egrave acuita dal fatto che nei nostri testi tutto ciograve (esposizione o descrizione di un algoritmo o della tabella associata) avviene sempre e solo sulla base di un esempio numerico para-digmatico Per questo motivo la tabella in quanto struttura (cioegrave privata dei dati numerici accidentali) non puograve fare a meno della descrizione45 Dal canto suo Teone come forse Pappo ancor prima descrive ed espone la tavola dei (sotto)multipli ma non la tabella di divisione lrsquoalgoritmo relativo a questrsquoultima egrave espresso come per controbilanciare in maniera eccezionalmente trasparente e formulare Se ciograve comporta un guada-gno a livello verbale-argomentativo sorge un problema operativo grave come e dove sistemare i resti e i quozienti parziali ndash cioegrave tutti i numeri in output dellrsquoalgoritmo differenti dai (sotto)multipli ndash che la tabella si incarica di disporre in modo lsquonaturalersquo Teone prescrive soltanto di confrontare i resti con la seconda colonna della tavola dei sottomultipli e di trascrivere via via il quoziente ottenuto dopo ogni passo Insomma come eseguire materialmente una divisione Non certo adattando ad un nuovo caso specifico la formulazione dellrsquoalgoritmo che Teone propone
Un secondo ordine di problemi e una trappola micidiale per il co-pista egrave interno alla dialettica lsquotabellarsquolsquosua descrizionersquo ed egrave in assenza di simbolismo quello dei riferimenti linguistici da adottarsi nella seconda agli enti grafici che figurano nella prima Occorre ricercare la massima generalitagrave fornita da una descrizione definita di un ente numerico (ad esempio impiegando il termine laquorestoraquo o la perifrasi laquomassimo sotto-multiplo minoranteraquo) o basta assumere direttamente il suo valore speci-fico come esempio paradigmatico E in che modo risolvere il conflitto tra uso e menzione se come nel nostro caso la tabella contiene segni convenzionali ed occorre fornirne una descrizione Si rende ad esempio necessario introdurre un lsquooperatore di citazionersquo noi useremmo le virgo-lette la lingua greca premette lrsquoarticolo neutro Drsquoaccordo ma nel caso
45 Questa caratteristica non egrave connaturata alla matematica degli algoritmi la risorsa dello lsquostile proceduralersquo serve esattamente ad aggirare questo problema al di lagrave di un certo livello di dettaglio perograve essa condurrebbe ad un appesantimento insostenibile della for-mulazione dovuto alla pluralitagrave dei riferimenti agli oggetti matematici in gioco sulla que-stione dei diversi stili della matematica greca si veda Acerbi 2012
Fabio Acerbi140
greco qual egrave il suo range E come distinguerlo nei casi ambigui da un semplice articolo che precede un sostantivo quando questrsquoultimo lo ri-chieda Nel corso del processo di copia del testo della descrizione infine possono generarsi tensioni tra enti grafici interpretabili vuoi come segno convenzionale vuoi come abbreviazione Ambiguitagrave relative a questi punti opacizzano la descrizione Un problema analogo si porrebbe a priori nella dialettica tra uso delle lettere denotative per designare enti geometrici e loro menzione nella costruzione di un diagramma ma esso egrave risolto con lrsquoazzeramento della seconda funzione le lettere denota-tive sono sempre usate allrsquointerno del testo (sono cioegrave il referente degli oggetti geometrici di cui tratta il discorso matematico) mai menzionate (come accadrebbe se fossero il referente di oggetti grafici posti nel dia-gramma) Insomma il codice adottato per la costituzione dei diagrammi geometrici egrave condiviso (cioegrave canonizzato) semplice e perspicuo mentre quello per le tabelle operazionali non lo egrave da qui le sviste dei copisti e le trascuratezze di correttori ed editori
Infine chi vuole apprendere da questi testi come eseguire una divi-sione a cosa deve prestar fede se ad esempio a causa di errori di copia la descrizione finisce per non coincidere con la tabella operazionale visto che sono entrambe due maniere valide di eseguire lo stesso algoritmo Dopo tutto lo scopo di tutta questa macchina grafico-argomentativa egrave di insegnare a eseguire divisioni in formato tabellare Questo problema si fa particolarmente acuto se la tabella non egrave trasparente nel metodo di Pappo lo egrave quasi completamente in quello anonimo no E gli errori che riscontreremo nella (doppia) tabella ai ff 17r-v del Marc gr 313 a chi sono attribuibili Allrsquoautore al trascrittore o al copista medievale
Questo groviglio di problemi riceve alcune risposte sorprendenti dalla tradizione manoscritta come andiamo finalmente a vedere
4 Analisi delle testimonianze
I codici che ho adibito per lrsquoedizione sono i seguenti M = Marc gr 31346 C = Marc gr 314 (Tolomeo Tetrabiblos et opera minora cum commentariis Vezio Valente Anthologiae)47 Z = Vat gr 2326 (fattizio
46 Riferibile al sec IX ex-X in accolgo la datazione suggeritami per litteras il 522005 da Nigel G Wilson si veda anche Agati 1992 pp 141-142 La presenza non sistematica degli accenti che fa anticipare a Wilson la datazione di laquosaec X medraquo fornita in Mioni 1985 p 24 indusse Boris Fonkič (2005 non vidi) ad assegnare il codice allrsquoinizio del IX secolo
47 Il manoscritto riferibile alla seconda o terza decade della prima metagrave del XIV secolo fu vergato da Michele Clostomalle olim lsquoMetochitesschreiberrsquo Bianconi 2005a pp 428-430 Il titolo dei Prolegomena in questa trascrizione identico in grafia ma non in formulazione a
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 141
e mutilo Tolomeo Almagestum) S = Vat gr 184 (varia astronomica scholia miscellanea ad Almagestum Tolomeo Almagestum) P = Par gr 2390 (varia astronomica) gli ultimi tre riferibili allo scorcio del XIII secolo48 e apografi sicuri del Vat gr 159449 attualmente mutilo di due fascicoli che ci privano dei due terzi finali dei Prolegomena M e il Vat gr 1594 ammettono un modello comune il resto della tradizione (25 trascrizioni in tutto) dipende dagli apografi appena citati del Vat gr 1594 Le varianti della recensione bizantina che leggiamo tra lrsquoaltro nei Vat gr 198 Marc gr 310 (Tolomeo Almagestum cum commentariis Pappi Theonis et Cabasilae) e con ulteriori modifiche Laur Plut 89 sup 48 (varia astronomica Tolomeo Almagestum Barlaam Logistica) sono identificate dal siglum K e si trovano punteggiatura originale in-clusa nel secondo apparato50 Lrsquoanalisi delle testimonianze51 costituite ovviamente anche dalle tabelle associate saragrave condotta nella forma di una sequenza di osservazioni indicizzate da numerali o lettere oltre che di alcune note a piersquo di pagina
Iniziamo dalla descrizione del metodo di divisione anonimo
quello che leggiamo nel Vat gr 1594 (questrsquoultimo coincide con quello adottato nella recen-sione bizantina) fu apposto da Niceforo Gregora e successivamente corretto da Bessarione
48 Sto studiando il primo e il terzo codice in collaborazione rispettivamente con Daniele Bianconi e Inmaculada Peacuterez Martiacuten
49 Su questo codice risalente alla seconda metagrave del IX secolo e sulla sua collocazione nella lsquocollezione filosoficarsquo per prima proposta in Follieri 1977 pp 145-146 si vedano almeno Perria 1991 pp 82-88 Ronconi 2013 Che il titolo dei Prolegomena nel Vat gr 1594 sia stato apposto da Niceforo Gregora egrave stato riconosciuto per la prima volta in Mazzucchi 1994 p 211 n 196 si veda Bianconi 2005a p 418 per altri interventi di Gregora nello stesso manoscritto
50 Il Vat gr 198 egrave stato vergato dal copista Malachia nel corso del terzo quarto del XIV secolo Mondrain 2004 pp 278-290 e 292 Allo stesso copista (denominato non a caso prima dellrsquoidentificazione anonymus Aristotelicus) dobbiamo un buon numero di trascrizioni aristoteliche con i relativi commentari in margine Gli dobbiamo anche il Par gr 2342 secondo tomo di un quadrivium quasi completo di cui il Vat gr 198 egrave il primo nellrsquoordine aritmetica armonica astronomia (Almagesto e commentari relativi) nel codice vaticano geometria ed ancora astronomia (corpus astronomico minore) in quello parigino le opere trascritte sono sempre accompagnate in margine dai relativi commentari Il copista del Marc gr 310 egrave Isacco Argiro (ca 1300-1375) Mondrain 2007 p 166 Allo stesso Argiro dobbiamo il codice laurenziano (Daniele Bianconi per litteras) Poicheacute la recensione modificata che leggiamo nel Laur Plut 89 sup 48 egrave senza alcun dubbio basata su quella nel Marc gr 310 e non viceversa ci troviamo di fronte ad un copista che trascrive due volte lo stesso testo in due versioni leggermente differenti la conclusione naturale egrave che la seconda recensione egrave dovuta ad Argiro stesso la questione andragrave studiata in dettaglio
51 Nei manoscritti citati i Prolegomena si trovano ai fogli seguenti Vat gr 1594 ff 1r-8v (mutilo mancano due fascicoli su tre) Marc gr 313 ff 1r-28r (incompleto man-cano due fogli allrsquoinizio e il f 6 attualmente rimpiazzato da uno bianco) Marc gr 314 ff 235r-255r Vat gr 2326 ff 19r-40v e 43r-v (incompleto e con i fascicoli in disordine) Vat gr 184 ff 10r-23v Par gr 2390 ff 1r-13v Vat gr 198 ff 127r-136v Marc gr 310 ff 1r-13r Laur Plut 89 sup 48 ff 7r-19r
Fabio Acerbi142
ἐκθέμενοι οὖν διάγραμμα τῶν ἀριθμῶν ὡς ὑπόκειται προτάσσομεν τὸν μεριζόμενον καὶ μικρὸν ὑπ᾽ αὐτὸν τὸν μερίζοντα ὡς ἔχει τὸ διάγραμμα ἐν στίχοις διοριζομένοις ὑπὸ γραμμῶν [hellip] καὶ τὰ μὲν γινόμενα ἐγγὺς ἐλάττονα ἐν τῇ μεταξὺ θέσει τοῦ μεριζομένου καὶ τοῦ μερίζοντος ἐν στίχοις παρασημειοῦσθαι πρὸς τὸ ἀσύγχυτον εἶναι τὴν τάξιν τὰ δὲ μεθ᾿ ὧν ὁ μερίζων ἐποίει τοὺς ἀεὶ ἐλάσσονας ὑπὸ τὸν μερίζοντα σημειοῦσθαι προγράφοντας ἐπὶ τοῦ στίχου αὐτῶν τὸ γίνεται οὕτως γι ἐν δὲ τῷ στίχῳ τῶν μεριζόντων τὸ παρὰ ἔχον οὕτως oslash ἀντὶ τοῦ παρ᾿ ἃ δεῖ τὸν μερισμὸν γίνεσθαι ἐν δὲ τῷ στίχῳ τῶν ἐλασσόνων τὸ αφ διὰ τὸ τούτους ἀεὶ ἀφαιρεῖσθαι ἀπὸ τῶν ἐπάνω τῶν μεριζομένων ἐν δὲ τοῖς τοῦ μεριζομένου λοιπάσμασι τοῖς καὶ ἐπιοφείλουσι τὸ λ κατὰ τὸ ἴδιον τῶν διαστάσεων ἑκάστης ndash λέγω δὴ λοιπάδος ndash ἀντὶ τοῦ λοιποὶ οἱ μέλλοντες ἐπιμερίζεσθαι
2 post τὸν suprascr τὸν ἐλάττονα m 2 S 5 πρὸς] MP et ex corr Z κατὰ S om C | ἀσύγχυτον] MSPC -χητον Z 6 ἀεὶ] MZPC ὡσεὶ S 7 γίνεται οὕτως γι ] γι τ οὕτως γι τ M γί οὕτως γί Z γι οὕτως γί SC τὸ γινόμενον οὕτως γίνεται P 8 τὸ παρὰ ἔχον οὕτως] scripsi τὸ παρέχον οὕτως M et π(αρ-) comp Z οὕτως τὸ περιέχον S προγράφοντας οὕτως ex corr m 2 P τὸ περιέχον οὕτως C | oslash] MZSC (sed ο fecit | Z) ἐλάττων comp ex corr m 2 P | παρ᾿ ἃ] scripsi παρα M π(αρα) comp ZSC ex παρα fe-cit παρὰ et τοῦτον suprascr m 2 P 9 γίνεσθαι] comp C | αφ ] αφ ε M ἀφ ZSC ἀφαί P | ἀεὶ] om M 11 ἐπιοφείλουσι] MZSC ex ἐπιο- fecit ἐπο- m 2 P | λ] MZPC λ´ S 12 λοιποὶ] PC λοιποῦ MZS
3 στίχοις] στίχῳ K 5 πρὸς] διὰ K 7 ἐπὶ mdash γι ] τὸ γίνεται διὰ τοιούτου σ(ημείου) γί K 8 τὸ παρὰ ἔχον mdash παρ᾿ ἃ] τὸ παρᾱ διὰ σ(ημείου) τοιούτου καὶ τοῦτο oslash δηλοῦντος τοῦ παρᾱ ὅτι παρὰ τὸν τοιοῦτον (ἀριθμὸν) K 9 αφ διὰ τὸ τούτους] ἀφ δηλοῖ δὲ τοῦτο ἀφαίρεσ(ιν) ὅτι τούτους ἀεὶ δεῖ K 11 ἐπιοφείλουσι] ἐπιμερίζεσθαι ὀφείλουσι K | λ] λ οι` K 12 ἀντὶ τοῦ] δηλοῦντος τοῦ σ(ημείου) τὸ K
lsquoRendendo esplicito un diagramma numerico come lo troviamo qui sotto disponiamo in primo luogo il dividendo e un poco al di sotto di esso il divisore come li ha il diagramma in righe delimitate da linee [hellip] e lsaquooccorreragraversaquo nella posizione tra il dividendo e il divisore annotare lrsquouno accanto allrsquoaltro i piugrave vicini lsaquodei numerirsaquo minori che risultano affincheacute la disposizione non sia confusa quelli con cui il divisore faceva ogni volta i lsaquonumerirsaquo minori annotarli sotto il divisore scrivendo in prima posizione sulla loro riga laquorisultaraquo cosigrave Ris nella riga dei diviso-ri52 invece laquoperraquo fatto cosigrave53 P in luogo di laquoquelli per cui deve farsi la divisioneraquo nella riga dei lsaquonumerirsaquo minori laquosottrraquo in quanto questi sono sempre sottratti dai dividendi che si trovano sopra nei residuli del dividendo (occorre ben farlo anche per loro) laquoReraquo in accordo con ciograve
52 I laquodivisoriraquo sono al plurale ma siamo semplicemente di fronte a un tratto idioma-tico della lingua greca nel caso di espressioni generalizzanti crsquoegrave soltanto un divisore che occupa lrsquounica colonna di cui si compone la sua riga
53 Si intenda ἔχον οὕτως = ita se habens
1
5
10
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 143
che egrave proprio agli scarti di ciascuno ndash intendo qui lsaquociascunrsaquo residuo54 ndash in luogo di laquoresti che vanno a essere divisi ulteriormenteraquorsquo
a) Operatori di citazione e segni convenzionali I segni introdotti sono quattro la mia discussione egrave condotta dando per scontato che essi siano identici a quelli impiegati dallrsquoautore dei Prolegomena anche se si tratta di unrsquoipotesi non corroborabile neacute falsificabile
i Segno per il risultato Lrsquoabbreviazione convenzionale per γίνεται egrave identica al segno introdotto dallrsquoautore e i copisti si dividono tra i due errori possibili scrivere due abbreviazioni o risolverle entrambe Un fenomeno del tutto analogo si riscontra nel Matr 4678 il manoscritto alla base di tutta la tradizione degli Arithmetica di Diofanto al momen-to della definizione dellrsquoἀριθμός (lrsquolsquoincognitarsquo nel nostro linguaggio) ὁ δὲ μηδὲν τούτων τῶν ἰδιωμάτων κτησάμενος ἔχων δὲ ἐν ἑαυτῷ πλῆθος μονάδων ἄλογος ςο` καλεῖται ς` ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον τὸ ς` laquoil lsaquonumerorsaquo che non possiede nessuna di queste proprietagrave ma che ha in seacute una molteplicitagrave indefinita di unitagrave egrave chiamato lsquonumerorsquo e il suo segno egrave ς`raquo Qui solo il terzo dei tre ς ha una barra a sormontare per segnalarne il carattere puramente denotativo (cioegrave di segno convenzionale e non di abbreviazione si veda il punto successivo)55 il primo egrave una delle abbreviazioni piugrave diffuse per ἀριθμός (e infatti egrave dotato del compendio per la desinenza e dellrsquoaccento grave) il secondo egrave una delle piugrave comu-ni per καὶ () Giovanni Cortasmeno autore di capillari annotazioni infra lineam agli Arithmetica nel codice madrileno scioglie il primo ςο`
54 Doppia variatio che impiega al posto di λοιπόν laquorestoraquo i due termini decisamente non canonici τὸ λοίπασμα e ἡ λοιπάς (piugrave oltre leggiamo anche il participio λοιπασθέντα) Una ricerca sul TLG in rete non ha fornito occorrenze del primo si tratta dunque di uno hapax Quanto al secondo che ricorre anche nella sezione sulla divisione lsquoalla Papporsquo lo si rintraccia giagrave nei papiri documentari il termine diventeragrave perograve canonico nelle esposizioni bizantine drsquointroduzione allrsquoAlmagesto ricalcate sul modello dei Prolegomena (si veda la nota 87 infra) Questi due termini designano i resti parziali prodotti nel corso di una divisione lunga li ho tradotti rispettivamente con il neologismo laquoresiduloraquo e con il sostantivo pari-menti non canonico laquoresiduoraquo
55 Il copista interpreta erroneamente il terzo segno come unrsquoabbreviazione e qui ag-giunge un apice inverso (cioegrave un accento grave) altrove lo scioglie direttamente in forme opportune di ἀριθμός Matr 4678 f 58v La frase come la leggiamo nel manoscritto egrave cor-rotta sulla base di una parafrasi in Psello (edita in DOO II p 3710-12) Tannery emendograve ἄλογος in ἀόριστον DOO I p 64-5 et app Il Matritensis vergato da due copisti differenti (cambio di mano a tre righe dalla fine del f 62r) contiene lrsquoIntroductio arithmetica di Nicomaco e le opere diofantee oltre ad alcuni brevi opuscoli musicali la sua data egrave stata recentemente corretta dal XIII al secolo XI pm in Peacuterez Martiacuten 2006 (una riproduzione digitale del manoscritto si trova allrsquoindirizzo httpbdhbneesbnesearchbibliotecaDio-fanto20de20AlejandrC3ADa)
Fabio Acerbi144
in ἀριθμός ed aggiunge un altro segno56 sopra il terzo anteponendovi lrsquoindicazione καὶ ἔστιν αὐτοῦ σ(ημεῖον) τόδε Va da seacute che non abbiamo nessuna garanzia che il segno originariamente introdotto da Diofanto coincidesse realmente con unrsquoabbreviazione convenzionale per ἀριθμός Lrsquoevidenza del PMich III 144 (sec II in) suggerisce drsquoaltronde che il Matritensis e con esso tutta la tradizione medievale di Diofanto ripro-duca fedelmente pur accentuandone la sinuositagrave il segno originario
ii Segno per il divisore Un cerchiolino sbarrato da non confondere con il segno per ὁμοῦ che nei manoscritti matematici ha di norma due barre trasversali (cf tav 2a) Non sono riuscito a rintracciarne ulteriori occorrenze in altre opere la forma che esso assume nel Vat gr 2326 e la correzione apportata nel Par gr 2390 lasciano aperta la possibilitagrave per quanto a mio avviso remota che la forma originaria non fosse lon-tana da unrsquoabbreviazione di παρά registrata nei repertori57 Il correttore del Par gr 2390 trasforma in effetti il segno oslash nellrsquoaffine abbreviazione canonica per (forme di) ἐλάσσων laquominoreraquo58 e si incarica diligente-mente di farlo notare ricapitolando i segni nella porzione superiore del margine esterno del f 7v Nello stesso margine egli traccia anche uno lsquoscolio tabellarersquo ed egrave lrsquounico a porre il (proprio) segno dove indicato dalla descrizione (tav 6 Par gr 2390 f 7v) Oltre a ciograve adattando la tabella al margine ristretto lo scoliaste trascrive come colonne affian-cate le due righe dei resti parziali e dei massimi multipli e aggiunge le indicazioni ὁ μεριζόμενος laquodividendoraquo e ὁ μερίζων laquodivisoreraquo ma vi introduce alcune incongruenze di formato il risultato scritto in verti-cale e la linea verticale di sinistra che separa il divisore dal segno che lo dovrebbe precedere direttamente
iii Segno per i massimi multipli Corrisponde alla semplice abbre-viazione per sospensione della forma verbale ἄφελε laquosottrairaquo in questo
56 Si tratta del segno di ampio uso praticamente identico allrsquoabbreviazione canonica per οὖν
57 Si tratta di un pi a forma di gancio sbarrato da uno slash di troncamento Ce-reteli 1904 tav IX item 7 sub ΠΑΡΑ che rinvia al PVindRain 423 cf anche la forma π` nel POxy LXI 4142 edito in Jones 1999 II pp 26-34 In generale nei papiri e nei manoscritti matematici in maiuscola le preposizioni sono abbreviate facendo seguire un lsquoapostroforsquo alla loro prima lettera Α᾽ Υ᾽ ecc Per la seconda fattispecie di supporto libra-rio si veda in particolare il cosiddetto fragmentum mathematicum Bobiense scriptio inferior databile al V-VI secolo del palinsesto Milano Biblioteca Ambrosiana L 99 sup (Isidoro di Siviglia Etymologiae datazione Cavallo 1977 p 100) pp 113-114 che sono stampate in riproduzione apografa conforme in Belger 1881 (la p 114 egrave riprodotta anche nella tav 10 di Acerbi 2010)
58 Se questa era lrsquointenzione si tratta ovviamente di una forzatura il divisore puograve ben essere maggiore del dividendo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 145
caso lo slash di troncamento taglia orizzontalmente il tratto verticale del phi I copisti offrono molteplici varianti apponendo chi uno spirito dolce chi un ε chi un αί accentato a sormontare Tutti questi segni svolgono la funzione di abbreviazioni vere e proprie (e cosigrave doveva essere anche per lrsquoautore si veda il punto 1 di p 153 infra) la forma originale si ottiene a mio avviso incrociando i dati del Marc gr 313 e dei tre apografi del Vat gr 1594 αφ anche se lrsquoassenza dello spirito potrebbe essere semplicemente dovuta alla pratica del copista del codice veneziano di economizzare nei diacritici
iv Segno per i resti Un lambda completato da una barra a sormon-tare o da un apice che rinvia alle abbreviazioni per sospensione di una forma opportuna di λοιπός laquorestoraquo In realtagrave la forma che troviamo nella tabella egrave differente (tav 2b) e coincide con quella offerta quasi unanimemente dai manoscritti nella descrizione e in almeno un caso nella tabella del metodo di divisione attribuito a Pappo (tav 4) un lambda che accoglie al di sotto una legatura omicron-iota () sbarrata da uno slash di troncamento Qualcosa di simile si trova nel PVindob G 19996 (sec I) una specie di lambda maiuscolo molto aperto e dal vertice arrotondato che include un circoletto interpretato dagli editori come segno per περίεστιν o per λοιπόν59 Lo stesso segno si rintraccia ad esempio in un medesimo scolio tabellare di prima mano ad Alma-gestum nel Vat gr 1594 f 93v e nel Marc gr 313 f 135r ma stavolta la forma del lambda egrave molto ben definita
Fin qui i segni Ma il gioco egrave piugrave complesso La descrizione si muo-ve pericolosamente sulla linea di confine non sempre ben definita tra segno convenzionale e abbreviazione il primo ndash e il repertorio grafico matematico-astronomico ne egrave particolarmente fornito60 ndash puograve anche
59 Ho consultato lrsquoedizione Gerstinger ndash Vogel 1932 pp 46 e 48 la porzione rilevante del papiro egrave riprodotta nella tav 11 di Fowler 1999 Si veda ancora ivi pp 253-257 per la trascrizione di questo segmento di testo (con correzioni rispetto alla princeps) e per una messa a punto recente inclusa la proposta di datazione che ho riportato qui sopra Il verso del papiro che contiene una tavola aritmetica del tutto scorrelata dalla tematica del recto egrave edito come PRain Unterricht 151
60 La pratica di ridurre lo spazio occupato da un testo tecnico per mezzo di abbreviazioni e segni convenzionali era molto diffusa nei manoscritti in maiuscola contrariamente a quanto avviene per altri generi letterari vedremo tra breve cosa accade negli Arithmetica di Diofanto ma si leggano in proposito anche le considerazioni di Hei-berg nei prolegomena alla propria edizione dellrsquoAlmagesto in particolare riguardo al ricorso massiccio ad espedienti brachigrafici nel modello del Vat gr 180 POO II pp lxxxiv-xciii civ-cv cxxvii cxxxviii-cxxxix Agli elenchi dettagliati forniti da Heiberg possiamo aggiungere il piccolo prontuario stampato in Hultsch 1876-1878 III 2 pp 126-132 e basato sul testo e sugli scolii alla Collectio di Pappo nel Vat gr 218 (sec X in) Si vedano infine le osservazioni del copista del Par gr 2360 f 120v trascritte da Heiberg in AOO III pp x-xi sulle laquonotazioni tipiche a scopo di tagliar corto nello scrivereraquo impiegate nel pro-
Fabio Acerbi146
derivare dalla seconda (un caso egrave appunto il segno per ἐλάσσων che probabilmente trae origine da una legatura epsilon-lambda) ma poi il rapporto referente-relato si fissa convenzionalmente Quelli definiti nel testo che abbiamo letto sono appunto segni convenzionali non ci sarebbe bisogno di spiegarne forma e funzione se fossero intesi come abbreviazioni assumono nella tabella una funzione denotativa non esplicativa o discorsiva (come accade invece nella tav 1a) Ma come vengono descritti questi segni
I referenti delle descrizioni sono i segni sono introdotti da οὕτως (item i-ii) o in alternativa da un τό con il ruolo di lsquooperatore di citazionersquo (item iii-iv) che corrisponde esattamente alle nostre virgolette In entram-bi i casi gli enti sono menzionati e svolgono una funzione metalinguistica sono collocati materialmente nel testo ma egrave come se si trovassero fuori e la loro descrizione li additasse ndash in effetti i segni convenzionali scritti nel testo sono a loro volta i relata di quelli che si trovano nella tabella
I relata dei segni scritti nel testo sono di due tipi singoli vocaboli (item i-ii) o descrizioni della funzione dei segni per mezzo di clausole sintaticamente complesse (item ii e iv) I singoli vocaboli sono γίνεται e παρά e sono entrambi preceduti dal τό lsquocitazionalersquo in quanto relata di segni convenzionali le forme abbreviate con cui sono tracciati nei manoscritti vanno forzatamente sciolte Bisogna ammettere che la per-spicacia e le risorse grafiche dei copisti ndash di cui tutto si puograve dire fuor che commettano qui degli errori ndash sono messe a dura prova con lrsquointrodurre segni identici ad abbreviazioni o con lrsquoattivare un gioco metalinguistico particolarmente serrato in un contesto meno lsquonaturalersquo di come potreb-be esserlo ad esempio quello di un trattato grammaticale Lrsquoitem iii che presenta direttamente un segno identico ad unrsquoabbreviazione non egrave sorretto da una descrizione ma da una giustificazione in διὰ τό Lrsquoartico-lo τό vi assume una funzione metalinguistica anche se non lsquocitazionalersquo poicheacute al tempo stesso genera un infinito sostantivato e lo singolarizza per questo ho scritto laquosono sottrattiraquo in corsivo nella mia traduzione
prio modello archimedeo (nota 32 supra) egli ne compila anche una breve lista Un elenco antico di laquosegni della geometriaraquo sicuramente redatto per assistere il copista si trova anche al f 3v del ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 vergato da Efrem negli anni 950-960 (tav 8 in Acerbi 2010) Possiamo farci unrsquoidea quantitativa del guadagno di spazio in rapporto ad un testo privo di abbreviazioni e con le parole separate da spazi sulla base del fragmentum mathematicum Bobiense il testo vi egrave disposto a tutta pagina su 36 righe di circa 30 segni ciascuna nelle due pagine in questione figurano 2038 segni con 15 mezze righe occupate dalle due figure Ora nel testo dellrsquoedizione stabilita in Heiberg 1927 pp 87-90 le stesse pagine contano 4455 segni spazi compresi Ne risulta che la dimensione in caratteri di un testo matematico puograve essere ridotta di piugrave della metagrave con lrsquoimpiego di compendi e segni convenzionali
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 147
Negli item ii e iv il segno si collega ad una descrizione nel secondo caso in via esclusiva le descrizioni pertanto rinforzano o sostituiscono lrsquoidentificazione con lrsquoente linguistico denotato Le clausole descrittive sono precedute da ἀντί e dallrsquoarticolo τό con funzione di lsquooperatore di citazionersquo esse sono παρ᾿ ἃ δεῖ τὸν μερισμὸν γίνεσθαι (item ii) e λοιποὶ οἱ μέλλοντες ἐπιμερίζεσθαι (item iv) Nella descrizione della divisione lsquoalla Papporsquo che leggeremo tra breve i segni negli item iii e iv rice-vono lo stesso trattamento degli altri due il loro relatum egrave un singolo vocabolo e non una clausola descrittiva rispettivamente nelle espres-sioni τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε (sul participio ritorneremo nel punto 1 infra) e τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά (la forma del segno notato con λ οι egrave descritta supra nellrsquoitem iv) La descrizione del segno oslash per il divisore merita una discussione piugrave dettagliata In origine si trovava probabilmente scritto Π(ΑΡΑ)ΕΧΟΝ successivamente letto come π(αρ[α])έχον ndash dato che lrsquoabbreviazione per il preverbo egrave identica a quella per la preposizione (che sia Π᾽ o un pi seguito dal segno per ἄρα a sormontare) ndash invece di π(αρὰ) ἔχον I copisti e i correttori si dettero a tutte le possibili contorsioni per restituire un testo dotato di senso leggere appunto una forma verbale con preverbo modificare il preverbo (ma forse il segno per ἄρα era insidiosamente simile ad uno epsilon) correggere il testo rileggiamo lrsquoapparato sub τὸ παρὰ ἔχον οὕτως τὸ παρέχον οὕτως M et π(αρ-) comp Z οὕτως τὸ περιέχον S τὸ περιέχον οὕτως C προγράφοντας οὕτως ex corr m 2 P Nella clausola descrittiva seguente la presenza liminare di παρὰ (che ho corretto in παρ᾿ ἃ nella speranza di restituire una frase che abbia un senso senza intervenire sul testo) innesca un bel corto circuito il Π(ΑΡΑ) che sicuramente figu-rava nellrsquoarchetipo egrave un sintagma complesso una preposizione unrsquoab-breviazione o un segno per unrsquoabbreviazione Se lrsquoeditore si trova in conflitto con la propria inclinazione alla critica conservativa i copisti si rifiutarono di mettere mano ad un testo che doveva stridere anche per loro essendo il compito demandato al ritocco del revisore del Par gr 2390 o alla riscrittura radicale del recensore bizantino Il problema egrave che ci troviamo di fronte ad unrsquoespressione che descrive la funzione dellrsquooggetto denotato non lrsquooggetto stesso ma che lo contiene al suo interno per soprammercato qui il Π(ΑΡΑ) egrave usato per giustificare una menzione a sua volta relatum di un segno
Evidentemente questa maniera di procedere che giagrave aveva attirato interventi da parte di copisti e correttori della recensione di base parve insostenibilmente opaca allrsquoautore della recensione bizantina61 Egli
61 Uno dei manoscritti di questa recensione propone anche una tabella di divisione
Fabio Acerbi148
modifica tutte le descrizioni diluendo lrsquoidiomatismo dellrsquoarticolo lsquocita-zionalersquo con lrsquointroduzione sistematica del verbo δηλόω e di frasi atte a chiarire quale sia il segno denotante e quale il vocabolo (o il segno) denotato Egli introduce allo scopo di rendere esplicita la funzione de-notativa dei segni introdotti il termine σημείου curiosamente in tutte le sue tre occorrenze esso compare a sua volta nella forma dellrsquoabbrevia-zione per sospensione σΗ´ Egli traccia il segno per i massimi multipli ἀφ e quello per i resti λ οι` in modo che non vi siano ambiguitagrave quanto al loro carattere di abbreviazione Si faccia infine attenzione al residuo di barra sul παρᾱ con funzione denotativa (2 occorrenze) contenuto nella descrizione del segno per il divisore sostituita dallrsquoaccento grave nel παρὰ con funzione discorsiva (la differenza egrave nettissima nei manoscritti da me consultati) Questa osservazione ci permette di passare direttamente allrsquoitem seguente
b) Le barre sui numerali e sulle lettere denotative Egrave opportuno discutere questo punto adesso esattamente percheacute di barre siffatte che pure troviamo in tutti i manoscritti i nostri testi non fanno mai menzione si tratta infatti di una pratica condivisa sin dallrsquoantichitagrave La barra identifica una stringa di lettere dellrsquoalfabeto che non svolge una funzione grammaticale o sintattica propria allrsquointerno del discorso Ciograve avviene in particolare e si tratta della fattispecie piugrave frequente se la stringa di lettere non dagrave origine a un vocabolo della lingua greca lette-re denotative e numerali certo ma anche termini provenienti da altri idiomi e contrazioni di parole greche come i nomina sacra62 tali termi-ni possono essere o no preceduti da un articolo lsquocitazionalersquo a seconda dellrsquouso che ne viene fatto allrsquointerno del discorso Ma non si tratta dellrsquounica fattispecie i papiri grammaticali ed i manoscritti piugrave antichi dei trattati dello stesso argomento segnalano gli esempi delle parti del discorso (cioegrave di lsquoverersquo parole greche) per mezzo di barre sormontanti63 La differenza insomma egrave tra menzione e uso (come parte del discorso in atto) di una stringa di caratteri tra il porre le lsquovirgolettersquo e il non porle tra funzione denotativa e non Apparentemente la convenzione si limi-
corredata dei segni opportuni e contrariamente alle indicazioni della descrizione svilup-pata lsquoin verticalersquo ma per motivi misteriosi non completa (tav 7a Laur Plut 89 sup 48 f 13r)
62 Tutto ciograve egrave spiegato con estrema chiarezza giagrave in Traube 1907 pp 45-4763 Si veda il Par gr 2548 codex vetustissimus e testimone unico delle lsquoopere minorirsquo
di Apollonio Discolo il f 106v con le barre ben visibili egrave riprodotto come tav 19 in De Gregorio 2000 (ivi pp 137-138 per la datazione) Per la testimonianza dei papiri grammaticali si veda Wouters 1979 passim essi contengono di norma elenchi di parti del discorso nessuna delle quali egrave preceduta dallrsquoarticolo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 149
tava in questo secondo caso a segnalare con la barra singoli vocaboli le menzioni di frasi o di sintagmi complessi sono di norma identificate dallrsquoarticolo lsquocitazionalersquo Drsquoaltra parte le abbreviazioni convenzionali non rientrano nella casistica percheacute la loro resa grafica che contiene elementi non alfabetici come compendi per desinenze lettere supra li-neam marche di contrazione o sospensione quali slashes o barre sotto-poste o sormontanti eventualmente solo un sottinsieme della stringa di segni alfabetici le esclude automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
Venendo al discorso matematico una barra sormonta senza ecce-zione le lettere denotative64 che sia in papiri o in manoscritti in maiu-scola65 o minuscola ma solo allrsquointerno del testo comrsquoegrave da attendersi nei diagrammi esse la perdono per il semplice motivo che non crsquoegrave alcun testo ambiente un diagramma ha unicamente una funzione denotati-va Drsquoaltra parte le lettere numerali che a volte figurano nei diagrammi della tradizione metrica66 allo scopo di indicare la lunghezza dei seg-menti mantengono la barra in un diagramma il contesto denotativo geometrico egrave prevalente e i numerali vengono percepiti come entitagrave grafiche lsquoesternersquo al discorso Va da seacute a fortiori che le lettere numerali inserite in un testo dovranno essere segnalate da barre che a loro volta non servono nelle tavole67 in quanto queste ultime sono come abbiamo visto un vero e proprio testo che perograve funge da ambiente a quello al-fabetico limitato alle titolazioni e non a caso tracciato in unrsquoopportuna lsquomaiuscola distintivarsquo allo scopo di segnalarne il carattere denotativo e non discorsivo68 Una tabella operazionale egrave invece un paratesto e quindi le barre sulle lettere numerali che rappresentano gli interi sono
64 La notazione per le lettere denotative subigrave unrsquoevoluzione (il cui risultato finale egrave descritto per sommi capi nella nota 3 supra) di cui non mette conto occuparsi qui
65 I papiri di contenuto geometrico (o astronomici ma che presentano argomenti geometrici) sono rari si vedano il PHerc 1061 (sec II aC Demetrio Lacone De geome-tria) e il PFay 9 (sec II ex Elementi I 39 e 41) Gli importanti ostraka OBerl 12002 e 12609 (sec III aC m Elementi XIII) non pongono le barre sopra le lettere denotative Per i manoscritti in maiuscola si veda ad esempio passim nel Par gr 2389 una cui riproduzione digitale egrave consultabile in rete allrsquoindirizzo httpgallicabnffrark12148btv1b8470171d o il fragmentum mathematicum Bobiense
66 Si veda ancora il ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 codex unicus dei Metrica di Erone e contenente una raccolta importante di problemi del corpus metrologico
67 Si vedano come esempio le tavole citate alle note 10 e 14 supra Discorso a parte per il segno di lsquoposto vuotorsquo si veda il punto c che segue
68 Queste regole generali vanno prese cum grano salis si dagrave naturalmente un certo dominio di variabilitagrave legato verosimilmente al grado di cultura grafica del copista nel PMich III 144 i numerali sono quasi tutti senza barra sia nel testo che nelle tabelle ope-razionali
Fabio Acerbi150
necessarie esse mancano invece sui segni convenzionali che ho descrit-to nel punto precedente e fatto rilevante sulle lettere numerali relative agli ordini sessagesimali quando esse siano identificate da uno o piugrave apici la presenza di questo segno grafico non alfabetico69 le esclude ancora una volta automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo Unrsquoultima osservazione che ci saragrave utile nel seacuteguito la descrizio-ne di una stringa di lettere lsquoagrammaticalersquo non puograve prevedere la men-zione della presenza della barra che le pertiene in quanto tale si tratta di una pratica denotativa che egrave possibile formulare soltanto ad un livello di discorso superiore sia a quello dellrsquouso che a quello della menzione70
c) Il segno di lsquoposto vuotorsquo Si noti nella tav 2b la forma ŏ per il segno di lsquoposto vuotorsquo in un ordine sessagesimale coerentemente con la propria notazione il copista del Marc gr 313 lo scioglie talvolta allrsquoin-terno del testo principale come unrsquoabbreviazione per οὐδέν laquonienteraquo Altre convenzioni di scrittura del tratto che accompagna il circoletto e che si badi bene fa parte integrante del segno di lsquoposto vuotorsquo ndash e infatti nelle tavole troviamo sempre il segno completo mentre tutti gli altri numerali sono come abbiamo visto nel punto precedente privi di barra o di apice a causa del fatto che i vari ordini sessagesimali sono univocamente determinati dalle linee di giustificazione ndash un tratto an-golare anteposto (tav 3 Lar Plut 2818 f 136v)71 o una semplice barra a sormontare (tavv 4-9) si produce in questo modo il segno 65926 che sembra essere stata la forma di base72
69 Occorre dunque supporre come testimoniano papiri e manoscritti in maiuscola che la convenzione relativa allrsquouso della barra si sia consolidata ben prima dellrsquointroduzione di segni diacritici quali accenti e spiriti
70 Si veda il punto 2 infra per maggiori dettagli sulla questione delle barre e degli apici e per le indicazioni in merito che leggiamo in Diofanto
71 Come accennato questa tavola dei sottomultipli coincide con quella descritta ed esposta nei Prolegomena Fatto molto rilevante i numerali nella prima non recano neacute barre neacute apici contrariamente a quanto accade a tutte le istanze della seconda nei manoscritti Quella del Laur Plut 2818 preserva a mio avviso la forma originaria come abbiamo visto una tavola non richiede segni aggiuntivi sulle lettere numerali
72 Si vedano come esempio ancora le tavole citate alle note 10 e 14 supra oppure per una rassegna delle forme che il segno assume nei manoscritti piugrave antichi delle Tavole facili Tihon 2011 pp 58-59 e per quelle che assume nei papiri Jones 1999 I pp 61-62 Ovviamente non possiamo leggere il segno 65926 come un omicron con una barra in quanto ο = 70 nella notazione greca e la barra egrave di rigore quando il numerale figuri allrsquointerno di un testo Occorre ammettere che si dagrave origine ad un bel corto circuito notazionale con il concepire un segno con funzione di lsquoposto vuotorsquo ma che lsquosomigliarsquo ad una lettera dellrsquoalfabeto sormontata da una barra cioegrave ad un numerale in piugrave quando il lsquoposto vuotorsquo non corrisponda ad un intero ma ad una specie sessagesimale la presenza della barra a priori indistinguibile da quella che sormonta gli interi introduce unrsquoincongruenza con la notazione a mezzo di apici vista nellrsquoitem precedente
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 151
d) Errori di copia La tabella riprodotta nella tav 2b ha una forma simmetrica ma si tratta di una forzatura il grande rettangolo in basso a destra drsquoaltronde assente nella descrizione contiene uno scolio che fa notare come lrsquoultimo resto parziale ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ͵γτνζ´´´´´ κζ´´´´´´ cioegrave 0 0 0 0 0 3357 27 siano ἔγγιστα λ´λ´ δ´δ´ ξ laquocon ottima approssimazione 60 minuti quartiraquo dove si notino gli apici semplici per indicare il pas-saggio allrsquoordinale e il raddoppiamento del sistema segno + apice per significare il plurale Lo scolio debitamente accompagnato dal segno di rimando in forma di simbolo solare egrave stato probabilmente incluso nella tabella proprio allo scopo di renderla simmetrica A sua volta un errore precedente spiega lo spazio eccessivo accordato al rettangolo contenente lo scolio il secondo massimo multiplo ŏ λβ´ ξδ´´ ριβ´´´ σιϛ´´´´ egrave trascritto anche al di sotto del risultato
Passiamo ora alla descrizione del metodo di divisione attribuito a Pappo
ἵνα οὖν ταῦτα συναχθῇ τὰ ἐκ τοῦ μερισμοῦ ὁ εἰρημένος Πάππος εὐδιατύπῳ τινὶ καὶ πρὸς τοῦτο τάξει χρησάμενος ποιεῖται τὴν τῆς συλλήψεως τοῦ ζητουμένου ἀνεύρεσιν οὕτως ἐκθέμενος γὰρ τὸν μέλλοντα μερίζεσθαι τουτέστι τὰς τξ μοίρας ἐν ἀρχῇ ἀφαιρεῖ ἀπ᾽ αὐτῶν τὸν ἐν τῇ σελίδι τυγχάνοντα ἐλάττονα τουτέστι τὸν τδ κβ´ κ´´ ὄντα τῶν ἐγγὺς ἐλασσόνων ὡς πρὸς τοὺς ἐκκειμένους διὸ καὶ γράφει αὐτὸν προγράφων αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε καὶ εὑρίσκων τὰ παρακείμενα αὐτῷ τῷ ἀπογραφέντι ἐν τῷ σελιδίῳ λεπτὰ πρῶτα ν´ συναπογράφεται παρατιθῶν αὐτοῖς τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον ἀνατείνουσαν σημαῖνον τὸ εἶδος ὅτι πρῶτα λεπτά εὑρίσκει οὖν οὕτως τὸ τῶν τξ μέρος τὸ τδ κβ´ κ´´ ὃ μεριζόμενον παρὰ τὰς τξε ιδ´ μη´´ ἡμέρας καὶ ποιοῦν τὸν ἐκ τοῦ μερισμοῦ ἀριθμὸν πρῶτα λεπτὰ ν´ καὶ τὸν λοιπὸν ἀπογραφόμενος τὸν νε λζ´ μ´´ προτάσσει αὐτοῦ τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά τάσσει δὲ καὶ ἁπλῆν τινα διατείνουσαν γραμμὴν ὡς ἀπὸ τοῦ τξ ἐπὶ τὸν ἑξῆς ἐκτεθειμένον ἐγγὺς
1
5
10
1 εὐδιατύπῳ] ZSPC εὐδιατύπωτ M 4 ἀφαιρεῖ] MZSP ἀφ ι C 5 ἐλάττονα] P comp MZSC 6 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | αφ ] αφ ε M ἀφ ZS ἀφαί P ἄφ C | ἀντὶ] om C | ἄφελε] MZSP ἄφ C 8 ἀπογραφέντι] MZSP ἐγγραφέντι C | λεπτὰ πρῶτα] P λε πρωτα SC λεπτῶν πρωτ MZ | παρατιθῶν] MZS παρατιθεὶς C et ex corr m 2 P 9 ᾱ] Z αο P α´ MS α C | ἔχον] MPC ἔχων ZS 9-10 πρῶτα λεπτά] ZP πρωτ λ´λ´ M πρωτα λε S αα λε C 11 ἡμέρας] comp codd | ἀριθμὸν] P et comp MZ καὶ C et comp S 12 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M πρωτ λεπτ(α) Z πρωτ λ εᾱ S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C | ἀπογραφόμενος] MZSP ἐγγραφόμενος C | νε λζ´] MZSP λζ νζ C 13 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | λ οι] MZSC ex λ fecit λ οι P | προσσημαῖνον] MC et προσ- comp ZS προση- P | τὸ] MZC τὰ S et fecit m 2 P 14 ἀπὸ] MZSP πρὸς C ἐλάττονα] P comp MZSC
1 εὐδιατύπῳ] εὐδιατυπώτω K 6-7 αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ] τὸ ἀφ K 8 παρατιθῶν mdash 10 λεπτά] τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ σημαίνουσαν τὸ εἶδος αὐτῶν ὅτι ᾱ λεπτά εἰσιν K | τὸ (sec)] τὰ K 12 πρῶτα] πρώτων K | τε λ ] λ οι` K | προσσημαῖνον mdash
Fabio Acerbi152
ἐλάττονα τὸν τδ κβ´ κ´´ ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις καὶ ταύτην ἐπιδεικνύουσαν τὴν τάξιν τῆς προόδου τῆς ἐκθέσεως ἧστινος κλωμένης γραμμῆς πρὸς τῷ ἐγγὺς ἐλάσσονι ἡ ἀντανάκλασις ἐπὶ τὸν λοιπὸν γέγραπται φερομένη ὡς εἴρηται διὰ τὸ εὔτακτον τῆς προκοπῆς οὕτως τε ποιήσας ἑξῆς τὸ αφ ποιῶν ὃ προσσημαίνει ὡς εἴρηται τὸ ὅτι δεῖ ἀφελεῖν ὁμοίως ἀπὸ τοῦ λοιποῦ καὶ δὴ τὸν ἐγγὺς πάλιν ἐλάσσονα ὡς πρὸς τὴν ἐν τῷ σελιδίῳ ἔκθεσιν εὑρισκόμενον λαμβάνων ἑξῆς προγράφει αὐτὸν ὄντα νδ μζ´ ιγ´´ ιβ´´´ καὶ εὑρίσκει αὐτοῖς παρακείμενα ἐν τῷ σελιδίῳ πρῶτα λεπτὰ θ´ ἅτινα καὶ αὐτὰ προσαπογράφεται σὺν τῇ παρασημειώσει τῶν πρώτων γράφων τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον τὴν ἀνατείνουσαν καὶ ὡς εἴρηται τὴν γραμμὴν πάλιν διὰ τὴν τάξιν κλωμένην κατὰ δευτέραν κλάσιν προσέλκει γινομένου τοῦ μέρους αὐτῆς τούτου παραλλήλου τῷ ἐξ ἀρχῆς
16 ante κλωμένης add ἐπὶ C 18 τε] MZP om SC | αφ ] M ἀφ ZSC ἀφαί P 19 προσσημαίνει] MS προση- ZC et ex corr P | ὅτι] ZP comp MSC 20 δὴ] MZSC διὰ fecit m 2 P 21 πρὸς] MSP et supra lineam C ex ἀπὸ fecit m 2 Z | ιγ´´] MZSP νγ´´ C 22 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M ᾱᾱ λεπτὰ Z άάα λε S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C 23 προσαπο- γράφεται] απο suprascr in comp M 24 ᾱ] ZP α´ MS α C 25 κλάσιν] MP τάξιν ZSC | τοῦ] ZSPC τούτου M 26 τούτου] τοῦ bis ZSPC sed prius erasit m 2 P τοῦ M
mdash 18 προκοπῆς] om K | τε ποιήσας] ποιήσας καὶ K | αφ ] ἀφ K 19 τὸ] om K 21 προ-γράφει] γράφει K 22 σελιδίῳ] α´ σελιδίῳ K | ἅτινα] ἃ K 23 προσαπογράφεται] ἀπογράφεται K | τῶν πρώτων mdash 26 ἐξ ἀρχῆς] om K
lsquoAllo scopo di raccogliere ciograve che risulta dalla divisione il detto Pappo utilizzando anche in questo caso una certa disposizione ben strutturata determina nel modo seguente il lsaquonumerorsaquo cercato preso nel suo insieme collocando73 in testa il lsaquonumerorsaquo che sta per essere diviso cioegrave i 360 gradi iniziali sottrae loro tra i piugrave prossimi dei lsaquonumerirsaquo minori rispetto a quelli esposti quello che si trova essere minore nella colonna (cioegrave 304 22 20) Questo egrave il motivo per cui lo trascrive scrivendogli davanti lrsquoabbreviazio-ne laquosottrraquo per laquosottrairaquo e trovando che 50 minuti primi sono collocati accanto a quello stesso lsaquonumerorsaquo che egrave stato trascritto nella colonna li trascrive al tempo stesso collocando accanto74 ad essi la lettera A con un lsaquotrattorsaquo75 sopra che significa la specie minuti primi Trova dunque in que-sto modo la parte di 360 che egrave 304 22 20 la quale divisa per 365 giorni 14 48 fa il numero lsaquoche risultarsaquo dalla divisione 50 minuti primi Trascrivendo
73 La descrizione egrave strutturata come una procedura Acerbi 201274 Il purismo del correttore del Par gr 2390 di Clostomalle nel Marc gr 314 e
dellrsquoautore della recensione bizantina impone loro di modificare la terminazione ma forme tematiche e contratte di τιθεῖν sono correnti nel greco tardivo
75 Il testo greco ha solo il participio con γραμμήν sottinteso Per il significato del participio si veda il punto 2
15
20
25
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 153
poi il resto 55 37 40 gli pone altresigrave76 a prefisso laquoReraquo che significa laquorestiraquo e dispone anche una certa linea semplice77 che va da 360 al piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori che egrave esposto di seacuteguito 304 22 20 come nello lsaquoschemarsaquo esposto linea che mostra lrsquoordine del percorso dellrsquoesposizione Questa linea spezzata lagrave dove si trova il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori egrave tracciata inflessa allrsquoindietro lsaquoersaquo punta verso il resto come egrave stato detto in vista di una progressione ordinata E cosigrave facendo prendendo di seacuteguito il laquosottrraquo che significa come egrave stato detto laquoche occorre similmente sottrarre dal re-storaquo e ovviamente prendendo di nuovo il lsaquonumerorsaquo che egrave trovato essere il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori in relazione alla disposizione nella colonna ndash 54 47 13 12 ndash lo scrive di seacuteguito e trova che 9 minuti primi sono posti loro accanto nella colonna trascrive78 anche questi con la segnaletica dei primi scrivendo la lettera A con un lsaquotrattorsaquo sopra e come egrave stato detto prolunga di nuovo la linea spezzata in vista di una buona disposizione tramite una seconda inflessione essendo questa sua parte parallela a quella inizialersquo
La descrizione continua con una serie di laquoe cosigrave viaraquo e non fa ulte-riore riferimento alla tabella
1) La forma verbale ἐξεσμένον Egrave il neutro del participio perfetto medio-passivo di ξέω lett laquopialloraquo laquolevigoraquo Si danno tre possibilitagrave si tratta di un termine canonico per quanto non altrove attestato per designare unrsquoabbreviazione oppure lrsquoautore anonimo improvvisa sul piano metaforico come se unrsquoabbreviazione non fosse altro che la paro-la completa lsquoaccorciata a colpi di piallarsquo in maniera opportuna oppure il testo egrave corrotto e srsquoimpone una correzione ad esempio τὸ ἑξῆς μένον laquociograve che sta di seacuteguitoraquo Questrsquoultima strada mi pare chiusa dal senso delle frase lrsquoabbreviazione non lsquosta di seacuteguitorsquo a niente ma anzi precede la perifrasi τὸ ἑξῆς μένον se impiegata semplicemente per rimandare al segno αφ immediatamente seguente costituirebbe un intollerabile solecismo Se accettiamo la prima di queste letture considerando quin-di lrsquoabbreviazione αφ in posizione predicativa abbiamo a che fare con
76 Rendo in questo modo il τε isolato77 La linea egrave laquosempliceraquo in quanto egrave una retta la precisazione intende evidenziare per
anticipazione il carattere lsquonon semplicersquo che essa assumeragrave alla prima inflessione quando diventeragrave una spezzata linee siffatte erano in effetti concepite dallrsquoanonimo e prima di lui da tutta la tradizione matematica greca come una singola linea spezzata nei punti drsquoinfles-sione I due segmenti paralleli menzionati al termine del passo sono orizzontali
78 Il verbo egrave al medio in variatio rispetto ai due che precedono e che seguono egrave il matematico che lsquosirsquo trascrive le cifre
Fabio Acerbi154
uno hapax semantico nella grecitagrave superstite come egrave facile verificare con una ricerca sul TLG in rete La recensione bizantina risolve il pro-blema sopprimendo semplicemente τὸ ἐξεσμένον
2) La notazione per le specie numeriche Nella terminologia matema-tica greca gli ordini sessagesimali sono εἴδη laquospecieraquo numerici essi corri- spondono agli ordini di grandezza nel nostro sistema decimale e indica-no in analogia con il caso geometrico la lsquoformarsquo che assume un numero quadrato cubo ecc Centinaia e migliaia sono quindi degli εἴδη rispet-tivamente quadrati (100 egrave il quadrato di 10) e cubi (1000 egrave il cubo di 10) sono specie numeriche ma non numeri particolari e drsquoaltronde 300 non egrave un quadrato ma 3 item dellrsquoεἶδος lsquoquadratorsquo 100 3 egrave il numerale di molteplicitagrave della specie quadrata lsquocentinaiarsquo i due 0 che seguono il 3 segnalano esattamente questo fatto che la notazione greca per gli interi non posizionale fa scomparire al livello denotativo Ciograve non vale soltan-to per i numeri interi ma anche per le loro parti i minuti secondi appar-tengono alla specie lsquoquadratorsquo in quanto 13600 egrave il quadrato di 160
La concezione appare interamente dispiegata nellrsquointroduzione degli Arithmetica diofantei79 che si rivela giova farlo rimarcare un te-stimone fondamentale per la ricostruzione della notazione matematica antica Alle specie usate in questrsquoopera vengono assegnati una denomi-nazione ed un segno convenzionale costituito dallrsquoiniziale (di ognuno dei componenti) della denominazione al quadrato o δύναμις il segno ΔΥ al κύβος il segno ΚΥ alla lsquoquarta potenzarsquo o δυναμοδύναμις il segno ΔΥΔ ecc La descrizione di tali segni egrave del tipo καὶ ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον Κ ἐπίσημον ἔχον Υ ΚΥ κύβος laquoe il suo segno egrave un Κ che ha come indice un Υ ΚΥ cuboraquo dove in accordo con quanto abbiamo visto nel punto b supra e pur nel comprensibile imbarazzo del copista della prima parte del Matritensis (o di un suo passato collega) a districarsi in questo formidabile ginepraio notazionale80 le due lettere Κ e Υ ricevono una barra mentre ΚΥ non la richiede a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον il quale ancora una volta esclude automaticamente il segno dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
79 In particolare a DOO I pp 214-62180 Nel Matr 4678 riscontriamo i seguenti fenomeni nelle poche righe a cavallo dei ff
58r-v 1) accento acuto posto su tutti i segni come se fossero abbreviazioni 2) ripetizione sistematica segnodenominazione come in ΚΥ κύβος appena letto dovuta sicuramente allrsquointrusione di glosse interlineari esplicative dei segni ndash e successivo pentimento (δύναμις e κύβος sono in effetti cancellati dalla prima mano il primo con un tratto il secondo con dei punti supra lineam poi il copista si stanca di correggere) 3) nella descrizione del segno per la δυναμοδύναμις menzione di un δέλτα δύο che saragrave molto probabilmente stato ΔΔ subito dopo nella descrizione del κυβόκυβος si legge un incongruo δύο KK
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 155
Diofanto introduce poi dei segni anche per le specie delle parti dellrsquounitagrave (le nostre frazioni) che egli chiama ὁμώνυμα μορία laquoparti omonimeraquo di cui quelle sessagesimali sono casi particolari81 Egli spie-ga appunto che le loro denominazioni sono ottenute da quelle delle specie degli interi per sinonimia passando ad un lsquoordinalersquo82 formato semplicemente aggiungendo il suffisso -στον δυναμοστόν κυβοστόν δυναμοδυναμοστόν ecc (sott μόριον) I loro segni convenzionali sono invece ottenuti da quelli per le specie degli interi aggiungendo una γραμμὴν διαστέλλουσαν τὸ εἶδος laquolinea che distingue la specieraquo83 Una linea sui segni delle specie delle parti egrave richiesta si badi bene per distinguerli dai segni di quelle degli interi come giagrave osservato questi ultimi sono giagrave lsquoagrammaticalirsquo a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον a fortiori lo saranno anche i primi Si tratta della traduzione semio-tica del passaggio dal cardinale allrsquoordinale che a livello grammaticale egrave effettuato con il suffisso -στον Che forma ha questa linea Barra o apice (Egrave cervellotico pensare a forme piugrave complesse) La domanda non ammette una risposta immediata in quanto delle specie diofantee nessuno piugrave si occupa nellrsquoantichitagrave84 Se egrave vero che la prima risposta darebbe origine ad un conflitto tra due convenzioni denotative diffe-renti la barra lsquocitazionalersquo e la barra che distingue la specie lrsquoevidenza grafica del Matritensis lascia lievemente sgomenti (ricordiamoci che giagrave i segni di base sono indebitamente dotati di un accento dal copista) Le poche occorrenze del segno per le specie delle parti85 vedono lrsquoaggiunta di uno slash di sospensione di un doppio apice inverso ndash in tutta evi-
81 Questo fatto era giagrave chiaro nellrsquoantichitagrave Teone in Alm I 10 in iA p 45310-1682 Il parallelo con i cardinali e gli ordinali relativi agli interi egrave reso esplicito da Dio-
fanto ὥσπερ δὲ τῶν ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια παρομοίως καλεῖται τοῖς ἀριθμοῖς τοῦ μὲν τρία τὸ τρίτον τοῦ δὲ τέσσαρα τὸ τέταρτον οὕτως καὶ τῶν νῦν ἐπονομασθέντων ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια κληθήσεται παρομοίως τοῖς ἀριθμοῖς laquocome le parti omonime dei numeri sono chia-mate per assonanza con i numeri di lsquotrersquo lsquolsaquounrsaquo terzorsquo di lsquoquattrorsquo lsquolsaquounrsaquo quartorsquo cosigrave le parti omonime dei numeri appena nominati saranno chiamate per assonanza con i numeriraquo (DOO I p 69-13 si noti lrsquoarticolo lsquocitazionalersquo al singolare in τοῦ τρία e τοῦ τέσσαρα) Il parallelo prosegue anche al livello dei segni che rappresentano queste specie come vedremo tra un attimo
83 Diofanto Arithmetica prefazione in DOO I p 620-21 un passaggio maltrattato in questa edizione occorre espungere il participio ἔχον senza introdurre segni ulteriori oppure eliminare un precedente ἐπί come fa un correttore del Matritensis f 58v
84 Unica parzialissima eccezione lrsquoaccenno di Teone menzionato nella nota 81 supra85 Al f 59r e per di piugrave nel margine per sanare un lungo saut du mecircme au mecircme La
collocazione in margine egrave il motivo per cui troviamo una notazione abbreviata nel resto del trattato il primo copista scioglie tutti i segni prendendoli per abbreviazioni mentre il secondo elimina sistematicamente il tratto aggiuntivo delle specie delle parti dellrsquounitagrave Drsquoaltronde egli scrive ad esempio ΔΥ invece di ΔΥ ed egrave quindi indotto a porre la barra al di sopra della stringa di lettere risultante (passim ma si veda ad esempio il f 72r)
Fabio Acerbi156
denza il compendio per la desinenza -ον accentata il copista interpreta il segno come unrsquoabbreviazione ndash e di una barra a sormontare lo Υ Potremmo forse interpretarlo come il segno di contrazione del grafema -στ- lrsquounico tassello mancante in unrsquoabbreviazione come ad esempio (δυναμοδυναμο)(στ)(ὸν) ma uno scolio di prima mano al f 58v rela-tivo alle specie degli interi inficia questrsquoipotesi esse sono dotate di slash di sospensione accento acuto in un caso del compendio canonico per la terminazione -ον hellip ma tutti gli Υ a esponente sono a loro volta sormontati da una barra
Meno legata al singolo manoscritto ma nondimeno non uniforme si presenta la pratica di notazione dei segni che rappresentano gli enti numerici sessagesimali86 da una parte sta lrsquoevidenza del testo dei Pro-legomena e delle sue tabelle apici ndash drsquoaltronde come abbiamo visto la notazione universalmente impiegata per i numerali ordinali e per le fra-zioni unitarie ndash dallrsquoaltra sta lrsquoevidenza del testo dellrsquoAlmagesto in tutti i manoscritti piugrave antichi e lo stesso si dica del commentario teonino a questrsquoopera o del suo lsquoGrande commentariorsquo alle Tavole facili e dei testi astronomici su papiro barre87 Sembra insomma che la nostra docu-
86 Sia le molteplicitagrave che le specie ahimeacute entrambe rappresentate da lettere dellrsquoalfabeto Come osservato allrsquoinizio della sezione 3 ci sono in effetti due tipi di lettere numerali in gioco se facciamo astrazione da apici o barre lsquo4 minuti secondirsquo si trova scritto δ β la prima lettera numerale denota la molteplicitagrave degli item di una certa specie la se-conda la specie nei Prolegomena entrambe sono accompagnate da un doppio apice il che rende inutile la presenza delle seconde Si noti che la descrizione della tabella non fa parola della notazione da usare per le lettere numerali che denotano la molteplicitagrave barre o apici e quanti apici hellip In questo caso fa interamente fede la tabella cioegrave la pratica grafica condivisa instauratasi non egrave chiaro quando
87 I manoscritti piugrave antichi dellrsquoAlmagesto sono menzionati nella nota 10 supra quelli dei due commentarii teonini sono il Laur Plut 2818 e il celeberrimo Vat gr 190 (sec IX in Euclide Elementi Data Teone lsquoGrande commentariorsquo) per la notazione dei pa-piri astronomici si veda Jones 1999 II passim La notazione non sembra lsquoinquinatarsquo dalla pratica dei copisti bizantini e pare dipendere soltanto dalla data di composizione Tro-viamo ad esempio barre sopra tutti i numerali di molteplicitagrave (interi o sessagesimali) nel frammento di un commentario alle Tavole facili contenente un calcolo relativo al 24 aprile 213 (Par gr 2841 sec XIII ex-XIV in oltre al frammento ai ff 32r l 11-34v l 23 contiene Arato Phaenomena ed Efestione Apotelesmatica edizione in Jones 1990) Nel commentario alle Tavole facili composto ca 610-617 ed attribuito a Stefano di Alessandria la situazione egrave la seguente (Jean Lempire per litteras per lrsquoedizione si veda Lempire 2014 ho controllato il Vat gr 304 ff 135r-171v sec XIV am contiene in aggiunta Teone in Almagestum I-II lsquoPiccolo commentariorsquo alle Tavole facili Diofanto Arithmetica e De polygo-nis numeris varia astronomica tabulae) barre sopra gli interi sporadicamente rimpiazzate da apici apici sopra le parti sessagesimali in numero uguale alla denominazione doppio () apice per le frazioni unitarie Sono impiegate barre sopra gli interi e apici sopra le parti sessagesimali nei manoscritti principali di tutti i trattati di introduzione allrsquoAlmagesto o comunque di argomento logistico redatti in epoca bizantina Giorgio Pachimere (1242-ca 1310) Quadrivium (autografo nel manoscritto Roma Biblioteca Angelica gr 38 [RGK III nr 115] si veda Tannery ndash Steacutephanou 1940 per lrsquoedizione) Teodoro Metochita (1270-
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 157
mentazione si faccia testimone di un cambio notazionale avvenuto nel periodo intercorrente fra Teone (sec IV pm) e la scuola alessandrina di Ammonio e dei suoi allievi (sec VI in) e probabilmente innescato da questrsquoultimo ambiente lrsquoaspetto paradossale egrave che nello stesso codice si rintraccino due notazioni differenti per gli enti numerici sessagesimali e lrsquouna (apici) sia adottata sistematicamente e coerentemente in uno scritto (i Prolegomena) che si presenta esattamente come unrsquointroduzione tecnica alla pratica numerico-algoritmica del trattato (lrsquoAlmagesto) in cui egrave adottata lrsquoaltra (barre che ritroviamo senza eccezioni anche negli scolii)
Torniamo ai Prolegomena la descrizione del segno da porre a fianco di ogni singolo quoziente parziale e denotante la sua specie numerica (minuti primi minuti secondi ecc) solleva tre problemi
Primo problema Ci vuole una barra o un apice su τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquola lettera A [hellip] che significa la specieraquo quando lo scriviamo nella tabella Tutta la nostra discussione precedente fa pro-pendere per lrsquoapice e si ricordi anche la forma verbale ἀνατείνουσαν che suggerisce qualcosa che si lsquoestende verso lrsquoaltorsquo (la mia traduzione egrave volutamente neutra) se fosse apposta una barra la cosa dovrebbe passare
1231332) Compendium astronomicum (copia lsquoautorizzatarsquo coeva nei Vat gr 182 e 181 da parte del copista che integrograve le parti mancanti del Par gr 2389 [ff 207-210 255-270 374-375] Bianconi 2005a pp 425-427 Peacuterez Martiacuten 2008 p 436 e n 177) Teodoro Meliteniota (morto lrsquo831393) Tribiblos astronomica (autografo nel Vat gr 792 si vedano Leurquin 1991 per unrsquoanalisi del manoscritto Leurquin 1990 per lrsquoedizione) una com-pilazione anonima (per cui ho consultato il Par gr 2396 ff 87r-92v limitatamente a questi fogli manu Costantino Trivoli [RGK II nr 318 ma ovviamente questo codice non vi egrave segnalato] terzo quarto del XV secolo il resto del codice annotato da Niceforo Gregora egrave di etagrave planudea e parzialmente [ff 33v-76v] un autografo di Planude stesso contiene Teone in Almagestum I II IV Mondrain 2002 il codice va completato ndash limitatamente a stralci dei libri VIII-X XII-XIII del commentario teonino la cui parte intermedia si egrave persa ndash con 26 carte [ff 123-147] inserite nel Vat gr 1087 anchrsquoesso contenente anno-tazioni di Gregora Rome 1927 per la figura del copista dei ff 77r-86r del Par gr 2396 e dei ff appena nominati del Vat gr 1087 un anonimo collaboratore di Gregora si veda in ultimo Bianconi 2006a pp 147-151) si veda anche il calcolo effettuato da Niceforo Gre-gora (12921295-13581361) dellrsquoeclisse di sole del 16 luglio 1330 (attestata unicamente ai ff 1r-8v della miscellanea astronomica Marc gr 325 databile ca 1324-1329 in parte vergata e ovunque fittamente annotata da Gregora stesso edizione del testo in Mogenet et al 1983 annotazioni di Gregora elencate in Bianconi 2005a p 413) Unrsquoeccezione apparente il lsquoPiccolo commentariorsquo di Teone alle Tavole facili le parti sessagesimali sono segnalate da apici (ad esempio nel Vat gr 175 vergato da Giovanni Catrario e completato nel 1321-1322 sulla figura di Catrario si vedano in ultimo Bianconi 2005b pp 141-156 e 2006b) lrsquoopera egrave antica ma la sua tradizione non rimonta oltre la fine del XIII secolo a parte un frammento nel Leiden BPG 78 ff 156r-161v (minuscola del IX-X secolo) e in effetti in questo manoscritto tutti i numerali di molteplicitagrave sono sormontati da barre Unrsquoeccezione effettiva egrave il De hypotesibus planetarum nel Vat gr 1594 barre sugli interi e apici sulle parti sessagesimali
Fabio Acerbi158
sotto silenzio e la presenza dellrsquoapice la rende inutile88 Si tratta della stessa convenzione diofantea e coincide ancora con la notazione per i numerali ordinali e per le frazioni unitarie che egrave corrente nei mano- scritti matematici greci per questo motivo non percheacute la descrizione sia particolarmente perspicua nessuno dei copisti della recensione an-tica ha incertezze apici Ma questi apici si rintracciano soltanto sulle indicazioni di specie non contemplate dalla descrizione che sono ante-poste ai resti parziali a fianco dei quozienti parziali i segni di specie sono invece trasformati in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordi-nali corrispondenti del tipo πρωτ tavv 5 e 7b-8 Il recensore bizantino taglia invece la testa al toro elimina dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali elimina la seconda menzione della laquolet-tera Araquo contestualmente allrsquoazzeramento dellrsquoespediente della linea a zig-zag (si veda il punto seguente) modifica la descrizione che contiene la prima menzione in quella dellrsquoapice associato direttamente ai nume-rali di molteplicitagrave riciclando addirittura lrsquoalpha per adibirlo a desi-gnare un numero cardinale (come sorprendersi) τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ laquoponendo al di sopra di essi [scil dei 50 minuti primi] 1 solo lsaquoaccentorsaquo acutoraquo La scelta del recensore egrave assennata che rechi una barra o un apice in una tabella un alpha denota un numero non un numero drsquoordine
Secondo problema da tenere ben distinto dal precedente Cosa ci vuole sul segno α per la lettera alpha menzionata nella frase τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquolettera A [hellip] che significa la specieraquo89 Unrsquooc-chiata allrsquoapparato critico rivela una bella incertezza nei manoscritti Z scrive sempre ᾱ e in un caso lo fa anche P MS optano sempre per α´ C per α P scrive nellrsquoaltro caso αο Per quanto solo la barra sia congrua con il senso della frase in quanto la lettera alpha egrave qui menzionata (si tratta di un oggetto che compare nella tabella) e non cambia niente se essa egrave accompagnata dal suo nome di genere στοιχεῖον ad un livello grafico lrsquoincertezza fra il segno ᾱ che denota laquola lettera αraquo e il segno α´ (o lrsquoabbreviazione αο) per una forma di πρῶτος egrave per piugrave versi giustificata
88 Detto in altri termini la barra egrave uno strumento grafico non matematico e quindi la sua presenza non va segnalata mentre un apice lo egrave e la sua presenza lo deve
89 Notare che in questa frase il primo α non vuole la barra (egrave menzionato allrsquointerno di una frase che impiega convenzioni moderne) il secondo sigrave (idem ma con convenzioni antiche) ndash e nella traduzione la scelta di denotarlo con A (senza virgolette) e non con lsquoArsquo (con virgolette) egrave del tutto arbitraria ndash si noti inoltre che le necessarie precisazioni laquosenzacon virgoletteraquo mostrano che le lingue moderne palesano difficoltagrave analoghe a quelle del greco antico per quanto riguarda i livelli denotativi in ambito metadiscorsivo per non usare le due parentetiche avrei dovuto scrivere rispettivamente lsquoArsquo e lsquolsquoArsquorsquo (doppie virgolette semplici)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 159
ᾱ coincide con il numerale 1 α egrave la prima lettera dellrsquoalfabeto ed inoltre α´ egrave esattamente quello che va scritto nella tabella Potremmo dirci che il sostantivo στοιχεῖον chiude la questione la sua presenza congiunta ad un ipotetico α´ renderebbe la descrizione ridondante o inappropriata90 Ma a parte il fatto che α egrave proprio τὸ πρῶτον στοιχεῖον il segno α´ cat-tura in fondo il cuore della descrizione di uno στοιχεῖον ἔχον lsaquoγραμμὴνrsaquo ἀνατείνουσαν
Terzo problema Lrsquoautore dei Prolegomena che si arresta allrsquoesem-pio dei minuti primi non dice quanti apici occorre mettere sulle lettere numerali che identificano gli ordini superiori al primo se uno soltanto come nel caso diofanteo e delle frazioni unitarie o in numero uguale alla loro denominazione (cioegrave pari al numero denotato dal numerale stesso su cui vanno posti) come effettivamente avviene nei mano-scritti dei Prolegomena La tabella egrave quindi sottodeterminata dalla sua descrizione anzi in un certo senso prende il sopravvento su di essa la pratica di marcare i numerali di molteplicitagrave con gli apici che compe-tono allrsquoordine cui appartengono viene trasferita ai segni per gli ordini stessi per supplire ad una descrizione carente di questi ultimi E la tabella egrave sottodeterminata dalla descrizione in quanto egrave la descrizione di una tabella reale ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις laquocome nello lsaquoschemarsaquo espostoraquo leggiamo a un certo punto del testo
3) La linea a zig-zag Non possiamo che applaudire a questo geniale espediente grafico lo troviamo messo in opera solo nel Marc gr 313 Per quanto lrsquoautore non faccia parola di ciograve nel corso della sua descrizione la linea spezzata egrave intesa dover lsquosaltarersquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue Il copista del codice marciano effettua correttamente due salti nella prima delle sue tabelle (tav 4) ma inserisce un lsquodentersquo in piugrave in quella che considera corretta (tav 5) La linea a zig-zag egrave incompatibile con la presenza di linee di giustificazione nella tabella che in effetti mancano nel Marc gr 313 ciograve induce gli errori di allineamento dei primi 5 quozienti parziali di cui egrave vittima il copista Probabilmente per questo motivo in nessuno degli apografi del Vat gr 1594 la linea a zig-zag figura nella tabella inquadrata come si conviene da una (doppia) cornice esterna e le cui colonne sono appunto separate da linee verticali (tav 7b Vat gr 184 f 17v e tav 8 Par gr 2390 f 9v cui egrave sostanzialmente identica la tabella del Marc gr 314 che si trova
90 Trascuro lrsquoabbreviazione αο = πρῶτος percheacute la desinenza non egrave quella richiesta neacute nella frase (egrave richiesto πρῶτον) neacute nella tabella (πρῶτα)
Fabio Acerbi160
al f 248r ndash ma la mancanza di linee orizzontali causa un gigantesco pa-sticcio nel codice vaticano) Alla recensione bizantina che dipende per il suo testo di base dal Vat gr 1594 e quindi non trova la linea a zig-zag nella tabella non resta che sopprimere la sua descrizione ndash ma proprio per questo motivo e finalmente diventa possibile tracciare un apparato completo di linee di giustificazione (tav 9 Laur Plut 89 sup 48 f 14v) Dato che la descrizione di Teone di questo procedimento di divi-sione non fa cenno allrsquoesistenza della linea a zig-zag viene da chiedersi se essa non costituisca un espediente escogitato dallrsquoautore dei Prolegomena per vivacizzare la procedura originale di Pappo
4) Discrepanze tra descrizione e tabella Il gioco delle minime va-rianti mostra che la divisione era stata eseguita (e trasmessa) corret-tamente tutti i valori numerici sono esatti La tabella nel Marc gr 313 presenta perograve alcune discrepanze con la propria descrizione Essa omette (ma non nella versione lsquoscorrettarsquo lrsquoomissione non si riscontra neanche nel Par gr 2390) il segno per laquorestoraquo di fronte ai resti par-ziali ma aggiunge lrsquoindicazione della loro specie Essa trasforma invece come abbiamo visto le indicazioni di specie che seguono i quozienti parziali in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordinali corri-spondenti La descrizione prevede di chiudere la tabella con il risultato καὶ συνάγων ἅπαντα τὰ ἐκ τῶν μερισθέντων μερῶν λεπτὰ σημειοῦται ὑπὸ πάντας οὕτως γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoe raccogliendo tutti i minuti che provengono dalle parti divise lsaquoPapporsaquo nota sotto tutto cosigrave Ris 0 59 8 17 13 12 31raquo ma sotto la tabella tutta la tradizione ci consegna qualcosa di piugrave articolato ὁ ζητούμενος καθ᾽ ὃν μερίζεται ὁ τξε ιδ´ μη´´ π(αρὰ) τὸν τξ γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoil lsaquonumerorsaquo cercato secondo cui 365 14 48 egrave diviso per 360 risulta 0 59 8 17 13 12 31raquo frase che del resto contiene due errori lrsquoinversione del dividendo e del divisore e la confusione tra segno convenzionale (iuxta descrizione) e abbreviazione (come nella frase) nel caso di γι Oltre ad eliminare la linea a zig-zag91 la recensione bizantina sopprime dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali e modifica come abbiamo visto al punto 2 le loro descrizioni in quelle di apici associati diretta-mente ai numerali di molteplicitagrave
91 Le due righe che nella recensione di base contengono solo i resti parziali minori di 160 del divisore ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue sono in parte completate con lrsquoindicazione abbreviata ἀνάλ(υσις) laquoanalisiraquo il termine greco per questa procedura di riduzione In un sussulto di ipercorrettismo matematico tali resti parziali ridotti non sono preceduti dal segno per laquorestoraquo come nel Par gr 2390 ma da quello per laquorisultatoraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 161
Gli esempi che abbiamo discusso mostrano come i problemi di notazione pesino e non poco sullrsquoespressione discorsiva di un algorit-mo matematico lrsquoente di riferimento per lsquoformularersquo il procedimento di divisione fu considerata la tabella cioegrave un oggetto la cui costitu-zione egrave legata piugrave ad una pratica grafica che a considerazioni logico- algoritmiche non la sua descrizione che in effetti finisce per determi-nare la tabella in maniera non univoca Di questa sottodeterminazione si fa testimone la traiettoria che abbiamo cercato di seguire nelle mani di copisti e revisori il procedimento di divisione si modifica a volte in aspetti secondari a volte in punti piugrave sostanziali ndash fino a rendere neces-saria una radicale revisione della sua descrizione per renderla conforme alla tabella ndash in ogni caso mai per ragioni squisitamente matematiche92
Abstract
The article presents and discusses in detail two passages from the anonymous Prolegomena to the Almagest a VIth century primer to the elementary procedures of calculation needed in Ptolemyrsquos Almagest In the two passages we may follow the complex interplay between mathematical notation the auctor who employed and described it the tachygrapher who transcribed it in vivo copyists who reproduced it correctors who modified it Along this path misgivings and errors arise in the transmission of abbreviations and paratextual units such as diagrams tables operational schemes
Fabio AcerbiCNRS UMR8560 Centre Alexandre Koyreacute
fabacerbigmailcom
92 Sono grato a Daniele Bianconi Lucio del Corso Jean Lempire per alcune preziose indicazioni
AOO = Archimedis opera omnia cum commentariis Eutocii ed J L Heiberg I-III Lipsiae 1910-1915
DOO = Diophanti Alexandrini opera omnia cum Graecis commentariis ed P Tannery I-II Lipsiae 1893-1895
GC = Le laquoGrand Commentaireraquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Mogenet ndash A Tihon I-III Cittagrave del Vaticano 1985-1999
iA = Commentaires de Pappus et de Theacuteon drsquoAlexandrie sur lrsquoAlmageste ed A Rome I-III con paginazione continua Cittagrave del Vaticano 1931-1943
HOO = Heronis Alexandrini opera quae supersunt omnia ed G Schmidt ndash L Nix ndash W Schmidt ndash H Schoene ndash J L Heiberg I-V Lipsiae 1899-1914
PC = Le ldquoPetit Commentairerdquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed A Tihon Cittagrave del Vaticano 1978
POO = Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia ed J L Heiberg I-II in 3 parti Lipsiae 1898-1907
RGK = Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600 I Handschriften aus Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln II Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs und Nachtraumlge zu den Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln III Handschriften aus Bibliotheken Roms mit dem Vatikan A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg unter Mitarbeit von D Harlfinger und P Eleuteri B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln Wien 1981-1997 (Oumlsterreichische Akademie der Wissenschaften Veroumlffentlichungen der Kommission fuumlr Byzantinistik III1-3 A-C)
Sigla
Acerbi 2010 = F Acerbi Il silenzio delle sirene La matematica greca antica Roma 2010
Acerbi 2012 = F Acerbi I codici stilistici della matematica greca dimostrazioni procedure algoritmi laquoQUCCraquo 1012 (2012) pp 167-214
Acerbi et al 2010 = F Acerbi ndash N Vinel ndash B Vitrac Les Proleacutegomegravenes agrave lrsquoAlmageste Une eacutedition agrave partir des manuscrits les plus anciens Introduction geacuteneacuterale ndash Parties I-III laquoSCIAMVSraquo 11 (2010) pp 53-210
Agati 1992 = M L Agati La minuscola laquoBouleteacuteeraquo Cittagrave del Vaticano 1992
Belger 1881 = C Belger Ein neues Fragmentum mathematicum Bobiense laquoHermesraquo 16 (1881) pp 261-284
Bianconi 2005a = D Bianconi La biblioteca di Cora tra Massimo Planude e Niceforo Gregora Una questione di mani laquoSampTraquo 3 (2005) pp 391-438
Bianconi 2005b = D Bianconi Tessalonica nellrsquoetagrave dei Paleologi Le pratiche intellettuali nel riflesso della cultura scritta Paris 2005
Bianconi 2006a = D Bianconi Le pietre e il ponte ovvero identificazioni di mani e storia della cultura laquoBizantinisticaraquo 8 (2006) pp 135-181
Bianconi 2006b = D Bianconi Qualcosa di nuovo su Giovanni Catrario laquoMEGraquo 6 (2006) pp 69-91
Cavallo 1977 = G Cavallo Funzione e strutture della maiuscola greca tra i secoli VIII-XI in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Colloque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 95-137
Cereteli 1904 = G F Cereteli De compendiis scripturae codicum Graecorum praecipue Petropolitanorum et Mosquensium anni nota instructorum Sankt-Petersburg 1904
De Gregorio 2000 = G De Gregorio Materiali vecchi e nuovi per uno studio della minu-scola greca fra VII e IX secolo in G Prato (a cura di) I manoscritti greci tra riflessione e dibattito Atti del V Colloquio Internazionale di Paleografia Greca Cremona 4-10 ottobre 1998 Firenze 2000 pp 83-151
Follieri 1977 = E Follieri La minuscola libraria dei secoli IX e X in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Col-loque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 139-165
Fonkič 2005 = B Fonkič Venecianskaia rukopisrsquo laquoAlrsquomagestaraquo Ptolemeja (Marc gr 313690) o datirovke i proischoždenii kodeksa laquoVDIraquo s III 254 (2005) pp 162-167
Fowler 1999 = D H Fowler The Mathematics of Platorsquos Academy A New Reconstruction Second Edition Oxford 1999
Bibliografia
Fabio Acerbi164
Gerstinger ndash Vogel 1932 = H Gerstinger ndash K Vogel Eine stereometrische Aufgaben-sammlung im Papyrus Graecus [sic] Vindobonensis 19996 laquoMitteilungen aus der Papy-russammlung der Nationalbibliothek in Wienraquo Neue Serie Folge 1 Griechische literarische Papyri 1 Wien 1932 pp 11-76
Heiberg 1927 = Mathematici Graeci Minores ed J L Heiberg Kjoslashbenhavn 1927
Hultsch 1876-1878 = Pappi Alexandrini Collectionis quae supersunt ed F Hultsch I-III Berlin 1876-1878
Janz 2003 = T Janz The Scribes and the Date of the Vat gr 1291 in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae X Cittagrave del Vaticano 2003 pp 159-180
Jones 1990 = Ptolemyrsquos First Commentator ed A Jones Philadelphia 1990
Jones 1999 = Astronomical Papyri from Oxyrhynchus ed A Jones I-II Philadelphia 1999
Jones 2005 = A Jones Ptolemyrsquos Canobic Inscription and Heliodorusrsquo Observation Reports laquoSCIAMVSraquo 6 (2005) pp 53-97
Lempire 2014 = Steacutephanos drsquoAlexandrie Le commentaire aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Lempire Louvain 2014
Leurquin 1990 = Theacuteodore Meacuteliteacuteniote Tribiblos astronomique Livre I ed R Leurquin Amsterdam 1990
Leurquin 1991 = R Leurquin Un manuscrit autographe de la Tribiblos Astronomique de Theacuteodore Meacuteliteacuteniote le Vaticanus graecus 792 laquoScriptoriumraquo 45 (1991) pp 145-162
Maas 1927 = P Maas Griechische Palaeographie in A Gercke ndash E Norden (hrsg von) Einleitung in die Altertumswissenschaft I9 Leipzig 1927 pp 69-80
Martinelli Tempesta 2010 = S Martinelli Tempesta Il codice Milano Biblioteca Am-brosiana B 75 sup (gr 104) e lrsquoevoluzione della scrittura di Giovanni Scutariota in A B Garciacutea ndash I Peacuterez Martiacuten (ed by) The Legacy of Bernard de Montfaucon Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting Proceedings of the Seventh Inter-national Colloquium of Greek Palaeography Madrid-Salamanca 15-20 September 2008 Turnhout 2010 pp 171-186
Mazzucchi 1994 = C M Mazzucchi Leggere i classici durante la catastrofe (Costantino-poli maggio-agosto 1203) le note marginali al Diodoro Siculo Vaticano gr 130 Parte prima stratigrafia laquoAevumraquo 68 (1994) pp 164-218
Mioni 1976 = E Mioni Bessarione scriba e alcuni suoi collaboratori in Miscellanea marcia-na di studi bessarionei Padova 1976 pp 263-323
Mioni 1985 = Codices graeci manuscripti Bibliothecae Divi Marci Venetiarum II Thesaurus Antiquus Codices 300-625 recensuit E Mioni Roma 1985
Mogenet 1962 = J Mogenet Une scholie ineacutedite du Vat gr 1594 sur les rapports entre lrsquoastronomie arabe et Byzance laquoOsirisraquo 14 (1962) pp 198-221
Mogenet et al 1983 = Niceacutephore Greacutegoras Calcul de lrsquoeacuteclipse de soleil du 16 juillet 1330 ed J Mogenet ndash A Tihon ndash R Royez ndash A Berg Amsterdam 1983
Mondrain 2002 = B Mondrain Maxime Planude Niceacutephore Greacutegoras et Ptoleacutemeacutee laquoPa-laeoslavicaraquo 10 (2002) pp 312-322
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 165
Mondrain 2004 = B Mondrain Lrsquoancien empereur Jean VI Cantacuzegravene et ses copistes in A Rigo (a cura di) Gregorio Palamas e oltre Studi e documenti sulle controversie teologiche del XIV secolo bizantino Firenze 2004 pp 249-296
Mondrain 2007 = B Mondrain Les eacutecritures dans les manuscrits byzantins du XIV e siegravecle Quelques probleacutematiques laquoRSBNraquo n s 44 (2007) pp 157-196
Peacuterez Martiacuten 2006 = I Peacuterez Martiacuten Maxime Planude et le Diophantus Matritensis (Madrid Biblioteca Nacional ms 4678) un paradigme de la reacutecupeacuteration des textes anciens dans la ldquorenaissance paleacuteologuerdquo laquoByzantionraquo 76 (2006) pp 433-462
Peacuterez Martiacuten 2008 = I Peacuterez Martiacuten El lsquoestilo Hodegosrsquo y su proyeccioacuten en las escrituras constantinopolitanas laquoSampTraquo 6 (2008) pp 389-458
Perria 1991 = L Perria Scrittura e ornamentazione nei codici della laquocollezione filosoficaraquo laquoRSBNraquo n s 28 (1991) pp 45-111
Rollo 2012 = A Rollo LrsquoArchimede di Giorgio Valla in V Fera ndash D Gionta ndash A Rollo (a cura di) Archimede e le sue fortune Atti del Convegno di Siracusa-Messina 24-26 giugno 2008 Messina 2012 pp 99-147
Rome 1927 = A Rome Membra disjecta laquoRBenraquo 39 (1927) pp 187-188
Rome 1938 = A Rome Un manuscrit de la bibliothegraveque de Boniface VIII agrave la Meacutediceacuteenne de Florence laquoACraquo 7 (1938) pp 261-268
Ronconi 2013 = F Ronconi La collection philosophique un fantocircme historique laquoScripto-riumraquo 67 (2013) pp 119-140
Tannery ndash Steacutephanou 1940 = Quadrivium de Georges Pachymegravere ed P Tannery ndash E Steacutephanou Cittagrave del Vaticano 1940
Tihon 2011 = Πτολεμαίου Πρόχειροι Κανόνες Les Tables faciles de Ptoleacutemeacutee vol Ia Tables A1-A2 ed A Tihon Leuven 2011
Traube 1907 = L Traube Nomina Sacra Versuch einer Geschichte der christlichen Kuumlrzung Muumlnchen 1907
Vogel 1936 = K Vogel Beitraumlge zur griechischen Logistik laquoSBAWraquo Mathematisch-natur-wissenschaftliche Abteilung Jahrgang 1936 pp 357-472
Wouters 1979 = A Wouters The Grammatical Papyri from Graeco-Roman Egypt Contri-butions to the Study of the lsquoArs Grammaticarsquo in Antiquity Brussel 1979
F ACERBI Tav 1
b Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 65r
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 284 f 160r
F ACERBITav 2
b Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 13r
a Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 19v
F ACERBI Tav 3
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 136v
F ACERBITav 4
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17r
F ACERBI Tav 5
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17v
F ACERBITav 6
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 7v
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
Fabio Acerbi124
evidenza un primer allrsquoesecuzione di queste operazioni di cui lrsquoAlmagesto fornisce sempre e soltanto i risultati egrave stata trasmessa a morsquo di introdu-zione al trattato tolemaico da uno solo dei rami della tradizione testuale di questrsquoultimo I Prolegomena non beneficiarono di una redazione defini-tiva anzi a tratti si ha lrsquoimpressione che quanto leggiamo sia poco piugrave che la trascrizione usci-ta dalle mani del tachigrafo Piugrave recensioni bizantine di cui una eseguita da un matematico competente e trasmessa da un grup-petto di codici i piugrave antichi dei quali riferibili al pieno del XIV secolo restituiscono un testo migliore specialmente dal punto di vista sintattico
I passi che discuterograve costituiscono due dei rarissimi esempi in cui possiamo seguire lrsquointera traiettoria delle interazioni fra notazione ma-tematica auctor che la impiega e la descrive tachigrafo che la trascrive in vivo copista che la riproduce a freddo recensore che la modifica discente che dovragrave necessariamente apprenderla con lrsquoaiuto di una rap-presentazione grafica (non sempre) conforme alla descrizione Lungo lo snodarsi di questa traiettoria si generano malintesi ed errori che tro-vano sfogo in zone di irrimediabile ambiguitagrave come le abbreviazioni e le unitagrave paratestuali (diagrammi tabelle liste numeriche organizzate) Inoltre uno dei due passi contiene un termine pertinente al lessico paleografico non attestato altrove con questo significato il participio perfetto medio-passivo ἐξεσμένον per designare unrsquolaquoabbreviazioneraquo
Nella prossima sezione propongo una suddivisione tipologica dei paratesti che accompagnano o completano gli scritti matematici Nella sezione successiva mi concentro sulle disposizioni tabellari delle opera-zioni aritmetiche elementari elencando le opere e i manoscritti dove siano reperibili descrivo anche i tratti salienti del sistema sessagesimale della notazione numerica associata e degli algoritmi di moltiplicazione e di divisione Queste due sezioni presentano materiale preliminare necessario per una comprensione piena delle testimonianze la sezione finale contiene la loro analisi specifica
2 Paratesti matematici una tipologia
La classificazione qui proposta dei paratesti matematici (o suppo-sti tali) egrave preliminare e strettamente funzionale a delineare un conte-
V p 11411-12) Ancora Eutocio (AOO III p 25816-18) menziona lrsquoὨκυτόκιον unrsquoopera in cui Apollonio di Perge otteneva unrsquoapprossimazione del rapporto tra la circonferenza di un cerchio e il suo diametro migliore di quella archimedea Lo studio piugrave completo sulla logistica greca resta Vogel 1936 che perograve ebbe solo accesso ad un segmento iniziale dei Prolegomena (le parti denominate a e b nella sezione 3 infra)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 125
sto grafico in cui collocare le testimonianze saragrave opportuno ritornare sullrsquoargomento se non altro per ampliare la gamma degli esempi o raf-finare la casistica
Intendo con lsquoparatesto matematico primariorsquo ogni sistema orga-nizzato di segni contenuto originariamente in unrsquoopera matematica e differente dalla stringa di lettere alfabetiche denotative o numerali3 che si struttura in discorso di senso compiuto Questrsquoultimo costituisce il lsquotestorsquo propriamente detto Tale sistema organizzato ha normalmente un significato ed unrsquoimportanza nellrsquoeconomia dellrsquoopera e li assume in riferimento implicito o esplicito al testo Possiamo in prima battuta distinguerne tre tipologie diagrammi tavole tabelle operazionali Le descriverograve brevemente con particolare attenzione al loro formato e alla messa in pagina che ne consegue
1) Diagrammi Un lsquodiagrammarsquo egrave una figura di norma dotata di lettere denotative che rappresenta la configurazione geometrica speci-fica di una proposizione matematica Si tratta di un ente grafico dalla funzione puramente referenziale egrave descritto allrsquoinizio della proposi-zione come entitagrave individuale4 e a sua volta raffigura la configurazione geometrica egrave impossibile trarne indicazioni deduttive univoche senza la guida del testo I manoscritti piugrave antichi presentano i diagrammi tracciati in indentazioni (lsquospecchirsquo) del testo di norma poste allrsquoinizio della proposizione seguente Abbiamo motivo di supporre che questo stato di cose rifletta la convenzione di mise en rouleau originaria ndash la descrizione della configurazione geometrica non egrave piugrave lsquosottrsquoocchiorsquo man mano che il rotolo viene svolto con il procedere della dimostrazione ed occorre rivolgersi alla figura Questi fatti confermano che i diagrammi sono dei genuini paratesti
2) Tavole Una lsquotavolarsquo egrave una disposizione ordinata di lettere numerali e altri segni grafici che rappresenta i valori assunti da una determinata gran-
3 Le lettere denotative isolate o a gruppi sono i lsquonomirsquo degli enti di cui tratta una proposizione matematica sono sempre precedute da un articolo dello stesso genere dellrsquoog-getto designato (ad esempio ἡ ΑΒ per una retta) o da unrsquoespressione preposizionale intro-dotta da un articolo (ad esempio ἡ ὑπὸ ΑΒ ΒΓ per un angolo) Le lettere numerali denotano numeri di norma sono precedute dallrsquoarticolo solo a partire dalla loro seconda occorrenza in un determinato algoritmo Nessuna di queste combinazioni alfabetiche costituisce una parte del discorso in linguaggio (greco) naturale assumono una funzione sintattica (sostan-tivi) solo nellrsquoidioletto matematico Le qualificazioni lsquoprimariorsquo e lsquooriginariamentersquo nella mia definizione escludono altri tipi di paratesti come gli scolii Un discorso a parte merita-no invece le titolazioni ma non egrave il caso di affrontarlo in questa sede
4 Ciograve avviene nelle parti specifiche della proposizione denominate ἔκθεσις laquoesposi-zioneraquo e κατασκευή laquocostruzioneraquo dove al tempo stesso sono assegnate le lettere denotative
Fabio Acerbi126
dezza in funzione di un insieme discreto di valori di un parametro Una tavola-tipo egrave composta di due colonne a sinistra i valori del parametro a destra quelli della grandezza Il parametro non egrave necessariamente nume-rico5 Le colonne possono essere piugrave di due a) se piugrave grandezze omologhe oppure no legate allo stesso parametro sono per economia di spazio ri-portate su colonne affiancate b) se una grandezza ha una rappresentazione numerica complessa ad ogni ordine essendo associata una colonna6
Le tavole sono sia costruite che descritte La lsquocostruzionersquo di una tavola consiste nellrsquoesposizione delle dimostrazioni ed operazioni neces-sarie a produrre lrsquoinsieme dei suoi valori senza che questi ultimi siano calcolati singolarmente La tavola presenta dunque in modo sintetico il risultato di una serie di operazioni questa serie puograve anche essere molto lunga e complessa ed egrave quasi sempre impossibile ricavare in tempi brevi una tavola dalla sua costruzione una tavola egrave costruita una volta per tutte si rende in questo modo indipendente dalla costruzione e non egrave univocamente determinata dalla sua lsquodescrizionersquo che si limita ad indi-care quale ente costituisca il parametro e quale la grandezza tabulata ed eventualmente a fornire indicazioni di formato Una tavola egrave collocata dopo la propria costruzione e la propria descrizione ed occupa quasi sempre per intero lo spazio grafico unitario (pagina colonna di rotolo) Una tavola insomma egrave un vero e proprio testo dal formato particolar-mente perspicuo di questo testo fanno anche parte gli altri segni grafici necessari ad un suo corretto utilizzo le linee orizzontali e verticali che separano righe e colonne la titolazione che ne identifica il tipo
Esempio la lsquotavola delle cordersquo nellrsquoAlmagesto Essa contiene i va-lori delle corde inscritte in un cerchio (seconda colonna) e dei loro incrementi parziali (terza colonna) tabulati in funzione dellrsquoarco di cerchio che esse sottendono (prima colonna)7 questrsquoultimo egrave il para-metro fornito con incrementi di mezzo grado da 0ordm a 180ordm nella tavola vi sono pertanto 360 righe La costruzione della tavola occupa quasi tutto il capitolo I 10 dellrsquoAlmagesto 15 pagine e mezzo nellrsquoedizione di Heiberg la descrizione prende 11 righe scarse includendo anche le istruzioni per lrsquouso dei valori nella terza colonna la tavola stessa si estende su 16 pagine8 Egrave particolarmente importante osservare che la
5 Esempio la lsquotavola delle cittagrave illustrirsquo nelle Tavole facili tolemaiche a sinistra il nome della cittagrave a destra le sue coordinate geografiche
6 Si veda infra la sezione 3 per questa terminologia nel caso del sistema sessagesimale7 I valori delle corde sono calcolati fino al secondo ordine sessagesimale quelli dei
loro incrementi parziali in sessantesimi fino al quarto ordine la lsquoseconda colonnarsquo consiste quindi in realtagrave di 3 colonne la lsquoterzarsquo di 4
8 Rispettivamente POO I 1 pp 319-4620 ivi p 472-13 κανόνια ὑποτάξομεν ἀνὰ
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 127
mise en rouleau dellrsquooriginale era differente come Tolomeo stesso spiega nella sua descrizione le 360 righe erano ripartite διὰ τὸ σύμμετρον laquoper motivi di simmetriaraquo9 in 8 tavole affiancate di 45 righe lrsquouna che nel rotolo figuravano probabilmente con una soluzione di continuitagrave minore di un intercolumnio standard in guisa di macrocolonna I ma-noscritti medievali rispettano questa disposizione ma devono ripartire le 8 tavole su 4 pagine10 Date le dimensioni della pagina a stampa cui egrave confinato Heiberg non puograve farlo e sdoppia ogni tavola poicheacute 45 egrave dispari e a causa della presenza dellrsquoapparato critico le sue tavole per-dono tutta la simmetria iniziale Nel caso delle tavole dunque rotolo e codice comportano mises en texte differenti per una volta egrave il rotolo e non il codice il supporto ideale per questo tipo di testi
Altro esempio tavole del moto medio del sole nellrsquoAlmagesto De-notando rispettivamente con a g o m e c i valori del tempo di ritorno annuale in giorni e loro parti e dei moti (in gradi per appropriate unitagrave di tempo) giornaliero orario mensile per mese di 30 giorni annuale per lrsquoanno egiziano di 365 giorni e infine su un ciclo di 18 anni la determinazione dei restanti a partire dal valore di a ammonta alla se-guente catena di operazioni a rarr 360a = g rarr g24 = o 30g = m 365g = e rarr 18e = c Ognuno di questi valori forma la base della costruzione per addizioni successive11 delle tavole12 che denoto con le stesse lettere
στίχους με διὰ τὸ σύμμετρον ὧν τὰ μὲν πρῶτα μέρη περιέξει τὰς πηλικότητας τῶν περιφερειῶν καθ᾽ ἡμιμοίριον παρηυξημένας τὰ δὲ δεύτερα τὰς τῶν παρακειμένων ταῖς περιφερείαις εὐθειῶν πηλικότητας ὡς τῆς διαμέτρου τῶν ρκ τμημάτων ὑποκειμένης τὰ δὲ τρίτα τὸ λʹ μέρος τῆς καθ᾽ ἕκαστον ἡμιμοίριον τῶν εὐθειῶν παραυξήσεως ἵνα ἔχοντες καὶ τὴν τοῦ ἑνὸς ἑξηκοστοῦ μέσην ἐπιβολὴν ἀδιαφοροῦσαν πρὸς αἴσθησιν τῆς ἀκριβοῦς καὶ τῶν μεταξὺ τοῦ ἡμίσους μερῶν ἐξ ἑτοίμου τὰς ἐπιβαλλούσας πηλικότητας ἐπιλογίζεσθαι δυνώμεθα laquodisporrograve le tavole su 45 righe per motivi di simmetria la prima parte di lsaquoognuna dirsaquo esse conterragrave i valori degli archi incre-mentati di mezzo grado alla volta la seconda i valori delle rette corrispondenti agli archi (il diametro essendo posto di 120 gradi) la terza la 30ordm parte dellrsquoincremento delle rette per ciascun lsaquointervallo dirsaquo mezzo grado di modo che sia possibile calcolare facilmente avendo in questa maniera a disposizione il valore intermedio lsaquodellrsquoincrementorsaquo corrispondente ad un singolo sessantesimo (esso egrave differente da quello esatto in maniera impercettibile) anche i valori delle frazioni intermedie tra i lsaquovalori limitati airsaquo mezzi gradiraquo Alm I 11 ivi pp 48-63
9 Non dobbiamo sopravvalutare la componente estetica implicita nel nostro termine laquosimmetriaraquo Tolomeo si limita a far riferimento alla laquocongruenzaraquo di 45 con 360 in quanto suo divisore esatto
10 Si vedano Par gr 2389 (sec IX in Tolomeo Almagestum) ff 17r-18v Vat gr 1594 (Prolegomena ad Almagestum Tolomeo Almagestum et opera minora) ff 20v-22r Marc gr 313 (Prolegomena ad Almagestum Tolomeo Almagestum) ff 46r-47v Vat gr 180 (sec X Tolomeo Almagestum) ff 18v-20r per la datazione del secondo e del terzo codice si veda la sezione 4
11 Tolomeo accorda alla menzione di questrsquooperazione di addizione una mezza riga proprio alla fine della sua esposizione κατὰ τὰς οἰκείας ἑκάστων ἐπισυναγωγάς laquoper opportune addizioni successive dei lsaquovalorirsaquo di ciascunoraquo Alm III 1 in POO I 1 p 20924-25
12 Alm III 1 ivi pp 2091-16 e 20922-25 descrizione ivi p 20917-22
Fabio Acerbi128
maiuscole ovviamente la tavola A egrave assente Per esempio la tavola G ha come prima riga il valore g (colonna di destra) accompagnato dalla cifra α laquo1raquo (colonna di sinistra) le altre righe hanno a sinistra i numerali da 2 a 30 e a destra i multipli corrispondenti di g il valore registrato a destra nellrsquoultima riga deve evidentemente coincidere con m In omaggio al principio delle 45 righe13 troviamo dunque una prima tavola C su 45 righe (corrispondente a un periodo di 18times45 = 810 anni avente come epoca il primo anno di regno di Nabonassar) una seconda su 42 righe che combina le 18 righe di E seguite dalle 24 di O una terza ancora su 42 righe che contiene le 12 di M seguite dalle 30 di G14 ndash nella seconda
13 διὰ τὸ φανησόμενον σύμμετρον τῆς κανονογραφίας laquoper una presentazione simme-trica del tracciato delle tavoleraquo ivi p 20914-15 allusione analoga in Alm I 10 ivi p 472-3 lrsquoabbiamo letta sottolineata nella nota 8 supra
14 Per la mise en page di queste tre tavole nei manoscritti medievali si vedano Par gr 2389 ff 69v-70r Vat gr 1594 f 63r-v (in questi due codici scritti su due colonne le tavole occupano unrsquointera pagina piugrave la prima colonna della successiva) Marc gr 313 f 98r-v (questo codice vergato a tutta pagina adotta momentaneamente una disposizione su due colonne al f 98v la prima contiene la tavola la seconda lrsquoinizio del capitolo successivo) Vat gr 180 ff 60v-61v Nelle Tavole facili dello stesso Tolomeo che passano a cicli di 25 anni e allrsquoepoca di Filippo le tavole appena descritte sono presentate con precisione ridotta rispetto a quelle dellrsquoAlmagesto nellrsquoordine C (periodo di 25times59 = 1475 anni) E (ciclo di 25 anni) M (direttamente con i nomi dei mesi del calendario egiziano mentre lrsquoAlmagesto ripartisce il parametro in multipli di 30 giorni fino a 360) G O Ogni tavola egrave suddivisa in unitagrave colonnari di non piugrave di 30 righe + titolazione La lsquotavola delle cordersquo non egrave inclusa nelle Tavole facili per le tavole del moto medio del sole e della luna nei manoscritti medievali di questrsquoopera si vedano Leiden Bibliothek der Rijksuniversiteit BPG 78 ff 91r-93v Laur Plut 2826 ff 71r-73v Vat gr 1291 ff 38r-40v Marc gr 331 ff 45r-47v ndash le parti in maiuscola di tutti questi codici contengono unicamente le Tavole facili e si datano sulla base dellrsquoultimo imperatore di cui il copista principale abbia riportato gli anni di regno nel cosid-detto canon regius nellrsquoordine Leiden BPG 78 copiato sotto il regno di Leone V 813-820 Vat gr 1291 copiato poco dopo il regno di Niceforo I 802-811 (Janz 2003) Laur Plut 2826 copiato sotto il regno di Leone VI 886-912 Marc gr 331 privo del canon regius e forse copiato anchrsquoesso sotto il regno di Leone VI si veda anche Tihon 2011 pp 19-41 per una sintesi e per ulteriori indicazioni bibliografiche Ovviamente anche le Tavole facili erano state concepite per il rotolo Tra lrsquoaltro Tolomeo sembra trascrivere nella stessa tavola i moti medi di Sole Luna Cor Leonis (la stella Regolo) e dei cinque pianeti cosa impossibile a farsi su una sola pagina di codex si legga la descrizione che ne dagrave nella parte iniziale del lsquomanuale di istruzionirsquo alle Tavole facili stesse in POO II p 1607-19 Nei manoscritti medievali questa tavola egrave smembrata poco dopo lrsquoinizio della sequenza di tavole si trovano i moti medi di Sole e Luna piugrave avanti quelli di Regolo e dei cinque pianeti Piugrave in generale il passaggio al codice comportograve una riorganizzazione delle lsquotavole facilirsquo dal piano originario in cui tutte quelle di longitudine erano molto verosimilmente raggruppate insieme e precedevano quelle di latitudine ad un ordinamento per corpi celesti (Tihon 2011 pp 12-14) Le Tavole facili furono copiate molto presto su codice i lsquopapirirsquo di questrsquoopera sono quasi unicamente su codex di pergamena (Jones 1999 I pp 102-108 e 160-168 edizione dei POxy LXI 4167-4173a contenenti frammenti delle Tavole facili ivi II pp 118-161 solo il primo di essi proviene sicuramente da un rotolo) Giagrave in pieno IV secolo Teone di Alessandria nel suo lsquoPiccolo commentariorsquo alle Tavole facili afferma che alcune di esse possono estendersi su πλειόνων πτυχίων laquopiugrave pagineraquo (PC p 2016 allinterno dellunica definizione di lsquotavolarsquo rintracciabile nel corpus antico) cosigrave le leggiamo attualmente nei manoscritti
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 129
e nella terza tavola il numero di righe egrave piugrave basso percheacute occorre pre-vedere uno spazio per il titolo addizionale Per mantenerne il formato tripartito Heiberg egrave costretto a stampare le tavole ruotate di 90ordm
Che le tavole siano dei testi egrave confermato da due fatti aggiuntivi e strettamente connessi15 Primo il lsquomanuale di istruzionirsquo alle Tavole facili che Tolomeo stesso redasse fu scritto ed ha circolato come opera a parte Secondo dalla descrizione delle tavole dettagliata ma priva di costruzione contenuta nello stesso lsquomanualersquo egrave impossibile ricavarne il contenuto numerico e la maniera drsquoimpiego16 a illustrare questrsquoultima provvederagrave una ricchissima tradizione di commentari di cui leggiamo ancora quelli di Teone il lsquoPiccolo Commentariorsquo spiega come usarle per scopi specifici il lsquoGrande Commentariorsquo come dedurle dallrsquoAlmagesto17 Le Tavole facili sono insomma unrsquoopera il cui testo egrave interamente strut-turato in formato tabulare
3) Tabelle operazionali Una lsquotabella operazionalersquo egrave una disposi-zione ordinata di lettere numerali e altri segni grafici che rappresenta lrsquoalgoritmo di unrsquooperazione aritmetica Ci troviamo in realtagrave di fronte a due modi di eseguire lrsquooperazione la tabella intende in qualche mi-sura riprodurre la dinamica operazionale dellrsquoalgoritmo questrsquoultimo si risolve a sua volta in una descrizione della tabella che senza tale de-scrizione risulterebbe incomprensibile e quindi non adattabile ad una differente operazione una tabella operazionale ha in questo caso una funzione paratestuale Si presuppone perograve che il discente apprenda a ri-produrre lrsquooperazione direttamente nel formato tabellare non in quello algoritmico In questo secondo caso una tabella operazionale assume una funzione testuale piena18 Lo statuto (para)testuale delle tabelle operazionali egrave pertanto oscillante nei commentari teonini allrsquoAlmagesto e soprattutto nei Prolegomena ad Almagestum di cui andremo ad occu-parci esse sono descritte in dettaglio e si configurano pertanto come genuini paratesti in Eutocio in Circ esse sono semplicemente eseguite e quindi assumono un ruolo testuale Nei manoscritti medievali la col-locazione di una tabella operazionale originaria egrave variabile e dipende dalle sue dimensioni e dalla capacitagrave del copista di identificarla come
15 Per un argomento ulteriore si veda la sezione 4 punto b16 POO II pp 159-18517 Nessuno dei due titoli ha fondamento nella trasmissione manoscritta la seconda
opera era detta realizzare una συμφωνία tra lrsquoAlmagesto e le Tavole facili Entrambi i com-mentari sono stati editi criticamente PC GC I-III
18 Resta il fatto che la quasi totalitagrave delle tabelle operazionali che rintracciamo nei manoscritti egrave relegata nei margini dellrsquoattivitagrave di annotazione degli scoliasti
Fabio Acerbi130
tale di solito le troviamo nei margini ma possono occupare lrsquointero specchio di scrittura e ciograve indipendentemente dalla determinazione del loro statuto paratestuale sulla base del criterio della presenzaassenza di una descrizione
Lo statuto meno elevato dei genuini paratesti (diagrammi e tabelle) rispetto ai testi (catene algoritmico-argomentative e tavole) indusse un atteggiamento differenziato in copisti ed editori attenti a rispettare lrsquointegritagrave dei secondi ma non dei primi ciograve che conta sono le informa-zioni veicolate dalle strutture discorsive e dalle porzioni alfanumeriche di diagrammi tavole e tabelle il resto egrave ritenuto adattabile alle esigenze dellrsquoedizione moderna19 o semplicemente ignorato nel corso del pro-cesso di copia in questa maniera si perdono perograve informazioni e strut-tura Come vedremo puograve avvenire che una parte della descrizione di unrsquooperazione resti senza relato nella resa grafica tabellare lrsquooperazione eseguita in forma algoritmica non corrisponde piugrave a quella eseguita in forma di tabella
3 Testi logistici e disposizione tabellare delle operazioni
Nessun testo matematico primario di etagrave ellenistica o imperiale contiene operazioni aritmetiche eseguite con una sola eccezione la de-scrizione che non ammette una rappresentazione tabellare del procedi-mento di estrazione approssimata di radice quadrata in Erone Metr I 8 Drsquoaltro canto abbiamo giagrave osservato che lrsquoAlmagesto di Tolomeo for-nisce il risultato di migliaia di operazioni ma nessuna di esse egrave eseguita Attestazioni di questi procedimenti sono pertanto legate ad iniziative editoriali di secondo livello come i commentari alla loro prima occor-renza oppure in casi paradigmatici gli algoritmi di calcolo omessi nel testo primario vi sono resi espliciti Di fatto e con una sola eccezione la nostra documentazione consiste in commentari allrsquoAlmagesto quello di Teone e i Prolegomena ad Almagestum
19 Abbiamo giagrave visto alcuni esempi di modifiche del formato delle tavole Quanto ai diagrammi quelli tracciati nelle edizioni moderne rappresentano il caso piugrave generale pos-sibile Le figure che troviamo nei manoscritti greci hanno invece la caratteristica opposta illustrano spesso casi particolari e sono metricamente scorrette Sono in effetti tracciati triangoli rettangoli isosceli cerchi uguali rette perpendicolari dove tutto ciograve non egrave richiesto dallrsquoenunciato e inoltre rettangoli invece di parallelogrammi segmenti uguali quando sia-no disuguali addirittura linee rette al posto di curve (in Archimede Meth 14 un arco di parabola egrave rappresentato da un angolo rettilineo) e in generale figure con proprietagrave di simmetria non richieste
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 131
LrsquoAlmagesto e con esso tutta la tradizione astronomica adotta il sistema sessagesimale per esprimere la parte non intera di un nu-mero che siano valori angolari o lineari non fa differenza20 come noi scriviamo 36524 e intendiamo 365 + 2 decimi + 4 centesimi (cioegrave 4102) cosigrave nel sistema sessagesimale 365 14 48 significa21 365 + 14 sessantesimi + 48 tremilaseicentesimi (cioegrave 48602) ovverosia nel lessico antico e nostro 365 14 πρῶτα λεπτά laquominuti primiraquo 48 δεύτερα λεπτά laquominuti secondiraquo dove laquoprimoraquo e laquosecondoraquo sono le laquodenominazioniraquo degli ordini (sono cioegrave numeri ordinali) 14 e 48 i lsquonumerali di molteplicitagraversquo relativi ai due ordini numerale di mol-teplicitagrave e relativa denominazione costituiscono insieme una lsquoparte sessagesimalersquo di un numero Drsquoaltronde per gli antichi come per noi lrsquoespressione di una parte non intera (ovvero di una frazione)
20 Trascuro il fatto ai nostri fini irrilevante che essendo i numerali greci lettere alfabetiche la notazione che ne risulta per i numeri interi non egrave posizionale nonostante le cifre scagravelino di un posto ad ogni potenza di dieci il segno μ per 4 (decine) non egrave identico al segno δ per 4 (unitagrave) Drsquoaltra parte una volta adottata la notazione decimale per i numerali di molteplicitagrave la notazione complessiva per la parte non intera espressa nel sistema sessa-gesimale non egrave posizionale neanche introducendo un segno di lsquoposto vuotorsquo una cui parte egrave nel caso greco analoga in forma al nostro 0 (su questo segno si veda ancora la sezione 4 punto c) occorre avvalersi di accorgimenti ulteriori quali lrsquointroduzione di spaziature fra le differenti parti sessagesimali (come viene fatto nei manoscritti greci ed in questrsquoarticolo) o di segni tipografici (come suggerito da Otto Neugebauer che avrebbe scritto 3651448 il numerale che leggeremo tra un attimo nel testo) Il problema egrave che altrimenti lrsquoordine associato ad un numerale di molteplicitagrave di una parte sessagesimale puograve non risultare uni-vocamente determinato dalla sua posizione Esempio scrivendo 0129 per un numero non intero nel sistema sessagesimale il numerale di molteplicitagrave 129 potrebbe rappresentare 1 minuto primo e 29 secondi oppure 12 minuti primi e 9 secondi ecc e la stessa difficoltagrave si presenta nella notazione greca (per la nozione di lsquonumerale di molteplicitagraversquo si veda infra nel testo) Il problema scomparirebbe se adottassimo singoli segni differenti per tutti i nu-merali da 1 a 59 ndash ma neacute noi neacute i greci siamo stati disposti a introdurre una complicazione siffatta Si ricordi infine che al di fuori dei contesti astronomici il sistema di numerazione greco egrave decimale
21 Scriverograve i numerali in cifre arabe sempre in questo modo parte intera seguita dalle parti sessagesimali (minuti primi secondi ecc) con ogni ordine separato da uno spazio bianco Se la parte intera egrave assente il numerale inzia con uno 0 Nella trascrizione dei numerali in greco ogni numerale di molteplicitagrave sessagesimale o frazione unitaria saragrave identificato come nei manoscritti piugrave antichi dei Prolegomena da un opportuno numero di apici (uno per ogni unitagrave dellrsquoordine avendo le frazioni unitarie un solo apice come vedremo nellrsquoAlmagesto contenuto negli stessi codici troviamo barre non apici con questa funzione) mentre la parte intera saragrave priva della barra che la sormonta invariabilmente nei manoscritti In questo modo 365 14 48 egrave la conversione in cifre arabe di τξε ιδ´ μη´´ La pratica dei manoscritti medievali egrave di collocare gli apici (quando presenti) sopra le lettere numerali per ragioni tipografiche li porrograve di seacuteguito al gruppo di lettere cui si riferiscono Si noti che nella notazione greca il segno ιδ´ per 1460 in sessagesimale egrave identico a quello per 114 in decimale Nel caso delle frazioni unitarie la presenza dellrsquo(unico) apice egrave la traduzione semiotica della trasformazione che a livello grammaticale egrave effettuata con il pas-saggio dal cardinale allrsquoordinale (ad esempio da τὰ τρία laquotreraquo a τὸ τρίτον laquoun terzoraquo) si veda anche la sezione 4 punto 1 e note 82 e 86 ivi incluse
Fabio Acerbi132
richiede sempre lrsquointroduzione di due numerali il lsquonumeratorersquo e il lsquodenominatorersquo
Il motivo della scelta del sistema sessagesimale che fu mutuato dallrsquoastronomia matematica babilonese egrave presto detto lrsquoelevato numero di divisori di 60 e cioegrave 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 Poicheacute i divi-sori di 10 sono un sottinsieme di quelli di 60 molti piugrave numeri hanno una rappresentazione finita nel sistema sessagesimale che in quello deci-male Calcolare in sessagesimale lungi dal creare difficoltagrave offre quindi un vantaggio cruciale22 che risulta piugrave facilmente comprensibile sulla base dellrsquoesempio seguente La lunghezza dellrsquoanno solare egrave stabilita da Tolomeo in 365 giorni + 14 ndash 1300 di giorno Per calcolare il moto giornaliero del sole si rende necessario dividere 360 per questo numero Noi avremmo due opzioni se non potessimo usare la calcolatrice ri-durre il divisore ad una singola frazione tramite passaggio al denomi-natore comune invertire questa frazione e moltiplicarla per 360 sem-plificare gli eventuali fattori comuni e finalmente eseguire la divisione a piugrave cifre tra numeri interi (nel nostro caso 5400054787) oppure scrivere il divisore come numero decimale periodico (365246666 hellip) e poi eseguire la divisione Nel sistema sessagesimale egrave tutto molto piugrave semplice 365 + 14 ndash 1300 ha una rappresentazione finita cioegrave 365 14 48 come eseguire la divisione lo vedremo tra un attimo
Passiamo dunque in rassegna il contenuto del lsquomanuale di logisticarsquo incluso nei Prolegomena ad Almagestum riportando in nota per ogni item anche esposizioni parallele in altri commentatori23
a) Costruzione del sistema sessagesimale24
22 E uno svantaggio se le molteplicitagrave dei singoli ordini vengono espresse in no-tazione decimale (come facciamo noi e facevano i greci) il numero di cifre necessario per raggiungere una precisione assegnata egrave maggiore nel sistema sessagesimale in quanto per esprimere i numerali da 10 a 59 occorrono due cifre mentre per quelli da 1 a 9 (o da α a θ e le decine da ι a ν nel caso greco) ne basta una e ciograve indipendentemente dal fatto che la notazione sia posizionale oppure no La differenza si fa perograve sentire solo a partire dal quinto ordine sessagesimale
23 Trascuro la parte finale del lsquomanualersquo dove sono esposte le regole di interpolazione (cui era legata la lsquoterza colonnarsquo della tavola delle corde tolemaica) e il procedimento di lsquosottrazionersquo di rapporti cioegrave la divisione di un rapporto per un altro
24 Per a-b cf Teone in Alm I 10 in iA pp 44919-45814 PC pp 2007-2014 GC I pp 10910-11124 e le definizioni e regole diofantee di manipolazione delle varie specie numeriche in Arithmetica prefazione in DOO I pp 214-1218 Le porzioni a-b sono giagrave state pubblicate da Paul Tannery in DOO II pp 318-1517 sulla base del Par gr 453 apografo ad opera di Giovanni Santamaura di un Vat gr 1594 giagrave mutilo (RGK II nr 238 ma lrsquoautore trascritto vi egrave indicato come lsquoPtolemaiosrsquo) Evidentemente il committente non fu soddisfatto della prima trascrizione (ff 67-76) che crivella di tratti rossi a segnalarne gli errori di copia Ne fu dunque eseguita una seconda (ff 78-86) cui Santamaura antepose
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 133
b) Regole di moltiplicazione e divisione degli ordini sessagesimali defini-zione generale di moltiplicazione moltiplicazione di ordini come somma delle loro laquodenominazioniraquo Definizione generale di divisione divisione di ordini uguali e di un ordine per quello che lo precede immediata-mente divisione di ordini come sottrazione delle loro laquodenominazioniraquo divisione per 60 come divisione per 1 accompagnata dallo slittamento di un posto dellrsquoordine
c) Problemi che sorgono nella divisione di una parte sessagesimale per una di quelle che seguono divisione breve per riduzione allo stesso ordine (metodo laquoper analisiraquo) due algoritmi differenti il secondo con riduzione dei fattori comuni attribuito a Siriano
d) laquoAltroraquo metodo di divisione breve in realtagrave divisione tra somme di parti sessagesimali appartenenti ad ordini differenti per riduzione allo stesso ordine e applicazione dei metodi precedenti esempio della divisione di 0 2 0 4 per 0 0 2 0 240
e) Metodo di moltiplicazione tra numeri con parti non intere disposizione tabellare dei termini esempio della moltiplicazione di 5 4 6 per 8 0 3 0 525
f ) Primo metodo di divisione lunga descrizione della disposizione tabellare ed esempio di algoritmo applicato alla divisione di 50 48 26 30 per 8 16 28 5426
g) Metodo di divisione lunga tratto da Pappo in Alm III descrizione della disposizione tabellare ed esempio di algoritmo applicato alla divisione di 360 per 365 14 48 come verifica del valore 0 59 8 17 13 12 31 fornito nellrsquoAlmagesto per il moto medio giornaliero del sole27
h) Metodo di approssimazione di una radice quadrata secondo Erone Metr I 8 con giustificazione geometrica di Teone (attualmente non attestata in suoi scritti)
i) Verifica tramite moltiplicazione della correttezza del valore tolemaico28 di 67 4 55 come radice quadrata approssimata di 4500 Metodo di estrazio-ne di radici quadrate secondo Teone basato su applicazioni successive di Elementi II 4 la procedura termina dopo un numero finito di passi nel caso di quadrati perfetti Applicazione al calcolo della radice quadrata di 450029
unrsquoannotazione spazientita laquoIl texto di questo 2do quinterno egrave stato recopiato fidelmente dallrsquooriginale a chi volesse vedere la prova lo potragrave conferire con detto originale le pagine del qual texto corrispondono con quelle dellrsquooriginale tanti versi che pagine [hellip]raquo (Moge-net 1962 p 200)
25 Teone in Alm I 10 e I 14 in iA pp 45815-4604 e 57911-5811026 Teone in Alm I 10 in iA pp 4611-46217 applicato alla divisione di 1515 20
15 per 25 12 1027 Teone in Alm III 1 e IV 3 in iA pp 84112-84422 (stesso calcolo dei Prolego-
mena) e 102916-10327 idem in Alm IX pp 377-378 dellrsquoedizione di Basilea del 1538 approntata dai tipografi di Walderus Lrsquooriginale pappiano non ci egrave pervenuto
28 Alm I 10 in POO I 1 p 341129 Teone in Alm I 10 in iA pp 46916-4738
Fabio Acerbi134
Lrsquounico testo non elencato qui sopra o nelle note e che contenga tabelle operazionali egrave il commentario eutociano a Circ 3-4 Il testo ar-chimedeo che Eutocio e noi con lui leggeva egrave particolarmente conciso ed egli verifica esplicitamente il sussistere di certe relazioni numeriche Si tratta in ognuno dei nove casi presenti di mostrare che il lsquoteorema di Pitagorarsquo egrave verificato con ottima approssimazione dai valori numerici di opportune terne di rette Eutocio esegue le tre moltiplicazioni dei valori per se stessi e mostra che la somma o la differenza di due dei risultati si discosta di poco dal terzo30 I numeri in questione sono interi seguiti o no da una parte non intera espressa come somma di frazioni unita-rie31 I nove gruppi di tre moltiplicazioni una a fianco allrsquoaltra sono organizzati in forma tabellare ma senza lrsquoausilio di linee separatrici32 le operazioni sono eseguite disponendo lsquoin colonnarsquo i risultati delle mol-tiplicazioni parziali e sommandoli esattamente come facciamo oggi poicheacute sono in gioco numeri interi con parti frazionarie unitarie e la notazione non egrave posizionale non egrave necessario che gli incolonnamenti siano esatti (unitagrave di un risultato parziale sotto le decine del precedente ecc) Sono inclusi nella tabella istruzioni e commenti in linguaggio corrente33 le prime relative allrsquooperazione da affettuare sui risultati delle
30 Eutocio non calcola radici quadrate approssimate per quanto ciograve si renda piugrave volte necessario fornisce il risultato e verifica la sua correttezza moltiplicandolo per se stesso Egli dichiara che il lettore interessato a questo procedimento di calcolo puograve rivolgersi Ἥρωνι ἐν τοῖς μετρικοῖς [hellip] Πάππῳ καὶ Θέωνι καὶ ἑτέροις πλείοσιν ἐξηγουμένοις τὴν μεγάλην σύνταξιν τοῦ Κλαυδίου Πτολεμαίου laquoa Erone nei Metrica [hellip] a Pappo e Teone e a svariati altri inter-preti della Grande composizione di Claudio Tolomeoraquo (AOO III p 23213-17)
31 Troviamo ad esempio ͵αωλη θ´ ια´ cioegrave 1838 + 19 + 111 notare il singolo apice per le frazioni unitarie
32 Essi sono editi in AOO III pp 234-256 La tradizione medievale del commentario eutociano che coincide con un ramo di quella archimedea e deriva da un codice appar-tenuto a Giorgio Valla perduto in etagrave rinascimentale ma riprodotto a volte con fedeltagrave assoluta negli apografi (si veda ad esempio nella tav 1a la riproduzione dellrsquoerronea di-sposizione di cifre e parte algoritmica nel primo gruppo di moltiplicazioni offerta dal Laur Plut 284 f 160r) egrave costituita da Marc gr 305 ff 142v-146v Laur Plut 284 ff 159r-164r Par gr 2360 ff 109v-113v Par gr 2361 pp 410-421 Nel codice veneziano in cui la disposizione per righe e colonne egrave irrimediabilmente alterata dal copista le operazioni sono cancellate con tratti di penna Il primo manoscritto fu esemplato per Bessarione da Giorgio Trivizias tra il 1455 e il 1468 (Mioni 1976 pp 309-312) il secondo fu vergato da Giovanni Scutariota in scrittura di imitazione (Martinelli Tempesta 2010 p 173 n 7 Rollo 2012) ca 1491-1492 il terzo fu trascritto per il cardinale di Firenze Niccolograve Ridolfi dopo che la biblioteca di Valla era stata acquistata a seacuteguito della sua morte avve-nuta il 23 gennaio 1500 per 800 scudi drsquooro da Alberto Pio di Carpi (nota del copista al f 120v) il quarto fu terminato per mano di Christopher Auer su commissione di Georges drsquoArmagnac il primo gennaio 1544 (sottoscrizione a p 474 del codice si veda RGK II nr 525)
33 A questi va aggiunto posto davanti al risultato finale di ogni moltiplicazione il segno convenzionale per ὁμοῦ laquoinsiemeraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 135
prime due moltiplicazioni34 i secondi alla bontagrave dellrsquoapprossimazione ottenuta35 Ogni gruppo di operazioni che chiude unrsquounitagrave esegetica ed egrave seguito dalla citazione che apre la successiva egrave trascritto come se facesse parte del testo a tutta pagina e preceduto dallrsquoindicazione οἱ δὲ πολλαπλασιασμοὶ ὑπόκεινται laquole moltiplicazioni sono poste qui sottoraquo Questi due fatti suggeriscono che tutte le operazioni cui Eutocio non fa alcun riferimento nel corpo del suo commentario siano unrsquoaggiunta editoriale risalente a Isidoro di Mileto che si occupograve della revisione del testo36
Gli incolonnamenti esatti sono invece necessari quando siano moltiplicati numeri con parti non intere espresse nel sistema sessage-simale in quanto la somma finale dei prodotti parziali va effettuata ordine per ordine Tale somma eccederagrave di norma il valore di 60 per un ordine dato nella tabella occorre pertanto trovare posto anche per i riporti che vanno sommati ai prodotti parziali dellrsquoordine preceden-te e quindi incolonnati con essi I testi ci offrono alcuni esempi di tabelle operazionali moltiplicative di questo tipo Teone afferma espli-citamente che la prima moltiplicazione che va a descrivere ha una rap-presentazione tabellare la cui disposizione ritroviamo pesantemente ingarbugliata nel Laur Plut 2818 f 35r37 Alla seconda occorrenza di una moltiplicazione eseguita (tav 1b Laur Plut 2818 f 65r) gli incolonnamenti sono meglio rispettati anche se il risultato finale egrave fatto erroneamente slittare di un posto verso destra i riporti (con un errore) si trovano nella penultima riga38 Nei Prolegomena ad Alma-gestum alcune moltiplicazioni sono accompagnate da tabelle quella meglio attestata egrave associata alla moltiplicazione di 67 4 55 per se stesso (sezione i nel riassunto fornito supra) ed egrave descritta additando sempli-cemente ad un ente materiale oramai inaccessibile forse tracciato in loquendo lsquoalla lavagnarsquo
34 Come λοιπὸν τὸ ἀπὸ ΕΓ laquoresta quello su ΕΓraquo seguito dal risultato della sottrazione di due quadrati
35 Come λείπει ἄρα μο β εἰς τὸ ἀκριβές laquomancano quindi 2 u(nitagrave) al risultato esattoraquo36 Si legga la sottoscrizione spuria ad AOO III p 26010-1237 Si legga la frase ἐκτίθεμαι αὐτὴν καὶ πάλιν αὐτὴν ὑφ᾽ αὑτὴν ὡς ὑπογέγραπται laquolo [scil il
valore del lato da moltiplicare per se stesso] dispongo lsaquouna voltarsaquo e di nuovo al sotto di se stesso come trascritto qui sottoraquo in iA p 45817 Il Laur Plut 2818 (Teone e Pappo Commentaria in Almagestum) egrave uno dei piugrave antichi manoscritti in minuscola sicuramente assegnabile alla prima metagrave del IX secolo (Follieri 1977 p 144 n 23 Maas 1927 p 76 n 17 riteneva che fosse piugrave antico del Tetraevangelo Uspenskij) per una sua analisi si veda Rome 1938
38 In nessuno dei due casi i numerali di molteplicitagrave sono segnalati con apici sono tutti sormontati da una barra si veda la sezione 4 punto b
Fabio Acerbi136
προκείσθω δὶς τὸ μῆκος αὐτῆς ὀφεῖλον τὴν τάξιν τοῦ κατὰ τοὺς πολλαπλασιασμοὺς κανόνος ἀποδοῦναι καὶ ἐκκείσθω ἐπὶ σελιδίων διαγεγραμμένων οὕτω καὶ δὴ αὐτῆς ἐφ᾽ ἑαυτὴν πολ-λαπλασιασθείσης γεγονέτωσαν τὰ ἐν τοῖς οἰκείοις σελιδίοις εἴδη ταῦτα δὴ συναγόμενα καθ᾽ ἣν ὑπεδείξαμεν τάξιν ποιήσει τὰς ὑπογεγραμμένας μοίρας ἢ καὶ λεπτά τινα εἴσι ͵δυϙθ νθ´ ιδ´´ ι´´´ κε´´´´ ὡς λείπειν τοῦ ἐπιμερισθῆναι ŏ ŏ με´´ μθ´´´ λε´´´´
che sia prescritto che la sua lunghezza debba figurare due volte nella disposizione della tavola delle moltiplicazioni e che lsaquoquestrsquoultimarsaquo sia disposta su colonne delimitate da linee cosigrave mdash E pertanto una volta moltiplicato lsaquoil latorsaquo per se stesso che le specie trovino posto nelle colonne appropriate quelle che vengono cosigrave raccolte secondo la disposizione che abbiamo indicato produrranno dunque i gradi o anche i minuti qui sotto trascritti 4499 59 14 10 25 in modo che dalle divisioni successive resti39 0 0 45 49 35
La tabella associata (tav 2a Marc gr 313 f 19v) contiene una sola svista grossolana reca 51 invece di 55 in ognuno dei due fattori posti affiancati sopra di essa Al di sotto preceduto dal segno convenzionale per ὁμοῦ egrave collocato il risultato incongruamente sfalsato di un paio di colonne e con la lettera numerale ͵δ priva di barra sormontante in-naturalmente disconnessa da υϙθ I riporti sono indicati dai numerali ι ρκγ´ η´´ ν´´´ posti al fondo delle prime quattro colonne Il calcolo egrave corretto in ogni sua parte
Il clou in questo piccolo spaccato delle interazioni testo-paratesto matematico risiede nella descrizione contenuta nei Prolegomena della disposizione tabellare di due procedimenti di divisione il primo ano-nimo e quindi da supporre tradizionale il secondo piugrave efficiente ed attribuito al matematico del IV secolo Pappo
Il primo metodo di divisione egrave sostanzialmente analogo a quello che usiamo attualmente Dividendo e divisore questrsquoultimo preceduto da un segno su cui ritorneremo nella prossima sezione sono posti uno sotto lrsquoaltro intervallati da una riga inizialmente vuota Primo passo viene reperito il massimo multiplo del divisore che sia minore del di-videndo esso viene trascritto sotto il dividendo nella prima lsquocasellarsquo della riga vuota recante in testa un segno per laquosottrairaquo il fattore mol-tiplicativo (o quoziente parziale) viene trascritto in una lsquocasellarsquo pre-ceduta da un segno per laquorisultaraquo sotto il divisore Secondo passo il massimo multiplo viene sottratto dal dividendo il resto cosigrave ottenuto egrave trascritto preceduto da un segno per laquorestoraquo in una casella posta
39 Lrsquoautore concettualizza il procedimento di estrazione di radice quadrata come una forma di divisione
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 137
accanto al dividendo40 I due passi precedenti sono quindi ripetuti con la sola differenza che il resto appena ottenuto prende il posto del divi-dendo il quoziente parziale scala di un ordine sessagesimale ad ogni passo41 E cosigrave via aggiungendo ogni volta due caselle La debolezza di questo metodo come di quello che utilizziamo attualmente risiede nel fatto che il reperimento dei quozienti parziali (ovverosia dei massimi multipli) viene effettuato per tentativi non riuscire a farlo al primo colpo appesantisce notevolmente i calcoli successivi e costringe ad un lavoro di riordino e addizione dei quozienti parziali stessi La tabella risultante dove appunto osserviamo questo fenomeno in parallelo con identiche inaccuratezze nella descrizione ha la forma riprodotta unico tra i manoscritti della recensione antica nel Marc gr 313 f 13r (tav 2b invito il lettore a non rivolgersi alle tavole se non dopo aver termi-nato questa sezione sarebbe anzi auspicabile che tentasse di ricostruire questa tabella e le due successive a partire dalla mia descrizione)42
Il secondo metodo di divisione attribuito a Pappo egrave congegnato in modo da rendere non aleatoria la ricerca dei quozienti parziali Come altrove nei Prolegomena la descrizione della procedura di calcolo si riag-gancia esplicitamente a una frase di Tolomeo laquouna volta dimostrato che il periodo di una singola rivoluzione lsaquodel solersaquo egrave di 365 giorni 14 48 se di-vidiamo per essi i 360 gradi di un singolo cerchio avremo il moto medio giornaliero del sole circa 0 gradi 59 8 17 13 12 31raquo43 Questrsquoaffermazione si trova nel terzo libro dellrsquoAlmagesto si tratta della prima occasione in cui viene effettuata una divisione in cui il divisore egrave maggiore del dividendo e i commentatori del trattato tolemaico non si fecero sfuggire lrsquooccasione di mostrare come eseguirla Ora il terzo libro del commentario di Pappo non ci egrave pervenuto Ci resta dunque come testo parallelo a quello dei Prolegomena la descrizione rigidamente formulare in Teone sicuramente un calco di quella pappiana Teone qui come nelle altre applicazioni del metodo (Laur Plut 2818 ff 136v [tav 3] e 190r) descrive brevemente ed espone esplicitamente la stessa tavola dei sottomultipli del divisore che
40 Esempio nella divisione di 378 per 17 il massimo multiplo egrave 374 il quoziente parziale egrave 22 il resto 4 e in effetti 378 = 374 + 4 = 17times22 + 4 Si noti che il segno per laquorestoraquo non egrave apposto in testa di riga ma davanti a ogni resto parziale e in effetti il dividendo che si trova in prima posizione in questa riga non egrave un resto
41 Analogamente nellrsquoalgoritmo moderno poniamo la virgola o scaliamo la cifra di un posto
42 Nei Prolegomena la descrizione della tabella associata al metodo anonimo egrave pre-ceduta da una breve sinossi dellrsquooperazione in stile procedurale (cioegrave senza riferimenti alla tabella) e seguita dalla sua esecuzione accurata ma con pochi riferimenti alla tabella se non quello ai due segni da apporre ai resti parziali e ai massimi multipli
43 Alm III 1 in POO I 1 p 2091-4
Fabio Acerbi138
troviamo nei Prolegomena ma non offre alcuna descrizione della disposi-zione tabellare della divisione stessa neacute vi fa riferimento
A questa procedura sono in effetti associate una tavola e una tabel-la costruite come segue (tavv 4 e 5 Marc gr 313 ff 17r e 17v il co-pista era ndash giustamente ndash insoddisfatto della prima versione) La tavola le cui righe e colonne sono delimitate da linee contiene sottomultipli44 del divisore 365 14 48 9 righe che riportano i valori da 160 a 960 piugrave altre 6 con i valori per decine da 1060 a 6060 la prima colonna elenca le 15 parti sessagesimali omettendo come drsquoabitudine la laquodenomina-zioneraquo dellrsquoordine (i numerali elencati sono quindi α β γ δ ε ϛ ζ η θ ι κ λ μ ν ξ) la seconda i sottomultipli corrispondenti organizzati su quattro colonne per tener conto dei tre ordini sessagesimali (il primo sottomultiplo egrave quindi ϛ ε´ ιδ´´ μη´´´ cioegrave 160 di τξε ιδ´ μη´´) La tabella priva di linee delimitanti espone la vera divisione Nella prima colonna troviamo i resti parziali ognuno preceduto dallrsquoindicazione del proprio ordine sessagesimale e da un segno per laquorestoraquo Nella seconda preceduti da un segno per laquosottrairaquo i sottraendi ognuno coincide ovviamente con uno dei sottomultipli nella tavola La terza colonna contiene se-guiti dallrsquoindicazione del proprio ordine sessagesimale i quozienti par-ziali ottenuti trascrivendo dalla prima riga della tavola il numerale corrispondente al sottraendo affiancato ed assegnando come ordine sessagesimale il successivo a quello posto in testa di riga Il risultato preceduto da un segno per laquorisultaraquo e posto al di sotto della tabella si ottiene sommando i quozienti parziali il procedimento non permette in generale di determinare lrsquointero quoziente parziale relativo ad un ordine sessagesimale fissato se non dopo due passi Una linea spezzata unisce i resti parziali successivi e i relativi sottraendi per evidenziare la laquoprogressione della proceduraraquo la spezzata lsquosaltarsquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore (le cui righe sono per il resto vuote) e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue di conseguenza anche il quoziente parziale relativo a questo resto appartiene allrsquoordine sessagesimale successivo
A questo punto possiamo rivolgerci alle tavv 4-5 e verificare se le immagini che ci siamo formati sulla base della mia descrizione corri-spondono a quelle che troviamo nel Marc gr 313 Non si tratta di un giochetto sterile egrave al contrario il cuore di un intrico di problemi Un primo ordine di problemi deriva dal fatto che nei Prolegomena lrsquoalgo-
44 Sottomultipli e non multipli in quanto il divisore egrave maggiore del dividendo Drsquoaltronde nel sistema sessagesimale come in quello decimale un sottomultiplo si ottiene dal multiplo corrispondente semplicemente scalando tutte le cifre di un posto (ad esempio 1360 di 365 14 48 si ottiene in questa maniera da 13 volte 365 14 48)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 139
ritmo della divisione lsquoalla Papporsquo non egrave mai eseguito (cioegrave formulato verbalmente) in maniera indipendente dalla descrizione della tabella Comrsquoegrave dunque possibile descrivere una tabella operazionale che non ha uno statuto testuale indipendente sulla base di un algoritmo in corso di esecuzione E drsquoaltro canto come non rilevare unrsquoanomalia in un algoritmo eseguito nella sua forma primaria sotto forma di descrizione di una tabella Ci potremmo chiedere se viene descritto lrsquoalgoritmo o la tabella La tensione fra i due enti grafici egrave acuita dal fatto che nei nostri testi tutto ciograve (esposizione o descrizione di un algoritmo o della tabella associata) avviene sempre e solo sulla base di un esempio numerico para-digmatico Per questo motivo la tabella in quanto struttura (cioegrave privata dei dati numerici accidentali) non puograve fare a meno della descrizione45 Dal canto suo Teone come forse Pappo ancor prima descrive ed espone la tavola dei (sotto)multipli ma non la tabella di divisione lrsquoalgoritmo relativo a questrsquoultima egrave espresso come per controbilanciare in maniera eccezionalmente trasparente e formulare Se ciograve comporta un guada-gno a livello verbale-argomentativo sorge un problema operativo grave come e dove sistemare i resti e i quozienti parziali ndash cioegrave tutti i numeri in output dellrsquoalgoritmo differenti dai (sotto)multipli ndash che la tabella si incarica di disporre in modo lsquonaturalersquo Teone prescrive soltanto di confrontare i resti con la seconda colonna della tavola dei sottomultipli e di trascrivere via via il quoziente ottenuto dopo ogni passo Insomma come eseguire materialmente una divisione Non certo adattando ad un nuovo caso specifico la formulazione dellrsquoalgoritmo che Teone propone
Un secondo ordine di problemi e una trappola micidiale per il co-pista egrave interno alla dialettica lsquotabellarsquolsquosua descrizionersquo ed egrave in assenza di simbolismo quello dei riferimenti linguistici da adottarsi nella seconda agli enti grafici che figurano nella prima Occorre ricercare la massima generalitagrave fornita da una descrizione definita di un ente numerico (ad esempio impiegando il termine laquorestoraquo o la perifrasi laquomassimo sotto-multiplo minoranteraquo) o basta assumere direttamente il suo valore speci-fico come esempio paradigmatico E in che modo risolvere il conflitto tra uso e menzione se come nel nostro caso la tabella contiene segni convenzionali ed occorre fornirne una descrizione Si rende ad esempio necessario introdurre un lsquooperatore di citazionersquo noi useremmo le virgo-lette la lingua greca premette lrsquoarticolo neutro Drsquoaccordo ma nel caso
45 Questa caratteristica non egrave connaturata alla matematica degli algoritmi la risorsa dello lsquostile proceduralersquo serve esattamente ad aggirare questo problema al di lagrave di un certo livello di dettaglio perograve essa condurrebbe ad un appesantimento insostenibile della for-mulazione dovuto alla pluralitagrave dei riferimenti agli oggetti matematici in gioco sulla que-stione dei diversi stili della matematica greca si veda Acerbi 2012
Fabio Acerbi140
greco qual egrave il suo range E come distinguerlo nei casi ambigui da un semplice articolo che precede un sostantivo quando questrsquoultimo lo ri-chieda Nel corso del processo di copia del testo della descrizione infine possono generarsi tensioni tra enti grafici interpretabili vuoi come segno convenzionale vuoi come abbreviazione Ambiguitagrave relative a questi punti opacizzano la descrizione Un problema analogo si porrebbe a priori nella dialettica tra uso delle lettere denotative per designare enti geometrici e loro menzione nella costruzione di un diagramma ma esso egrave risolto con lrsquoazzeramento della seconda funzione le lettere denota-tive sono sempre usate allrsquointerno del testo (sono cioegrave il referente degli oggetti geometrici di cui tratta il discorso matematico) mai menzionate (come accadrebbe se fossero il referente di oggetti grafici posti nel dia-gramma) Insomma il codice adottato per la costituzione dei diagrammi geometrici egrave condiviso (cioegrave canonizzato) semplice e perspicuo mentre quello per le tabelle operazionali non lo egrave da qui le sviste dei copisti e le trascuratezze di correttori ed editori
Infine chi vuole apprendere da questi testi come eseguire una divi-sione a cosa deve prestar fede se ad esempio a causa di errori di copia la descrizione finisce per non coincidere con la tabella operazionale visto che sono entrambe due maniere valide di eseguire lo stesso algoritmo Dopo tutto lo scopo di tutta questa macchina grafico-argomentativa egrave di insegnare a eseguire divisioni in formato tabellare Questo problema si fa particolarmente acuto se la tabella non egrave trasparente nel metodo di Pappo lo egrave quasi completamente in quello anonimo no E gli errori che riscontreremo nella (doppia) tabella ai ff 17r-v del Marc gr 313 a chi sono attribuibili Allrsquoautore al trascrittore o al copista medievale
Questo groviglio di problemi riceve alcune risposte sorprendenti dalla tradizione manoscritta come andiamo finalmente a vedere
4 Analisi delle testimonianze
I codici che ho adibito per lrsquoedizione sono i seguenti M = Marc gr 31346 C = Marc gr 314 (Tolomeo Tetrabiblos et opera minora cum commentariis Vezio Valente Anthologiae)47 Z = Vat gr 2326 (fattizio
46 Riferibile al sec IX ex-X in accolgo la datazione suggeritami per litteras il 522005 da Nigel G Wilson si veda anche Agati 1992 pp 141-142 La presenza non sistematica degli accenti che fa anticipare a Wilson la datazione di laquosaec X medraquo fornita in Mioni 1985 p 24 indusse Boris Fonkič (2005 non vidi) ad assegnare il codice allrsquoinizio del IX secolo
47 Il manoscritto riferibile alla seconda o terza decade della prima metagrave del XIV secolo fu vergato da Michele Clostomalle olim lsquoMetochitesschreiberrsquo Bianconi 2005a pp 428-430 Il titolo dei Prolegomena in questa trascrizione identico in grafia ma non in formulazione a
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 141
e mutilo Tolomeo Almagestum) S = Vat gr 184 (varia astronomica scholia miscellanea ad Almagestum Tolomeo Almagestum) P = Par gr 2390 (varia astronomica) gli ultimi tre riferibili allo scorcio del XIII secolo48 e apografi sicuri del Vat gr 159449 attualmente mutilo di due fascicoli che ci privano dei due terzi finali dei Prolegomena M e il Vat gr 1594 ammettono un modello comune il resto della tradizione (25 trascrizioni in tutto) dipende dagli apografi appena citati del Vat gr 1594 Le varianti della recensione bizantina che leggiamo tra lrsquoaltro nei Vat gr 198 Marc gr 310 (Tolomeo Almagestum cum commentariis Pappi Theonis et Cabasilae) e con ulteriori modifiche Laur Plut 89 sup 48 (varia astronomica Tolomeo Almagestum Barlaam Logistica) sono identificate dal siglum K e si trovano punteggiatura originale in-clusa nel secondo apparato50 Lrsquoanalisi delle testimonianze51 costituite ovviamente anche dalle tabelle associate saragrave condotta nella forma di una sequenza di osservazioni indicizzate da numerali o lettere oltre che di alcune note a piersquo di pagina
Iniziamo dalla descrizione del metodo di divisione anonimo
quello che leggiamo nel Vat gr 1594 (questrsquoultimo coincide con quello adottato nella recen-sione bizantina) fu apposto da Niceforo Gregora e successivamente corretto da Bessarione
48 Sto studiando il primo e il terzo codice in collaborazione rispettivamente con Daniele Bianconi e Inmaculada Peacuterez Martiacuten
49 Su questo codice risalente alla seconda metagrave del IX secolo e sulla sua collocazione nella lsquocollezione filosoficarsquo per prima proposta in Follieri 1977 pp 145-146 si vedano almeno Perria 1991 pp 82-88 Ronconi 2013 Che il titolo dei Prolegomena nel Vat gr 1594 sia stato apposto da Niceforo Gregora egrave stato riconosciuto per la prima volta in Mazzucchi 1994 p 211 n 196 si veda Bianconi 2005a p 418 per altri interventi di Gregora nello stesso manoscritto
50 Il Vat gr 198 egrave stato vergato dal copista Malachia nel corso del terzo quarto del XIV secolo Mondrain 2004 pp 278-290 e 292 Allo stesso copista (denominato non a caso prima dellrsquoidentificazione anonymus Aristotelicus) dobbiamo un buon numero di trascrizioni aristoteliche con i relativi commentari in margine Gli dobbiamo anche il Par gr 2342 secondo tomo di un quadrivium quasi completo di cui il Vat gr 198 egrave il primo nellrsquoordine aritmetica armonica astronomia (Almagesto e commentari relativi) nel codice vaticano geometria ed ancora astronomia (corpus astronomico minore) in quello parigino le opere trascritte sono sempre accompagnate in margine dai relativi commentari Il copista del Marc gr 310 egrave Isacco Argiro (ca 1300-1375) Mondrain 2007 p 166 Allo stesso Argiro dobbiamo il codice laurenziano (Daniele Bianconi per litteras) Poicheacute la recensione modificata che leggiamo nel Laur Plut 89 sup 48 egrave senza alcun dubbio basata su quella nel Marc gr 310 e non viceversa ci troviamo di fronte ad un copista che trascrive due volte lo stesso testo in due versioni leggermente differenti la conclusione naturale egrave che la seconda recensione egrave dovuta ad Argiro stesso la questione andragrave studiata in dettaglio
51 Nei manoscritti citati i Prolegomena si trovano ai fogli seguenti Vat gr 1594 ff 1r-8v (mutilo mancano due fascicoli su tre) Marc gr 313 ff 1r-28r (incompleto man-cano due fogli allrsquoinizio e il f 6 attualmente rimpiazzato da uno bianco) Marc gr 314 ff 235r-255r Vat gr 2326 ff 19r-40v e 43r-v (incompleto e con i fascicoli in disordine) Vat gr 184 ff 10r-23v Par gr 2390 ff 1r-13v Vat gr 198 ff 127r-136v Marc gr 310 ff 1r-13r Laur Plut 89 sup 48 ff 7r-19r
Fabio Acerbi142
ἐκθέμενοι οὖν διάγραμμα τῶν ἀριθμῶν ὡς ὑπόκειται προτάσσομεν τὸν μεριζόμενον καὶ μικρὸν ὑπ᾽ αὐτὸν τὸν μερίζοντα ὡς ἔχει τὸ διάγραμμα ἐν στίχοις διοριζομένοις ὑπὸ γραμμῶν [hellip] καὶ τὰ μὲν γινόμενα ἐγγὺς ἐλάττονα ἐν τῇ μεταξὺ θέσει τοῦ μεριζομένου καὶ τοῦ μερίζοντος ἐν στίχοις παρασημειοῦσθαι πρὸς τὸ ἀσύγχυτον εἶναι τὴν τάξιν τὰ δὲ μεθ᾿ ὧν ὁ μερίζων ἐποίει τοὺς ἀεὶ ἐλάσσονας ὑπὸ τὸν μερίζοντα σημειοῦσθαι προγράφοντας ἐπὶ τοῦ στίχου αὐτῶν τὸ γίνεται οὕτως γι ἐν δὲ τῷ στίχῳ τῶν μεριζόντων τὸ παρὰ ἔχον οὕτως oslash ἀντὶ τοῦ παρ᾿ ἃ δεῖ τὸν μερισμὸν γίνεσθαι ἐν δὲ τῷ στίχῳ τῶν ἐλασσόνων τὸ αφ διὰ τὸ τούτους ἀεὶ ἀφαιρεῖσθαι ἀπὸ τῶν ἐπάνω τῶν μεριζομένων ἐν δὲ τοῖς τοῦ μεριζομένου λοιπάσμασι τοῖς καὶ ἐπιοφείλουσι τὸ λ κατὰ τὸ ἴδιον τῶν διαστάσεων ἑκάστης ndash λέγω δὴ λοιπάδος ndash ἀντὶ τοῦ λοιποὶ οἱ μέλλοντες ἐπιμερίζεσθαι
2 post τὸν suprascr τὸν ἐλάττονα m 2 S 5 πρὸς] MP et ex corr Z κατὰ S om C | ἀσύγχυτον] MSPC -χητον Z 6 ἀεὶ] MZPC ὡσεὶ S 7 γίνεται οὕτως γι ] γι τ οὕτως γι τ M γί οὕτως γί Z γι οὕτως γί SC τὸ γινόμενον οὕτως γίνεται P 8 τὸ παρὰ ἔχον οὕτως] scripsi τὸ παρέχον οὕτως M et π(αρ-) comp Z οὕτως τὸ περιέχον S προγράφοντας οὕτως ex corr m 2 P τὸ περιέχον οὕτως C | oslash] MZSC (sed ο fecit | Z) ἐλάττων comp ex corr m 2 P | παρ᾿ ἃ] scripsi παρα M π(αρα) comp ZSC ex παρα fe-cit παρὰ et τοῦτον suprascr m 2 P 9 γίνεσθαι] comp C | αφ ] αφ ε M ἀφ ZSC ἀφαί P | ἀεὶ] om M 11 ἐπιοφείλουσι] MZSC ex ἐπιο- fecit ἐπο- m 2 P | λ] MZPC λ´ S 12 λοιποὶ] PC λοιποῦ MZS
3 στίχοις] στίχῳ K 5 πρὸς] διὰ K 7 ἐπὶ mdash γι ] τὸ γίνεται διὰ τοιούτου σ(ημείου) γί K 8 τὸ παρὰ ἔχον mdash παρ᾿ ἃ] τὸ παρᾱ διὰ σ(ημείου) τοιούτου καὶ τοῦτο oslash δηλοῦντος τοῦ παρᾱ ὅτι παρὰ τὸν τοιοῦτον (ἀριθμὸν) K 9 αφ διὰ τὸ τούτους] ἀφ δηλοῖ δὲ τοῦτο ἀφαίρεσ(ιν) ὅτι τούτους ἀεὶ δεῖ K 11 ἐπιοφείλουσι] ἐπιμερίζεσθαι ὀφείλουσι K | λ] λ οι` K 12 ἀντὶ τοῦ] δηλοῦντος τοῦ σ(ημείου) τὸ K
lsquoRendendo esplicito un diagramma numerico come lo troviamo qui sotto disponiamo in primo luogo il dividendo e un poco al di sotto di esso il divisore come li ha il diagramma in righe delimitate da linee [hellip] e lsaquooccorreragraversaquo nella posizione tra il dividendo e il divisore annotare lrsquouno accanto allrsquoaltro i piugrave vicini lsaquodei numerirsaquo minori che risultano affincheacute la disposizione non sia confusa quelli con cui il divisore faceva ogni volta i lsaquonumerirsaquo minori annotarli sotto il divisore scrivendo in prima posizione sulla loro riga laquorisultaraquo cosigrave Ris nella riga dei diviso-ri52 invece laquoperraquo fatto cosigrave53 P in luogo di laquoquelli per cui deve farsi la divisioneraquo nella riga dei lsaquonumerirsaquo minori laquosottrraquo in quanto questi sono sempre sottratti dai dividendi che si trovano sopra nei residuli del dividendo (occorre ben farlo anche per loro) laquoReraquo in accordo con ciograve
52 I laquodivisoriraquo sono al plurale ma siamo semplicemente di fronte a un tratto idioma-tico della lingua greca nel caso di espressioni generalizzanti crsquoegrave soltanto un divisore che occupa lrsquounica colonna di cui si compone la sua riga
53 Si intenda ἔχον οὕτως = ita se habens
1
5
10
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 143
che egrave proprio agli scarti di ciascuno ndash intendo qui lsaquociascunrsaquo residuo54 ndash in luogo di laquoresti che vanno a essere divisi ulteriormenteraquorsquo
a) Operatori di citazione e segni convenzionali I segni introdotti sono quattro la mia discussione egrave condotta dando per scontato che essi siano identici a quelli impiegati dallrsquoautore dei Prolegomena anche se si tratta di unrsquoipotesi non corroborabile neacute falsificabile
i Segno per il risultato Lrsquoabbreviazione convenzionale per γίνεται egrave identica al segno introdotto dallrsquoautore e i copisti si dividono tra i due errori possibili scrivere due abbreviazioni o risolverle entrambe Un fenomeno del tutto analogo si riscontra nel Matr 4678 il manoscritto alla base di tutta la tradizione degli Arithmetica di Diofanto al momen-to della definizione dellrsquoἀριθμός (lrsquolsquoincognitarsquo nel nostro linguaggio) ὁ δὲ μηδὲν τούτων τῶν ἰδιωμάτων κτησάμενος ἔχων δὲ ἐν ἑαυτῷ πλῆθος μονάδων ἄλογος ςο` καλεῖται ς` ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον τὸ ς` laquoil lsaquonumerorsaquo che non possiede nessuna di queste proprietagrave ma che ha in seacute una molteplicitagrave indefinita di unitagrave egrave chiamato lsquonumerorsquo e il suo segno egrave ς`raquo Qui solo il terzo dei tre ς ha una barra a sormontare per segnalarne il carattere puramente denotativo (cioegrave di segno convenzionale e non di abbreviazione si veda il punto successivo)55 il primo egrave una delle abbreviazioni piugrave diffuse per ἀριθμός (e infatti egrave dotato del compendio per la desinenza e dellrsquoaccento grave) il secondo egrave una delle piugrave comu-ni per καὶ () Giovanni Cortasmeno autore di capillari annotazioni infra lineam agli Arithmetica nel codice madrileno scioglie il primo ςο`
54 Doppia variatio che impiega al posto di λοιπόν laquorestoraquo i due termini decisamente non canonici τὸ λοίπασμα e ἡ λοιπάς (piugrave oltre leggiamo anche il participio λοιπασθέντα) Una ricerca sul TLG in rete non ha fornito occorrenze del primo si tratta dunque di uno hapax Quanto al secondo che ricorre anche nella sezione sulla divisione lsquoalla Papporsquo lo si rintraccia giagrave nei papiri documentari il termine diventeragrave perograve canonico nelle esposizioni bizantine drsquointroduzione allrsquoAlmagesto ricalcate sul modello dei Prolegomena (si veda la nota 87 infra) Questi due termini designano i resti parziali prodotti nel corso di una divisione lunga li ho tradotti rispettivamente con il neologismo laquoresiduloraquo e con il sostantivo pari-menti non canonico laquoresiduoraquo
55 Il copista interpreta erroneamente il terzo segno come unrsquoabbreviazione e qui ag-giunge un apice inverso (cioegrave un accento grave) altrove lo scioglie direttamente in forme opportune di ἀριθμός Matr 4678 f 58v La frase come la leggiamo nel manoscritto egrave cor-rotta sulla base di una parafrasi in Psello (edita in DOO II p 3710-12) Tannery emendograve ἄλογος in ἀόριστον DOO I p 64-5 et app Il Matritensis vergato da due copisti differenti (cambio di mano a tre righe dalla fine del f 62r) contiene lrsquoIntroductio arithmetica di Nicomaco e le opere diofantee oltre ad alcuni brevi opuscoli musicali la sua data egrave stata recentemente corretta dal XIII al secolo XI pm in Peacuterez Martiacuten 2006 (una riproduzione digitale del manoscritto si trova allrsquoindirizzo httpbdhbneesbnesearchbibliotecaDio-fanto20de20AlejandrC3ADa)
Fabio Acerbi144
in ἀριθμός ed aggiunge un altro segno56 sopra il terzo anteponendovi lrsquoindicazione καὶ ἔστιν αὐτοῦ σ(ημεῖον) τόδε Va da seacute che non abbiamo nessuna garanzia che il segno originariamente introdotto da Diofanto coincidesse realmente con unrsquoabbreviazione convenzionale per ἀριθμός Lrsquoevidenza del PMich III 144 (sec II in) suggerisce drsquoaltronde che il Matritensis e con esso tutta la tradizione medievale di Diofanto ripro-duca fedelmente pur accentuandone la sinuositagrave il segno originario
ii Segno per il divisore Un cerchiolino sbarrato da non confondere con il segno per ὁμοῦ che nei manoscritti matematici ha di norma due barre trasversali (cf tav 2a) Non sono riuscito a rintracciarne ulteriori occorrenze in altre opere la forma che esso assume nel Vat gr 2326 e la correzione apportata nel Par gr 2390 lasciano aperta la possibilitagrave per quanto a mio avviso remota che la forma originaria non fosse lon-tana da unrsquoabbreviazione di παρά registrata nei repertori57 Il correttore del Par gr 2390 trasforma in effetti il segno oslash nellrsquoaffine abbreviazione canonica per (forme di) ἐλάσσων laquominoreraquo58 e si incarica diligente-mente di farlo notare ricapitolando i segni nella porzione superiore del margine esterno del f 7v Nello stesso margine egli traccia anche uno lsquoscolio tabellarersquo ed egrave lrsquounico a porre il (proprio) segno dove indicato dalla descrizione (tav 6 Par gr 2390 f 7v) Oltre a ciograve adattando la tabella al margine ristretto lo scoliaste trascrive come colonne affian-cate le due righe dei resti parziali e dei massimi multipli e aggiunge le indicazioni ὁ μεριζόμενος laquodividendoraquo e ὁ μερίζων laquodivisoreraquo ma vi introduce alcune incongruenze di formato il risultato scritto in verti-cale e la linea verticale di sinistra che separa il divisore dal segno che lo dovrebbe precedere direttamente
iii Segno per i massimi multipli Corrisponde alla semplice abbre-viazione per sospensione della forma verbale ἄφελε laquosottrairaquo in questo
56 Si tratta del segno di ampio uso praticamente identico allrsquoabbreviazione canonica per οὖν
57 Si tratta di un pi a forma di gancio sbarrato da uno slash di troncamento Ce-reteli 1904 tav IX item 7 sub ΠΑΡΑ che rinvia al PVindRain 423 cf anche la forma π` nel POxy LXI 4142 edito in Jones 1999 II pp 26-34 In generale nei papiri e nei manoscritti matematici in maiuscola le preposizioni sono abbreviate facendo seguire un lsquoapostroforsquo alla loro prima lettera Α᾽ Υ᾽ ecc Per la seconda fattispecie di supporto libra-rio si veda in particolare il cosiddetto fragmentum mathematicum Bobiense scriptio inferior databile al V-VI secolo del palinsesto Milano Biblioteca Ambrosiana L 99 sup (Isidoro di Siviglia Etymologiae datazione Cavallo 1977 p 100) pp 113-114 che sono stampate in riproduzione apografa conforme in Belger 1881 (la p 114 egrave riprodotta anche nella tav 10 di Acerbi 2010)
58 Se questa era lrsquointenzione si tratta ovviamente di una forzatura il divisore puograve ben essere maggiore del dividendo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 145
caso lo slash di troncamento taglia orizzontalmente il tratto verticale del phi I copisti offrono molteplici varianti apponendo chi uno spirito dolce chi un ε chi un αί accentato a sormontare Tutti questi segni svolgono la funzione di abbreviazioni vere e proprie (e cosigrave doveva essere anche per lrsquoautore si veda il punto 1 di p 153 infra) la forma originale si ottiene a mio avviso incrociando i dati del Marc gr 313 e dei tre apografi del Vat gr 1594 αφ anche se lrsquoassenza dello spirito potrebbe essere semplicemente dovuta alla pratica del copista del codice veneziano di economizzare nei diacritici
iv Segno per i resti Un lambda completato da una barra a sormon-tare o da un apice che rinvia alle abbreviazioni per sospensione di una forma opportuna di λοιπός laquorestoraquo In realtagrave la forma che troviamo nella tabella egrave differente (tav 2b) e coincide con quella offerta quasi unanimemente dai manoscritti nella descrizione e in almeno un caso nella tabella del metodo di divisione attribuito a Pappo (tav 4) un lambda che accoglie al di sotto una legatura omicron-iota () sbarrata da uno slash di troncamento Qualcosa di simile si trova nel PVindob G 19996 (sec I) una specie di lambda maiuscolo molto aperto e dal vertice arrotondato che include un circoletto interpretato dagli editori come segno per περίεστιν o per λοιπόν59 Lo stesso segno si rintraccia ad esempio in un medesimo scolio tabellare di prima mano ad Alma-gestum nel Vat gr 1594 f 93v e nel Marc gr 313 f 135r ma stavolta la forma del lambda egrave molto ben definita
Fin qui i segni Ma il gioco egrave piugrave complesso La descrizione si muo-ve pericolosamente sulla linea di confine non sempre ben definita tra segno convenzionale e abbreviazione il primo ndash e il repertorio grafico matematico-astronomico ne egrave particolarmente fornito60 ndash puograve anche
59 Ho consultato lrsquoedizione Gerstinger ndash Vogel 1932 pp 46 e 48 la porzione rilevante del papiro egrave riprodotta nella tav 11 di Fowler 1999 Si veda ancora ivi pp 253-257 per la trascrizione di questo segmento di testo (con correzioni rispetto alla princeps) e per una messa a punto recente inclusa la proposta di datazione che ho riportato qui sopra Il verso del papiro che contiene una tavola aritmetica del tutto scorrelata dalla tematica del recto egrave edito come PRain Unterricht 151
60 La pratica di ridurre lo spazio occupato da un testo tecnico per mezzo di abbreviazioni e segni convenzionali era molto diffusa nei manoscritti in maiuscola contrariamente a quanto avviene per altri generi letterari vedremo tra breve cosa accade negli Arithmetica di Diofanto ma si leggano in proposito anche le considerazioni di Hei-berg nei prolegomena alla propria edizione dellrsquoAlmagesto in particolare riguardo al ricorso massiccio ad espedienti brachigrafici nel modello del Vat gr 180 POO II pp lxxxiv-xciii civ-cv cxxvii cxxxviii-cxxxix Agli elenchi dettagliati forniti da Heiberg possiamo aggiungere il piccolo prontuario stampato in Hultsch 1876-1878 III 2 pp 126-132 e basato sul testo e sugli scolii alla Collectio di Pappo nel Vat gr 218 (sec X in) Si vedano infine le osservazioni del copista del Par gr 2360 f 120v trascritte da Heiberg in AOO III pp x-xi sulle laquonotazioni tipiche a scopo di tagliar corto nello scrivereraquo impiegate nel pro-
Fabio Acerbi146
derivare dalla seconda (un caso egrave appunto il segno per ἐλάσσων che probabilmente trae origine da una legatura epsilon-lambda) ma poi il rapporto referente-relato si fissa convenzionalmente Quelli definiti nel testo che abbiamo letto sono appunto segni convenzionali non ci sarebbe bisogno di spiegarne forma e funzione se fossero intesi come abbreviazioni assumono nella tabella una funzione denotativa non esplicativa o discorsiva (come accade invece nella tav 1a) Ma come vengono descritti questi segni
I referenti delle descrizioni sono i segni sono introdotti da οὕτως (item i-ii) o in alternativa da un τό con il ruolo di lsquooperatore di citazionersquo (item iii-iv) che corrisponde esattamente alle nostre virgolette In entram-bi i casi gli enti sono menzionati e svolgono una funzione metalinguistica sono collocati materialmente nel testo ma egrave come se si trovassero fuori e la loro descrizione li additasse ndash in effetti i segni convenzionali scritti nel testo sono a loro volta i relata di quelli che si trovano nella tabella
I relata dei segni scritti nel testo sono di due tipi singoli vocaboli (item i-ii) o descrizioni della funzione dei segni per mezzo di clausole sintaticamente complesse (item ii e iv) I singoli vocaboli sono γίνεται e παρά e sono entrambi preceduti dal τό lsquocitazionalersquo in quanto relata di segni convenzionali le forme abbreviate con cui sono tracciati nei manoscritti vanno forzatamente sciolte Bisogna ammettere che la per-spicacia e le risorse grafiche dei copisti ndash di cui tutto si puograve dire fuor che commettano qui degli errori ndash sono messe a dura prova con lrsquointrodurre segni identici ad abbreviazioni o con lrsquoattivare un gioco metalinguistico particolarmente serrato in un contesto meno lsquonaturalersquo di come potreb-be esserlo ad esempio quello di un trattato grammaticale Lrsquoitem iii che presenta direttamente un segno identico ad unrsquoabbreviazione non egrave sorretto da una descrizione ma da una giustificazione in διὰ τό Lrsquoartico-lo τό vi assume una funzione metalinguistica anche se non lsquocitazionalersquo poicheacute al tempo stesso genera un infinito sostantivato e lo singolarizza per questo ho scritto laquosono sottrattiraquo in corsivo nella mia traduzione
prio modello archimedeo (nota 32 supra) egli ne compila anche una breve lista Un elenco antico di laquosegni della geometriaraquo sicuramente redatto per assistere il copista si trova anche al f 3v del ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 vergato da Efrem negli anni 950-960 (tav 8 in Acerbi 2010) Possiamo farci unrsquoidea quantitativa del guadagno di spazio in rapporto ad un testo privo di abbreviazioni e con le parole separate da spazi sulla base del fragmentum mathematicum Bobiense il testo vi egrave disposto a tutta pagina su 36 righe di circa 30 segni ciascuna nelle due pagine in questione figurano 2038 segni con 15 mezze righe occupate dalle due figure Ora nel testo dellrsquoedizione stabilita in Heiberg 1927 pp 87-90 le stesse pagine contano 4455 segni spazi compresi Ne risulta che la dimensione in caratteri di un testo matematico puograve essere ridotta di piugrave della metagrave con lrsquoimpiego di compendi e segni convenzionali
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 147
Negli item ii e iv il segno si collega ad una descrizione nel secondo caso in via esclusiva le descrizioni pertanto rinforzano o sostituiscono lrsquoidentificazione con lrsquoente linguistico denotato Le clausole descrittive sono precedute da ἀντί e dallrsquoarticolo τό con funzione di lsquooperatore di citazionersquo esse sono παρ᾿ ἃ δεῖ τὸν μερισμὸν γίνεσθαι (item ii) e λοιποὶ οἱ μέλλοντες ἐπιμερίζεσθαι (item iv) Nella descrizione della divisione lsquoalla Papporsquo che leggeremo tra breve i segni negli item iii e iv rice-vono lo stesso trattamento degli altri due il loro relatum egrave un singolo vocabolo e non una clausola descrittiva rispettivamente nelle espres-sioni τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε (sul participio ritorneremo nel punto 1 infra) e τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά (la forma del segno notato con λ οι egrave descritta supra nellrsquoitem iv) La descrizione del segno oslash per il divisore merita una discussione piugrave dettagliata In origine si trovava probabilmente scritto Π(ΑΡΑ)ΕΧΟΝ successivamente letto come π(αρ[α])έχον ndash dato che lrsquoabbreviazione per il preverbo egrave identica a quella per la preposizione (che sia Π᾽ o un pi seguito dal segno per ἄρα a sormontare) ndash invece di π(αρὰ) ἔχον I copisti e i correttori si dettero a tutte le possibili contorsioni per restituire un testo dotato di senso leggere appunto una forma verbale con preverbo modificare il preverbo (ma forse il segno per ἄρα era insidiosamente simile ad uno epsilon) correggere il testo rileggiamo lrsquoapparato sub τὸ παρὰ ἔχον οὕτως τὸ παρέχον οὕτως M et π(αρ-) comp Z οὕτως τὸ περιέχον S τὸ περιέχον οὕτως C προγράφοντας οὕτως ex corr m 2 P Nella clausola descrittiva seguente la presenza liminare di παρὰ (che ho corretto in παρ᾿ ἃ nella speranza di restituire una frase che abbia un senso senza intervenire sul testo) innesca un bel corto circuito il Π(ΑΡΑ) che sicuramente figu-rava nellrsquoarchetipo egrave un sintagma complesso una preposizione unrsquoab-breviazione o un segno per unrsquoabbreviazione Se lrsquoeditore si trova in conflitto con la propria inclinazione alla critica conservativa i copisti si rifiutarono di mettere mano ad un testo che doveva stridere anche per loro essendo il compito demandato al ritocco del revisore del Par gr 2390 o alla riscrittura radicale del recensore bizantino Il problema egrave che ci troviamo di fronte ad unrsquoespressione che descrive la funzione dellrsquooggetto denotato non lrsquooggetto stesso ma che lo contiene al suo interno per soprammercato qui il Π(ΑΡΑ) egrave usato per giustificare una menzione a sua volta relatum di un segno
Evidentemente questa maniera di procedere che giagrave aveva attirato interventi da parte di copisti e correttori della recensione di base parve insostenibilmente opaca allrsquoautore della recensione bizantina61 Egli
61 Uno dei manoscritti di questa recensione propone anche una tabella di divisione
Fabio Acerbi148
modifica tutte le descrizioni diluendo lrsquoidiomatismo dellrsquoarticolo lsquocita-zionalersquo con lrsquointroduzione sistematica del verbo δηλόω e di frasi atte a chiarire quale sia il segno denotante e quale il vocabolo (o il segno) denotato Egli introduce allo scopo di rendere esplicita la funzione de-notativa dei segni introdotti il termine σημείου curiosamente in tutte le sue tre occorrenze esso compare a sua volta nella forma dellrsquoabbrevia-zione per sospensione σΗ´ Egli traccia il segno per i massimi multipli ἀφ e quello per i resti λ οι` in modo che non vi siano ambiguitagrave quanto al loro carattere di abbreviazione Si faccia infine attenzione al residuo di barra sul παρᾱ con funzione denotativa (2 occorrenze) contenuto nella descrizione del segno per il divisore sostituita dallrsquoaccento grave nel παρὰ con funzione discorsiva (la differenza egrave nettissima nei manoscritti da me consultati) Questa osservazione ci permette di passare direttamente allrsquoitem seguente
b) Le barre sui numerali e sulle lettere denotative Egrave opportuno discutere questo punto adesso esattamente percheacute di barre siffatte che pure troviamo in tutti i manoscritti i nostri testi non fanno mai menzione si tratta infatti di una pratica condivisa sin dallrsquoantichitagrave La barra identifica una stringa di lettere dellrsquoalfabeto che non svolge una funzione grammaticale o sintattica propria allrsquointerno del discorso Ciograve avviene in particolare e si tratta della fattispecie piugrave frequente se la stringa di lettere non dagrave origine a un vocabolo della lingua greca lette-re denotative e numerali certo ma anche termini provenienti da altri idiomi e contrazioni di parole greche come i nomina sacra62 tali termi-ni possono essere o no preceduti da un articolo lsquocitazionalersquo a seconda dellrsquouso che ne viene fatto allrsquointerno del discorso Ma non si tratta dellrsquounica fattispecie i papiri grammaticali ed i manoscritti piugrave antichi dei trattati dello stesso argomento segnalano gli esempi delle parti del discorso (cioegrave di lsquoverersquo parole greche) per mezzo di barre sormontanti63 La differenza insomma egrave tra menzione e uso (come parte del discorso in atto) di una stringa di caratteri tra il porre le lsquovirgolettersquo e il non porle tra funzione denotativa e non Apparentemente la convenzione si limi-
corredata dei segni opportuni e contrariamente alle indicazioni della descrizione svilup-pata lsquoin verticalersquo ma per motivi misteriosi non completa (tav 7a Laur Plut 89 sup 48 f 13r)
62 Tutto ciograve egrave spiegato con estrema chiarezza giagrave in Traube 1907 pp 45-4763 Si veda il Par gr 2548 codex vetustissimus e testimone unico delle lsquoopere minorirsquo
di Apollonio Discolo il f 106v con le barre ben visibili egrave riprodotto come tav 19 in De Gregorio 2000 (ivi pp 137-138 per la datazione) Per la testimonianza dei papiri grammaticali si veda Wouters 1979 passim essi contengono di norma elenchi di parti del discorso nessuna delle quali egrave preceduta dallrsquoarticolo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 149
tava in questo secondo caso a segnalare con la barra singoli vocaboli le menzioni di frasi o di sintagmi complessi sono di norma identificate dallrsquoarticolo lsquocitazionalersquo Drsquoaltra parte le abbreviazioni convenzionali non rientrano nella casistica percheacute la loro resa grafica che contiene elementi non alfabetici come compendi per desinenze lettere supra li-neam marche di contrazione o sospensione quali slashes o barre sotto-poste o sormontanti eventualmente solo un sottinsieme della stringa di segni alfabetici le esclude automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
Venendo al discorso matematico una barra sormonta senza ecce-zione le lettere denotative64 che sia in papiri o in manoscritti in maiu-scola65 o minuscola ma solo allrsquointerno del testo comrsquoegrave da attendersi nei diagrammi esse la perdono per il semplice motivo che non crsquoegrave alcun testo ambiente un diagramma ha unicamente una funzione denotati-va Drsquoaltra parte le lettere numerali che a volte figurano nei diagrammi della tradizione metrica66 allo scopo di indicare la lunghezza dei seg-menti mantengono la barra in un diagramma il contesto denotativo geometrico egrave prevalente e i numerali vengono percepiti come entitagrave grafiche lsquoesternersquo al discorso Va da seacute a fortiori che le lettere numerali inserite in un testo dovranno essere segnalate da barre che a loro volta non servono nelle tavole67 in quanto queste ultime sono come abbiamo visto un vero e proprio testo che perograve funge da ambiente a quello al-fabetico limitato alle titolazioni e non a caso tracciato in unrsquoopportuna lsquomaiuscola distintivarsquo allo scopo di segnalarne il carattere denotativo e non discorsivo68 Una tabella operazionale egrave invece un paratesto e quindi le barre sulle lettere numerali che rappresentano gli interi sono
64 La notazione per le lettere denotative subigrave unrsquoevoluzione (il cui risultato finale egrave descritto per sommi capi nella nota 3 supra) di cui non mette conto occuparsi qui
65 I papiri di contenuto geometrico (o astronomici ma che presentano argomenti geometrici) sono rari si vedano il PHerc 1061 (sec II aC Demetrio Lacone De geome-tria) e il PFay 9 (sec II ex Elementi I 39 e 41) Gli importanti ostraka OBerl 12002 e 12609 (sec III aC m Elementi XIII) non pongono le barre sopra le lettere denotative Per i manoscritti in maiuscola si veda ad esempio passim nel Par gr 2389 una cui riproduzione digitale egrave consultabile in rete allrsquoindirizzo httpgallicabnffrark12148btv1b8470171d o il fragmentum mathematicum Bobiense
66 Si veda ancora il ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 codex unicus dei Metrica di Erone e contenente una raccolta importante di problemi del corpus metrologico
67 Si vedano come esempio le tavole citate alle note 10 e 14 supra Discorso a parte per il segno di lsquoposto vuotorsquo si veda il punto c che segue
68 Queste regole generali vanno prese cum grano salis si dagrave naturalmente un certo dominio di variabilitagrave legato verosimilmente al grado di cultura grafica del copista nel PMich III 144 i numerali sono quasi tutti senza barra sia nel testo che nelle tabelle ope-razionali
Fabio Acerbi150
necessarie esse mancano invece sui segni convenzionali che ho descrit-to nel punto precedente e fatto rilevante sulle lettere numerali relative agli ordini sessagesimali quando esse siano identificate da uno o piugrave apici la presenza di questo segno grafico non alfabetico69 le esclude ancora una volta automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo Unrsquoultima osservazione che ci saragrave utile nel seacuteguito la descrizio-ne di una stringa di lettere lsquoagrammaticalersquo non puograve prevedere la men-zione della presenza della barra che le pertiene in quanto tale si tratta di una pratica denotativa che egrave possibile formulare soltanto ad un livello di discorso superiore sia a quello dellrsquouso che a quello della menzione70
c) Il segno di lsquoposto vuotorsquo Si noti nella tav 2b la forma ŏ per il segno di lsquoposto vuotorsquo in un ordine sessagesimale coerentemente con la propria notazione il copista del Marc gr 313 lo scioglie talvolta allrsquoin-terno del testo principale come unrsquoabbreviazione per οὐδέν laquonienteraquo Altre convenzioni di scrittura del tratto che accompagna il circoletto e che si badi bene fa parte integrante del segno di lsquoposto vuotorsquo ndash e infatti nelle tavole troviamo sempre il segno completo mentre tutti gli altri numerali sono come abbiamo visto nel punto precedente privi di barra o di apice a causa del fatto che i vari ordini sessagesimali sono univocamente determinati dalle linee di giustificazione ndash un tratto an-golare anteposto (tav 3 Lar Plut 2818 f 136v)71 o una semplice barra a sormontare (tavv 4-9) si produce in questo modo il segno 65926 che sembra essere stata la forma di base72
69 Occorre dunque supporre come testimoniano papiri e manoscritti in maiuscola che la convenzione relativa allrsquouso della barra si sia consolidata ben prima dellrsquointroduzione di segni diacritici quali accenti e spiriti
70 Si veda il punto 2 infra per maggiori dettagli sulla questione delle barre e degli apici e per le indicazioni in merito che leggiamo in Diofanto
71 Come accennato questa tavola dei sottomultipli coincide con quella descritta ed esposta nei Prolegomena Fatto molto rilevante i numerali nella prima non recano neacute barre neacute apici contrariamente a quanto accade a tutte le istanze della seconda nei manoscritti Quella del Laur Plut 2818 preserva a mio avviso la forma originaria come abbiamo visto una tavola non richiede segni aggiuntivi sulle lettere numerali
72 Si vedano come esempio ancora le tavole citate alle note 10 e 14 supra oppure per una rassegna delle forme che il segno assume nei manoscritti piugrave antichi delle Tavole facili Tihon 2011 pp 58-59 e per quelle che assume nei papiri Jones 1999 I pp 61-62 Ovviamente non possiamo leggere il segno 65926 come un omicron con una barra in quanto ο = 70 nella notazione greca e la barra egrave di rigore quando il numerale figuri allrsquointerno di un testo Occorre ammettere che si dagrave origine ad un bel corto circuito notazionale con il concepire un segno con funzione di lsquoposto vuotorsquo ma che lsquosomigliarsquo ad una lettera dellrsquoalfabeto sormontata da una barra cioegrave ad un numerale in piugrave quando il lsquoposto vuotorsquo non corrisponda ad un intero ma ad una specie sessagesimale la presenza della barra a priori indistinguibile da quella che sormonta gli interi introduce unrsquoincongruenza con la notazione a mezzo di apici vista nellrsquoitem precedente
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 151
d) Errori di copia La tabella riprodotta nella tav 2b ha una forma simmetrica ma si tratta di una forzatura il grande rettangolo in basso a destra drsquoaltronde assente nella descrizione contiene uno scolio che fa notare come lrsquoultimo resto parziale ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ͵γτνζ´´´´´ κζ´´´´´´ cioegrave 0 0 0 0 0 3357 27 siano ἔγγιστα λ´λ´ δ´δ´ ξ laquocon ottima approssimazione 60 minuti quartiraquo dove si notino gli apici semplici per indicare il pas-saggio allrsquoordinale e il raddoppiamento del sistema segno + apice per significare il plurale Lo scolio debitamente accompagnato dal segno di rimando in forma di simbolo solare egrave stato probabilmente incluso nella tabella proprio allo scopo di renderla simmetrica A sua volta un errore precedente spiega lo spazio eccessivo accordato al rettangolo contenente lo scolio il secondo massimo multiplo ŏ λβ´ ξδ´´ ριβ´´´ σιϛ´´´´ egrave trascritto anche al di sotto del risultato
Passiamo ora alla descrizione del metodo di divisione attribuito a Pappo
ἵνα οὖν ταῦτα συναχθῇ τὰ ἐκ τοῦ μερισμοῦ ὁ εἰρημένος Πάππος εὐδιατύπῳ τινὶ καὶ πρὸς τοῦτο τάξει χρησάμενος ποιεῖται τὴν τῆς συλλήψεως τοῦ ζητουμένου ἀνεύρεσιν οὕτως ἐκθέμενος γὰρ τὸν μέλλοντα μερίζεσθαι τουτέστι τὰς τξ μοίρας ἐν ἀρχῇ ἀφαιρεῖ ἀπ᾽ αὐτῶν τὸν ἐν τῇ σελίδι τυγχάνοντα ἐλάττονα τουτέστι τὸν τδ κβ´ κ´´ ὄντα τῶν ἐγγὺς ἐλασσόνων ὡς πρὸς τοὺς ἐκκειμένους διὸ καὶ γράφει αὐτὸν προγράφων αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε καὶ εὑρίσκων τὰ παρακείμενα αὐτῷ τῷ ἀπογραφέντι ἐν τῷ σελιδίῳ λεπτὰ πρῶτα ν´ συναπογράφεται παρατιθῶν αὐτοῖς τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον ἀνατείνουσαν σημαῖνον τὸ εἶδος ὅτι πρῶτα λεπτά εὑρίσκει οὖν οὕτως τὸ τῶν τξ μέρος τὸ τδ κβ´ κ´´ ὃ μεριζόμενον παρὰ τὰς τξε ιδ´ μη´´ ἡμέρας καὶ ποιοῦν τὸν ἐκ τοῦ μερισμοῦ ἀριθμὸν πρῶτα λεπτὰ ν´ καὶ τὸν λοιπὸν ἀπογραφόμενος τὸν νε λζ´ μ´´ προτάσσει αὐτοῦ τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά τάσσει δὲ καὶ ἁπλῆν τινα διατείνουσαν γραμμὴν ὡς ἀπὸ τοῦ τξ ἐπὶ τὸν ἑξῆς ἐκτεθειμένον ἐγγὺς
1
5
10
1 εὐδιατύπῳ] ZSPC εὐδιατύπωτ M 4 ἀφαιρεῖ] MZSP ἀφ ι C 5 ἐλάττονα] P comp MZSC 6 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | αφ ] αφ ε M ἀφ ZS ἀφαί P ἄφ C | ἀντὶ] om C | ἄφελε] MZSP ἄφ C 8 ἀπογραφέντι] MZSP ἐγγραφέντι C | λεπτὰ πρῶτα] P λε πρωτα SC λεπτῶν πρωτ MZ | παρατιθῶν] MZS παρατιθεὶς C et ex corr m 2 P 9 ᾱ] Z αο P α´ MS α C | ἔχον] MPC ἔχων ZS 9-10 πρῶτα λεπτά] ZP πρωτ λ´λ´ M πρωτα λε S αα λε C 11 ἡμέρας] comp codd | ἀριθμὸν] P et comp MZ καὶ C et comp S 12 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M πρωτ λεπτ(α) Z πρωτ λ εᾱ S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C | ἀπογραφόμενος] MZSP ἐγγραφόμενος C | νε λζ´] MZSP λζ νζ C 13 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | λ οι] MZSC ex λ fecit λ οι P | προσσημαῖνον] MC et προσ- comp ZS προση- P | τὸ] MZC τὰ S et fecit m 2 P 14 ἀπὸ] MZSP πρὸς C ἐλάττονα] P comp MZSC
1 εὐδιατύπῳ] εὐδιατυπώτω K 6-7 αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ] τὸ ἀφ K 8 παρατιθῶν mdash 10 λεπτά] τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ σημαίνουσαν τὸ εἶδος αὐτῶν ὅτι ᾱ λεπτά εἰσιν K | τὸ (sec)] τὰ K 12 πρῶτα] πρώτων K | τε λ ] λ οι` K | προσσημαῖνον mdash
Fabio Acerbi152
ἐλάττονα τὸν τδ κβ´ κ´´ ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις καὶ ταύτην ἐπιδεικνύουσαν τὴν τάξιν τῆς προόδου τῆς ἐκθέσεως ἧστινος κλωμένης γραμμῆς πρὸς τῷ ἐγγὺς ἐλάσσονι ἡ ἀντανάκλασις ἐπὶ τὸν λοιπὸν γέγραπται φερομένη ὡς εἴρηται διὰ τὸ εὔτακτον τῆς προκοπῆς οὕτως τε ποιήσας ἑξῆς τὸ αφ ποιῶν ὃ προσσημαίνει ὡς εἴρηται τὸ ὅτι δεῖ ἀφελεῖν ὁμοίως ἀπὸ τοῦ λοιποῦ καὶ δὴ τὸν ἐγγὺς πάλιν ἐλάσσονα ὡς πρὸς τὴν ἐν τῷ σελιδίῳ ἔκθεσιν εὑρισκόμενον λαμβάνων ἑξῆς προγράφει αὐτὸν ὄντα νδ μζ´ ιγ´´ ιβ´´´ καὶ εὑρίσκει αὐτοῖς παρακείμενα ἐν τῷ σελιδίῳ πρῶτα λεπτὰ θ´ ἅτινα καὶ αὐτὰ προσαπογράφεται σὺν τῇ παρασημειώσει τῶν πρώτων γράφων τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον τὴν ἀνατείνουσαν καὶ ὡς εἴρηται τὴν γραμμὴν πάλιν διὰ τὴν τάξιν κλωμένην κατὰ δευτέραν κλάσιν προσέλκει γινομένου τοῦ μέρους αὐτῆς τούτου παραλλήλου τῷ ἐξ ἀρχῆς
16 ante κλωμένης add ἐπὶ C 18 τε] MZP om SC | αφ ] M ἀφ ZSC ἀφαί P 19 προσσημαίνει] MS προση- ZC et ex corr P | ὅτι] ZP comp MSC 20 δὴ] MZSC διὰ fecit m 2 P 21 πρὸς] MSP et supra lineam C ex ἀπὸ fecit m 2 Z | ιγ´´] MZSP νγ´´ C 22 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M ᾱᾱ λεπτὰ Z άάα λε S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C 23 προσαπο- γράφεται] απο suprascr in comp M 24 ᾱ] ZP α´ MS α C 25 κλάσιν] MP τάξιν ZSC | τοῦ] ZSPC τούτου M 26 τούτου] τοῦ bis ZSPC sed prius erasit m 2 P τοῦ M
mdash 18 προκοπῆς] om K | τε ποιήσας] ποιήσας καὶ K | αφ ] ἀφ K 19 τὸ] om K 21 προ-γράφει] γράφει K 22 σελιδίῳ] α´ σελιδίῳ K | ἅτινα] ἃ K 23 προσαπογράφεται] ἀπογράφεται K | τῶν πρώτων mdash 26 ἐξ ἀρχῆς] om K
lsquoAllo scopo di raccogliere ciograve che risulta dalla divisione il detto Pappo utilizzando anche in questo caso una certa disposizione ben strutturata determina nel modo seguente il lsaquonumerorsaquo cercato preso nel suo insieme collocando73 in testa il lsaquonumerorsaquo che sta per essere diviso cioegrave i 360 gradi iniziali sottrae loro tra i piugrave prossimi dei lsaquonumerirsaquo minori rispetto a quelli esposti quello che si trova essere minore nella colonna (cioegrave 304 22 20) Questo egrave il motivo per cui lo trascrive scrivendogli davanti lrsquoabbreviazio-ne laquosottrraquo per laquosottrairaquo e trovando che 50 minuti primi sono collocati accanto a quello stesso lsaquonumerorsaquo che egrave stato trascritto nella colonna li trascrive al tempo stesso collocando accanto74 ad essi la lettera A con un lsaquotrattorsaquo75 sopra che significa la specie minuti primi Trova dunque in que-sto modo la parte di 360 che egrave 304 22 20 la quale divisa per 365 giorni 14 48 fa il numero lsaquoche risultarsaquo dalla divisione 50 minuti primi Trascrivendo
73 La descrizione egrave strutturata come una procedura Acerbi 201274 Il purismo del correttore del Par gr 2390 di Clostomalle nel Marc gr 314 e
dellrsquoautore della recensione bizantina impone loro di modificare la terminazione ma forme tematiche e contratte di τιθεῖν sono correnti nel greco tardivo
75 Il testo greco ha solo il participio con γραμμήν sottinteso Per il significato del participio si veda il punto 2
15
20
25
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 153
poi il resto 55 37 40 gli pone altresigrave76 a prefisso laquoReraquo che significa laquorestiraquo e dispone anche una certa linea semplice77 che va da 360 al piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori che egrave esposto di seacuteguito 304 22 20 come nello lsaquoschemarsaquo esposto linea che mostra lrsquoordine del percorso dellrsquoesposizione Questa linea spezzata lagrave dove si trova il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori egrave tracciata inflessa allrsquoindietro lsaquoersaquo punta verso il resto come egrave stato detto in vista di una progressione ordinata E cosigrave facendo prendendo di seacuteguito il laquosottrraquo che significa come egrave stato detto laquoche occorre similmente sottrarre dal re-storaquo e ovviamente prendendo di nuovo il lsaquonumerorsaquo che egrave trovato essere il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori in relazione alla disposizione nella colonna ndash 54 47 13 12 ndash lo scrive di seacuteguito e trova che 9 minuti primi sono posti loro accanto nella colonna trascrive78 anche questi con la segnaletica dei primi scrivendo la lettera A con un lsaquotrattorsaquo sopra e come egrave stato detto prolunga di nuovo la linea spezzata in vista di una buona disposizione tramite una seconda inflessione essendo questa sua parte parallela a quella inizialersquo
La descrizione continua con una serie di laquoe cosigrave viaraquo e non fa ulte-riore riferimento alla tabella
1) La forma verbale ἐξεσμένον Egrave il neutro del participio perfetto medio-passivo di ξέω lett laquopialloraquo laquolevigoraquo Si danno tre possibilitagrave si tratta di un termine canonico per quanto non altrove attestato per designare unrsquoabbreviazione oppure lrsquoautore anonimo improvvisa sul piano metaforico come se unrsquoabbreviazione non fosse altro che la paro-la completa lsquoaccorciata a colpi di piallarsquo in maniera opportuna oppure il testo egrave corrotto e srsquoimpone una correzione ad esempio τὸ ἑξῆς μένον laquociograve che sta di seacuteguitoraquo Questrsquoultima strada mi pare chiusa dal senso delle frase lrsquoabbreviazione non lsquosta di seacuteguitorsquo a niente ma anzi precede la perifrasi τὸ ἑξῆς μένον se impiegata semplicemente per rimandare al segno αφ immediatamente seguente costituirebbe un intollerabile solecismo Se accettiamo la prima di queste letture considerando quin-di lrsquoabbreviazione αφ in posizione predicativa abbiamo a che fare con
76 Rendo in questo modo il τε isolato77 La linea egrave laquosempliceraquo in quanto egrave una retta la precisazione intende evidenziare per
anticipazione il carattere lsquonon semplicersquo che essa assumeragrave alla prima inflessione quando diventeragrave una spezzata linee siffatte erano in effetti concepite dallrsquoanonimo e prima di lui da tutta la tradizione matematica greca come una singola linea spezzata nei punti drsquoinfles-sione I due segmenti paralleli menzionati al termine del passo sono orizzontali
78 Il verbo egrave al medio in variatio rispetto ai due che precedono e che seguono egrave il matematico che lsquosirsquo trascrive le cifre
Fabio Acerbi154
uno hapax semantico nella grecitagrave superstite come egrave facile verificare con una ricerca sul TLG in rete La recensione bizantina risolve il pro-blema sopprimendo semplicemente τὸ ἐξεσμένον
2) La notazione per le specie numeriche Nella terminologia matema-tica greca gli ordini sessagesimali sono εἴδη laquospecieraquo numerici essi corri- spondono agli ordini di grandezza nel nostro sistema decimale e indica-no in analogia con il caso geometrico la lsquoformarsquo che assume un numero quadrato cubo ecc Centinaia e migliaia sono quindi degli εἴδη rispet-tivamente quadrati (100 egrave il quadrato di 10) e cubi (1000 egrave il cubo di 10) sono specie numeriche ma non numeri particolari e drsquoaltronde 300 non egrave un quadrato ma 3 item dellrsquoεἶδος lsquoquadratorsquo 100 3 egrave il numerale di molteplicitagrave della specie quadrata lsquocentinaiarsquo i due 0 che seguono il 3 segnalano esattamente questo fatto che la notazione greca per gli interi non posizionale fa scomparire al livello denotativo Ciograve non vale soltan-to per i numeri interi ma anche per le loro parti i minuti secondi appar-tengono alla specie lsquoquadratorsquo in quanto 13600 egrave il quadrato di 160
La concezione appare interamente dispiegata nellrsquointroduzione degli Arithmetica diofantei79 che si rivela giova farlo rimarcare un te-stimone fondamentale per la ricostruzione della notazione matematica antica Alle specie usate in questrsquoopera vengono assegnati una denomi-nazione ed un segno convenzionale costituito dallrsquoiniziale (di ognuno dei componenti) della denominazione al quadrato o δύναμις il segno ΔΥ al κύβος il segno ΚΥ alla lsquoquarta potenzarsquo o δυναμοδύναμις il segno ΔΥΔ ecc La descrizione di tali segni egrave del tipo καὶ ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον Κ ἐπίσημον ἔχον Υ ΚΥ κύβος laquoe il suo segno egrave un Κ che ha come indice un Υ ΚΥ cuboraquo dove in accordo con quanto abbiamo visto nel punto b supra e pur nel comprensibile imbarazzo del copista della prima parte del Matritensis (o di un suo passato collega) a districarsi in questo formidabile ginepraio notazionale80 le due lettere Κ e Υ ricevono una barra mentre ΚΥ non la richiede a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον il quale ancora una volta esclude automaticamente il segno dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
79 In particolare a DOO I pp 214-62180 Nel Matr 4678 riscontriamo i seguenti fenomeni nelle poche righe a cavallo dei ff
58r-v 1) accento acuto posto su tutti i segni come se fossero abbreviazioni 2) ripetizione sistematica segnodenominazione come in ΚΥ κύβος appena letto dovuta sicuramente allrsquointrusione di glosse interlineari esplicative dei segni ndash e successivo pentimento (δύναμις e κύβος sono in effetti cancellati dalla prima mano il primo con un tratto il secondo con dei punti supra lineam poi il copista si stanca di correggere) 3) nella descrizione del segno per la δυναμοδύναμις menzione di un δέλτα δύο che saragrave molto probabilmente stato ΔΔ subito dopo nella descrizione del κυβόκυβος si legge un incongruo δύο KK
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 155
Diofanto introduce poi dei segni anche per le specie delle parti dellrsquounitagrave (le nostre frazioni) che egli chiama ὁμώνυμα μορία laquoparti omonimeraquo di cui quelle sessagesimali sono casi particolari81 Egli spie-ga appunto che le loro denominazioni sono ottenute da quelle delle specie degli interi per sinonimia passando ad un lsquoordinalersquo82 formato semplicemente aggiungendo il suffisso -στον δυναμοστόν κυβοστόν δυναμοδυναμοστόν ecc (sott μόριον) I loro segni convenzionali sono invece ottenuti da quelli per le specie degli interi aggiungendo una γραμμὴν διαστέλλουσαν τὸ εἶδος laquolinea che distingue la specieraquo83 Una linea sui segni delle specie delle parti egrave richiesta si badi bene per distinguerli dai segni di quelle degli interi come giagrave osservato questi ultimi sono giagrave lsquoagrammaticalirsquo a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον a fortiori lo saranno anche i primi Si tratta della traduzione semio-tica del passaggio dal cardinale allrsquoordinale che a livello grammaticale egrave effettuato con il suffisso -στον Che forma ha questa linea Barra o apice (Egrave cervellotico pensare a forme piugrave complesse) La domanda non ammette una risposta immediata in quanto delle specie diofantee nessuno piugrave si occupa nellrsquoantichitagrave84 Se egrave vero che la prima risposta darebbe origine ad un conflitto tra due convenzioni denotative diffe-renti la barra lsquocitazionalersquo e la barra che distingue la specie lrsquoevidenza grafica del Matritensis lascia lievemente sgomenti (ricordiamoci che giagrave i segni di base sono indebitamente dotati di un accento dal copista) Le poche occorrenze del segno per le specie delle parti85 vedono lrsquoaggiunta di uno slash di sospensione di un doppio apice inverso ndash in tutta evi-
81 Questo fatto era giagrave chiaro nellrsquoantichitagrave Teone in Alm I 10 in iA p 45310-1682 Il parallelo con i cardinali e gli ordinali relativi agli interi egrave reso esplicito da Dio-
fanto ὥσπερ δὲ τῶν ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια παρομοίως καλεῖται τοῖς ἀριθμοῖς τοῦ μὲν τρία τὸ τρίτον τοῦ δὲ τέσσαρα τὸ τέταρτον οὕτως καὶ τῶν νῦν ἐπονομασθέντων ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια κληθήσεται παρομοίως τοῖς ἀριθμοῖς laquocome le parti omonime dei numeri sono chia-mate per assonanza con i numeri di lsquotrersquo lsquolsaquounrsaquo terzorsquo di lsquoquattrorsquo lsquolsaquounrsaquo quartorsquo cosigrave le parti omonime dei numeri appena nominati saranno chiamate per assonanza con i numeriraquo (DOO I p 69-13 si noti lrsquoarticolo lsquocitazionalersquo al singolare in τοῦ τρία e τοῦ τέσσαρα) Il parallelo prosegue anche al livello dei segni che rappresentano queste specie come vedremo tra un attimo
83 Diofanto Arithmetica prefazione in DOO I p 620-21 un passaggio maltrattato in questa edizione occorre espungere il participio ἔχον senza introdurre segni ulteriori oppure eliminare un precedente ἐπί come fa un correttore del Matritensis f 58v
84 Unica parzialissima eccezione lrsquoaccenno di Teone menzionato nella nota 81 supra85 Al f 59r e per di piugrave nel margine per sanare un lungo saut du mecircme au mecircme La
collocazione in margine egrave il motivo per cui troviamo una notazione abbreviata nel resto del trattato il primo copista scioglie tutti i segni prendendoli per abbreviazioni mentre il secondo elimina sistematicamente il tratto aggiuntivo delle specie delle parti dellrsquounitagrave Drsquoaltronde egli scrive ad esempio ΔΥ invece di ΔΥ ed egrave quindi indotto a porre la barra al di sopra della stringa di lettere risultante (passim ma si veda ad esempio il f 72r)
Fabio Acerbi156
denza il compendio per la desinenza -ον accentata il copista interpreta il segno come unrsquoabbreviazione ndash e di una barra a sormontare lo Υ Potremmo forse interpretarlo come il segno di contrazione del grafema -στ- lrsquounico tassello mancante in unrsquoabbreviazione come ad esempio (δυναμοδυναμο)(στ)(ὸν) ma uno scolio di prima mano al f 58v rela-tivo alle specie degli interi inficia questrsquoipotesi esse sono dotate di slash di sospensione accento acuto in un caso del compendio canonico per la terminazione -ον hellip ma tutti gli Υ a esponente sono a loro volta sormontati da una barra
Meno legata al singolo manoscritto ma nondimeno non uniforme si presenta la pratica di notazione dei segni che rappresentano gli enti numerici sessagesimali86 da una parte sta lrsquoevidenza del testo dei Pro-legomena e delle sue tabelle apici ndash drsquoaltronde come abbiamo visto la notazione universalmente impiegata per i numerali ordinali e per le fra-zioni unitarie ndash dallrsquoaltra sta lrsquoevidenza del testo dellrsquoAlmagesto in tutti i manoscritti piugrave antichi e lo stesso si dica del commentario teonino a questrsquoopera o del suo lsquoGrande commentariorsquo alle Tavole facili e dei testi astronomici su papiro barre87 Sembra insomma che la nostra docu-
86 Sia le molteplicitagrave che le specie ahimeacute entrambe rappresentate da lettere dellrsquoalfabeto Come osservato allrsquoinizio della sezione 3 ci sono in effetti due tipi di lettere numerali in gioco se facciamo astrazione da apici o barre lsquo4 minuti secondirsquo si trova scritto δ β la prima lettera numerale denota la molteplicitagrave degli item di una certa specie la se-conda la specie nei Prolegomena entrambe sono accompagnate da un doppio apice il che rende inutile la presenza delle seconde Si noti che la descrizione della tabella non fa parola della notazione da usare per le lettere numerali che denotano la molteplicitagrave barre o apici e quanti apici hellip In questo caso fa interamente fede la tabella cioegrave la pratica grafica condivisa instauratasi non egrave chiaro quando
87 I manoscritti piugrave antichi dellrsquoAlmagesto sono menzionati nella nota 10 supra quelli dei due commentarii teonini sono il Laur Plut 2818 e il celeberrimo Vat gr 190 (sec IX in Euclide Elementi Data Teone lsquoGrande commentariorsquo) per la notazione dei pa-piri astronomici si veda Jones 1999 II passim La notazione non sembra lsquoinquinatarsquo dalla pratica dei copisti bizantini e pare dipendere soltanto dalla data di composizione Tro-viamo ad esempio barre sopra tutti i numerali di molteplicitagrave (interi o sessagesimali) nel frammento di un commentario alle Tavole facili contenente un calcolo relativo al 24 aprile 213 (Par gr 2841 sec XIII ex-XIV in oltre al frammento ai ff 32r l 11-34v l 23 contiene Arato Phaenomena ed Efestione Apotelesmatica edizione in Jones 1990) Nel commentario alle Tavole facili composto ca 610-617 ed attribuito a Stefano di Alessandria la situazione egrave la seguente (Jean Lempire per litteras per lrsquoedizione si veda Lempire 2014 ho controllato il Vat gr 304 ff 135r-171v sec XIV am contiene in aggiunta Teone in Almagestum I-II lsquoPiccolo commentariorsquo alle Tavole facili Diofanto Arithmetica e De polygo-nis numeris varia astronomica tabulae) barre sopra gli interi sporadicamente rimpiazzate da apici apici sopra le parti sessagesimali in numero uguale alla denominazione doppio () apice per le frazioni unitarie Sono impiegate barre sopra gli interi e apici sopra le parti sessagesimali nei manoscritti principali di tutti i trattati di introduzione allrsquoAlmagesto o comunque di argomento logistico redatti in epoca bizantina Giorgio Pachimere (1242-ca 1310) Quadrivium (autografo nel manoscritto Roma Biblioteca Angelica gr 38 [RGK III nr 115] si veda Tannery ndash Steacutephanou 1940 per lrsquoedizione) Teodoro Metochita (1270-
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 157
mentazione si faccia testimone di un cambio notazionale avvenuto nel periodo intercorrente fra Teone (sec IV pm) e la scuola alessandrina di Ammonio e dei suoi allievi (sec VI in) e probabilmente innescato da questrsquoultimo ambiente lrsquoaspetto paradossale egrave che nello stesso codice si rintraccino due notazioni differenti per gli enti numerici sessagesimali e lrsquouna (apici) sia adottata sistematicamente e coerentemente in uno scritto (i Prolegomena) che si presenta esattamente come unrsquointroduzione tecnica alla pratica numerico-algoritmica del trattato (lrsquoAlmagesto) in cui egrave adottata lrsquoaltra (barre che ritroviamo senza eccezioni anche negli scolii)
Torniamo ai Prolegomena la descrizione del segno da porre a fianco di ogni singolo quoziente parziale e denotante la sua specie numerica (minuti primi minuti secondi ecc) solleva tre problemi
Primo problema Ci vuole una barra o un apice su τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquola lettera A [hellip] che significa la specieraquo quando lo scriviamo nella tabella Tutta la nostra discussione precedente fa pro-pendere per lrsquoapice e si ricordi anche la forma verbale ἀνατείνουσαν che suggerisce qualcosa che si lsquoestende verso lrsquoaltorsquo (la mia traduzione egrave volutamente neutra) se fosse apposta una barra la cosa dovrebbe passare
1231332) Compendium astronomicum (copia lsquoautorizzatarsquo coeva nei Vat gr 182 e 181 da parte del copista che integrograve le parti mancanti del Par gr 2389 [ff 207-210 255-270 374-375] Bianconi 2005a pp 425-427 Peacuterez Martiacuten 2008 p 436 e n 177) Teodoro Meliteniota (morto lrsquo831393) Tribiblos astronomica (autografo nel Vat gr 792 si vedano Leurquin 1991 per unrsquoanalisi del manoscritto Leurquin 1990 per lrsquoedizione) una com-pilazione anonima (per cui ho consultato il Par gr 2396 ff 87r-92v limitatamente a questi fogli manu Costantino Trivoli [RGK II nr 318 ma ovviamente questo codice non vi egrave segnalato] terzo quarto del XV secolo il resto del codice annotato da Niceforo Gregora egrave di etagrave planudea e parzialmente [ff 33v-76v] un autografo di Planude stesso contiene Teone in Almagestum I II IV Mondrain 2002 il codice va completato ndash limitatamente a stralci dei libri VIII-X XII-XIII del commentario teonino la cui parte intermedia si egrave persa ndash con 26 carte [ff 123-147] inserite nel Vat gr 1087 anchrsquoesso contenente anno-tazioni di Gregora Rome 1927 per la figura del copista dei ff 77r-86r del Par gr 2396 e dei ff appena nominati del Vat gr 1087 un anonimo collaboratore di Gregora si veda in ultimo Bianconi 2006a pp 147-151) si veda anche il calcolo effettuato da Niceforo Gre-gora (12921295-13581361) dellrsquoeclisse di sole del 16 luglio 1330 (attestata unicamente ai ff 1r-8v della miscellanea astronomica Marc gr 325 databile ca 1324-1329 in parte vergata e ovunque fittamente annotata da Gregora stesso edizione del testo in Mogenet et al 1983 annotazioni di Gregora elencate in Bianconi 2005a p 413) Unrsquoeccezione apparente il lsquoPiccolo commentariorsquo di Teone alle Tavole facili le parti sessagesimali sono segnalate da apici (ad esempio nel Vat gr 175 vergato da Giovanni Catrario e completato nel 1321-1322 sulla figura di Catrario si vedano in ultimo Bianconi 2005b pp 141-156 e 2006b) lrsquoopera egrave antica ma la sua tradizione non rimonta oltre la fine del XIII secolo a parte un frammento nel Leiden BPG 78 ff 156r-161v (minuscola del IX-X secolo) e in effetti in questo manoscritto tutti i numerali di molteplicitagrave sono sormontati da barre Unrsquoeccezione effettiva egrave il De hypotesibus planetarum nel Vat gr 1594 barre sugli interi e apici sulle parti sessagesimali
Fabio Acerbi158
sotto silenzio e la presenza dellrsquoapice la rende inutile88 Si tratta della stessa convenzione diofantea e coincide ancora con la notazione per i numerali ordinali e per le frazioni unitarie che egrave corrente nei mano- scritti matematici greci per questo motivo non percheacute la descrizione sia particolarmente perspicua nessuno dei copisti della recensione an-tica ha incertezze apici Ma questi apici si rintracciano soltanto sulle indicazioni di specie non contemplate dalla descrizione che sono ante-poste ai resti parziali a fianco dei quozienti parziali i segni di specie sono invece trasformati in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordi-nali corrispondenti del tipo πρωτ tavv 5 e 7b-8 Il recensore bizantino taglia invece la testa al toro elimina dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali elimina la seconda menzione della laquolet-tera Araquo contestualmente allrsquoazzeramento dellrsquoespediente della linea a zig-zag (si veda il punto seguente) modifica la descrizione che contiene la prima menzione in quella dellrsquoapice associato direttamente ai nume-rali di molteplicitagrave riciclando addirittura lrsquoalpha per adibirlo a desi-gnare un numero cardinale (come sorprendersi) τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ laquoponendo al di sopra di essi [scil dei 50 minuti primi] 1 solo lsaquoaccentorsaquo acutoraquo La scelta del recensore egrave assennata che rechi una barra o un apice in una tabella un alpha denota un numero non un numero drsquoordine
Secondo problema da tenere ben distinto dal precedente Cosa ci vuole sul segno α per la lettera alpha menzionata nella frase τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquolettera A [hellip] che significa la specieraquo89 Unrsquooc-chiata allrsquoapparato critico rivela una bella incertezza nei manoscritti Z scrive sempre ᾱ e in un caso lo fa anche P MS optano sempre per α´ C per α P scrive nellrsquoaltro caso αο Per quanto solo la barra sia congrua con il senso della frase in quanto la lettera alpha egrave qui menzionata (si tratta di un oggetto che compare nella tabella) e non cambia niente se essa egrave accompagnata dal suo nome di genere στοιχεῖον ad un livello grafico lrsquoincertezza fra il segno ᾱ che denota laquola lettera αraquo e il segno α´ (o lrsquoabbreviazione αο) per una forma di πρῶτος egrave per piugrave versi giustificata
88 Detto in altri termini la barra egrave uno strumento grafico non matematico e quindi la sua presenza non va segnalata mentre un apice lo egrave e la sua presenza lo deve
89 Notare che in questa frase il primo α non vuole la barra (egrave menzionato allrsquointerno di una frase che impiega convenzioni moderne) il secondo sigrave (idem ma con convenzioni antiche) ndash e nella traduzione la scelta di denotarlo con A (senza virgolette) e non con lsquoArsquo (con virgolette) egrave del tutto arbitraria ndash si noti inoltre che le necessarie precisazioni laquosenzacon virgoletteraquo mostrano che le lingue moderne palesano difficoltagrave analoghe a quelle del greco antico per quanto riguarda i livelli denotativi in ambito metadiscorsivo per non usare le due parentetiche avrei dovuto scrivere rispettivamente lsquoArsquo e lsquolsquoArsquorsquo (doppie virgolette semplici)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 159
ᾱ coincide con il numerale 1 α egrave la prima lettera dellrsquoalfabeto ed inoltre α´ egrave esattamente quello che va scritto nella tabella Potremmo dirci che il sostantivo στοιχεῖον chiude la questione la sua presenza congiunta ad un ipotetico α´ renderebbe la descrizione ridondante o inappropriata90 Ma a parte il fatto che α egrave proprio τὸ πρῶτον στοιχεῖον il segno α´ cat-tura in fondo il cuore della descrizione di uno στοιχεῖον ἔχον lsaquoγραμμὴνrsaquo ἀνατείνουσαν
Terzo problema Lrsquoautore dei Prolegomena che si arresta allrsquoesem-pio dei minuti primi non dice quanti apici occorre mettere sulle lettere numerali che identificano gli ordini superiori al primo se uno soltanto come nel caso diofanteo e delle frazioni unitarie o in numero uguale alla loro denominazione (cioegrave pari al numero denotato dal numerale stesso su cui vanno posti) come effettivamente avviene nei mano-scritti dei Prolegomena La tabella egrave quindi sottodeterminata dalla sua descrizione anzi in un certo senso prende il sopravvento su di essa la pratica di marcare i numerali di molteplicitagrave con gli apici che compe-tono allrsquoordine cui appartengono viene trasferita ai segni per gli ordini stessi per supplire ad una descrizione carente di questi ultimi E la tabella egrave sottodeterminata dalla descrizione in quanto egrave la descrizione di una tabella reale ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις laquocome nello lsaquoschemarsaquo espostoraquo leggiamo a un certo punto del testo
3) La linea a zig-zag Non possiamo che applaudire a questo geniale espediente grafico lo troviamo messo in opera solo nel Marc gr 313 Per quanto lrsquoautore non faccia parola di ciograve nel corso della sua descrizione la linea spezzata egrave intesa dover lsquosaltarersquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue Il copista del codice marciano effettua correttamente due salti nella prima delle sue tabelle (tav 4) ma inserisce un lsquodentersquo in piugrave in quella che considera corretta (tav 5) La linea a zig-zag egrave incompatibile con la presenza di linee di giustificazione nella tabella che in effetti mancano nel Marc gr 313 ciograve induce gli errori di allineamento dei primi 5 quozienti parziali di cui egrave vittima il copista Probabilmente per questo motivo in nessuno degli apografi del Vat gr 1594 la linea a zig-zag figura nella tabella inquadrata come si conviene da una (doppia) cornice esterna e le cui colonne sono appunto separate da linee verticali (tav 7b Vat gr 184 f 17v e tav 8 Par gr 2390 f 9v cui egrave sostanzialmente identica la tabella del Marc gr 314 che si trova
90 Trascuro lrsquoabbreviazione αο = πρῶτος percheacute la desinenza non egrave quella richiesta neacute nella frase (egrave richiesto πρῶτον) neacute nella tabella (πρῶτα)
Fabio Acerbi160
al f 248r ndash ma la mancanza di linee orizzontali causa un gigantesco pa-sticcio nel codice vaticano) Alla recensione bizantina che dipende per il suo testo di base dal Vat gr 1594 e quindi non trova la linea a zig-zag nella tabella non resta che sopprimere la sua descrizione ndash ma proprio per questo motivo e finalmente diventa possibile tracciare un apparato completo di linee di giustificazione (tav 9 Laur Plut 89 sup 48 f 14v) Dato che la descrizione di Teone di questo procedimento di divi-sione non fa cenno allrsquoesistenza della linea a zig-zag viene da chiedersi se essa non costituisca un espediente escogitato dallrsquoautore dei Prolegomena per vivacizzare la procedura originale di Pappo
4) Discrepanze tra descrizione e tabella Il gioco delle minime va-rianti mostra che la divisione era stata eseguita (e trasmessa) corret-tamente tutti i valori numerici sono esatti La tabella nel Marc gr 313 presenta perograve alcune discrepanze con la propria descrizione Essa omette (ma non nella versione lsquoscorrettarsquo lrsquoomissione non si riscontra neanche nel Par gr 2390) il segno per laquorestoraquo di fronte ai resti par-ziali ma aggiunge lrsquoindicazione della loro specie Essa trasforma invece come abbiamo visto le indicazioni di specie che seguono i quozienti parziali in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordinali corri-spondenti La descrizione prevede di chiudere la tabella con il risultato καὶ συνάγων ἅπαντα τὰ ἐκ τῶν μερισθέντων μερῶν λεπτὰ σημειοῦται ὑπὸ πάντας οὕτως γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoe raccogliendo tutti i minuti che provengono dalle parti divise lsaquoPapporsaquo nota sotto tutto cosigrave Ris 0 59 8 17 13 12 31raquo ma sotto la tabella tutta la tradizione ci consegna qualcosa di piugrave articolato ὁ ζητούμενος καθ᾽ ὃν μερίζεται ὁ τξε ιδ´ μη´´ π(αρὰ) τὸν τξ γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoil lsaquonumerorsaquo cercato secondo cui 365 14 48 egrave diviso per 360 risulta 0 59 8 17 13 12 31raquo frase che del resto contiene due errori lrsquoinversione del dividendo e del divisore e la confusione tra segno convenzionale (iuxta descrizione) e abbreviazione (come nella frase) nel caso di γι Oltre ad eliminare la linea a zig-zag91 la recensione bizantina sopprime dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali e modifica come abbiamo visto al punto 2 le loro descrizioni in quelle di apici associati diretta-mente ai numerali di molteplicitagrave
91 Le due righe che nella recensione di base contengono solo i resti parziali minori di 160 del divisore ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue sono in parte completate con lrsquoindicazione abbreviata ἀνάλ(υσις) laquoanalisiraquo il termine greco per questa procedura di riduzione In un sussulto di ipercorrettismo matematico tali resti parziali ridotti non sono preceduti dal segno per laquorestoraquo come nel Par gr 2390 ma da quello per laquorisultatoraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 161
Gli esempi che abbiamo discusso mostrano come i problemi di notazione pesino e non poco sullrsquoespressione discorsiva di un algorit-mo matematico lrsquoente di riferimento per lsquoformularersquo il procedimento di divisione fu considerata la tabella cioegrave un oggetto la cui costitu-zione egrave legata piugrave ad una pratica grafica che a considerazioni logico- algoritmiche non la sua descrizione che in effetti finisce per determi-nare la tabella in maniera non univoca Di questa sottodeterminazione si fa testimone la traiettoria che abbiamo cercato di seguire nelle mani di copisti e revisori il procedimento di divisione si modifica a volte in aspetti secondari a volte in punti piugrave sostanziali ndash fino a rendere neces-saria una radicale revisione della sua descrizione per renderla conforme alla tabella ndash in ogni caso mai per ragioni squisitamente matematiche92
Abstract
The article presents and discusses in detail two passages from the anonymous Prolegomena to the Almagest a VIth century primer to the elementary procedures of calculation needed in Ptolemyrsquos Almagest In the two passages we may follow the complex interplay between mathematical notation the auctor who employed and described it the tachygrapher who transcribed it in vivo copyists who reproduced it correctors who modified it Along this path misgivings and errors arise in the transmission of abbreviations and paratextual units such as diagrams tables operational schemes
Fabio AcerbiCNRS UMR8560 Centre Alexandre Koyreacute
fabacerbigmailcom
92 Sono grato a Daniele Bianconi Lucio del Corso Jean Lempire per alcune preziose indicazioni
AOO = Archimedis opera omnia cum commentariis Eutocii ed J L Heiberg I-III Lipsiae 1910-1915
DOO = Diophanti Alexandrini opera omnia cum Graecis commentariis ed P Tannery I-II Lipsiae 1893-1895
GC = Le laquoGrand Commentaireraquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Mogenet ndash A Tihon I-III Cittagrave del Vaticano 1985-1999
iA = Commentaires de Pappus et de Theacuteon drsquoAlexandrie sur lrsquoAlmageste ed A Rome I-III con paginazione continua Cittagrave del Vaticano 1931-1943
HOO = Heronis Alexandrini opera quae supersunt omnia ed G Schmidt ndash L Nix ndash W Schmidt ndash H Schoene ndash J L Heiberg I-V Lipsiae 1899-1914
PC = Le ldquoPetit Commentairerdquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed A Tihon Cittagrave del Vaticano 1978
POO = Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia ed J L Heiberg I-II in 3 parti Lipsiae 1898-1907
RGK = Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600 I Handschriften aus Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln II Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs und Nachtraumlge zu den Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln III Handschriften aus Bibliotheken Roms mit dem Vatikan A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg unter Mitarbeit von D Harlfinger und P Eleuteri B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln Wien 1981-1997 (Oumlsterreichische Akademie der Wissenschaften Veroumlffentlichungen der Kommission fuumlr Byzantinistik III1-3 A-C)
Sigla
Acerbi 2010 = F Acerbi Il silenzio delle sirene La matematica greca antica Roma 2010
Acerbi 2012 = F Acerbi I codici stilistici della matematica greca dimostrazioni procedure algoritmi laquoQUCCraquo 1012 (2012) pp 167-214
Acerbi et al 2010 = F Acerbi ndash N Vinel ndash B Vitrac Les Proleacutegomegravenes agrave lrsquoAlmageste Une eacutedition agrave partir des manuscrits les plus anciens Introduction geacuteneacuterale ndash Parties I-III laquoSCIAMVSraquo 11 (2010) pp 53-210
Agati 1992 = M L Agati La minuscola laquoBouleteacuteeraquo Cittagrave del Vaticano 1992
Belger 1881 = C Belger Ein neues Fragmentum mathematicum Bobiense laquoHermesraquo 16 (1881) pp 261-284
Bianconi 2005a = D Bianconi La biblioteca di Cora tra Massimo Planude e Niceforo Gregora Una questione di mani laquoSampTraquo 3 (2005) pp 391-438
Bianconi 2005b = D Bianconi Tessalonica nellrsquoetagrave dei Paleologi Le pratiche intellettuali nel riflesso della cultura scritta Paris 2005
Bianconi 2006a = D Bianconi Le pietre e il ponte ovvero identificazioni di mani e storia della cultura laquoBizantinisticaraquo 8 (2006) pp 135-181
Bianconi 2006b = D Bianconi Qualcosa di nuovo su Giovanni Catrario laquoMEGraquo 6 (2006) pp 69-91
Cavallo 1977 = G Cavallo Funzione e strutture della maiuscola greca tra i secoli VIII-XI in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Colloque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 95-137
Cereteli 1904 = G F Cereteli De compendiis scripturae codicum Graecorum praecipue Petropolitanorum et Mosquensium anni nota instructorum Sankt-Petersburg 1904
De Gregorio 2000 = G De Gregorio Materiali vecchi e nuovi per uno studio della minu-scola greca fra VII e IX secolo in G Prato (a cura di) I manoscritti greci tra riflessione e dibattito Atti del V Colloquio Internazionale di Paleografia Greca Cremona 4-10 ottobre 1998 Firenze 2000 pp 83-151
Follieri 1977 = E Follieri La minuscola libraria dei secoli IX e X in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Col-loque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 139-165
Fonkič 2005 = B Fonkič Venecianskaia rukopisrsquo laquoAlrsquomagestaraquo Ptolemeja (Marc gr 313690) o datirovke i proischoždenii kodeksa laquoVDIraquo s III 254 (2005) pp 162-167
Fowler 1999 = D H Fowler The Mathematics of Platorsquos Academy A New Reconstruction Second Edition Oxford 1999
Bibliografia
Fabio Acerbi164
Gerstinger ndash Vogel 1932 = H Gerstinger ndash K Vogel Eine stereometrische Aufgaben-sammlung im Papyrus Graecus [sic] Vindobonensis 19996 laquoMitteilungen aus der Papy-russammlung der Nationalbibliothek in Wienraquo Neue Serie Folge 1 Griechische literarische Papyri 1 Wien 1932 pp 11-76
Heiberg 1927 = Mathematici Graeci Minores ed J L Heiberg Kjoslashbenhavn 1927
Hultsch 1876-1878 = Pappi Alexandrini Collectionis quae supersunt ed F Hultsch I-III Berlin 1876-1878
Janz 2003 = T Janz The Scribes and the Date of the Vat gr 1291 in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae X Cittagrave del Vaticano 2003 pp 159-180
Jones 1990 = Ptolemyrsquos First Commentator ed A Jones Philadelphia 1990
Jones 1999 = Astronomical Papyri from Oxyrhynchus ed A Jones I-II Philadelphia 1999
Jones 2005 = A Jones Ptolemyrsquos Canobic Inscription and Heliodorusrsquo Observation Reports laquoSCIAMVSraquo 6 (2005) pp 53-97
Lempire 2014 = Steacutephanos drsquoAlexandrie Le commentaire aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Lempire Louvain 2014
Leurquin 1990 = Theacuteodore Meacuteliteacuteniote Tribiblos astronomique Livre I ed R Leurquin Amsterdam 1990
Leurquin 1991 = R Leurquin Un manuscrit autographe de la Tribiblos Astronomique de Theacuteodore Meacuteliteacuteniote le Vaticanus graecus 792 laquoScriptoriumraquo 45 (1991) pp 145-162
Maas 1927 = P Maas Griechische Palaeographie in A Gercke ndash E Norden (hrsg von) Einleitung in die Altertumswissenschaft I9 Leipzig 1927 pp 69-80
Martinelli Tempesta 2010 = S Martinelli Tempesta Il codice Milano Biblioteca Am-brosiana B 75 sup (gr 104) e lrsquoevoluzione della scrittura di Giovanni Scutariota in A B Garciacutea ndash I Peacuterez Martiacuten (ed by) The Legacy of Bernard de Montfaucon Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting Proceedings of the Seventh Inter-national Colloquium of Greek Palaeography Madrid-Salamanca 15-20 September 2008 Turnhout 2010 pp 171-186
Mazzucchi 1994 = C M Mazzucchi Leggere i classici durante la catastrofe (Costantino-poli maggio-agosto 1203) le note marginali al Diodoro Siculo Vaticano gr 130 Parte prima stratigrafia laquoAevumraquo 68 (1994) pp 164-218
Mioni 1976 = E Mioni Bessarione scriba e alcuni suoi collaboratori in Miscellanea marcia-na di studi bessarionei Padova 1976 pp 263-323
Mioni 1985 = Codices graeci manuscripti Bibliothecae Divi Marci Venetiarum II Thesaurus Antiquus Codices 300-625 recensuit E Mioni Roma 1985
Mogenet 1962 = J Mogenet Une scholie ineacutedite du Vat gr 1594 sur les rapports entre lrsquoastronomie arabe et Byzance laquoOsirisraquo 14 (1962) pp 198-221
Mogenet et al 1983 = Niceacutephore Greacutegoras Calcul de lrsquoeacuteclipse de soleil du 16 juillet 1330 ed J Mogenet ndash A Tihon ndash R Royez ndash A Berg Amsterdam 1983
Mondrain 2002 = B Mondrain Maxime Planude Niceacutephore Greacutegoras et Ptoleacutemeacutee laquoPa-laeoslavicaraquo 10 (2002) pp 312-322
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 165
Mondrain 2004 = B Mondrain Lrsquoancien empereur Jean VI Cantacuzegravene et ses copistes in A Rigo (a cura di) Gregorio Palamas e oltre Studi e documenti sulle controversie teologiche del XIV secolo bizantino Firenze 2004 pp 249-296
Mondrain 2007 = B Mondrain Les eacutecritures dans les manuscrits byzantins du XIV e siegravecle Quelques probleacutematiques laquoRSBNraquo n s 44 (2007) pp 157-196
Peacuterez Martiacuten 2006 = I Peacuterez Martiacuten Maxime Planude et le Diophantus Matritensis (Madrid Biblioteca Nacional ms 4678) un paradigme de la reacutecupeacuteration des textes anciens dans la ldquorenaissance paleacuteologuerdquo laquoByzantionraquo 76 (2006) pp 433-462
Peacuterez Martiacuten 2008 = I Peacuterez Martiacuten El lsquoestilo Hodegosrsquo y su proyeccioacuten en las escrituras constantinopolitanas laquoSampTraquo 6 (2008) pp 389-458
Perria 1991 = L Perria Scrittura e ornamentazione nei codici della laquocollezione filosoficaraquo laquoRSBNraquo n s 28 (1991) pp 45-111
Rollo 2012 = A Rollo LrsquoArchimede di Giorgio Valla in V Fera ndash D Gionta ndash A Rollo (a cura di) Archimede e le sue fortune Atti del Convegno di Siracusa-Messina 24-26 giugno 2008 Messina 2012 pp 99-147
Rome 1927 = A Rome Membra disjecta laquoRBenraquo 39 (1927) pp 187-188
Rome 1938 = A Rome Un manuscrit de la bibliothegraveque de Boniface VIII agrave la Meacutediceacuteenne de Florence laquoACraquo 7 (1938) pp 261-268
Ronconi 2013 = F Ronconi La collection philosophique un fantocircme historique laquoScripto-riumraquo 67 (2013) pp 119-140
Tannery ndash Steacutephanou 1940 = Quadrivium de Georges Pachymegravere ed P Tannery ndash E Steacutephanou Cittagrave del Vaticano 1940
Tihon 2011 = Πτολεμαίου Πρόχειροι Κανόνες Les Tables faciles de Ptoleacutemeacutee vol Ia Tables A1-A2 ed A Tihon Leuven 2011
Traube 1907 = L Traube Nomina Sacra Versuch einer Geschichte der christlichen Kuumlrzung Muumlnchen 1907
Vogel 1936 = K Vogel Beitraumlge zur griechischen Logistik laquoSBAWraquo Mathematisch-natur-wissenschaftliche Abteilung Jahrgang 1936 pp 357-472
Wouters 1979 = A Wouters The Grammatical Papyri from Graeco-Roman Egypt Contri-butions to the Study of the lsquoArs Grammaticarsquo in Antiquity Brussel 1979
F ACERBI Tav 1
b Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 65r
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 284 f 160r
F ACERBITav 2
b Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 13r
a Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 19v
F ACERBI Tav 3
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 136v
F ACERBITav 4
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17r
F ACERBI Tav 5
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17v
F ACERBITav 6
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 7v
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 125
sto grafico in cui collocare le testimonianze saragrave opportuno ritornare sullrsquoargomento se non altro per ampliare la gamma degli esempi o raf-finare la casistica
Intendo con lsquoparatesto matematico primariorsquo ogni sistema orga-nizzato di segni contenuto originariamente in unrsquoopera matematica e differente dalla stringa di lettere alfabetiche denotative o numerali3 che si struttura in discorso di senso compiuto Questrsquoultimo costituisce il lsquotestorsquo propriamente detto Tale sistema organizzato ha normalmente un significato ed unrsquoimportanza nellrsquoeconomia dellrsquoopera e li assume in riferimento implicito o esplicito al testo Possiamo in prima battuta distinguerne tre tipologie diagrammi tavole tabelle operazionali Le descriverograve brevemente con particolare attenzione al loro formato e alla messa in pagina che ne consegue
1) Diagrammi Un lsquodiagrammarsquo egrave una figura di norma dotata di lettere denotative che rappresenta la configurazione geometrica speci-fica di una proposizione matematica Si tratta di un ente grafico dalla funzione puramente referenziale egrave descritto allrsquoinizio della proposi-zione come entitagrave individuale4 e a sua volta raffigura la configurazione geometrica egrave impossibile trarne indicazioni deduttive univoche senza la guida del testo I manoscritti piugrave antichi presentano i diagrammi tracciati in indentazioni (lsquospecchirsquo) del testo di norma poste allrsquoinizio della proposizione seguente Abbiamo motivo di supporre che questo stato di cose rifletta la convenzione di mise en rouleau originaria ndash la descrizione della configurazione geometrica non egrave piugrave lsquosottrsquoocchiorsquo man mano che il rotolo viene svolto con il procedere della dimostrazione ed occorre rivolgersi alla figura Questi fatti confermano che i diagrammi sono dei genuini paratesti
2) Tavole Una lsquotavolarsquo egrave una disposizione ordinata di lettere numerali e altri segni grafici che rappresenta i valori assunti da una determinata gran-
3 Le lettere denotative isolate o a gruppi sono i lsquonomirsquo degli enti di cui tratta una proposizione matematica sono sempre precedute da un articolo dello stesso genere dellrsquoog-getto designato (ad esempio ἡ ΑΒ per una retta) o da unrsquoespressione preposizionale intro-dotta da un articolo (ad esempio ἡ ὑπὸ ΑΒ ΒΓ per un angolo) Le lettere numerali denotano numeri di norma sono precedute dallrsquoarticolo solo a partire dalla loro seconda occorrenza in un determinato algoritmo Nessuna di queste combinazioni alfabetiche costituisce una parte del discorso in linguaggio (greco) naturale assumono una funzione sintattica (sostan-tivi) solo nellrsquoidioletto matematico Le qualificazioni lsquoprimariorsquo e lsquooriginariamentersquo nella mia definizione escludono altri tipi di paratesti come gli scolii Un discorso a parte merita-no invece le titolazioni ma non egrave il caso di affrontarlo in questa sede
4 Ciograve avviene nelle parti specifiche della proposizione denominate ἔκθεσις laquoesposi-zioneraquo e κατασκευή laquocostruzioneraquo dove al tempo stesso sono assegnate le lettere denotative
Fabio Acerbi126
dezza in funzione di un insieme discreto di valori di un parametro Una tavola-tipo egrave composta di due colonne a sinistra i valori del parametro a destra quelli della grandezza Il parametro non egrave necessariamente nume-rico5 Le colonne possono essere piugrave di due a) se piugrave grandezze omologhe oppure no legate allo stesso parametro sono per economia di spazio ri-portate su colonne affiancate b) se una grandezza ha una rappresentazione numerica complessa ad ogni ordine essendo associata una colonna6
Le tavole sono sia costruite che descritte La lsquocostruzionersquo di una tavola consiste nellrsquoesposizione delle dimostrazioni ed operazioni neces-sarie a produrre lrsquoinsieme dei suoi valori senza che questi ultimi siano calcolati singolarmente La tavola presenta dunque in modo sintetico il risultato di una serie di operazioni questa serie puograve anche essere molto lunga e complessa ed egrave quasi sempre impossibile ricavare in tempi brevi una tavola dalla sua costruzione una tavola egrave costruita una volta per tutte si rende in questo modo indipendente dalla costruzione e non egrave univocamente determinata dalla sua lsquodescrizionersquo che si limita ad indi-care quale ente costituisca il parametro e quale la grandezza tabulata ed eventualmente a fornire indicazioni di formato Una tavola egrave collocata dopo la propria costruzione e la propria descrizione ed occupa quasi sempre per intero lo spazio grafico unitario (pagina colonna di rotolo) Una tavola insomma egrave un vero e proprio testo dal formato particolar-mente perspicuo di questo testo fanno anche parte gli altri segni grafici necessari ad un suo corretto utilizzo le linee orizzontali e verticali che separano righe e colonne la titolazione che ne identifica il tipo
Esempio la lsquotavola delle cordersquo nellrsquoAlmagesto Essa contiene i va-lori delle corde inscritte in un cerchio (seconda colonna) e dei loro incrementi parziali (terza colonna) tabulati in funzione dellrsquoarco di cerchio che esse sottendono (prima colonna)7 questrsquoultimo egrave il para-metro fornito con incrementi di mezzo grado da 0ordm a 180ordm nella tavola vi sono pertanto 360 righe La costruzione della tavola occupa quasi tutto il capitolo I 10 dellrsquoAlmagesto 15 pagine e mezzo nellrsquoedizione di Heiberg la descrizione prende 11 righe scarse includendo anche le istruzioni per lrsquouso dei valori nella terza colonna la tavola stessa si estende su 16 pagine8 Egrave particolarmente importante osservare che la
5 Esempio la lsquotavola delle cittagrave illustrirsquo nelle Tavole facili tolemaiche a sinistra il nome della cittagrave a destra le sue coordinate geografiche
6 Si veda infra la sezione 3 per questa terminologia nel caso del sistema sessagesimale7 I valori delle corde sono calcolati fino al secondo ordine sessagesimale quelli dei
loro incrementi parziali in sessantesimi fino al quarto ordine la lsquoseconda colonnarsquo consiste quindi in realtagrave di 3 colonne la lsquoterzarsquo di 4
8 Rispettivamente POO I 1 pp 319-4620 ivi p 472-13 κανόνια ὑποτάξομεν ἀνὰ
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 127
mise en rouleau dellrsquooriginale era differente come Tolomeo stesso spiega nella sua descrizione le 360 righe erano ripartite διὰ τὸ σύμμετρον laquoper motivi di simmetriaraquo9 in 8 tavole affiancate di 45 righe lrsquouna che nel rotolo figuravano probabilmente con una soluzione di continuitagrave minore di un intercolumnio standard in guisa di macrocolonna I ma-noscritti medievali rispettano questa disposizione ma devono ripartire le 8 tavole su 4 pagine10 Date le dimensioni della pagina a stampa cui egrave confinato Heiberg non puograve farlo e sdoppia ogni tavola poicheacute 45 egrave dispari e a causa della presenza dellrsquoapparato critico le sue tavole per-dono tutta la simmetria iniziale Nel caso delle tavole dunque rotolo e codice comportano mises en texte differenti per una volta egrave il rotolo e non il codice il supporto ideale per questo tipo di testi
Altro esempio tavole del moto medio del sole nellrsquoAlmagesto De-notando rispettivamente con a g o m e c i valori del tempo di ritorno annuale in giorni e loro parti e dei moti (in gradi per appropriate unitagrave di tempo) giornaliero orario mensile per mese di 30 giorni annuale per lrsquoanno egiziano di 365 giorni e infine su un ciclo di 18 anni la determinazione dei restanti a partire dal valore di a ammonta alla se-guente catena di operazioni a rarr 360a = g rarr g24 = o 30g = m 365g = e rarr 18e = c Ognuno di questi valori forma la base della costruzione per addizioni successive11 delle tavole12 che denoto con le stesse lettere
στίχους με διὰ τὸ σύμμετρον ὧν τὰ μὲν πρῶτα μέρη περιέξει τὰς πηλικότητας τῶν περιφερειῶν καθ᾽ ἡμιμοίριον παρηυξημένας τὰ δὲ δεύτερα τὰς τῶν παρακειμένων ταῖς περιφερείαις εὐθειῶν πηλικότητας ὡς τῆς διαμέτρου τῶν ρκ τμημάτων ὑποκειμένης τὰ δὲ τρίτα τὸ λʹ μέρος τῆς καθ᾽ ἕκαστον ἡμιμοίριον τῶν εὐθειῶν παραυξήσεως ἵνα ἔχοντες καὶ τὴν τοῦ ἑνὸς ἑξηκοστοῦ μέσην ἐπιβολὴν ἀδιαφοροῦσαν πρὸς αἴσθησιν τῆς ἀκριβοῦς καὶ τῶν μεταξὺ τοῦ ἡμίσους μερῶν ἐξ ἑτοίμου τὰς ἐπιβαλλούσας πηλικότητας ἐπιλογίζεσθαι δυνώμεθα laquodisporrograve le tavole su 45 righe per motivi di simmetria la prima parte di lsaquoognuna dirsaquo esse conterragrave i valori degli archi incre-mentati di mezzo grado alla volta la seconda i valori delle rette corrispondenti agli archi (il diametro essendo posto di 120 gradi) la terza la 30ordm parte dellrsquoincremento delle rette per ciascun lsaquointervallo dirsaquo mezzo grado di modo che sia possibile calcolare facilmente avendo in questa maniera a disposizione il valore intermedio lsaquodellrsquoincrementorsaquo corrispondente ad un singolo sessantesimo (esso egrave differente da quello esatto in maniera impercettibile) anche i valori delle frazioni intermedie tra i lsaquovalori limitati airsaquo mezzi gradiraquo Alm I 11 ivi pp 48-63
9 Non dobbiamo sopravvalutare la componente estetica implicita nel nostro termine laquosimmetriaraquo Tolomeo si limita a far riferimento alla laquocongruenzaraquo di 45 con 360 in quanto suo divisore esatto
10 Si vedano Par gr 2389 (sec IX in Tolomeo Almagestum) ff 17r-18v Vat gr 1594 (Prolegomena ad Almagestum Tolomeo Almagestum et opera minora) ff 20v-22r Marc gr 313 (Prolegomena ad Almagestum Tolomeo Almagestum) ff 46r-47v Vat gr 180 (sec X Tolomeo Almagestum) ff 18v-20r per la datazione del secondo e del terzo codice si veda la sezione 4
11 Tolomeo accorda alla menzione di questrsquooperazione di addizione una mezza riga proprio alla fine della sua esposizione κατὰ τὰς οἰκείας ἑκάστων ἐπισυναγωγάς laquoper opportune addizioni successive dei lsaquovalorirsaquo di ciascunoraquo Alm III 1 in POO I 1 p 20924-25
12 Alm III 1 ivi pp 2091-16 e 20922-25 descrizione ivi p 20917-22
Fabio Acerbi128
maiuscole ovviamente la tavola A egrave assente Per esempio la tavola G ha come prima riga il valore g (colonna di destra) accompagnato dalla cifra α laquo1raquo (colonna di sinistra) le altre righe hanno a sinistra i numerali da 2 a 30 e a destra i multipli corrispondenti di g il valore registrato a destra nellrsquoultima riga deve evidentemente coincidere con m In omaggio al principio delle 45 righe13 troviamo dunque una prima tavola C su 45 righe (corrispondente a un periodo di 18times45 = 810 anni avente come epoca il primo anno di regno di Nabonassar) una seconda su 42 righe che combina le 18 righe di E seguite dalle 24 di O una terza ancora su 42 righe che contiene le 12 di M seguite dalle 30 di G14 ndash nella seconda
13 διὰ τὸ φανησόμενον σύμμετρον τῆς κανονογραφίας laquoper una presentazione simme-trica del tracciato delle tavoleraquo ivi p 20914-15 allusione analoga in Alm I 10 ivi p 472-3 lrsquoabbiamo letta sottolineata nella nota 8 supra
14 Per la mise en page di queste tre tavole nei manoscritti medievali si vedano Par gr 2389 ff 69v-70r Vat gr 1594 f 63r-v (in questi due codici scritti su due colonne le tavole occupano unrsquointera pagina piugrave la prima colonna della successiva) Marc gr 313 f 98r-v (questo codice vergato a tutta pagina adotta momentaneamente una disposizione su due colonne al f 98v la prima contiene la tavola la seconda lrsquoinizio del capitolo successivo) Vat gr 180 ff 60v-61v Nelle Tavole facili dello stesso Tolomeo che passano a cicli di 25 anni e allrsquoepoca di Filippo le tavole appena descritte sono presentate con precisione ridotta rispetto a quelle dellrsquoAlmagesto nellrsquoordine C (periodo di 25times59 = 1475 anni) E (ciclo di 25 anni) M (direttamente con i nomi dei mesi del calendario egiziano mentre lrsquoAlmagesto ripartisce il parametro in multipli di 30 giorni fino a 360) G O Ogni tavola egrave suddivisa in unitagrave colonnari di non piugrave di 30 righe + titolazione La lsquotavola delle cordersquo non egrave inclusa nelle Tavole facili per le tavole del moto medio del sole e della luna nei manoscritti medievali di questrsquoopera si vedano Leiden Bibliothek der Rijksuniversiteit BPG 78 ff 91r-93v Laur Plut 2826 ff 71r-73v Vat gr 1291 ff 38r-40v Marc gr 331 ff 45r-47v ndash le parti in maiuscola di tutti questi codici contengono unicamente le Tavole facili e si datano sulla base dellrsquoultimo imperatore di cui il copista principale abbia riportato gli anni di regno nel cosid-detto canon regius nellrsquoordine Leiden BPG 78 copiato sotto il regno di Leone V 813-820 Vat gr 1291 copiato poco dopo il regno di Niceforo I 802-811 (Janz 2003) Laur Plut 2826 copiato sotto il regno di Leone VI 886-912 Marc gr 331 privo del canon regius e forse copiato anchrsquoesso sotto il regno di Leone VI si veda anche Tihon 2011 pp 19-41 per una sintesi e per ulteriori indicazioni bibliografiche Ovviamente anche le Tavole facili erano state concepite per il rotolo Tra lrsquoaltro Tolomeo sembra trascrivere nella stessa tavola i moti medi di Sole Luna Cor Leonis (la stella Regolo) e dei cinque pianeti cosa impossibile a farsi su una sola pagina di codex si legga la descrizione che ne dagrave nella parte iniziale del lsquomanuale di istruzionirsquo alle Tavole facili stesse in POO II p 1607-19 Nei manoscritti medievali questa tavola egrave smembrata poco dopo lrsquoinizio della sequenza di tavole si trovano i moti medi di Sole e Luna piugrave avanti quelli di Regolo e dei cinque pianeti Piugrave in generale il passaggio al codice comportograve una riorganizzazione delle lsquotavole facilirsquo dal piano originario in cui tutte quelle di longitudine erano molto verosimilmente raggruppate insieme e precedevano quelle di latitudine ad un ordinamento per corpi celesti (Tihon 2011 pp 12-14) Le Tavole facili furono copiate molto presto su codice i lsquopapirirsquo di questrsquoopera sono quasi unicamente su codex di pergamena (Jones 1999 I pp 102-108 e 160-168 edizione dei POxy LXI 4167-4173a contenenti frammenti delle Tavole facili ivi II pp 118-161 solo il primo di essi proviene sicuramente da un rotolo) Giagrave in pieno IV secolo Teone di Alessandria nel suo lsquoPiccolo commentariorsquo alle Tavole facili afferma che alcune di esse possono estendersi su πλειόνων πτυχίων laquopiugrave pagineraquo (PC p 2016 allinterno dellunica definizione di lsquotavolarsquo rintracciabile nel corpus antico) cosigrave le leggiamo attualmente nei manoscritti
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 129
e nella terza tavola il numero di righe egrave piugrave basso percheacute occorre pre-vedere uno spazio per il titolo addizionale Per mantenerne il formato tripartito Heiberg egrave costretto a stampare le tavole ruotate di 90ordm
Che le tavole siano dei testi egrave confermato da due fatti aggiuntivi e strettamente connessi15 Primo il lsquomanuale di istruzionirsquo alle Tavole facili che Tolomeo stesso redasse fu scritto ed ha circolato come opera a parte Secondo dalla descrizione delle tavole dettagliata ma priva di costruzione contenuta nello stesso lsquomanualersquo egrave impossibile ricavarne il contenuto numerico e la maniera drsquoimpiego16 a illustrare questrsquoultima provvederagrave una ricchissima tradizione di commentari di cui leggiamo ancora quelli di Teone il lsquoPiccolo Commentariorsquo spiega come usarle per scopi specifici il lsquoGrande Commentariorsquo come dedurle dallrsquoAlmagesto17 Le Tavole facili sono insomma unrsquoopera il cui testo egrave interamente strut-turato in formato tabulare
3) Tabelle operazionali Una lsquotabella operazionalersquo egrave una disposi-zione ordinata di lettere numerali e altri segni grafici che rappresenta lrsquoalgoritmo di unrsquooperazione aritmetica Ci troviamo in realtagrave di fronte a due modi di eseguire lrsquooperazione la tabella intende in qualche mi-sura riprodurre la dinamica operazionale dellrsquoalgoritmo questrsquoultimo si risolve a sua volta in una descrizione della tabella che senza tale de-scrizione risulterebbe incomprensibile e quindi non adattabile ad una differente operazione una tabella operazionale ha in questo caso una funzione paratestuale Si presuppone perograve che il discente apprenda a ri-produrre lrsquooperazione direttamente nel formato tabellare non in quello algoritmico In questo secondo caso una tabella operazionale assume una funzione testuale piena18 Lo statuto (para)testuale delle tabelle operazionali egrave pertanto oscillante nei commentari teonini allrsquoAlmagesto e soprattutto nei Prolegomena ad Almagestum di cui andremo ad occu-parci esse sono descritte in dettaglio e si configurano pertanto come genuini paratesti in Eutocio in Circ esse sono semplicemente eseguite e quindi assumono un ruolo testuale Nei manoscritti medievali la col-locazione di una tabella operazionale originaria egrave variabile e dipende dalle sue dimensioni e dalla capacitagrave del copista di identificarla come
15 Per un argomento ulteriore si veda la sezione 4 punto b16 POO II pp 159-18517 Nessuno dei due titoli ha fondamento nella trasmissione manoscritta la seconda
opera era detta realizzare una συμφωνία tra lrsquoAlmagesto e le Tavole facili Entrambi i com-mentari sono stati editi criticamente PC GC I-III
18 Resta il fatto che la quasi totalitagrave delle tabelle operazionali che rintracciamo nei manoscritti egrave relegata nei margini dellrsquoattivitagrave di annotazione degli scoliasti
Fabio Acerbi130
tale di solito le troviamo nei margini ma possono occupare lrsquointero specchio di scrittura e ciograve indipendentemente dalla determinazione del loro statuto paratestuale sulla base del criterio della presenzaassenza di una descrizione
Lo statuto meno elevato dei genuini paratesti (diagrammi e tabelle) rispetto ai testi (catene algoritmico-argomentative e tavole) indusse un atteggiamento differenziato in copisti ed editori attenti a rispettare lrsquointegritagrave dei secondi ma non dei primi ciograve che conta sono le informa-zioni veicolate dalle strutture discorsive e dalle porzioni alfanumeriche di diagrammi tavole e tabelle il resto egrave ritenuto adattabile alle esigenze dellrsquoedizione moderna19 o semplicemente ignorato nel corso del pro-cesso di copia in questa maniera si perdono perograve informazioni e strut-tura Come vedremo puograve avvenire che una parte della descrizione di unrsquooperazione resti senza relato nella resa grafica tabellare lrsquooperazione eseguita in forma algoritmica non corrisponde piugrave a quella eseguita in forma di tabella
3 Testi logistici e disposizione tabellare delle operazioni
Nessun testo matematico primario di etagrave ellenistica o imperiale contiene operazioni aritmetiche eseguite con una sola eccezione la de-scrizione che non ammette una rappresentazione tabellare del procedi-mento di estrazione approssimata di radice quadrata in Erone Metr I 8 Drsquoaltro canto abbiamo giagrave osservato che lrsquoAlmagesto di Tolomeo for-nisce il risultato di migliaia di operazioni ma nessuna di esse egrave eseguita Attestazioni di questi procedimenti sono pertanto legate ad iniziative editoriali di secondo livello come i commentari alla loro prima occor-renza oppure in casi paradigmatici gli algoritmi di calcolo omessi nel testo primario vi sono resi espliciti Di fatto e con una sola eccezione la nostra documentazione consiste in commentari allrsquoAlmagesto quello di Teone e i Prolegomena ad Almagestum
19 Abbiamo giagrave visto alcuni esempi di modifiche del formato delle tavole Quanto ai diagrammi quelli tracciati nelle edizioni moderne rappresentano il caso piugrave generale pos-sibile Le figure che troviamo nei manoscritti greci hanno invece la caratteristica opposta illustrano spesso casi particolari e sono metricamente scorrette Sono in effetti tracciati triangoli rettangoli isosceli cerchi uguali rette perpendicolari dove tutto ciograve non egrave richiesto dallrsquoenunciato e inoltre rettangoli invece di parallelogrammi segmenti uguali quando sia-no disuguali addirittura linee rette al posto di curve (in Archimede Meth 14 un arco di parabola egrave rappresentato da un angolo rettilineo) e in generale figure con proprietagrave di simmetria non richieste
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 131
LrsquoAlmagesto e con esso tutta la tradizione astronomica adotta il sistema sessagesimale per esprimere la parte non intera di un nu-mero che siano valori angolari o lineari non fa differenza20 come noi scriviamo 36524 e intendiamo 365 + 2 decimi + 4 centesimi (cioegrave 4102) cosigrave nel sistema sessagesimale 365 14 48 significa21 365 + 14 sessantesimi + 48 tremilaseicentesimi (cioegrave 48602) ovverosia nel lessico antico e nostro 365 14 πρῶτα λεπτά laquominuti primiraquo 48 δεύτερα λεπτά laquominuti secondiraquo dove laquoprimoraquo e laquosecondoraquo sono le laquodenominazioniraquo degli ordini (sono cioegrave numeri ordinali) 14 e 48 i lsquonumerali di molteplicitagraversquo relativi ai due ordini numerale di mol-teplicitagrave e relativa denominazione costituiscono insieme una lsquoparte sessagesimalersquo di un numero Drsquoaltronde per gli antichi come per noi lrsquoespressione di una parte non intera (ovvero di una frazione)
20 Trascuro il fatto ai nostri fini irrilevante che essendo i numerali greci lettere alfabetiche la notazione che ne risulta per i numeri interi non egrave posizionale nonostante le cifre scagravelino di un posto ad ogni potenza di dieci il segno μ per 4 (decine) non egrave identico al segno δ per 4 (unitagrave) Drsquoaltra parte una volta adottata la notazione decimale per i numerali di molteplicitagrave la notazione complessiva per la parte non intera espressa nel sistema sessa-gesimale non egrave posizionale neanche introducendo un segno di lsquoposto vuotorsquo una cui parte egrave nel caso greco analoga in forma al nostro 0 (su questo segno si veda ancora la sezione 4 punto c) occorre avvalersi di accorgimenti ulteriori quali lrsquointroduzione di spaziature fra le differenti parti sessagesimali (come viene fatto nei manoscritti greci ed in questrsquoarticolo) o di segni tipografici (come suggerito da Otto Neugebauer che avrebbe scritto 3651448 il numerale che leggeremo tra un attimo nel testo) Il problema egrave che altrimenti lrsquoordine associato ad un numerale di molteplicitagrave di una parte sessagesimale puograve non risultare uni-vocamente determinato dalla sua posizione Esempio scrivendo 0129 per un numero non intero nel sistema sessagesimale il numerale di molteplicitagrave 129 potrebbe rappresentare 1 minuto primo e 29 secondi oppure 12 minuti primi e 9 secondi ecc e la stessa difficoltagrave si presenta nella notazione greca (per la nozione di lsquonumerale di molteplicitagraversquo si veda infra nel testo) Il problema scomparirebbe se adottassimo singoli segni differenti per tutti i nu-merali da 1 a 59 ndash ma neacute noi neacute i greci siamo stati disposti a introdurre una complicazione siffatta Si ricordi infine che al di fuori dei contesti astronomici il sistema di numerazione greco egrave decimale
21 Scriverograve i numerali in cifre arabe sempre in questo modo parte intera seguita dalle parti sessagesimali (minuti primi secondi ecc) con ogni ordine separato da uno spazio bianco Se la parte intera egrave assente il numerale inzia con uno 0 Nella trascrizione dei numerali in greco ogni numerale di molteplicitagrave sessagesimale o frazione unitaria saragrave identificato come nei manoscritti piugrave antichi dei Prolegomena da un opportuno numero di apici (uno per ogni unitagrave dellrsquoordine avendo le frazioni unitarie un solo apice come vedremo nellrsquoAlmagesto contenuto negli stessi codici troviamo barre non apici con questa funzione) mentre la parte intera saragrave priva della barra che la sormonta invariabilmente nei manoscritti In questo modo 365 14 48 egrave la conversione in cifre arabe di τξε ιδ´ μη´´ La pratica dei manoscritti medievali egrave di collocare gli apici (quando presenti) sopra le lettere numerali per ragioni tipografiche li porrograve di seacuteguito al gruppo di lettere cui si riferiscono Si noti che nella notazione greca il segno ιδ´ per 1460 in sessagesimale egrave identico a quello per 114 in decimale Nel caso delle frazioni unitarie la presenza dellrsquo(unico) apice egrave la traduzione semiotica della trasformazione che a livello grammaticale egrave effettuata con il pas-saggio dal cardinale allrsquoordinale (ad esempio da τὰ τρία laquotreraquo a τὸ τρίτον laquoun terzoraquo) si veda anche la sezione 4 punto 1 e note 82 e 86 ivi incluse
Fabio Acerbi132
richiede sempre lrsquointroduzione di due numerali il lsquonumeratorersquo e il lsquodenominatorersquo
Il motivo della scelta del sistema sessagesimale che fu mutuato dallrsquoastronomia matematica babilonese egrave presto detto lrsquoelevato numero di divisori di 60 e cioegrave 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 Poicheacute i divi-sori di 10 sono un sottinsieme di quelli di 60 molti piugrave numeri hanno una rappresentazione finita nel sistema sessagesimale che in quello deci-male Calcolare in sessagesimale lungi dal creare difficoltagrave offre quindi un vantaggio cruciale22 che risulta piugrave facilmente comprensibile sulla base dellrsquoesempio seguente La lunghezza dellrsquoanno solare egrave stabilita da Tolomeo in 365 giorni + 14 ndash 1300 di giorno Per calcolare il moto giornaliero del sole si rende necessario dividere 360 per questo numero Noi avremmo due opzioni se non potessimo usare la calcolatrice ri-durre il divisore ad una singola frazione tramite passaggio al denomi-natore comune invertire questa frazione e moltiplicarla per 360 sem-plificare gli eventuali fattori comuni e finalmente eseguire la divisione a piugrave cifre tra numeri interi (nel nostro caso 5400054787) oppure scrivere il divisore come numero decimale periodico (365246666 hellip) e poi eseguire la divisione Nel sistema sessagesimale egrave tutto molto piugrave semplice 365 + 14 ndash 1300 ha una rappresentazione finita cioegrave 365 14 48 come eseguire la divisione lo vedremo tra un attimo
Passiamo dunque in rassegna il contenuto del lsquomanuale di logisticarsquo incluso nei Prolegomena ad Almagestum riportando in nota per ogni item anche esposizioni parallele in altri commentatori23
a) Costruzione del sistema sessagesimale24
22 E uno svantaggio se le molteplicitagrave dei singoli ordini vengono espresse in no-tazione decimale (come facciamo noi e facevano i greci) il numero di cifre necessario per raggiungere una precisione assegnata egrave maggiore nel sistema sessagesimale in quanto per esprimere i numerali da 10 a 59 occorrono due cifre mentre per quelli da 1 a 9 (o da α a θ e le decine da ι a ν nel caso greco) ne basta una e ciograve indipendentemente dal fatto che la notazione sia posizionale oppure no La differenza si fa perograve sentire solo a partire dal quinto ordine sessagesimale
23 Trascuro la parte finale del lsquomanualersquo dove sono esposte le regole di interpolazione (cui era legata la lsquoterza colonnarsquo della tavola delle corde tolemaica) e il procedimento di lsquosottrazionersquo di rapporti cioegrave la divisione di un rapporto per un altro
24 Per a-b cf Teone in Alm I 10 in iA pp 44919-45814 PC pp 2007-2014 GC I pp 10910-11124 e le definizioni e regole diofantee di manipolazione delle varie specie numeriche in Arithmetica prefazione in DOO I pp 214-1218 Le porzioni a-b sono giagrave state pubblicate da Paul Tannery in DOO II pp 318-1517 sulla base del Par gr 453 apografo ad opera di Giovanni Santamaura di un Vat gr 1594 giagrave mutilo (RGK II nr 238 ma lrsquoautore trascritto vi egrave indicato come lsquoPtolemaiosrsquo) Evidentemente il committente non fu soddisfatto della prima trascrizione (ff 67-76) che crivella di tratti rossi a segnalarne gli errori di copia Ne fu dunque eseguita una seconda (ff 78-86) cui Santamaura antepose
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 133
b) Regole di moltiplicazione e divisione degli ordini sessagesimali defini-zione generale di moltiplicazione moltiplicazione di ordini come somma delle loro laquodenominazioniraquo Definizione generale di divisione divisione di ordini uguali e di un ordine per quello che lo precede immediata-mente divisione di ordini come sottrazione delle loro laquodenominazioniraquo divisione per 60 come divisione per 1 accompagnata dallo slittamento di un posto dellrsquoordine
c) Problemi che sorgono nella divisione di una parte sessagesimale per una di quelle che seguono divisione breve per riduzione allo stesso ordine (metodo laquoper analisiraquo) due algoritmi differenti il secondo con riduzione dei fattori comuni attribuito a Siriano
d) laquoAltroraquo metodo di divisione breve in realtagrave divisione tra somme di parti sessagesimali appartenenti ad ordini differenti per riduzione allo stesso ordine e applicazione dei metodi precedenti esempio della divisione di 0 2 0 4 per 0 0 2 0 240
e) Metodo di moltiplicazione tra numeri con parti non intere disposizione tabellare dei termini esempio della moltiplicazione di 5 4 6 per 8 0 3 0 525
f ) Primo metodo di divisione lunga descrizione della disposizione tabellare ed esempio di algoritmo applicato alla divisione di 50 48 26 30 per 8 16 28 5426
g) Metodo di divisione lunga tratto da Pappo in Alm III descrizione della disposizione tabellare ed esempio di algoritmo applicato alla divisione di 360 per 365 14 48 come verifica del valore 0 59 8 17 13 12 31 fornito nellrsquoAlmagesto per il moto medio giornaliero del sole27
h) Metodo di approssimazione di una radice quadrata secondo Erone Metr I 8 con giustificazione geometrica di Teone (attualmente non attestata in suoi scritti)
i) Verifica tramite moltiplicazione della correttezza del valore tolemaico28 di 67 4 55 come radice quadrata approssimata di 4500 Metodo di estrazio-ne di radici quadrate secondo Teone basato su applicazioni successive di Elementi II 4 la procedura termina dopo un numero finito di passi nel caso di quadrati perfetti Applicazione al calcolo della radice quadrata di 450029
unrsquoannotazione spazientita laquoIl texto di questo 2do quinterno egrave stato recopiato fidelmente dallrsquooriginale a chi volesse vedere la prova lo potragrave conferire con detto originale le pagine del qual texto corrispondono con quelle dellrsquooriginale tanti versi che pagine [hellip]raquo (Moge-net 1962 p 200)
25 Teone in Alm I 10 e I 14 in iA pp 45815-4604 e 57911-5811026 Teone in Alm I 10 in iA pp 4611-46217 applicato alla divisione di 1515 20
15 per 25 12 1027 Teone in Alm III 1 e IV 3 in iA pp 84112-84422 (stesso calcolo dei Prolego-
mena) e 102916-10327 idem in Alm IX pp 377-378 dellrsquoedizione di Basilea del 1538 approntata dai tipografi di Walderus Lrsquooriginale pappiano non ci egrave pervenuto
28 Alm I 10 in POO I 1 p 341129 Teone in Alm I 10 in iA pp 46916-4738
Fabio Acerbi134
Lrsquounico testo non elencato qui sopra o nelle note e che contenga tabelle operazionali egrave il commentario eutociano a Circ 3-4 Il testo ar-chimedeo che Eutocio e noi con lui leggeva egrave particolarmente conciso ed egli verifica esplicitamente il sussistere di certe relazioni numeriche Si tratta in ognuno dei nove casi presenti di mostrare che il lsquoteorema di Pitagorarsquo egrave verificato con ottima approssimazione dai valori numerici di opportune terne di rette Eutocio esegue le tre moltiplicazioni dei valori per se stessi e mostra che la somma o la differenza di due dei risultati si discosta di poco dal terzo30 I numeri in questione sono interi seguiti o no da una parte non intera espressa come somma di frazioni unita-rie31 I nove gruppi di tre moltiplicazioni una a fianco allrsquoaltra sono organizzati in forma tabellare ma senza lrsquoausilio di linee separatrici32 le operazioni sono eseguite disponendo lsquoin colonnarsquo i risultati delle mol-tiplicazioni parziali e sommandoli esattamente come facciamo oggi poicheacute sono in gioco numeri interi con parti frazionarie unitarie e la notazione non egrave posizionale non egrave necessario che gli incolonnamenti siano esatti (unitagrave di un risultato parziale sotto le decine del precedente ecc) Sono inclusi nella tabella istruzioni e commenti in linguaggio corrente33 le prime relative allrsquooperazione da affettuare sui risultati delle
30 Eutocio non calcola radici quadrate approssimate per quanto ciograve si renda piugrave volte necessario fornisce il risultato e verifica la sua correttezza moltiplicandolo per se stesso Egli dichiara che il lettore interessato a questo procedimento di calcolo puograve rivolgersi Ἥρωνι ἐν τοῖς μετρικοῖς [hellip] Πάππῳ καὶ Θέωνι καὶ ἑτέροις πλείοσιν ἐξηγουμένοις τὴν μεγάλην σύνταξιν τοῦ Κλαυδίου Πτολεμαίου laquoa Erone nei Metrica [hellip] a Pappo e Teone e a svariati altri inter-preti della Grande composizione di Claudio Tolomeoraquo (AOO III p 23213-17)
31 Troviamo ad esempio ͵αωλη θ´ ια´ cioegrave 1838 + 19 + 111 notare il singolo apice per le frazioni unitarie
32 Essi sono editi in AOO III pp 234-256 La tradizione medievale del commentario eutociano che coincide con un ramo di quella archimedea e deriva da un codice appar-tenuto a Giorgio Valla perduto in etagrave rinascimentale ma riprodotto a volte con fedeltagrave assoluta negli apografi (si veda ad esempio nella tav 1a la riproduzione dellrsquoerronea di-sposizione di cifre e parte algoritmica nel primo gruppo di moltiplicazioni offerta dal Laur Plut 284 f 160r) egrave costituita da Marc gr 305 ff 142v-146v Laur Plut 284 ff 159r-164r Par gr 2360 ff 109v-113v Par gr 2361 pp 410-421 Nel codice veneziano in cui la disposizione per righe e colonne egrave irrimediabilmente alterata dal copista le operazioni sono cancellate con tratti di penna Il primo manoscritto fu esemplato per Bessarione da Giorgio Trivizias tra il 1455 e il 1468 (Mioni 1976 pp 309-312) il secondo fu vergato da Giovanni Scutariota in scrittura di imitazione (Martinelli Tempesta 2010 p 173 n 7 Rollo 2012) ca 1491-1492 il terzo fu trascritto per il cardinale di Firenze Niccolograve Ridolfi dopo che la biblioteca di Valla era stata acquistata a seacuteguito della sua morte avve-nuta il 23 gennaio 1500 per 800 scudi drsquooro da Alberto Pio di Carpi (nota del copista al f 120v) il quarto fu terminato per mano di Christopher Auer su commissione di Georges drsquoArmagnac il primo gennaio 1544 (sottoscrizione a p 474 del codice si veda RGK II nr 525)
33 A questi va aggiunto posto davanti al risultato finale di ogni moltiplicazione il segno convenzionale per ὁμοῦ laquoinsiemeraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 135
prime due moltiplicazioni34 i secondi alla bontagrave dellrsquoapprossimazione ottenuta35 Ogni gruppo di operazioni che chiude unrsquounitagrave esegetica ed egrave seguito dalla citazione che apre la successiva egrave trascritto come se facesse parte del testo a tutta pagina e preceduto dallrsquoindicazione οἱ δὲ πολλαπλασιασμοὶ ὑπόκεινται laquole moltiplicazioni sono poste qui sottoraquo Questi due fatti suggeriscono che tutte le operazioni cui Eutocio non fa alcun riferimento nel corpo del suo commentario siano unrsquoaggiunta editoriale risalente a Isidoro di Mileto che si occupograve della revisione del testo36
Gli incolonnamenti esatti sono invece necessari quando siano moltiplicati numeri con parti non intere espresse nel sistema sessage-simale in quanto la somma finale dei prodotti parziali va effettuata ordine per ordine Tale somma eccederagrave di norma il valore di 60 per un ordine dato nella tabella occorre pertanto trovare posto anche per i riporti che vanno sommati ai prodotti parziali dellrsquoordine preceden-te e quindi incolonnati con essi I testi ci offrono alcuni esempi di tabelle operazionali moltiplicative di questo tipo Teone afferma espli-citamente che la prima moltiplicazione che va a descrivere ha una rap-presentazione tabellare la cui disposizione ritroviamo pesantemente ingarbugliata nel Laur Plut 2818 f 35r37 Alla seconda occorrenza di una moltiplicazione eseguita (tav 1b Laur Plut 2818 f 65r) gli incolonnamenti sono meglio rispettati anche se il risultato finale egrave fatto erroneamente slittare di un posto verso destra i riporti (con un errore) si trovano nella penultima riga38 Nei Prolegomena ad Alma-gestum alcune moltiplicazioni sono accompagnate da tabelle quella meglio attestata egrave associata alla moltiplicazione di 67 4 55 per se stesso (sezione i nel riassunto fornito supra) ed egrave descritta additando sempli-cemente ad un ente materiale oramai inaccessibile forse tracciato in loquendo lsquoalla lavagnarsquo
34 Come λοιπὸν τὸ ἀπὸ ΕΓ laquoresta quello su ΕΓraquo seguito dal risultato della sottrazione di due quadrati
35 Come λείπει ἄρα μο β εἰς τὸ ἀκριβές laquomancano quindi 2 u(nitagrave) al risultato esattoraquo36 Si legga la sottoscrizione spuria ad AOO III p 26010-1237 Si legga la frase ἐκτίθεμαι αὐτὴν καὶ πάλιν αὐτὴν ὑφ᾽ αὑτὴν ὡς ὑπογέγραπται laquolo [scil il
valore del lato da moltiplicare per se stesso] dispongo lsaquouna voltarsaquo e di nuovo al sotto di se stesso come trascritto qui sottoraquo in iA p 45817 Il Laur Plut 2818 (Teone e Pappo Commentaria in Almagestum) egrave uno dei piugrave antichi manoscritti in minuscola sicuramente assegnabile alla prima metagrave del IX secolo (Follieri 1977 p 144 n 23 Maas 1927 p 76 n 17 riteneva che fosse piugrave antico del Tetraevangelo Uspenskij) per una sua analisi si veda Rome 1938
38 In nessuno dei due casi i numerali di molteplicitagrave sono segnalati con apici sono tutti sormontati da una barra si veda la sezione 4 punto b
Fabio Acerbi136
προκείσθω δὶς τὸ μῆκος αὐτῆς ὀφεῖλον τὴν τάξιν τοῦ κατὰ τοὺς πολλαπλασιασμοὺς κανόνος ἀποδοῦναι καὶ ἐκκείσθω ἐπὶ σελιδίων διαγεγραμμένων οὕτω καὶ δὴ αὐτῆς ἐφ᾽ ἑαυτὴν πολ-λαπλασιασθείσης γεγονέτωσαν τὰ ἐν τοῖς οἰκείοις σελιδίοις εἴδη ταῦτα δὴ συναγόμενα καθ᾽ ἣν ὑπεδείξαμεν τάξιν ποιήσει τὰς ὑπογεγραμμένας μοίρας ἢ καὶ λεπτά τινα εἴσι ͵δυϙθ νθ´ ιδ´´ ι´´´ κε´´´´ ὡς λείπειν τοῦ ἐπιμερισθῆναι ŏ ŏ με´´ μθ´´´ λε´´´´
che sia prescritto che la sua lunghezza debba figurare due volte nella disposizione della tavola delle moltiplicazioni e che lsaquoquestrsquoultimarsaquo sia disposta su colonne delimitate da linee cosigrave mdash E pertanto una volta moltiplicato lsaquoil latorsaquo per se stesso che le specie trovino posto nelle colonne appropriate quelle che vengono cosigrave raccolte secondo la disposizione che abbiamo indicato produrranno dunque i gradi o anche i minuti qui sotto trascritti 4499 59 14 10 25 in modo che dalle divisioni successive resti39 0 0 45 49 35
La tabella associata (tav 2a Marc gr 313 f 19v) contiene una sola svista grossolana reca 51 invece di 55 in ognuno dei due fattori posti affiancati sopra di essa Al di sotto preceduto dal segno convenzionale per ὁμοῦ egrave collocato il risultato incongruamente sfalsato di un paio di colonne e con la lettera numerale ͵δ priva di barra sormontante in-naturalmente disconnessa da υϙθ I riporti sono indicati dai numerali ι ρκγ´ η´´ ν´´´ posti al fondo delle prime quattro colonne Il calcolo egrave corretto in ogni sua parte
Il clou in questo piccolo spaccato delle interazioni testo-paratesto matematico risiede nella descrizione contenuta nei Prolegomena della disposizione tabellare di due procedimenti di divisione il primo ano-nimo e quindi da supporre tradizionale il secondo piugrave efficiente ed attribuito al matematico del IV secolo Pappo
Il primo metodo di divisione egrave sostanzialmente analogo a quello che usiamo attualmente Dividendo e divisore questrsquoultimo preceduto da un segno su cui ritorneremo nella prossima sezione sono posti uno sotto lrsquoaltro intervallati da una riga inizialmente vuota Primo passo viene reperito il massimo multiplo del divisore che sia minore del di-videndo esso viene trascritto sotto il dividendo nella prima lsquocasellarsquo della riga vuota recante in testa un segno per laquosottrairaquo il fattore mol-tiplicativo (o quoziente parziale) viene trascritto in una lsquocasellarsquo pre-ceduta da un segno per laquorisultaraquo sotto il divisore Secondo passo il massimo multiplo viene sottratto dal dividendo il resto cosigrave ottenuto egrave trascritto preceduto da un segno per laquorestoraquo in una casella posta
39 Lrsquoautore concettualizza il procedimento di estrazione di radice quadrata come una forma di divisione
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 137
accanto al dividendo40 I due passi precedenti sono quindi ripetuti con la sola differenza che il resto appena ottenuto prende il posto del divi-dendo il quoziente parziale scala di un ordine sessagesimale ad ogni passo41 E cosigrave via aggiungendo ogni volta due caselle La debolezza di questo metodo come di quello che utilizziamo attualmente risiede nel fatto che il reperimento dei quozienti parziali (ovverosia dei massimi multipli) viene effettuato per tentativi non riuscire a farlo al primo colpo appesantisce notevolmente i calcoli successivi e costringe ad un lavoro di riordino e addizione dei quozienti parziali stessi La tabella risultante dove appunto osserviamo questo fenomeno in parallelo con identiche inaccuratezze nella descrizione ha la forma riprodotta unico tra i manoscritti della recensione antica nel Marc gr 313 f 13r (tav 2b invito il lettore a non rivolgersi alle tavole se non dopo aver termi-nato questa sezione sarebbe anzi auspicabile che tentasse di ricostruire questa tabella e le due successive a partire dalla mia descrizione)42
Il secondo metodo di divisione attribuito a Pappo egrave congegnato in modo da rendere non aleatoria la ricerca dei quozienti parziali Come altrove nei Prolegomena la descrizione della procedura di calcolo si riag-gancia esplicitamente a una frase di Tolomeo laquouna volta dimostrato che il periodo di una singola rivoluzione lsaquodel solersaquo egrave di 365 giorni 14 48 se di-vidiamo per essi i 360 gradi di un singolo cerchio avremo il moto medio giornaliero del sole circa 0 gradi 59 8 17 13 12 31raquo43 Questrsquoaffermazione si trova nel terzo libro dellrsquoAlmagesto si tratta della prima occasione in cui viene effettuata una divisione in cui il divisore egrave maggiore del dividendo e i commentatori del trattato tolemaico non si fecero sfuggire lrsquooccasione di mostrare come eseguirla Ora il terzo libro del commentario di Pappo non ci egrave pervenuto Ci resta dunque come testo parallelo a quello dei Prolegomena la descrizione rigidamente formulare in Teone sicuramente un calco di quella pappiana Teone qui come nelle altre applicazioni del metodo (Laur Plut 2818 ff 136v [tav 3] e 190r) descrive brevemente ed espone esplicitamente la stessa tavola dei sottomultipli del divisore che
40 Esempio nella divisione di 378 per 17 il massimo multiplo egrave 374 il quoziente parziale egrave 22 il resto 4 e in effetti 378 = 374 + 4 = 17times22 + 4 Si noti che il segno per laquorestoraquo non egrave apposto in testa di riga ma davanti a ogni resto parziale e in effetti il dividendo che si trova in prima posizione in questa riga non egrave un resto
41 Analogamente nellrsquoalgoritmo moderno poniamo la virgola o scaliamo la cifra di un posto
42 Nei Prolegomena la descrizione della tabella associata al metodo anonimo egrave pre-ceduta da una breve sinossi dellrsquooperazione in stile procedurale (cioegrave senza riferimenti alla tabella) e seguita dalla sua esecuzione accurata ma con pochi riferimenti alla tabella se non quello ai due segni da apporre ai resti parziali e ai massimi multipli
43 Alm III 1 in POO I 1 p 2091-4
Fabio Acerbi138
troviamo nei Prolegomena ma non offre alcuna descrizione della disposi-zione tabellare della divisione stessa neacute vi fa riferimento
A questa procedura sono in effetti associate una tavola e una tabel-la costruite come segue (tavv 4 e 5 Marc gr 313 ff 17r e 17v il co-pista era ndash giustamente ndash insoddisfatto della prima versione) La tavola le cui righe e colonne sono delimitate da linee contiene sottomultipli44 del divisore 365 14 48 9 righe che riportano i valori da 160 a 960 piugrave altre 6 con i valori per decine da 1060 a 6060 la prima colonna elenca le 15 parti sessagesimali omettendo come drsquoabitudine la laquodenomina-zioneraquo dellrsquoordine (i numerali elencati sono quindi α β γ δ ε ϛ ζ η θ ι κ λ μ ν ξ) la seconda i sottomultipli corrispondenti organizzati su quattro colonne per tener conto dei tre ordini sessagesimali (il primo sottomultiplo egrave quindi ϛ ε´ ιδ´´ μη´´´ cioegrave 160 di τξε ιδ´ μη´´) La tabella priva di linee delimitanti espone la vera divisione Nella prima colonna troviamo i resti parziali ognuno preceduto dallrsquoindicazione del proprio ordine sessagesimale e da un segno per laquorestoraquo Nella seconda preceduti da un segno per laquosottrairaquo i sottraendi ognuno coincide ovviamente con uno dei sottomultipli nella tavola La terza colonna contiene se-guiti dallrsquoindicazione del proprio ordine sessagesimale i quozienti par-ziali ottenuti trascrivendo dalla prima riga della tavola il numerale corrispondente al sottraendo affiancato ed assegnando come ordine sessagesimale il successivo a quello posto in testa di riga Il risultato preceduto da un segno per laquorisultaraquo e posto al di sotto della tabella si ottiene sommando i quozienti parziali il procedimento non permette in generale di determinare lrsquointero quoziente parziale relativo ad un ordine sessagesimale fissato se non dopo due passi Una linea spezzata unisce i resti parziali successivi e i relativi sottraendi per evidenziare la laquoprogressione della proceduraraquo la spezzata lsquosaltarsquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore (le cui righe sono per il resto vuote) e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue di conseguenza anche il quoziente parziale relativo a questo resto appartiene allrsquoordine sessagesimale successivo
A questo punto possiamo rivolgerci alle tavv 4-5 e verificare se le immagini che ci siamo formati sulla base della mia descrizione corri-spondono a quelle che troviamo nel Marc gr 313 Non si tratta di un giochetto sterile egrave al contrario il cuore di un intrico di problemi Un primo ordine di problemi deriva dal fatto che nei Prolegomena lrsquoalgo-
44 Sottomultipli e non multipli in quanto il divisore egrave maggiore del dividendo Drsquoaltronde nel sistema sessagesimale come in quello decimale un sottomultiplo si ottiene dal multiplo corrispondente semplicemente scalando tutte le cifre di un posto (ad esempio 1360 di 365 14 48 si ottiene in questa maniera da 13 volte 365 14 48)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 139
ritmo della divisione lsquoalla Papporsquo non egrave mai eseguito (cioegrave formulato verbalmente) in maniera indipendente dalla descrizione della tabella Comrsquoegrave dunque possibile descrivere una tabella operazionale che non ha uno statuto testuale indipendente sulla base di un algoritmo in corso di esecuzione E drsquoaltro canto come non rilevare unrsquoanomalia in un algoritmo eseguito nella sua forma primaria sotto forma di descrizione di una tabella Ci potremmo chiedere se viene descritto lrsquoalgoritmo o la tabella La tensione fra i due enti grafici egrave acuita dal fatto che nei nostri testi tutto ciograve (esposizione o descrizione di un algoritmo o della tabella associata) avviene sempre e solo sulla base di un esempio numerico para-digmatico Per questo motivo la tabella in quanto struttura (cioegrave privata dei dati numerici accidentali) non puograve fare a meno della descrizione45 Dal canto suo Teone come forse Pappo ancor prima descrive ed espone la tavola dei (sotto)multipli ma non la tabella di divisione lrsquoalgoritmo relativo a questrsquoultima egrave espresso come per controbilanciare in maniera eccezionalmente trasparente e formulare Se ciograve comporta un guada-gno a livello verbale-argomentativo sorge un problema operativo grave come e dove sistemare i resti e i quozienti parziali ndash cioegrave tutti i numeri in output dellrsquoalgoritmo differenti dai (sotto)multipli ndash che la tabella si incarica di disporre in modo lsquonaturalersquo Teone prescrive soltanto di confrontare i resti con la seconda colonna della tavola dei sottomultipli e di trascrivere via via il quoziente ottenuto dopo ogni passo Insomma come eseguire materialmente una divisione Non certo adattando ad un nuovo caso specifico la formulazione dellrsquoalgoritmo che Teone propone
Un secondo ordine di problemi e una trappola micidiale per il co-pista egrave interno alla dialettica lsquotabellarsquolsquosua descrizionersquo ed egrave in assenza di simbolismo quello dei riferimenti linguistici da adottarsi nella seconda agli enti grafici che figurano nella prima Occorre ricercare la massima generalitagrave fornita da una descrizione definita di un ente numerico (ad esempio impiegando il termine laquorestoraquo o la perifrasi laquomassimo sotto-multiplo minoranteraquo) o basta assumere direttamente il suo valore speci-fico come esempio paradigmatico E in che modo risolvere il conflitto tra uso e menzione se come nel nostro caso la tabella contiene segni convenzionali ed occorre fornirne una descrizione Si rende ad esempio necessario introdurre un lsquooperatore di citazionersquo noi useremmo le virgo-lette la lingua greca premette lrsquoarticolo neutro Drsquoaccordo ma nel caso
45 Questa caratteristica non egrave connaturata alla matematica degli algoritmi la risorsa dello lsquostile proceduralersquo serve esattamente ad aggirare questo problema al di lagrave di un certo livello di dettaglio perograve essa condurrebbe ad un appesantimento insostenibile della for-mulazione dovuto alla pluralitagrave dei riferimenti agli oggetti matematici in gioco sulla que-stione dei diversi stili della matematica greca si veda Acerbi 2012
Fabio Acerbi140
greco qual egrave il suo range E come distinguerlo nei casi ambigui da un semplice articolo che precede un sostantivo quando questrsquoultimo lo ri-chieda Nel corso del processo di copia del testo della descrizione infine possono generarsi tensioni tra enti grafici interpretabili vuoi come segno convenzionale vuoi come abbreviazione Ambiguitagrave relative a questi punti opacizzano la descrizione Un problema analogo si porrebbe a priori nella dialettica tra uso delle lettere denotative per designare enti geometrici e loro menzione nella costruzione di un diagramma ma esso egrave risolto con lrsquoazzeramento della seconda funzione le lettere denota-tive sono sempre usate allrsquointerno del testo (sono cioegrave il referente degli oggetti geometrici di cui tratta il discorso matematico) mai menzionate (come accadrebbe se fossero il referente di oggetti grafici posti nel dia-gramma) Insomma il codice adottato per la costituzione dei diagrammi geometrici egrave condiviso (cioegrave canonizzato) semplice e perspicuo mentre quello per le tabelle operazionali non lo egrave da qui le sviste dei copisti e le trascuratezze di correttori ed editori
Infine chi vuole apprendere da questi testi come eseguire una divi-sione a cosa deve prestar fede se ad esempio a causa di errori di copia la descrizione finisce per non coincidere con la tabella operazionale visto che sono entrambe due maniere valide di eseguire lo stesso algoritmo Dopo tutto lo scopo di tutta questa macchina grafico-argomentativa egrave di insegnare a eseguire divisioni in formato tabellare Questo problema si fa particolarmente acuto se la tabella non egrave trasparente nel metodo di Pappo lo egrave quasi completamente in quello anonimo no E gli errori che riscontreremo nella (doppia) tabella ai ff 17r-v del Marc gr 313 a chi sono attribuibili Allrsquoautore al trascrittore o al copista medievale
Questo groviglio di problemi riceve alcune risposte sorprendenti dalla tradizione manoscritta come andiamo finalmente a vedere
4 Analisi delle testimonianze
I codici che ho adibito per lrsquoedizione sono i seguenti M = Marc gr 31346 C = Marc gr 314 (Tolomeo Tetrabiblos et opera minora cum commentariis Vezio Valente Anthologiae)47 Z = Vat gr 2326 (fattizio
46 Riferibile al sec IX ex-X in accolgo la datazione suggeritami per litteras il 522005 da Nigel G Wilson si veda anche Agati 1992 pp 141-142 La presenza non sistematica degli accenti che fa anticipare a Wilson la datazione di laquosaec X medraquo fornita in Mioni 1985 p 24 indusse Boris Fonkič (2005 non vidi) ad assegnare il codice allrsquoinizio del IX secolo
47 Il manoscritto riferibile alla seconda o terza decade della prima metagrave del XIV secolo fu vergato da Michele Clostomalle olim lsquoMetochitesschreiberrsquo Bianconi 2005a pp 428-430 Il titolo dei Prolegomena in questa trascrizione identico in grafia ma non in formulazione a
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 141
e mutilo Tolomeo Almagestum) S = Vat gr 184 (varia astronomica scholia miscellanea ad Almagestum Tolomeo Almagestum) P = Par gr 2390 (varia astronomica) gli ultimi tre riferibili allo scorcio del XIII secolo48 e apografi sicuri del Vat gr 159449 attualmente mutilo di due fascicoli che ci privano dei due terzi finali dei Prolegomena M e il Vat gr 1594 ammettono un modello comune il resto della tradizione (25 trascrizioni in tutto) dipende dagli apografi appena citati del Vat gr 1594 Le varianti della recensione bizantina che leggiamo tra lrsquoaltro nei Vat gr 198 Marc gr 310 (Tolomeo Almagestum cum commentariis Pappi Theonis et Cabasilae) e con ulteriori modifiche Laur Plut 89 sup 48 (varia astronomica Tolomeo Almagestum Barlaam Logistica) sono identificate dal siglum K e si trovano punteggiatura originale in-clusa nel secondo apparato50 Lrsquoanalisi delle testimonianze51 costituite ovviamente anche dalle tabelle associate saragrave condotta nella forma di una sequenza di osservazioni indicizzate da numerali o lettere oltre che di alcune note a piersquo di pagina
Iniziamo dalla descrizione del metodo di divisione anonimo
quello che leggiamo nel Vat gr 1594 (questrsquoultimo coincide con quello adottato nella recen-sione bizantina) fu apposto da Niceforo Gregora e successivamente corretto da Bessarione
48 Sto studiando il primo e il terzo codice in collaborazione rispettivamente con Daniele Bianconi e Inmaculada Peacuterez Martiacuten
49 Su questo codice risalente alla seconda metagrave del IX secolo e sulla sua collocazione nella lsquocollezione filosoficarsquo per prima proposta in Follieri 1977 pp 145-146 si vedano almeno Perria 1991 pp 82-88 Ronconi 2013 Che il titolo dei Prolegomena nel Vat gr 1594 sia stato apposto da Niceforo Gregora egrave stato riconosciuto per la prima volta in Mazzucchi 1994 p 211 n 196 si veda Bianconi 2005a p 418 per altri interventi di Gregora nello stesso manoscritto
50 Il Vat gr 198 egrave stato vergato dal copista Malachia nel corso del terzo quarto del XIV secolo Mondrain 2004 pp 278-290 e 292 Allo stesso copista (denominato non a caso prima dellrsquoidentificazione anonymus Aristotelicus) dobbiamo un buon numero di trascrizioni aristoteliche con i relativi commentari in margine Gli dobbiamo anche il Par gr 2342 secondo tomo di un quadrivium quasi completo di cui il Vat gr 198 egrave il primo nellrsquoordine aritmetica armonica astronomia (Almagesto e commentari relativi) nel codice vaticano geometria ed ancora astronomia (corpus astronomico minore) in quello parigino le opere trascritte sono sempre accompagnate in margine dai relativi commentari Il copista del Marc gr 310 egrave Isacco Argiro (ca 1300-1375) Mondrain 2007 p 166 Allo stesso Argiro dobbiamo il codice laurenziano (Daniele Bianconi per litteras) Poicheacute la recensione modificata che leggiamo nel Laur Plut 89 sup 48 egrave senza alcun dubbio basata su quella nel Marc gr 310 e non viceversa ci troviamo di fronte ad un copista che trascrive due volte lo stesso testo in due versioni leggermente differenti la conclusione naturale egrave che la seconda recensione egrave dovuta ad Argiro stesso la questione andragrave studiata in dettaglio
51 Nei manoscritti citati i Prolegomena si trovano ai fogli seguenti Vat gr 1594 ff 1r-8v (mutilo mancano due fascicoli su tre) Marc gr 313 ff 1r-28r (incompleto man-cano due fogli allrsquoinizio e il f 6 attualmente rimpiazzato da uno bianco) Marc gr 314 ff 235r-255r Vat gr 2326 ff 19r-40v e 43r-v (incompleto e con i fascicoli in disordine) Vat gr 184 ff 10r-23v Par gr 2390 ff 1r-13v Vat gr 198 ff 127r-136v Marc gr 310 ff 1r-13r Laur Plut 89 sup 48 ff 7r-19r
Fabio Acerbi142
ἐκθέμενοι οὖν διάγραμμα τῶν ἀριθμῶν ὡς ὑπόκειται προτάσσομεν τὸν μεριζόμενον καὶ μικρὸν ὑπ᾽ αὐτὸν τὸν μερίζοντα ὡς ἔχει τὸ διάγραμμα ἐν στίχοις διοριζομένοις ὑπὸ γραμμῶν [hellip] καὶ τὰ μὲν γινόμενα ἐγγὺς ἐλάττονα ἐν τῇ μεταξὺ θέσει τοῦ μεριζομένου καὶ τοῦ μερίζοντος ἐν στίχοις παρασημειοῦσθαι πρὸς τὸ ἀσύγχυτον εἶναι τὴν τάξιν τὰ δὲ μεθ᾿ ὧν ὁ μερίζων ἐποίει τοὺς ἀεὶ ἐλάσσονας ὑπὸ τὸν μερίζοντα σημειοῦσθαι προγράφοντας ἐπὶ τοῦ στίχου αὐτῶν τὸ γίνεται οὕτως γι ἐν δὲ τῷ στίχῳ τῶν μεριζόντων τὸ παρὰ ἔχον οὕτως oslash ἀντὶ τοῦ παρ᾿ ἃ δεῖ τὸν μερισμὸν γίνεσθαι ἐν δὲ τῷ στίχῳ τῶν ἐλασσόνων τὸ αφ διὰ τὸ τούτους ἀεὶ ἀφαιρεῖσθαι ἀπὸ τῶν ἐπάνω τῶν μεριζομένων ἐν δὲ τοῖς τοῦ μεριζομένου λοιπάσμασι τοῖς καὶ ἐπιοφείλουσι τὸ λ κατὰ τὸ ἴδιον τῶν διαστάσεων ἑκάστης ndash λέγω δὴ λοιπάδος ndash ἀντὶ τοῦ λοιποὶ οἱ μέλλοντες ἐπιμερίζεσθαι
2 post τὸν suprascr τὸν ἐλάττονα m 2 S 5 πρὸς] MP et ex corr Z κατὰ S om C | ἀσύγχυτον] MSPC -χητον Z 6 ἀεὶ] MZPC ὡσεὶ S 7 γίνεται οὕτως γι ] γι τ οὕτως γι τ M γί οὕτως γί Z γι οὕτως γί SC τὸ γινόμενον οὕτως γίνεται P 8 τὸ παρὰ ἔχον οὕτως] scripsi τὸ παρέχον οὕτως M et π(αρ-) comp Z οὕτως τὸ περιέχον S προγράφοντας οὕτως ex corr m 2 P τὸ περιέχον οὕτως C | oslash] MZSC (sed ο fecit | Z) ἐλάττων comp ex corr m 2 P | παρ᾿ ἃ] scripsi παρα M π(αρα) comp ZSC ex παρα fe-cit παρὰ et τοῦτον suprascr m 2 P 9 γίνεσθαι] comp C | αφ ] αφ ε M ἀφ ZSC ἀφαί P | ἀεὶ] om M 11 ἐπιοφείλουσι] MZSC ex ἐπιο- fecit ἐπο- m 2 P | λ] MZPC λ´ S 12 λοιποὶ] PC λοιποῦ MZS
3 στίχοις] στίχῳ K 5 πρὸς] διὰ K 7 ἐπὶ mdash γι ] τὸ γίνεται διὰ τοιούτου σ(ημείου) γί K 8 τὸ παρὰ ἔχον mdash παρ᾿ ἃ] τὸ παρᾱ διὰ σ(ημείου) τοιούτου καὶ τοῦτο oslash δηλοῦντος τοῦ παρᾱ ὅτι παρὰ τὸν τοιοῦτον (ἀριθμὸν) K 9 αφ διὰ τὸ τούτους] ἀφ δηλοῖ δὲ τοῦτο ἀφαίρεσ(ιν) ὅτι τούτους ἀεὶ δεῖ K 11 ἐπιοφείλουσι] ἐπιμερίζεσθαι ὀφείλουσι K | λ] λ οι` K 12 ἀντὶ τοῦ] δηλοῦντος τοῦ σ(ημείου) τὸ K
lsquoRendendo esplicito un diagramma numerico come lo troviamo qui sotto disponiamo in primo luogo il dividendo e un poco al di sotto di esso il divisore come li ha il diagramma in righe delimitate da linee [hellip] e lsaquooccorreragraversaquo nella posizione tra il dividendo e il divisore annotare lrsquouno accanto allrsquoaltro i piugrave vicini lsaquodei numerirsaquo minori che risultano affincheacute la disposizione non sia confusa quelli con cui il divisore faceva ogni volta i lsaquonumerirsaquo minori annotarli sotto il divisore scrivendo in prima posizione sulla loro riga laquorisultaraquo cosigrave Ris nella riga dei diviso-ri52 invece laquoperraquo fatto cosigrave53 P in luogo di laquoquelli per cui deve farsi la divisioneraquo nella riga dei lsaquonumerirsaquo minori laquosottrraquo in quanto questi sono sempre sottratti dai dividendi che si trovano sopra nei residuli del dividendo (occorre ben farlo anche per loro) laquoReraquo in accordo con ciograve
52 I laquodivisoriraquo sono al plurale ma siamo semplicemente di fronte a un tratto idioma-tico della lingua greca nel caso di espressioni generalizzanti crsquoegrave soltanto un divisore che occupa lrsquounica colonna di cui si compone la sua riga
53 Si intenda ἔχον οὕτως = ita se habens
1
5
10
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 143
che egrave proprio agli scarti di ciascuno ndash intendo qui lsaquociascunrsaquo residuo54 ndash in luogo di laquoresti che vanno a essere divisi ulteriormenteraquorsquo
a) Operatori di citazione e segni convenzionali I segni introdotti sono quattro la mia discussione egrave condotta dando per scontato che essi siano identici a quelli impiegati dallrsquoautore dei Prolegomena anche se si tratta di unrsquoipotesi non corroborabile neacute falsificabile
i Segno per il risultato Lrsquoabbreviazione convenzionale per γίνεται egrave identica al segno introdotto dallrsquoautore e i copisti si dividono tra i due errori possibili scrivere due abbreviazioni o risolverle entrambe Un fenomeno del tutto analogo si riscontra nel Matr 4678 il manoscritto alla base di tutta la tradizione degli Arithmetica di Diofanto al momen-to della definizione dellrsquoἀριθμός (lrsquolsquoincognitarsquo nel nostro linguaggio) ὁ δὲ μηδὲν τούτων τῶν ἰδιωμάτων κτησάμενος ἔχων δὲ ἐν ἑαυτῷ πλῆθος μονάδων ἄλογος ςο` καλεῖται ς` ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον τὸ ς` laquoil lsaquonumerorsaquo che non possiede nessuna di queste proprietagrave ma che ha in seacute una molteplicitagrave indefinita di unitagrave egrave chiamato lsquonumerorsquo e il suo segno egrave ς`raquo Qui solo il terzo dei tre ς ha una barra a sormontare per segnalarne il carattere puramente denotativo (cioegrave di segno convenzionale e non di abbreviazione si veda il punto successivo)55 il primo egrave una delle abbreviazioni piugrave diffuse per ἀριθμός (e infatti egrave dotato del compendio per la desinenza e dellrsquoaccento grave) il secondo egrave una delle piugrave comu-ni per καὶ () Giovanni Cortasmeno autore di capillari annotazioni infra lineam agli Arithmetica nel codice madrileno scioglie il primo ςο`
54 Doppia variatio che impiega al posto di λοιπόν laquorestoraquo i due termini decisamente non canonici τὸ λοίπασμα e ἡ λοιπάς (piugrave oltre leggiamo anche il participio λοιπασθέντα) Una ricerca sul TLG in rete non ha fornito occorrenze del primo si tratta dunque di uno hapax Quanto al secondo che ricorre anche nella sezione sulla divisione lsquoalla Papporsquo lo si rintraccia giagrave nei papiri documentari il termine diventeragrave perograve canonico nelle esposizioni bizantine drsquointroduzione allrsquoAlmagesto ricalcate sul modello dei Prolegomena (si veda la nota 87 infra) Questi due termini designano i resti parziali prodotti nel corso di una divisione lunga li ho tradotti rispettivamente con il neologismo laquoresiduloraquo e con il sostantivo pari-menti non canonico laquoresiduoraquo
55 Il copista interpreta erroneamente il terzo segno come unrsquoabbreviazione e qui ag-giunge un apice inverso (cioegrave un accento grave) altrove lo scioglie direttamente in forme opportune di ἀριθμός Matr 4678 f 58v La frase come la leggiamo nel manoscritto egrave cor-rotta sulla base di una parafrasi in Psello (edita in DOO II p 3710-12) Tannery emendograve ἄλογος in ἀόριστον DOO I p 64-5 et app Il Matritensis vergato da due copisti differenti (cambio di mano a tre righe dalla fine del f 62r) contiene lrsquoIntroductio arithmetica di Nicomaco e le opere diofantee oltre ad alcuni brevi opuscoli musicali la sua data egrave stata recentemente corretta dal XIII al secolo XI pm in Peacuterez Martiacuten 2006 (una riproduzione digitale del manoscritto si trova allrsquoindirizzo httpbdhbneesbnesearchbibliotecaDio-fanto20de20AlejandrC3ADa)
Fabio Acerbi144
in ἀριθμός ed aggiunge un altro segno56 sopra il terzo anteponendovi lrsquoindicazione καὶ ἔστιν αὐτοῦ σ(ημεῖον) τόδε Va da seacute che non abbiamo nessuna garanzia che il segno originariamente introdotto da Diofanto coincidesse realmente con unrsquoabbreviazione convenzionale per ἀριθμός Lrsquoevidenza del PMich III 144 (sec II in) suggerisce drsquoaltronde che il Matritensis e con esso tutta la tradizione medievale di Diofanto ripro-duca fedelmente pur accentuandone la sinuositagrave il segno originario
ii Segno per il divisore Un cerchiolino sbarrato da non confondere con il segno per ὁμοῦ che nei manoscritti matematici ha di norma due barre trasversali (cf tav 2a) Non sono riuscito a rintracciarne ulteriori occorrenze in altre opere la forma che esso assume nel Vat gr 2326 e la correzione apportata nel Par gr 2390 lasciano aperta la possibilitagrave per quanto a mio avviso remota che la forma originaria non fosse lon-tana da unrsquoabbreviazione di παρά registrata nei repertori57 Il correttore del Par gr 2390 trasforma in effetti il segno oslash nellrsquoaffine abbreviazione canonica per (forme di) ἐλάσσων laquominoreraquo58 e si incarica diligente-mente di farlo notare ricapitolando i segni nella porzione superiore del margine esterno del f 7v Nello stesso margine egli traccia anche uno lsquoscolio tabellarersquo ed egrave lrsquounico a porre il (proprio) segno dove indicato dalla descrizione (tav 6 Par gr 2390 f 7v) Oltre a ciograve adattando la tabella al margine ristretto lo scoliaste trascrive come colonne affian-cate le due righe dei resti parziali e dei massimi multipli e aggiunge le indicazioni ὁ μεριζόμενος laquodividendoraquo e ὁ μερίζων laquodivisoreraquo ma vi introduce alcune incongruenze di formato il risultato scritto in verti-cale e la linea verticale di sinistra che separa il divisore dal segno che lo dovrebbe precedere direttamente
iii Segno per i massimi multipli Corrisponde alla semplice abbre-viazione per sospensione della forma verbale ἄφελε laquosottrairaquo in questo
56 Si tratta del segno di ampio uso praticamente identico allrsquoabbreviazione canonica per οὖν
57 Si tratta di un pi a forma di gancio sbarrato da uno slash di troncamento Ce-reteli 1904 tav IX item 7 sub ΠΑΡΑ che rinvia al PVindRain 423 cf anche la forma π` nel POxy LXI 4142 edito in Jones 1999 II pp 26-34 In generale nei papiri e nei manoscritti matematici in maiuscola le preposizioni sono abbreviate facendo seguire un lsquoapostroforsquo alla loro prima lettera Α᾽ Υ᾽ ecc Per la seconda fattispecie di supporto libra-rio si veda in particolare il cosiddetto fragmentum mathematicum Bobiense scriptio inferior databile al V-VI secolo del palinsesto Milano Biblioteca Ambrosiana L 99 sup (Isidoro di Siviglia Etymologiae datazione Cavallo 1977 p 100) pp 113-114 che sono stampate in riproduzione apografa conforme in Belger 1881 (la p 114 egrave riprodotta anche nella tav 10 di Acerbi 2010)
58 Se questa era lrsquointenzione si tratta ovviamente di una forzatura il divisore puograve ben essere maggiore del dividendo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 145
caso lo slash di troncamento taglia orizzontalmente il tratto verticale del phi I copisti offrono molteplici varianti apponendo chi uno spirito dolce chi un ε chi un αί accentato a sormontare Tutti questi segni svolgono la funzione di abbreviazioni vere e proprie (e cosigrave doveva essere anche per lrsquoautore si veda il punto 1 di p 153 infra) la forma originale si ottiene a mio avviso incrociando i dati del Marc gr 313 e dei tre apografi del Vat gr 1594 αφ anche se lrsquoassenza dello spirito potrebbe essere semplicemente dovuta alla pratica del copista del codice veneziano di economizzare nei diacritici
iv Segno per i resti Un lambda completato da una barra a sormon-tare o da un apice che rinvia alle abbreviazioni per sospensione di una forma opportuna di λοιπός laquorestoraquo In realtagrave la forma che troviamo nella tabella egrave differente (tav 2b) e coincide con quella offerta quasi unanimemente dai manoscritti nella descrizione e in almeno un caso nella tabella del metodo di divisione attribuito a Pappo (tav 4) un lambda che accoglie al di sotto una legatura omicron-iota () sbarrata da uno slash di troncamento Qualcosa di simile si trova nel PVindob G 19996 (sec I) una specie di lambda maiuscolo molto aperto e dal vertice arrotondato che include un circoletto interpretato dagli editori come segno per περίεστιν o per λοιπόν59 Lo stesso segno si rintraccia ad esempio in un medesimo scolio tabellare di prima mano ad Alma-gestum nel Vat gr 1594 f 93v e nel Marc gr 313 f 135r ma stavolta la forma del lambda egrave molto ben definita
Fin qui i segni Ma il gioco egrave piugrave complesso La descrizione si muo-ve pericolosamente sulla linea di confine non sempre ben definita tra segno convenzionale e abbreviazione il primo ndash e il repertorio grafico matematico-astronomico ne egrave particolarmente fornito60 ndash puograve anche
59 Ho consultato lrsquoedizione Gerstinger ndash Vogel 1932 pp 46 e 48 la porzione rilevante del papiro egrave riprodotta nella tav 11 di Fowler 1999 Si veda ancora ivi pp 253-257 per la trascrizione di questo segmento di testo (con correzioni rispetto alla princeps) e per una messa a punto recente inclusa la proposta di datazione che ho riportato qui sopra Il verso del papiro che contiene una tavola aritmetica del tutto scorrelata dalla tematica del recto egrave edito come PRain Unterricht 151
60 La pratica di ridurre lo spazio occupato da un testo tecnico per mezzo di abbreviazioni e segni convenzionali era molto diffusa nei manoscritti in maiuscola contrariamente a quanto avviene per altri generi letterari vedremo tra breve cosa accade negli Arithmetica di Diofanto ma si leggano in proposito anche le considerazioni di Hei-berg nei prolegomena alla propria edizione dellrsquoAlmagesto in particolare riguardo al ricorso massiccio ad espedienti brachigrafici nel modello del Vat gr 180 POO II pp lxxxiv-xciii civ-cv cxxvii cxxxviii-cxxxix Agli elenchi dettagliati forniti da Heiberg possiamo aggiungere il piccolo prontuario stampato in Hultsch 1876-1878 III 2 pp 126-132 e basato sul testo e sugli scolii alla Collectio di Pappo nel Vat gr 218 (sec X in) Si vedano infine le osservazioni del copista del Par gr 2360 f 120v trascritte da Heiberg in AOO III pp x-xi sulle laquonotazioni tipiche a scopo di tagliar corto nello scrivereraquo impiegate nel pro-
Fabio Acerbi146
derivare dalla seconda (un caso egrave appunto il segno per ἐλάσσων che probabilmente trae origine da una legatura epsilon-lambda) ma poi il rapporto referente-relato si fissa convenzionalmente Quelli definiti nel testo che abbiamo letto sono appunto segni convenzionali non ci sarebbe bisogno di spiegarne forma e funzione se fossero intesi come abbreviazioni assumono nella tabella una funzione denotativa non esplicativa o discorsiva (come accade invece nella tav 1a) Ma come vengono descritti questi segni
I referenti delle descrizioni sono i segni sono introdotti da οὕτως (item i-ii) o in alternativa da un τό con il ruolo di lsquooperatore di citazionersquo (item iii-iv) che corrisponde esattamente alle nostre virgolette In entram-bi i casi gli enti sono menzionati e svolgono una funzione metalinguistica sono collocati materialmente nel testo ma egrave come se si trovassero fuori e la loro descrizione li additasse ndash in effetti i segni convenzionali scritti nel testo sono a loro volta i relata di quelli che si trovano nella tabella
I relata dei segni scritti nel testo sono di due tipi singoli vocaboli (item i-ii) o descrizioni della funzione dei segni per mezzo di clausole sintaticamente complesse (item ii e iv) I singoli vocaboli sono γίνεται e παρά e sono entrambi preceduti dal τό lsquocitazionalersquo in quanto relata di segni convenzionali le forme abbreviate con cui sono tracciati nei manoscritti vanno forzatamente sciolte Bisogna ammettere che la per-spicacia e le risorse grafiche dei copisti ndash di cui tutto si puograve dire fuor che commettano qui degli errori ndash sono messe a dura prova con lrsquointrodurre segni identici ad abbreviazioni o con lrsquoattivare un gioco metalinguistico particolarmente serrato in un contesto meno lsquonaturalersquo di come potreb-be esserlo ad esempio quello di un trattato grammaticale Lrsquoitem iii che presenta direttamente un segno identico ad unrsquoabbreviazione non egrave sorretto da una descrizione ma da una giustificazione in διὰ τό Lrsquoartico-lo τό vi assume una funzione metalinguistica anche se non lsquocitazionalersquo poicheacute al tempo stesso genera un infinito sostantivato e lo singolarizza per questo ho scritto laquosono sottrattiraquo in corsivo nella mia traduzione
prio modello archimedeo (nota 32 supra) egli ne compila anche una breve lista Un elenco antico di laquosegni della geometriaraquo sicuramente redatto per assistere il copista si trova anche al f 3v del ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 vergato da Efrem negli anni 950-960 (tav 8 in Acerbi 2010) Possiamo farci unrsquoidea quantitativa del guadagno di spazio in rapporto ad un testo privo di abbreviazioni e con le parole separate da spazi sulla base del fragmentum mathematicum Bobiense il testo vi egrave disposto a tutta pagina su 36 righe di circa 30 segni ciascuna nelle due pagine in questione figurano 2038 segni con 15 mezze righe occupate dalle due figure Ora nel testo dellrsquoedizione stabilita in Heiberg 1927 pp 87-90 le stesse pagine contano 4455 segni spazi compresi Ne risulta che la dimensione in caratteri di un testo matematico puograve essere ridotta di piugrave della metagrave con lrsquoimpiego di compendi e segni convenzionali
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 147
Negli item ii e iv il segno si collega ad una descrizione nel secondo caso in via esclusiva le descrizioni pertanto rinforzano o sostituiscono lrsquoidentificazione con lrsquoente linguistico denotato Le clausole descrittive sono precedute da ἀντί e dallrsquoarticolo τό con funzione di lsquooperatore di citazionersquo esse sono παρ᾿ ἃ δεῖ τὸν μερισμὸν γίνεσθαι (item ii) e λοιποὶ οἱ μέλλοντες ἐπιμερίζεσθαι (item iv) Nella descrizione della divisione lsquoalla Papporsquo che leggeremo tra breve i segni negli item iii e iv rice-vono lo stesso trattamento degli altri due il loro relatum egrave un singolo vocabolo e non una clausola descrittiva rispettivamente nelle espres-sioni τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε (sul participio ritorneremo nel punto 1 infra) e τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά (la forma del segno notato con λ οι egrave descritta supra nellrsquoitem iv) La descrizione del segno oslash per il divisore merita una discussione piugrave dettagliata In origine si trovava probabilmente scritto Π(ΑΡΑ)ΕΧΟΝ successivamente letto come π(αρ[α])έχον ndash dato che lrsquoabbreviazione per il preverbo egrave identica a quella per la preposizione (che sia Π᾽ o un pi seguito dal segno per ἄρα a sormontare) ndash invece di π(αρὰ) ἔχον I copisti e i correttori si dettero a tutte le possibili contorsioni per restituire un testo dotato di senso leggere appunto una forma verbale con preverbo modificare il preverbo (ma forse il segno per ἄρα era insidiosamente simile ad uno epsilon) correggere il testo rileggiamo lrsquoapparato sub τὸ παρὰ ἔχον οὕτως τὸ παρέχον οὕτως M et π(αρ-) comp Z οὕτως τὸ περιέχον S τὸ περιέχον οὕτως C προγράφοντας οὕτως ex corr m 2 P Nella clausola descrittiva seguente la presenza liminare di παρὰ (che ho corretto in παρ᾿ ἃ nella speranza di restituire una frase che abbia un senso senza intervenire sul testo) innesca un bel corto circuito il Π(ΑΡΑ) che sicuramente figu-rava nellrsquoarchetipo egrave un sintagma complesso una preposizione unrsquoab-breviazione o un segno per unrsquoabbreviazione Se lrsquoeditore si trova in conflitto con la propria inclinazione alla critica conservativa i copisti si rifiutarono di mettere mano ad un testo che doveva stridere anche per loro essendo il compito demandato al ritocco del revisore del Par gr 2390 o alla riscrittura radicale del recensore bizantino Il problema egrave che ci troviamo di fronte ad unrsquoespressione che descrive la funzione dellrsquooggetto denotato non lrsquooggetto stesso ma che lo contiene al suo interno per soprammercato qui il Π(ΑΡΑ) egrave usato per giustificare una menzione a sua volta relatum di un segno
Evidentemente questa maniera di procedere che giagrave aveva attirato interventi da parte di copisti e correttori della recensione di base parve insostenibilmente opaca allrsquoautore della recensione bizantina61 Egli
61 Uno dei manoscritti di questa recensione propone anche una tabella di divisione
Fabio Acerbi148
modifica tutte le descrizioni diluendo lrsquoidiomatismo dellrsquoarticolo lsquocita-zionalersquo con lrsquointroduzione sistematica del verbo δηλόω e di frasi atte a chiarire quale sia il segno denotante e quale il vocabolo (o il segno) denotato Egli introduce allo scopo di rendere esplicita la funzione de-notativa dei segni introdotti il termine σημείου curiosamente in tutte le sue tre occorrenze esso compare a sua volta nella forma dellrsquoabbrevia-zione per sospensione σΗ´ Egli traccia il segno per i massimi multipli ἀφ e quello per i resti λ οι` in modo che non vi siano ambiguitagrave quanto al loro carattere di abbreviazione Si faccia infine attenzione al residuo di barra sul παρᾱ con funzione denotativa (2 occorrenze) contenuto nella descrizione del segno per il divisore sostituita dallrsquoaccento grave nel παρὰ con funzione discorsiva (la differenza egrave nettissima nei manoscritti da me consultati) Questa osservazione ci permette di passare direttamente allrsquoitem seguente
b) Le barre sui numerali e sulle lettere denotative Egrave opportuno discutere questo punto adesso esattamente percheacute di barre siffatte che pure troviamo in tutti i manoscritti i nostri testi non fanno mai menzione si tratta infatti di una pratica condivisa sin dallrsquoantichitagrave La barra identifica una stringa di lettere dellrsquoalfabeto che non svolge una funzione grammaticale o sintattica propria allrsquointerno del discorso Ciograve avviene in particolare e si tratta della fattispecie piugrave frequente se la stringa di lettere non dagrave origine a un vocabolo della lingua greca lette-re denotative e numerali certo ma anche termini provenienti da altri idiomi e contrazioni di parole greche come i nomina sacra62 tali termi-ni possono essere o no preceduti da un articolo lsquocitazionalersquo a seconda dellrsquouso che ne viene fatto allrsquointerno del discorso Ma non si tratta dellrsquounica fattispecie i papiri grammaticali ed i manoscritti piugrave antichi dei trattati dello stesso argomento segnalano gli esempi delle parti del discorso (cioegrave di lsquoverersquo parole greche) per mezzo di barre sormontanti63 La differenza insomma egrave tra menzione e uso (come parte del discorso in atto) di una stringa di caratteri tra il porre le lsquovirgolettersquo e il non porle tra funzione denotativa e non Apparentemente la convenzione si limi-
corredata dei segni opportuni e contrariamente alle indicazioni della descrizione svilup-pata lsquoin verticalersquo ma per motivi misteriosi non completa (tav 7a Laur Plut 89 sup 48 f 13r)
62 Tutto ciograve egrave spiegato con estrema chiarezza giagrave in Traube 1907 pp 45-4763 Si veda il Par gr 2548 codex vetustissimus e testimone unico delle lsquoopere minorirsquo
di Apollonio Discolo il f 106v con le barre ben visibili egrave riprodotto come tav 19 in De Gregorio 2000 (ivi pp 137-138 per la datazione) Per la testimonianza dei papiri grammaticali si veda Wouters 1979 passim essi contengono di norma elenchi di parti del discorso nessuna delle quali egrave preceduta dallrsquoarticolo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 149
tava in questo secondo caso a segnalare con la barra singoli vocaboli le menzioni di frasi o di sintagmi complessi sono di norma identificate dallrsquoarticolo lsquocitazionalersquo Drsquoaltra parte le abbreviazioni convenzionali non rientrano nella casistica percheacute la loro resa grafica che contiene elementi non alfabetici come compendi per desinenze lettere supra li-neam marche di contrazione o sospensione quali slashes o barre sotto-poste o sormontanti eventualmente solo un sottinsieme della stringa di segni alfabetici le esclude automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
Venendo al discorso matematico una barra sormonta senza ecce-zione le lettere denotative64 che sia in papiri o in manoscritti in maiu-scola65 o minuscola ma solo allrsquointerno del testo comrsquoegrave da attendersi nei diagrammi esse la perdono per il semplice motivo che non crsquoegrave alcun testo ambiente un diagramma ha unicamente una funzione denotati-va Drsquoaltra parte le lettere numerali che a volte figurano nei diagrammi della tradizione metrica66 allo scopo di indicare la lunghezza dei seg-menti mantengono la barra in un diagramma il contesto denotativo geometrico egrave prevalente e i numerali vengono percepiti come entitagrave grafiche lsquoesternersquo al discorso Va da seacute a fortiori che le lettere numerali inserite in un testo dovranno essere segnalate da barre che a loro volta non servono nelle tavole67 in quanto queste ultime sono come abbiamo visto un vero e proprio testo che perograve funge da ambiente a quello al-fabetico limitato alle titolazioni e non a caso tracciato in unrsquoopportuna lsquomaiuscola distintivarsquo allo scopo di segnalarne il carattere denotativo e non discorsivo68 Una tabella operazionale egrave invece un paratesto e quindi le barre sulle lettere numerali che rappresentano gli interi sono
64 La notazione per le lettere denotative subigrave unrsquoevoluzione (il cui risultato finale egrave descritto per sommi capi nella nota 3 supra) di cui non mette conto occuparsi qui
65 I papiri di contenuto geometrico (o astronomici ma che presentano argomenti geometrici) sono rari si vedano il PHerc 1061 (sec II aC Demetrio Lacone De geome-tria) e il PFay 9 (sec II ex Elementi I 39 e 41) Gli importanti ostraka OBerl 12002 e 12609 (sec III aC m Elementi XIII) non pongono le barre sopra le lettere denotative Per i manoscritti in maiuscola si veda ad esempio passim nel Par gr 2389 una cui riproduzione digitale egrave consultabile in rete allrsquoindirizzo httpgallicabnffrark12148btv1b8470171d o il fragmentum mathematicum Bobiense
66 Si veda ancora il ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 codex unicus dei Metrica di Erone e contenente una raccolta importante di problemi del corpus metrologico
67 Si vedano come esempio le tavole citate alle note 10 e 14 supra Discorso a parte per il segno di lsquoposto vuotorsquo si veda il punto c che segue
68 Queste regole generali vanno prese cum grano salis si dagrave naturalmente un certo dominio di variabilitagrave legato verosimilmente al grado di cultura grafica del copista nel PMich III 144 i numerali sono quasi tutti senza barra sia nel testo che nelle tabelle ope-razionali
Fabio Acerbi150
necessarie esse mancano invece sui segni convenzionali che ho descrit-to nel punto precedente e fatto rilevante sulle lettere numerali relative agli ordini sessagesimali quando esse siano identificate da uno o piugrave apici la presenza di questo segno grafico non alfabetico69 le esclude ancora una volta automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo Unrsquoultima osservazione che ci saragrave utile nel seacuteguito la descrizio-ne di una stringa di lettere lsquoagrammaticalersquo non puograve prevedere la men-zione della presenza della barra che le pertiene in quanto tale si tratta di una pratica denotativa che egrave possibile formulare soltanto ad un livello di discorso superiore sia a quello dellrsquouso che a quello della menzione70
c) Il segno di lsquoposto vuotorsquo Si noti nella tav 2b la forma ŏ per il segno di lsquoposto vuotorsquo in un ordine sessagesimale coerentemente con la propria notazione il copista del Marc gr 313 lo scioglie talvolta allrsquoin-terno del testo principale come unrsquoabbreviazione per οὐδέν laquonienteraquo Altre convenzioni di scrittura del tratto che accompagna il circoletto e che si badi bene fa parte integrante del segno di lsquoposto vuotorsquo ndash e infatti nelle tavole troviamo sempre il segno completo mentre tutti gli altri numerali sono come abbiamo visto nel punto precedente privi di barra o di apice a causa del fatto che i vari ordini sessagesimali sono univocamente determinati dalle linee di giustificazione ndash un tratto an-golare anteposto (tav 3 Lar Plut 2818 f 136v)71 o una semplice barra a sormontare (tavv 4-9) si produce in questo modo il segno 65926 che sembra essere stata la forma di base72
69 Occorre dunque supporre come testimoniano papiri e manoscritti in maiuscola che la convenzione relativa allrsquouso della barra si sia consolidata ben prima dellrsquointroduzione di segni diacritici quali accenti e spiriti
70 Si veda il punto 2 infra per maggiori dettagli sulla questione delle barre e degli apici e per le indicazioni in merito che leggiamo in Diofanto
71 Come accennato questa tavola dei sottomultipli coincide con quella descritta ed esposta nei Prolegomena Fatto molto rilevante i numerali nella prima non recano neacute barre neacute apici contrariamente a quanto accade a tutte le istanze della seconda nei manoscritti Quella del Laur Plut 2818 preserva a mio avviso la forma originaria come abbiamo visto una tavola non richiede segni aggiuntivi sulle lettere numerali
72 Si vedano come esempio ancora le tavole citate alle note 10 e 14 supra oppure per una rassegna delle forme che il segno assume nei manoscritti piugrave antichi delle Tavole facili Tihon 2011 pp 58-59 e per quelle che assume nei papiri Jones 1999 I pp 61-62 Ovviamente non possiamo leggere il segno 65926 come un omicron con una barra in quanto ο = 70 nella notazione greca e la barra egrave di rigore quando il numerale figuri allrsquointerno di un testo Occorre ammettere che si dagrave origine ad un bel corto circuito notazionale con il concepire un segno con funzione di lsquoposto vuotorsquo ma che lsquosomigliarsquo ad una lettera dellrsquoalfabeto sormontata da una barra cioegrave ad un numerale in piugrave quando il lsquoposto vuotorsquo non corrisponda ad un intero ma ad una specie sessagesimale la presenza della barra a priori indistinguibile da quella che sormonta gli interi introduce unrsquoincongruenza con la notazione a mezzo di apici vista nellrsquoitem precedente
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 151
d) Errori di copia La tabella riprodotta nella tav 2b ha una forma simmetrica ma si tratta di una forzatura il grande rettangolo in basso a destra drsquoaltronde assente nella descrizione contiene uno scolio che fa notare come lrsquoultimo resto parziale ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ͵γτνζ´´´´´ κζ´´´´´´ cioegrave 0 0 0 0 0 3357 27 siano ἔγγιστα λ´λ´ δ´δ´ ξ laquocon ottima approssimazione 60 minuti quartiraquo dove si notino gli apici semplici per indicare il pas-saggio allrsquoordinale e il raddoppiamento del sistema segno + apice per significare il plurale Lo scolio debitamente accompagnato dal segno di rimando in forma di simbolo solare egrave stato probabilmente incluso nella tabella proprio allo scopo di renderla simmetrica A sua volta un errore precedente spiega lo spazio eccessivo accordato al rettangolo contenente lo scolio il secondo massimo multiplo ŏ λβ´ ξδ´´ ριβ´´´ σιϛ´´´´ egrave trascritto anche al di sotto del risultato
Passiamo ora alla descrizione del metodo di divisione attribuito a Pappo
ἵνα οὖν ταῦτα συναχθῇ τὰ ἐκ τοῦ μερισμοῦ ὁ εἰρημένος Πάππος εὐδιατύπῳ τινὶ καὶ πρὸς τοῦτο τάξει χρησάμενος ποιεῖται τὴν τῆς συλλήψεως τοῦ ζητουμένου ἀνεύρεσιν οὕτως ἐκθέμενος γὰρ τὸν μέλλοντα μερίζεσθαι τουτέστι τὰς τξ μοίρας ἐν ἀρχῇ ἀφαιρεῖ ἀπ᾽ αὐτῶν τὸν ἐν τῇ σελίδι τυγχάνοντα ἐλάττονα τουτέστι τὸν τδ κβ´ κ´´ ὄντα τῶν ἐγγὺς ἐλασσόνων ὡς πρὸς τοὺς ἐκκειμένους διὸ καὶ γράφει αὐτὸν προγράφων αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε καὶ εὑρίσκων τὰ παρακείμενα αὐτῷ τῷ ἀπογραφέντι ἐν τῷ σελιδίῳ λεπτὰ πρῶτα ν´ συναπογράφεται παρατιθῶν αὐτοῖς τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον ἀνατείνουσαν σημαῖνον τὸ εἶδος ὅτι πρῶτα λεπτά εὑρίσκει οὖν οὕτως τὸ τῶν τξ μέρος τὸ τδ κβ´ κ´´ ὃ μεριζόμενον παρὰ τὰς τξε ιδ´ μη´´ ἡμέρας καὶ ποιοῦν τὸν ἐκ τοῦ μερισμοῦ ἀριθμὸν πρῶτα λεπτὰ ν´ καὶ τὸν λοιπὸν ἀπογραφόμενος τὸν νε λζ´ μ´´ προτάσσει αὐτοῦ τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά τάσσει δὲ καὶ ἁπλῆν τινα διατείνουσαν γραμμὴν ὡς ἀπὸ τοῦ τξ ἐπὶ τὸν ἑξῆς ἐκτεθειμένον ἐγγὺς
1
5
10
1 εὐδιατύπῳ] ZSPC εὐδιατύπωτ M 4 ἀφαιρεῖ] MZSP ἀφ ι C 5 ἐλάττονα] P comp MZSC 6 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | αφ ] αφ ε M ἀφ ZS ἀφαί P ἄφ C | ἀντὶ] om C | ἄφελε] MZSP ἄφ C 8 ἀπογραφέντι] MZSP ἐγγραφέντι C | λεπτὰ πρῶτα] P λε πρωτα SC λεπτῶν πρωτ MZ | παρατιθῶν] MZS παρατιθεὶς C et ex corr m 2 P 9 ᾱ] Z αο P α´ MS α C | ἔχον] MPC ἔχων ZS 9-10 πρῶτα λεπτά] ZP πρωτ λ´λ´ M πρωτα λε S αα λε C 11 ἡμέρας] comp codd | ἀριθμὸν] P et comp MZ καὶ C et comp S 12 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M πρωτ λεπτ(α) Z πρωτ λ εᾱ S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C | ἀπογραφόμενος] MZSP ἐγγραφόμενος C | νε λζ´] MZSP λζ νζ C 13 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | λ οι] MZSC ex λ fecit λ οι P | προσσημαῖνον] MC et προσ- comp ZS προση- P | τὸ] MZC τὰ S et fecit m 2 P 14 ἀπὸ] MZSP πρὸς C ἐλάττονα] P comp MZSC
1 εὐδιατύπῳ] εὐδιατυπώτω K 6-7 αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ] τὸ ἀφ K 8 παρατιθῶν mdash 10 λεπτά] τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ σημαίνουσαν τὸ εἶδος αὐτῶν ὅτι ᾱ λεπτά εἰσιν K | τὸ (sec)] τὰ K 12 πρῶτα] πρώτων K | τε λ ] λ οι` K | προσσημαῖνον mdash
Fabio Acerbi152
ἐλάττονα τὸν τδ κβ´ κ´´ ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις καὶ ταύτην ἐπιδεικνύουσαν τὴν τάξιν τῆς προόδου τῆς ἐκθέσεως ἧστινος κλωμένης γραμμῆς πρὸς τῷ ἐγγὺς ἐλάσσονι ἡ ἀντανάκλασις ἐπὶ τὸν λοιπὸν γέγραπται φερομένη ὡς εἴρηται διὰ τὸ εὔτακτον τῆς προκοπῆς οὕτως τε ποιήσας ἑξῆς τὸ αφ ποιῶν ὃ προσσημαίνει ὡς εἴρηται τὸ ὅτι δεῖ ἀφελεῖν ὁμοίως ἀπὸ τοῦ λοιποῦ καὶ δὴ τὸν ἐγγὺς πάλιν ἐλάσσονα ὡς πρὸς τὴν ἐν τῷ σελιδίῳ ἔκθεσιν εὑρισκόμενον λαμβάνων ἑξῆς προγράφει αὐτὸν ὄντα νδ μζ´ ιγ´´ ιβ´´´ καὶ εὑρίσκει αὐτοῖς παρακείμενα ἐν τῷ σελιδίῳ πρῶτα λεπτὰ θ´ ἅτινα καὶ αὐτὰ προσαπογράφεται σὺν τῇ παρασημειώσει τῶν πρώτων γράφων τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον τὴν ἀνατείνουσαν καὶ ὡς εἴρηται τὴν γραμμὴν πάλιν διὰ τὴν τάξιν κλωμένην κατὰ δευτέραν κλάσιν προσέλκει γινομένου τοῦ μέρους αὐτῆς τούτου παραλλήλου τῷ ἐξ ἀρχῆς
16 ante κλωμένης add ἐπὶ C 18 τε] MZP om SC | αφ ] M ἀφ ZSC ἀφαί P 19 προσσημαίνει] MS προση- ZC et ex corr P | ὅτι] ZP comp MSC 20 δὴ] MZSC διὰ fecit m 2 P 21 πρὸς] MSP et supra lineam C ex ἀπὸ fecit m 2 Z | ιγ´´] MZSP νγ´´ C 22 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M ᾱᾱ λεπτὰ Z άάα λε S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C 23 προσαπο- γράφεται] απο suprascr in comp M 24 ᾱ] ZP α´ MS α C 25 κλάσιν] MP τάξιν ZSC | τοῦ] ZSPC τούτου M 26 τούτου] τοῦ bis ZSPC sed prius erasit m 2 P τοῦ M
mdash 18 προκοπῆς] om K | τε ποιήσας] ποιήσας καὶ K | αφ ] ἀφ K 19 τὸ] om K 21 προ-γράφει] γράφει K 22 σελιδίῳ] α´ σελιδίῳ K | ἅτινα] ἃ K 23 προσαπογράφεται] ἀπογράφεται K | τῶν πρώτων mdash 26 ἐξ ἀρχῆς] om K
lsquoAllo scopo di raccogliere ciograve che risulta dalla divisione il detto Pappo utilizzando anche in questo caso una certa disposizione ben strutturata determina nel modo seguente il lsaquonumerorsaquo cercato preso nel suo insieme collocando73 in testa il lsaquonumerorsaquo che sta per essere diviso cioegrave i 360 gradi iniziali sottrae loro tra i piugrave prossimi dei lsaquonumerirsaquo minori rispetto a quelli esposti quello che si trova essere minore nella colonna (cioegrave 304 22 20) Questo egrave il motivo per cui lo trascrive scrivendogli davanti lrsquoabbreviazio-ne laquosottrraquo per laquosottrairaquo e trovando che 50 minuti primi sono collocati accanto a quello stesso lsaquonumerorsaquo che egrave stato trascritto nella colonna li trascrive al tempo stesso collocando accanto74 ad essi la lettera A con un lsaquotrattorsaquo75 sopra che significa la specie minuti primi Trova dunque in que-sto modo la parte di 360 che egrave 304 22 20 la quale divisa per 365 giorni 14 48 fa il numero lsaquoche risultarsaquo dalla divisione 50 minuti primi Trascrivendo
73 La descrizione egrave strutturata come una procedura Acerbi 201274 Il purismo del correttore del Par gr 2390 di Clostomalle nel Marc gr 314 e
dellrsquoautore della recensione bizantina impone loro di modificare la terminazione ma forme tematiche e contratte di τιθεῖν sono correnti nel greco tardivo
75 Il testo greco ha solo il participio con γραμμήν sottinteso Per il significato del participio si veda il punto 2
15
20
25
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 153
poi il resto 55 37 40 gli pone altresigrave76 a prefisso laquoReraquo che significa laquorestiraquo e dispone anche una certa linea semplice77 che va da 360 al piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori che egrave esposto di seacuteguito 304 22 20 come nello lsaquoschemarsaquo esposto linea che mostra lrsquoordine del percorso dellrsquoesposizione Questa linea spezzata lagrave dove si trova il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori egrave tracciata inflessa allrsquoindietro lsaquoersaquo punta verso il resto come egrave stato detto in vista di una progressione ordinata E cosigrave facendo prendendo di seacuteguito il laquosottrraquo che significa come egrave stato detto laquoche occorre similmente sottrarre dal re-storaquo e ovviamente prendendo di nuovo il lsaquonumerorsaquo che egrave trovato essere il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori in relazione alla disposizione nella colonna ndash 54 47 13 12 ndash lo scrive di seacuteguito e trova che 9 minuti primi sono posti loro accanto nella colonna trascrive78 anche questi con la segnaletica dei primi scrivendo la lettera A con un lsaquotrattorsaquo sopra e come egrave stato detto prolunga di nuovo la linea spezzata in vista di una buona disposizione tramite una seconda inflessione essendo questa sua parte parallela a quella inizialersquo
La descrizione continua con una serie di laquoe cosigrave viaraquo e non fa ulte-riore riferimento alla tabella
1) La forma verbale ἐξεσμένον Egrave il neutro del participio perfetto medio-passivo di ξέω lett laquopialloraquo laquolevigoraquo Si danno tre possibilitagrave si tratta di un termine canonico per quanto non altrove attestato per designare unrsquoabbreviazione oppure lrsquoautore anonimo improvvisa sul piano metaforico come se unrsquoabbreviazione non fosse altro che la paro-la completa lsquoaccorciata a colpi di piallarsquo in maniera opportuna oppure il testo egrave corrotto e srsquoimpone una correzione ad esempio τὸ ἑξῆς μένον laquociograve che sta di seacuteguitoraquo Questrsquoultima strada mi pare chiusa dal senso delle frase lrsquoabbreviazione non lsquosta di seacuteguitorsquo a niente ma anzi precede la perifrasi τὸ ἑξῆς μένον se impiegata semplicemente per rimandare al segno αφ immediatamente seguente costituirebbe un intollerabile solecismo Se accettiamo la prima di queste letture considerando quin-di lrsquoabbreviazione αφ in posizione predicativa abbiamo a che fare con
76 Rendo in questo modo il τε isolato77 La linea egrave laquosempliceraquo in quanto egrave una retta la precisazione intende evidenziare per
anticipazione il carattere lsquonon semplicersquo che essa assumeragrave alla prima inflessione quando diventeragrave una spezzata linee siffatte erano in effetti concepite dallrsquoanonimo e prima di lui da tutta la tradizione matematica greca come una singola linea spezzata nei punti drsquoinfles-sione I due segmenti paralleli menzionati al termine del passo sono orizzontali
78 Il verbo egrave al medio in variatio rispetto ai due che precedono e che seguono egrave il matematico che lsquosirsquo trascrive le cifre
Fabio Acerbi154
uno hapax semantico nella grecitagrave superstite come egrave facile verificare con una ricerca sul TLG in rete La recensione bizantina risolve il pro-blema sopprimendo semplicemente τὸ ἐξεσμένον
2) La notazione per le specie numeriche Nella terminologia matema-tica greca gli ordini sessagesimali sono εἴδη laquospecieraquo numerici essi corri- spondono agli ordini di grandezza nel nostro sistema decimale e indica-no in analogia con il caso geometrico la lsquoformarsquo che assume un numero quadrato cubo ecc Centinaia e migliaia sono quindi degli εἴδη rispet-tivamente quadrati (100 egrave il quadrato di 10) e cubi (1000 egrave il cubo di 10) sono specie numeriche ma non numeri particolari e drsquoaltronde 300 non egrave un quadrato ma 3 item dellrsquoεἶδος lsquoquadratorsquo 100 3 egrave il numerale di molteplicitagrave della specie quadrata lsquocentinaiarsquo i due 0 che seguono il 3 segnalano esattamente questo fatto che la notazione greca per gli interi non posizionale fa scomparire al livello denotativo Ciograve non vale soltan-to per i numeri interi ma anche per le loro parti i minuti secondi appar-tengono alla specie lsquoquadratorsquo in quanto 13600 egrave il quadrato di 160
La concezione appare interamente dispiegata nellrsquointroduzione degli Arithmetica diofantei79 che si rivela giova farlo rimarcare un te-stimone fondamentale per la ricostruzione della notazione matematica antica Alle specie usate in questrsquoopera vengono assegnati una denomi-nazione ed un segno convenzionale costituito dallrsquoiniziale (di ognuno dei componenti) della denominazione al quadrato o δύναμις il segno ΔΥ al κύβος il segno ΚΥ alla lsquoquarta potenzarsquo o δυναμοδύναμις il segno ΔΥΔ ecc La descrizione di tali segni egrave del tipo καὶ ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον Κ ἐπίσημον ἔχον Υ ΚΥ κύβος laquoe il suo segno egrave un Κ che ha come indice un Υ ΚΥ cuboraquo dove in accordo con quanto abbiamo visto nel punto b supra e pur nel comprensibile imbarazzo del copista della prima parte del Matritensis (o di un suo passato collega) a districarsi in questo formidabile ginepraio notazionale80 le due lettere Κ e Υ ricevono una barra mentre ΚΥ non la richiede a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον il quale ancora una volta esclude automaticamente il segno dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
79 In particolare a DOO I pp 214-62180 Nel Matr 4678 riscontriamo i seguenti fenomeni nelle poche righe a cavallo dei ff
58r-v 1) accento acuto posto su tutti i segni come se fossero abbreviazioni 2) ripetizione sistematica segnodenominazione come in ΚΥ κύβος appena letto dovuta sicuramente allrsquointrusione di glosse interlineari esplicative dei segni ndash e successivo pentimento (δύναμις e κύβος sono in effetti cancellati dalla prima mano il primo con un tratto il secondo con dei punti supra lineam poi il copista si stanca di correggere) 3) nella descrizione del segno per la δυναμοδύναμις menzione di un δέλτα δύο che saragrave molto probabilmente stato ΔΔ subito dopo nella descrizione del κυβόκυβος si legge un incongruo δύο KK
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 155
Diofanto introduce poi dei segni anche per le specie delle parti dellrsquounitagrave (le nostre frazioni) che egli chiama ὁμώνυμα μορία laquoparti omonimeraquo di cui quelle sessagesimali sono casi particolari81 Egli spie-ga appunto che le loro denominazioni sono ottenute da quelle delle specie degli interi per sinonimia passando ad un lsquoordinalersquo82 formato semplicemente aggiungendo il suffisso -στον δυναμοστόν κυβοστόν δυναμοδυναμοστόν ecc (sott μόριον) I loro segni convenzionali sono invece ottenuti da quelli per le specie degli interi aggiungendo una γραμμὴν διαστέλλουσαν τὸ εἶδος laquolinea che distingue la specieraquo83 Una linea sui segni delle specie delle parti egrave richiesta si badi bene per distinguerli dai segni di quelle degli interi come giagrave osservato questi ultimi sono giagrave lsquoagrammaticalirsquo a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον a fortiori lo saranno anche i primi Si tratta della traduzione semio-tica del passaggio dal cardinale allrsquoordinale che a livello grammaticale egrave effettuato con il suffisso -στον Che forma ha questa linea Barra o apice (Egrave cervellotico pensare a forme piugrave complesse) La domanda non ammette una risposta immediata in quanto delle specie diofantee nessuno piugrave si occupa nellrsquoantichitagrave84 Se egrave vero che la prima risposta darebbe origine ad un conflitto tra due convenzioni denotative diffe-renti la barra lsquocitazionalersquo e la barra che distingue la specie lrsquoevidenza grafica del Matritensis lascia lievemente sgomenti (ricordiamoci che giagrave i segni di base sono indebitamente dotati di un accento dal copista) Le poche occorrenze del segno per le specie delle parti85 vedono lrsquoaggiunta di uno slash di sospensione di un doppio apice inverso ndash in tutta evi-
81 Questo fatto era giagrave chiaro nellrsquoantichitagrave Teone in Alm I 10 in iA p 45310-1682 Il parallelo con i cardinali e gli ordinali relativi agli interi egrave reso esplicito da Dio-
fanto ὥσπερ δὲ τῶν ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια παρομοίως καλεῖται τοῖς ἀριθμοῖς τοῦ μὲν τρία τὸ τρίτον τοῦ δὲ τέσσαρα τὸ τέταρτον οὕτως καὶ τῶν νῦν ἐπονομασθέντων ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια κληθήσεται παρομοίως τοῖς ἀριθμοῖς laquocome le parti omonime dei numeri sono chia-mate per assonanza con i numeri di lsquotrersquo lsquolsaquounrsaquo terzorsquo di lsquoquattrorsquo lsquolsaquounrsaquo quartorsquo cosigrave le parti omonime dei numeri appena nominati saranno chiamate per assonanza con i numeriraquo (DOO I p 69-13 si noti lrsquoarticolo lsquocitazionalersquo al singolare in τοῦ τρία e τοῦ τέσσαρα) Il parallelo prosegue anche al livello dei segni che rappresentano queste specie come vedremo tra un attimo
83 Diofanto Arithmetica prefazione in DOO I p 620-21 un passaggio maltrattato in questa edizione occorre espungere il participio ἔχον senza introdurre segni ulteriori oppure eliminare un precedente ἐπί come fa un correttore del Matritensis f 58v
84 Unica parzialissima eccezione lrsquoaccenno di Teone menzionato nella nota 81 supra85 Al f 59r e per di piugrave nel margine per sanare un lungo saut du mecircme au mecircme La
collocazione in margine egrave il motivo per cui troviamo una notazione abbreviata nel resto del trattato il primo copista scioglie tutti i segni prendendoli per abbreviazioni mentre il secondo elimina sistematicamente il tratto aggiuntivo delle specie delle parti dellrsquounitagrave Drsquoaltronde egli scrive ad esempio ΔΥ invece di ΔΥ ed egrave quindi indotto a porre la barra al di sopra della stringa di lettere risultante (passim ma si veda ad esempio il f 72r)
Fabio Acerbi156
denza il compendio per la desinenza -ον accentata il copista interpreta il segno come unrsquoabbreviazione ndash e di una barra a sormontare lo Υ Potremmo forse interpretarlo come il segno di contrazione del grafema -στ- lrsquounico tassello mancante in unrsquoabbreviazione come ad esempio (δυναμοδυναμο)(στ)(ὸν) ma uno scolio di prima mano al f 58v rela-tivo alle specie degli interi inficia questrsquoipotesi esse sono dotate di slash di sospensione accento acuto in un caso del compendio canonico per la terminazione -ον hellip ma tutti gli Υ a esponente sono a loro volta sormontati da una barra
Meno legata al singolo manoscritto ma nondimeno non uniforme si presenta la pratica di notazione dei segni che rappresentano gli enti numerici sessagesimali86 da una parte sta lrsquoevidenza del testo dei Pro-legomena e delle sue tabelle apici ndash drsquoaltronde come abbiamo visto la notazione universalmente impiegata per i numerali ordinali e per le fra-zioni unitarie ndash dallrsquoaltra sta lrsquoevidenza del testo dellrsquoAlmagesto in tutti i manoscritti piugrave antichi e lo stesso si dica del commentario teonino a questrsquoopera o del suo lsquoGrande commentariorsquo alle Tavole facili e dei testi astronomici su papiro barre87 Sembra insomma che la nostra docu-
86 Sia le molteplicitagrave che le specie ahimeacute entrambe rappresentate da lettere dellrsquoalfabeto Come osservato allrsquoinizio della sezione 3 ci sono in effetti due tipi di lettere numerali in gioco se facciamo astrazione da apici o barre lsquo4 minuti secondirsquo si trova scritto δ β la prima lettera numerale denota la molteplicitagrave degli item di una certa specie la se-conda la specie nei Prolegomena entrambe sono accompagnate da un doppio apice il che rende inutile la presenza delle seconde Si noti che la descrizione della tabella non fa parola della notazione da usare per le lettere numerali che denotano la molteplicitagrave barre o apici e quanti apici hellip In questo caso fa interamente fede la tabella cioegrave la pratica grafica condivisa instauratasi non egrave chiaro quando
87 I manoscritti piugrave antichi dellrsquoAlmagesto sono menzionati nella nota 10 supra quelli dei due commentarii teonini sono il Laur Plut 2818 e il celeberrimo Vat gr 190 (sec IX in Euclide Elementi Data Teone lsquoGrande commentariorsquo) per la notazione dei pa-piri astronomici si veda Jones 1999 II passim La notazione non sembra lsquoinquinatarsquo dalla pratica dei copisti bizantini e pare dipendere soltanto dalla data di composizione Tro-viamo ad esempio barre sopra tutti i numerali di molteplicitagrave (interi o sessagesimali) nel frammento di un commentario alle Tavole facili contenente un calcolo relativo al 24 aprile 213 (Par gr 2841 sec XIII ex-XIV in oltre al frammento ai ff 32r l 11-34v l 23 contiene Arato Phaenomena ed Efestione Apotelesmatica edizione in Jones 1990) Nel commentario alle Tavole facili composto ca 610-617 ed attribuito a Stefano di Alessandria la situazione egrave la seguente (Jean Lempire per litteras per lrsquoedizione si veda Lempire 2014 ho controllato il Vat gr 304 ff 135r-171v sec XIV am contiene in aggiunta Teone in Almagestum I-II lsquoPiccolo commentariorsquo alle Tavole facili Diofanto Arithmetica e De polygo-nis numeris varia astronomica tabulae) barre sopra gli interi sporadicamente rimpiazzate da apici apici sopra le parti sessagesimali in numero uguale alla denominazione doppio () apice per le frazioni unitarie Sono impiegate barre sopra gli interi e apici sopra le parti sessagesimali nei manoscritti principali di tutti i trattati di introduzione allrsquoAlmagesto o comunque di argomento logistico redatti in epoca bizantina Giorgio Pachimere (1242-ca 1310) Quadrivium (autografo nel manoscritto Roma Biblioteca Angelica gr 38 [RGK III nr 115] si veda Tannery ndash Steacutephanou 1940 per lrsquoedizione) Teodoro Metochita (1270-
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 157
mentazione si faccia testimone di un cambio notazionale avvenuto nel periodo intercorrente fra Teone (sec IV pm) e la scuola alessandrina di Ammonio e dei suoi allievi (sec VI in) e probabilmente innescato da questrsquoultimo ambiente lrsquoaspetto paradossale egrave che nello stesso codice si rintraccino due notazioni differenti per gli enti numerici sessagesimali e lrsquouna (apici) sia adottata sistematicamente e coerentemente in uno scritto (i Prolegomena) che si presenta esattamente come unrsquointroduzione tecnica alla pratica numerico-algoritmica del trattato (lrsquoAlmagesto) in cui egrave adottata lrsquoaltra (barre che ritroviamo senza eccezioni anche negli scolii)
Torniamo ai Prolegomena la descrizione del segno da porre a fianco di ogni singolo quoziente parziale e denotante la sua specie numerica (minuti primi minuti secondi ecc) solleva tre problemi
Primo problema Ci vuole una barra o un apice su τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquola lettera A [hellip] che significa la specieraquo quando lo scriviamo nella tabella Tutta la nostra discussione precedente fa pro-pendere per lrsquoapice e si ricordi anche la forma verbale ἀνατείνουσαν che suggerisce qualcosa che si lsquoestende verso lrsquoaltorsquo (la mia traduzione egrave volutamente neutra) se fosse apposta una barra la cosa dovrebbe passare
1231332) Compendium astronomicum (copia lsquoautorizzatarsquo coeva nei Vat gr 182 e 181 da parte del copista che integrograve le parti mancanti del Par gr 2389 [ff 207-210 255-270 374-375] Bianconi 2005a pp 425-427 Peacuterez Martiacuten 2008 p 436 e n 177) Teodoro Meliteniota (morto lrsquo831393) Tribiblos astronomica (autografo nel Vat gr 792 si vedano Leurquin 1991 per unrsquoanalisi del manoscritto Leurquin 1990 per lrsquoedizione) una com-pilazione anonima (per cui ho consultato il Par gr 2396 ff 87r-92v limitatamente a questi fogli manu Costantino Trivoli [RGK II nr 318 ma ovviamente questo codice non vi egrave segnalato] terzo quarto del XV secolo il resto del codice annotato da Niceforo Gregora egrave di etagrave planudea e parzialmente [ff 33v-76v] un autografo di Planude stesso contiene Teone in Almagestum I II IV Mondrain 2002 il codice va completato ndash limitatamente a stralci dei libri VIII-X XII-XIII del commentario teonino la cui parte intermedia si egrave persa ndash con 26 carte [ff 123-147] inserite nel Vat gr 1087 anchrsquoesso contenente anno-tazioni di Gregora Rome 1927 per la figura del copista dei ff 77r-86r del Par gr 2396 e dei ff appena nominati del Vat gr 1087 un anonimo collaboratore di Gregora si veda in ultimo Bianconi 2006a pp 147-151) si veda anche il calcolo effettuato da Niceforo Gre-gora (12921295-13581361) dellrsquoeclisse di sole del 16 luglio 1330 (attestata unicamente ai ff 1r-8v della miscellanea astronomica Marc gr 325 databile ca 1324-1329 in parte vergata e ovunque fittamente annotata da Gregora stesso edizione del testo in Mogenet et al 1983 annotazioni di Gregora elencate in Bianconi 2005a p 413) Unrsquoeccezione apparente il lsquoPiccolo commentariorsquo di Teone alle Tavole facili le parti sessagesimali sono segnalate da apici (ad esempio nel Vat gr 175 vergato da Giovanni Catrario e completato nel 1321-1322 sulla figura di Catrario si vedano in ultimo Bianconi 2005b pp 141-156 e 2006b) lrsquoopera egrave antica ma la sua tradizione non rimonta oltre la fine del XIII secolo a parte un frammento nel Leiden BPG 78 ff 156r-161v (minuscola del IX-X secolo) e in effetti in questo manoscritto tutti i numerali di molteplicitagrave sono sormontati da barre Unrsquoeccezione effettiva egrave il De hypotesibus planetarum nel Vat gr 1594 barre sugli interi e apici sulle parti sessagesimali
Fabio Acerbi158
sotto silenzio e la presenza dellrsquoapice la rende inutile88 Si tratta della stessa convenzione diofantea e coincide ancora con la notazione per i numerali ordinali e per le frazioni unitarie che egrave corrente nei mano- scritti matematici greci per questo motivo non percheacute la descrizione sia particolarmente perspicua nessuno dei copisti della recensione an-tica ha incertezze apici Ma questi apici si rintracciano soltanto sulle indicazioni di specie non contemplate dalla descrizione che sono ante-poste ai resti parziali a fianco dei quozienti parziali i segni di specie sono invece trasformati in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordi-nali corrispondenti del tipo πρωτ tavv 5 e 7b-8 Il recensore bizantino taglia invece la testa al toro elimina dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali elimina la seconda menzione della laquolet-tera Araquo contestualmente allrsquoazzeramento dellrsquoespediente della linea a zig-zag (si veda il punto seguente) modifica la descrizione che contiene la prima menzione in quella dellrsquoapice associato direttamente ai nume-rali di molteplicitagrave riciclando addirittura lrsquoalpha per adibirlo a desi-gnare un numero cardinale (come sorprendersi) τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ laquoponendo al di sopra di essi [scil dei 50 minuti primi] 1 solo lsaquoaccentorsaquo acutoraquo La scelta del recensore egrave assennata che rechi una barra o un apice in una tabella un alpha denota un numero non un numero drsquoordine
Secondo problema da tenere ben distinto dal precedente Cosa ci vuole sul segno α per la lettera alpha menzionata nella frase τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquolettera A [hellip] che significa la specieraquo89 Unrsquooc-chiata allrsquoapparato critico rivela una bella incertezza nei manoscritti Z scrive sempre ᾱ e in un caso lo fa anche P MS optano sempre per α´ C per α P scrive nellrsquoaltro caso αο Per quanto solo la barra sia congrua con il senso della frase in quanto la lettera alpha egrave qui menzionata (si tratta di un oggetto che compare nella tabella) e non cambia niente se essa egrave accompagnata dal suo nome di genere στοιχεῖον ad un livello grafico lrsquoincertezza fra il segno ᾱ che denota laquola lettera αraquo e il segno α´ (o lrsquoabbreviazione αο) per una forma di πρῶτος egrave per piugrave versi giustificata
88 Detto in altri termini la barra egrave uno strumento grafico non matematico e quindi la sua presenza non va segnalata mentre un apice lo egrave e la sua presenza lo deve
89 Notare che in questa frase il primo α non vuole la barra (egrave menzionato allrsquointerno di una frase che impiega convenzioni moderne) il secondo sigrave (idem ma con convenzioni antiche) ndash e nella traduzione la scelta di denotarlo con A (senza virgolette) e non con lsquoArsquo (con virgolette) egrave del tutto arbitraria ndash si noti inoltre che le necessarie precisazioni laquosenzacon virgoletteraquo mostrano che le lingue moderne palesano difficoltagrave analoghe a quelle del greco antico per quanto riguarda i livelli denotativi in ambito metadiscorsivo per non usare le due parentetiche avrei dovuto scrivere rispettivamente lsquoArsquo e lsquolsquoArsquorsquo (doppie virgolette semplici)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 159
ᾱ coincide con il numerale 1 α egrave la prima lettera dellrsquoalfabeto ed inoltre α´ egrave esattamente quello che va scritto nella tabella Potremmo dirci che il sostantivo στοιχεῖον chiude la questione la sua presenza congiunta ad un ipotetico α´ renderebbe la descrizione ridondante o inappropriata90 Ma a parte il fatto che α egrave proprio τὸ πρῶτον στοιχεῖον il segno α´ cat-tura in fondo il cuore della descrizione di uno στοιχεῖον ἔχον lsaquoγραμμὴνrsaquo ἀνατείνουσαν
Terzo problema Lrsquoautore dei Prolegomena che si arresta allrsquoesem-pio dei minuti primi non dice quanti apici occorre mettere sulle lettere numerali che identificano gli ordini superiori al primo se uno soltanto come nel caso diofanteo e delle frazioni unitarie o in numero uguale alla loro denominazione (cioegrave pari al numero denotato dal numerale stesso su cui vanno posti) come effettivamente avviene nei mano-scritti dei Prolegomena La tabella egrave quindi sottodeterminata dalla sua descrizione anzi in un certo senso prende il sopravvento su di essa la pratica di marcare i numerali di molteplicitagrave con gli apici che compe-tono allrsquoordine cui appartengono viene trasferita ai segni per gli ordini stessi per supplire ad una descrizione carente di questi ultimi E la tabella egrave sottodeterminata dalla descrizione in quanto egrave la descrizione di una tabella reale ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις laquocome nello lsaquoschemarsaquo espostoraquo leggiamo a un certo punto del testo
3) La linea a zig-zag Non possiamo che applaudire a questo geniale espediente grafico lo troviamo messo in opera solo nel Marc gr 313 Per quanto lrsquoautore non faccia parola di ciograve nel corso della sua descrizione la linea spezzata egrave intesa dover lsquosaltarersquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue Il copista del codice marciano effettua correttamente due salti nella prima delle sue tabelle (tav 4) ma inserisce un lsquodentersquo in piugrave in quella che considera corretta (tav 5) La linea a zig-zag egrave incompatibile con la presenza di linee di giustificazione nella tabella che in effetti mancano nel Marc gr 313 ciograve induce gli errori di allineamento dei primi 5 quozienti parziali di cui egrave vittima il copista Probabilmente per questo motivo in nessuno degli apografi del Vat gr 1594 la linea a zig-zag figura nella tabella inquadrata come si conviene da una (doppia) cornice esterna e le cui colonne sono appunto separate da linee verticali (tav 7b Vat gr 184 f 17v e tav 8 Par gr 2390 f 9v cui egrave sostanzialmente identica la tabella del Marc gr 314 che si trova
90 Trascuro lrsquoabbreviazione αο = πρῶτος percheacute la desinenza non egrave quella richiesta neacute nella frase (egrave richiesto πρῶτον) neacute nella tabella (πρῶτα)
Fabio Acerbi160
al f 248r ndash ma la mancanza di linee orizzontali causa un gigantesco pa-sticcio nel codice vaticano) Alla recensione bizantina che dipende per il suo testo di base dal Vat gr 1594 e quindi non trova la linea a zig-zag nella tabella non resta che sopprimere la sua descrizione ndash ma proprio per questo motivo e finalmente diventa possibile tracciare un apparato completo di linee di giustificazione (tav 9 Laur Plut 89 sup 48 f 14v) Dato che la descrizione di Teone di questo procedimento di divi-sione non fa cenno allrsquoesistenza della linea a zig-zag viene da chiedersi se essa non costituisca un espediente escogitato dallrsquoautore dei Prolegomena per vivacizzare la procedura originale di Pappo
4) Discrepanze tra descrizione e tabella Il gioco delle minime va-rianti mostra che la divisione era stata eseguita (e trasmessa) corret-tamente tutti i valori numerici sono esatti La tabella nel Marc gr 313 presenta perograve alcune discrepanze con la propria descrizione Essa omette (ma non nella versione lsquoscorrettarsquo lrsquoomissione non si riscontra neanche nel Par gr 2390) il segno per laquorestoraquo di fronte ai resti par-ziali ma aggiunge lrsquoindicazione della loro specie Essa trasforma invece come abbiamo visto le indicazioni di specie che seguono i quozienti parziali in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordinali corri-spondenti La descrizione prevede di chiudere la tabella con il risultato καὶ συνάγων ἅπαντα τὰ ἐκ τῶν μερισθέντων μερῶν λεπτὰ σημειοῦται ὑπὸ πάντας οὕτως γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoe raccogliendo tutti i minuti che provengono dalle parti divise lsaquoPapporsaquo nota sotto tutto cosigrave Ris 0 59 8 17 13 12 31raquo ma sotto la tabella tutta la tradizione ci consegna qualcosa di piugrave articolato ὁ ζητούμενος καθ᾽ ὃν μερίζεται ὁ τξε ιδ´ μη´´ π(αρὰ) τὸν τξ γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoil lsaquonumerorsaquo cercato secondo cui 365 14 48 egrave diviso per 360 risulta 0 59 8 17 13 12 31raquo frase che del resto contiene due errori lrsquoinversione del dividendo e del divisore e la confusione tra segno convenzionale (iuxta descrizione) e abbreviazione (come nella frase) nel caso di γι Oltre ad eliminare la linea a zig-zag91 la recensione bizantina sopprime dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali e modifica come abbiamo visto al punto 2 le loro descrizioni in quelle di apici associati diretta-mente ai numerali di molteplicitagrave
91 Le due righe che nella recensione di base contengono solo i resti parziali minori di 160 del divisore ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue sono in parte completate con lrsquoindicazione abbreviata ἀνάλ(υσις) laquoanalisiraquo il termine greco per questa procedura di riduzione In un sussulto di ipercorrettismo matematico tali resti parziali ridotti non sono preceduti dal segno per laquorestoraquo come nel Par gr 2390 ma da quello per laquorisultatoraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 161
Gli esempi che abbiamo discusso mostrano come i problemi di notazione pesino e non poco sullrsquoespressione discorsiva di un algorit-mo matematico lrsquoente di riferimento per lsquoformularersquo il procedimento di divisione fu considerata la tabella cioegrave un oggetto la cui costitu-zione egrave legata piugrave ad una pratica grafica che a considerazioni logico- algoritmiche non la sua descrizione che in effetti finisce per determi-nare la tabella in maniera non univoca Di questa sottodeterminazione si fa testimone la traiettoria che abbiamo cercato di seguire nelle mani di copisti e revisori il procedimento di divisione si modifica a volte in aspetti secondari a volte in punti piugrave sostanziali ndash fino a rendere neces-saria una radicale revisione della sua descrizione per renderla conforme alla tabella ndash in ogni caso mai per ragioni squisitamente matematiche92
Abstract
The article presents and discusses in detail two passages from the anonymous Prolegomena to the Almagest a VIth century primer to the elementary procedures of calculation needed in Ptolemyrsquos Almagest In the two passages we may follow the complex interplay between mathematical notation the auctor who employed and described it the tachygrapher who transcribed it in vivo copyists who reproduced it correctors who modified it Along this path misgivings and errors arise in the transmission of abbreviations and paratextual units such as diagrams tables operational schemes
Fabio AcerbiCNRS UMR8560 Centre Alexandre Koyreacute
fabacerbigmailcom
92 Sono grato a Daniele Bianconi Lucio del Corso Jean Lempire per alcune preziose indicazioni
AOO = Archimedis opera omnia cum commentariis Eutocii ed J L Heiberg I-III Lipsiae 1910-1915
DOO = Diophanti Alexandrini opera omnia cum Graecis commentariis ed P Tannery I-II Lipsiae 1893-1895
GC = Le laquoGrand Commentaireraquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Mogenet ndash A Tihon I-III Cittagrave del Vaticano 1985-1999
iA = Commentaires de Pappus et de Theacuteon drsquoAlexandrie sur lrsquoAlmageste ed A Rome I-III con paginazione continua Cittagrave del Vaticano 1931-1943
HOO = Heronis Alexandrini opera quae supersunt omnia ed G Schmidt ndash L Nix ndash W Schmidt ndash H Schoene ndash J L Heiberg I-V Lipsiae 1899-1914
PC = Le ldquoPetit Commentairerdquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed A Tihon Cittagrave del Vaticano 1978
POO = Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia ed J L Heiberg I-II in 3 parti Lipsiae 1898-1907
RGK = Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600 I Handschriften aus Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln II Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs und Nachtraumlge zu den Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln III Handschriften aus Bibliotheken Roms mit dem Vatikan A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg unter Mitarbeit von D Harlfinger und P Eleuteri B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln Wien 1981-1997 (Oumlsterreichische Akademie der Wissenschaften Veroumlffentlichungen der Kommission fuumlr Byzantinistik III1-3 A-C)
Sigla
Acerbi 2010 = F Acerbi Il silenzio delle sirene La matematica greca antica Roma 2010
Acerbi 2012 = F Acerbi I codici stilistici della matematica greca dimostrazioni procedure algoritmi laquoQUCCraquo 1012 (2012) pp 167-214
Acerbi et al 2010 = F Acerbi ndash N Vinel ndash B Vitrac Les Proleacutegomegravenes agrave lrsquoAlmageste Une eacutedition agrave partir des manuscrits les plus anciens Introduction geacuteneacuterale ndash Parties I-III laquoSCIAMVSraquo 11 (2010) pp 53-210
Agati 1992 = M L Agati La minuscola laquoBouleteacuteeraquo Cittagrave del Vaticano 1992
Belger 1881 = C Belger Ein neues Fragmentum mathematicum Bobiense laquoHermesraquo 16 (1881) pp 261-284
Bianconi 2005a = D Bianconi La biblioteca di Cora tra Massimo Planude e Niceforo Gregora Una questione di mani laquoSampTraquo 3 (2005) pp 391-438
Bianconi 2005b = D Bianconi Tessalonica nellrsquoetagrave dei Paleologi Le pratiche intellettuali nel riflesso della cultura scritta Paris 2005
Bianconi 2006a = D Bianconi Le pietre e il ponte ovvero identificazioni di mani e storia della cultura laquoBizantinisticaraquo 8 (2006) pp 135-181
Bianconi 2006b = D Bianconi Qualcosa di nuovo su Giovanni Catrario laquoMEGraquo 6 (2006) pp 69-91
Cavallo 1977 = G Cavallo Funzione e strutture della maiuscola greca tra i secoli VIII-XI in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Colloque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 95-137
Cereteli 1904 = G F Cereteli De compendiis scripturae codicum Graecorum praecipue Petropolitanorum et Mosquensium anni nota instructorum Sankt-Petersburg 1904
De Gregorio 2000 = G De Gregorio Materiali vecchi e nuovi per uno studio della minu-scola greca fra VII e IX secolo in G Prato (a cura di) I manoscritti greci tra riflessione e dibattito Atti del V Colloquio Internazionale di Paleografia Greca Cremona 4-10 ottobre 1998 Firenze 2000 pp 83-151
Follieri 1977 = E Follieri La minuscola libraria dei secoli IX e X in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Col-loque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 139-165
Fonkič 2005 = B Fonkič Venecianskaia rukopisrsquo laquoAlrsquomagestaraquo Ptolemeja (Marc gr 313690) o datirovke i proischoždenii kodeksa laquoVDIraquo s III 254 (2005) pp 162-167
Fowler 1999 = D H Fowler The Mathematics of Platorsquos Academy A New Reconstruction Second Edition Oxford 1999
Bibliografia
Fabio Acerbi164
Gerstinger ndash Vogel 1932 = H Gerstinger ndash K Vogel Eine stereometrische Aufgaben-sammlung im Papyrus Graecus [sic] Vindobonensis 19996 laquoMitteilungen aus der Papy-russammlung der Nationalbibliothek in Wienraquo Neue Serie Folge 1 Griechische literarische Papyri 1 Wien 1932 pp 11-76
Heiberg 1927 = Mathematici Graeci Minores ed J L Heiberg Kjoslashbenhavn 1927
Hultsch 1876-1878 = Pappi Alexandrini Collectionis quae supersunt ed F Hultsch I-III Berlin 1876-1878
Janz 2003 = T Janz The Scribes and the Date of the Vat gr 1291 in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae X Cittagrave del Vaticano 2003 pp 159-180
Jones 1990 = Ptolemyrsquos First Commentator ed A Jones Philadelphia 1990
Jones 1999 = Astronomical Papyri from Oxyrhynchus ed A Jones I-II Philadelphia 1999
Jones 2005 = A Jones Ptolemyrsquos Canobic Inscription and Heliodorusrsquo Observation Reports laquoSCIAMVSraquo 6 (2005) pp 53-97
Lempire 2014 = Steacutephanos drsquoAlexandrie Le commentaire aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Lempire Louvain 2014
Leurquin 1990 = Theacuteodore Meacuteliteacuteniote Tribiblos astronomique Livre I ed R Leurquin Amsterdam 1990
Leurquin 1991 = R Leurquin Un manuscrit autographe de la Tribiblos Astronomique de Theacuteodore Meacuteliteacuteniote le Vaticanus graecus 792 laquoScriptoriumraquo 45 (1991) pp 145-162
Maas 1927 = P Maas Griechische Palaeographie in A Gercke ndash E Norden (hrsg von) Einleitung in die Altertumswissenschaft I9 Leipzig 1927 pp 69-80
Martinelli Tempesta 2010 = S Martinelli Tempesta Il codice Milano Biblioteca Am-brosiana B 75 sup (gr 104) e lrsquoevoluzione della scrittura di Giovanni Scutariota in A B Garciacutea ndash I Peacuterez Martiacuten (ed by) The Legacy of Bernard de Montfaucon Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting Proceedings of the Seventh Inter-national Colloquium of Greek Palaeography Madrid-Salamanca 15-20 September 2008 Turnhout 2010 pp 171-186
Mazzucchi 1994 = C M Mazzucchi Leggere i classici durante la catastrofe (Costantino-poli maggio-agosto 1203) le note marginali al Diodoro Siculo Vaticano gr 130 Parte prima stratigrafia laquoAevumraquo 68 (1994) pp 164-218
Mioni 1976 = E Mioni Bessarione scriba e alcuni suoi collaboratori in Miscellanea marcia-na di studi bessarionei Padova 1976 pp 263-323
Mioni 1985 = Codices graeci manuscripti Bibliothecae Divi Marci Venetiarum II Thesaurus Antiquus Codices 300-625 recensuit E Mioni Roma 1985
Mogenet 1962 = J Mogenet Une scholie ineacutedite du Vat gr 1594 sur les rapports entre lrsquoastronomie arabe et Byzance laquoOsirisraquo 14 (1962) pp 198-221
Mogenet et al 1983 = Niceacutephore Greacutegoras Calcul de lrsquoeacuteclipse de soleil du 16 juillet 1330 ed J Mogenet ndash A Tihon ndash R Royez ndash A Berg Amsterdam 1983
Mondrain 2002 = B Mondrain Maxime Planude Niceacutephore Greacutegoras et Ptoleacutemeacutee laquoPa-laeoslavicaraquo 10 (2002) pp 312-322
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 165
Mondrain 2004 = B Mondrain Lrsquoancien empereur Jean VI Cantacuzegravene et ses copistes in A Rigo (a cura di) Gregorio Palamas e oltre Studi e documenti sulle controversie teologiche del XIV secolo bizantino Firenze 2004 pp 249-296
Mondrain 2007 = B Mondrain Les eacutecritures dans les manuscrits byzantins du XIV e siegravecle Quelques probleacutematiques laquoRSBNraquo n s 44 (2007) pp 157-196
Peacuterez Martiacuten 2006 = I Peacuterez Martiacuten Maxime Planude et le Diophantus Matritensis (Madrid Biblioteca Nacional ms 4678) un paradigme de la reacutecupeacuteration des textes anciens dans la ldquorenaissance paleacuteologuerdquo laquoByzantionraquo 76 (2006) pp 433-462
Peacuterez Martiacuten 2008 = I Peacuterez Martiacuten El lsquoestilo Hodegosrsquo y su proyeccioacuten en las escrituras constantinopolitanas laquoSampTraquo 6 (2008) pp 389-458
Perria 1991 = L Perria Scrittura e ornamentazione nei codici della laquocollezione filosoficaraquo laquoRSBNraquo n s 28 (1991) pp 45-111
Rollo 2012 = A Rollo LrsquoArchimede di Giorgio Valla in V Fera ndash D Gionta ndash A Rollo (a cura di) Archimede e le sue fortune Atti del Convegno di Siracusa-Messina 24-26 giugno 2008 Messina 2012 pp 99-147
Rome 1927 = A Rome Membra disjecta laquoRBenraquo 39 (1927) pp 187-188
Rome 1938 = A Rome Un manuscrit de la bibliothegraveque de Boniface VIII agrave la Meacutediceacuteenne de Florence laquoACraquo 7 (1938) pp 261-268
Ronconi 2013 = F Ronconi La collection philosophique un fantocircme historique laquoScripto-riumraquo 67 (2013) pp 119-140
Tannery ndash Steacutephanou 1940 = Quadrivium de Georges Pachymegravere ed P Tannery ndash E Steacutephanou Cittagrave del Vaticano 1940
Tihon 2011 = Πτολεμαίου Πρόχειροι Κανόνες Les Tables faciles de Ptoleacutemeacutee vol Ia Tables A1-A2 ed A Tihon Leuven 2011
Traube 1907 = L Traube Nomina Sacra Versuch einer Geschichte der christlichen Kuumlrzung Muumlnchen 1907
Vogel 1936 = K Vogel Beitraumlge zur griechischen Logistik laquoSBAWraquo Mathematisch-natur-wissenschaftliche Abteilung Jahrgang 1936 pp 357-472
Wouters 1979 = A Wouters The Grammatical Papyri from Graeco-Roman Egypt Contri-butions to the Study of the lsquoArs Grammaticarsquo in Antiquity Brussel 1979
F ACERBI Tav 1
b Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 65r
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 284 f 160r
F ACERBITav 2
b Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 13r
a Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 19v
F ACERBI Tav 3
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 136v
F ACERBITav 4
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17r
F ACERBI Tav 5
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17v
F ACERBITav 6
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 7v
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
Fabio Acerbi126
dezza in funzione di un insieme discreto di valori di un parametro Una tavola-tipo egrave composta di due colonne a sinistra i valori del parametro a destra quelli della grandezza Il parametro non egrave necessariamente nume-rico5 Le colonne possono essere piugrave di due a) se piugrave grandezze omologhe oppure no legate allo stesso parametro sono per economia di spazio ri-portate su colonne affiancate b) se una grandezza ha una rappresentazione numerica complessa ad ogni ordine essendo associata una colonna6
Le tavole sono sia costruite che descritte La lsquocostruzionersquo di una tavola consiste nellrsquoesposizione delle dimostrazioni ed operazioni neces-sarie a produrre lrsquoinsieme dei suoi valori senza che questi ultimi siano calcolati singolarmente La tavola presenta dunque in modo sintetico il risultato di una serie di operazioni questa serie puograve anche essere molto lunga e complessa ed egrave quasi sempre impossibile ricavare in tempi brevi una tavola dalla sua costruzione una tavola egrave costruita una volta per tutte si rende in questo modo indipendente dalla costruzione e non egrave univocamente determinata dalla sua lsquodescrizionersquo che si limita ad indi-care quale ente costituisca il parametro e quale la grandezza tabulata ed eventualmente a fornire indicazioni di formato Una tavola egrave collocata dopo la propria costruzione e la propria descrizione ed occupa quasi sempre per intero lo spazio grafico unitario (pagina colonna di rotolo) Una tavola insomma egrave un vero e proprio testo dal formato particolar-mente perspicuo di questo testo fanno anche parte gli altri segni grafici necessari ad un suo corretto utilizzo le linee orizzontali e verticali che separano righe e colonne la titolazione che ne identifica il tipo
Esempio la lsquotavola delle cordersquo nellrsquoAlmagesto Essa contiene i va-lori delle corde inscritte in un cerchio (seconda colonna) e dei loro incrementi parziali (terza colonna) tabulati in funzione dellrsquoarco di cerchio che esse sottendono (prima colonna)7 questrsquoultimo egrave il para-metro fornito con incrementi di mezzo grado da 0ordm a 180ordm nella tavola vi sono pertanto 360 righe La costruzione della tavola occupa quasi tutto il capitolo I 10 dellrsquoAlmagesto 15 pagine e mezzo nellrsquoedizione di Heiberg la descrizione prende 11 righe scarse includendo anche le istruzioni per lrsquouso dei valori nella terza colonna la tavola stessa si estende su 16 pagine8 Egrave particolarmente importante osservare che la
5 Esempio la lsquotavola delle cittagrave illustrirsquo nelle Tavole facili tolemaiche a sinistra il nome della cittagrave a destra le sue coordinate geografiche
6 Si veda infra la sezione 3 per questa terminologia nel caso del sistema sessagesimale7 I valori delle corde sono calcolati fino al secondo ordine sessagesimale quelli dei
loro incrementi parziali in sessantesimi fino al quarto ordine la lsquoseconda colonnarsquo consiste quindi in realtagrave di 3 colonne la lsquoterzarsquo di 4
8 Rispettivamente POO I 1 pp 319-4620 ivi p 472-13 κανόνια ὑποτάξομεν ἀνὰ
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 127
mise en rouleau dellrsquooriginale era differente come Tolomeo stesso spiega nella sua descrizione le 360 righe erano ripartite διὰ τὸ σύμμετρον laquoper motivi di simmetriaraquo9 in 8 tavole affiancate di 45 righe lrsquouna che nel rotolo figuravano probabilmente con una soluzione di continuitagrave minore di un intercolumnio standard in guisa di macrocolonna I ma-noscritti medievali rispettano questa disposizione ma devono ripartire le 8 tavole su 4 pagine10 Date le dimensioni della pagina a stampa cui egrave confinato Heiberg non puograve farlo e sdoppia ogni tavola poicheacute 45 egrave dispari e a causa della presenza dellrsquoapparato critico le sue tavole per-dono tutta la simmetria iniziale Nel caso delle tavole dunque rotolo e codice comportano mises en texte differenti per una volta egrave il rotolo e non il codice il supporto ideale per questo tipo di testi
Altro esempio tavole del moto medio del sole nellrsquoAlmagesto De-notando rispettivamente con a g o m e c i valori del tempo di ritorno annuale in giorni e loro parti e dei moti (in gradi per appropriate unitagrave di tempo) giornaliero orario mensile per mese di 30 giorni annuale per lrsquoanno egiziano di 365 giorni e infine su un ciclo di 18 anni la determinazione dei restanti a partire dal valore di a ammonta alla se-guente catena di operazioni a rarr 360a = g rarr g24 = o 30g = m 365g = e rarr 18e = c Ognuno di questi valori forma la base della costruzione per addizioni successive11 delle tavole12 che denoto con le stesse lettere
στίχους με διὰ τὸ σύμμετρον ὧν τὰ μὲν πρῶτα μέρη περιέξει τὰς πηλικότητας τῶν περιφερειῶν καθ᾽ ἡμιμοίριον παρηυξημένας τὰ δὲ δεύτερα τὰς τῶν παρακειμένων ταῖς περιφερείαις εὐθειῶν πηλικότητας ὡς τῆς διαμέτρου τῶν ρκ τμημάτων ὑποκειμένης τὰ δὲ τρίτα τὸ λʹ μέρος τῆς καθ᾽ ἕκαστον ἡμιμοίριον τῶν εὐθειῶν παραυξήσεως ἵνα ἔχοντες καὶ τὴν τοῦ ἑνὸς ἑξηκοστοῦ μέσην ἐπιβολὴν ἀδιαφοροῦσαν πρὸς αἴσθησιν τῆς ἀκριβοῦς καὶ τῶν μεταξὺ τοῦ ἡμίσους μερῶν ἐξ ἑτοίμου τὰς ἐπιβαλλούσας πηλικότητας ἐπιλογίζεσθαι δυνώμεθα laquodisporrograve le tavole su 45 righe per motivi di simmetria la prima parte di lsaquoognuna dirsaquo esse conterragrave i valori degli archi incre-mentati di mezzo grado alla volta la seconda i valori delle rette corrispondenti agli archi (il diametro essendo posto di 120 gradi) la terza la 30ordm parte dellrsquoincremento delle rette per ciascun lsaquointervallo dirsaquo mezzo grado di modo che sia possibile calcolare facilmente avendo in questa maniera a disposizione il valore intermedio lsaquodellrsquoincrementorsaquo corrispondente ad un singolo sessantesimo (esso egrave differente da quello esatto in maniera impercettibile) anche i valori delle frazioni intermedie tra i lsaquovalori limitati airsaquo mezzi gradiraquo Alm I 11 ivi pp 48-63
9 Non dobbiamo sopravvalutare la componente estetica implicita nel nostro termine laquosimmetriaraquo Tolomeo si limita a far riferimento alla laquocongruenzaraquo di 45 con 360 in quanto suo divisore esatto
10 Si vedano Par gr 2389 (sec IX in Tolomeo Almagestum) ff 17r-18v Vat gr 1594 (Prolegomena ad Almagestum Tolomeo Almagestum et opera minora) ff 20v-22r Marc gr 313 (Prolegomena ad Almagestum Tolomeo Almagestum) ff 46r-47v Vat gr 180 (sec X Tolomeo Almagestum) ff 18v-20r per la datazione del secondo e del terzo codice si veda la sezione 4
11 Tolomeo accorda alla menzione di questrsquooperazione di addizione una mezza riga proprio alla fine della sua esposizione κατὰ τὰς οἰκείας ἑκάστων ἐπισυναγωγάς laquoper opportune addizioni successive dei lsaquovalorirsaquo di ciascunoraquo Alm III 1 in POO I 1 p 20924-25
12 Alm III 1 ivi pp 2091-16 e 20922-25 descrizione ivi p 20917-22
Fabio Acerbi128
maiuscole ovviamente la tavola A egrave assente Per esempio la tavola G ha come prima riga il valore g (colonna di destra) accompagnato dalla cifra α laquo1raquo (colonna di sinistra) le altre righe hanno a sinistra i numerali da 2 a 30 e a destra i multipli corrispondenti di g il valore registrato a destra nellrsquoultima riga deve evidentemente coincidere con m In omaggio al principio delle 45 righe13 troviamo dunque una prima tavola C su 45 righe (corrispondente a un periodo di 18times45 = 810 anni avente come epoca il primo anno di regno di Nabonassar) una seconda su 42 righe che combina le 18 righe di E seguite dalle 24 di O una terza ancora su 42 righe che contiene le 12 di M seguite dalle 30 di G14 ndash nella seconda
13 διὰ τὸ φανησόμενον σύμμετρον τῆς κανονογραφίας laquoper una presentazione simme-trica del tracciato delle tavoleraquo ivi p 20914-15 allusione analoga in Alm I 10 ivi p 472-3 lrsquoabbiamo letta sottolineata nella nota 8 supra
14 Per la mise en page di queste tre tavole nei manoscritti medievali si vedano Par gr 2389 ff 69v-70r Vat gr 1594 f 63r-v (in questi due codici scritti su due colonne le tavole occupano unrsquointera pagina piugrave la prima colonna della successiva) Marc gr 313 f 98r-v (questo codice vergato a tutta pagina adotta momentaneamente una disposizione su due colonne al f 98v la prima contiene la tavola la seconda lrsquoinizio del capitolo successivo) Vat gr 180 ff 60v-61v Nelle Tavole facili dello stesso Tolomeo che passano a cicli di 25 anni e allrsquoepoca di Filippo le tavole appena descritte sono presentate con precisione ridotta rispetto a quelle dellrsquoAlmagesto nellrsquoordine C (periodo di 25times59 = 1475 anni) E (ciclo di 25 anni) M (direttamente con i nomi dei mesi del calendario egiziano mentre lrsquoAlmagesto ripartisce il parametro in multipli di 30 giorni fino a 360) G O Ogni tavola egrave suddivisa in unitagrave colonnari di non piugrave di 30 righe + titolazione La lsquotavola delle cordersquo non egrave inclusa nelle Tavole facili per le tavole del moto medio del sole e della luna nei manoscritti medievali di questrsquoopera si vedano Leiden Bibliothek der Rijksuniversiteit BPG 78 ff 91r-93v Laur Plut 2826 ff 71r-73v Vat gr 1291 ff 38r-40v Marc gr 331 ff 45r-47v ndash le parti in maiuscola di tutti questi codici contengono unicamente le Tavole facili e si datano sulla base dellrsquoultimo imperatore di cui il copista principale abbia riportato gli anni di regno nel cosid-detto canon regius nellrsquoordine Leiden BPG 78 copiato sotto il regno di Leone V 813-820 Vat gr 1291 copiato poco dopo il regno di Niceforo I 802-811 (Janz 2003) Laur Plut 2826 copiato sotto il regno di Leone VI 886-912 Marc gr 331 privo del canon regius e forse copiato anchrsquoesso sotto il regno di Leone VI si veda anche Tihon 2011 pp 19-41 per una sintesi e per ulteriori indicazioni bibliografiche Ovviamente anche le Tavole facili erano state concepite per il rotolo Tra lrsquoaltro Tolomeo sembra trascrivere nella stessa tavola i moti medi di Sole Luna Cor Leonis (la stella Regolo) e dei cinque pianeti cosa impossibile a farsi su una sola pagina di codex si legga la descrizione che ne dagrave nella parte iniziale del lsquomanuale di istruzionirsquo alle Tavole facili stesse in POO II p 1607-19 Nei manoscritti medievali questa tavola egrave smembrata poco dopo lrsquoinizio della sequenza di tavole si trovano i moti medi di Sole e Luna piugrave avanti quelli di Regolo e dei cinque pianeti Piugrave in generale il passaggio al codice comportograve una riorganizzazione delle lsquotavole facilirsquo dal piano originario in cui tutte quelle di longitudine erano molto verosimilmente raggruppate insieme e precedevano quelle di latitudine ad un ordinamento per corpi celesti (Tihon 2011 pp 12-14) Le Tavole facili furono copiate molto presto su codice i lsquopapirirsquo di questrsquoopera sono quasi unicamente su codex di pergamena (Jones 1999 I pp 102-108 e 160-168 edizione dei POxy LXI 4167-4173a contenenti frammenti delle Tavole facili ivi II pp 118-161 solo il primo di essi proviene sicuramente da un rotolo) Giagrave in pieno IV secolo Teone di Alessandria nel suo lsquoPiccolo commentariorsquo alle Tavole facili afferma che alcune di esse possono estendersi su πλειόνων πτυχίων laquopiugrave pagineraquo (PC p 2016 allinterno dellunica definizione di lsquotavolarsquo rintracciabile nel corpus antico) cosigrave le leggiamo attualmente nei manoscritti
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 129
e nella terza tavola il numero di righe egrave piugrave basso percheacute occorre pre-vedere uno spazio per il titolo addizionale Per mantenerne il formato tripartito Heiberg egrave costretto a stampare le tavole ruotate di 90ordm
Che le tavole siano dei testi egrave confermato da due fatti aggiuntivi e strettamente connessi15 Primo il lsquomanuale di istruzionirsquo alle Tavole facili che Tolomeo stesso redasse fu scritto ed ha circolato come opera a parte Secondo dalla descrizione delle tavole dettagliata ma priva di costruzione contenuta nello stesso lsquomanualersquo egrave impossibile ricavarne il contenuto numerico e la maniera drsquoimpiego16 a illustrare questrsquoultima provvederagrave una ricchissima tradizione di commentari di cui leggiamo ancora quelli di Teone il lsquoPiccolo Commentariorsquo spiega come usarle per scopi specifici il lsquoGrande Commentariorsquo come dedurle dallrsquoAlmagesto17 Le Tavole facili sono insomma unrsquoopera il cui testo egrave interamente strut-turato in formato tabulare
3) Tabelle operazionali Una lsquotabella operazionalersquo egrave una disposi-zione ordinata di lettere numerali e altri segni grafici che rappresenta lrsquoalgoritmo di unrsquooperazione aritmetica Ci troviamo in realtagrave di fronte a due modi di eseguire lrsquooperazione la tabella intende in qualche mi-sura riprodurre la dinamica operazionale dellrsquoalgoritmo questrsquoultimo si risolve a sua volta in una descrizione della tabella che senza tale de-scrizione risulterebbe incomprensibile e quindi non adattabile ad una differente operazione una tabella operazionale ha in questo caso una funzione paratestuale Si presuppone perograve che il discente apprenda a ri-produrre lrsquooperazione direttamente nel formato tabellare non in quello algoritmico In questo secondo caso una tabella operazionale assume una funzione testuale piena18 Lo statuto (para)testuale delle tabelle operazionali egrave pertanto oscillante nei commentari teonini allrsquoAlmagesto e soprattutto nei Prolegomena ad Almagestum di cui andremo ad occu-parci esse sono descritte in dettaglio e si configurano pertanto come genuini paratesti in Eutocio in Circ esse sono semplicemente eseguite e quindi assumono un ruolo testuale Nei manoscritti medievali la col-locazione di una tabella operazionale originaria egrave variabile e dipende dalle sue dimensioni e dalla capacitagrave del copista di identificarla come
15 Per un argomento ulteriore si veda la sezione 4 punto b16 POO II pp 159-18517 Nessuno dei due titoli ha fondamento nella trasmissione manoscritta la seconda
opera era detta realizzare una συμφωνία tra lrsquoAlmagesto e le Tavole facili Entrambi i com-mentari sono stati editi criticamente PC GC I-III
18 Resta il fatto che la quasi totalitagrave delle tabelle operazionali che rintracciamo nei manoscritti egrave relegata nei margini dellrsquoattivitagrave di annotazione degli scoliasti
Fabio Acerbi130
tale di solito le troviamo nei margini ma possono occupare lrsquointero specchio di scrittura e ciograve indipendentemente dalla determinazione del loro statuto paratestuale sulla base del criterio della presenzaassenza di una descrizione
Lo statuto meno elevato dei genuini paratesti (diagrammi e tabelle) rispetto ai testi (catene algoritmico-argomentative e tavole) indusse un atteggiamento differenziato in copisti ed editori attenti a rispettare lrsquointegritagrave dei secondi ma non dei primi ciograve che conta sono le informa-zioni veicolate dalle strutture discorsive e dalle porzioni alfanumeriche di diagrammi tavole e tabelle il resto egrave ritenuto adattabile alle esigenze dellrsquoedizione moderna19 o semplicemente ignorato nel corso del pro-cesso di copia in questa maniera si perdono perograve informazioni e strut-tura Come vedremo puograve avvenire che una parte della descrizione di unrsquooperazione resti senza relato nella resa grafica tabellare lrsquooperazione eseguita in forma algoritmica non corrisponde piugrave a quella eseguita in forma di tabella
3 Testi logistici e disposizione tabellare delle operazioni
Nessun testo matematico primario di etagrave ellenistica o imperiale contiene operazioni aritmetiche eseguite con una sola eccezione la de-scrizione che non ammette una rappresentazione tabellare del procedi-mento di estrazione approssimata di radice quadrata in Erone Metr I 8 Drsquoaltro canto abbiamo giagrave osservato che lrsquoAlmagesto di Tolomeo for-nisce il risultato di migliaia di operazioni ma nessuna di esse egrave eseguita Attestazioni di questi procedimenti sono pertanto legate ad iniziative editoriali di secondo livello come i commentari alla loro prima occor-renza oppure in casi paradigmatici gli algoritmi di calcolo omessi nel testo primario vi sono resi espliciti Di fatto e con una sola eccezione la nostra documentazione consiste in commentari allrsquoAlmagesto quello di Teone e i Prolegomena ad Almagestum
19 Abbiamo giagrave visto alcuni esempi di modifiche del formato delle tavole Quanto ai diagrammi quelli tracciati nelle edizioni moderne rappresentano il caso piugrave generale pos-sibile Le figure che troviamo nei manoscritti greci hanno invece la caratteristica opposta illustrano spesso casi particolari e sono metricamente scorrette Sono in effetti tracciati triangoli rettangoli isosceli cerchi uguali rette perpendicolari dove tutto ciograve non egrave richiesto dallrsquoenunciato e inoltre rettangoli invece di parallelogrammi segmenti uguali quando sia-no disuguali addirittura linee rette al posto di curve (in Archimede Meth 14 un arco di parabola egrave rappresentato da un angolo rettilineo) e in generale figure con proprietagrave di simmetria non richieste
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 131
LrsquoAlmagesto e con esso tutta la tradizione astronomica adotta il sistema sessagesimale per esprimere la parte non intera di un nu-mero che siano valori angolari o lineari non fa differenza20 come noi scriviamo 36524 e intendiamo 365 + 2 decimi + 4 centesimi (cioegrave 4102) cosigrave nel sistema sessagesimale 365 14 48 significa21 365 + 14 sessantesimi + 48 tremilaseicentesimi (cioegrave 48602) ovverosia nel lessico antico e nostro 365 14 πρῶτα λεπτά laquominuti primiraquo 48 δεύτερα λεπτά laquominuti secondiraquo dove laquoprimoraquo e laquosecondoraquo sono le laquodenominazioniraquo degli ordini (sono cioegrave numeri ordinali) 14 e 48 i lsquonumerali di molteplicitagraversquo relativi ai due ordini numerale di mol-teplicitagrave e relativa denominazione costituiscono insieme una lsquoparte sessagesimalersquo di un numero Drsquoaltronde per gli antichi come per noi lrsquoespressione di una parte non intera (ovvero di una frazione)
20 Trascuro il fatto ai nostri fini irrilevante che essendo i numerali greci lettere alfabetiche la notazione che ne risulta per i numeri interi non egrave posizionale nonostante le cifre scagravelino di un posto ad ogni potenza di dieci il segno μ per 4 (decine) non egrave identico al segno δ per 4 (unitagrave) Drsquoaltra parte una volta adottata la notazione decimale per i numerali di molteplicitagrave la notazione complessiva per la parte non intera espressa nel sistema sessa-gesimale non egrave posizionale neanche introducendo un segno di lsquoposto vuotorsquo una cui parte egrave nel caso greco analoga in forma al nostro 0 (su questo segno si veda ancora la sezione 4 punto c) occorre avvalersi di accorgimenti ulteriori quali lrsquointroduzione di spaziature fra le differenti parti sessagesimali (come viene fatto nei manoscritti greci ed in questrsquoarticolo) o di segni tipografici (come suggerito da Otto Neugebauer che avrebbe scritto 3651448 il numerale che leggeremo tra un attimo nel testo) Il problema egrave che altrimenti lrsquoordine associato ad un numerale di molteplicitagrave di una parte sessagesimale puograve non risultare uni-vocamente determinato dalla sua posizione Esempio scrivendo 0129 per un numero non intero nel sistema sessagesimale il numerale di molteplicitagrave 129 potrebbe rappresentare 1 minuto primo e 29 secondi oppure 12 minuti primi e 9 secondi ecc e la stessa difficoltagrave si presenta nella notazione greca (per la nozione di lsquonumerale di molteplicitagraversquo si veda infra nel testo) Il problema scomparirebbe se adottassimo singoli segni differenti per tutti i nu-merali da 1 a 59 ndash ma neacute noi neacute i greci siamo stati disposti a introdurre una complicazione siffatta Si ricordi infine che al di fuori dei contesti astronomici il sistema di numerazione greco egrave decimale
21 Scriverograve i numerali in cifre arabe sempre in questo modo parte intera seguita dalle parti sessagesimali (minuti primi secondi ecc) con ogni ordine separato da uno spazio bianco Se la parte intera egrave assente il numerale inzia con uno 0 Nella trascrizione dei numerali in greco ogni numerale di molteplicitagrave sessagesimale o frazione unitaria saragrave identificato come nei manoscritti piugrave antichi dei Prolegomena da un opportuno numero di apici (uno per ogni unitagrave dellrsquoordine avendo le frazioni unitarie un solo apice come vedremo nellrsquoAlmagesto contenuto negli stessi codici troviamo barre non apici con questa funzione) mentre la parte intera saragrave priva della barra che la sormonta invariabilmente nei manoscritti In questo modo 365 14 48 egrave la conversione in cifre arabe di τξε ιδ´ μη´´ La pratica dei manoscritti medievali egrave di collocare gli apici (quando presenti) sopra le lettere numerali per ragioni tipografiche li porrograve di seacuteguito al gruppo di lettere cui si riferiscono Si noti che nella notazione greca il segno ιδ´ per 1460 in sessagesimale egrave identico a quello per 114 in decimale Nel caso delle frazioni unitarie la presenza dellrsquo(unico) apice egrave la traduzione semiotica della trasformazione che a livello grammaticale egrave effettuata con il pas-saggio dal cardinale allrsquoordinale (ad esempio da τὰ τρία laquotreraquo a τὸ τρίτον laquoun terzoraquo) si veda anche la sezione 4 punto 1 e note 82 e 86 ivi incluse
Fabio Acerbi132
richiede sempre lrsquointroduzione di due numerali il lsquonumeratorersquo e il lsquodenominatorersquo
Il motivo della scelta del sistema sessagesimale che fu mutuato dallrsquoastronomia matematica babilonese egrave presto detto lrsquoelevato numero di divisori di 60 e cioegrave 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 Poicheacute i divi-sori di 10 sono un sottinsieme di quelli di 60 molti piugrave numeri hanno una rappresentazione finita nel sistema sessagesimale che in quello deci-male Calcolare in sessagesimale lungi dal creare difficoltagrave offre quindi un vantaggio cruciale22 che risulta piugrave facilmente comprensibile sulla base dellrsquoesempio seguente La lunghezza dellrsquoanno solare egrave stabilita da Tolomeo in 365 giorni + 14 ndash 1300 di giorno Per calcolare il moto giornaliero del sole si rende necessario dividere 360 per questo numero Noi avremmo due opzioni se non potessimo usare la calcolatrice ri-durre il divisore ad una singola frazione tramite passaggio al denomi-natore comune invertire questa frazione e moltiplicarla per 360 sem-plificare gli eventuali fattori comuni e finalmente eseguire la divisione a piugrave cifre tra numeri interi (nel nostro caso 5400054787) oppure scrivere il divisore come numero decimale periodico (365246666 hellip) e poi eseguire la divisione Nel sistema sessagesimale egrave tutto molto piugrave semplice 365 + 14 ndash 1300 ha una rappresentazione finita cioegrave 365 14 48 come eseguire la divisione lo vedremo tra un attimo
Passiamo dunque in rassegna il contenuto del lsquomanuale di logisticarsquo incluso nei Prolegomena ad Almagestum riportando in nota per ogni item anche esposizioni parallele in altri commentatori23
a) Costruzione del sistema sessagesimale24
22 E uno svantaggio se le molteplicitagrave dei singoli ordini vengono espresse in no-tazione decimale (come facciamo noi e facevano i greci) il numero di cifre necessario per raggiungere una precisione assegnata egrave maggiore nel sistema sessagesimale in quanto per esprimere i numerali da 10 a 59 occorrono due cifre mentre per quelli da 1 a 9 (o da α a θ e le decine da ι a ν nel caso greco) ne basta una e ciograve indipendentemente dal fatto che la notazione sia posizionale oppure no La differenza si fa perograve sentire solo a partire dal quinto ordine sessagesimale
23 Trascuro la parte finale del lsquomanualersquo dove sono esposte le regole di interpolazione (cui era legata la lsquoterza colonnarsquo della tavola delle corde tolemaica) e il procedimento di lsquosottrazionersquo di rapporti cioegrave la divisione di un rapporto per un altro
24 Per a-b cf Teone in Alm I 10 in iA pp 44919-45814 PC pp 2007-2014 GC I pp 10910-11124 e le definizioni e regole diofantee di manipolazione delle varie specie numeriche in Arithmetica prefazione in DOO I pp 214-1218 Le porzioni a-b sono giagrave state pubblicate da Paul Tannery in DOO II pp 318-1517 sulla base del Par gr 453 apografo ad opera di Giovanni Santamaura di un Vat gr 1594 giagrave mutilo (RGK II nr 238 ma lrsquoautore trascritto vi egrave indicato come lsquoPtolemaiosrsquo) Evidentemente il committente non fu soddisfatto della prima trascrizione (ff 67-76) che crivella di tratti rossi a segnalarne gli errori di copia Ne fu dunque eseguita una seconda (ff 78-86) cui Santamaura antepose
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 133
b) Regole di moltiplicazione e divisione degli ordini sessagesimali defini-zione generale di moltiplicazione moltiplicazione di ordini come somma delle loro laquodenominazioniraquo Definizione generale di divisione divisione di ordini uguali e di un ordine per quello che lo precede immediata-mente divisione di ordini come sottrazione delle loro laquodenominazioniraquo divisione per 60 come divisione per 1 accompagnata dallo slittamento di un posto dellrsquoordine
c) Problemi che sorgono nella divisione di una parte sessagesimale per una di quelle che seguono divisione breve per riduzione allo stesso ordine (metodo laquoper analisiraquo) due algoritmi differenti il secondo con riduzione dei fattori comuni attribuito a Siriano
d) laquoAltroraquo metodo di divisione breve in realtagrave divisione tra somme di parti sessagesimali appartenenti ad ordini differenti per riduzione allo stesso ordine e applicazione dei metodi precedenti esempio della divisione di 0 2 0 4 per 0 0 2 0 240
e) Metodo di moltiplicazione tra numeri con parti non intere disposizione tabellare dei termini esempio della moltiplicazione di 5 4 6 per 8 0 3 0 525
f ) Primo metodo di divisione lunga descrizione della disposizione tabellare ed esempio di algoritmo applicato alla divisione di 50 48 26 30 per 8 16 28 5426
g) Metodo di divisione lunga tratto da Pappo in Alm III descrizione della disposizione tabellare ed esempio di algoritmo applicato alla divisione di 360 per 365 14 48 come verifica del valore 0 59 8 17 13 12 31 fornito nellrsquoAlmagesto per il moto medio giornaliero del sole27
h) Metodo di approssimazione di una radice quadrata secondo Erone Metr I 8 con giustificazione geometrica di Teone (attualmente non attestata in suoi scritti)
i) Verifica tramite moltiplicazione della correttezza del valore tolemaico28 di 67 4 55 come radice quadrata approssimata di 4500 Metodo di estrazio-ne di radici quadrate secondo Teone basato su applicazioni successive di Elementi II 4 la procedura termina dopo un numero finito di passi nel caso di quadrati perfetti Applicazione al calcolo della radice quadrata di 450029
unrsquoannotazione spazientita laquoIl texto di questo 2do quinterno egrave stato recopiato fidelmente dallrsquooriginale a chi volesse vedere la prova lo potragrave conferire con detto originale le pagine del qual texto corrispondono con quelle dellrsquooriginale tanti versi che pagine [hellip]raquo (Moge-net 1962 p 200)
25 Teone in Alm I 10 e I 14 in iA pp 45815-4604 e 57911-5811026 Teone in Alm I 10 in iA pp 4611-46217 applicato alla divisione di 1515 20
15 per 25 12 1027 Teone in Alm III 1 e IV 3 in iA pp 84112-84422 (stesso calcolo dei Prolego-
mena) e 102916-10327 idem in Alm IX pp 377-378 dellrsquoedizione di Basilea del 1538 approntata dai tipografi di Walderus Lrsquooriginale pappiano non ci egrave pervenuto
28 Alm I 10 in POO I 1 p 341129 Teone in Alm I 10 in iA pp 46916-4738
Fabio Acerbi134
Lrsquounico testo non elencato qui sopra o nelle note e che contenga tabelle operazionali egrave il commentario eutociano a Circ 3-4 Il testo ar-chimedeo che Eutocio e noi con lui leggeva egrave particolarmente conciso ed egli verifica esplicitamente il sussistere di certe relazioni numeriche Si tratta in ognuno dei nove casi presenti di mostrare che il lsquoteorema di Pitagorarsquo egrave verificato con ottima approssimazione dai valori numerici di opportune terne di rette Eutocio esegue le tre moltiplicazioni dei valori per se stessi e mostra che la somma o la differenza di due dei risultati si discosta di poco dal terzo30 I numeri in questione sono interi seguiti o no da una parte non intera espressa come somma di frazioni unita-rie31 I nove gruppi di tre moltiplicazioni una a fianco allrsquoaltra sono organizzati in forma tabellare ma senza lrsquoausilio di linee separatrici32 le operazioni sono eseguite disponendo lsquoin colonnarsquo i risultati delle mol-tiplicazioni parziali e sommandoli esattamente come facciamo oggi poicheacute sono in gioco numeri interi con parti frazionarie unitarie e la notazione non egrave posizionale non egrave necessario che gli incolonnamenti siano esatti (unitagrave di un risultato parziale sotto le decine del precedente ecc) Sono inclusi nella tabella istruzioni e commenti in linguaggio corrente33 le prime relative allrsquooperazione da affettuare sui risultati delle
30 Eutocio non calcola radici quadrate approssimate per quanto ciograve si renda piugrave volte necessario fornisce il risultato e verifica la sua correttezza moltiplicandolo per se stesso Egli dichiara che il lettore interessato a questo procedimento di calcolo puograve rivolgersi Ἥρωνι ἐν τοῖς μετρικοῖς [hellip] Πάππῳ καὶ Θέωνι καὶ ἑτέροις πλείοσιν ἐξηγουμένοις τὴν μεγάλην σύνταξιν τοῦ Κλαυδίου Πτολεμαίου laquoa Erone nei Metrica [hellip] a Pappo e Teone e a svariati altri inter-preti della Grande composizione di Claudio Tolomeoraquo (AOO III p 23213-17)
31 Troviamo ad esempio ͵αωλη θ´ ια´ cioegrave 1838 + 19 + 111 notare il singolo apice per le frazioni unitarie
32 Essi sono editi in AOO III pp 234-256 La tradizione medievale del commentario eutociano che coincide con un ramo di quella archimedea e deriva da un codice appar-tenuto a Giorgio Valla perduto in etagrave rinascimentale ma riprodotto a volte con fedeltagrave assoluta negli apografi (si veda ad esempio nella tav 1a la riproduzione dellrsquoerronea di-sposizione di cifre e parte algoritmica nel primo gruppo di moltiplicazioni offerta dal Laur Plut 284 f 160r) egrave costituita da Marc gr 305 ff 142v-146v Laur Plut 284 ff 159r-164r Par gr 2360 ff 109v-113v Par gr 2361 pp 410-421 Nel codice veneziano in cui la disposizione per righe e colonne egrave irrimediabilmente alterata dal copista le operazioni sono cancellate con tratti di penna Il primo manoscritto fu esemplato per Bessarione da Giorgio Trivizias tra il 1455 e il 1468 (Mioni 1976 pp 309-312) il secondo fu vergato da Giovanni Scutariota in scrittura di imitazione (Martinelli Tempesta 2010 p 173 n 7 Rollo 2012) ca 1491-1492 il terzo fu trascritto per il cardinale di Firenze Niccolograve Ridolfi dopo che la biblioteca di Valla era stata acquistata a seacuteguito della sua morte avve-nuta il 23 gennaio 1500 per 800 scudi drsquooro da Alberto Pio di Carpi (nota del copista al f 120v) il quarto fu terminato per mano di Christopher Auer su commissione di Georges drsquoArmagnac il primo gennaio 1544 (sottoscrizione a p 474 del codice si veda RGK II nr 525)
33 A questi va aggiunto posto davanti al risultato finale di ogni moltiplicazione il segno convenzionale per ὁμοῦ laquoinsiemeraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 135
prime due moltiplicazioni34 i secondi alla bontagrave dellrsquoapprossimazione ottenuta35 Ogni gruppo di operazioni che chiude unrsquounitagrave esegetica ed egrave seguito dalla citazione che apre la successiva egrave trascritto come se facesse parte del testo a tutta pagina e preceduto dallrsquoindicazione οἱ δὲ πολλαπλασιασμοὶ ὑπόκεινται laquole moltiplicazioni sono poste qui sottoraquo Questi due fatti suggeriscono che tutte le operazioni cui Eutocio non fa alcun riferimento nel corpo del suo commentario siano unrsquoaggiunta editoriale risalente a Isidoro di Mileto che si occupograve della revisione del testo36
Gli incolonnamenti esatti sono invece necessari quando siano moltiplicati numeri con parti non intere espresse nel sistema sessage-simale in quanto la somma finale dei prodotti parziali va effettuata ordine per ordine Tale somma eccederagrave di norma il valore di 60 per un ordine dato nella tabella occorre pertanto trovare posto anche per i riporti che vanno sommati ai prodotti parziali dellrsquoordine preceden-te e quindi incolonnati con essi I testi ci offrono alcuni esempi di tabelle operazionali moltiplicative di questo tipo Teone afferma espli-citamente che la prima moltiplicazione che va a descrivere ha una rap-presentazione tabellare la cui disposizione ritroviamo pesantemente ingarbugliata nel Laur Plut 2818 f 35r37 Alla seconda occorrenza di una moltiplicazione eseguita (tav 1b Laur Plut 2818 f 65r) gli incolonnamenti sono meglio rispettati anche se il risultato finale egrave fatto erroneamente slittare di un posto verso destra i riporti (con un errore) si trovano nella penultima riga38 Nei Prolegomena ad Alma-gestum alcune moltiplicazioni sono accompagnate da tabelle quella meglio attestata egrave associata alla moltiplicazione di 67 4 55 per se stesso (sezione i nel riassunto fornito supra) ed egrave descritta additando sempli-cemente ad un ente materiale oramai inaccessibile forse tracciato in loquendo lsquoalla lavagnarsquo
34 Come λοιπὸν τὸ ἀπὸ ΕΓ laquoresta quello su ΕΓraquo seguito dal risultato della sottrazione di due quadrati
35 Come λείπει ἄρα μο β εἰς τὸ ἀκριβές laquomancano quindi 2 u(nitagrave) al risultato esattoraquo36 Si legga la sottoscrizione spuria ad AOO III p 26010-1237 Si legga la frase ἐκτίθεμαι αὐτὴν καὶ πάλιν αὐτὴν ὑφ᾽ αὑτὴν ὡς ὑπογέγραπται laquolo [scil il
valore del lato da moltiplicare per se stesso] dispongo lsaquouna voltarsaquo e di nuovo al sotto di se stesso come trascritto qui sottoraquo in iA p 45817 Il Laur Plut 2818 (Teone e Pappo Commentaria in Almagestum) egrave uno dei piugrave antichi manoscritti in minuscola sicuramente assegnabile alla prima metagrave del IX secolo (Follieri 1977 p 144 n 23 Maas 1927 p 76 n 17 riteneva che fosse piugrave antico del Tetraevangelo Uspenskij) per una sua analisi si veda Rome 1938
38 In nessuno dei due casi i numerali di molteplicitagrave sono segnalati con apici sono tutti sormontati da una barra si veda la sezione 4 punto b
Fabio Acerbi136
προκείσθω δὶς τὸ μῆκος αὐτῆς ὀφεῖλον τὴν τάξιν τοῦ κατὰ τοὺς πολλαπλασιασμοὺς κανόνος ἀποδοῦναι καὶ ἐκκείσθω ἐπὶ σελιδίων διαγεγραμμένων οὕτω καὶ δὴ αὐτῆς ἐφ᾽ ἑαυτὴν πολ-λαπλασιασθείσης γεγονέτωσαν τὰ ἐν τοῖς οἰκείοις σελιδίοις εἴδη ταῦτα δὴ συναγόμενα καθ᾽ ἣν ὑπεδείξαμεν τάξιν ποιήσει τὰς ὑπογεγραμμένας μοίρας ἢ καὶ λεπτά τινα εἴσι ͵δυϙθ νθ´ ιδ´´ ι´´´ κε´´´´ ὡς λείπειν τοῦ ἐπιμερισθῆναι ŏ ŏ με´´ μθ´´´ λε´´´´
che sia prescritto che la sua lunghezza debba figurare due volte nella disposizione della tavola delle moltiplicazioni e che lsaquoquestrsquoultimarsaquo sia disposta su colonne delimitate da linee cosigrave mdash E pertanto una volta moltiplicato lsaquoil latorsaquo per se stesso che le specie trovino posto nelle colonne appropriate quelle che vengono cosigrave raccolte secondo la disposizione che abbiamo indicato produrranno dunque i gradi o anche i minuti qui sotto trascritti 4499 59 14 10 25 in modo che dalle divisioni successive resti39 0 0 45 49 35
La tabella associata (tav 2a Marc gr 313 f 19v) contiene una sola svista grossolana reca 51 invece di 55 in ognuno dei due fattori posti affiancati sopra di essa Al di sotto preceduto dal segno convenzionale per ὁμοῦ egrave collocato il risultato incongruamente sfalsato di un paio di colonne e con la lettera numerale ͵δ priva di barra sormontante in-naturalmente disconnessa da υϙθ I riporti sono indicati dai numerali ι ρκγ´ η´´ ν´´´ posti al fondo delle prime quattro colonne Il calcolo egrave corretto in ogni sua parte
Il clou in questo piccolo spaccato delle interazioni testo-paratesto matematico risiede nella descrizione contenuta nei Prolegomena della disposizione tabellare di due procedimenti di divisione il primo ano-nimo e quindi da supporre tradizionale il secondo piugrave efficiente ed attribuito al matematico del IV secolo Pappo
Il primo metodo di divisione egrave sostanzialmente analogo a quello che usiamo attualmente Dividendo e divisore questrsquoultimo preceduto da un segno su cui ritorneremo nella prossima sezione sono posti uno sotto lrsquoaltro intervallati da una riga inizialmente vuota Primo passo viene reperito il massimo multiplo del divisore che sia minore del di-videndo esso viene trascritto sotto il dividendo nella prima lsquocasellarsquo della riga vuota recante in testa un segno per laquosottrairaquo il fattore mol-tiplicativo (o quoziente parziale) viene trascritto in una lsquocasellarsquo pre-ceduta da un segno per laquorisultaraquo sotto il divisore Secondo passo il massimo multiplo viene sottratto dal dividendo il resto cosigrave ottenuto egrave trascritto preceduto da un segno per laquorestoraquo in una casella posta
39 Lrsquoautore concettualizza il procedimento di estrazione di radice quadrata come una forma di divisione
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 137
accanto al dividendo40 I due passi precedenti sono quindi ripetuti con la sola differenza che il resto appena ottenuto prende il posto del divi-dendo il quoziente parziale scala di un ordine sessagesimale ad ogni passo41 E cosigrave via aggiungendo ogni volta due caselle La debolezza di questo metodo come di quello che utilizziamo attualmente risiede nel fatto che il reperimento dei quozienti parziali (ovverosia dei massimi multipli) viene effettuato per tentativi non riuscire a farlo al primo colpo appesantisce notevolmente i calcoli successivi e costringe ad un lavoro di riordino e addizione dei quozienti parziali stessi La tabella risultante dove appunto osserviamo questo fenomeno in parallelo con identiche inaccuratezze nella descrizione ha la forma riprodotta unico tra i manoscritti della recensione antica nel Marc gr 313 f 13r (tav 2b invito il lettore a non rivolgersi alle tavole se non dopo aver termi-nato questa sezione sarebbe anzi auspicabile che tentasse di ricostruire questa tabella e le due successive a partire dalla mia descrizione)42
Il secondo metodo di divisione attribuito a Pappo egrave congegnato in modo da rendere non aleatoria la ricerca dei quozienti parziali Come altrove nei Prolegomena la descrizione della procedura di calcolo si riag-gancia esplicitamente a una frase di Tolomeo laquouna volta dimostrato che il periodo di una singola rivoluzione lsaquodel solersaquo egrave di 365 giorni 14 48 se di-vidiamo per essi i 360 gradi di un singolo cerchio avremo il moto medio giornaliero del sole circa 0 gradi 59 8 17 13 12 31raquo43 Questrsquoaffermazione si trova nel terzo libro dellrsquoAlmagesto si tratta della prima occasione in cui viene effettuata una divisione in cui il divisore egrave maggiore del dividendo e i commentatori del trattato tolemaico non si fecero sfuggire lrsquooccasione di mostrare come eseguirla Ora il terzo libro del commentario di Pappo non ci egrave pervenuto Ci resta dunque come testo parallelo a quello dei Prolegomena la descrizione rigidamente formulare in Teone sicuramente un calco di quella pappiana Teone qui come nelle altre applicazioni del metodo (Laur Plut 2818 ff 136v [tav 3] e 190r) descrive brevemente ed espone esplicitamente la stessa tavola dei sottomultipli del divisore che
40 Esempio nella divisione di 378 per 17 il massimo multiplo egrave 374 il quoziente parziale egrave 22 il resto 4 e in effetti 378 = 374 + 4 = 17times22 + 4 Si noti che il segno per laquorestoraquo non egrave apposto in testa di riga ma davanti a ogni resto parziale e in effetti il dividendo che si trova in prima posizione in questa riga non egrave un resto
41 Analogamente nellrsquoalgoritmo moderno poniamo la virgola o scaliamo la cifra di un posto
42 Nei Prolegomena la descrizione della tabella associata al metodo anonimo egrave pre-ceduta da una breve sinossi dellrsquooperazione in stile procedurale (cioegrave senza riferimenti alla tabella) e seguita dalla sua esecuzione accurata ma con pochi riferimenti alla tabella se non quello ai due segni da apporre ai resti parziali e ai massimi multipli
43 Alm III 1 in POO I 1 p 2091-4
Fabio Acerbi138
troviamo nei Prolegomena ma non offre alcuna descrizione della disposi-zione tabellare della divisione stessa neacute vi fa riferimento
A questa procedura sono in effetti associate una tavola e una tabel-la costruite come segue (tavv 4 e 5 Marc gr 313 ff 17r e 17v il co-pista era ndash giustamente ndash insoddisfatto della prima versione) La tavola le cui righe e colonne sono delimitate da linee contiene sottomultipli44 del divisore 365 14 48 9 righe che riportano i valori da 160 a 960 piugrave altre 6 con i valori per decine da 1060 a 6060 la prima colonna elenca le 15 parti sessagesimali omettendo come drsquoabitudine la laquodenomina-zioneraquo dellrsquoordine (i numerali elencati sono quindi α β γ δ ε ϛ ζ η θ ι κ λ μ ν ξ) la seconda i sottomultipli corrispondenti organizzati su quattro colonne per tener conto dei tre ordini sessagesimali (il primo sottomultiplo egrave quindi ϛ ε´ ιδ´´ μη´´´ cioegrave 160 di τξε ιδ´ μη´´) La tabella priva di linee delimitanti espone la vera divisione Nella prima colonna troviamo i resti parziali ognuno preceduto dallrsquoindicazione del proprio ordine sessagesimale e da un segno per laquorestoraquo Nella seconda preceduti da un segno per laquosottrairaquo i sottraendi ognuno coincide ovviamente con uno dei sottomultipli nella tavola La terza colonna contiene se-guiti dallrsquoindicazione del proprio ordine sessagesimale i quozienti par-ziali ottenuti trascrivendo dalla prima riga della tavola il numerale corrispondente al sottraendo affiancato ed assegnando come ordine sessagesimale il successivo a quello posto in testa di riga Il risultato preceduto da un segno per laquorisultaraquo e posto al di sotto della tabella si ottiene sommando i quozienti parziali il procedimento non permette in generale di determinare lrsquointero quoziente parziale relativo ad un ordine sessagesimale fissato se non dopo due passi Una linea spezzata unisce i resti parziali successivi e i relativi sottraendi per evidenziare la laquoprogressione della proceduraraquo la spezzata lsquosaltarsquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore (le cui righe sono per il resto vuote) e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue di conseguenza anche il quoziente parziale relativo a questo resto appartiene allrsquoordine sessagesimale successivo
A questo punto possiamo rivolgerci alle tavv 4-5 e verificare se le immagini che ci siamo formati sulla base della mia descrizione corri-spondono a quelle che troviamo nel Marc gr 313 Non si tratta di un giochetto sterile egrave al contrario il cuore di un intrico di problemi Un primo ordine di problemi deriva dal fatto che nei Prolegomena lrsquoalgo-
44 Sottomultipli e non multipli in quanto il divisore egrave maggiore del dividendo Drsquoaltronde nel sistema sessagesimale come in quello decimale un sottomultiplo si ottiene dal multiplo corrispondente semplicemente scalando tutte le cifre di un posto (ad esempio 1360 di 365 14 48 si ottiene in questa maniera da 13 volte 365 14 48)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 139
ritmo della divisione lsquoalla Papporsquo non egrave mai eseguito (cioegrave formulato verbalmente) in maniera indipendente dalla descrizione della tabella Comrsquoegrave dunque possibile descrivere una tabella operazionale che non ha uno statuto testuale indipendente sulla base di un algoritmo in corso di esecuzione E drsquoaltro canto come non rilevare unrsquoanomalia in un algoritmo eseguito nella sua forma primaria sotto forma di descrizione di una tabella Ci potremmo chiedere se viene descritto lrsquoalgoritmo o la tabella La tensione fra i due enti grafici egrave acuita dal fatto che nei nostri testi tutto ciograve (esposizione o descrizione di un algoritmo o della tabella associata) avviene sempre e solo sulla base di un esempio numerico para-digmatico Per questo motivo la tabella in quanto struttura (cioegrave privata dei dati numerici accidentali) non puograve fare a meno della descrizione45 Dal canto suo Teone come forse Pappo ancor prima descrive ed espone la tavola dei (sotto)multipli ma non la tabella di divisione lrsquoalgoritmo relativo a questrsquoultima egrave espresso come per controbilanciare in maniera eccezionalmente trasparente e formulare Se ciograve comporta un guada-gno a livello verbale-argomentativo sorge un problema operativo grave come e dove sistemare i resti e i quozienti parziali ndash cioegrave tutti i numeri in output dellrsquoalgoritmo differenti dai (sotto)multipli ndash che la tabella si incarica di disporre in modo lsquonaturalersquo Teone prescrive soltanto di confrontare i resti con la seconda colonna della tavola dei sottomultipli e di trascrivere via via il quoziente ottenuto dopo ogni passo Insomma come eseguire materialmente una divisione Non certo adattando ad un nuovo caso specifico la formulazione dellrsquoalgoritmo che Teone propone
Un secondo ordine di problemi e una trappola micidiale per il co-pista egrave interno alla dialettica lsquotabellarsquolsquosua descrizionersquo ed egrave in assenza di simbolismo quello dei riferimenti linguistici da adottarsi nella seconda agli enti grafici che figurano nella prima Occorre ricercare la massima generalitagrave fornita da una descrizione definita di un ente numerico (ad esempio impiegando il termine laquorestoraquo o la perifrasi laquomassimo sotto-multiplo minoranteraquo) o basta assumere direttamente il suo valore speci-fico come esempio paradigmatico E in che modo risolvere il conflitto tra uso e menzione se come nel nostro caso la tabella contiene segni convenzionali ed occorre fornirne una descrizione Si rende ad esempio necessario introdurre un lsquooperatore di citazionersquo noi useremmo le virgo-lette la lingua greca premette lrsquoarticolo neutro Drsquoaccordo ma nel caso
45 Questa caratteristica non egrave connaturata alla matematica degli algoritmi la risorsa dello lsquostile proceduralersquo serve esattamente ad aggirare questo problema al di lagrave di un certo livello di dettaglio perograve essa condurrebbe ad un appesantimento insostenibile della for-mulazione dovuto alla pluralitagrave dei riferimenti agli oggetti matematici in gioco sulla que-stione dei diversi stili della matematica greca si veda Acerbi 2012
Fabio Acerbi140
greco qual egrave il suo range E come distinguerlo nei casi ambigui da un semplice articolo che precede un sostantivo quando questrsquoultimo lo ri-chieda Nel corso del processo di copia del testo della descrizione infine possono generarsi tensioni tra enti grafici interpretabili vuoi come segno convenzionale vuoi come abbreviazione Ambiguitagrave relative a questi punti opacizzano la descrizione Un problema analogo si porrebbe a priori nella dialettica tra uso delle lettere denotative per designare enti geometrici e loro menzione nella costruzione di un diagramma ma esso egrave risolto con lrsquoazzeramento della seconda funzione le lettere denota-tive sono sempre usate allrsquointerno del testo (sono cioegrave il referente degli oggetti geometrici di cui tratta il discorso matematico) mai menzionate (come accadrebbe se fossero il referente di oggetti grafici posti nel dia-gramma) Insomma il codice adottato per la costituzione dei diagrammi geometrici egrave condiviso (cioegrave canonizzato) semplice e perspicuo mentre quello per le tabelle operazionali non lo egrave da qui le sviste dei copisti e le trascuratezze di correttori ed editori
Infine chi vuole apprendere da questi testi come eseguire una divi-sione a cosa deve prestar fede se ad esempio a causa di errori di copia la descrizione finisce per non coincidere con la tabella operazionale visto che sono entrambe due maniere valide di eseguire lo stesso algoritmo Dopo tutto lo scopo di tutta questa macchina grafico-argomentativa egrave di insegnare a eseguire divisioni in formato tabellare Questo problema si fa particolarmente acuto se la tabella non egrave trasparente nel metodo di Pappo lo egrave quasi completamente in quello anonimo no E gli errori che riscontreremo nella (doppia) tabella ai ff 17r-v del Marc gr 313 a chi sono attribuibili Allrsquoautore al trascrittore o al copista medievale
Questo groviglio di problemi riceve alcune risposte sorprendenti dalla tradizione manoscritta come andiamo finalmente a vedere
4 Analisi delle testimonianze
I codici che ho adibito per lrsquoedizione sono i seguenti M = Marc gr 31346 C = Marc gr 314 (Tolomeo Tetrabiblos et opera minora cum commentariis Vezio Valente Anthologiae)47 Z = Vat gr 2326 (fattizio
46 Riferibile al sec IX ex-X in accolgo la datazione suggeritami per litteras il 522005 da Nigel G Wilson si veda anche Agati 1992 pp 141-142 La presenza non sistematica degli accenti che fa anticipare a Wilson la datazione di laquosaec X medraquo fornita in Mioni 1985 p 24 indusse Boris Fonkič (2005 non vidi) ad assegnare il codice allrsquoinizio del IX secolo
47 Il manoscritto riferibile alla seconda o terza decade della prima metagrave del XIV secolo fu vergato da Michele Clostomalle olim lsquoMetochitesschreiberrsquo Bianconi 2005a pp 428-430 Il titolo dei Prolegomena in questa trascrizione identico in grafia ma non in formulazione a
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 141
e mutilo Tolomeo Almagestum) S = Vat gr 184 (varia astronomica scholia miscellanea ad Almagestum Tolomeo Almagestum) P = Par gr 2390 (varia astronomica) gli ultimi tre riferibili allo scorcio del XIII secolo48 e apografi sicuri del Vat gr 159449 attualmente mutilo di due fascicoli che ci privano dei due terzi finali dei Prolegomena M e il Vat gr 1594 ammettono un modello comune il resto della tradizione (25 trascrizioni in tutto) dipende dagli apografi appena citati del Vat gr 1594 Le varianti della recensione bizantina che leggiamo tra lrsquoaltro nei Vat gr 198 Marc gr 310 (Tolomeo Almagestum cum commentariis Pappi Theonis et Cabasilae) e con ulteriori modifiche Laur Plut 89 sup 48 (varia astronomica Tolomeo Almagestum Barlaam Logistica) sono identificate dal siglum K e si trovano punteggiatura originale in-clusa nel secondo apparato50 Lrsquoanalisi delle testimonianze51 costituite ovviamente anche dalle tabelle associate saragrave condotta nella forma di una sequenza di osservazioni indicizzate da numerali o lettere oltre che di alcune note a piersquo di pagina
Iniziamo dalla descrizione del metodo di divisione anonimo
quello che leggiamo nel Vat gr 1594 (questrsquoultimo coincide con quello adottato nella recen-sione bizantina) fu apposto da Niceforo Gregora e successivamente corretto da Bessarione
48 Sto studiando il primo e il terzo codice in collaborazione rispettivamente con Daniele Bianconi e Inmaculada Peacuterez Martiacuten
49 Su questo codice risalente alla seconda metagrave del IX secolo e sulla sua collocazione nella lsquocollezione filosoficarsquo per prima proposta in Follieri 1977 pp 145-146 si vedano almeno Perria 1991 pp 82-88 Ronconi 2013 Che il titolo dei Prolegomena nel Vat gr 1594 sia stato apposto da Niceforo Gregora egrave stato riconosciuto per la prima volta in Mazzucchi 1994 p 211 n 196 si veda Bianconi 2005a p 418 per altri interventi di Gregora nello stesso manoscritto
50 Il Vat gr 198 egrave stato vergato dal copista Malachia nel corso del terzo quarto del XIV secolo Mondrain 2004 pp 278-290 e 292 Allo stesso copista (denominato non a caso prima dellrsquoidentificazione anonymus Aristotelicus) dobbiamo un buon numero di trascrizioni aristoteliche con i relativi commentari in margine Gli dobbiamo anche il Par gr 2342 secondo tomo di un quadrivium quasi completo di cui il Vat gr 198 egrave il primo nellrsquoordine aritmetica armonica astronomia (Almagesto e commentari relativi) nel codice vaticano geometria ed ancora astronomia (corpus astronomico minore) in quello parigino le opere trascritte sono sempre accompagnate in margine dai relativi commentari Il copista del Marc gr 310 egrave Isacco Argiro (ca 1300-1375) Mondrain 2007 p 166 Allo stesso Argiro dobbiamo il codice laurenziano (Daniele Bianconi per litteras) Poicheacute la recensione modificata che leggiamo nel Laur Plut 89 sup 48 egrave senza alcun dubbio basata su quella nel Marc gr 310 e non viceversa ci troviamo di fronte ad un copista che trascrive due volte lo stesso testo in due versioni leggermente differenti la conclusione naturale egrave che la seconda recensione egrave dovuta ad Argiro stesso la questione andragrave studiata in dettaglio
51 Nei manoscritti citati i Prolegomena si trovano ai fogli seguenti Vat gr 1594 ff 1r-8v (mutilo mancano due fascicoli su tre) Marc gr 313 ff 1r-28r (incompleto man-cano due fogli allrsquoinizio e il f 6 attualmente rimpiazzato da uno bianco) Marc gr 314 ff 235r-255r Vat gr 2326 ff 19r-40v e 43r-v (incompleto e con i fascicoli in disordine) Vat gr 184 ff 10r-23v Par gr 2390 ff 1r-13v Vat gr 198 ff 127r-136v Marc gr 310 ff 1r-13r Laur Plut 89 sup 48 ff 7r-19r
Fabio Acerbi142
ἐκθέμενοι οὖν διάγραμμα τῶν ἀριθμῶν ὡς ὑπόκειται προτάσσομεν τὸν μεριζόμενον καὶ μικρὸν ὑπ᾽ αὐτὸν τὸν μερίζοντα ὡς ἔχει τὸ διάγραμμα ἐν στίχοις διοριζομένοις ὑπὸ γραμμῶν [hellip] καὶ τὰ μὲν γινόμενα ἐγγὺς ἐλάττονα ἐν τῇ μεταξὺ θέσει τοῦ μεριζομένου καὶ τοῦ μερίζοντος ἐν στίχοις παρασημειοῦσθαι πρὸς τὸ ἀσύγχυτον εἶναι τὴν τάξιν τὰ δὲ μεθ᾿ ὧν ὁ μερίζων ἐποίει τοὺς ἀεὶ ἐλάσσονας ὑπὸ τὸν μερίζοντα σημειοῦσθαι προγράφοντας ἐπὶ τοῦ στίχου αὐτῶν τὸ γίνεται οὕτως γι ἐν δὲ τῷ στίχῳ τῶν μεριζόντων τὸ παρὰ ἔχον οὕτως oslash ἀντὶ τοῦ παρ᾿ ἃ δεῖ τὸν μερισμὸν γίνεσθαι ἐν δὲ τῷ στίχῳ τῶν ἐλασσόνων τὸ αφ διὰ τὸ τούτους ἀεὶ ἀφαιρεῖσθαι ἀπὸ τῶν ἐπάνω τῶν μεριζομένων ἐν δὲ τοῖς τοῦ μεριζομένου λοιπάσμασι τοῖς καὶ ἐπιοφείλουσι τὸ λ κατὰ τὸ ἴδιον τῶν διαστάσεων ἑκάστης ndash λέγω δὴ λοιπάδος ndash ἀντὶ τοῦ λοιποὶ οἱ μέλλοντες ἐπιμερίζεσθαι
2 post τὸν suprascr τὸν ἐλάττονα m 2 S 5 πρὸς] MP et ex corr Z κατὰ S om C | ἀσύγχυτον] MSPC -χητον Z 6 ἀεὶ] MZPC ὡσεὶ S 7 γίνεται οὕτως γι ] γι τ οὕτως γι τ M γί οὕτως γί Z γι οὕτως γί SC τὸ γινόμενον οὕτως γίνεται P 8 τὸ παρὰ ἔχον οὕτως] scripsi τὸ παρέχον οὕτως M et π(αρ-) comp Z οὕτως τὸ περιέχον S προγράφοντας οὕτως ex corr m 2 P τὸ περιέχον οὕτως C | oslash] MZSC (sed ο fecit | Z) ἐλάττων comp ex corr m 2 P | παρ᾿ ἃ] scripsi παρα M π(αρα) comp ZSC ex παρα fe-cit παρὰ et τοῦτον suprascr m 2 P 9 γίνεσθαι] comp C | αφ ] αφ ε M ἀφ ZSC ἀφαί P | ἀεὶ] om M 11 ἐπιοφείλουσι] MZSC ex ἐπιο- fecit ἐπο- m 2 P | λ] MZPC λ´ S 12 λοιποὶ] PC λοιποῦ MZS
3 στίχοις] στίχῳ K 5 πρὸς] διὰ K 7 ἐπὶ mdash γι ] τὸ γίνεται διὰ τοιούτου σ(ημείου) γί K 8 τὸ παρὰ ἔχον mdash παρ᾿ ἃ] τὸ παρᾱ διὰ σ(ημείου) τοιούτου καὶ τοῦτο oslash δηλοῦντος τοῦ παρᾱ ὅτι παρὰ τὸν τοιοῦτον (ἀριθμὸν) K 9 αφ διὰ τὸ τούτους] ἀφ δηλοῖ δὲ τοῦτο ἀφαίρεσ(ιν) ὅτι τούτους ἀεὶ δεῖ K 11 ἐπιοφείλουσι] ἐπιμερίζεσθαι ὀφείλουσι K | λ] λ οι` K 12 ἀντὶ τοῦ] δηλοῦντος τοῦ σ(ημείου) τὸ K
lsquoRendendo esplicito un diagramma numerico come lo troviamo qui sotto disponiamo in primo luogo il dividendo e un poco al di sotto di esso il divisore come li ha il diagramma in righe delimitate da linee [hellip] e lsaquooccorreragraversaquo nella posizione tra il dividendo e il divisore annotare lrsquouno accanto allrsquoaltro i piugrave vicini lsaquodei numerirsaquo minori che risultano affincheacute la disposizione non sia confusa quelli con cui il divisore faceva ogni volta i lsaquonumerirsaquo minori annotarli sotto il divisore scrivendo in prima posizione sulla loro riga laquorisultaraquo cosigrave Ris nella riga dei diviso-ri52 invece laquoperraquo fatto cosigrave53 P in luogo di laquoquelli per cui deve farsi la divisioneraquo nella riga dei lsaquonumerirsaquo minori laquosottrraquo in quanto questi sono sempre sottratti dai dividendi che si trovano sopra nei residuli del dividendo (occorre ben farlo anche per loro) laquoReraquo in accordo con ciograve
52 I laquodivisoriraquo sono al plurale ma siamo semplicemente di fronte a un tratto idioma-tico della lingua greca nel caso di espressioni generalizzanti crsquoegrave soltanto un divisore che occupa lrsquounica colonna di cui si compone la sua riga
53 Si intenda ἔχον οὕτως = ita se habens
1
5
10
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 143
che egrave proprio agli scarti di ciascuno ndash intendo qui lsaquociascunrsaquo residuo54 ndash in luogo di laquoresti che vanno a essere divisi ulteriormenteraquorsquo
a) Operatori di citazione e segni convenzionali I segni introdotti sono quattro la mia discussione egrave condotta dando per scontato che essi siano identici a quelli impiegati dallrsquoautore dei Prolegomena anche se si tratta di unrsquoipotesi non corroborabile neacute falsificabile
i Segno per il risultato Lrsquoabbreviazione convenzionale per γίνεται egrave identica al segno introdotto dallrsquoautore e i copisti si dividono tra i due errori possibili scrivere due abbreviazioni o risolverle entrambe Un fenomeno del tutto analogo si riscontra nel Matr 4678 il manoscritto alla base di tutta la tradizione degli Arithmetica di Diofanto al momen-to della definizione dellrsquoἀριθμός (lrsquolsquoincognitarsquo nel nostro linguaggio) ὁ δὲ μηδὲν τούτων τῶν ἰδιωμάτων κτησάμενος ἔχων δὲ ἐν ἑαυτῷ πλῆθος μονάδων ἄλογος ςο` καλεῖται ς` ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον τὸ ς` laquoil lsaquonumerorsaquo che non possiede nessuna di queste proprietagrave ma che ha in seacute una molteplicitagrave indefinita di unitagrave egrave chiamato lsquonumerorsquo e il suo segno egrave ς`raquo Qui solo il terzo dei tre ς ha una barra a sormontare per segnalarne il carattere puramente denotativo (cioegrave di segno convenzionale e non di abbreviazione si veda il punto successivo)55 il primo egrave una delle abbreviazioni piugrave diffuse per ἀριθμός (e infatti egrave dotato del compendio per la desinenza e dellrsquoaccento grave) il secondo egrave una delle piugrave comu-ni per καὶ () Giovanni Cortasmeno autore di capillari annotazioni infra lineam agli Arithmetica nel codice madrileno scioglie il primo ςο`
54 Doppia variatio che impiega al posto di λοιπόν laquorestoraquo i due termini decisamente non canonici τὸ λοίπασμα e ἡ λοιπάς (piugrave oltre leggiamo anche il participio λοιπασθέντα) Una ricerca sul TLG in rete non ha fornito occorrenze del primo si tratta dunque di uno hapax Quanto al secondo che ricorre anche nella sezione sulla divisione lsquoalla Papporsquo lo si rintraccia giagrave nei papiri documentari il termine diventeragrave perograve canonico nelle esposizioni bizantine drsquointroduzione allrsquoAlmagesto ricalcate sul modello dei Prolegomena (si veda la nota 87 infra) Questi due termini designano i resti parziali prodotti nel corso di una divisione lunga li ho tradotti rispettivamente con il neologismo laquoresiduloraquo e con il sostantivo pari-menti non canonico laquoresiduoraquo
55 Il copista interpreta erroneamente il terzo segno come unrsquoabbreviazione e qui ag-giunge un apice inverso (cioegrave un accento grave) altrove lo scioglie direttamente in forme opportune di ἀριθμός Matr 4678 f 58v La frase come la leggiamo nel manoscritto egrave cor-rotta sulla base di una parafrasi in Psello (edita in DOO II p 3710-12) Tannery emendograve ἄλογος in ἀόριστον DOO I p 64-5 et app Il Matritensis vergato da due copisti differenti (cambio di mano a tre righe dalla fine del f 62r) contiene lrsquoIntroductio arithmetica di Nicomaco e le opere diofantee oltre ad alcuni brevi opuscoli musicali la sua data egrave stata recentemente corretta dal XIII al secolo XI pm in Peacuterez Martiacuten 2006 (una riproduzione digitale del manoscritto si trova allrsquoindirizzo httpbdhbneesbnesearchbibliotecaDio-fanto20de20AlejandrC3ADa)
Fabio Acerbi144
in ἀριθμός ed aggiunge un altro segno56 sopra il terzo anteponendovi lrsquoindicazione καὶ ἔστιν αὐτοῦ σ(ημεῖον) τόδε Va da seacute che non abbiamo nessuna garanzia che il segno originariamente introdotto da Diofanto coincidesse realmente con unrsquoabbreviazione convenzionale per ἀριθμός Lrsquoevidenza del PMich III 144 (sec II in) suggerisce drsquoaltronde che il Matritensis e con esso tutta la tradizione medievale di Diofanto ripro-duca fedelmente pur accentuandone la sinuositagrave il segno originario
ii Segno per il divisore Un cerchiolino sbarrato da non confondere con il segno per ὁμοῦ che nei manoscritti matematici ha di norma due barre trasversali (cf tav 2a) Non sono riuscito a rintracciarne ulteriori occorrenze in altre opere la forma che esso assume nel Vat gr 2326 e la correzione apportata nel Par gr 2390 lasciano aperta la possibilitagrave per quanto a mio avviso remota che la forma originaria non fosse lon-tana da unrsquoabbreviazione di παρά registrata nei repertori57 Il correttore del Par gr 2390 trasforma in effetti il segno oslash nellrsquoaffine abbreviazione canonica per (forme di) ἐλάσσων laquominoreraquo58 e si incarica diligente-mente di farlo notare ricapitolando i segni nella porzione superiore del margine esterno del f 7v Nello stesso margine egli traccia anche uno lsquoscolio tabellarersquo ed egrave lrsquounico a porre il (proprio) segno dove indicato dalla descrizione (tav 6 Par gr 2390 f 7v) Oltre a ciograve adattando la tabella al margine ristretto lo scoliaste trascrive come colonne affian-cate le due righe dei resti parziali e dei massimi multipli e aggiunge le indicazioni ὁ μεριζόμενος laquodividendoraquo e ὁ μερίζων laquodivisoreraquo ma vi introduce alcune incongruenze di formato il risultato scritto in verti-cale e la linea verticale di sinistra che separa il divisore dal segno che lo dovrebbe precedere direttamente
iii Segno per i massimi multipli Corrisponde alla semplice abbre-viazione per sospensione della forma verbale ἄφελε laquosottrairaquo in questo
56 Si tratta del segno di ampio uso praticamente identico allrsquoabbreviazione canonica per οὖν
57 Si tratta di un pi a forma di gancio sbarrato da uno slash di troncamento Ce-reteli 1904 tav IX item 7 sub ΠΑΡΑ che rinvia al PVindRain 423 cf anche la forma π` nel POxy LXI 4142 edito in Jones 1999 II pp 26-34 In generale nei papiri e nei manoscritti matematici in maiuscola le preposizioni sono abbreviate facendo seguire un lsquoapostroforsquo alla loro prima lettera Α᾽ Υ᾽ ecc Per la seconda fattispecie di supporto libra-rio si veda in particolare il cosiddetto fragmentum mathematicum Bobiense scriptio inferior databile al V-VI secolo del palinsesto Milano Biblioteca Ambrosiana L 99 sup (Isidoro di Siviglia Etymologiae datazione Cavallo 1977 p 100) pp 113-114 che sono stampate in riproduzione apografa conforme in Belger 1881 (la p 114 egrave riprodotta anche nella tav 10 di Acerbi 2010)
58 Se questa era lrsquointenzione si tratta ovviamente di una forzatura il divisore puograve ben essere maggiore del dividendo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 145
caso lo slash di troncamento taglia orizzontalmente il tratto verticale del phi I copisti offrono molteplici varianti apponendo chi uno spirito dolce chi un ε chi un αί accentato a sormontare Tutti questi segni svolgono la funzione di abbreviazioni vere e proprie (e cosigrave doveva essere anche per lrsquoautore si veda il punto 1 di p 153 infra) la forma originale si ottiene a mio avviso incrociando i dati del Marc gr 313 e dei tre apografi del Vat gr 1594 αφ anche se lrsquoassenza dello spirito potrebbe essere semplicemente dovuta alla pratica del copista del codice veneziano di economizzare nei diacritici
iv Segno per i resti Un lambda completato da una barra a sormon-tare o da un apice che rinvia alle abbreviazioni per sospensione di una forma opportuna di λοιπός laquorestoraquo In realtagrave la forma che troviamo nella tabella egrave differente (tav 2b) e coincide con quella offerta quasi unanimemente dai manoscritti nella descrizione e in almeno un caso nella tabella del metodo di divisione attribuito a Pappo (tav 4) un lambda che accoglie al di sotto una legatura omicron-iota () sbarrata da uno slash di troncamento Qualcosa di simile si trova nel PVindob G 19996 (sec I) una specie di lambda maiuscolo molto aperto e dal vertice arrotondato che include un circoletto interpretato dagli editori come segno per περίεστιν o per λοιπόν59 Lo stesso segno si rintraccia ad esempio in un medesimo scolio tabellare di prima mano ad Alma-gestum nel Vat gr 1594 f 93v e nel Marc gr 313 f 135r ma stavolta la forma del lambda egrave molto ben definita
Fin qui i segni Ma il gioco egrave piugrave complesso La descrizione si muo-ve pericolosamente sulla linea di confine non sempre ben definita tra segno convenzionale e abbreviazione il primo ndash e il repertorio grafico matematico-astronomico ne egrave particolarmente fornito60 ndash puograve anche
59 Ho consultato lrsquoedizione Gerstinger ndash Vogel 1932 pp 46 e 48 la porzione rilevante del papiro egrave riprodotta nella tav 11 di Fowler 1999 Si veda ancora ivi pp 253-257 per la trascrizione di questo segmento di testo (con correzioni rispetto alla princeps) e per una messa a punto recente inclusa la proposta di datazione che ho riportato qui sopra Il verso del papiro che contiene una tavola aritmetica del tutto scorrelata dalla tematica del recto egrave edito come PRain Unterricht 151
60 La pratica di ridurre lo spazio occupato da un testo tecnico per mezzo di abbreviazioni e segni convenzionali era molto diffusa nei manoscritti in maiuscola contrariamente a quanto avviene per altri generi letterari vedremo tra breve cosa accade negli Arithmetica di Diofanto ma si leggano in proposito anche le considerazioni di Hei-berg nei prolegomena alla propria edizione dellrsquoAlmagesto in particolare riguardo al ricorso massiccio ad espedienti brachigrafici nel modello del Vat gr 180 POO II pp lxxxiv-xciii civ-cv cxxvii cxxxviii-cxxxix Agli elenchi dettagliati forniti da Heiberg possiamo aggiungere il piccolo prontuario stampato in Hultsch 1876-1878 III 2 pp 126-132 e basato sul testo e sugli scolii alla Collectio di Pappo nel Vat gr 218 (sec X in) Si vedano infine le osservazioni del copista del Par gr 2360 f 120v trascritte da Heiberg in AOO III pp x-xi sulle laquonotazioni tipiche a scopo di tagliar corto nello scrivereraquo impiegate nel pro-
Fabio Acerbi146
derivare dalla seconda (un caso egrave appunto il segno per ἐλάσσων che probabilmente trae origine da una legatura epsilon-lambda) ma poi il rapporto referente-relato si fissa convenzionalmente Quelli definiti nel testo che abbiamo letto sono appunto segni convenzionali non ci sarebbe bisogno di spiegarne forma e funzione se fossero intesi come abbreviazioni assumono nella tabella una funzione denotativa non esplicativa o discorsiva (come accade invece nella tav 1a) Ma come vengono descritti questi segni
I referenti delle descrizioni sono i segni sono introdotti da οὕτως (item i-ii) o in alternativa da un τό con il ruolo di lsquooperatore di citazionersquo (item iii-iv) che corrisponde esattamente alle nostre virgolette In entram-bi i casi gli enti sono menzionati e svolgono una funzione metalinguistica sono collocati materialmente nel testo ma egrave come se si trovassero fuori e la loro descrizione li additasse ndash in effetti i segni convenzionali scritti nel testo sono a loro volta i relata di quelli che si trovano nella tabella
I relata dei segni scritti nel testo sono di due tipi singoli vocaboli (item i-ii) o descrizioni della funzione dei segni per mezzo di clausole sintaticamente complesse (item ii e iv) I singoli vocaboli sono γίνεται e παρά e sono entrambi preceduti dal τό lsquocitazionalersquo in quanto relata di segni convenzionali le forme abbreviate con cui sono tracciati nei manoscritti vanno forzatamente sciolte Bisogna ammettere che la per-spicacia e le risorse grafiche dei copisti ndash di cui tutto si puograve dire fuor che commettano qui degli errori ndash sono messe a dura prova con lrsquointrodurre segni identici ad abbreviazioni o con lrsquoattivare un gioco metalinguistico particolarmente serrato in un contesto meno lsquonaturalersquo di come potreb-be esserlo ad esempio quello di un trattato grammaticale Lrsquoitem iii che presenta direttamente un segno identico ad unrsquoabbreviazione non egrave sorretto da una descrizione ma da una giustificazione in διὰ τό Lrsquoartico-lo τό vi assume una funzione metalinguistica anche se non lsquocitazionalersquo poicheacute al tempo stesso genera un infinito sostantivato e lo singolarizza per questo ho scritto laquosono sottrattiraquo in corsivo nella mia traduzione
prio modello archimedeo (nota 32 supra) egli ne compila anche una breve lista Un elenco antico di laquosegni della geometriaraquo sicuramente redatto per assistere il copista si trova anche al f 3v del ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 vergato da Efrem negli anni 950-960 (tav 8 in Acerbi 2010) Possiamo farci unrsquoidea quantitativa del guadagno di spazio in rapporto ad un testo privo di abbreviazioni e con le parole separate da spazi sulla base del fragmentum mathematicum Bobiense il testo vi egrave disposto a tutta pagina su 36 righe di circa 30 segni ciascuna nelle due pagine in questione figurano 2038 segni con 15 mezze righe occupate dalle due figure Ora nel testo dellrsquoedizione stabilita in Heiberg 1927 pp 87-90 le stesse pagine contano 4455 segni spazi compresi Ne risulta che la dimensione in caratteri di un testo matematico puograve essere ridotta di piugrave della metagrave con lrsquoimpiego di compendi e segni convenzionali
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 147
Negli item ii e iv il segno si collega ad una descrizione nel secondo caso in via esclusiva le descrizioni pertanto rinforzano o sostituiscono lrsquoidentificazione con lrsquoente linguistico denotato Le clausole descrittive sono precedute da ἀντί e dallrsquoarticolo τό con funzione di lsquooperatore di citazionersquo esse sono παρ᾿ ἃ δεῖ τὸν μερισμὸν γίνεσθαι (item ii) e λοιποὶ οἱ μέλλοντες ἐπιμερίζεσθαι (item iv) Nella descrizione della divisione lsquoalla Papporsquo che leggeremo tra breve i segni negli item iii e iv rice-vono lo stesso trattamento degli altri due il loro relatum egrave un singolo vocabolo e non una clausola descrittiva rispettivamente nelle espres-sioni τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε (sul participio ritorneremo nel punto 1 infra) e τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά (la forma del segno notato con λ οι egrave descritta supra nellrsquoitem iv) La descrizione del segno oslash per il divisore merita una discussione piugrave dettagliata In origine si trovava probabilmente scritto Π(ΑΡΑ)ΕΧΟΝ successivamente letto come π(αρ[α])έχον ndash dato che lrsquoabbreviazione per il preverbo egrave identica a quella per la preposizione (che sia Π᾽ o un pi seguito dal segno per ἄρα a sormontare) ndash invece di π(αρὰ) ἔχον I copisti e i correttori si dettero a tutte le possibili contorsioni per restituire un testo dotato di senso leggere appunto una forma verbale con preverbo modificare il preverbo (ma forse il segno per ἄρα era insidiosamente simile ad uno epsilon) correggere il testo rileggiamo lrsquoapparato sub τὸ παρὰ ἔχον οὕτως τὸ παρέχον οὕτως M et π(αρ-) comp Z οὕτως τὸ περιέχον S τὸ περιέχον οὕτως C προγράφοντας οὕτως ex corr m 2 P Nella clausola descrittiva seguente la presenza liminare di παρὰ (che ho corretto in παρ᾿ ἃ nella speranza di restituire una frase che abbia un senso senza intervenire sul testo) innesca un bel corto circuito il Π(ΑΡΑ) che sicuramente figu-rava nellrsquoarchetipo egrave un sintagma complesso una preposizione unrsquoab-breviazione o un segno per unrsquoabbreviazione Se lrsquoeditore si trova in conflitto con la propria inclinazione alla critica conservativa i copisti si rifiutarono di mettere mano ad un testo che doveva stridere anche per loro essendo il compito demandato al ritocco del revisore del Par gr 2390 o alla riscrittura radicale del recensore bizantino Il problema egrave che ci troviamo di fronte ad unrsquoespressione che descrive la funzione dellrsquooggetto denotato non lrsquooggetto stesso ma che lo contiene al suo interno per soprammercato qui il Π(ΑΡΑ) egrave usato per giustificare una menzione a sua volta relatum di un segno
Evidentemente questa maniera di procedere che giagrave aveva attirato interventi da parte di copisti e correttori della recensione di base parve insostenibilmente opaca allrsquoautore della recensione bizantina61 Egli
61 Uno dei manoscritti di questa recensione propone anche una tabella di divisione
Fabio Acerbi148
modifica tutte le descrizioni diluendo lrsquoidiomatismo dellrsquoarticolo lsquocita-zionalersquo con lrsquointroduzione sistematica del verbo δηλόω e di frasi atte a chiarire quale sia il segno denotante e quale il vocabolo (o il segno) denotato Egli introduce allo scopo di rendere esplicita la funzione de-notativa dei segni introdotti il termine σημείου curiosamente in tutte le sue tre occorrenze esso compare a sua volta nella forma dellrsquoabbrevia-zione per sospensione σΗ´ Egli traccia il segno per i massimi multipli ἀφ e quello per i resti λ οι` in modo che non vi siano ambiguitagrave quanto al loro carattere di abbreviazione Si faccia infine attenzione al residuo di barra sul παρᾱ con funzione denotativa (2 occorrenze) contenuto nella descrizione del segno per il divisore sostituita dallrsquoaccento grave nel παρὰ con funzione discorsiva (la differenza egrave nettissima nei manoscritti da me consultati) Questa osservazione ci permette di passare direttamente allrsquoitem seguente
b) Le barre sui numerali e sulle lettere denotative Egrave opportuno discutere questo punto adesso esattamente percheacute di barre siffatte che pure troviamo in tutti i manoscritti i nostri testi non fanno mai menzione si tratta infatti di una pratica condivisa sin dallrsquoantichitagrave La barra identifica una stringa di lettere dellrsquoalfabeto che non svolge una funzione grammaticale o sintattica propria allrsquointerno del discorso Ciograve avviene in particolare e si tratta della fattispecie piugrave frequente se la stringa di lettere non dagrave origine a un vocabolo della lingua greca lette-re denotative e numerali certo ma anche termini provenienti da altri idiomi e contrazioni di parole greche come i nomina sacra62 tali termi-ni possono essere o no preceduti da un articolo lsquocitazionalersquo a seconda dellrsquouso che ne viene fatto allrsquointerno del discorso Ma non si tratta dellrsquounica fattispecie i papiri grammaticali ed i manoscritti piugrave antichi dei trattati dello stesso argomento segnalano gli esempi delle parti del discorso (cioegrave di lsquoverersquo parole greche) per mezzo di barre sormontanti63 La differenza insomma egrave tra menzione e uso (come parte del discorso in atto) di una stringa di caratteri tra il porre le lsquovirgolettersquo e il non porle tra funzione denotativa e non Apparentemente la convenzione si limi-
corredata dei segni opportuni e contrariamente alle indicazioni della descrizione svilup-pata lsquoin verticalersquo ma per motivi misteriosi non completa (tav 7a Laur Plut 89 sup 48 f 13r)
62 Tutto ciograve egrave spiegato con estrema chiarezza giagrave in Traube 1907 pp 45-4763 Si veda il Par gr 2548 codex vetustissimus e testimone unico delle lsquoopere minorirsquo
di Apollonio Discolo il f 106v con le barre ben visibili egrave riprodotto come tav 19 in De Gregorio 2000 (ivi pp 137-138 per la datazione) Per la testimonianza dei papiri grammaticali si veda Wouters 1979 passim essi contengono di norma elenchi di parti del discorso nessuna delle quali egrave preceduta dallrsquoarticolo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 149
tava in questo secondo caso a segnalare con la barra singoli vocaboli le menzioni di frasi o di sintagmi complessi sono di norma identificate dallrsquoarticolo lsquocitazionalersquo Drsquoaltra parte le abbreviazioni convenzionali non rientrano nella casistica percheacute la loro resa grafica che contiene elementi non alfabetici come compendi per desinenze lettere supra li-neam marche di contrazione o sospensione quali slashes o barre sotto-poste o sormontanti eventualmente solo un sottinsieme della stringa di segni alfabetici le esclude automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
Venendo al discorso matematico una barra sormonta senza ecce-zione le lettere denotative64 che sia in papiri o in manoscritti in maiu-scola65 o minuscola ma solo allrsquointerno del testo comrsquoegrave da attendersi nei diagrammi esse la perdono per il semplice motivo che non crsquoegrave alcun testo ambiente un diagramma ha unicamente una funzione denotati-va Drsquoaltra parte le lettere numerali che a volte figurano nei diagrammi della tradizione metrica66 allo scopo di indicare la lunghezza dei seg-menti mantengono la barra in un diagramma il contesto denotativo geometrico egrave prevalente e i numerali vengono percepiti come entitagrave grafiche lsquoesternersquo al discorso Va da seacute a fortiori che le lettere numerali inserite in un testo dovranno essere segnalate da barre che a loro volta non servono nelle tavole67 in quanto queste ultime sono come abbiamo visto un vero e proprio testo che perograve funge da ambiente a quello al-fabetico limitato alle titolazioni e non a caso tracciato in unrsquoopportuna lsquomaiuscola distintivarsquo allo scopo di segnalarne il carattere denotativo e non discorsivo68 Una tabella operazionale egrave invece un paratesto e quindi le barre sulle lettere numerali che rappresentano gli interi sono
64 La notazione per le lettere denotative subigrave unrsquoevoluzione (il cui risultato finale egrave descritto per sommi capi nella nota 3 supra) di cui non mette conto occuparsi qui
65 I papiri di contenuto geometrico (o astronomici ma che presentano argomenti geometrici) sono rari si vedano il PHerc 1061 (sec II aC Demetrio Lacone De geome-tria) e il PFay 9 (sec II ex Elementi I 39 e 41) Gli importanti ostraka OBerl 12002 e 12609 (sec III aC m Elementi XIII) non pongono le barre sopra le lettere denotative Per i manoscritti in maiuscola si veda ad esempio passim nel Par gr 2389 una cui riproduzione digitale egrave consultabile in rete allrsquoindirizzo httpgallicabnffrark12148btv1b8470171d o il fragmentum mathematicum Bobiense
66 Si veda ancora il ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 codex unicus dei Metrica di Erone e contenente una raccolta importante di problemi del corpus metrologico
67 Si vedano come esempio le tavole citate alle note 10 e 14 supra Discorso a parte per il segno di lsquoposto vuotorsquo si veda il punto c che segue
68 Queste regole generali vanno prese cum grano salis si dagrave naturalmente un certo dominio di variabilitagrave legato verosimilmente al grado di cultura grafica del copista nel PMich III 144 i numerali sono quasi tutti senza barra sia nel testo che nelle tabelle ope-razionali
Fabio Acerbi150
necessarie esse mancano invece sui segni convenzionali che ho descrit-to nel punto precedente e fatto rilevante sulle lettere numerali relative agli ordini sessagesimali quando esse siano identificate da uno o piugrave apici la presenza di questo segno grafico non alfabetico69 le esclude ancora una volta automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo Unrsquoultima osservazione che ci saragrave utile nel seacuteguito la descrizio-ne di una stringa di lettere lsquoagrammaticalersquo non puograve prevedere la men-zione della presenza della barra che le pertiene in quanto tale si tratta di una pratica denotativa che egrave possibile formulare soltanto ad un livello di discorso superiore sia a quello dellrsquouso che a quello della menzione70
c) Il segno di lsquoposto vuotorsquo Si noti nella tav 2b la forma ŏ per il segno di lsquoposto vuotorsquo in un ordine sessagesimale coerentemente con la propria notazione il copista del Marc gr 313 lo scioglie talvolta allrsquoin-terno del testo principale come unrsquoabbreviazione per οὐδέν laquonienteraquo Altre convenzioni di scrittura del tratto che accompagna il circoletto e che si badi bene fa parte integrante del segno di lsquoposto vuotorsquo ndash e infatti nelle tavole troviamo sempre il segno completo mentre tutti gli altri numerali sono come abbiamo visto nel punto precedente privi di barra o di apice a causa del fatto che i vari ordini sessagesimali sono univocamente determinati dalle linee di giustificazione ndash un tratto an-golare anteposto (tav 3 Lar Plut 2818 f 136v)71 o una semplice barra a sormontare (tavv 4-9) si produce in questo modo il segno 65926 che sembra essere stata la forma di base72
69 Occorre dunque supporre come testimoniano papiri e manoscritti in maiuscola che la convenzione relativa allrsquouso della barra si sia consolidata ben prima dellrsquointroduzione di segni diacritici quali accenti e spiriti
70 Si veda il punto 2 infra per maggiori dettagli sulla questione delle barre e degli apici e per le indicazioni in merito che leggiamo in Diofanto
71 Come accennato questa tavola dei sottomultipli coincide con quella descritta ed esposta nei Prolegomena Fatto molto rilevante i numerali nella prima non recano neacute barre neacute apici contrariamente a quanto accade a tutte le istanze della seconda nei manoscritti Quella del Laur Plut 2818 preserva a mio avviso la forma originaria come abbiamo visto una tavola non richiede segni aggiuntivi sulle lettere numerali
72 Si vedano come esempio ancora le tavole citate alle note 10 e 14 supra oppure per una rassegna delle forme che il segno assume nei manoscritti piugrave antichi delle Tavole facili Tihon 2011 pp 58-59 e per quelle che assume nei papiri Jones 1999 I pp 61-62 Ovviamente non possiamo leggere il segno 65926 come un omicron con una barra in quanto ο = 70 nella notazione greca e la barra egrave di rigore quando il numerale figuri allrsquointerno di un testo Occorre ammettere che si dagrave origine ad un bel corto circuito notazionale con il concepire un segno con funzione di lsquoposto vuotorsquo ma che lsquosomigliarsquo ad una lettera dellrsquoalfabeto sormontata da una barra cioegrave ad un numerale in piugrave quando il lsquoposto vuotorsquo non corrisponda ad un intero ma ad una specie sessagesimale la presenza della barra a priori indistinguibile da quella che sormonta gli interi introduce unrsquoincongruenza con la notazione a mezzo di apici vista nellrsquoitem precedente
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 151
d) Errori di copia La tabella riprodotta nella tav 2b ha una forma simmetrica ma si tratta di una forzatura il grande rettangolo in basso a destra drsquoaltronde assente nella descrizione contiene uno scolio che fa notare come lrsquoultimo resto parziale ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ͵γτνζ´´´´´ κζ´´´´´´ cioegrave 0 0 0 0 0 3357 27 siano ἔγγιστα λ´λ´ δ´δ´ ξ laquocon ottima approssimazione 60 minuti quartiraquo dove si notino gli apici semplici per indicare il pas-saggio allrsquoordinale e il raddoppiamento del sistema segno + apice per significare il plurale Lo scolio debitamente accompagnato dal segno di rimando in forma di simbolo solare egrave stato probabilmente incluso nella tabella proprio allo scopo di renderla simmetrica A sua volta un errore precedente spiega lo spazio eccessivo accordato al rettangolo contenente lo scolio il secondo massimo multiplo ŏ λβ´ ξδ´´ ριβ´´´ σιϛ´´´´ egrave trascritto anche al di sotto del risultato
Passiamo ora alla descrizione del metodo di divisione attribuito a Pappo
ἵνα οὖν ταῦτα συναχθῇ τὰ ἐκ τοῦ μερισμοῦ ὁ εἰρημένος Πάππος εὐδιατύπῳ τινὶ καὶ πρὸς τοῦτο τάξει χρησάμενος ποιεῖται τὴν τῆς συλλήψεως τοῦ ζητουμένου ἀνεύρεσιν οὕτως ἐκθέμενος γὰρ τὸν μέλλοντα μερίζεσθαι τουτέστι τὰς τξ μοίρας ἐν ἀρχῇ ἀφαιρεῖ ἀπ᾽ αὐτῶν τὸν ἐν τῇ σελίδι τυγχάνοντα ἐλάττονα τουτέστι τὸν τδ κβ´ κ´´ ὄντα τῶν ἐγγὺς ἐλασσόνων ὡς πρὸς τοὺς ἐκκειμένους διὸ καὶ γράφει αὐτὸν προγράφων αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε καὶ εὑρίσκων τὰ παρακείμενα αὐτῷ τῷ ἀπογραφέντι ἐν τῷ σελιδίῳ λεπτὰ πρῶτα ν´ συναπογράφεται παρατιθῶν αὐτοῖς τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον ἀνατείνουσαν σημαῖνον τὸ εἶδος ὅτι πρῶτα λεπτά εὑρίσκει οὖν οὕτως τὸ τῶν τξ μέρος τὸ τδ κβ´ κ´´ ὃ μεριζόμενον παρὰ τὰς τξε ιδ´ μη´´ ἡμέρας καὶ ποιοῦν τὸν ἐκ τοῦ μερισμοῦ ἀριθμὸν πρῶτα λεπτὰ ν´ καὶ τὸν λοιπὸν ἀπογραφόμενος τὸν νε λζ´ μ´´ προτάσσει αὐτοῦ τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά τάσσει δὲ καὶ ἁπλῆν τινα διατείνουσαν γραμμὴν ὡς ἀπὸ τοῦ τξ ἐπὶ τὸν ἑξῆς ἐκτεθειμένον ἐγγὺς
1
5
10
1 εὐδιατύπῳ] ZSPC εὐδιατύπωτ M 4 ἀφαιρεῖ] MZSP ἀφ ι C 5 ἐλάττονα] P comp MZSC 6 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | αφ ] αφ ε M ἀφ ZS ἀφαί P ἄφ C | ἀντὶ] om C | ἄφελε] MZSP ἄφ C 8 ἀπογραφέντι] MZSP ἐγγραφέντι C | λεπτὰ πρῶτα] P λε πρωτα SC λεπτῶν πρωτ MZ | παρατιθῶν] MZS παρατιθεὶς C et ex corr m 2 P 9 ᾱ] Z αο P α´ MS α C | ἔχον] MPC ἔχων ZS 9-10 πρῶτα λεπτά] ZP πρωτ λ´λ´ M πρωτα λε S αα λε C 11 ἡμέρας] comp codd | ἀριθμὸν] P et comp MZ καὶ C et comp S 12 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M πρωτ λεπτ(α) Z πρωτ λ εᾱ S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C | ἀπογραφόμενος] MZSP ἐγγραφόμενος C | νε λζ´] MZSP λζ νζ C 13 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | λ οι] MZSC ex λ fecit λ οι P | προσσημαῖνον] MC et προσ- comp ZS προση- P | τὸ] MZC τὰ S et fecit m 2 P 14 ἀπὸ] MZSP πρὸς C ἐλάττονα] P comp MZSC
1 εὐδιατύπῳ] εὐδιατυπώτω K 6-7 αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ] τὸ ἀφ K 8 παρατιθῶν mdash 10 λεπτά] τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ σημαίνουσαν τὸ εἶδος αὐτῶν ὅτι ᾱ λεπτά εἰσιν K | τὸ (sec)] τὰ K 12 πρῶτα] πρώτων K | τε λ ] λ οι` K | προσσημαῖνον mdash
Fabio Acerbi152
ἐλάττονα τὸν τδ κβ´ κ´´ ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις καὶ ταύτην ἐπιδεικνύουσαν τὴν τάξιν τῆς προόδου τῆς ἐκθέσεως ἧστινος κλωμένης γραμμῆς πρὸς τῷ ἐγγὺς ἐλάσσονι ἡ ἀντανάκλασις ἐπὶ τὸν λοιπὸν γέγραπται φερομένη ὡς εἴρηται διὰ τὸ εὔτακτον τῆς προκοπῆς οὕτως τε ποιήσας ἑξῆς τὸ αφ ποιῶν ὃ προσσημαίνει ὡς εἴρηται τὸ ὅτι δεῖ ἀφελεῖν ὁμοίως ἀπὸ τοῦ λοιποῦ καὶ δὴ τὸν ἐγγὺς πάλιν ἐλάσσονα ὡς πρὸς τὴν ἐν τῷ σελιδίῳ ἔκθεσιν εὑρισκόμενον λαμβάνων ἑξῆς προγράφει αὐτὸν ὄντα νδ μζ´ ιγ´´ ιβ´´´ καὶ εὑρίσκει αὐτοῖς παρακείμενα ἐν τῷ σελιδίῳ πρῶτα λεπτὰ θ´ ἅτινα καὶ αὐτὰ προσαπογράφεται σὺν τῇ παρασημειώσει τῶν πρώτων γράφων τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον τὴν ἀνατείνουσαν καὶ ὡς εἴρηται τὴν γραμμὴν πάλιν διὰ τὴν τάξιν κλωμένην κατὰ δευτέραν κλάσιν προσέλκει γινομένου τοῦ μέρους αὐτῆς τούτου παραλλήλου τῷ ἐξ ἀρχῆς
16 ante κλωμένης add ἐπὶ C 18 τε] MZP om SC | αφ ] M ἀφ ZSC ἀφαί P 19 προσσημαίνει] MS προση- ZC et ex corr P | ὅτι] ZP comp MSC 20 δὴ] MZSC διὰ fecit m 2 P 21 πρὸς] MSP et supra lineam C ex ἀπὸ fecit m 2 Z | ιγ´´] MZSP νγ´´ C 22 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M ᾱᾱ λεπτὰ Z άάα λε S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C 23 προσαπο- γράφεται] απο suprascr in comp M 24 ᾱ] ZP α´ MS α C 25 κλάσιν] MP τάξιν ZSC | τοῦ] ZSPC τούτου M 26 τούτου] τοῦ bis ZSPC sed prius erasit m 2 P τοῦ M
mdash 18 προκοπῆς] om K | τε ποιήσας] ποιήσας καὶ K | αφ ] ἀφ K 19 τὸ] om K 21 προ-γράφει] γράφει K 22 σελιδίῳ] α´ σελιδίῳ K | ἅτινα] ἃ K 23 προσαπογράφεται] ἀπογράφεται K | τῶν πρώτων mdash 26 ἐξ ἀρχῆς] om K
lsquoAllo scopo di raccogliere ciograve che risulta dalla divisione il detto Pappo utilizzando anche in questo caso una certa disposizione ben strutturata determina nel modo seguente il lsaquonumerorsaquo cercato preso nel suo insieme collocando73 in testa il lsaquonumerorsaquo che sta per essere diviso cioegrave i 360 gradi iniziali sottrae loro tra i piugrave prossimi dei lsaquonumerirsaquo minori rispetto a quelli esposti quello che si trova essere minore nella colonna (cioegrave 304 22 20) Questo egrave il motivo per cui lo trascrive scrivendogli davanti lrsquoabbreviazio-ne laquosottrraquo per laquosottrairaquo e trovando che 50 minuti primi sono collocati accanto a quello stesso lsaquonumerorsaquo che egrave stato trascritto nella colonna li trascrive al tempo stesso collocando accanto74 ad essi la lettera A con un lsaquotrattorsaquo75 sopra che significa la specie minuti primi Trova dunque in que-sto modo la parte di 360 che egrave 304 22 20 la quale divisa per 365 giorni 14 48 fa il numero lsaquoche risultarsaquo dalla divisione 50 minuti primi Trascrivendo
73 La descrizione egrave strutturata come una procedura Acerbi 201274 Il purismo del correttore del Par gr 2390 di Clostomalle nel Marc gr 314 e
dellrsquoautore della recensione bizantina impone loro di modificare la terminazione ma forme tematiche e contratte di τιθεῖν sono correnti nel greco tardivo
75 Il testo greco ha solo il participio con γραμμήν sottinteso Per il significato del participio si veda il punto 2
15
20
25
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 153
poi il resto 55 37 40 gli pone altresigrave76 a prefisso laquoReraquo che significa laquorestiraquo e dispone anche una certa linea semplice77 che va da 360 al piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori che egrave esposto di seacuteguito 304 22 20 come nello lsaquoschemarsaquo esposto linea che mostra lrsquoordine del percorso dellrsquoesposizione Questa linea spezzata lagrave dove si trova il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori egrave tracciata inflessa allrsquoindietro lsaquoersaquo punta verso il resto come egrave stato detto in vista di una progressione ordinata E cosigrave facendo prendendo di seacuteguito il laquosottrraquo che significa come egrave stato detto laquoche occorre similmente sottrarre dal re-storaquo e ovviamente prendendo di nuovo il lsaquonumerorsaquo che egrave trovato essere il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori in relazione alla disposizione nella colonna ndash 54 47 13 12 ndash lo scrive di seacuteguito e trova che 9 minuti primi sono posti loro accanto nella colonna trascrive78 anche questi con la segnaletica dei primi scrivendo la lettera A con un lsaquotrattorsaquo sopra e come egrave stato detto prolunga di nuovo la linea spezzata in vista di una buona disposizione tramite una seconda inflessione essendo questa sua parte parallela a quella inizialersquo
La descrizione continua con una serie di laquoe cosigrave viaraquo e non fa ulte-riore riferimento alla tabella
1) La forma verbale ἐξεσμένον Egrave il neutro del participio perfetto medio-passivo di ξέω lett laquopialloraquo laquolevigoraquo Si danno tre possibilitagrave si tratta di un termine canonico per quanto non altrove attestato per designare unrsquoabbreviazione oppure lrsquoautore anonimo improvvisa sul piano metaforico come se unrsquoabbreviazione non fosse altro che la paro-la completa lsquoaccorciata a colpi di piallarsquo in maniera opportuna oppure il testo egrave corrotto e srsquoimpone una correzione ad esempio τὸ ἑξῆς μένον laquociograve che sta di seacuteguitoraquo Questrsquoultima strada mi pare chiusa dal senso delle frase lrsquoabbreviazione non lsquosta di seacuteguitorsquo a niente ma anzi precede la perifrasi τὸ ἑξῆς μένον se impiegata semplicemente per rimandare al segno αφ immediatamente seguente costituirebbe un intollerabile solecismo Se accettiamo la prima di queste letture considerando quin-di lrsquoabbreviazione αφ in posizione predicativa abbiamo a che fare con
76 Rendo in questo modo il τε isolato77 La linea egrave laquosempliceraquo in quanto egrave una retta la precisazione intende evidenziare per
anticipazione il carattere lsquonon semplicersquo che essa assumeragrave alla prima inflessione quando diventeragrave una spezzata linee siffatte erano in effetti concepite dallrsquoanonimo e prima di lui da tutta la tradizione matematica greca come una singola linea spezzata nei punti drsquoinfles-sione I due segmenti paralleli menzionati al termine del passo sono orizzontali
78 Il verbo egrave al medio in variatio rispetto ai due che precedono e che seguono egrave il matematico che lsquosirsquo trascrive le cifre
Fabio Acerbi154
uno hapax semantico nella grecitagrave superstite come egrave facile verificare con una ricerca sul TLG in rete La recensione bizantina risolve il pro-blema sopprimendo semplicemente τὸ ἐξεσμένον
2) La notazione per le specie numeriche Nella terminologia matema-tica greca gli ordini sessagesimali sono εἴδη laquospecieraquo numerici essi corri- spondono agli ordini di grandezza nel nostro sistema decimale e indica-no in analogia con il caso geometrico la lsquoformarsquo che assume un numero quadrato cubo ecc Centinaia e migliaia sono quindi degli εἴδη rispet-tivamente quadrati (100 egrave il quadrato di 10) e cubi (1000 egrave il cubo di 10) sono specie numeriche ma non numeri particolari e drsquoaltronde 300 non egrave un quadrato ma 3 item dellrsquoεἶδος lsquoquadratorsquo 100 3 egrave il numerale di molteplicitagrave della specie quadrata lsquocentinaiarsquo i due 0 che seguono il 3 segnalano esattamente questo fatto che la notazione greca per gli interi non posizionale fa scomparire al livello denotativo Ciograve non vale soltan-to per i numeri interi ma anche per le loro parti i minuti secondi appar-tengono alla specie lsquoquadratorsquo in quanto 13600 egrave il quadrato di 160
La concezione appare interamente dispiegata nellrsquointroduzione degli Arithmetica diofantei79 che si rivela giova farlo rimarcare un te-stimone fondamentale per la ricostruzione della notazione matematica antica Alle specie usate in questrsquoopera vengono assegnati una denomi-nazione ed un segno convenzionale costituito dallrsquoiniziale (di ognuno dei componenti) della denominazione al quadrato o δύναμις il segno ΔΥ al κύβος il segno ΚΥ alla lsquoquarta potenzarsquo o δυναμοδύναμις il segno ΔΥΔ ecc La descrizione di tali segni egrave del tipo καὶ ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον Κ ἐπίσημον ἔχον Υ ΚΥ κύβος laquoe il suo segno egrave un Κ che ha come indice un Υ ΚΥ cuboraquo dove in accordo con quanto abbiamo visto nel punto b supra e pur nel comprensibile imbarazzo del copista della prima parte del Matritensis (o di un suo passato collega) a districarsi in questo formidabile ginepraio notazionale80 le due lettere Κ e Υ ricevono una barra mentre ΚΥ non la richiede a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον il quale ancora una volta esclude automaticamente il segno dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
79 In particolare a DOO I pp 214-62180 Nel Matr 4678 riscontriamo i seguenti fenomeni nelle poche righe a cavallo dei ff
58r-v 1) accento acuto posto su tutti i segni come se fossero abbreviazioni 2) ripetizione sistematica segnodenominazione come in ΚΥ κύβος appena letto dovuta sicuramente allrsquointrusione di glosse interlineari esplicative dei segni ndash e successivo pentimento (δύναμις e κύβος sono in effetti cancellati dalla prima mano il primo con un tratto il secondo con dei punti supra lineam poi il copista si stanca di correggere) 3) nella descrizione del segno per la δυναμοδύναμις menzione di un δέλτα δύο che saragrave molto probabilmente stato ΔΔ subito dopo nella descrizione del κυβόκυβος si legge un incongruo δύο KK
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 155
Diofanto introduce poi dei segni anche per le specie delle parti dellrsquounitagrave (le nostre frazioni) che egli chiama ὁμώνυμα μορία laquoparti omonimeraquo di cui quelle sessagesimali sono casi particolari81 Egli spie-ga appunto che le loro denominazioni sono ottenute da quelle delle specie degli interi per sinonimia passando ad un lsquoordinalersquo82 formato semplicemente aggiungendo il suffisso -στον δυναμοστόν κυβοστόν δυναμοδυναμοστόν ecc (sott μόριον) I loro segni convenzionali sono invece ottenuti da quelli per le specie degli interi aggiungendo una γραμμὴν διαστέλλουσαν τὸ εἶδος laquolinea che distingue la specieraquo83 Una linea sui segni delle specie delle parti egrave richiesta si badi bene per distinguerli dai segni di quelle degli interi come giagrave osservato questi ultimi sono giagrave lsquoagrammaticalirsquo a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον a fortiori lo saranno anche i primi Si tratta della traduzione semio-tica del passaggio dal cardinale allrsquoordinale che a livello grammaticale egrave effettuato con il suffisso -στον Che forma ha questa linea Barra o apice (Egrave cervellotico pensare a forme piugrave complesse) La domanda non ammette una risposta immediata in quanto delle specie diofantee nessuno piugrave si occupa nellrsquoantichitagrave84 Se egrave vero che la prima risposta darebbe origine ad un conflitto tra due convenzioni denotative diffe-renti la barra lsquocitazionalersquo e la barra che distingue la specie lrsquoevidenza grafica del Matritensis lascia lievemente sgomenti (ricordiamoci che giagrave i segni di base sono indebitamente dotati di un accento dal copista) Le poche occorrenze del segno per le specie delle parti85 vedono lrsquoaggiunta di uno slash di sospensione di un doppio apice inverso ndash in tutta evi-
81 Questo fatto era giagrave chiaro nellrsquoantichitagrave Teone in Alm I 10 in iA p 45310-1682 Il parallelo con i cardinali e gli ordinali relativi agli interi egrave reso esplicito da Dio-
fanto ὥσπερ δὲ τῶν ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια παρομοίως καλεῖται τοῖς ἀριθμοῖς τοῦ μὲν τρία τὸ τρίτον τοῦ δὲ τέσσαρα τὸ τέταρτον οὕτως καὶ τῶν νῦν ἐπονομασθέντων ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια κληθήσεται παρομοίως τοῖς ἀριθμοῖς laquocome le parti omonime dei numeri sono chia-mate per assonanza con i numeri di lsquotrersquo lsquolsaquounrsaquo terzorsquo di lsquoquattrorsquo lsquolsaquounrsaquo quartorsquo cosigrave le parti omonime dei numeri appena nominati saranno chiamate per assonanza con i numeriraquo (DOO I p 69-13 si noti lrsquoarticolo lsquocitazionalersquo al singolare in τοῦ τρία e τοῦ τέσσαρα) Il parallelo prosegue anche al livello dei segni che rappresentano queste specie come vedremo tra un attimo
83 Diofanto Arithmetica prefazione in DOO I p 620-21 un passaggio maltrattato in questa edizione occorre espungere il participio ἔχον senza introdurre segni ulteriori oppure eliminare un precedente ἐπί come fa un correttore del Matritensis f 58v
84 Unica parzialissima eccezione lrsquoaccenno di Teone menzionato nella nota 81 supra85 Al f 59r e per di piugrave nel margine per sanare un lungo saut du mecircme au mecircme La
collocazione in margine egrave il motivo per cui troviamo una notazione abbreviata nel resto del trattato il primo copista scioglie tutti i segni prendendoli per abbreviazioni mentre il secondo elimina sistematicamente il tratto aggiuntivo delle specie delle parti dellrsquounitagrave Drsquoaltronde egli scrive ad esempio ΔΥ invece di ΔΥ ed egrave quindi indotto a porre la barra al di sopra della stringa di lettere risultante (passim ma si veda ad esempio il f 72r)
Fabio Acerbi156
denza il compendio per la desinenza -ον accentata il copista interpreta il segno come unrsquoabbreviazione ndash e di una barra a sormontare lo Υ Potremmo forse interpretarlo come il segno di contrazione del grafema -στ- lrsquounico tassello mancante in unrsquoabbreviazione come ad esempio (δυναμοδυναμο)(στ)(ὸν) ma uno scolio di prima mano al f 58v rela-tivo alle specie degli interi inficia questrsquoipotesi esse sono dotate di slash di sospensione accento acuto in un caso del compendio canonico per la terminazione -ον hellip ma tutti gli Υ a esponente sono a loro volta sormontati da una barra
Meno legata al singolo manoscritto ma nondimeno non uniforme si presenta la pratica di notazione dei segni che rappresentano gli enti numerici sessagesimali86 da una parte sta lrsquoevidenza del testo dei Pro-legomena e delle sue tabelle apici ndash drsquoaltronde come abbiamo visto la notazione universalmente impiegata per i numerali ordinali e per le fra-zioni unitarie ndash dallrsquoaltra sta lrsquoevidenza del testo dellrsquoAlmagesto in tutti i manoscritti piugrave antichi e lo stesso si dica del commentario teonino a questrsquoopera o del suo lsquoGrande commentariorsquo alle Tavole facili e dei testi astronomici su papiro barre87 Sembra insomma che la nostra docu-
86 Sia le molteplicitagrave che le specie ahimeacute entrambe rappresentate da lettere dellrsquoalfabeto Come osservato allrsquoinizio della sezione 3 ci sono in effetti due tipi di lettere numerali in gioco se facciamo astrazione da apici o barre lsquo4 minuti secondirsquo si trova scritto δ β la prima lettera numerale denota la molteplicitagrave degli item di una certa specie la se-conda la specie nei Prolegomena entrambe sono accompagnate da un doppio apice il che rende inutile la presenza delle seconde Si noti che la descrizione della tabella non fa parola della notazione da usare per le lettere numerali che denotano la molteplicitagrave barre o apici e quanti apici hellip In questo caso fa interamente fede la tabella cioegrave la pratica grafica condivisa instauratasi non egrave chiaro quando
87 I manoscritti piugrave antichi dellrsquoAlmagesto sono menzionati nella nota 10 supra quelli dei due commentarii teonini sono il Laur Plut 2818 e il celeberrimo Vat gr 190 (sec IX in Euclide Elementi Data Teone lsquoGrande commentariorsquo) per la notazione dei pa-piri astronomici si veda Jones 1999 II passim La notazione non sembra lsquoinquinatarsquo dalla pratica dei copisti bizantini e pare dipendere soltanto dalla data di composizione Tro-viamo ad esempio barre sopra tutti i numerali di molteplicitagrave (interi o sessagesimali) nel frammento di un commentario alle Tavole facili contenente un calcolo relativo al 24 aprile 213 (Par gr 2841 sec XIII ex-XIV in oltre al frammento ai ff 32r l 11-34v l 23 contiene Arato Phaenomena ed Efestione Apotelesmatica edizione in Jones 1990) Nel commentario alle Tavole facili composto ca 610-617 ed attribuito a Stefano di Alessandria la situazione egrave la seguente (Jean Lempire per litteras per lrsquoedizione si veda Lempire 2014 ho controllato il Vat gr 304 ff 135r-171v sec XIV am contiene in aggiunta Teone in Almagestum I-II lsquoPiccolo commentariorsquo alle Tavole facili Diofanto Arithmetica e De polygo-nis numeris varia astronomica tabulae) barre sopra gli interi sporadicamente rimpiazzate da apici apici sopra le parti sessagesimali in numero uguale alla denominazione doppio () apice per le frazioni unitarie Sono impiegate barre sopra gli interi e apici sopra le parti sessagesimali nei manoscritti principali di tutti i trattati di introduzione allrsquoAlmagesto o comunque di argomento logistico redatti in epoca bizantina Giorgio Pachimere (1242-ca 1310) Quadrivium (autografo nel manoscritto Roma Biblioteca Angelica gr 38 [RGK III nr 115] si veda Tannery ndash Steacutephanou 1940 per lrsquoedizione) Teodoro Metochita (1270-
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 157
mentazione si faccia testimone di un cambio notazionale avvenuto nel periodo intercorrente fra Teone (sec IV pm) e la scuola alessandrina di Ammonio e dei suoi allievi (sec VI in) e probabilmente innescato da questrsquoultimo ambiente lrsquoaspetto paradossale egrave che nello stesso codice si rintraccino due notazioni differenti per gli enti numerici sessagesimali e lrsquouna (apici) sia adottata sistematicamente e coerentemente in uno scritto (i Prolegomena) che si presenta esattamente come unrsquointroduzione tecnica alla pratica numerico-algoritmica del trattato (lrsquoAlmagesto) in cui egrave adottata lrsquoaltra (barre che ritroviamo senza eccezioni anche negli scolii)
Torniamo ai Prolegomena la descrizione del segno da porre a fianco di ogni singolo quoziente parziale e denotante la sua specie numerica (minuti primi minuti secondi ecc) solleva tre problemi
Primo problema Ci vuole una barra o un apice su τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquola lettera A [hellip] che significa la specieraquo quando lo scriviamo nella tabella Tutta la nostra discussione precedente fa pro-pendere per lrsquoapice e si ricordi anche la forma verbale ἀνατείνουσαν che suggerisce qualcosa che si lsquoestende verso lrsquoaltorsquo (la mia traduzione egrave volutamente neutra) se fosse apposta una barra la cosa dovrebbe passare
1231332) Compendium astronomicum (copia lsquoautorizzatarsquo coeva nei Vat gr 182 e 181 da parte del copista che integrograve le parti mancanti del Par gr 2389 [ff 207-210 255-270 374-375] Bianconi 2005a pp 425-427 Peacuterez Martiacuten 2008 p 436 e n 177) Teodoro Meliteniota (morto lrsquo831393) Tribiblos astronomica (autografo nel Vat gr 792 si vedano Leurquin 1991 per unrsquoanalisi del manoscritto Leurquin 1990 per lrsquoedizione) una com-pilazione anonima (per cui ho consultato il Par gr 2396 ff 87r-92v limitatamente a questi fogli manu Costantino Trivoli [RGK II nr 318 ma ovviamente questo codice non vi egrave segnalato] terzo quarto del XV secolo il resto del codice annotato da Niceforo Gregora egrave di etagrave planudea e parzialmente [ff 33v-76v] un autografo di Planude stesso contiene Teone in Almagestum I II IV Mondrain 2002 il codice va completato ndash limitatamente a stralci dei libri VIII-X XII-XIII del commentario teonino la cui parte intermedia si egrave persa ndash con 26 carte [ff 123-147] inserite nel Vat gr 1087 anchrsquoesso contenente anno-tazioni di Gregora Rome 1927 per la figura del copista dei ff 77r-86r del Par gr 2396 e dei ff appena nominati del Vat gr 1087 un anonimo collaboratore di Gregora si veda in ultimo Bianconi 2006a pp 147-151) si veda anche il calcolo effettuato da Niceforo Gre-gora (12921295-13581361) dellrsquoeclisse di sole del 16 luglio 1330 (attestata unicamente ai ff 1r-8v della miscellanea astronomica Marc gr 325 databile ca 1324-1329 in parte vergata e ovunque fittamente annotata da Gregora stesso edizione del testo in Mogenet et al 1983 annotazioni di Gregora elencate in Bianconi 2005a p 413) Unrsquoeccezione apparente il lsquoPiccolo commentariorsquo di Teone alle Tavole facili le parti sessagesimali sono segnalate da apici (ad esempio nel Vat gr 175 vergato da Giovanni Catrario e completato nel 1321-1322 sulla figura di Catrario si vedano in ultimo Bianconi 2005b pp 141-156 e 2006b) lrsquoopera egrave antica ma la sua tradizione non rimonta oltre la fine del XIII secolo a parte un frammento nel Leiden BPG 78 ff 156r-161v (minuscola del IX-X secolo) e in effetti in questo manoscritto tutti i numerali di molteplicitagrave sono sormontati da barre Unrsquoeccezione effettiva egrave il De hypotesibus planetarum nel Vat gr 1594 barre sugli interi e apici sulle parti sessagesimali
Fabio Acerbi158
sotto silenzio e la presenza dellrsquoapice la rende inutile88 Si tratta della stessa convenzione diofantea e coincide ancora con la notazione per i numerali ordinali e per le frazioni unitarie che egrave corrente nei mano- scritti matematici greci per questo motivo non percheacute la descrizione sia particolarmente perspicua nessuno dei copisti della recensione an-tica ha incertezze apici Ma questi apici si rintracciano soltanto sulle indicazioni di specie non contemplate dalla descrizione che sono ante-poste ai resti parziali a fianco dei quozienti parziali i segni di specie sono invece trasformati in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordi-nali corrispondenti del tipo πρωτ tavv 5 e 7b-8 Il recensore bizantino taglia invece la testa al toro elimina dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali elimina la seconda menzione della laquolet-tera Araquo contestualmente allrsquoazzeramento dellrsquoespediente della linea a zig-zag (si veda il punto seguente) modifica la descrizione che contiene la prima menzione in quella dellrsquoapice associato direttamente ai nume-rali di molteplicitagrave riciclando addirittura lrsquoalpha per adibirlo a desi-gnare un numero cardinale (come sorprendersi) τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ laquoponendo al di sopra di essi [scil dei 50 minuti primi] 1 solo lsaquoaccentorsaquo acutoraquo La scelta del recensore egrave assennata che rechi una barra o un apice in una tabella un alpha denota un numero non un numero drsquoordine
Secondo problema da tenere ben distinto dal precedente Cosa ci vuole sul segno α per la lettera alpha menzionata nella frase τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquolettera A [hellip] che significa la specieraquo89 Unrsquooc-chiata allrsquoapparato critico rivela una bella incertezza nei manoscritti Z scrive sempre ᾱ e in un caso lo fa anche P MS optano sempre per α´ C per α P scrive nellrsquoaltro caso αο Per quanto solo la barra sia congrua con il senso della frase in quanto la lettera alpha egrave qui menzionata (si tratta di un oggetto che compare nella tabella) e non cambia niente se essa egrave accompagnata dal suo nome di genere στοιχεῖον ad un livello grafico lrsquoincertezza fra il segno ᾱ che denota laquola lettera αraquo e il segno α´ (o lrsquoabbreviazione αο) per una forma di πρῶτος egrave per piugrave versi giustificata
88 Detto in altri termini la barra egrave uno strumento grafico non matematico e quindi la sua presenza non va segnalata mentre un apice lo egrave e la sua presenza lo deve
89 Notare che in questa frase il primo α non vuole la barra (egrave menzionato allrsquointerno di una frase che impiega convenzioni moderne) il secondo sigrave (idem ma con convenzioni antiche) ndash e nella traduzione la scelta di denotarlo con A (senza virgolette) e non con lsquoArsquo (con virgolette) egrave del tutto arbitraria ndash si noti inoltre che le necessarie precisazioni laquosenzacon virgoletteraquo mostrano che le lingue moderne palesano difficoltagrave analoghe a quelle del greco antico per quanto riguarda i livelli denotativi in ambito metadiscorsivo per non usare le due parentetiche avrei dovuto scrivere rispettivamente lsquoArsquo e lsquolsquoArsquorsquo (doppie virgolette semplici)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 159
ᾱ coincide con il numerale 1 α egrave la prima lettera dellrsquoalfabeto ed inoltre α´ egrave esattamente quello che va scritto nella tabella Potremmo dirci che il sostantivo στοιχεῖον chiude la questione la sua presenza congiunta ad un ipotetico α´ renderebbe la descrizione ridondante o inappropriata90 Ma a parte il fatto che α egrave proprio τὸ πρῶτον στοιχεῖον il segno α´ cat-tura in fondo il cuore della descrizione di uno στοιχεῖον ἔχον lsaquoγραμμὴνrsaquo ἀνατείνουσαν
Terzo problema Lrsquoautore dei Prolegomena che si arresta allrsquoesem-pio dei minuti primi non dice quanti apici occorre mettere sulle lettere numerali che identificano gli ordini superiori al primo se uno soltanto come nel caso diofanteo e delle frazioni unitarie o in numero uguale alla loro denominazione (cioegrave pari al numero denotato dal numerale stesso su cui vanno posti) come effettivamente avviene nei mano-scritti dei Prolegomena La tabella egrave quindi sottodeterminata dalla sua descrizione anzi in un certo senso prende il sopravvento su di essa la pratica di marcare i numerali di molteplicitagrave con gli apici che compe-tono allrsquoordine cui appartengono viene trasferita ai segni per gli ordini stessi per supplire ad una descrizione carente di questi ultimi E la tabella egrave sottodeterminata dalla descrizione in quanto egrave la descrizione di una tabella reale ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις laquocome nello lsaquoschemarsaquo espostoraquo leggiamo a un certo punto del testo
3) La linea a zig-zag Non possiamo che applaudire a questo geniale espediente grafico lo troviamo messo in opera solo nel Marc gr 313 Per quanto lrsquoautore non faccia parola di ciograve nel corso della sua descrizione la linea spezzata egrave intesa dover lsquosaltarersquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue Il copista del codice marciano effettua correttamente due salti nella prima delle sue tabelle (tav 4) ma inserisce un lsquodentersquo in piugrave in quella che considera corretta (tav 5) La linea a zig-zag egrave incompatibile con la presenza di linee di giustificazione nella tabella che in effetti mancano nel Marc gr 313 ciograve induce gli errori di allineamento dei primi 5 quozienti parziali di cui egrave vittima il copista Probabilmente per questo motivo in nessuno degli apografi del Vat gr 1594 la linea a zig-zag figura nella tabella inquadrata come si conviene da una (doppia) cornice esterna e le cui colonne sono appunto separate da linee verticali (tav 7b Vat gr 184 f 17v e tav 8 Par gr 2390 f 9v cui egrave sostanzialmente identica la tabella del Marc gr 314 che si trova
90 Trascuro lrsquoabbreviazione αο = πρῶτος percheacute la desinenza non egrave quella richiesta neacute nella frase (egrave richiesto πρῶτον) neacute nella tabella (πρῶτα)
Fabio Acerbi160
al f 248r ndash ma la mancanza di linee orizzontali causa un gigantesco pa-sticcio nel codice vaticano) Alla recensione bizantina che dipende per il suo testo di base dal Vat gr 1594 e quindi non trova la linea a zig-zag nella tabella non resta che sopprimere la sua descrizione ndash ma proprio per questo motivo e finalmente diventa possibile tracciare un apparato completo di linee di giustificazione (tav 9 Laur Plut 89 sup 48 f 14v) Dato che la descrizione di Teone di questo procedimento di divi-sione non fa cenno allrsquoesistenza della linea a zig-zag viene da chiedersi se essa non costituisca un espediente escogitato dallrsquoautore dei Prolegomena per vivacizzare la procedura originale di Pappo
4) Discrepanze tra descrizione e tabella Il gioco delle minime va-rianti mostra che la divisione era stata eseguita (e trasmessa) corret-tamente tutti i valori numerici sono esatti La tabella nel Marc gr 313 presenta perograve alcune discrepanze con la propria descrizione Essa omette (ma non nella versione lsquoscorrettarsquo lrsquoomissione non si riscontra neanche nel Par gr 2390) il segno per laquorestoraquo di fronte ai resti par-ziali ma aggiunge lrsquoindicazione della loro specie Essa trasforma invece come abbiamo visto le indicazioni di specie che seguono i quozienti parziali in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordinali corri-spondenti La descrizione prevede di chiudere la tabella con il risultato καὶ συνάγων ἅπαντα τὰ ἐκ τῶν μερισθέντων μερῶν λεπτὰ σημειοῦται ὑπὸ πάντας οὕτως γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoe raccogliendo tutti i minuti che provengono dalle parti divise lsaquoPapporsaquo nota sotto tutto cosigrave Ris 0 59 8 17 13 12 31raquo ma sotto la tabella tutta la tradizione ci consegna qualcosa di piugrave articolato ὁ ζητούμενος καθ᾽ ὃν μερίζεται ὁ τξε ιδ´ μη´´ π(αρὰ) τὸν τξ γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoil lsaquonumerorsaquo cercato secondo cui 365 14 48 egrave diviso per 360 risulta 0 59 8 17 13 12 31raquo frase che del resto contiene due errori lrsquoinversione del dividendo e del divisore e la confusione tra segno convenzionale (iuxta descrizione) e abbreviazione (come nella frase) nel caso di γι Oltre ad eliminare la linea a zig-zag91 la recensione bizantina sopprime dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali e modifica come abbiamo visto al punto 2 le loro descrizioni in quelle di apici associati diretta-mente ai numerali di molteplicitagrave
91 Le due righe che nella recensione di base contengono solo i resti parziali minori di 160 del divisore ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue sono in parte completate con lrsquoindicazione abbreviata ἀνάλ(υσις) laquoanalisiraquo il termine greco per questa procedura di riduzione In un sussulto di ipercorrettismo matematico tali resti parziali ridotti non sono preceduti dal segno per laquorestoraquo come nel Par gr 2390 ma da quello per laquorisultatoraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 161
Gli esempi che abbiamo discusso mostrano come i problemi di notazione pesino e non poco sullrsquoespressione discorsiva di un algorit-mo matematico lrsquoente di riferimento per lsquoformularersquo il procedimento di divisione fu considerata la tabella cioegrave un oggetto la cui costitu-zione egrave legata piugrave ad una pratica grafica che a considerazioni logico- algoritmiche non la sua descrizione che in effetti finisce per determi-nare la tabella in maniera non univoca Di questa sottodeterminazione si fa testimone la traiettoria che abbiamo cercato di seguire nelle mani di copisti e revisori il procedimento di divisione si modifica a volte in aspetti secondari a volte in punti piugrave sostanziali ndash fino a rendere neces-saria una radicale revisione della sua descrizione per renderla conforme alla tabella ndash in ogni caso mai per ragioni squisitamente matematiche92
Abstract
The article presents and discusses in detail two passages from the anonymous Prolegomena to the Almagest a VIth century primer to the elementary procedures of calculation needed in Ptolemyrsquos Almagest In the two passages we may follow the complex interplay between mathematical notation the auctor who employed and described it the tachygrapher who transcribed it in vivo copyists who reproduced it correctors who modified it Along this path misgivings and errors arise in the transmission of abbreviations and paratextual units such as diagrams tables operational schemes
Fabio AcerbiCNRS UMR8560 Centre Alexandre Koyreacute
fabacerbigmailcom
92 Sono grato a Daniele Bianconi Lucio del Corso Jean Lempire per alcune preziose indicazioni
AOO = Archimedis opera omnia cum commentariis Eutocii ed J L Heiberg I-III Lipsiae 1910-1915
DOO = Diophanti Alexandrini opera omnia cum Graecis commentariis ed P Tannery I-II Lipsiae 1893-1895
GC = Le laquoGrand Commentaireraquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Mogenet ndash A Tihon I-III Cittagrave del Vaticano 1985-1999
iA = Commentaires de Pappus et de Theacuteon drsquoAlexandrie sur lrsquoAlmageste ed A Rome I-III con paginazione continua Cittagrave del Vaticano 1931-1943
HOO = Heronis Alexandrini opera quae supersunt omnia ed G Schmidt ndash L Nix ndash W Schmidt ndash H Schoene ndash J L Heiberg I-V Lipsiae 1899-1914
PC = Le ldquoPetit Commentairerdquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed A Tihon Cittagrave del Vaticano 1978
POO = Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia ed J L Heiberg I-II in 3 parti Lipsiae 1898-1907
RGK = Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600 I Handschriften aus Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln II Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs und Nachtraumlge zu den Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln III Handschriften aus Bibliotheken Roms mit dem Vatikan A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg unter Mitarbeit von D Harlfinger und P Eleuteri B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln Wien 1981-1997 (Oumlsterreichische Akademie der Wissenschaften Veroumlffentlichungen der Kommission fuumlr Byzantinistik III1-3 A-C)
Sigla
Acerbi 2010 = F Acerbi Il silenzio delle sirene La matematica greca antica Roma 2010
Acerbi 2012 = F Acerbi I codici stilistici della matematica greca dimostrazioni procedure algoritmi laquoQUCCraquo 1012 (2012) pp 167-214
Acerbi et al 2010 = F Acerbi ndash N Vinel ndash B Vitrac Les Proleacutegomegravenes agrave lrsquoAlmageste Une eacutedition agrave partir des manuscrits les plus anciens Introduction geacuteneacuterale ndash Parties I-III laquoSCIAMVSraquo 11 (2010) pp 53-210
Agati 1992 = M L Agati La minuscola laquoBouleteacuteeraquo Cittagrave del Vaticano 1992
Belger 1881 = C Belger Ein neues Fragmentum mathematicum Bobiense laquoHermesraquo 16 (1881) pp 261-284
Bianconi 2005a = D Bianconi La biblioteca di Cora tra Massimo Planude e Niceforo Gregora Una questione di mani laquoSampTraquo 3 (2005) pp 391-438
Bianconi 2005b = D Bianconi Tessalonica nellrsquoetagrave dei Paleologi Le pratiche intellettuali nel riflesso della cultura scritta Paris 2005
Bianconi 2006a = D Bianconi Le pietre e il ponte ovvero identificazioni di mani e storia della cultura laquoBizantinisticaraquo 8 (2006) pp 135-181
Bianconi 2006b = D Bianconi Qualcosa di nuovo su Giovanni Catrario laquoMEGraquo 6 (2006) pp 69-91
Cavallo 1977 = G Cavallo Funzione e strutture della maiuscola greca tra i secoli VIII-XI in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Colloque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 95-137
Cereteli 1904 = G F Cereteli De compendiis scripturae codicum Graecorum praecipue Petropolitanorum et Mosquensium anni nota instructorum Sankt-Petersburg 1904
De Gregorio 2000 = G De Gregorio Materiali vecchi e nuovi per uno studio della minu-scola greca fra VII e IX secolo in G Prato (a cura di) I manoscritti greci tra riflessione e dibattito Atti del V Colloquio Internazionale di Paleografia Greca Cremona 4-10 ottobre 1998 Firenze 2000 pp 83-151
Follieri 1977 = E Follieri La minuscola libraria dei secoli IX e X in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Col-loque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 139-165
Fonkič 2005 = B Fonkič Venecianskaia rukopisrsquo laquoAlrsquomagestaraquo Ptolemeja (Marc gr 313690) o datirovke i proischoždenii kodeksa laquoVDIraquo s III 254 (2005) pp 162-167
Fowler 1999 = D H Fowler The Mathematics of Platorsquos Academy A New Reconstruction Second Edition Oxford 1999
Bibliografia
Fabio Acerbi164
Gerstinger ndash Vogel 1932 = H Gerstinger ndash K Vogel Eine stereometrische Aufgaben-sammlung im Papyrus Graecus [sic] Vindobonensis 19996 laquoMitteilungen aus der Papy-russammlung der Nationalbibliothek in Wienraquo Neue Serie Folge 1 Griechische literarische Papyri 1 Wien 1932 pp 11-76
Heiberg 1927 = Mathematici Graeci Minores ed J L Heiberg Kjoslashbenhavn 1927
Hultsch 1876-1878 = Pappi Alexandrini Collectionis quae supersunt ed F Hultsch I-III Berlin 1876-1878
Janz 2003 = T Janz The Scribes and the Date of the Vat gr 1291 in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae X Cittagrave del Vaticano 2003 pp 159-180
Jones 1990 = Ptolemyrsquos First Commentator ed A Jones Philadelphia 1990
Jones 1999 = Astronomical Papyri from Oxyrhynchus ed A Jones I-II Philadelphia 1999
Jones 2005 = A Jones Ptolemyrsquos Canobic Inscription and Heliodorusrsquo Observation Reports laquoSCIAMVSraquo 6 (2005) pp 53-97
Lempire 2014 = Steacutephanos drsquoAlexandrie Le commentaire aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Lempire Louvain 2014
Leurquin 1990 = Theacuteodore Meacuteliteacuteniote Tribiblos astronomique Livre I ed R Leurquin Amsterdam 1990
Leurquin 1991 = R Leurquin Un manuscrit autographe de la Tribiblos Astronomique de Theacuteodore Meacuteliteacuteniote le Vaticanus graecus 792 laquoScriptoriumraquo 45 (1991) pp 145-162
Maas 1927 = P Maas Griechische Palaeographie in A Gercke ndash E Norden (hrsg von) Einleitung in die Altertumswissenschaft I9 Leipzig 1927 pp 69-80
Martinelli Tempesta 2010 = S Martinelli Tempesta Il codice Milano Biblioteca Am-brosiana B 75 sup (gr 104) e lrsquoevoluzione della scrittura di Giovanni Scutariota in A B Garciacutea ndash I Peacuterez Martiacuten (ed by) The Legacy of Bernard de Montfaucon Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting Proceedings of the Seventh Inter-national Colloquium of Greek Palaeography Madrid-Salamanca 15-20 September 2008 Turnhout 2010 pp 171-186
Mazzucchi 1994 = C M Mazzucchi Leggere i classici durante la catastrofe (Costantino-poli maggio-agosto 1203) le note marginali al Diodoro Siculo Vaticano gr 130 Parte prima stratigrafia laquoAevumraquo 68 (1994) pp 164-218
Mioni 1976 = E Mioni Bessarione scriba e alcuni suoi collaboratori in Miscellanea marcia-na di studi bessarionei Padova 1976 pp 263-323
Mioni 1985 = Codices graeci manuscripti Bibliothecae Divi Marci Venetiarum II Thesaurus Antiquus Codices 300-625 recensuit E Mioni Roma 1985
Mogenet 1962 = J Mogenet Une scholie ineacutedite du Vat gr 1594 sur les rapports entre lrsquoastronomie arabe et Byzance laquoOsirisraquo 14 (1962) pp 198-221
Mogenet et al 1983 = Niceacutephore Greacutegoras Calcul de lrsquoeacuteclipse de soleil du 16 juillet 1330 ed J Mogenet ndash A Tihon ndash R Royez ndash A Berg Amsterdam 1983
Mondrain 2002 = B Mondrain Maxime Planude Niceacutephore Greacutegoras et Ptoleacutemeacutee laquoPa-laeoslavicaraquo 10 (2002) pp 312-322
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 165
Mondrain 2004 = B Mondrain Lrsquoancien empereur Jean VI Cantacuzegravene et ses copistes in A Rigo (a cura di) Gregorio Palamas e oltre Studi e documenti sulle controversie teologiche del XIV secolo bizantino Firenze 2004 pp 249-296
Mondrain 2007 = B Mondrain Les eacutecritures dans les manuscrits byzantins du XIV e siegravecle Quelques probleacutematiques laquoRSBNraquo n s 44 (2007) pp 157-196
Peacuterez Martiacuten 2006 = I Peacuterez Martiacuten Maxime Planude et le Diophantus Matritensis (Madrid Biblioteca Nacional ms 4678) un paradigme de la reacutecupeacuteration des textes anciens dans la ldquorenaissance paleacuteologuerdquo laquoByzantionraquo 76 (2006) pp 433-462
Peacuterez Martiacuten 2008 = I Peacuterez Martiacuten El lsquoestilo Hodegosrsquo y su proyeccioacuten en las escrituras constantinopolitanas laquoSampTraquo 6 (2008) pp 389-458
Perria 1991 = L Perria Scrittura e ornamentazione nei codici della laquocollezione filosoficaraquo laquoRSBNraquo n s 28 (1991) pp 45-111
Rollo 2012 = A Rollo LrsquoArchimede di Giorgio Valla in V Fera ndash D Gionta ndash A Rollo (a cura di) Archimede e le sue fortune Atti del Convegno di Siracusa-Messina 24-26 giugno 2008 Messina 2012 pp 99-147
Rome 1927 = A Rome Membra disjecta laquoRBenraquo 39 (1927) pp 187-188
Rome 1938 = A Rome Un manuscrit de la bibliothegraveque de Boniface VIII agrave la Meacutediceacuteenne de Florence laquoACraquo 7 (1938) pp 261-268
Ronconi 2013 = F Ronconi La collection philosophique un fantocircme historique laquoScripto-riumraquo 67 (2013) pp 119-140
Tannery ndash Steacutephanou 1940 = Quadrivium de Georges Pachymegravere ed P Tannery ndash E Steacutephanou Cittagrave del Vaticano 1940
Tihon 2011 = Πτολεμαίου Πρόχειροι Κανόνες Les Tables faciles de Ptoleacutemeacutee vol Ia Tables A1-A2 ed A Tihon Leuven 2011
Traube 1907 = L Traube Nomina Sacra Versuch einer Geschichte der christlichen Kuumlrzung Muumlnchen 1907
Vogel 1936 = K Vogel Beitraumlge zur griechischen Logistik laquoSBAWraquo Mathematisch-natur-wissenschaftliche Abteilung Jahrgang 1936 pp 357-472
Wouters 1979 = A Wouters The Grammatical Papyri from Graeco-Roman Egypt Contri-butions to the Study of the lsquoArs Grammaticarsquo in Antiquity Brussel 1979
F ACERBI Tav 1
b Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 65r
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 284 f 160r
F ACERBITav 2
b Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 13r
a Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 19v
F ACERBI Tav 3
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 136v
F ACERBITav 4
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17r
F ACERBI Tav 5
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17v
F ACERBITav 6
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 7v
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 127
mise en rouleau dellrsquooriginale era differente come Tolomeo stesso spiega nella sua descrizione le 360 righe erano ripartite διὰ τὸ σύμμετρον laquoper motivi di simmetriaraquo9 in 8 tavole affiancate di 45 righe lrsquouna che nel rotolo figuravano probabilmente con una soluzione di continuitagrave minore di un intercolumnio standard in guisa di macrocolonna I ma-noscritti medievali rispettano questa disposizione ma devono ripartire le 8 tavole su 4 pagine10 Date le dimensioni della pagina a stampa cui egrave confinato Heiberg non puograve farlo e sdoppia ogni tavola poicheacute 45 egrave dispari e a causa della presenza dellrsquoapparato critico le sue tavole per-dono tutta la simmetria iniziale Nel caso delle tavole dunque rotolo e codice comportano mises en texte differenti per una volta egrave il rotolo e non il codice il supporto ideale per questo tipo di testi
Altro esempio tavole del moto medio del sole nellrsquoAlmagesto De-notando rispettivamente con a g o m e c i valori del tempo di ritorno annuale in giorni e loro parti e dei moti (in gradi per appropriate unitagrave di tempo) giornaliero orario mensile per mese di 30 giorni annuale per lrsquoanno egiziano di 365 giorni e infine su un ciclo di 18 anni la determinazione dei restanti a partire dal valore di a ammonta alla se-guente catena di operazioni a rarr 360a = g rarr g24 = o 30g = m 365g = e rarr 18e = c Ognuno di questi valori forma la base della costruzione per addizioni successive11 delle tavole12 che denoto con le stesse lettere
στίχους με διὰ τὸ σύμμετρον ὧν τὰ μὲν πρῶτα μέρη περιέξει τὰς πηλικότητας τῶν περιφερειῶν καθ᾽ ἡμιμοίριον παρηυξημένας τὰ δὲ δεύτερα τὰς τῶν παρακειμένων ταῖς περιφερείαις εὐθειῶν πηλικότητας ὡς τῆς διαμέτρου τῶν ρκ τμημάτων ὑποκειμένης τὰ δὲ τρίτα τὸ λʹ μέρος τῆς καθ᾽ ἕκαστον ἡμιμοίριον τῶν εὐθειῶν παραυξήσεως ἵνα ἔχοντες καὶ τὴν τοῦ ἑνὸς ἑξηκοστοῦ μέσην ἐπιβολὴν ἀδιαφοροῦσαν πρὸς αἴσθησιν τῆς ἀκριβοῦς καὶ τῶν μεταξὺ τοῦ ἡμίσους μερῶν ἐξ ἑτοίμου τὰς ἐπιβαλλούσας πηλικότητας ἐπιλογίζεσθαι δυνώμεθα laquodisporrograve le tavole su 45 righe per motivi di simmetria la prima parte di lsaquoognuna dirsaquo esse conterragrave i valori degli archi incre-mentati di mezzo grado alla volta la seconda i valori delle rette corrispondenti agli archi (il diametro essendo posto di 120 gradi) la terza la 30ordm parte dellrsquoincremento delle rette per ciascun lsaquointervallo dirsaquo mezzo grado di modo che sia possibile calcolare facilmente avendo in questa maniera a disposizione il valore intermedio lsaquodellrsquoincrementorsaquo corrispondente ad un singolo sessantesimo (esso egrave differente da quello esatto in maniera impercettibile) anche i valori delle frazioni intermedie tra i lsaquovalori limitati airsaquo mezzi gradiraquo Alm I 11 ivi pp 48-63
9 Non dobbiamo sopravvalutare la componente estetica implicita nel nostro termine laquosimmetriaraquo Tolomeo si limita a far riferimento alla laquocongruenzaraquo di 45 con 360 in quanto suo divisore esatto
10 Si vedano Par gr 2389 (sec IX in Tolomeo Almagestum) ff 17r-18v Vat gr 1594 (Prolegomena ad Almagestum Tolomeo Almagestum et opera minora) ff 20v-22r Marc gr 313 (Prolegomena ad Almagestum Tolomeo Almagestum) ff 46r-47v Vat gr 180 (sec X Tolomeo Almagestum) ff 18v-20r per la datazione del secondo e del terzo codice si veda la sezione 4
11 Tolomeo accorda alla menzione di questrsquooperazione di addizione una mezza riga proprio alla fine della sua esposizione κατὰ τὰς οἰκείας ἑκάστων ἐπισυναγωγάς laquoper opportune addizioni successive dei lsaquovalorirsaquo di ciascunoraquo Alm III 1 in POO I 1 p 20924-25
12 Alm III 1 ivi pp 2091-16 e 20922-25 descrizione ivi p 20917-22
Fabio Acerbi128
maiuscole ovviamente la tavola A egrave assente Per esempio la tavola G ha come prima riga il valore g (colonna di destra) accompagnato dalla cifra α laquo1raquo (colonna di sinistra) le altre righe hanno a sinistra i numerali da 2 a 30 e a destra i multipli corrispondenti di g il valore registrato a destra nellrsquoultima riga deve evidentemente coincidere con m In omaggio al principio delle 45 righe13 troviamo dunque una prima tavola C su 45 righe (corrispondente a un periodo di 18times45 = 810 anni avente come epoca il primo anno di regno di Nabonassar) una seconda su 42 righe che combina le 18 righe di E seguite dalle 24 di O una terza ancora su 42 righe che contiene le 12 di M seguite dalle 30 di G14 ndash nella seconda
13 διὰ τὸ φανησόμενον σύμμετρον τῆς κανονογραφίας laquoper una presentazione simme-trica del tracciato delle tavoleraquo ivi p 20914-15 allusione analoga in Alm I 10 ivi p 472-3 lrsquoabbiamo letta sottolineata nella nota 8 supra
14 Per la mise en page di queste tre tavole nei manoscritti medievali si vedano Par gr 2389 ff 69v-70r Vat gr 1594 f 63r-v (in questi due codici scritti su due colonne le tavole occupano unrsquointera pagina piugrave la prima colonna della successiva) Marc gr 313 f 98r-v (questo codice vergato a tutta pagina adotta momentaneamente una disposizione su due colonne al f 98v la prima contiene la tavola la seconda lrsquoinizio del capitolo successivo) Vat gr 180 ff 60v-61v Nelle Tavole facili dello stesso Tolomeo che passano a cicli di 25 anni e allrsquoepoca di Filippo le tavole appena descritte sono presentate con precisione ridotta rispetto a quelle dellrsquoAlmagesto nellrsquoordine C (periodo di 25times59 = 1475 anni) E (ciclo di 25 anni) M (direttamente con i nomi dei mesi del calendario egiziano mentre lrsquoAlmagesto ripartisce il parametro in multipli di 30 giorni fino a 360) G O Ogni tavola egrave suddivisa in unitagrave colonnari di non piugrave di 30 righe + titolazione La lsquotavola delle cordersquo non egrave inclusa nelle Tavole facili per le tavole del moto medio del sole e della luna nei manoscritti medievali di questrsquoopera si vedano Leiden Bibliothek der Rijksuniversiteit BPG 78 ff 91r-93v Laur Plut 2826 ff 71r-73v Vat gr 1291 ff 38r-40v Marc gr 331 ff 45r-47v ndash le parti in maiuscola di tutti questi codici contengono unicamente le Tavole facili e si datano sulla base dellrsquoultimo imperatore di cui il copista principale abbia riportato gli anni di regno nel cosid-detto canon regius nellrsquoordine Leiden BPG 78 copiato sotto il regno di Leone V 813-820 Vat gr 1291 copiato poco dopo il regno di Niceforo I 802-811 (Janz 2003) Laur Plut 2826 copiato sotto il regno di Leone VI 886-912 Marc gr 331 privo del canon regius e forse copiato anchrsquoesso sotto il regno di Leone VI si veda anche Tihon 2011 pp 19-41 per una sintesi e per ulteriori indicazioni bibliografiche Ovviamente anche le Tavole facili erano state concepite per il rotolo Tra lrsquoaltro Tolomeo sembra trascrivere nella stessa tavola i moti medi di Sole Luna Cor Leonis (la stella Regolo) e dei cinque pianeti cosa impossibile a farsi su una sola pagina di codex si legga la descrizione che ne dagrave nella parte iniziale del lsquomanuale di istruzionirsquo alle Tavole facili stesse in POO II p 1607-19 Nei manoscritti medievali questa tavola egrave smembrata poco dopo lrsquoinizio della sequenza di tavole si trovano i moti medi di Sole e Luna piugrave avanti quelli di Regolo e dei cinque pianeti Piugrave in generale il passaggio al codice comportograve una riorganizzazione delle lsquotavole facilirsquo dal piano originario in cui tutte quelle di longitudine erano molto verosimilmente raggruppate insieme e precedevano quelle di latitudine ad un ordinamento per corpi celesti (Tihon 2011 pp 12-14) Le Tavole facili furono copiate molto presto su codice i lsquopapirirsquo di questrsquoopera sono quasi unicamente su codex di pergamena (Jones 1999 I pp 102-108 e 160-168 edizione dei POxy LXI 4167-4173a contenenti frammenti delle Tavole facili ivi II pp 118-161 solo il primo di essi proviene sicuramente da un rotolo) Giagrave in pieno IV secolo Teone di Alessandria nel suo lsquoPiccolo commentariorsquo alle Tavole facili afferma che alcune di esse possono estendersi su πλειόνων πτυχίων laquopiugrave pagineraquo (PC p 2016 allinterno dellunica definizione di lsquotavolarsquo rintracciabile nel corpus antico) cosigrave le leggiamo attualmente nei manoscritti
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 129
e nella terza tavola il numero di righe egrave piugrave basso percheacute occorre pre-vedere uno spazio per il titolo addizionale Per mantenerne il formato tripartito Heiberg egrave costretto a stampare le tavole ruotate di 90ordm
Che le tavole siano dei testi egrave confermato da due fatti aggiuntivi e strettamente connessi15 Primo il lsquomanuale di istruzionirsquo alle Tavole facili che Tolomeo stesso redasse fu scritto ed ha circolato come opera a parte Secondo dalla descrizione delle tavole dettagliata ma priva di costruzione contenuta nello stesso lsquomanualersquo egrave impossibile ricavarne il contenuto numerico e la maniera drsquoimpiego16 a illustrare questrsquoultima provvederagrave una ricchissima tradizione di commentari di cui leggiamo ancora quelli di Teone il lsquoPiccolo Commentariorsquo spiega come usarle per scopi specifici il lsquoGrande Commentariorsquo come dedurle dallrsquoAlmagesto17 Le Tavole facili sono insomma unrsquoopera il cui testo egrave interamente strut-turato in formato tabulare
3) Tabelle operazionali Una lsquotabella operazionalersquo egrave una disposi-zione ordinata di lettere numerali e altri segni grafici che rappresenta lrsquoalgoritmo di unrsquooperazione aritmetica Ci troviamo in realtagrave di fronte a due modi di eseguire lrsquooperazione la tabella intende in qualche mi-sura riprodurre la dinamica operazionale dellrsquoalgoritmo questrsquoultimo si risolve a sua volta in una descrizione della tabella che senza tale de-scrizione risulterebbe incomprensibile e quindi non adattabile ad una differente operazione una tabella operazionale ha in questo caso una funzione paratestuale Si presuppone perograve che il discente apprenda a ri-produrre lrsquooperazione direttamente nel formato tabellare non in quello algoritmico In questo secondo caso una tabella operazionale assume una funzione testuale piena18 Lo statuto (para)testuale delle tabelle operazionali egrave pertanto oscillante nei commentari teonini allrsquoAlmagesto e soprattutto nei Prolegomena ad Almagestum di cui andremo ad occu-parci esse sono descritte in dettaglio e si configurano pertanto come genuini paratesti in Eutocio in Circ esse sono semplicemente eseguite e quindi assumono un ruolo testuale Nei manoscritti medievali la col-locazione di una tabella operazionale originaria egrave variabile e dipende dalle sue dimensioni e dalla capacitagrave del copista di identificarla come
15 Per un argomento ulteriore si veda la sezione 4 punto b16 POO II pp 159-18517 Nessuno dei due titoli ha fondamento nella trasmissione manoscritta la seconda
opera era detta realizzare una συμφωνία tra lrsquoAlmagesto e le Tavole facili Entrambi i com-mentari sono stati editi criticamente PC GC I-III
18 Resta il fatto che la quasi totalitagrave delle tabelle operazionali che rintracciamo nei manoscritti egrave relegata nei margini dellrsquoattivitagrave di annotazione degli scoliasti
Fabio Acerbi130
tale di solito le troviamo nei margini ma possono occupare lrsquointero specchio di scrittura e ciograve indipendentemente dalla determinazione del loro statuto paratestuale sulla base del criterio della presenzaassenza di una descrizione
Lo statuto meno elevato dei genuini paratesti (diagrammi e tabelle) rispetto ai testi (catene algoritmico-argomentative e tavole) indusse un atteggiamento differenziato in copisti ed editori attenti a rispettare lrsquointegritagrave dei secondi ma non dei primi ciograve che conta sono le informa-zioni veicolate dalle strutture discorsive e dalle porzioni alfanumeriche di diagrammi tavole e tabelle il resto egrave ritenuto adattabile alle esigenze dellrsquoedizione moderna19 o semplicemente ignorato nel corso del pro-cesso di copia in questa maniera si perdono perograve informazioni e strut-tura Come vedremo puograve avvenire che una parte della descrizione di unrsquooperazione resti senza relato nella resa grafica tabellare lrsquooperazione eseguita in forma algoritmica non corrisponde piugrave a quella eseguita in forma di tabella
3 Testi logistici e disposizione tabellare delle operazioni
Nessun testo matematico primario di etagrave ellenistica o imperiale contiene operazioni aritmetiche eseguite con una sola eccezione la de-scrizione che non ammette una rappresentazione tabellare del procedi-mento di estrazione approssimata di radice quadrata in Erone Metr I 8 Drsquoaltro canto abbiamo giagrave osservato che lrsquoAlmagesto di Tolomeo for-nisce il risultato di migliaia di operazioni ma nessuna di esse egrave eseguita Attestazioni di questi procedimenti sono pertanto legate ad iniziative editoriali di secondo livello come i commentari alla loro prima occor-renza oppure in casi paradigmatici gli algoritmi di calcolo omessi nel testo primario vi sono resi espliciti Di fatto e con una sola eccezione la nostra documentazione consiste in commentari allrsquoAlmagesto quello di Teone e i Prolegomena ad Almagestum
19 Abbiamo giagrave visto alcuni esempi di modifiche del formato delle tavole Quanto ai diagrammi quelli tracciati nelle edizioni moderne rappresentano il caso piugrave generale pos-sibile Le figure che troviamo nei manoscritti greci hanno invece la caratteristica opposta illustrano spesso casi particolari e sono metricamente scorrette Sono in effetti tracciati triangoli rettangoli isosceli cerchi uguali rette perpendicolari dove tutto ciograve non egrave richiesto dallrsquoenunciato e inoltre rettangoli invece di parallelogrammi segmenti uguali quando sia-no disuguali addirittura linee rette al posto di curve (in Archimede Meth 14 un arco di parabola egrave rappresentato da un angolo rettilineo) e in generale figure con proprietagrave di simmetria non richieste
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 131
LrsquoAlmagesto e con esso tutta la tradizione astronomica adotta il sistema sessagesimale per esprimere la parte non intera di un nu-mero che siano valori angolari o lineari non fa differenza20 come noi scriviamo 36524 e intendiamo 365 + 2 decimi + 4 centesimi (cioegrave 4102) cosigrave nel sistema sessagesimale 365 14 48 significa21 365 + 14 sessantesimi + 48 tremilaseicentesimi (cioegrave 48602) ovverosia nel lessico antico e nostro 365 14 πρῶτα λεπτά laquominuti primiraquo 48 δεύτερα λεπτά laquominuti secondiraquo dove laquoprimoraquo e laquosecondoraquo sono le laquodenominazioniraquo degli ordini (sono cioegrave numeri ordinali) 14 e 48 i lsquonumerali di molteplicitagraversquo relativi ai due ordini numerale di mol-teplicitagrave e relativa denominazione costituiscono insieme una lsquoparte sessagesimalersquo di un numero Drsquoaltronde per gli antichi come per noi lrsquoespressione di una parte non intera (ovvero di una frazione)
20 Trascuro il fatto ai nostri fini irrilevante che essendo i numerali greci lettere alfabetiche la notazione che ne risulta per i numeri interi non egrave posizionale nonostante le cifre scagravelino di un posto ad ogni potenza di dieci il segno μ per 4 (decine) non egrave identico al segno δ per 4 (unitagrave) Drsquoaltra parte una volta adottata la notazione decimale per i numerali di molteplicitagrave la notazione complessiva per la parte non intera espressa nel sistema sessa-gesimale non egrave posizionale neanche introducendo un segno di lsquoposto vuotorsquo una cui parte egrave nel caso greco analoga in forma al nostro 0 (su questo segno si veda ancora la sezione 4 punto c) occorre avvalersi di accorgimenti ulteriori quali lrsquointroduzione di spaziature fra le differenti parti sessagesimali (come viene fatto nei manoscritti greci ed in questrsquoarticolo) o di segni tipografici (come suggerito da Otto Neugebauer che avrebbe scritto 3651448 il numerale che leggeremo tra un attimo nel testo) Il problema egrave che altrimenti lrsquoordine associato ad un numerale di molteplicitagrave di una parte sessagesimale puograve non risultare uni-vocamente determinato dalla sua posizione Esempio scrivendo 0129 per un numero non intero nel sistema sessagesimale il numerale di molteplicitagrave 129 potrebbe rappresentare 1 minuto primo e 29 secondi oppure 12 minuti primi e 9 secondi ecc e la stessa difficoltagrave si presenta nella notazione greca (per la nozione di lsquonumerale di molteplicitagraversquo si veda infra nel testo) Il problema scomparirebbe se adottassimo singoli segni differenti per tutti i nu-merali da 1 a 59 ndash ma neacute noi neacute i greci siamo stati disposti a introdurre una complicazione siffatta Si ricordi infine che al di fuori dei contesti astronomici il sistema di numerazione greco egrave decimale
21 Scriverograve i numerali in cifre arabe sempre in questo modo parte intera seguita dalle parti sessagesimali (minuti primi secondi ecc) con ogni ordine separato da uno spazio bianco Se la parte intera egrave assente il numerale inzia con uno 0 Nella trascrizione dei numerali in greco ogni numerale di molteplicitagrave sessagesimale o frazione unitaria saragrave identificato come nei manoscritti piugrave antichi dei Prolegomena da un opportuno numero di apici (uno per ogni unitagrave dellrsquoordine avendo le frazioni unitarie un solo apice come vedremo nellrsquoAlmagesto contenuto negli stessi codici troviamo barre non apici con questa funzione) mentre la parte intera saragrave priva della barra che la sormonta invariabilmente nei manoscritti In questo modo 365 14 48 egrave la conversione in cifre arabe di τξε ιδ´ μη´´ La pratica dei manoscritti medievali egrave di collocare gli apici (quando presenti) sopra le lettere numerali per ragioni tipografiche li porrograve di seacuteguito al gruppo di lettere cui si riferiscono Si noti che nella notazione greca il segno ιδ´ per 1460 in sessagesimale egrave identico a quello per 114 in decimale Nel caso delle frazioni unitarie la presenza dellrsquo(unico) apice egrave la traduzione semiotica della trasformazione che a livello grammaticale egrave effettuata con il pas-saggio dal cardinale allrsquoordinale (ad esempio da τὰ τρία laquotreraquo a τὸ τρίτον laquoun terzoraquo) si veda anche la sezione 4 punto 1 e note 82 e 86 ivi incluse
Fabio Acerbi132
richiede sempre lrsquointroduzione di due numerali il lsquonumeratorersquo e il lsquodenominatorersquo
Il motivo della scelta del sistema sessagesimale che fu mutuato dallrsquoastronomia matematica babilonese egrave presto detto lrsquoelevato numero di divisori di 60 e cioegrave 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 Poicheacute i divi-sori di 10 sono un sottinsieme di quelli di 60 molti piugrave numeri hanno una rappresentazione finita nel sistema sessagesimale che in quello deci-male Calcolare in sessagesimale lungi dal creare difficoltagrave offre quindi un vantaggio cruciale22 che risulta piugrave facilmente comprensibile sulla base dellrsquoesempio seguente La lunghezza dellrsquoanno solare egrave stabilita da Tolomeo in 365 giorni + 14 ndash 1300 di giorno Per calcolare il moto giornaliero del sole si rende necessario dividere 360 per questo numero Noi avremmo due opzioni se non potessimo usare la calcolatrice ri-durre il divisore ad una singola frazione tramite passaggio al denomi-natore comune invertire questa frazione e moltiplicarla per 360 sem-plificare gli eventuali fattori comuni e finalmente eseguire la divisione a piugrave cifre tra numeri interi (nel nostro caso 5400054787) oppure scrivere il divisore come numero decimale periodico (365246666 hellip) e poi eseguire la divisione Nel sistema sessagesimale egrave tutto molto piugrave semplice 365 + 14 ndash 1300 ha una rappresentazione finita cioegrave 365 14 48 come eseguire la divisione lo vedremo tra un attimo
Passiamo dunque in rassegna il contenuto del lsquomanuale di logisticarsquo incluso nei Prolegomena ad Almagestum riportando in nota per ogni item anche esposizioni parallele in altri commentatori23
a) Costruzione del sistema sessagesimale24
22 E uno svantaggio se le molteplicitagrave dei singoli ordini vengono espresse in no-tazione decimale (come facciamo noi e facevano i greci) il numero di cifre necessario per raggiungere una precisione assegnata egrave maggiore nel sistema sessagesimale in quanto per esprimere i numerali da 10 a 59 occorrono due cifre mentre per quelli da 1 a 9 (o da α a θ e le decine da ι a ν nel caso greco) ne basta una e ciograve indipendentemente dal fatto che la notazione sia posizionale oppure no La differenza si fa perograve sentire solo a partire dal quinto ordine sessagesimale
23 Trascuro la parte finale del lsquomanualersquo dove sono esposte le regole di interpolazione (cui era legata la lsquoterza colonnarsquo della tavola delle corde tolemaica) e il procedimento di lsquosottrazionersquo di rapporti cioegrave la divisione di un rapporto per un altro
24 Per a-b cf Teone in Alm I 10 in iA pp 44919-45814 PC pp 2007-2014 GC I pp 10910-11124 e le definizioni e regole diofantee di manipolazione delle varie specie numeriche in Arithmetica prefazione in DOO I pp 214-1218 Le porzioni a-b sono giagrave state pubblicate da Paul Tannery in DOO II pp 318-1517 sulla base del Par gr 453 apografo ad opera di Giovanni Santamaura di un Vat gr 1594 giagrave mutilo (RGK II nr 238 ma lrsquoautore trascritto vi egrave indicato come lsquoPtolemaiosrsquo) Evidentemente il committente non fu soddisfatto della prima trascrizione (ff 67-76) che crivella di tratti rossi a segnalarne gli errori di copia Ne fu dunque eseguita una seconda (ff 78-86) cui Santamaura antepose
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 133
b) Regole di moltiplicazione e divisione degli ordini sessagesimali defini-zione generale di moltiplicazione moltiplicazione di ordini come somma delle loro laquodenominazioniraquo Definizione generale di divisione divisione di ordini uguali e di un ordine per quello che lo precede immediata-mente divisione di ordini come sottrazione delle loro laquodenominazioniraquo divisione per 60 come divisione per 1 accompagnata dallo slittamento di un posto dellrsquoordine
c) Problemi che sorgono nella divisione di una parte sessagesimale per una di quelle che seguono divisione breve per riduzione allo stesso ordine (metodo laquoper analisiraquo) due algoritmi differenti il secondo con riduzione dei fattori comuni attribuito a Siriano
d) laquoAltroraquo metodo di divisione breve in realtagrave divisione tra somme di parti sessagesimali appartenenti ad ordini differenti per riduzione allo stesso ordine e applicazione dei metodi precedenti esempio della divisione di 0 2 0 4 per 0 0 2 0 240
e) Metodo di moltiplicazione tra numeri con parti non intere disposizione tabellare dei termini esempio della moltiplicazione di 5 4 6 per 8 0 3 0 525
f ) Primo metodo di divisione lunga descrizione della disposizione tabellare ed esempio di algoritmo applicato alla divisione di 50 48 26 30 per 8 16 28 5426
g) Metodo di divisione lunga tratto da Pappo in Alm III descrizione della disposizione tabellare ed esempio di algoritmo applicato alla divisione di 360 per 365 14 48 come verifica del valore 0 59 8 17 13 12 31 fornito nellrsquoAlmagesto per il moto medio giornaliero del sole27
h) Metodo di approssimazione di una radice quadrata secondo Erone Metr I 8 con giustificazione geometrica di Teone (attualmente non attestata in suoi scritti)
i) Verifica tramite moltiplicazione della correttezza del valore tolemaico28 di 67 4 55 come radice quadrata approssimata di 4500 Metodo di estrazio-ne di radici quadrate secondo Teone basato su applicazioni successive di Elementi II 4 la procedura termina dopo un numero finito di passi nel caso di quadrati perfetti Applicazione al calcolo della radice quadrata di 450029
unrsquoannotazione spazientita laquoIl texto di questo 2do quinterno egrave stato recopiato fidelmente dallrsquooriginale a chi volesse vedere la prova lo potragrave conferire con detto originale le pagine del qual texto corrispondono con quelle dellrsquooriginale tanti versi che pagine [hellip]raquo (Moge-net 1962 p 200)
25 Teone in Alm I 10 e I 14 in iA pp 45815-4604 e 57911-5811026 Teone in Alm I 10 in iA pp 4611-46217 applicato alla divisione di 1515 20
15 per 25 12 1027 Teone in Alm III 1 e IV 3 in iA pp 84112-84422 (stesso calcolo dei Prolego-
mena) e 102916-10327 idem in Alm IX pp 377-378 dellrsquoedizione di Basilea del 1538 approntata dai tipografi di Walderus Lrsquooriginale pappiano non ci egrave pervenuto
28 Alm I 10 in POO I 1 p 341129 Teone in Alm I 10 in iA pp 46916-4738
Fabio Acerbi134
Lrsquounico testo non elencato qui sopra o nelle note e che contenga tabelle operazionali egrave il commentario eutociano a Circ 3-4 Il testo ar-chimedeo che Eutocio e noi con lui leggeva egrave particolarmente conciso ed egli verifica esplicitamente il sussistere di certe relazioni numeriche Si tratta in ognuno dei nove casi presenti di mostrare che il lsquoteorema di Pitagorarsquo egrave verificato con ottima approssimazione dai valori numerici di opportune terne di rette Eutocio esegue le tre moltiplicazioni dei valori per se stessi e mostra che la somma o la differenza di due dei risultati si discosta di poco dal terzo30 I numeri in questione sono interi seguiti o no da una parte non intera espressa come somma di frazioni unita-rie31 I nove gruppi di tre moltiplicazioni una a fianco allrsquoaltra sono organizzati in forma tabellare ma senza lrsquoausilio di linee separatrici32 le operazioni sono eseguite disponendo lsquoin colonnarsquo i risultati delle mol-tiplicazioni parziali e sommandoli esattamente come facciamo oggi poicheacute sono in gioco numeri interi con parti frazionarie unitarie e la notazione non egrave posizionale non egrave necessario che gli incolonnamenti siano esatti (unitagrave di un risultato parziale sotto le decine del precedente ecc) Sono inclusi nella tabella istruzioni e commenti in linguaggio corrente33 le prime relative allrsquooperazione da affettuare sui risultati delle
30 Eutocio non calcola radici quadrate approssimate per quanto ciograve si renda piugrave volte necessario fornisce il risultato e verifica la sua correttezza moltiplicandolo per se stesso Egli dichiara che il lettore interessato a questo procedimento di calcolo puograve rivolgersi Ἥρωνι ἐν τοῖς μετρικοῖς [hellip] Πάππῳ καὶ Θέωνι καὶ ἑτέροις πλείοσιν ἐξηγουμένοις τὴν μεγάλην σύνταξιν τοῦ Κλαυδίου Πτολεμαίου laquoa Erone nei Metrica [hellip] a Pappo e Teone e a svariati altri inter-preti della Grande composizione di Claudio Tolomeoraquo (AOO III p 23213-17)
31 Troviamo ad esempio ͵αωλη θ´ ια´ cioegrave 1838 + 19 + 111 notare il singolo apice per le frazioni unitarie
32 Essi sono editi in AOO III pp 234-256 La tradizione medievale del commentario eutociano che coincide con un ramo di quella archimedea e deriva da un codice appar-tenuto a Giorgio Valla perduto in etagrave rinascimentale ma riprodotto a volte con fedeltagrave assoluta negli apografi (si veda ad esempio nella tav 1a la riproduzione dellrsquoerronea di-sposizione di cifre e parte algoritmica nel primo gruppo di moltiplicazioni offerta dal Laur Plut 284 f 160r) egrave costituita da Marc gr 305 ff 142v-146v Laur Plut 284 ff 159r-164r Par gr 2360 ff 109v-113v Par gr 2361 pp 410-421 Nel codice veneziano in cui la disposizione per righe e colonne egrave irrimediabilmente alterata dal copista le operazioni sono cancellate con tratti di penna Il primo manoscritto fu esemplato per Bessarione da Giorgio Trivizias tra il 1455 e il 1468 (Mioni 1976 pp 309-312) il secondo fu vergato da Giovanni Scutariota in scrittura di imitazione (Martinelli Tempesta 2010 p 173 n 7 Rollo 2012) ca 1491-1492 il terzo fu trascritto per il cardinale di Firenze Niccolograve Ridolfi dopo che la biblioteca di Valla era stata acquistata a seacuteguito della sua morte avve-nuta il 23 gennaio 1500 per 800 scudi drsquooro da Alberto Pio di Carpi (nota del copista al f 120v) il quarto fu terminato per mano di Christopher Auer su commissione di Georges drsquoArmagnac il primo gennaio 1544 (sottoscrizione a p 474 del codice si veda RGK II nr 525)
33 A questi va aggiunto posto davanti al risultato finale di ogni moltiplicazione il segno convenzionale per ὁμοῦ laquoinsiemeraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 135
prime due moltiplicazioni34 i secondi alla bontagrave dellrsquoapprossimazione ottenuta35 Ogni gruppo di operazioni che chiude unrsquounitagrave esegetica ed egrave seguito dalla citazione che apre la successiva egrave trascritto come se facesse parte del testo a tutta pagina e preceduto dallrsquoindicazione οἱ δὲ πολλαπλασιασμοὶ ὑπόκεινται laquole moltiplicazioni sono poste qui sottoraquo Questi due fatti suggeriscono che tutte le operazioni cui Eutocio non fa alcun riferimento nel corpo del suo commentario siano unrsquoaggiunta editoriale risalente a Isidoro di Mileto che si occupograve della revisione del testo36
Gli incolonnamenti esatti sono invece necessari quando siano moltiplicati numeri con parti non intere espresse nel sistema sessage-simale in quanto la somma finale dei prodotti parziali va effettuata ordine per ordine Tale somma eccederagrave di norma il valore di 60 per un ordine dato nella tabella occorre pertanto trovare posto anche per i riporti che vanno sommati ai prodotti parziali dellrsquoordine preceden-te e quindi incolonnati con essi I testi ci offrono alcuni esempi di tabelle operazionali moltiplicative di questo tipo Teone afferma espli-citamente che la prima moltiplicazione che va a descrivere ha una rap-presentazione tabellare la cui disposizione ritroviamo pesantemente ingarbugliata nel Laur Plut 2818 f 35r37 Alla seconda occorrenza di una moltiplicazione eseguita (tav 1b Laur Plut 2818 f 65r) gli incolonnamenti sono meglio rispettati anche se il risultato finale egrave fatto erroneamente slittare di un posto verso destra i riporti (con un errore) si trovano nella penultima riga38 Nei Prolegomena ad Alma-gestum alcune moltiplicazioni sono accompagnate da tabelle quella meglio attestata egrave associata alla moltiplicazione di 67 4 55 per se stesso (sezione i nel riassunto fornito supra) ed egrave descritta additando sempli-cemente ad un ente materiale oramai inaccessibile forse tracciato in loquendo lsquoalla lavagnarsquo
34 Come λοιπὸν τὸ ἀπὸ ΕΓ laquoresta quello su ΕΓraquo seguito dal risultato della sottrazione di due quadrati
35 Come λείπει ἄρα μο β εἰς τὸ ἀκριβές laquomancano quindi 2 u(nitagrave) al risultato esattoraquo36 Si legga la sottoscrizione spuria ad AOO III p 26010-1237 Si legga la frase ἐκτίθεμαι αὐτὴν καὶ πάλιν αὐτὴν ὑφ᾽ αὑτὴν ὡς ὑπογέγραπται laquolo [scil il
valore del lato da moltiplicare per se stesso] dispongo lsaquouna voltarsaquo e di nuovo al sotto di se stesso come trascritto qui sottoraquo in iA p 45817 Il Laur Plut 2818 (Teone e Pappo Commentaria in Almagestum) egrave uno dei piugrave antichi manoscritti in minuscola sicuramente assegnabile alla prima metagrave del IX secolo (Follieri 1977 p 144 n 23 Maas 1927 p 76 n 17 riteneva che fosse piugrave antico del Tetraevangelo Uspenskij) per una sua analisi si veda Rome 1938
38 In nessuno dei due casi i numerali di molteplicitagrave sono segnalati con apici sono tutti sormontati da una barra si veda la sezione 4 punto b
Fabio Acerbi136
προκείσθω δὶς τὸ μῆκος αὐτῆς ὀφεῖλον τὴν τάξιν τοῦ κατὰ τοὺς πολλαπλασιασμοὺς κανόνος ἀποδοῦναι καὶ ἐκκείσθω ἐπὶ σελιδίων διαγεγραμμένων οὕτω καὶ δὴ αὐτῆς ἐφ᾽ ἑαυτὴν πολ-λαπλασιασθείσης γεγονέτωσαν τὰ ἐν τοῖς οἰκείοις σελιδίοις εἴδη ταῦτα δὴ συναγόμενα καθ᾽ ἣν ὑπεδείξαμεν τάξιν ποιήσει τὰς ὑπογεγραμμένας μοίρας ἢ καὶ λεπτά τινα εἴσι ͵δυϙθ νθ´ ιδ´´ ι´´´ κε´´´´ ὡς λείπειν τοῦ ἐπιμερισθῆναι ŏ ŏ με´´ μθ´´´ λε´´´´
che sia prescritto che la sua lunghezza debba figurare due volte nella disposizione della tavola delle moltiplicazioni e che lsaquoquestrsquoultimarsaquo sia disposta su colonne delimitate da linee cosigrave mdash E pertanto una volta moltiplicato lsaquoil latorsaquo per se stesso che le specie trovino posto nelle colonne appropriate quelle che vengono cosigrave raccolte secondo la disposizione che abbiamo indicato produrranno dunque i gradi o anche i minuti qui sotto trascritti 4499 59 14 10 25 in modo che dalle divisioni successive resti39 0 0 45 49 35
La tabella associata (tav 2a Marc gr 313 f 19v) contiene una sola svista grossolana reca 51 invece di 55 in ognuno dei due fattori posti affiancati sopra di essa Al di sotto preceduto dal segno convenzionale per ὁμοῦ egrave collocato il risultato incongruamente sfalsato di un paio di colonne e con la lettera numerale ͵δ priva di barra sormontante in-naturalmente disconnessa da υϙθ I riporti sono indicati dai numerali ι ρκγ´ η´´ ν´´´ posti al fondo delle prime quattro colonne Il calcolo egrave corretto in ogni sua parte
Il clou in questo piccolo spaccato delle interazioni testo-paratesto matematico risiede nella descrizione contenuta nei Prolegomena della disposizione tabellare di due procedimenti di divisione il primo ano-nimo e quindi da supporre tradizionale il secondo piugrave efficiente ed attribuito al matematico del IV secolo Pappo
Il primo metodo di divisione egrave sostanzialmente analogo a quello che usiamo attualmente Dividendo e divisore questrsquoultimo preceduto da un segno su cui ritorneremo nella prossima sezione sono posti uno sotto lrsquoaltro intervallati da una riga inizialmente vuota Primo passo viene reperito il massimo multiplo del divisore che sia minore del di-videndo esso viene trascritto sotto il dividendo nella prima lsquocasellarsquo della riga vuota recante in testa un segno per laquosottrairaquo il fattore mol-tiplicativo (o quoziente parziale) viene trascritto in una lsquocasellarsquo pre-ceduta da un segno per laquorisultaraquo sotto il divisore Secondo passo il massimo multiplo viene sottratto dal dividendo il resto cosigrave ottenuto egrave trascritto preceduto da un segno per laquorestoraquo in una casella posta
39 Lrsquoautore concettualizza il procedimento di estrazione di radice quadrata come una forma di divisione
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 137
accanto al dividendo40 I due passi precedenti sono quindi ripetuti con la sola differenza che il resto appena ottenuto prende il posto del divi-dendo il quoziente parziale scala di un ordine sessagesimale ad ogni passo41 E cosigrave via aggiungendo ogni volta due caselle La debolezza di questo metodo come di quello che utilizziamo attualmente risiede nel fatto che il reperimento dei quozienti parziali (ovverosia dei massimi multipli) viene effettuato per tentativi non riuscire a farlo al primo colpo appesantisce notevolmente i calcoli successivi e costringe ad un lavoro di riordino e addizione dei quozienti parziali stessi La tabella risultante dove appunto osserviamo questo fenomeno in parallelo con identiche inaccuratezze nella descrizione ha la forma riprodotta unico tra i manoscritti della recensione antica nel Marc gr 313 f 13r (tav 2b invito il lettore a non rivolgersi alle tavole se non dopo aver termi-nato questa sezione sarebbe anzi auspicabile che tentasse di ricostruire questa tabella e le due successive a partire dalla mia descrizione)42
Il secondo metodo di divisione attribuito a Pappo egrave congegnato in modo da rendere non aleatoria la ricerca dei quozienti parziali Come altrove nei Prolegomena la descrizione della procedura di calcolo si riag-gancia esplicitamente a una frase di Tolomeo laquouna volta dimostrato che il periodo di una singola rivoluzione lsaquodel solersaquo egrave di 365 giorni 14 48 se di-vidiamo per essi i 360 gradi di un singolo cerchio avremo il moto medio giornaliero del sole circa 0 gradi 59 8 17 13 12 31raquo43 Questrsquoaffermazione si trova nel terzo libro dellrsquoAlmagesto si tratta della prima occasione in cui viene effettuata una divisione in cui il divisore egrave maggiore del dividendo e i commentatori del trattato tolemaico non si fecero sfuggire lrsquooccasione di mostrare come eseguirla Ora il terzo libro del commentario di Pappo non ci egrave pervenuto Ci resta dunque come testo parallelo a quello dei Prolegomena la descrizione rigidamente formulare in Teone sicuramente un calco di quella pappiana Teone qui come nelle altre applicazioni del metodo (Laur Plut 2818 ff 136v [tav 3] e 190r) descrive brevemente ed espone esplicitamente la stessa tavola dei sottomultipli del divisore che
40 Esempio nella divisione di 378 per 17 il massimo multiplo egrave 374 il quoziente parziale egrave 22 il resto 4 e in effetti 378 = 374 + 4 = 17times22 + 4 Si noti che il segno per laquorestoraquo non egrave apposto in testa di riga ma davanti a ogni resto parziale e in effetti il dividendo che si trova in prima posizione in questa riga non egrave un resto
41 Analogamente nellrsquoalgoritmo moderno poniamo la virgola o scaliamo la cifra di un posto
42 Nei Prolegomena la descrizione della tabella associata al metodo anonimo egrave pre-ceduta da una breve sinossi dellrsquooperazione in stile procedurale (cioegrave senza riferimenti alla tabella) e seguita dalla sua esecuzione accurata ma con pochi riferimenti alla tabella se non quello ai due segni da apporre ai resti parziali e ai massimi multipli
43 Alm III 1 in POO I 1 p 2091-4
Fabio Acerbi138
troviamo nei Prolegomena ma non offre alcuna descrizione della disposi-zione tabellare della divisione stessa neacute vi fa riferimento
A questa procedura sono in effetti associate una tavola e una tabel-la costruite come segue (tavv 4 e 5 Marc gr 313 ff 17r e 17v il co-pista era ndash giustamente ndash insoddisfatto della prima versione) La tavola le cui righe e colonne sono delimitate da linee contiene sottomultipli44 del divisore 365 14 48 9 righe che riportano i valori da 160 a 960 piugrave altre 6 con i valori per decine da 1060 a 6060 la prima colonna elenca le 15 parti sessagesimali omettendo come drsquoabitudine la laquodenomina-zioneraquo dellrsquoordine (i numerali elencati sono quindi α β γ δ ε ϛ ζ η θ ι κ λ μ ν ξ) la seconda i sottomultipli corrispondenti organizzati su quattro colonne per tener conto dei tre ordini sessagesimali (il primo sottomultiplo egrave quindi ϛ ε´ ιδ´´ μη´´´ cioegrave 160 di τξε ιδ´ μη´´) La tabella priva di linee delimitanti espone la vera divisione Nella prima colonna troviamo i resti parziali ognuno preceduto dallrsquoindicazione del proprio ordine sessagesimale e da un segno per laquorestoraquo Nella seconda preceduti da un segno per laquosottrairaquo i sottraendi ognuno coincide ovviamente con uno dei sottomultipli nella tavola La terza colonna contiene se-guiti dallrsquoindicazione del proprio ordine sessagesimale i quozienti par-ziali ottenuti trascrivendo dalla prima riga della tavola il numerale corrispondente al sottraendo affiancato ed assegnando come ordine sessagesimale il successivo a quello posto in testa di riga Il risultato preceduto da un segno per laquorisultaraquo e posto al di sotto della tabella si ottiene sommando i quozienti parziali il procedimento non permette in generale di determinare lrsquointero quoziente parziale relativo ad un ordine sessagesimale fissato se non dopo due passi Una linea spezzata unisce i resti parziali successivi e i relativi sottraendi per evidenziare la laquoprogressione della proceduraraquo la spezzata lsquosaltarsquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore (le cui righe sono per il resto vuote) e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue di conseguenza anche il quoziente parziale relativo a questo resto appartiene allrsquoordine sessagesimale successivo
A questo punto possiamo rivolgerci alle tavv 4-5 e verificare se le immagini che ci siamo formati sulla base della mia descrizione corri-spondono a quelle che troviamo nel Marc gr 313 Non si tratta di un giochetto sterile egrave al contrario il cuore di un intrico di problemi Un primo ordine di problemi deriva dal fatto che nei Prolegomena lrsquoalgo-
44 Sottomultipli e non multipli in quanto il divisore egrave maggiore del dividendo Drsquoaltronde nel sistema sessagesimale come in quello decimale un sottomultiplo si ottiene dal multiplo corrispondente semplicemente scalando tutte le cifre di un posto (ad esempio 1360 di 365 14 48 si ottiene in questa maniera da 13 volte 365 14 48)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 139
ritmo della divisione lsquoalla Papporsquo non egrave mai eseguito (cioegrave formulato verbalmente) in maniera indipendente dalla descrizione della tabella Comrsquoegrave dunque possibile descrivere una tabella operazionale che non ha uno statuto testuale indipendente sulla base di un algoritmo in corso di esecuzione E drsquoaltro canto come non rilevare unrsquoanomalia in un algoritmo eseguito nella sua forma primaria sotto forma di descrizione di una tabella Ci potremmo chiedere se viene descritto lrsquoalgoritmo o la tabella La tensione fra i due enti grafici egrave acuita dal fatto che nei nostri testi tutto ciograve (esposizione o descrizione di un algoritmo o della tabella associata) avviene sempre e solo sulla base di un esempio numerico para-digmatico Per questo motivo la tabella in quanto struttura (cioegrave privata dei dati numerici accidentali) non puograve fare a meno della descrizione45 Dal canto suo Teone come forse Pappo ancor prima descrive ed espone la tavola dei (sotto)multipli ma non la tabella di divisione lrsquoalgoritmo relativo a questrsquoultima egrave espresso come per controbilanciare in maniera eccezionalmente trasparente e formulare Se ciograve comporta un guada-gno a livello verbale-argomentativo sorge un problema operativo grave come e dove sistemare i resti e i quozienti parziali ndash cioegrave tutti i numeri in output dellrsquoalgoritmo differenti dai (sotto)multipli ndash che la tabella si incarica di disporre in modo lsquonaturalersquo Teone prescrive soltanto di confrontare i resti con la seconda colonna della tavola dei sottomultipli e di trascrivere via via il quoziente ottenuto dopo ogni passo Insomma come eseguire materialmente una divisione Non certo adattando ad un nuovo caso specifico la formulazione dellrsquoalgoritmo che Teone propone
Un secondo ordine di problemi e una trappola micidiale per il co-pista egrave interno alla dialettica lsquotabellarsquolsquosua descrizionersquo ed egrave in assenza di simbolismo quello dei riferimenti linguistici da adottarsi nella seconda agli enti grafici che figurano nella prima Occorre ricercare la massima generalitagrave fornita da una descrizione definita di un ente numerico (ad esempio impiegando il termine laquorestoraquo o la perifrasi laquomassimo sotto-multiplo minoranteraquo) o basta assumere direttamente il suo valore speci-fico come esempio paradigmatico E in che modo risolvere il conflitto tra uso e menzione se come nel nostro caso la tabella contiene segni convenzionali ed occorre fornirne una descrizione Si rende ad esempio necessario introdurre un lsquooperatore di citazionersquo noi useremmo le virgo-lette la lingua greca premette lrsquoarticolo neutro Drsquoaccordo ma nel caso
45 Questa caratteristica non egrave connaturata alla matematica degli algoritmi la risorsa dello lsquostile proceduralersquo serve esattamente ad aggirare questo problema al di lagrave di un certo livello di dettaglio perograve essa condurrebbe ad un appesantimento insostenibile della for-mulazione dovuto alla pluralitagrave dei riferimenti agli oggetti matematici in gioco sulla que-stione dei diversi stili della matematica greca si veda Acerbi 2012
Fabio Acerbi140
greco qual egrave il suo range E come distinguerlo nei casi ambigui da un semplice articolo che precede un sostantivo quando questrsquoultimo lo ri-chieda Nel corso del processo di copia del testo della descrizione infine possono generarsi tensioni tra enti grafici interpretabili vuoi come segno convenzionale vuoi come abbreviazione Ambiguitagrave relative a questi punti opacizzano la descrizione Un problema analogo si porrebbe a priori nella dialettica tra uso delle lettere denotative per designare enti geometrici e loro menzione nella costruzione di un diagramma ma esso egrave risolto con lrsquoazzeramento della seconda funzione le lettere denota-tive sono sempre usate allrsquointerno del testo (sono cioegrave il referente degli oggetti geometrici di cui tratta il discorso matematico) mai menzionate (come accadrebbe se fossero il referente di oggetti grafici posti nel dia-gramma) Insomma il codice adottato per la costituzione dei diagrammi geometrici egrave condiviso (cioegrave canonizzato) semplice e perspicuo mentre quello per le tabelle operazionali non lo egrave da qui le sviste dei copisti e le trascuratezze di correttori ed editori
Infine chi vuole apprendere da questi testi come eseguire una divi-sione a cosa deve prestar fede se ad esempio a causa di errori di copia la descrizione finisce per non coincidere con la tabella operazionale visto che sono entrambe due maniere valide di eseguire lo stesso algoritmo Dopo tutto lo scopo di tutta questa macchina grafico-argomentativa egrave di insegnare a eseguire divisioni in formato tabellare Questo problema si fa particolarmente acuto se la tabella non egrave trasparente nel metodo di Pappo lo egrave quasi completamente in quello anonimo no E gli errori che riscontreremo nella (doppia) tabella ai ff 17r-v del Marc gr 313 a chi sono attribuibili Allrsquoautore al trascrittore o al copista medievale
Questo groviglio di problemi riceve alcune risposte sorprendenti dalla tradizione manoscritta come andiamo finalmente a vedere
4 Analisi delle testimonianze
I codici che ho adibito per lrsquoedizione sono i seguenti M = Marc gr 31346 C = Marc gr 314 (Tolomeo Tetrabiblos et opera minora cum commentariis Vezio Valente Anthologiae)47 Z = Vat gr 2326 (fattizio
46 Riferibile al sec IX ex-X in accolgo la datazione suggeritami per litteras il 522005 da Nigel G Wilson si veda anche Agati 1992 pp 141-142 La presenza non sistematica degli accenti che fa anticipare a Wilson la datazione di laquosaec X medraquo fornita in Mioni 1985 p 24 indusse Boris Fonkič (2005 non vidi) ad assegnare il codice allrsquoinizio del IX secolo
47 Il manoscritto riferibile alla seconda o terza decade della prima metagrave del XIV secolo fu vergato da Michele Clostomalle olim lsquoMetochitesschreiberrsquo Bianconi 2005a pp 428-430 Il titolo dei Prolegomena in questa trascrizione identico in grafia ma non in formulazione a
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 141
e mutilo Tolomeo Almagestum) S = Vat gr 184 (varia astronomica scholia miscellanea ad Almagestum Tolomeo Almagestum) P = Par gr 2390 (varia astronomica) gli ultimi tre riferibili allo scorcio del XIII secolo48 e apografi sicuri del Vat gr 159449 attualmente mutilo di due fascicoli che ci privano dei due terzi finali dei Prolegomena M e il Vat gr 1594 ammettono un modello comune il resto della tradizione (25 trascrizioni in tutto) dipende dagli apografi appena citati del Vat gr 1594 Le varianti della recensione bizantina che leggiamo tra lrsquoaltro nei Vat gr 198 Marc gr 310 (Tolomeo Almagestum cum commentariis Pappi Theonis et Cabasilae) e con ulteriori modifiche Laur Plut 89 sup 48 (varia astronomica Tolomeo Almagestum Barlaam Logistica) sono identificate dal siglum K e si trovano punteggiatura originale in-clusa nel secondo apparato50 Lrsquoanalisi delle testimonianze51 costituite ovviamente anche dalle tabelle associate saragrave condotta nella forma di una sequenza di osservazioni indicizzate da numerali o lettere oltre che di alcune note a piersquo di pagina
Iniziamo dalla descrizione del metodo di divisione anonimo
quello che leggiamo nel Vat gr 1594 (questrsquoultimo coincide con quello adottato nella recen-sione bizantina) fu apposto da Niceforo Gregora e successivamente corretto da Bessarione
48 Sto studiando il primo e il terzo codice in collaborazione rispettivamente con Daniele Bianconi e Inmaculada Peacuterez Martiacuten
49 Su questo codice risalente alla seconda metagrave del IX secolo e sulla sua collocazione nella lsquocollezione filosoficarsquo per prima proposta in Follieri 1977 pp 145-146 si vedano almeno Perria 1991 pp 82-88 Ronconi 2013 Che il titolo dei Prolegomena nel Vat gr 1594 sia stato apposto da Niceforo Gregora egrave stato riconosciuto per la prima volta in Mazzucchi 1994 p 211 n 196 si veda Bianconi 2005a p 418 per altri interventi di Gregora nello stesso manoscritto
50 Il Vat gr 198 egrave stato vergato dal copista Malachia nel corso del terzo quarto del XIV secolo Mondrain 2004 pp 278-290 e 292 Allo stesso copista (denominato non a caso prima dellrsquoidentificazione anonymus Aristotelicus) dobbiamo un buon numero di trascrizioni aristoteliche con i relativi commentari in margine Gli dobbiamo anche il Par gr 2342 secondo tomo di un quadrivium quasi completo di cui il Vat gr 198 egrave il primo nellrsquoordine aritmetica armonica astronomia (Almagesto e commentari relativi) nel codice vaticano geometria ed ancora astronomia (corpus astronomico minore) in quello parigino le opere trascritte sono sempre accompagnate in margine dai relativi commentari Il copista del Marc gr 310 egrave Isacco Argiro (ca 1300-1375) Mondrain 2007 p 166 Allo stesso Argiro dobbiamo il codice laurenziano (Daniele Bianconi per litteras) Poicheacute la recensione modificata che leggiamo nel Laur Plut 89 sup 48 egrave senza alcun dubbio basata su quella nel Marc gr 310 e non viceversa ci troviamo di fronte ad un copista che trascrive due volte lo stesso testo in due versioni leggermente differenti la conclusione naturale egrave che la seconda recensione egrave dovuta ad Argiro stesso la questione andragrave studiata in dettaglio
51 Nei manoscritti citati i Prolegomena si trovano ai fogli seguenti Vat gr 1594 ff 1r-8v (mutilo mancano due fascicoli su tre) Marc gr 313 ff 1r-28r (incompleto man-cano due fogli allrsquoinizio e il f 6 attualmente rimpiazzato da uno bianco) Marc gr 314 ff 235r-255r Vat gr 2326 ff 19r-40v e 43r-v (incompleto e con i fascicoli in disordine) Vat gr 184 ff 10r-23v Par gr 2390 ff 1r-13v Vat gr 198 ff 127r-136v Marc gr 310 ff 1r-13r Laur Plut 89 sup 48 ff 7r-19r
Fabio Acerbi142
ἐκθέμενοι οὖν διάγραμμα τῶν ἀριθμῶν ὡς ὑπόκειται προτάσσομεν τὸν μεριζόμενον καὶ μικρὸν ὑπ᾽ αὐτὸν τὸν μερίζοντα ὡς ἔχει τὸ διάγραμμα ἐν στίχοις διοριζομένοις ὑπὸ γραμμῶν [hellip] καὶ τὰ μὲν γινόμενα ἐγγὺς ἐλάττονα ἐν τῇ μεταξὺ θέσει τοῦ μεριζομένου καὶ τοῦ μερίζοντος ἐν στίχοις παρασημειοῦσθαι πρὸς τὸ ἀσύγχυτον εἶναι τὴν τάξιν τὰ δὲ μεθ᾿ ὧν ὁ μερίζων ἐποίει τοὺς ἀεὶ ἐλάσσονας ὑπὸ τὸν μερίζοντα σημειοῦσθαι προγράφοντας ἐπὶ τοῦ στίχου αὐτῶν τὸ γίνεται οὕτως γι ἐν δὲ τῷ στίχῳ τῶν μεριζόντων τὸ παρὰ ἔχον οὕτως oslash ἀντὶ τοῦ παρ᾿ ἃ δεῖ τὸν μερισμὸν γίνεσθαι ἐν δὲ τῷ στίχῳ τῶν ἐλασσόνων τὸ αφ διὰ τὸ τούτους ἀεὶ ἀφαιρεῖσθαι ἀπὸ τῶν ἐπάνω τῶν μεριζομένων ἐν δὲ τοῖς τοῦ μεριζομένου λοιπάσμασι τοῖς καὶ ἐπιοφείλουσι τὸ λ κατὰ τὸ ἴδιον τῶν διαστάσεων ἑκάστης ndash λέγω δὴ λοιπάδος ndash ἀντὶ τοῦ λοιποὶ οἱ μέλλοντες ἐπιμερίζεσθαι
2 post τὸν suprascr τὸν ἐλάττονα m 2 S 5 πρὸς] MP et ex corr Z κατὰ S om C | ἀσύγχυτον] MSPC -χητον Z 6 ἀεὶ] MZPC ὡσεὶ S 7 γίνεται οὕτως γι ] γι τ οὕτως γι τ M γί οὕτως γί Z γι οὕτως γί SC τὸ γινόμενον οὕτως γίνεται P 8 τὸ παρὰ ἔχον οὕτως] scripsi τὸ παρέχον οὕτως M et π(αρ-) comp Z οὕτως τὸ περιέχον S προγράφοντας οὕτως ex corr m 2 P τὸ περιέχον οὕτως C | oslash] MZSC (sed ο fecit | Z) ἐλάττων comp ex corr m 2 P | παρ᾿ ἃ] scripsi παρα M π(αρα) comp ZSC ex παρα fe-cit παρὰ et τοῦτον suprascr m 2 P 9 γίνεσθαι] comp C | αφ ] αφ ε M ἀφ ZSC ἀφαί P | ἀεὶ] om M 11 ἐπιοφείλουσι] MZSC ex ἐπιο- fecit ἐπο- m 2 P | λ] MZPC λ´ S 12 λοιποὶ] PC λοιποῦ MZS
3 στίχοις] στίχῳ K 5 πρὸς] διὰ K 7 ἐπὶ mdash γι ] τὸ γίνεται διὰ τοιούτου σ(ημείου) γί K 8 τὸ παρὰ ἔχον mdash παρ᾿ ἃ] τὸ παρᾱ διὰ σ(ημείου) τοιούτου καὶ τοῦτο oslash δηλοῦντος τοῦ παρᾱ ὅτι παρὰ τὸν τοιοῦτον (ἀριθμὸν) K 9 αφ διὰ τὸ τούτους] ἀφ δηλοῖ δὲ τοῦτο ἀφαίρεσ(ιν) ὅτι τούτους ἀεὶ δεῖ K 11 ἐπιοφείλουσι] ἐπιμερίζεσθαι ὀφείλουσι K | λ] λ οι` K 12 ἀντὶ τοῦ] δηλοῦντος τοῦ σ(ημείου) τὸ K
lsquoRendendo esplicito un diagramma numerico come lo troviamo qui sotto disponiamo in primo luogo il dividendo e un poco al di sotto di esso il divisore come li ha il diagramma in righe delimitate da linee [hellip] e lsaquooccorreragraversaquo nella posizione tra il dividendo e il divisore annotare lrsquouno accanto allrsquoaltro i piugrave vicini lsaquodei numerirsaquo minori che risultano affincheacute la disposizione non sia confusa quelli con cui il divisore faceva ogni volta i lsaquonumerirsaquo minori annotarli sotto il divisore scrivendo in prima posizione sulla loro riga laquorisultaraquo cosigrave Ris nella riga dei diviso-ri52 invece laquoperraquo fatto cosigrave53 P in luogo di laquoquelli per cui deve farsi la divisioneraquo nella riga dei lsaquonumerirsaquo minori laquosottrraquo in quanto questi sono sempre sottratti dai dividendi che si trovano sopra nei residuli del dividendo (occorre ben farlo anche per loro) laquoReraquo in accordo con ciograve
52 I laquodivisoriraquo sono al plurale ma siamo semplicemente di fronte a un tratto idioma-tico della lingua greca nel caso di espressioni generalizzanti crsquoegrave soltanto un divisore che occupa lrsquounica colonna di cui si compone la sua riga
53 Si intenda ἔχον οὕτως = ita se habens
1
5
10
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 143
che egrave proprio agli scarti di ciascuno ndash intendo qui lsaquociascunrsaquo residuo54 ndash in luogo di laquoresti che vanno a essere divisi ulteriormenteraquorsquo
a) Operatori di citazione e segni convenzionali I segni introdotti sono quattro la mia discussione egrave condotta dando per scontato che essi siano identici a quelli impiegati dallrsquoautore dei Prolegomena anche se si tratta di unrsquoipotesi non corroborabile neacute falsificabile
i Segno per il risultato Lrsquoabbreviazione convenzionale per γίνεται egrave identica al segno introdotto dallrsquoautore e i copisti si dividono tra i due errori possibili scrivere due abbreviazioni o risolverle entrambe Un fenomeno del tutto analogo si riscontra nel Matr 4678 il manoscritto alla base di tutta la tradizione degli Arithmetica di Diofanto al momen-to della definizione dellrsquoἀριθμός (lrsquolsquoincognitarsquo nel nostro linguaggio) ὁ δὲ μηδὲν τούτων τῶν ἰδιωμάτων κτησάμενος ἔχων δὲ ἐν ἑαυτῷ πλῆθος μονάδων ἄλογος ςο` καλεῖται ς` ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον τὸ ς` laquoil lsaquonumerorsaquo che non possiede nessuna di queste proprietagrave ma che ha in seacute una molteplicitagrave indefinita di unitagrave egrave chiamato lsquonumerorsquo e il suo segno egrave ς`raquo Qui solo il terzo dei tre ς ha una barra a sormontare per segnalarne il carattere puramente denotativo (cioegrave di segno convenzionale e non di abbreviazione si veda il punto successivo)55 il primo egrave una delle abbreviazioni piugrave diffuse per ἀριθμός (e infatti egrave dotato del compendio per la desinenza e dellrsquoaccento grave) il secondo egrave una delle piugrave comu-ni per καὶ () Giovanni Cortasmeno autore di capillari annotazioni infra lineam agli Arithmetica nel codice madrileno scioglie il primo ςο`
54 Doppia variatio che impiega al posto di λοιπόν laquorestoraquo i due termini decisamente non canonici τὸ λοίπασμα e ἡ λοιπάς (piugrave oltre leggiamo anche il participio λοιπασθέντα) Una ricerca sul TLG in rete non ha fornito occorrenze del primo si tratta dunque di uno hapax Quanto al secondo che ricorre anche nella sezione sulla divisione lsquoalla Papporsquo lo si rintraccia giagrave nei papiri documentari il termine diventeragrave perograve canonico nelle esposizioni bizantine drsquointroduzione allrsquoAlmagesto ricalcate sul modello dei Prolegomena (si veda la nota 87 infra) Questi due termini designano i resti parziali prodotti nel corso di una divisione lunga li ho tradotti rispettivamente con il neologismo laquoresiduloraquo e con il sostantivo pari-menti non canonico laquoresiduoraquo
55 Il copista interpreta erroneamente il terzo segno come unrsquoabbreviazione e qui ag-giunge un apice inverso (cioegrave un accento grave) altrove lo scioglie direttamente in forme opportune di ἀριθμός Matr 4678 f 58v La frase come la leggiamo nel manoscritto egrave cor-rotta sulla base di una parafrasi in Psello (edita in DOO II p 3710-12) Tannery emendograve ἄλογος in ἀόριστον DOO I p 64-5 et app Il Matritensis vergato da due copisti differenti (cambio di mano a tre righe dalla fine del f 62r) contiene lrsquoIntroductio arithmetica di Nicomaco e le opere diofantee oltre ad alcuni brevi opuscoli musicali la sua data egrave stata recentemente corretta dal XIII al secolo XI pm in Peacuterez Martiacuten 2006 (una riproduzione digitale del manoscritto si trova allrsquoindirizzo httpbdhbneesbnesearchbibliotecaDio-fanto20de20AlejandrC3ADa)
Fabio Acerbi144
in ἀριθμός ed aggiunge un altro segno56 sopra il terzo anteponendovi lrsquoindicazione καὶ ἔστιν αὐτοῦ σ(ημεῖον) τόδε Va da seacute che non abbiamo nessuna garanzia che il segno originariamente introdotto da Diofanto coincidesse realmente con unrsquoabbreviazione convenzionale per ἀριθμός Lrsquoevidenza del PMich III 144 (sec II in) suggerisce drsquoaltronde che il Matritensis e con esso tutta la tradizione medievale di Diofanto ripro-duca fedelmente pur accentuandone la sinuositagrave il segno originario
ii Segno per il divisore Un cerchiolino sbarrato da non confondere con il segno per ὁμοῦ che nei manoscritti matematici ha di norma due barre trasversali (cf tav 2a) Non sono riuscito a rintracciarne ulteriori occorrenze in altre opere la forma che esso assume nel Vat gr 2326 e la correzione apportata nel Par gr 2390 lasciano aperta la possibilitagrave per quanto a mio avviso remota che la forma originaria non fosse lon-tana da unrsquoabbreviazione di παρά registrata nei repertori57 Il correttore del Par gr 2390 trasforma in effetti il segno oslash nellrsquoaffine abbreviazione canonica per (forme di) ἐλάσσων laquominoreraquo58 e si incarica diligente-mente di farlo notare ricapitolando i segni nella porzione superiore del margine esterno del f 7v Nello stesso margine egli traccia anche uno lsquoscolio tabellarersquo ed egrave lrsquounico a porre il (proprio) segno dove indicato dalla descrizione (tav 6 Par gr 2390 f 7v) Oltre a ciograve adattando la tabella al margine ristretto lo scoliaste trascrive come colonne affian-cate le due righe dei resti parziali e dei massimi multipli e aggiunge le indicazioni ὁ μεριζόμενος laquodividendoraquo e ὁ μερίζων laquodivisoreraquo ma vi introduce alcune incongruenze di formato il risultato scritto in verti-cale e la linea verticale di sinistra che separa il divisore dal segno che lo dovrebbe precedere direttamente
iii Segno per i massimi multipli Corrisponde alla semplice abbre-viazione per sospensione della forma verbale ἄφελε laquosottrairaquo in questo
56 Si tratta del segno di ampio uso praticamente identico allrsquoabbreviazione canonica per οὖν
57 Si tratta di un pi a forma di gancio sbarrato da uno slash di troncamento Ce-reteli 1904 tav IX item 7 sub ΠΑΡΑ che rinvia al PVindRain 423 cf anche la forma π` nel POxy LXI 4142 edito in Jones 1999 II pp 26-34 In generale nei papiri e nei manoscritti matematici in maiuscola le preposizioni sono abbreviate facendo seguire un lsquoapostroforsquo alla loro prima lettera Α᾽ Υ᾽ ecc Per la seconda fattispecie di supporto libra-rio si veda in particolare il cosiddetto fragmentum mathematicum Bobiense scriptio inferior databile al V-VI secolo del palinsesto Milano Biblioteca Ambrosiana L 99 sup (Isidoro di Siviglia Etymologiae datazione Cavallo 1977 p 100) pp 113-114 che sono stampate in riproduzione apografa conforme in Belger 1881 (la p 114 egrave riprodotta anche nella tav 10 di Acerbi 2010)
58 Se questa era lrsquointenzione si tratta ovviamente di una forzatura il divisore puograve ben essere maggiore del dividendo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 145
caso lo slash di troncamento taglia orizzontalmente il tratto verticale del phi I copisti offrono molteplici varianti apponendo chi uno spirito dolce chi un ε chi un αί accentato a sormontare Tutti questi segni svolgono la funzione di abbreviazioni vere e proprie (e cosigrave doveva essere anche per lrsquoautore si veda il punto 1 di p 153 infra) la forma originale si ottiene a mio avviso incrociando i dati del Marc gr 313 e dei tre apografi del Vat gr 1594 αφ anche se lrsquoassenza dello spirito potrebbe essere semplicemente dovuta alla pratica del copista del codice veneziano di economizzare nei diacritici
iv Segno per i resti Un lambda completato da una barra a sormon-tare o da un apice che rinvia alle abbreviazioni per sospensione di una forma opportuna di λοιπός laquorestoraquo In realtagrave la forma che troviamo nella tabella egrave differente (tav 2b) e coincide con quella offerta quasi unanimemente dai manoscritti nella descrizione e in almeno un caso nella tabella del metodo di divisione attribuito a Pappo (tav 4) un lambda che accoglie al di sotto una legatura omicron-iota () sbarrata da uno slash di troncamento Qualcosa di simile si trova nel PVindob G 19996 (sec I) una specie di lambda maiuscolo molto aperto e dal vertice arrotondato che include un circoletto interpretato dagli editori come segno per περίεστιν o per λοιπόν59 Lo stesso segno si rintraccia ad esempio in un medesimo scolio tabellare di prima mano ad Alma-gestum nel Vat gr 1594 f 93v e nel Marc gr 313 f 135r ma stavolta la forma del lambda egrave molto ben definita
Fin qui i segni Ma il gioco egrave piugrave complesso La descrizione si muo-ve pericolosamente sulla linea di confine non sempre ben definita tra segno convenzionale e abbreviazione il primo ndash e il repertorio grafico matematico-astronomico ne egrave particolarmente fornito60 ndash puograve anche
59 Ho consultato lrsquoedizione Gerstinger ndash Vogel 1932 pp 46 e 48 la porzione rilevante del papiro egrave riprodotta nella tav 11 di Fowler 1999 Si veda ancora ivi pp 253-257 per la trascrizione di questo segmento di testo (con correzioni rispetto alla princeps) e per una messa a punto recente inclusa la proposta di datazione che ho riportato qui sopra Il verso del papiro che contiene una tavola aritmetica del tutto scorrelata dalla tematica del recto egrave edito come PRain Unterricht 151
60 La pratica di ridurre lo spazio occupato da un testo tecnico per mezzo di abbreviazioni e segni convenzionali era molto diffusa nei manoscritti in maiuscola contrariamente a quanto avviene per altri generi letterari vedremo tra breve cosa accade negli Arithmetica di Diofanto ma si leggano in proposito anche le considerazioni di Hei-berg nei prolegomena alla propria edizione dellrsquoAlmagesto in particolare riguardo al ricorso massiccio ad espedienti brachigrafici nel modello del Vat gr 180 POO II pp lxxxiv-xciii civ-cv cxxvii cxxxviii-cxxxix Agli elenchi dettagliati forniti da Heiberg possiamo aggiungere il piccolo prontuario stampato in Hultsch 1876-1878 III 2 pp 126-132 e basato sul testo e sugli scolii alla Collectio di Pappo nel Vat gr 218 (sec X in) Si vedano infine le osservazioni del copista del Par gr 2360 f 120v trascritte da Heiberg in AOO III pp x-xi sulle laquonotazioni tipiche a scopo di tagliar corto nello scrivereraquo impiegate nel pro-
Fabio Acerbi146
derivare dalla seconda (un caso egrave appunto il segno per ἐλάσσων che probabilmente trae origine da una legatura epsilon-lambda) ma poi il rapporto referente-relato si fissa convenzionalmente Quelli definiti nel testo che abbiamo letto sono appunto segni convenzionali non ci sarebbe bisogno di spiegarne forma e funzione se fossero intesi come abbreviazioni assumono nella tabella una funzione denotativa non esplicativa o discorsiva (come accade invece nella tav 1a) Ma come vengono descritti questi segni
I referenti delle descrizioni sono i segni sono introdotti da οὕτως (item i-ii) o in alternativa da un τό con il ruolo di lsquooperatore di citazionersquo (item iii-iv) che corrisponde esattamente alle nostre virgolette In entram-bi i casi gli enti sono menzionati e svolgono una funzione metalinguistica sono collocati materialmente nel testo ma egrave come se si trovassero fuori e la loro descrizione li additasse ndash in effetti i segni convenzionali scritti nel testo sono a loro volta i relata di quelli che si trovano nella tabella
I relata dei segni scritti nel testo sono di due tipi singoli vocaboli (item i-ii) o descrizioni della funzione dei segni per mezzo di clausole sintaticamente complesse (item ii e iv) I singoli vocaboli sono γίνεται e παρά e sono entrambi preceduti dal τό lsquocitazionalersquo in quanto relata di segni convenzionali le forme abbreviate con cui sono tracciati nei manoscritti vanno forzatamente sciolte Bisogna ammettere che la per-spicacia e le risorse grafiche dei copisti ndash di cui tutto si puograve dire fuor che commettano qui degli errori ndash sono messe a dura prova con lrsquointrodurre segni identici ad abbreviazioni o con lrsquoattivare un gioco metalinguistico particolarmente serrato in un contesto meno lsquonaturalersquo di come potreb-be esserlo ad esempio quello di un trattato grammaticale Lrsquoitem iii che presenta direttamente un segno identico ad unrsquoabbreviazione non egrave sorretto da una descrizione ma da una giustificazione in διὰ τό Lrsquoartico-lo τό vi assume una funzione metalinguistica anche se non lsquocitazionalersquo poicheacute al tempo stesso genera un infinito sostantivato e lo singolarizza per questo ho scritto laquosono sottrattiraquo in corsivo nella mia traduzione
prio modello archimedeo (nota 32 supra) egli ne compila anche una breve lista Un elenco antico di laquosegni della geometriaraquo sicuramente redatto per assistere il copista si trova anche al f 3v del ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 vergato da Efrem negli anni 950-960 (tav 8 in Acerbi 2010) Possiamo farci unrsquoidea quantitativa del guadagno di spazio in rapporto ad un testo privo di abbreviazioni e con le parole separate da spazi sulla base del fragmentum mathematicum Bobiense il testo vi egrave disposto a tutta pagina su 36 righe di circa 30 segni ciascuna nelle due pagine in questione figurano 2038 segni con 15 mezze righe occupate dalle due figure Ora nel testo dellrsquoedizione stabilita in Heiberg 1927 pp 87-90 le stesse pagine contano 4455 segni spazi compresi Ne risulta che la dimensione in caratteri di un testo matematico puograve essere ridotta di piugrave della metagrave con lrsquoimpiego di compendi e segni convenzionali
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 147
Negli item ii e iv il segno si collega ad una descrizione nel secondo caso in via esclusiva le descrizioni pertanto rinforzano o sostituiscono lrsquoidentificazione con lrsquoente linguistico denotato Le clausole descrittive sono precedute da ἀντί e dallrsquoarticolo τό con funzione di lsquooperatore di citazionersquo esse sono παρ᾿ ἃ δεῖ τὸν μερισμὸν γίνεσθαι (item ii) e λοιποὶ οἱ μέλλοντες ἐπιμερίζεσθαι (item iv) Nella descrizione della divisione lsquoalla Papporsquo che leggeremo tra breve i segni negli item iii e iv rice-vono lo stesso trattamento degli altri due il loro relatum egrave un singolo vocabolo e non una clausola descrittiva rispettivamente nelle espres-sioni τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε (sul participio ritorneremo nel punto 1 infra) e τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά (la forma del segno notato con λ οι egrave descritta supra nellrsquoitem iv) La descrizione del segno oslash per il divisore merita una discussione piugrave dettagliata In origine si trovava probabilmente scritto Π(ΑΡΑ)ΕΧΟΝ successivamente letto come π(αρ[α])έχον ndash dato che lrsquoabbreviazione per il preverbo egrave identica a quella per la preposizione (che sia Π᾽ o un pi seguito dal segno per ἄρα a sormontare) ndash invece di π(αρὰ) ἔχον I copisti e i correttori si dettero a tutte le possibili contorsioni per restituire un testo dotato di senso leggere appunto una forma verbale con preverbo modificare il preverbo (ma forse il segno per ἄρα era insidiosamente simile ad uno epsilon) correggere il testo rileggiamo lrsquoapparato sub τὸ παρὰ ἔχον οὕτως τὸ παρέχον οὕτως M et π(αρ-) comp Z οὕτως τὸ περιέχον S τὸ περιέχον οὕτως C προγράφοντας οὕτως ex corr m 2 P Nella clausola descrittiva seguente la presenza liminare di παρὰ (che ho corretto in παρ᾿ ἃ nella speranza di restituire una frase che abbia un senso senza intervenire sul testo) innesca un bel corto circuito il Π(ΑΡΑ) che sicuramente figu-rava nellrsquoarchetipo egrave un sintagma complesso una preposizione unrsquoab-breviazione o un segno per unrsquoabbreviazione Se lrsquoeditore si trova in conflitto con la propria inclinazione alla critica conservativa i copisti si rifiutarono di mettere mano ad un testo che doveva stridere anche per loro essendo il compito demandato al ritocco del revisore del Par gr 2390 o alla riscrittura radicale del recensore bizantino Il problema egrave che ci troviamo di fronte ad unrsquoespressione che descrive la funzione dellrsquooggetto denotato non lrsquooggetto stesso ma che lo contiene al suo interno per soprammercato qui il Π(ΑΡΑ) egrave usato per giustificare una menzione a sua volta relatum di un segno
Evidentemente questa maniera di procedere che giagrave aveva attirato interventi da parte di copisti e correttori della recensione di base parve insostenibilmente opaca allrsquoautore della recensione bizantina61 Egli
61 Uno dei manoscritti di questa recensione propone anche una tabella di divisione
Fabio Acerbi148
modifica tutte le descrizioni diluendo lrsquoidiomatismo dellrsquoarticolo lsquocita-zionalersquo con lrsquointroduzione sistematica del verbo δηλόω e di frasi atte a chiarire quale sia il segno denotante e quale il vocabolo (o il segno) denotato Egli introduce allo scopo di rendere esplicita la funzione de-notativa dei segni introdotti il termine σημείου curiosamente in tutte le sue tre occorrenze esso compare a sua volta nella forma dellrsquoabbrevia-zione per sospensione σΗ´ Egli traccia il segno per i massimi multipli ἀφ e quello per i resti λ οι` in modo che non vi siano ambiguitagrave quanto al loro carattere di abbreviazione Si faccia infine attenzione al residuo di barra sul παρᾱ con funzione denotativa (2 occorrenze) contenuto nella descrizione del segno per il divisore sostituita dallrsquoaccento grave nel παρὰ con funzione discorsiva (la differenza egrave nettissima nei manoscritti da me consultati) Questa osservazione ci permette di passare direttamente allrsquoitem seguente
b) Le barre sui numerali e sulle lettere denotative Egrave opportuno discutere questo punto adesso esattamente percheacute di barre siffatte che pure troviamo in tutti i manoscritti i nostri testi non fanno mai menzione si tratta infatti di una pratica condivisa sin dallrsquoantichitagrave La barra identifica una stringa di lettere dellrsquoalfabeto che non svolge una funzione grammaticale o sintattica propria allrsquointerno del discorso Ciograve avviene in particolare e si tratta della fattispecie piugrave frequente se la stringa di lettere non dagrave origine a un vocabolo della lingua greca lette-re denotative e numerali certo ma anche termini provenienti da altri idiomi e contrazioni di parole greche come i nomina sacra62 tali termi-ni possono essere o no preceduti da un articolo lsquocitazionalersquo a seconda dellrsquouso che ne viene fatto allrsquointerno del discorso Ma non si tratta dellrsquounica fattispecie i papiri grammaticali ed i manoscritti piugrave antichi dei trattati dello stesso argomento segnalano gli esempi delle parti del discorso (cioegrave di lsquoverersquo parole greche) per mezzo di barre sormontanti63 La differenza insomma egrave tra menzione e uso (come parte del discorso in atto) di una stringa di caratteri tra il porre le lsquovirgolettersquo e il non porle tra funzione denotativa e non Apparentemente la convenzione si limi-
corredata dei segni opportuni e contrariamente alle indicazioni della descrizione svilup-pata lsquoin verticalersquo ma per motivi misteriosi non completa (tav 7a Laur Plut 89 sup 48 f 13r)
62 Tutto ciograve egrave spiegato con estrema chiarezza giagrave in Traube 1907 pp 45-4763 Si veda il Par gr 2548 codex vetustissimus e testimone unico delle lsquoopere minorirsquo
di Apollonio Discolo il f 106v con le barre ben visibili egrave riprodotto come tav 19 in De Gregorio 2000 (ivi pp 137-138 per la datazione) Per la testimonianza dei papiri grammaticali si veda Wouters 1979 passim essi contengono di norma elenchi di parti del discorso nessuna delle quali egrave preceduta dallrsquoarticolo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 149
tava in questo secondo caso a segnalare con la barra singoli vocaboli le menzioni di frasi o di sintagmi complessi sono di norma identificate dallrsquoarticolo lsquocitazionalersquo Drsquoaltra parte le abbreviazioni convenzionali non rientrano nella casistica percheacute la loro resa grafica che contiene elementi non alfabetici come compendi per desinenze lettere supra li-neam marche di contrazione o sospensione quali slashes o barre sotto-poste o sormontanti eventualmente solo un sottinsieme della stringa di segni alfabetici le esclude automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
Venendo al discorso matematico una barra sormonta senza ecce-zione le lettere denotative64 che sia in papiri o in manoscritti in maiu-scola65 o minuscola ma solo allrsquointerno del testo comrsquoegrave da attendersi nei diagrammi esse la perdono per il semplice motivo che non crsquoegrave alcun testo ambiente un diagramma ha unicamente una funzione denotati-va Drsquoaltra parte le lettere numerali che a volte figurano nei diagrammi della tradizione metrica66 allo scopo di indicare la lunghezza dei seg-menti mantengono la barra in un diagramma il contesto denotativo geometrico egrave prevalente e i numerali vengono percepiti come entitagrave grafiche lsquoesternersquo al discorso Va da seacute a fortiori che le lettere numerali inserite in un testo dovranno essere segnalate da barre che a loro volta non servono nelle tavole67 in quanto queste ultime sono come abbiamo visto un vero e proprio testo che perograve funge da ambiente a quello al-fabetico limitato alle titolazioni e non a caso tracciato in unrsquoopportuna lsquomaiuscola distintivarsquo allo scopo di segnalarne il carattere denotativo e non discorsivo68 Una tabella operazionale egrave invece un paratesto e quindi le barre sulle lettere numerali che rappresentano gli interi sono
64 La notazione per le lettere denotative subigrave unrsquoevoluzione (il cui risultato finale egrave descritto per sommi capi nella nota 3 supra) di cui non mette conto occuparsi qui
65 I papiri di contenuto geometrico (o astronomici ma che presentano argomenti geometrici) sono rari si vedano il PHerc 1061 (sec II aC Demetrio Lacone De geome-tria) e il PFay 9 (sec II ex Elementi I 39 e 41) Gli importanti ostraka OBerl 12002 e 12609 (sec III aC m Elementi XIII) non pongono le barre sopra le lettere denotative Per i manoscritti in maiuscola si veda ad esempio passim nel Par gr 2389 una cui riproduzione digitale egrave consultabile in rete allrsquoindirizzo httpgallicabnffrark12148btv1b8470171d o il fragmentum mathematicum Bobiense
66 Si veda ancora il ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 codex unicus dei Metrica di Erone e contenente una raccolta importante di problemi del corpus metrologico
67 Si vedano come esempio le tavole citate alle note 10 e 14 supra Discorso a parte per il segno di lsquoposto vuotorsquo si veda il punto c che segue
68 Queste regole generali vanno prese cum grano salis si dagrave naturalmente un certo dominio di variabilitagrave legato verosimilmente al grado di cultura grafica del copista nel PMich III 144 i numerali sono quasi tutti senza barra sia nel testo che nelle tabelle ope-razionali
Fabio Acerbi150
necessarie esse mancano invece sui segni convenzionali che ho descrit-to nel punto precedente e fatto rilevante sulle lettere numerali relative agli ordini sessagesimali quando esse siano identificate da uno o piugrave apici la presenza di questo segno grafico non alfabetico69 le esclude ancora una volta automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo Unrsquoultima osservazione che ci saragrave utile nel seacuteguito la descrizio-ne di una stringa di lettere lsquoagrammaticalersquo non puograve prevedere la men-zione della presenza della barra che le pertiene in quanto tale si tratta di una pratica denotativa che egrave possibile formulare soltanto ad un livello di discorso superiore sia a quello dellrsquouso che a quello della menzione70
c) Il segno di lsquoposto vuotorsquo Si noti nella tav 2b la forma ŏ per il segno di lsquoposto vuotorsquo in un ordine sessagesimale coerentemente con la propria notazione il copista del Marc gr 313 lo scioglie talvolta allrsquoin-terno del testo principale come unrsquoabbreviazione per οὐδέν laquonienteraquo Altre convenzioni di scrittura del tratto che accompagna il circoletto e che si badi bene fa parte integrante del segno di lsquoposto vuotorsquo ndash e infatti nelle tavole troviamo sempre il segno completo mentre tutti gli altri numerali sono come abbiamo visto nel punto precedente privi di barra o di apice a causa del fatto che i vari ordini sessagesimali sono univocamente determinati dalle linee di giustificazione ndash un tratto an-golare anteposto (tav 3 Lar Plut 2818 f 136v)71 o una semplice barra a sormontare (tavv 4-9) si produce in questo modo il segno 65926 che sembra essere stata la forma di base72
69 Occorre dunque supporre come testimoniano papiri e manoscritti in maiuscola che la convenzione relativa allrsquouso della barra si sia consolidata ben prima dellrsquointroduzione di segni diacritici quali accenti e spiriti
70 Si veda il punto 2 infra per maggiori dettagli sulla questione delle barre e degli apici e per le indicazioni in merito che leggiamo in Diofanto
71 Come accennato questa tavola dei sottomultipli coincide con quella descritta ed esposta nei Prolegomena Fatto molto rilevante i numerali nella prima non recano neacute barre neacute apici contrariamente a quanto accade a tutte le istanze della seconda nei manoscritti Quella del Laur Plut 2818 preserva a mio avviso la forma originaria come abbiamo visto una tavola non richiede segni aggiuntivi sulle lettere numerali
72 Si vedano come esempio ancora le tavole citate alle note 10 e 14 supra oppure per una rassegna delle forme che il segno assume nei manoscritti piugrave antichi delle Tavole facili Tihon 2011 pp 58-59 e per quelle che assume nei papiri Jones 1999 I pp 61-62 Ovviamente non possiamo leggere il segno 65926 come un omicron con una barra in quanto ο = 70 nella notazione greca e la barra egrave di rigore quando il numerale figuri allrsquointerno di un testo Occorre ammettere che si dagrave origine ad un bel corto circuito notazionale con il concepire un segno con funzione di lsquoposto vuotorsquo ma che lsquosomigliarsquo ad una lettera dellrsquoalfabeto sormontata da una barra cioegrave ad un numerale in piugrave quando il lsquoposto vuotorsquo non corrisponda ad un intero ma ad una specie sessagesimale la presenza della barra a priori indistinguibile da quella che sormonta gli interi introduce unrsquoincongruenza con la notazione a mezzo di apici vista nellrsquoitem precedente
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 151
d) Errori di copia La tabella riprodotta nella tav 2b ha una forma simmetrica ma si tratta di una forzatura il grande rettangolo in basso a destra drsquoaltronde assente nella descrizione contiene uno scolio che fa notare come lrsquoultimo resto parziale ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ͵γτνζ´´´´´ κζ´´´´´´ cioegrave 0 0 0 0 0 3357 27 siano ἔγγιστα λ´λ´ δ´δ´ ξ laquocon ottima approssimazione 60 minuti quartiraquo dove si notino gli apici semplici per indicare il pas-saggio allrsquoordinale e il raddoppiamento del sistema segno + apice per significare il plurale Lo scolio debitamente accompagnato dal segno di rimando in forma di simbolo solare egrave stato probabilmente incluso nella tabella proprio allo scopo di renderla simmetrica A sua volta un errore precedente spiega lo spazio eccessivo accordato al rettangolo contenente lo scolio il secondo massimo multiplo ŏ λβ´ ξδ´´ ριβ´´´ σιϛ´´´´ egrave trascritto anche al di sotto del risultato
Passiamo ora alla descrizione del metodo di divisione attribuito a Pappo
ἵνα οὖν ταῦτα συναχθῇ τὰ ἐκ τοῦ μερισμοῦ ὁ εἰρημένος Πάππος εὐδιατύπῳ τινὶ καὶ πρὸς τοῦτο τάξει χρησάμενος ποιεῖται τὴν τῆς συλλήψεως τοῦ ζητουμένου ἀνεύρεσιν οὕτως ἐκθέμενος γὰρ τὸν μέλλοντα μερίζεσθαι τουτέστι τὰς τξ μοίρας ἐν ἀρχῇ ἀφαιρεῖ ἀπ᾽ αὐτῶν τὸν ἐν τῇ σελίδι τυγχάνοντα ἐλάττονα τουτέστι τὸν τδ κβ´ κ´´ ὄντα τῶν ἐγγὺς ἐλασσόνων ὡς πρὸς τοὺς ἐκκειμένους διὸ καὶ γράφει αὐτὸν προγράφων αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε καὶ εὑρίσκων τὰ παρακείμενα αὐτῷ τῷ ἀπογραφέντι ἐν τῷ σελιδίῳ λεπτὰ πρῶτα ν´ συναπογράφεται παρατιθῶν αὐτοῖς τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον ἀνατείνουσαν σημαῖνον τὸ εἶδος ὅτι πρῶτα λεπτά εὑρίσκει οὖν οὕτως τὸ τῶν τξ μέρος τὸ τδ κβ´ κ´´ ὃ μεριζόμενον παρὰ τὰς τξε ιδ´ μη´´ ἡμέρας καὶ ποιοῦν τὸν ἐκ τοῦ μερισμοῦ ἀριθμὸν πρῶτα λεπτὰ ν´ καὶ τὸν λοιπὸν ἀπογραφόμενος τὸν νε λζ´ μ´´ προτάσσει αὐτοῦ τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά τάσσει δὲ καὶ ἁπλῆν τινα διατείνουσαν γραμμὴν ὡς ἀπὸ τοῦ τξ ἐπὶ τὸν ἑξῆς ἐκτεθειμένον ἐγγὺς
1
5
10
1 εὐδιατύπῳ] ZSPC εὐδιατύπωτ M 4 ἀφαιρεῖ] MZSP ἀφ ι C 5 ἐλάττονα] P comp MZSC 6 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | αφ ] αφ ε M ἀφ ZS ἀφαί P ἄφ C | ἀντὶ] om C | ἄφελε] MZSP ἄφ C 8 ἀπογραφέντι] MZSP ἐγγραφέντι C | λεπτὰ πρῶτα] P λε πρωτα SC λεπτῶν πρωτ MZ | παρατιθῶν] MZS παρατιθεὶς C et ex corr m 2 P 9 ᾱ] Z αο P α´ MS α C | ἔχον] MPC ἔχων ZS 9-10 πρῶτα λεπτά] ZP πρωτ λ´λ´ M πρωτα λε S αα λε C 11 ἡμέρας] comp codd | ἀριθμὸν] P et comp MZ καὶ C et comp S 12 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M πρωτ λεπτ(α) Z πρωτ λ εᾱ S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C | ἀπογραφόμενος] MZSP ἐγγραφόμενος C | νε λζ´] MZSP λζ νζ C 13 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | λ οι] MZSC ex λ fecit λ οι P | προσσημαῖνον] MC et προσ- comp ZS προση- P | τὸ] MZC τὰ S et fecit m 2 P 14 ἀπὸ] MZSP πρὸς C ἐλάττονα] P comp MZSC
1 εὐδιατύπῳ] εὐδιατυπώτω K 6-7 αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ] τὸ ἀφ K 8 παρατιθῶν mdash 10 λεπτά] τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ σημαίνουσαν τὸ εἶδος αὐτῶν ὅτι ᾱ λεπτά εἰσιν K | τὸ (sec)] τὰ K 12 πρῶτα] πρώτων K | τε λ ] λ οι` K | προσσημαῖνον mdash
Fabio Acerbi152
ἐλάττονα τὸν τδ κβ´ κ´´ ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις καὶ ταύτην ἐπιδεικνύουσαν τὴν τάξιν τῆς προόδου τῆς ἐκθέσεως ἧστινος κλωμένης γραμμῆς πρὸς τῷ ἐγγὺς ἐλάσσονι ἡ ἀντανάκλασις ἐπὶ τὸν λοιπὸν γέγραπται φερομένη ὡς εἴρηται διὰ τὸ εὔτακτον τῆς προκοπῆς οὕτως τε ποιήσας ἑξῆς τὸ αφ ποιῶν ὃ προσσημαίνει ὡς εἴρηται τὸ ὅτι δεῖ ἀφελεῖν ὁμοίως ἀπὸ τοῦ λοιποῦ καὶ δὴ τὸν ἐγγὺς πάλιν ἐλάσσονα ὡς πρὸς τὴν ἐν τῷ σελιδίῳ ἔκθεσιν εὑρισκόμενον λαμβάνων ἑξῆς προγράφει αὐτὸν ὄντα νδ μζ´ ιγ´´ ιβ´´´ καὶ εὑρίσκει αὐτοῖς παρακείμενα ἐν τῷ σελιδίῳ πρῶτα λεπτὰ θ´ ἅτινα καὶ αὐτὰ προσαπογράφεται σὺν τῇ παρασημειώσει τῶν πρώτων γράφων τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον τὴν ἀνατείνουσαν καὶ ὡς εἴρηται τὴν γραμμὴν πάλιν διὰ τὴν τάξιν κλωμένην κατὰ δευτέραν κλάσιν προσέλκει γινομένου τοῦ μέρους αὐτῆς τούτου παραλλήλου τῷ ἐξ ἀρχῆς
16 ante κλωμένης add ἐπὶ C 18 τε] MZP om SC | αφ ] M ἀφ ZSC ἀφαί P 19 προσσημαίνει] MS προση- ZC et ex corr P | ὅτι] ZP comp MSC 20 δὴ] MZSC διὰ fecit m 2 P 21 πρὸς] MSP et supra lineam C ex ἀπὸ fecit m 2 Z | ιγ´´] MZSP νγ´´ C 22 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M ᾱᾱ λεπτὰ Z άάα λε S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C 23 προσαπο- γράφεται] απο suprascr in comp M 24 ᾱ] ZP α´ MS α C 25 κλάσιν] MP τάξιν ZSC | τοῦ] ZSPC τούτου M 26 τούτου] τοῦ bis ZSPC sed prius erasit m 2 P τοῦ M
mdash 18 προκοπῆς] om K | τε ποιήσας] ποιήσας καὶ K | αφ ] ἀφ K 19 τὸ] om K 21 προ-γράφει] γράφει K 22 σελιδίῳ] α´ σελιδίῳ K | ἅτινα] ἃ K 23 προσαπογράφεται] ἀπογράφεται K | τῶν πρώτων mdash 26 ἐξ ἀρχῆς] om K
lsquoAllo scopo di raccogliere ciograve che risulta dalla divisione il detto Pappo utilizzando anche in questo caso una certa disposizione ben strutturata determina nel modo seguente il lsaquonumerorsaquo cercato preso nel suo insieme collocando73 in testa il lsaquonumerorsaquo che sta per essere diviso cioegrave i 360 gradi iniziali sottrae loro tra i piugrave prossimi dei lsaquonumerirsaquo minori rispetto a quelli esposti quello che si trova essere minore nella colonna (cioegrave 304 22 20) Questo egrave il motivo per cui lo trascrive scrivendogli davanti lrsquoabbreviazio-ne laquosottrraquo per laquosottrairaquo e trovando che 50 minuti primi sono collocati accanto a quello stesso lsaquonumerorsaquo che egrave stato trascritto nella colonna li trascrive al tempo stesso collocando accanto74 ad essi la lettera A con un lsaquotrattorsaquo75 sopra che significa la specie minuti primi Trova dunque in que-sto modo la parte di 360 che egrave 304 22 20 la quale divisa per 365 giorni 14 48 fa il numero lsaquoche risultarsaquo dalla divisione 50 minuti primi Trascrivendo
73 La descrizione egrave strutturata come una procedura Acerbi 201274 Il purismo del correttore del Par gr 2390 di Clostomalle nel Marc gr 314 e
dellrsquoautore della recensione bizantina impone loro di modificare la terminazione ma forme tematiche e contratte di τιθεῖν sono correnti nel greco tardivo
75 Il testo greco ha solo il participio con γραμμήν sottinteso Per il significato del participio si veda il punto 2
15
20
25
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 153
poi il resto 55 37 40 gli pone altresigrave76 a prefisso laquoReraquo che significa laquorestiraquo e dispone anche una certa linea semplice77 che va da 360 al piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori che egrave esposto di seacuteguito 304 22 20 come nello lsaquoschemarsaquo esposto linea che mostra lrsquoordine del percorso dellrsquoesposizione Questa linea spezzata lagrave dove si trova il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori egrave tracciata inflessa allrsquoindietro lsaquoersaquo punta verso il resto come egrave stato detto in vista di una progressione ordinata E cosigrave facendo prendendo di seacuteguito il laquosottrraquo che significa come egrave stato detto laquoche occorre similmente sottrarre dal re-storaquo e ovviamente prendendo di nuovo il lsaquonumerorsaquo che egrave trovato essere il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori in relazione alla disposizione nella colonna ndash 54 47 13 12 ndash lo scrive di seacuteguito e trova che 9 minuti primi sono posti loro accanto nella colonna trascrive78 anche questi con la segnaletica dei primi scrivendo la lettera A con un lsaquotrattorsaquo sopra e come egrave stato detto prolunga di nuovo la linea spezzata in vista di una buona disposizione tramite una seconda inflessione essendo questa sua parte parallela a quella inizialersquo
La descrizione continua con una serie di laquoe cosigrave viaraquo e non fa ulte-riore riferimento alla tabella
1) La forma verbale ἐξεσμένον Egrave il neutro del participio perfetto medio-passivo di ξέω lett laquopialloraquo laquolevigoraquo Si danno tre possibilitagrave si tratta di un termine canonico per quanto non altrove attestato per designare unrsquoabbreviazione oppure lrsquoautore anonimo improvvisa sul piano metaforico come se unrsquoabbreviazione non fosse altro che la paro-la completa lsquoaccorciata a colpi di piallarsquo in maniera opportuna oppure il testo egrave corrotto e srsquoimpone una correzione ad esempio τὸ ἑξῆς μένον laquociograve che sta di seacuteguitoraquo Questrsquoultima strada mi pare chiusa dal senso delle frase lrsquoabbreviazione non lsquosta di seacuteguitorsquo a niente ma anzi precede la perifrasi τὸ ἑξῆς μένον se impiegata semplicemente per rimandare al segno αφ immediatamente seguente costituirebbe un intollerabile solecismo Se accettiamo la prima di queste letture considerando quin-di lrsquoabbreviazione αφ in posizione predicativa abbiamo a che fare con
76 Rendo in questo modo il τε isolato77 La linea egrave laquosempliceraquo in quanto egrave una retta la precisazione intende evidenziare per
anticipazione il carattere lsquonon semplicersquo che essa assumeragrave alla prima inflessione quando diventeragrave una spezzata linee siffatte erano in effetti concepite dallrsquoanonimo e prima di lui da tutta la tradizione matematica greca come una singola linea spezzata nei punti drsquoinfles-sione I due segmenti paralleli menzionati al termine del passo sono orizzontali
78 Il verbo egrave al medio in variatio rispetto ai due che precedono e che seguono egrave il matematico che lsquosirsquo trascrive le cifre
Fabio Acerbi154
uno hapax semantico nella grecitagrave superstite come egrave facile verificare con una ricerca sul TLG in rete La recensione bizantina risolve il pro-blema sopprimendo semplicemente τὸ ἐξεσμένον
2) La notazione per le specie numeriche Nella terminologia matema-tica greca gli ordini sessagesimali sono εἴδη laquospecieraquo numerici essi corri- spondono agli ordini di grandezza nel nostro sistema decimale e indica-no in analogia con il caso geometrico la lsquoformarsquo che assume un numero quadrato cubo ecc Centinaia e migliaia sono quindi degli εἴδη rispet-tivamente quadrati (100 egrave il quadrato di 10) e cubi (1000 egrave il cubo di 10) sono specie numeriche ma non numeri particolari e drsquoaltronde 300 non egrave un quadrato ma 3 item dellrsquoεἶδος lsquoquadratorsquo 100 3 egrave il numerale di molteplicitagrave della specie quadrata lsquocentinaiarsquo i due 0 che seguono il 3 segnalano esattamente questo fatto che la notazione greca per gli interi non posizionale fa scomparire al livello denotativo Ciograve non vale soltan-to per i numeri interi ma anche per le loro parti i minuti secondi appar-tengono alla specie lsquoquadratorsquo in quanto 13600 egrave il quadrato di 160
La concezione appare interamente dispiegata nellrsquointroduzione degli Arithmetica diofantei79 che si rivela giova farlo rimarcare un te-stimone fondamentale per la ricostruzione della notazione matematica antica Alle specie usate in questrsquoopera vengono assegnati una denomi-nazione ed un segno convenzionale costituito dallrsquoiniziale (di ognuno dei componenti) della denominazione al quadrato o δύναμις il segno ΔΥ al κύβος il segno ΚΥ alla lsquoquarta potenzarsquo o δυναμοδύναμις il segno ΔΥΔ ecc La descrizione di tali segni egrave del tipo καὶ ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον Κ ἐπίσημον ἔχον Υ ΚΥ κύβος laquoe il suo segno egrave un Κ che ha come indice un Υ ΚΥ cuboraquo dove in accordo con quanto abbiamo visto nel punto b supra e pur nel comprensibile imbarazzo del copista della prima parte del Matritensis (o di un suo passato collega) a districarsi in questo formidabile ginepraio notazionale80 le due lettere Κ e Υ ricevono una barra mentre ΚΥ non la richiede a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον il quale ancora una volta esclude automaticamente il segno dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
79 In particolare a DOO I pp 214-62180 Nel Matr 4678 riscontriamo i seguenti fenomeni nelle poche righe a cavallo dei ff
58r-v 1) accento acuto posto su tutti i segni come se fossero abbreviazioni 2) ripetizione sistematica segnodenominazione come in ΚΥ κύβος appena letto dovuta sicuramente allrsquointrusione di glosse interlineari esplicative dei segni ndash e successivo pentimento (δύναμις e κύβος sono in effetti cancellati dalla prima mano il primo con un tratto il secondo con dei punti supra lineam poi il copista si stanca di correggere) 3) nella descrizione del segno per la δυναμοδύναμις menzione di un δέλτα δύο che saragrave molto probabilmente stato ΔΔ subito dopo nella descrizione del κυβόκυβος si legge un incongruo δύο KK
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 155
Diofanto introduce poi dei segni anche per le specie delle parti dellrsquounitagrave (le nostre frazioni) che egli chiama ὁμώνυμα μορία laquoparti omonimeraquo di cui quelle sessagesimali sono casi particolari81 Egli spie-ga appunto che le loro denominazioni sono ottenute da quelle delle specie degli interi per sinonimia passando ad un lsquoordinalersquo82 formato semplicemente aggiungendo il suffisso -στον δυναμοστόν κυβοστόν δυναμοδυναμοστόν ecc (sott μόριον) I loro segni convenzionali sono invece ottenuti da quelli per le specie degli interi aggiungendo una γραμμὴν διαστέλλουσαν τὸ εἶδος laquolinea che distingue la specieraquo83 Una linea sui segni delle specie delle parti egrave richiesta si badi bene per distinguerli dai segni di quelle degli interi come giagrave osservato questi ultimi sono giagrave lsquoagrammaticalirsquo a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον a fortiori lo saranno anche i primi Si tratta della traduzione semio-tica del passaggio dal cardinale allrsquoordinale che a livello grammaticale egrave effettuato con il suffisso -στον Che forma ha questa linea Barra o apice (Egrave cervellotico pensare a forme piugrave complesse) La domanda non ammette una risposta immediata in quanto delle specie diofantee nessuno piugrave si occupa nellrsquoantichitagrave84 Se egrave vero che la prima risposta darebbe origine ad un conflitto tra due convenzioni denotative diffe-renti la barra lsquocitazionalersquo e la barra che distingue la specie lrsquoevidenza grafica del Matritensis lascia lievemente sgomenti (ricordiamoci che giagrave i segni di base sono indebitamente dotati di un accento dal copista) Le poche occorrenze del segno per le specie delle parti85 vedono lrsquoaggiunta di uno slash di sospensione di un doppio apice inverso ndash in tutta evi-
81 Questo fatto era giagrave chiaro nellrsquoantichitagrave Teone in Alm I 10 in iA p 45310-1682 Il parallelo con i cardinali e gli ordinali relativi agli interi egrave reso esplicito da Dio-
fanto ὥσπερ δὲ τῶν ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια παρομοίως καλεῖται τοῖς ἀριθμοῖς τοῦ μὲν τρία τὸ τρίτον τοῦ δὲ τέσσαρα τὸ τέταρτον οὕτως καὶ τῶν νῦν ἐπονομασθέντων ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια κληθήσεται παρομοίως τοῖς ἀριθμοῖς laquocome le parti omonime dei numeri sono chia-mate per assonanza con i numeri di lsquotrersquo lsquolsaquounrsaquo terzorsquo di lsquoquattrorsquo lsquolsaquounrsaquo quartorsquo cosigrave le parti omonime dei numeri appena nominati saranno chiamate per assonanza con i numeriraquo (DOO I p 69-13 si noti lrsquoarticolo lsquocitazionalersquo al singolare in τοῦ τρία e τοῦ τέσσαρα) Il parallelo prosegue anche al livello dei segni che rappresentano queste specie come vedremo tra un attimo
83 Diofanto Arithmetica prefazione in DOO I p 620-21 un passaggio maltrattato in questa edizione occorre espungere il participio ἔχον senza introdurre segni ulteriori oppure eliminare un precedente ἐπί come fa un correttore del Matritensis f 58v
84 Unica parzialissima eccezione lrsquoaccenno di Teone menzionato nella nota 81 supra85 Al f 59r e per di piugrave nel margine per sanare un lungo saut du mecircme au mecircme La
collocazione in margine egrave il motivo per cui troviamo una notazione abbreviata nel resto del trattato il primo copista scioglie tutti i segni prendendoli per abbreviazioni mentre il secondo elimina sistematicamente il tratto aggiuntivo delle specie delle parti dellrsquounitagrave Drsquoaltronde egli scrive ad esempio ΔΥ invece di ΔΥ ed egrave quindi indotto a porre la barra al di sopra della stringa di lettere risultante (passim ma si veda ad esempio il f 72r)
Fabio Acerbi156
denza il compendio per la desinenza -ον accentata il copista interpreta il segno come unrsquoabbreviazione ndash e di una barra a sormontare lo Υ Potremmo forse interpretarlo come il segno di contrazione del grafema -στ- lrsquounico tassello mancante in unrsquoabbreviazione come ad esempio (δυναμοδυναμο)(στ)(ὸν) ma uno scolio di prima mano al f 58v rela-tivo alle specie degli interi inficia questrsquoipotesi esse sono dotate di slash di sospensione accento acuto in un caso del compendio canonico per la terminazione -ον hellip ma tutti gli Υ a esponente sono a loro volta sormontati da una barra
Meno legata al singolo manoscritto ma nondimeno non uniforme si presenta la pratica di notazione dei segni che rappresentano gli enti numerici sessagesimali86 da una parte sta lrsquoevidenza del testo dei Pro-legomena e delle sue tabelle apici ndash drsquoaltronde come abbiamo visto la notazione universalmente impiegata per i numerali ordinali e per le fra-zioni unitarie ndash dallrsquoaltra sta lrsquoevidenza del testo dellrsquoAlmagesto in tutti i manoscritti piugrave antichi e lo stesso si dica del commentario teonino a questrsquoopera o del suo lsquoGrande commentariorsquo alle Tavole facili e dei testi astronomici su papiro barre87 Sembra insomma che la nostra docu-
86 Sia le molteplicitagrave che le specie ahimeacute entrambe rappresentate da lettere dellrsquoalfabeto Come osservato allrsquoinizio della sezione 3 ci sono in effetti due tipi di lettere numerali in gioco se facciamo astrazione da apici o barre lsquo4 minuti secondirsquo si trova scritto δ β la prima lettera numerale denota la molteplicitagrave degli item di una certa specie la se-conda la specie nei Prolegomena entrambe sono accompagnate da un doppio apice il che rende inutile la presenza delle seconde Si noti che la descrizione della tabella non fa parola della notazione da usare per le lettere numerali che denotano la molteplicitagrave barre o apici e quanti apici hellip In questo caso fa interamente fede la tabella cioegrave la pratica grafica condivisa instauratasi non egrave chiaro quando
87 I manoscritti piugrave antichi dellrsquoAlmagesto sono menzionati nella nota 10 supra quelli dei due commentarii teonini sono il Laur Plut 2818 e il celeberrimo Vat gr 190 (sec IX in Euclide Elementi Data Teone lsquoGrande commentariorsquo) per la notazione dei pa-piri astronomici si veda Jones 1999 II passim La notazione non sembra lsquoinquinatarsquo dalla pratica dei copisti bizantini e pare dipendere soltanto dalla data di composizione Tro-viamo ad esempio barre sopra tutti i numerali di molteplicitagrave (interi o sessagesimali) nel frammento di un commentario alle Tavole facili contenente un calcolo relativo al 24 aprile 213 (Par gr 2841 sec XIII ex-XIV in oltre al frammento ai ff 32r l 11-34v l 23 contiene Arato Phaenomena ed Efestione Apotelesmatica edizione in Jones 1990) Nel commentario alle Tavole facili composto ca 610-617 ed attribuito a Stefano di Alessandria la situazione egrave la seguente (Jean Lempire per litteras per lrsquoedizione si veda Lempire 2014 ho controllato il Vat gr 304 ff 135r-171v sec XIV am contiene in aggiunta Teone in Almagestum I-II lsquoPiccolo commentariorsquo alle Tavole facili Diofanto Arithmetica e De polygo-nis numeris varia astronomica tabulae) barre sopra gli interi sporadicamente rimpiazzate da apici apici sopra le parti sessagesimali in numero uguale alla denominazione doppio () apice per le frazioni unitarie Sono impiegate barre sopra gli interi e apici sopra le parti sessagesimali nei manoscritti principali di tutti i trattati di introduzione allrsquoAlmagesto o comunque di argomento logistico redatti in epoca bizantina Giorgio Pachimere (1242-ca 1310) Quadrivium (autografo nel manoscritto Roma Biblioteca Angelica gr 38 [RGK III nr 115] si veda Tannery ndash Steacutephanou 1940 per lrsquoedizione) Teodoro Metochita (1270-
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 157
mentazione si faccia testimone di un cambio notazionale avvenuto nel periodo intercorrente fra Teone (sec IV pm) e la scuola alessandrina di Ammonio e dei suoi allievi (sec VI in) e probabilmente innescato da questrsquoultimo ambiente lrsquoaspetto paradossale egrave che nello stesso codice si rintraccino due notazioni differenti per gli enti numerici sessagesimali e lrsquouna (apici) sia adottata sistematicamente e coerentemente in uno scritto (i Prolegomena) che si presenta esattamente come unrsquointroduzione tecnica alla pratica numerico-algoritmica del trattato (lrsquoAlmagesto) in cui egrave adottata lrsquoaltra (barre che ritroviamo senza eccezioni anche negli scolii)
Torniamo ai Prolegomena la descrizione del segno da porre a fianco di ogni singolo quoziente parziale e denotante la sua specie numerica (minuti primi minuti secondi ecc) solleva tre problemi
Primo problema Ci vuole una barra o un apice su τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquola lettera A [hellip] che significa la specieraquo quando lo scriviamo nella tabella Tutta la nostra discussione precedente fa pro-pendere per lrsquoapice e si ricordi anche la forma verbale ἀνατείνουσαν che suggerisce qualcosa che si lsquoestende verso lrsquoaltorsquo (la mia traduzione egrave volutamente neutra) se fosse apposta una barra la cosa dovrebbe passare
1231332) Compendium astronomicum (copia lsquoautorizzatarsquo coeva nei Vat gr 182 e 181 da parte del copista che integrograve le parti mancanti del Par gr 2389 [ff 207-210 255-270 374-375] Bianconi 2005a pp 425-427 Peacuterez Martiacuten 2008 p 436 e n 177) Teodoro Meliteniota (morto lrsquo831393) Tribiblos astronomica (autografo nel Vat gr 792 si vedano Leurquin 1991 per unrsquoanalisi del manoscritto Leurquin 1990 per lrsquoedizione) una com-pilazione anonima (per cui ho consultato il Par gr 2396 ff 87r-92v limitatamente a questi fogli manu Costantino Trivoli [RGK II nr 318 ma ovviamente questo codice non vi egrave segnalato] terzo quarto del XV secolo il resto del codice annotato da Niceforo Gregora egrave di etagrave planudea e parzialmente [ff 33v-76v] un autografo di Planude stesso contiene Teone in Almagestum I II IV Mondrain 2002 il codice va completato ndash limitatamente a stralci dei libri VIII-X XII-XIII del commentario teonino la cui parte intermedia si egrave persa ndash con 26 carte [ff 123-147] inserite nel Vat gr 1087 anchrsquoesso contenente anno-tazioni di Gregora Rome 1927 per la figura del copista dei ff 77r-86r del Par gr 2396 e dei ff appena nominati del Vat gr 1087 un anonimo collaboratore di Gregora si veda in ultimo Bianconi 2006a pp 147-151) si veda anche il calcolo effettuato da Niceforo Gre-gora (12921295-13581361) dellrsquoeclisse di sole del 16 luglio 1330 (attestata unicamente ai ff 1r-8v della miscellanea astronomica Marc gr 325 databile ca 1324-1329 in parte vergata e ovunque fittamente annotata da Gregora stesso edizione del testo in Mogenet et al 1983 annotazioni di Gregora elencate in Bianconi 2005a p 413) Unrsquoeccezione apparente il lsquoPiccolo commentariorsquo di Teone alle Tavole facili le parti sessagesimali sono segnalate da apici (ad esempio nel Vat gr 175 vergato da Giovanni Catrario e completato nel 1321-1322 sulla figura di Catrario si vedano in ultimo Bianconi 2005b pp 141-156 e 2006b) lrsquoopera egrave antica ma la sua tradizione non rimonta oltre la fine del XIII secolo a parte un frammento nel Leiden BPG 78 ff 156r-161v (minuscola del IX-X secolo) e in effetti in questo manoscritto tutti i numerali di molteplicitagrave sono sormontati da barre Unrsquoeccezione effettiva egrave il De hypotesibus planetarum nel Vat gr 1594 barre sugli interi e apici sulle parti sessagesimali
Fabio Acerbi158
sotto silenzio e la presenza dellrsquoapice la rende inutile88 Si tratta della stessa convenzione diofantea e coincide ancora con la notazione per i numerali ordinali e per le frazioni unitarie che egrave corrente nei mano- scritti matematici greci per questo motivo non percheacute la descrizione sia particolarmente perspicua nessuno dei copisti della recensione an-tica ha incertezze apici Ma questi apici si rintracciano soltanto sulle indicazioni di specie non contemplate dalla descrizione che sono ante-poste ai resti parziali a fianco dei quozienti parziali i segni di specie sono invece trasformati in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordi-nali corrispondenti del tipo πρωτ tavv 5 e 7b-8 Il recensore bizantino taglia invece la testa al toro elimina dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali elimina la seconda menzione della laquolet-tera Araquo contestualmente allrsquoazzeramento dellrsquoespediente della linea a zig-zag (si veda il punto seguente) modifica la descrizione che contiene la prima menzione in quella dellrsquoapice associato direttamente ai nume-rali di molteplicitagrave riciclando addirittura lrsquoalpha per adibirlo a desi-gnare un numero cardinale (come sorprendersi) τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ laquoponendo al di sopra di essi [scil dei 50 minuti primi] 1 solo lsaquoaccentorsaquo acutoraquo La scelta del recensore egrave assennata che rechi una barra o un apice in una tabella un alpha denota un numero non un numero drsquoordine
Secondo problema da tenere ben distinto dal precedente Cosa ci vuole sul segno α per la lettera alpha menzionata nella frase τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquolettera A [hellip] che significa la specieraquo89 Unrsquooc-chiata allrsquoapparato critico rivela una bella incertezza nei manoscritti Z scrive sempre ᾱ e in un caso lo fa anche P MS optano sempre per α´ C per α P scrive nellrsquoaltro caso αο Per quanto solo la barra sia congrua con il senso della frase in quanto la lettera alpha egrave qui menzionata (si tratta di un oggetto che compare nella tabella) e non cambia niente se essa egrave accompagnata dal suo nome di genere στοιχεῖον ad un livello grafico lrsquoincertezza fra il segno ᾱ che denota laquola lettera αraquo e il segno α´ (o lrsquoabbreviazione αο) per una forma di πρῶτος egrave per piugrave versi giustificata
88 Detto in altri termini la barra egrave uno strumento grafico non matematico e quindi la sua presenza non va segnalata mentre un apice lo egrave e la sua presenza lo deve
89 Notare che in questa frase il primo α non vuole la barra (egrave menzionato allrsquointerno di una frase che impiega convenzioni moderne) il secondo sigrave (idem ma con convenzioni antiche) ndash e nella traduzione la scelta di denotarlo con A (senza virgolette) e non con lsquoArsquo (con virgolette) egrave del tutto arbitraria ndash si noti inoltre che le necessarie precisazioni laquosenzacon virgoletteraquo mostrano che le lingue moderne palesano difficoltagrave analoghe a quelle del greco antico per quanto riguarda i livelli denotativi in ambito metadiscorsivo per non usare le due parentetiche avrei dovuto scrivere rispettivamente lsquoArsquo e lsquolsquoArsquorsquo (doppie virgolette semplici)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 159
ᾱ coincide con il numerale 1 α egrave la prima lettera dellrsquoalfabeto ed inoltre α´ egrave esattamente quello che va scritto nella tabella Potremmo dirci che il sostantivo στοιχεῖον chiude la questione la sua presenza congiunta ad un ipotetico α´ renderebbe la descrizione ridondante o inappropriata90 Ma a parte il fatto che α egrave proprio τὸ πρῶτον στοιχεῖον il segno α´ cat-tura in fondo il cuore della descrizione di uno στοιχεῖον ἔχον lsaquoγραμμὴνrsaquo ἀνατείνουσαν
Terzo problema Lrsquoautore dei Prolegomena che si arresta allrsquoesem-pio dei minuti primi non dice quanti apici occorre mettere sulle lettere numerali che identificano gli ordini superiori al primo se uno soltanto come nel caso diofanteo e delle frazioni unitarie o in numero uguale alla loro denominazione (cioegrave pari al numero denotato dal numerale stesso su cui vanno posti) come effettivamente avviene nei mano-scritti dei Prolegomena La tabella egrave quindi sottodeterminata dalla sua descrizione anzi in un certo senso prende il sopravvento su di essa la pratica di marcare i numerali di molteplicitagrave con gli apici che compe-tono allrsquoordine cui appartengono viene trasferita ai segni per gli ordini stessi per supplire ad una descrizione carente di questi ultimi E la tabella egrave sottodeterminata dalla descrizione in quanto egrave la descrizione di una tabella reale ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις laquocome nello lsaquoschemarsaquo espostoraquo leggiamo a un certo punto del testo
3) La linea a zig-zag Non possiamo che applaudire a questo geniale espediente grafico lo troviamo messo in opera solo nel Marc gr 313 Per quanto lrsquoautore non faccia parola di ciograve nel corso della sua descrizione la linea spezzata egrave intesa dover lsquosaltarersquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue Il copista del codice marciano effettua correttamente due salti nella prima delle sue tabelle (tav 4) ma inserisce un lsquodentersquo in piugrave in quella che considera corretta (tav 5) La linea a zig-zag egrave incompatibile con la presenza di linee di giustificazione nella tabella che in effetti mancano nel Marc gr 313 ciograve induce gli errori di allineamento dei primi 5 quozienti parziali di cui egrave vittima il copista Probabilmente per questo motivo in nessuno degli apografi del Vat gr 1594 la linea a zig-zag figura nella tabella inquadrata come si conviene da una (doppia) cornice esterna e le cui colonne sono appunto separate da linee verticali (tav 7b Vat gr 184 f 17v e tav 8 Par gr 2390 f 9v cui egrave sostanzialmente identica la tabella del Marc gr 314 che si trova
90 Trascuro lrsquoabbreviazione αο = πρῶτος percheacute la desinenza non egrave quella richiesta neacute nella frase (egrave richiesto πρῶτον) neacute nella tabella (πρῶτα)
Fabio Acerbi160
al f 248r ndash ma la mancanza di linee orizzontali causa un gigantesco pa-sticcio nel codice vaticano) Alla recensione bizantina che dipende per il suo testo di base dal Vat gr 1594 e quindi non trova la linea a zig-zag nella tabella non resta che sopprimere la sua descrizione ndash ma proprio per questo motivo e finalmente diventa possibile tracciare un apparato completo di linee di giustificazione (tav 9 Laur Plut 89 sup 48 f 14v) Dato che la descrizione di Teone di questo procedimento di divi-sione non fa cenno allrsquoesistenza della linea a zig-zag viene da chiedersi se essa non costituisca un espediente escogitato dallrsquoautore dei Prolegomena per vivacizzare la procedura originale di Pappo
4) Discrepanze tra descrizione e tabella Il gioco delle minime va-rianti mostra che la divisione era stata eseguita (e trasmessa) corret-tamente tutti i valori numerici sono esatti La tabella nel Marc gr 313 presenta perograve alcune discrepanze con la propria descrizione Essa omette (ma non nella versione lsquoscorrettarsquo lrsquoomissione non si riscontra neanche nel Par gr 2390) il segno per laquorestoraquo di fronte ai resti par-ziali ma aggiunge lrsquoindicazione della loro specie Essa trasforma invece come abbiamo visto le indicazioni di specie che seguono i quozienti parziali in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordinali corri-spondenti La descrizione prevede di chiudere la tabella con il risultato καὶ συνάγων ἅπαντα τὰ ἐκ τῶν μερισθέντων μερῶν λεπτὰ σημειοῦται ὑπὸ πάντας οὕτως γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoe raccogliendo tutti i minuti che provengono dalle parti divise lsaquoPapporsaquo nota sotto tutto cosigrave Ris 0 59 8 17 13 12 31raquo ma sotto la tabella tutta la tradizione ci consegna qualcosa di piugrave articolato ὁ ζητούμενος καθ᾽ ὃν μερίζεται ὁ τξε ιδ´ μη´´ π(αρὰ) τὸν τξ γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoil lsaquonumerorsaquo cercato secondo cui 365 14 48 egrave diviso per 360 risulta 0 59 8 17 13 12 31raquo frase che del resto contiene due errori lrsquoinversione del dividendo e del divisore e la confusione tra segno convenzionale (iuxta descrizione) e abbreviazione (come nella frase) nel caso di γι Oltre ad eliminare la linea a zig-zag91 la recensione bizantina sopprime dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali e modifica come abbiamo visto al punto 2 le loro descrizioni in quelle di apici associati diretta-mente ai numerali di molteplicitagrave
91 Le due righe che nella recensione di base contengono solo i resti parziali minori di 160 del divisore ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue sono in parte completate con lrsquoindicazione abbreviata ἀνάλ(υσις) laquoanalisiraquo il termine greco per questa procedura di riduzione In un sussulto di ipercorrettismo matematico tali resti parziali ridotti non sono preceduti dal segno per laquorestoraquo come nel Par gr 2390 ma da quello per laquorisultatoraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 161
Gli esempi che abbiamo discusso mostrano come i problemi di notazione pesino e non poco sullrsquoespressione discorsiva di un algorit-mo matematico lrsquoente di riferimento per lsquoformularersquo il procedimento di divisione fu considerata la tabella cioegrave un oggetto la cui costitu-zione egrave legata piugrave ad una pratica grafica che a considerazioni logico- algoritmiche non la sua descrizione che in effetti finisce per determi-nare la tabella in maniera non univoca Di questa sottodeterminazione si fa testimone la traiettoria che abbiamo cercato di seguire nelle mani di copisti e revisori il procedimento di divisione si modifica a volte in aspetti secondari a volte in punti piugrave sostanziali ndash fino a rendere neces-saria una radicale revisione della sua descrizione per renderla conforme alla tabella ndash in ogni caso mai per ragioni squisitamente matematiche92
Abstract
The article presents and discusses in detail two passages from the anonymous Prolegomena to the Almagest a VIth century primer to the elementary procedures of calculation needed in Ptolemyrsquos Almagest In the two passages we may follow the complex interplay between mathematical notation the auctor who employed and described it the tachygrapher who transcribed it in vivo copyists who reproduced it correctors who modified it Along this path misgivings and errors arise in the transmission of abbreviations and paratextual units such as diagrams tables operational schemes
Fabio AcerbiCNRS UMR8560 Centre Alexandre Koyreacute
fabacerbigmailcom
92 Sono grato a Daniele Bianconi Lucio del Corso Jean Lempire per alcune preziose indicazioni
AOO = Archimedis opera omnia cum commentariis Eutocii ed J L Heiberg I-III Lipsiae 1910-1915
DOO = Diophanti Alexandrini opera omnia cum Graecis commentariis ed P Tannery I-II Lipsiae 1893-1895
GC = Le laquoGrand Commentaireraquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Mogenet ndash A Tihon I-III Cittagrave del Vaticano 1985-1999
iA = Commentaires de Pappus et de Theacuteon drsquoAlexandrie sur lrsquoAlmageste ed A Rome I-III con paginazione continua Cittagrave del Vaticano 1931-1943
HOO = Heronis Alexandrini opera quae supersunt omnia ed G Schmidt ndash L Nix ndash W Schmidt ndash H Schoene ndash J L Heiberg I-V Lipsiae 1899-1914
PC = Le ldquoPetit Commentairerdquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed A Tihon Cittagrave del Vaticano 1978
POO = Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia ed J L Heiberg I-II in 3 parti Lipsiae 1898-1907
RGK = Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600 I Handschriften aus Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln II Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs und Nachtraumlge zu den Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln III Handschriften aus Bibliotheken Roms mit dem Vatikan A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg unter Mitarbeit von D Harlfinger und P Eleuteri B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln Wien 1981-1997 (Oumlsterreichische Akademie der Wissenschaften Veroumlffentlichungen der Kommission fuumlr Byzantinistik III1-3 A-C)
Sigla
Acerbi 2010 = F Acerbi Il silenzio delle sirene La matematica greca antica Roma 2010
Acerbi 2012 = F Acerbi I codici stilistici della matematica greca dimostrazioni procedure algoritmi laquoQUCCraquo 1012 (2012) pp 167-214
Acerbi et al 2010 = F Acerbi ndash N Vinel ndash B Vitrac Les Proleacutegomegravenes agrave lrsquoAlmageste Une eacutedition agrave partir des manuscrits les plus anciens Introduction geacuteneacuterale ndash Parties I-III laquoSCIAMVSraquo 11 (2010) pp 53-210
Agati 1992 = M L Agati La minuscola laquoBouleteacuteeraquo Cittagrave del Vaticano 1992
Belger 1881 = C Belger Ein neues Fragmentum mathematicum Bobiense laquoHermesraquo 16 (1881) pp 261-284
Bianconi 2005a = D Bianconi La biblioteca di Cora tra Massimo Planude e Niceforo Gregora Una questione di mani laquoSampTraquo 3 (2005) pp 391-438
Bianconi 2005b = D Bianconi Tessalonica nellrsquoetagrave dei Paleologi Le pratiche intellettuali nel riflesso della cultura scritta Paris 2005
Bianconi 2006a = D Bianconi Le pietre e il ponte ovvero identificazioni di mani e storia della cultura laquoBizantinisticaraquo 8 (2006) pp 135-181
Bianconi 2006b = D Bianconi Qualcosa di nuovo su Giovanni Catrario laquoMEGraquo 6 (2006) pp 69-91
Cavallo 1977 = G Cavallo Funzione e strutture della maiuscola greca tra i secoli VIII-XI in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Colloque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 95-137
Cereteli 1904 = G F Cereteli De compendiis scripturae codicum Graecorum praecipue Petropolitanorum et Mosquensium anni nota instructorum Sankt-Petersburg 1904
De Gregorio 2000 = G De Gregorio Materiali vecchi e nuovi per uno studio della minu-scola greca fra VII e IX secolo in G Prato (a cura di) I manoscritti greci tra riflessione e dibattito Atti del V Colloquio Internazionale di Paleografia Greca Cremona 4-10 ottobre 1998 Firenze 2000 pp 83-151
Follieri 1977 = E Follieri La minuscola libraria dei secoli IX e X in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Col-loque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 139-165
Fonkič 2005 = B Fonkič Venecianskaia rukopisrsquo laquoAlrsquomagestaraquo Ptolemeja (Marc gr 313690) o datirovke i proischoždenii kodeksa laquoVDIraquo s III 254 (2005) pp 162-167
Fowler 1999 = D H Fowler The Mathematics of Platorsquos Academy A New Reconstruction Second Edition Oxford 1999
Bibliografia
Fabio Acerbi164
Gerstinger ndash Vogel 1932 = H Gerstinger ndash K Vogel Eine stereometrische Aufgaben-sammlung im Papyrus Graecus [sic] Vindobonensis 19996 laquoMitteilungen aus der Papy-russammlung der Nationalbibliothek in Wienraquo Neue Serie Folge 1 Griechische literarische Papyri 1 Wien 1932 pp 11-76
Heiberg 1927 = Mathematici Graeci Minores ed J L Heiberg Kjoslashbenhavn 1927
Hultsch 1876-1878 = Pappi Alexandrini Collectionis quae supersunt ed F Hultsch I-III Berlin 1876-1878
Janz 2003 = T Janz The Scribes and the Date of the Vat gr 1291 in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae X Cittagrave del Vaticano 2003 pp 159-180
Jones 1990 = Ptolemyrsquos First Commentator ed A Jones Philadelphia 1990
Jones 1999 = Astronomical Papyri from Oxyrhynchus ed A Jones I-II Philadelphia 1999
Jones 2005 = A Jones Ptolemyrsquos Canobic Inscription and Heliodorusrsquo Observation Reports laquoSCIAMVSraquo 6 (2005) pp 53-97
Lempire 2014 = Steacutephanos drsquoAlexandrie Le commentaire aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Lempire Louvain 2014
Leurquin 1990 = Theacuteodore Meacuteliteacuteniote Tribiblos astronomique Livre I ed R Leurquin Amsterdam 1990
Leurquin 1991 = R Leurquin Un manuscrit autographe de la Tribiblos Astronomique de Theacuteodore Meacuteliteacuteniote le Vaticanus graecus 792 laquoScriptoriumraquo 45 (1991) pp 145-162
Maas 1927 = P Maas Griechische Palaeographie in A Gercke ndash E Norden (hrsg von) Einleitung in die Altertumswissenschaft I9 Leipzig 1927 pp 69-80
Martinelli Tempesta 2010 = S Martinelli Tempesta Il codice Milano Biblioteca Am-brosiana B 75 sup (gr 104) e lrsquoevoluzione della scrittura di Giovanni Scutariota in A B Garciacutea ndash I Peacuterez Martiacuten (ed by) The Legacy of Bernard de Montfaucon Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting Proceedings of the Seventh Inter-national Colloquium of Greek Palaeography Madrid-Salamanca 15-20 September 2008 Turnhout 2010 pp 171-186
Mazzucchi 1994 = C M Mazzucchi Leggere i classici durante la catastrofe (Costantino-poli maggio-agosto 1203) le note marginali al Diodoro Siculo Vaticano gr 130 Parte prima stratigrafia laquoAevumraquo 68 (1994) pp 164-218
Mioni 1976 = E Mioni Bessarione scriba e alcuni suoi collaboratori in Miscellanea marcia-na di studi bessarionei Padova 1976 pp 263-323
Mioni 1985 = Codices graeci manuscripti Bibliothecae Divi Marci Venetiarum II Thesaurus Antiquus Codices 300-625 recensuit E Mioni Roma 1985
Mogenet 1962 = J Mogenet Une scholie ineacutedite du Vat gr 1594 sur les rapports entre lrsquoastronomie arabe et Byzance laquoOsirisraquo 14 (1962) pp 198-221
Mogenet et al 1983 = Niceacutephore Greacutegoras Calcul de lrsquoeacuteclipse de soleil du 16 juillet 1330 ed J Mogenet ndash A Tihon ndash R Royez ndash A Berg Amsterdam 1983
Mondrain 2002 = B Mondrain Maxime Planude Niceacutephore Greacutegoras et Ptoleacutemeacutee laquoPa-laeoslavicaraquo 10 (2002) pp 312-322
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 165
Mondrain 2004 = B Mondrain Lrsquoancien empereur Jean VI Cantacuzegravene et ses copistes in A Rigo (a cura di) Gregorio Palamas e oltre Studi e documenti sulle controversie teologiche del XIV secolo bizantino Firenze 2004 pp 249-296
Mondrain 2007 = B Mondrain Les eacutecritures dans les manuscrits byzantins du XIV e siegravecle Quelques probleacutematiques laquoRSBNraquo n s 44 (2007) pp 157-196
Peacuterez Martiacuten 2006 = I Peacuterez Martiacuten Maxime Planude et le Diophantus Matritensis (Madrid Biblioteca Nacional ms 4678) un paradigme de la reacutecupeacuteration des textes anciens dans la ldquorenaissance paleacuteologuerdquo laquoByzantionraquo 76 (2006) pp 433-462
Peacuterez Martiacuten 2008 = I Peacuterez Martiacuten El lsquoestilo Hodegosrsquo y su proyeccioacuten en las escrituras constantinopolitanas laquoSampTraquo 6 (2008) pp 389-458
Perria 1991 = L Perria Scrittura e ornamentazione nei codici della laquocollezione filosoficaraquo laquoRSBNraquo n s 28 (1991) pp 45-111
Rollo 2012 = A Rollo LrsquoArchimede di Giorgio Valla in V Fera ndash D Gionta ndash A Rollo (a cura di) Archimede e le sue fortune Atti del Convegno di Siracusa-Messina 24-26 giugno 2008 Messina 2012 pp 99-147
Rome 1927 = A Rome Membra disjecta laquoRBenraquo 39 (1927) pp 187-188
Rome 1938 = A Rome Un manuscrit de la bibliothegraveque de Boniface VIII agrave la Meacutediceacuteenne de Florence laquoACraquo 7 (1938) pp 261-268
Ronconi 2013 = F Ronconi La collection philosophique un fantocircme historique laquoScripto-riumraquo 67 (2013) pp 119-140
Tannery ndash Steacutephanou 1940 = Quadrivium de Georges Pachymegravere ed P Tannery ndash E Steacutephanou Cittagrave del Vaticano 1940
Tihon 2011 = Πτολεμαίου Πρόχειροι Κανόνες Les Tables faciles de Ptoleacutemeacutee vol Ia Tables A1-A2 ed A Tihon Leuven 2011
Traube 1907 = L Traube Nomina Sacra Versuch einer Geschichte der christlichen Kuumlrzung Muumlnchen 1907
Vogel 1936 = K Vogel Beitraumlge zur griechischen Logistik laquoSBAWraquo Mathematisch-natur-wissenschaftliche Abteilung Jahrgang 1936 pp 357-472
Wouters 1979 = A Wouters The Grammatical Papyri from Graeco-Roman Egypt Contri-butions to the Study of the lsquoArs Grammaticarsquo in Antiquity Brussel 1979
F ACERBI Tav 1
b Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 65r
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 284 f 160r
F ACERBITav 2
b Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 13r
a Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 19v
F ACERBI Tav 3
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 136v
F ACERBITav 4
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17r
F ACERBI Tav 5
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17v
F ACERBITav 6
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 7v
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
Fabio Acerbi128
maiuscole ovviamente la tavola A egrave assente Per esempio la tavola G ha come prima riga il valore g (colonna di destra) accompagnato dalla cifra α laquo1raquo (colonna di sinistra) le altre righe hanno a sinistra i numerali da 2 a 30 e a destra i multipli corrispondenti di g il valore registrato a destra nellrsquoultima riga deve evidentemente coincidere con m In omaggio al principio delle 45 righe13 troviamo dunque una prima tavola C su 45 righe (corrispondente a un periodo di 18times45 = 810 anni avente come epoca il primo anno di regno di Nabonassar) una seconda su 42 righe che combina le 18 righe di E seguite dalle 24 di O una terza ancora su 42 righe che contiene le 12 di M seguite dalle 30 di G14 ndash nella seconda
13 διὰ τὸ φανησόμενον σύμμετρον τῆς κανονογραφίας laquoper una presentazione simme-trica del tracciato delle tavoleraquo ivi p 20914-15 allusione analoga in Alm I 10 ivi p 472-3 lrsquoabbiamo letta sottolineata nella nota 8 supra
14 Per la mise en page di queste tre tavole nei manoscritti medievali si vedano Par gr 2389 ff 69v-70r Vat gr 1594 f 63r-v (in questi due codici scritti su due colonne le tavole occupano unrsquointera pagina piugrave la prima colonna della successiva) Marc gr 313 f 98r-v (questo codice vergato a tutta pagina adotta momentaneamente una disposizione su due colonne al f 98v la prima contiene la tavola la seconda lrsquoinizio del capitolo successivo) Vat gr 180 ff 60v-61v Nelle Tavole facili dello stesso Tolomeo che passano a cicli di 25 anni e allrsquoepoca di Filippo le tavole appena descritte sono presentate con precisione ridotta rispetto a quelle dellrsquoAlmagesto nellrsquoordine C (periodo di 25times59 = 1475 anni) E (ciclo di 25 anni) M (direttamente con i nomi dei mesi del calendario egiziano mentre lrsquoAlmagesto ripartisce il parametro in multipli di 30 giorni fino a 360) G O Ogni tavola egrave suddivisa in unitagrave colonnari di non piugrave di 30 righe + titolazione La lsquotavola delle cordersquo non egrave inclusa nelle Tavole facili per le tavole del moto medio del sole e della luna nei manoscritti medievali di questrsquoopera si vedano Leiden Bibliothek der Rijksuniversiteit BPG 78 ff 91r-93v Laur Plut 2826 ff 71r-73v Vat gr 1291 ff 38r-40v Marc gr 331 ff 45r-47v ndash le parti in maiuscola di tutti questi codici contengono unicamente le Tavole facili e si datano sulla base dellrsquoultimo imperatore di cui il copista principale abbia riportato gli anni di regno nel cosid-detto canon regius nellrsquoordine Leiden BPG 78 copiato sotto il regno di Leone V 813-820 Vat gr 1291 copiato poco dopo il regno di Niceforo I 802-811 (Janz 2003) Laur Plut 2826 copiato sotto il regno di Leone VI 886-912 Marc gr 331 privo del canon regius e forse copiato anchrsquoesso sotto il regno di Leone VI si veda anche Tihon 2011 pp 19-41 per una sintesi e per ulteriori indicazioni bibliografiche Ovviamente anche le Tavole facili erano state concepite per il rotolo Tra lrsquoaltro Tolomeo sembra trascrivere nella stessa tavola i moti medi di Sole Luna Cor Leonis (la stella Regolo) e dei cinque pianeti cosa impossibile a farsi su una sola pagina di codex si legga la descrizione che ne dagrave nella parte iniziale del lsquomanuale di istruzionirsquo alle Tavole facili stesse in POO II p 1607-19 Nei manoscritti medievali questa tavola egrave smembrata poco dopo lrsquoinizio della sequenza di tavole si trovano i moti medi di Sole e Luna piugrave avanti quelli di Regolo e dei cinque pianeti Piugrave in generale il passaggio al codice comportograve una riorganizzazione delle lsquotavole facilirsquo dal piano originario in cui tutte quelle di longitudine erano molto verosimilmente raggruppate insieme e precedevano quelle di latitudine ad un ordinamento per corpi celesti (Tihon 2011 pp 12-14) Le Tavole facili furono copiate molto presto su codice i lsquopapirirsquo di questrsquoopera sono quasi unicamente su codex di pergamena (Jones 1999 I pp 102-108 e 160-168 edizione dei POxy LXI 4167-4173a contenenti frammenti delle Tavole facili ivi II pp 118-161 solo il primo di essi proviene sicuramente da un rotolo) Giagrave in pieno IV secolo Teone di Alessandria nel suo lsquoPiccolo commentariorsquo alle Tavole facili afferma che alcune di esse possono estendersi su πλειόνων πτυχίων laquopiugrave pagineraquo (PC p 2016 allinterno dellunica definizione di lsquotavolarsquo rintracciabile nel corpus antico) cosigrave le leggiamo attualmente nei manoscritti
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 129
e nella terza tavola il numero di righe egrave piugrave basso percheacute occorre pre-vedere uno spazio per il titolo addizionale Per mantenerne il formato tripartito Heiberg egrave costretto a stampare le tavole ruotate di 90ordm
Che le tavole siano dei testi egrave confermato da due fatti aggiuntivi e strettamente connessi15 Primo il lsquomanuale di istruzionirsquo alle Tavole facili che Tolomeo stesso redasse fu scritto ed ha circolato come opera a parte Secondo dalla descrizione delle tavole dettagliata ma priva di costruzione contenuta nello stesso lsquomanualersquo egrave impossibile ricavarne il contenuto numerico e la maniera drsquoimpiego16 a illustrare questrsquoultima provvederagrave una ricchissima tradizione di commentari di cui leggiamo ancora quelli di Teone il lsquoPiccolo Commentariorsquo spiega come usarle per scopi specifici il lsquoGrande Commentariorsquo come dedurle dallrsquoAlmagesto17 Le Tavole facili sono insomma unrsquoopera il cui testo egrave interamente strut-turato in formato tabulare
3) Tabelle operazionali Una lsquotabella operazionalersquo egrave una disposi-zione ordinata di lettere numerali e altri segni grafici che rappresenta lrsquoalgoritmo di unrsquooperazione aritmetica Ci troviamo in realtagrave di fronte a due modi di eseguire lrsquooperazione la tabella intende in qualche mi-sura riprodurre la dinamica operazionale dellrsquoalgoritmo questrsquoultimo si risolve a sua volta in una descrizione della tabella che senza tale de-scrizione risulterebbe incomprensibile e quindi non adattabile ad una differente operazione una tabella operazionale ha in questo caso una funzione paratestuale Si presuppone perograve che il discente apprenda a ri-produrre lrsquooperazione direttamente nel formato tabellare non in quello algoritmico In questo secondo caso una tabella operazionale assume una funzione testuale piena18 Lo statuto (para)testuale delle tabelle operazionali egrave pertanto oscillante nei commentari teonini allrsquoAlmagesto e soprattutto nei Prolegomena ad Almagestum di cui andremo ad occu-parci esse sono descritte in dettaglio e si configurano pertanto come genuini paratesti in Eutocio in Circ esse sono semplicemente eseguite e quindi assumono un ruolo testuale Nei manoscritti medievali la col-locazione di una tabella operazionale originaria egrave variabile e dipende dalle sue dimensioni e dalla capacitagrave del copista di identificarla come
15 Per un argomento ulteriore si veda la sezione 4 punto b16 POO II pp 159-18517 Nessuno dei due titoli ha fondamento nella trasmissione manoscritta la seconda
opera era detta realizzare una συμφωνία tra lrsquoAlmagesto e le Tavole facili Entrambi i com-mentari sono stati editi criticamente PC GC I-III
18 Resta il fatto che la quasi totalitagrave delle tabelle operazionali che rintracciamo nei manoscritti egrave relegata nei margini dellrsquoattivitagrave di annotazione degli scoliasti
Fabio Acerbi130
tale di solito le troviamo nei margini ma possono occupare lrsquointero specchio di scrittura e ciograve indipendentemente dalla determinazione del loro statuto paratestuale sulla base del criterio della presenzaassenza di una descrizione
Lo statuto meno elevato dei genuini paratesti (diagrammi e tabelle) rispetto ai testi (catene algoritmico-argomentative e tavole) indusse un atteggiamento differenziato in copisti ed editori attenti a rispettare lrsquointegritagrave dei secondi ma non dei primi ciograve che conta sono le informa-zioni veicolate dalle strutture discorsive e dalle porzioni alfanumeriche di diagrammi tavole e tabelle il resto egrave ritenuto adattabile alle esigenze dellrsquoedizione moderna19 o semplicemente ignorato nel corso del pro-cesso di copia in questa maniera si perdono perograve informazioni e strut-tura Come vedremo puograve avvenire che una parte della descrizione di unrsquooperazione resti senza relato nella resa grafica tabellare lrsquooperazione eseguita in forma algoritmica non corrisponde piugrave a quella eseguita in forma di tabella
3 Testi logistici e disposizione tabellare delle operazioni
Nessun testo matematico primario di etagrave ellenistica o imperiale contiene operazioni aritmetiche eseguite con una sola eccezione la de-scrizione che non ammette una rappresentazione tabellare del procedi-mento di estrazione approssimata di radice quadrata in Erone Metr I 8 Drsquoaltro canto abbiamo giagrave osservato che lrsquoAlmagesto di Tolomeo for-nisce il risultato di migliaia di operazioni ma nessuna di esse egrave eseguita Attestazioni di questi procedimenti sono pertanto legate ad iniziative editoriali di secondo livello come i commentari alla loro prima occor-renza oppure in casi paradigmatici gli algoritmi di calcolo omessi nel testo primario vi sono resi espliciti Di fatto e con una sola eccezione la nostra documentazione consiste in commentari allrsquoAlmagesto quello di Teone e i Prolegomena ad Almagestum
19 Abbiamo giagrave visto alcuni esempi di modifiche del formato delle tavole Quanto ai diagrammi quelli tracciati nelle edizioni moderne rappresentano il caso piugrave generale pos-sibile Le figure che troviamo nei manoscritti greci hanno invece la caratteristica opposta illustrano spesso casi particolari e sono metricamente scorrette Sono in effetti tracciati triangoli rettangoli isosceli cerchi uguali rette perpendicolari dove tutto ciograve non egrave richiesto dallrsquoenunciato e inoltre rettangoli invece di parallelogrammi segmenti uguali quando sia-no disuguali addirittura linee rette al posto di curve (in Archimede Meth 14 un arco di parabola egrave rappresentato da un angolo rettilineo) e in generale figure con proprietagrave di simmetria non richieste
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 131
LrsquoAlmagesto e con esso tutta la tradizione astronomica adotta il sistema sessagesimale per esprimere la parte non intera di un nu-mero che siano valori angolari o lineari non fa differenza20 come noi scriviamo 36524 e intendiamo 365 + 2 decimi + 4 centesimi (cioegrave 4102) cosigrave nel sistema sessagesimale 365 14 48 significa21 365 + 14 sessantesimi + 48 tremilaseicentesimi (cioegrave 48602) ovverosia nel lessico antico e nostro 365 14 πρῶτα λεπτά laquominuti primiraquo 48 δεύτερα λεπτά laquominuti secondiraquo dove laquoprimoraquo e laquosecondoraquo sono le laquodenominazioniraquo degli ordini (sono cioegrave numeri ordinali) 14 e 48 i lsquonumerali di molteplicitagraversquo relativi ai due ordini numerale di mol-teplicitagrave e relativa denominazione costituiscono insieme una lsquoparte sessagesimalersquo di un numero Drsquoaltronde per gli antichi come per noi lrsquoespressione di una parte non intera (ovvero di una frazione)
20 Trascuro il fatto ai nostri fini irrilevante che essendo i numerali greci lettere alfabetiche la notazione che ne risulta per i numeri interi non egrave posizionale nonostante le cifre scagravelino di un posto ad ogni potenza di dieci il segno μ per 4 (decine) non egrave identico al segno δ per 4 (unitagrave) Drsquoaltra parte una volta adottata la notazione decimale per i numerali di molteplicitagrave la notazione complessiva per la parte non intera espressa nel sistema sessa-gesimale non egrave posizionale neanche introducendo un segno di lsquoposto vuotorsquo una cui parte egrave nel caso greco analoga in forma al nostro 0 (su questo segno si veda ancora la sezione 4 punto c) occorre avvalersi di accorgimenti ulteriori quali lrsquointroduzione di spaziature fra le differenti parti sessagesimali (come viene fatto nei manoscritti greci ed in questrsquoarticolo) o di segni tipografici (come suggerito da Otto Neugebauer che avrebbe scritto 3651448 il numerale che leggeremo tra un attimo nel testo) Il problema egrave che altrimenti lrsquoordine associato ad un numerale di molteplicitagrave di una parte sessagesimale puograve non risultare uni-vocamente determinato dalla sua posizione Esempio scrivendo 0129 per un numero non intero nel sistema sessagesimale il numerale di molteplicitagrave 129 potrebbe rappresentare 1 minuto primo e 29 secondi oppure 12 minuti primi e 9 secondi ecc e la stessa difficoltagrave si presenta nella notazione greca (per la nozione di lsquonumerale di molteplicitagraversquo si veda infra nel testo) Il problema scomparirebbe se adottassimo singoli segni differenti per tutti i nu-merali da 1 a 59 ndash ma neacute noi neacute i greci siamo stati disposti a introdurre una complicazione siffatta Si ricordi infine che al di fuori dei contesti astronomici il sistema di numerazione greco egrave decimale
21 Scriverograve i numerali in cifre arabe sempre in questo modo parte intera seguita dalle parti sessagesimali (minuti primi secondi ecc) con ogni ordine separato da uno spazio bianco Se la parte intera egrave assente il numerale inzia con uno 0 Nella trascrizione dei numerali in greco ogni numerale di molteplicitagrave sessagesimale o frazione unitaria saragrave identificato come nei manoscritti piugrave antichi dei Prolegomena da un opportuno numero di apici (uno per ogni unitagrave dellrsquoordine avendo le frazioni unitarie un solo apice come vedremo nellrsquoAlmagesto contenuto negli stessi codici troviamo barre non apici con questa funzione) mentre la parte intera saragrave priva della barra che la sormonta invariabilmente nei manoscritti In questo modo 365 14 48 egrave la conversione in cifre arabe di τξε ιδ´ μη´´ La pratica dei manoscritti medievali egrave di collocare gli apici (quando presenti) sopra le lettere numerali per ragioni tipografiche li porrograve di seacuteguito al gruppo di lettere cui si riferiscono Si noti che nella notazione greca il segno ιδ´ per 1460 in sessagesimale egrave identico a quello per 114 in decimale Nel caso delle frazioni unitarie la presenza dellrsquo(unico) apice egrave la traduzione semiotica della trasformazione che a livello grammaticale egrave effettuata con il pas-saggio dal cardinale allrsquoordinale (ad esempio da τὰ τρία laquotreraquo a τὸ τρίτον laquoun terzoraquo) si veda anche la sezione 4 punto 1 e note 82 e 86 ivi incluse
Fabio Acerbi132
richiede sempre lrsquointroduzione di due numerali il lsquonumeratorersquo e il lsquodenominatorersquo
Il motivo della scelta del sistema sessagesimale che fu mutuato dallrsquoastronomia matematica babilonese egrave presto detto lrsquoelevato numero di divisori di 60 e cioegrave 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 Poicheacute i divi-sori di 10 sono un sottinsieme di quelli di 60 molti piugrave numeri hanno una rappresentazione finita nel sistema sessagesimale che in quello deci-male Calcolare in sessagesimale lungi dal creare difficoltagrave offre quindi un vantaggio cruciale22 che risulta piugrave facilmente comprensibile sulla base dellrsquoesempio seguente La lunghezza dellrsquoanno solare egrave stabilita da Tolomeo in 365 giorni + 14 ndash 1300 di giorno Per calcolare il moto giornaliero del sole si rende necessario dividere 360 per questo numero Noi avremmo due opzioni se non potessimo usare la calcolatrice ri-durre il divisore ad una singola frazione tramite passaggio al denomi-natore comune invertire questa frazione e moltiplicarla per 360 sem-plificare gli eventuali fattori comuni e finalmente eseguire la divisione a piugrave cifre tra numeri interi (nel nostro caso 5400054787) oppure scrivere il divisore come numero decimale periodico (365246666 hellip) e poi eseguire la divisione Nel sistema sessagesimale egrave tutto molto piugrave semplice 365 + 14 ndash 1300 ha una rappresentazione finita cioegrave 365 14 48 come eseguire la divisione lo vedremo tra un attimo
Passiamo dunque in rassegna il contenuto del lsquomanuale di logisticarsquo incluso nei Prolegomena ad Almagestum riportando in nota per ogni item anche esposizioni parallele in altri commentatori23
a) Costruzione del sistema sessagesimale24
22 E uno svantaggio se le molteplicitagrave dei singoli ordini vengono espresse in no-tazione decimale (come facciamo noi e facevano i greci) il numero di cifre necessario per raggiungere una precisione assegnata egrave maggiore nel sistema sessagesimale in quanto per esprimere i numerali da 10 a 59 occorrono due cifre mentre per quelli da 1 a 9 (o da α a θ e le decine da ι a ν nel caso greco) ne basta una e ciograve indipendentemente dal fatto che la notazione sia posizionale oppure no La differenza si fa perograve sentire solo a partire dal quinto ordine sessagesimale
23 Trascuro la parte finale del lsquomanualersquo dove sono esposte le regole di interpolazione (cui era legata la lsquoterza colonnarsquo della tavola delle corde tolemaica) e il procedimento di lsquosottrazionersquo di rapporti cioegrave la divisione di un rapporto per un altro
24 Per a-b cf Teone in Alm I 10 in iA pp 44919-45814 PC pp 2007-2014 GC I pp 10910-11124 e le definizioni e regole diofantee di manipolazione delle varie specie numeriche in Arithmetica prefazione in DOO I pp 214-1218 Le porzioni a-b sono giagrave state pubblicate da Paul Tannery in DOO II pp 318-1517 sulla base del Par gr 453 apografo ad opera di Giovanni Santamaura di un Vat gr 1594 giagrave mutilo (RGK II nr 238 ma lrsquoautore trascritto vi egrave indicato come lsquoPtolemaiosrsquo) Evidentemente il committente non fu soddisfatto della prima trascrizione (ff 67-76) che crivella di tratti rossi a segnalarne gli errori di copia Ne fu dunque eseguita una seconda (ff 78-86) cui Santamaura antepose
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 133
b) Regole di moltiplicazione e divisione degli ordini sessagesimali defini-zione generale di moltiplicazione moltiplicazione di ordini come somma delle loro laquodenominazioniraquo Definizione generale di divisione divisione di ordini uguali e di un ordine per quello che lo precede immediata-mente divisione di ordini come sottrazione delle loro laquodenominazioniraquo divisione per 60 come divisione per 1 accompagnata dallo slittamento di un posto dellrsquoordine
c) Problemi che sorgono nella divisione di una parte sessagesimale per una di quelle che seguono divisione breve per riduzione allo stesso ordine (metodo laquoper analisiraquo) due algoritmi differenti il secondo con riduzione dei fattori comuni attribuito a Siriano
d) laquoAltroraquo metodo di divisione breve in realtagrave divisione tra somme di parti sessagesimali appartenenti ad ordini differenti per riduzione allo stesso ordine e applicazione dei metodi precedenti esempio della divisione di 0 2 0 4 per 0 0 2 0 240
e) Metodo di moltiplicazione tra numeri con parti non intere disposizione tabellare dei termini esempio della moltiplicazione di 5 4 6 per 8 0 3 0 525
f ) Primo metodo di divisione lunga descrizione della disposizione tabellare ed esempio di algoritmo applicato alla divisione di 50 48 26 30 per 8 16 28 5426
g) Metodo di divisione lunga tratto da Pappo in Alm III descrizione della disposizione tabellare ed esempio di algoritmo applicato alla divisione di 360 per 365 14 48 come verifica del valore 0 59 8 17 13 12 31 fornito nellrsquoAlmagesto per il moto medio giornaliero del sole27
h) Metodo di approssimazione di una radice quadrata secondo Erone Metr I 8 con giustificazione geometrica di Teone (attualmente non attestata in suoi scritti)
i) Verifica tramite moltiplicazione della correttezza del valore tolemaico28 di 67 4 55 come radice quadrata approssimata di 4500 Metodo di estrazio-ne di radici quadrate secondo Teone basato su applicazioni successive di Elementi II 4 la procedura termina dopo un numero finito di passi nel caso di quadrati perfetti Applicazione al calcolo della radice quadrata di 450029
unrsquoannotazione spazientita laquoIl texto di questo 2do quinterno egrave stato recopiato fidelmente dallrsquooriginale a chi volesse vedere la prova lo potragrave conferire con detto originale le pagine del qual texto corrispondono con quelle dellrsquooriginale tanti versi che pagine [hellip]raquo (Moge-net 1962 p 200)
25 Teone in Alm I 10 e I 14 in iA pp 45815-4604 e 57911-5811026 Teone in Alm I 10 in iA pp 4611-46217 applicato alla divisione di 1515 20
15 per 25 12 1027 Teone in Alm III 1 e IV 3 in iA pp 84112-84422 (stesso calcolo dei Prolego-
mena) e 102916-10327 idem in Alm IX pp 377-378 dellrsquoedizione di Basilea del 1538 approntata dai tipografi di Walderus Lrsquooriginale pappiano non ci egrave pervenuto
28 Alm I 10 in POO I 1 p 341129 Teone in Alm I 10 in iA pp 46916-4738
Fabio Acerbi134
Lrsquounico testo non elencato qui sopra o nelle note e che contenga tabelle operazionali egrave il commentario eutociano a Circ 3-4 Il testo ar-chimedeo che Eutocio e noi con lui leggeva egrave particolarmente conciso ed egli verifica esplicitamente il sussistere di certe relazioni numeriche Si tratta in ognuno dei nove casi presenti di mostrare che il lsquoteorema di Pitagorarsquo egrave verificato con ottima approssimazione dai valori numerici di opportune terne di rette Eutocio esegue le tre moltiplicazioni dei valori per se stessi e mostra che la somma o la differenza di due dei risultati si discosta di poco dal terzo30 I numeri in questione sono interi seguiti o no da una parte non intera espressa come somma di frazioni unita-rie31 I nove gruppi di tre moltiplicazioni una a fianco allrsquoaltra sono organizzati in forma tabellare ma senza lrsquoausilio di linee separatrici32 le operazioni sono eseguite disponendo lsquoin colonnarsquo i risultati delle mol-tiplicazioni parziali e sommandoli esattamente come facciamo oggi poicheacute sono in gioco numeri interi con parti frazionarie unitarie e la notazione non egrave posizionale non egrave necessario che gli incolonnamenti siano esatti (unitagrave di un risultato parziale sotto le decine del precedente ecc) Sono inclusi nella tabella istruzioni e commenti in linguaggio corrente33 le prime relative allrsquooperazione da affettuare sui risultati delle
30 Eutocio non calcola radici quadrate approssimate per quanto ciograve si renda piugrave volte necessario fornisce il risultato e verifica la sua correttezza moltiplicandolo per se stesso Egli dichiara che il lettore interessato a questo procedimento di calcolo puograve rivolgersi Ἥρωνι ἐν τοῖς μετρικοῖς [hellip] Πάππῳ καὶ Θέωνι καὶ ἑτέροις πλείοσιν ἐξηγουμένοις τὴν μεγάλην σύνταξιν τοῦ Κλαυδίου Πτολεμαίου laquoa Erone nei Metrica [hellip] a Pappo e Teone e a svariati altri inter-preti della Grande composizione di Claudio Tolomeoraquo (AOO III p 23213-17)
31 Troviamo ad esempio ͵αωλη θ´ ια´ cioegrave 1838 + 19 + 111 notare il singolo apice per le frazioni unitarie
32 Essi sono editi in AOO III pp 234-256 La tradizione medievale del commentario eutociano che coincide con un ramo di quella archimedea e deriva da un codice appar-tenuto a Giorgio Valla perduto in etagrave rinascimentale ma riprodotto a volte con fedeltagrave assoluta negli apografi (si veda ad esempio nella tav 1a la riproduzione dellrsquoerronea di-sposizione di cifre e parte algoritmica nel primo gruppo di moltiplicazioni offerta dal Laur Plut 284 f 160r) egrave costituita da Marc gr 305 ff 142v-146v Laur Plut 284 ff 159r-164r Par gr 2360 ff 109v-113v Par gr 2361 pp 410-421 Nel codice veneziano in cui la disposizione per righe e colonne egrave irrimediabilmente alterata dal copista le operazioni sono cancellate con tratti di penna Il primo manoscritto fu esemplato per Bessarione da Giorgio Trivizias tra il 1455 e il 1468 (Mioni 1976 pp 309-312) il secondo fu vergato da Giovanni Scutariota in scrittura di imitazione (Martinelli Tempesta 2010 p 173 n 7 Rollo 2012) ca 1491-1492 il terzo fu trascritto per il cardinale di Firenze Niccolograve Ridolfi dopo che la biblioteca di Valla era stata acquistata a seacuteguito della sua morte avve-nuta il 23 gennaio 1500 per 800 scudi drsquooro da Alberto Pio di Carpi (nota del copista al f 120v) il quarto fu terminato per mano di Christopher Auer su commissione di Georges drsquoArmagnac il primo gennaio 1544 (sottoscrizione a p 474 del codice si veda RGK II nr 525)
33 A questi va aggiunto posto davanti al risultato finale di ogni moltiplicazione il segno convenzionale per ὁμοῦ laquoinsiemeraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 135
prime due moltiplicazioni34 i secondi alla bontagrave dellrsquoapprossimazione ottenuta35 Ogni gruppo di operazioni che chiude unrsquounitagrave esegetica ed egrave seguito dalla citazione che apre la successiva egrave trascritto come se facesse parte del testo a tutta pagina e preceduto dallrsquoindicazione οἱ δὲ πολλαπλασιασμοὶ ὑπόκεινται laquole moltiplicazioni sono poste qui sottoraquo Questi due fatti suggeriscono che tutte le operazioni cui Eutocio non fa alcun riferimento nel corpo del suo commentario siano unrsquoaggiunta editoriale risalente a Isidoro di Mileto che si occupograve della revisione del testo36
Gli incolonnamenti esatti sono invece necessari quando siano moltiplicati numeri con parti non intere espresse nel sistema sessage-simale in quanto la somma finale dei prodotti parziali va effettuata ordine per ordine Tale somma eccederagrave di norma il valore di 60 per un ordine dato nella tabella occorre pertanto trovare posto anche per i riporti che vanno sommati ai prodotti parziali dellrsquoordine preceden-te e quindi incolonnati con essi I testi ci offrono alcuni esempi di tabelle operazionali moltiplicative di questo tipo Teone afferma espli-citamente che la prima moltiplicazione che va a descrivere ha una rap-presentazione tabellare la cui disposizione ritroviamo pesantemente ingarbugliata nel Laur Plut 2818 f 35r37 Alla seconda occorrenza di una moltiplicazione eseguita (tav 1b Laur Plut 2818 f 65r) gli incolonnamenti sono meglio rispettati anche se il risultato finale egrave fatto erroneamente slittare di un posto verso destra i riporti (con un errore) si trovano nella penultima riga38 Nei Prolegomena ad Alma-gestum alcune moltiplicazioni sono accompagnate da tabelle quella meglio attestata egrave associata alla moltiplicazione di 67 4 55 per se stesso (sezione i nel riassunto fornito supra) ed egrave descritta additando sempli-cemente ad un ente materiale oramai inaccessibile forse tracciato in loquendo lsquoalla lavagnarsquo
34 Come λοιπὸν τὸ ἀπὸ ΕΓ laquoresta quello su ΕΓraquo seguito dal risultato della sottrazione di due quadrati
35 Come λείπει ἄρα μο β εἰς τὸ ἀκριβές laquomancano quindi 2 u(nitagrave) al risultato esattoraquo36 Si legga la sottoscrizione spuria ad AOO III p 26010-1237 Si legga la frase ἐκτίθεμαι αὐτὴν καὶ πάλιν αὐτὴν ὑφ᾽ αὑτὴν ὡς ὑπογέγραπται laquolo [scil il
valore del lato da moltiplicare per se stesso] dispongo lsaquouna voltarsaquo e di nuovo al sotto di se stesso come trascritto qui sottoraquo in iA p 45817 Il Laur Plut 2818 (Teone e Pappo Commentaria in Almagestum) egrave uno dei piugrave antichi manoscritti in minuscola sicuramente assegnabile alla prima metagrave del IX secolo (Follieri 1977 p 144 n 23 Maas 1927 p 76 n 17 riteneva che fosse piugrave antico del Tetraevangelo Uspenskij) per una sua analisi si veda Rome 1938
38 In nessuno dei due casi i numerali di molteplicitagrave sono segnalati con apici sono tutti sormontati da una barra si veda la sezione 4 punto b
Fabio Acerbi136
προκείσθω δὶς τὸ μῆκος αὐτῆς ὀφεῖλον τὴν τάξιν τοῦ κατὰ τοὺς πολλαπλασιασμοὺς κανόνος ἀποδοῦναι καὶ ἐκκείσθω ἐπὶ σελιδίων διαγεγραμμένων οὕτω καὶ δὴ αὐτῆς ἐφ᾽ ἑαυτὴν πολ-λαπλασιασθείσης γεγονέτωσαν τὰ ἐν τοῖς οἰκείοις σελιδίοις εἴδη ταῦτα δὴ συναγόμενα καθ᾽ ἣν ὑπεδείξαμεν τάξιν ποιήσει τὰς ὑπογεγραμμένας μοίρας ἢ καὶ λεπτά τινα εἴσι ͵δυϙθ νθ´ ιδ´´ ι´´´ κε´´´´ ὡς λείπειν τοῦ ἐπιμερισθῆναι ŏ ŏ με´´ μθ´´´ λε´´´´
che sia prescritto che la sua lunghezza debba figurare due volte nella disposizione della tavola delle moltiplicazioni e che lsaquoquestrsquoultimarsaquo sia disposta su colonne delimitate da linee cosigrave mdash E pertanto una volta moltiplicato lsaquoil latorsaquo per se stesso che le specie trovino posto nelle colonne appropriate quelle che vengono cosigrave raccolte secondo la disposizione che abbiamo indicato produrranno dunque i gradi o anche i minuti qui sotto trascritti 4499 59 14 10 25 in modo che dalle divisioni successive resti39 0 0 45 49 35
La tabella associata (tav 2a Marc gr 313 f 19v) contiene una sola svista grossolana reca 51 invece di 55 in ognuno dei due fattori posti affiancati sopra di essa Al di sotto preceduto dal segno convenzionale per ὁμοῦ egrave collocato il risultato incongruamente sfalsato di un paio di colonne e con la lettera numerale ͵δ priva di barra sormontante in-naturalmente disconnessa da υϙθ I riporti sono indicati dai numerali ι ρκγ´ η´´ ν´´´ posti al fondo delle prime quattro colonne Il calcolo egrave corretto in ogni sua parte
Il clou in questo piccolo spaccato delle interazioni testo-paratesto matematico risiede nella descrizione contenuta nei Prolegomena della disposizione tabellare di due procedimenti di divisione il primo ano-nimo e quindi da supporre tradizionale il secondo piugrave efficiente ed attribuito al matematico del IV secolo Pappo
Il primo metodo di divisione egrave sostanzialmente analogo a quello che usiamo attualmente Dividendo e divisore questrsquoultimo preceduto da un segno su cui ritorneremo nella prossima sezione sono posti uno sotto lrsquoaltro intervallati da una riga inizialmente vuota Primo passo viene reperito il massimo multiplo del divisore che sia minore del di-videndo esso viene trascritto sotto il dividendo nella prima lsquocasellarsquo della riga vuota recante in testa un segno per laquosottrairaquo il fattore mol-tiplicativo (o quoziente parziale) viene trascritto in una lsquocasellarsquo pre-ceduta da un segno per laquorisultaraquo sotto il divisore Secondo passo il massimo multiplo viene sottratto dal dividendo il resto cosigrave ottenuto egrave trascritto preceduto da un segno per laquorestoraquo in una casella posta
39 Lrsquoautore concettualizza il procedimento di estrazione di radice quadrata come una forma di divisione
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 137
accanto al dividendo40 I due passi precedenti sono quindi ripetuti con la sola differenza che il resto appena ottenuto prende il posto del divi-dendo il quoziente parziale scala di un ordine sessagesimale ad ogni passo41 E cosigrave via aggiungendo ogni volta due caselle La debolezza di questo metodo come di quello che utilizziamo attualmente risiede nel fatto che il reperimento dei quozienti parziali (ovverosia dei massimi multipli) viene effettuato per tentativi non riuscire a farlo al primo colpo appesantisce notevolmente i calcoli successivi e costringe ad un lavoro di riordino e addizione dei quozienti parziali stessi La tabella risultante dove appunto osserviamo questo fenomeno in parallelo con identiche inaccuratezze nella descrizione ha la forma riprodotta unico tra i manoscritti della recensione antica nel Marc gr 313 f 13r (tav 2b invito il lettore a non rivolgersi alle tavole se non dopo aver termi-nato questa sezione sarebbe anzi auspicabile che tentasse di ricostruire questa tabella e le due successive a partire dalla mia descrizione)42
Il secondo metodo di divisione attribuito a Pappo egrave congegnato in modo da rendere non aleatoria la ricerca dei quozienti parziali Come altrove nei Prolegomena la descrizione della procedura di calcolo si riag-gancia esplicitamente a una frase di Tolomeo laquouna volta dimostrato che il periodo di una singola rivoluzione lsaquodel solersaquo egrave di 365 giorni 14 48 se di-vidiamo per essi i 360 gradi di un singolo cerchio avremo il moto medio giornaliero del sole circa 0 gradi 59 8 17 13 12 31raquo43 Questrsquoaffermazione si trova nel terzo libro dellrsquoAlmagesto si tratta della prima occasione in cui viene effettuata una divisione in cui il divisore egrave maggiore del dividendo e i commentatori del trattato tolemaico non si fecero sfuggire lrsquooccasione di mostrare come eseguirla Ora il terzo libro del commentario di Pappo non ci egrave pervenuto Ci resta dunque come testo parallelo a quello dei Prolegomena la descrizione rigidamente formulare in Teone sicuramente un calco di quella pappiana Teone qui come nelle altre applicazioni del metodo (Laur Plut 2818 ff 136v [tav 3] e 190r) descrive brevemente ed espone esplicitamente la stessa tavola dei sottomultipli del divisore che
40 Esempio nella divisione di 378 per 17 il massimo multiplo egrave 374 il quoziente parziale egrave 22 il resto 4 e in effetti 378 = 374 + 4 = 17times22 + 4 Si noti che il segno per laquorestoraquo non egrave apposto in testa di riga ma davanti a ogni resto parziale e in effetti il dividendo che si trova in prima posizione in questa riga non egrave un resto
41 Analogamente nellrsquoalgoritmo moderno poniamo la virgola o scaliamo la cifra di un posto
42 Nei Prolegomena la descrizione della tabella associata al metodo anonimo egrave pre-ceduta da una breve sinossi dellrsquooperazione in stile procedurale (cioegrave senza riferimenti alla tabella) e seguita dalla sua esecuzione accurata ma con pochi riferimenti alla tabella se non quello ai due segni da apporre ai resti parziali e ai massimi multipli
43 Alm III 1 in POO I 1 p 2091-4
Fabio Acerbi138
troviamo nei Prolegomena ma non offre alcuna descrizione della disposi-zione tabellare della divisione stessa neacute vi fa riferimento
A questa procedura sono in effetti associate una tavola e una tabel-la costruite come segue (tavv 4 e 5 Marc gr 313 ff 17r e 17v il co-pista era ndash giustamente ndash insoddisfatto della prima versione) La tavola le cui righe e colonne sono delimitate da linee contiene sottomultipli44 del divisore 365 14 48 9 righe che riportano i valori da 160 a 960 piugrave altre 6 con i valori per decine da 1060 a 6060 la prima colonna elenca le 15 parti sessagesimali omettendo come drsquoabitudine la laquodenomina-zioneraquo dellrsquoordine (i numerali elencati sono quindi α β γ δ ε ϛ ζ η θ ι κ λ μ ν ξ) la seconda i sottomultipli corrispondenti organizzati su quattro colonne per tener conto dei tre ordini sessagesimali (il primo sottomultiplo egrave quindi ϛ ε´ ιδ´´ μη´´´ cioegrave 160 di τξε ιδ´ μη´´) La tabella priva di linee delimitanti espone la vera divisione Nella prima colonna troviamo i resti parziali ognuno preceduto dallrsquoindicazione del proprio ordine sessagesimale e da un segno per laquorestoraquo Nella seconda preceduti da un segno per laquosottrairaquo i sottraendi ognuno coincide ovviamente con uno dei sottomultipli nella tavola La terza colonna contiene se-guiti dallrsquoindicazione del proprio ordine sessagesimale i quozienti par-ziali ottenuti trascrivendo dalla prima riga della tavola il numerale corrispondente al sottraendo affiancato ed assegnando come ordine sessagesimale il successivo a quello posto in testa di riga Il risultato preceduto da un segno per laquorisultaraquo e posto al di sotto della tabella si ottiene sommando i quozienti parziali il procedimento non permette in generale di determinare lrsquointero quoziente parziale relativo ad un ordine sessagesimale fissato se non dopo due passi Una linea spezzata unisce i resti parziali successivi e i relativi sottraendi per evidenziare la laquoprogressione della proceduraraquo la spezzata lsquosaltarsquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore (le cui righe sono per il resto vuote) e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue di conseguenza anche il quoziente parziale relativo a questo resto appartiene allrsquoordine sessagesimale successivo
A questo punto possiamo rivolgerci alle tavv 4-5 e verificare se le immagini che ci siamo formati sulla base della mia descrizione corri-spondono a quelle che troviamo nel Marc gr 313 Non si tratta di un giochetto sterile egrave al contrario il cuore di un intrico di problemi Un primo ordine di problemi deriva dal fatto che nei Prolegomena lrsquoalgo-
44 Sottomultipli e non multipli in quanto il divisore egrave maggiore del dividendo Drsquoaltronde nel sistema sessagesimale come in quello decimale un sottomultiplo si ottiene dal multiplo corrispondente semplicemente scalando tutte le cifre di un posto (ad esempio 1360 di 365 14 48 si ottiene in questa maniera da 13 volte 365 14 48)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 139
ritmo della divisione lsquoalla Papporsquo non egrave mai eseguito (cioegrave formulato verbalmente) in maniera indipendente dalla descrizione della tabella Comrsquoegrave dunque possibile descrivere una tabella operazionale che non ha uno statuto testuale indipendente sulla base di un algoritmo in corso di esecuzione E drsquoaltro canto come non rilevare unrsquoanomalia in un algoritmo eseguito nella sua forma primaria sotto forma di descrizione di una tabella Ci potremmo chiedere se viene descritto lrsquoalgoritmo o la tabella La tensione fra i due enti grafici egrave acuita dal fatto che nei nostri testi tutto ciograve (esposizione o descrizione di un algoritmo o della tabella associata) avviene sempre e solo sulla base di un esempio numerico para-digmatico Per questo motivo la tabella in quanto struttura (cioegrave privata dei dati numerici accidentali) non puograve fare a meno della descrizione45 Dal canto suo Teone come forse Pappo ancor prima descrive ed espone la tavola dei (sotto)multipli ma non la tabella di divisione lrsquoalgoritmo relativo a questrsquoultima egrave espresso come per controbilanciare in maniera eccezionalmente trasparente e formulare Se ciograve comporta un guada-gno a livello verbale-argomentativo sorge un problema operativo grave come e dove sistemare i resti e i quozienti parziali ndash cioegrave tutti i numeri in output dellrsquoalgoritmo differenti dai (sotto)multipli ndash che la tabella si incarica di disporre in modo lsquonaturalersquo Teone prescrive soltanto di confrontare i resti con la seconda colonna della tavola dei sottomultipli e di trascrivere via via il quoziente ottenuto dopo ogni passo Insomma come eseguire materialmente una divisione Non certo adattando ad un nuovo caso specifico la formulazione dellrsquoalgoritmo che Teone propone
Un secondo ordine di problemi e una trappola micidiale per il co-pista egrave interno alla dialettica lsquotabellarsquolsquosua descrizionersquo ed egrave in assenza di simbolismo quello dei riferimenti linguistici da adottarsi nella seconda agli enti grafici che figurano nella prima Occorre ricercare la massima generalitagrave fornita da una descrizione definita di un ente numerico (ad esempio impiegando il termine laquorestoraquo o la perifrasi laquomassimo sotto-multiplo minoranteraquo) o basta assumere direttamente il suo valore speci-fico come esempio paradigmatico E in che modo risolvere il conflitto tra uso e menzione se come nel nostro caso la tabella contiene segni convenzionali ed occorre fornirne una descrizione Si rende ad esempio necessario introdurre un lsquooperatore di citazionersquo noi useremmo le virgo-lette la lingua greca premette lrsquoarticolo neutro Drsquoaccordo ma nel caso
45 Questa caratteristica non egrave connaturata alla matematica degli algoritmi la risorsa dello lsquostile proceduralersquo serve esattamente ad aggirare questo problema al di lagrave di un certo livello di dettaglio perograve essa condurrebbe ad un appesantimento insostenibile della for-mulazione dovuto alla pluralitagrave dei riferimenti agli oggetti matematici in gioco sulla que-stione dei diversi stili della matematica greca si veda Acerbi 2012
Fabio Acerbi140
greco qual egrave il suo range E come distinguerlo nei casi ambigui da un semplice articolo che precede un sostantivo quando questrsquoultimo lo ri-chieda Nel corso del processo di copia del testo della descrizione infine possono generarsi tensioni tra enti grafici interpretabili vuoi come segno convenzionale vuoi come abbreviazione Ambiguitagrave relative a questi punti opacizzano la descrizione Un problema analogo si porrebbe a priori nella dialettica tra uso delle lettere denotative per designare enti geometrici e loro menzione nella costruzione di un diagramma ma esso egrave risolto con lrsquoazzeramento della seconda funzione le lettere denota-tive sono sempre usate allrsquointerno del testo (sono cioegrave il referente degli oggetti geometrici di cui tratta il discorso matematico) mai menzionate (come accadrebbe se fossero il referente di oggetti grafici posti nel dia-gramma) Insomma il codice adottato per la costituzione dei diagrammi geometrici egrave condiviso (cioegrave canonizzato) semplice e perspicuo mentre quello per le tabelle operazionali non lo egrave da qui le sviste dei copisti e le trascuratezze di correttori ed editori
Infine chi vuole apprendere da questi testi come eseguire una divi-sione a cosa deve prestar fede se ad esempio a causa di errori di copia la descrizione finisce per non coincidere con la tabella operazionale visto che sono entrambe due maniere valide di eseguire lo stesso algoritmo Dopo tutto lo scopo di tutta questa macchina grafico-argomentativa egrave di insegnare a eseguire divisioni in formato tabellare Questo problema si fa particolarmente acuto se la tabella non egrave trasparente nel metodo di Pappo lo egrave quasi completamente in quello anonimo no E gli errori che riscontreremo nella (doppia) tabella ai ff 17r-v del Marc gr 313 a chi sono attribuibili Allrsquoautore al trascrittore o al copista medievale
Questo groviglio di problemi riceve alcune risposte sorprendenti dalla tradizione manoscritta come andiamo finalmente a vedere
4 Analisi delle testimonianze
I codici che ho adibito per lrsquoedizione sono i seguenti M = Marc gr 31346 C = Marc gr 314 (Tolomeo Tetrabiblos et opera minora cum commentariis Vezio Valente Anthologiae)47 Z = Vat gr 2326 (fattizio
46 Riferibile al sec IX ex-X in accolgo la datazione suggeritami per litteras il 522005 da Nigel G Wilson si veda anche Agati 1992 pp 141-142 La presenza non sistematica degli accenti che fa anticipare a Wilson la datazione di laquosaec X medraquo fornita in Mioni 1985 p 24 indusse Boris Fonkič (2005 non vidi) ad assegnare il codice allrsquoinizio del IX secolo
47 Il manoscritto riferibile alla seconda o terza decade della prima metagrave del XIV secolo fu vergato da Michele Clostomalle olim lsquoMetochitesschreiberrsquo Bianconi 2005a pp 428-430 Il titolo dei Prolegomena in questa trascrizione identico in grafia ma non in formulazione a
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 141
e mutilo Tolomeo Almagestum) S = Vat gr 184 (varia astronomica scholia miscellanea ad Almagestum Tolomeo Almagestum) P = Par gr 2390 (varia astronomica) gli ultimi tre riferibili allo scorcio del XIII secolo48 e apografi sicuri del Vat gr 159449 attualmente mutilo di due fascicoli che ci privano dei due terzi finali dei Prolegomena M e il Vat gr 1594 ammettono un modello comune il resto della tradizione (25 trascrizioni in tutto) dipende dagli apografi appena citati del Vat gr 1594 Le varianti della recensione bizantina che leggiamo tra lrsquoaltro nei Vat gr 198 Marc gr 310 (Tolomeo Almagestum cum commentariis Pappi Theonis et Cabasilae) e con ulteriori modifiche Laur Plut 89 sup 48 (varia astronomica Tolomeo Almagestum Barlaam Logistica) sono identificate dal siglum K e si trovano punteggiatura originale in-clusa nel secondo apparato50 Lrsquoanalisi delle testimonianze51 costituite ovviamente anche dalle tabelle associate saragrave condotta nella forma di una sequenza di osservazioni indicizzate da numerali o lettere oltre che di alcune note a piersquo di pagina
Iniziamo dalla descrizione del metodo di divisione anonimo
quello che leggiamo nel Vat gr 1594 (questrsquoultimo coincide con quello adottato nella recen-sione bizantina) fu apposto da Niceforo Gregora e successivamente corretto da Bessarione
48 Sto studiando il primo e il terzo codice in collaborazione rispettivamente con Daniele Bianconi e Inmaculada Peacuterez Martiacuten
49 Su questo codice risalente alla seconda metagrave del IX secolo e sulla sua collocazione nella lsquocollezione filosoficarsquo per prima proposta in Follieri 1977 pp 145-146 si vedano almeno Perria 1991 pp 82-88 Ronconi 2013 Che il titolo dei Prolegomena nel Vat gr 1594 sia stato apposto da Niceforo Gregora egrave stato riconosciuto per la prima volta in Mazzucchi 1994 p 211 n 196 si veda Bianconi 2005a p 418 per altri interventi di Gregora nello stesso manoscritto
50 Il Vat gr 198 egrave stato vergato dal copista Malachia nel corso del terzo quarto del XIV secolo Mondrain 2004 pp 278-290 e 292 Allo stesso copista (denominato non a caso prima dellrsquoidentificazione anonymus Aristotelicus) dobbiamo un buon numero di trascrizioni aristoteliche con i relativi commentari in margine Gli dobbiamo anche il Par gr 2342 secondo tomo di un quadrivium quasi completo di cui il Vat gr 198 egrave il primo nellrsquoordine aritmetica armonica astronomia (Almagesto e commentari relativi) nel codice vaticano geometria ed ancora astronomia (corpus astronomico minore) in quello parigino le opere trascritte sono sempre accompagnate in margine dai relativi commentari Il copista del Marc gr 310 egrave Isacco Argiro (ca 1300-1375) Mondrain 2007 p 166 Allo stesso Argiro dobbiamo il codice laurenziano (Daniele Bianconi per litteras) Poicheacute la recensione modificata che leggiamo nel Laur Plut 89 sup 48 egrave senza alcun dubbio basata su quella nel Marc gr 310 e non viceversa ci troviamo di fronte ad un copista che trascrive due volte lo stesso testo in due versioni leggermente differenti la conclusione naturale egrave che la seconda recensione egrave dovuta ad Argiro stesso la questione andragrave studiata in dettaglio
51 Nei manoscritti citati i Prolegomena si trovano ai fogli seguenti Vat gr 1594 ff 1r-8v (mutilo mancano due fascicoli su tre) Marc gr 313 ff 1r-28r (incompleto man-cano due fogli allrsquoinizio e il f 6 attualmente rimpiazzato da uno bianco) Marc gr 314 ff 235r-255r Vat gr 2326 ff 19r-40v e 43r-v (incompleto e con i fascicoli in disordine) Vat gr 184 ff 10r-23v Par gr 2390 ff 1r-13v Vat gr 198 ff 127r-136v Marc gr 310 ff 1r-13r Laur Plut 89 sup 48 ff 7r-19r
Fabio Acerbi142
ἐκθέμενοι οὖν διάγραμμα τῶν ἀριθμῶν ὡς ὑπόκειται προτάσσομεν τὸν μεριζόμενον καὶ μικρὸν ὑπ᾽ αὐτὸν τὸν μερίζοντα ὡς ἔχει τὸ διάγραμμα ἐν στίχοις διοριζομένοις ὑπὸ γραμμῶν [hellip] καὶ τὰ μὲν γινόμενα ἐγγὺς ἐλάττονα ἐν τῇ μεταξὺ θέσει τοῦ μεριζομένου καὶ τοῦ μερίζοντος ἐν στίχοις παρασημειοῦσθαι πρὸς τὸ ἀσύγχυτον εἶναι τὴν τάξιν τὰ δὲ μεθ᾿ ὧν ὁ μερίζων ἐποίει τοὺς ἀεὶ ἐλάσσονας ὑπὸ τὸν μερίζοντα σημειοῦσθαι προγράφοντας ἐπὶ τοῦ στίχου αὐτῶν τὸ γίνεται οὕτως γι ἐν δὲ τῷ στίχῳ τῶν μεριζόντων τὸ παρὰ ἔχον οὕτως oslash ἀντὶ τοῦ παρ᾿ ἃ δεῖ τὸν μερισμὸν γίνεσθαι ἐν δὲ τῷ στίχῳ τῶν ἐλασσόνων τὸ αφ διὰ τὸ τούτους ἀεὶ ἀφαιρεῖσθαι ἀπὸ τῶν ἐπάνω τῶν μεριζομένων ἐν δὲ τοῖς τοῦ μεριζομένου λοιπάσμασι τοῖς καὶ ἐπιοφείλουσι τὸ λ κατὰ τὸ ἴδιον τῶν διαστάσεων ἑκάστης ndash λέγω δὴ λοιπάδος ndash ἀντὶ τοῦ λοιποὶ οἱ μέλλοντες ἐπιμερίζεσθαι
2 post τὸν suprascr τὸν ἐλάττονα m 2 S 5 πρὸς] MP et ex corr Z κατὰ S om C | ἀσύγχυτον] MSPC -χητον Z 6 ἀεὶ] MZPC ὡσεὶ S 7 γίνεται οὕτως γι ] γι τ οὕτως γι τ M γί οὕτως γί Z γι οὕτως γί SC τὸ γινόμενον οὕτως γίνεται P 8 τὸ παρὰ ἔχον οὕτως] scripsi τὸ παρέχον οὕτως M et π(αρ-) comp Z οὕτως τὸ περιέχον S προγράφοντας οὕτως ex corr m 2 P τὸ περιέχον οὕτως C | oslash] MZSC (sed ο fecit | Z) ἐλάττων comp ex corr m 2 P | παρ᾿ ἃ] scripsi παρα M π(αρα) comp ZSC ex παρα fe-cit παρὰ et τοῦτον suprascr m 2 P 9 γίνεσθαι] comp C | αφ ] αφ ε M ἀφ ZSC ἀφαί P | ἀεὶ] om M 11 ἐπιοφείλουσι] MZSC ex ἐπιο- fecit ἐπο- m 2 P | λ] MZPC λ´ S 12 λοιποὶ] PC λοιποῦ MZS
3 στίχοις] στίχῳ K 5 πρὸς] διὰ K 7 ἐπὶ mdash γι ] τὸ γίνεται διὰ τοιούτου σ(ημείου) γί K 8 τὸ παρὰ ἔχον mdash παρ᾿ ἃ] τὸ παρᾱ διὰ σ(ημείου) τοιούτου καὶ τοῦτο oslash δηλοῦντος τοῦ παρᾱ ὅτι παρὰ τὸν τοιοῦτον (ἀριθμὸν) K 9 αφ διὰ τὸ τούτους] ἀφ δηλοῖ δὲ τοῦτο ἀφαίρεσ(ιν) ὅτι τούτους ἀεὶ δεῖ K 11 ἐπιοφείλουσι] ἐπιμερίζεσθαι ὀφείλουσι K | λ] λ οι` K 12 ἀντὶ τοῦ] δηλοῦντος τοῦ σ(ημείου) τὸ K
lsquoRendendo esplicito un diagramma numerico come lo troviamo qui sotto disponiamo in primo luogo il dividendo e un poco al di sotto di esso il divisore come li ha il diagramma in righe delimitate da linee [hellip] e lsaquooccorreragraversaquo nella posizione tra il dividendo e il divisore annotare lrsquouno accanto allrsquoaltro i piugrave vicini lsaquodei numerirsaquo minori che risultano affincheacute la disposizione non sia confusa quelli con cui il divisore faceva ogni volta i lsaquonumerirsaquo minori annotarli sotto il divisore scrivendo in prima posizione sulla loro riga laquorisultaraquo cosigrave Ris nella riga dei diviso-ri52 invece laquoperraquo fatto cosigrave53 P in luogo di laquoquelli per cui deve farsi la divisioneraquo nella riga dei lsaquonumerirsaquo minori laquosottrraquo in quanto questi sono sempre sottratti dai dividendi che si trovano sopra nei residuli del dividendo (occorre ben farlo anche per loro) laquoReraquo in accordo con ciograve
52 I laquodivisoriraquo sono al plurale ma siamo semplicemente di fronte a un tratto idioma-tico della lingua greca nel caso di espressioni generalizzanti crsquoegrave soltanto un divisore che occupa lrsquounica colonna di cui si compone la sua riga
53 Si intenda ἔχον οὕτως = ita se habens
1
5
10
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 143
che egrave proprio agli scarti di ciascuno ndash intendo qui lsaquociascunrsaquo residuo54 ndash in luogo di laquoresti che vanno a essere divisi ulteriormenteraquorsquo
a) Operatori di citazione e segni convenzionali I segni introdotti sono quattro la mia discussione egrave condotta dando per scontato che essi siano identici a quelli impiegati dallrsquoautore dei Prolegomena anche se si tratta di unrsquoipotesi non corroborabile neacute falsificabile
i Segno per il risultato Lrsquoabbreviazione convenzionale per γίνεται egrave identica al segno introdotto dallrsquoautore e i copisti si dividono tra i due errori possibili scrivere due abbreviazioni o risolverle entrambe Un fenomeno del tutto analogo si riscontra nel Matr 4678 il manoscritto alla base di tutta la tradizione degli Arithmetica di Diofanto al momen-to della definizione dellrsquoἀριθμός (lrsquolsquoincognitarsquo nel nostro linguaggio) ὁ δὲ μηδὲν τούτων τῶν ἰδιωμάτων κτησάμενος ἔχων δὲ ἐν ἑαυτῷ πλῆθος μονάδων ἄλογος ςο` καλεῖται ς` ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον τὸ ς` laquoil lsaquonumerorsaquo che non possiede nessuna di queste proprietagrave ma che ha in seacute una molteplicitagrave indefinita di unitagrave egrave chiamato lsquonumerorsquo e il suo segno egrave ς`raquo Qui solo il terzo dei tre ς ha una barra a sormontare per segnalarne il carattere puramente denotativo (cioegrave di segno convenzionale e non di abbreviazione si veda il punto successivo)55 il primo egrave una delle abbreviazioni piugrave diffuse per ἀριθμός (e infatti egrave dotato del compendio per la desinenza e dellrsquoaccento grave) il secondo egrave una delle piugrave comu-ni per καὶ () Giovanni Cortasmeno autore di capillari annotazioni infra lineam agli Arithmetica nel codice madrileno scioglie il primo ςο`
54 Doppia variatio che impiega al posto di λοιπόν laquorestoraquo i due termini decisamente non canonici τὸ λοίπασμα e ἡ λοιπάς (piugrave oltre leggiamo anche il participio λοιπασθέντα) Una ricerca sul TLG in rete non ha fornito occorrenze del primo si tratta dunque di uno hapax Quanto al secondo che ricorre anche nella sezione sulla divisione lsquoalla Papporsquo lo si rintraccia giagrave nei papiri documentari il termine diventeragrave perograve canonico nelle esposizioni bizantine drsquointroduzione allrsquoAlmagesto ricalcate sul modello dei Prolegomena (si veda la nota 87 infra) Questi due termini designano i resti parziali prodotti nel corso di una divisione lunga li ho tradotti rispettivamente con il neologismo laquoresiduloraquo e con il sostantivo pari-menti non canonico laquoresiduoraquo
55 Il copista interpreta erroneamente il terzo segno come unrsquoabbreviazione e qui ag-giunge un apice inverso (cioegrave un accento grave) altrove lo scioglie direttamente in forme opportune di ἀριθμός Matr 4678 f 58v La frase come la leggiamo nel manoscritto egrave cor-rotta sulla base di una parafrasi in Psello (edita in DOO II p 3710-12) Tannery emendograve ἄλογος in ἀόριστον DOO I p 64-5 et app Il Matritensis vergato da due copisti differenti (cambio di mano a tre righe dalla fine del f 62r) contiene lrsquoIntroductio arithmetica di Nicomaco e le opere diofantee oltre ad alcuni brevi opuscoli musicali la sua data egrave stata recentemente corretta dal XIII al secolo XI pm in Peacuterez Martiacuten 2006 (una riproduzione digitale del manoscritto si trova allrsquoindirizzo httpbdhbneesbnesearchbibliotecaDio-fanto20de20AlejandrC3ADa)
Fabio Acerbi144
in ἀριθμός ed aggiunge un altro segno56 sopra il terzo anteponendovi lrsquoindicazione καὶ ἔστιν αὐτοῦ σ(ημεῖον) τόδε Va da seacute che non abbiamo nessuna garanzia che il segno originariamente introdotto da Diofanto coincidesse realmente con unrsquoabbreviazione convenzionale per ἀριθμός Lrsquoevidenza del PMich III 144 (sec II in) suggerisce drsquoaltronde che il Matritensis e con esso tutta la tradizione medievale di Diofanto ripro-duca fedelmente pur accentuandone la sinuositagrave il segno originario
ii Segno per il divisore Un cerchiolino sbarrato da non confondere con il segno per ὁμοῦ che nei manoscritti matematici ha di norma due barre trasversali (cf tav 2a) Non sono riuscito a rintracciarne ulteriori occorrenze in altre opere la forma che esso assume nel Vat gr 2326 e la correzione apportata nel Par gr 2390 lasciano aperta la possibilitagrave per quanto a mio avviso remota che la forma originaria non fosse lon-tana da unrsquoabbreviazione di παρά registrata nei repertori57 Il correttore del Par gr 2390 trasforma in effetti il segno oslash nellrsquoaffine abbreviazione canonica per (forme di) ἐλάσσων laquominoreraquo58 e si incarica diligente-mente di farlo notare ricapitolando i segni nella porzione superiore del margine esterno del f 7v Nello stesso margine egli traccia anche uno lsquoscolio tabellarersquo ed egrave lrsquounico a porre il (proprio) segno dove indicato dalla descrizione (tav 6 Par gr 2390 f 7v) Oltre a ciograve adattando la tabella al margine ristretto lo scoliaste trascrive come colonne affian-cate le due righe dei resti parziali e dei massimi multipli e aggiunge le indicazioni ὁ μεριζόμενος laquodividendoraquo e ὁ μερίζων laquodivisoreraquo ma vi introduce alcune incongruenze di formato il risultato scritto in verti-cale e la linea verticale di sinistra che separa il divisore dal segno che lo dovrebbe precedere direttamente
iii Segno per i massimi multipli Corrisponde alla semplice abbre-viazione per sospensione della forma verbale ἄφελε laquosottrairaquo in questo
56 Si tratta del segno di ampio uso praticamente identico allrsquoabbreviazione canonica per οὖν
57 Si tratta di un pi a forma di gancio sbarrato da uno slash di troncamento Ce-reteli 1904 tav IX item 7 sub ΠΑΡΑ che rinvia al PVindRain 423 cf anche la forma π` nel POxy LXI 4142 edito in Jones 1999 II pp 26-34 In generale nei papiri e nei manoscritti matematici in maiuscola le preposizioni sono abbreviate facendo seguire un lsquoapostroforsquo alla loro prima lettera Α᾽ Υ᾽ ecc Per la seconda fattispecie di supporto libra-rio si veda in particolare il cosiddetto fragmentum mathematicum Bobiense scriptio inferior databile al V-VI secolo del palinsesto Milano Biblioteca Ambrosiana L 99 sup (Isidoro di Siviglia Etymologiae datazione Cavallo 1977 p 100) pp 113-114 che sono stampate in riproduzione apografa conforme in Belger 1881 (la p 114 egrave riprodotta anche nella tav 10 di Acerbi 2010)
58 Se questa era lrsquointenzione si tratta ovviamente di una forzatura il divisore puograve ben essere maggiore del dividendo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 145
caso lo slash di troncamento taglia orizzontalmente il tratto verticale del phi I copisti offrono molteplici varianti apponendo chi uno spirito dolce chi un ε chi un αί accentato a sormontare Tutti questi segni svolgono la funzione di abbreviazioni vere e proprie (e cosigrave doveva essere anche per lrsquoautore si veda il punto 1 di p 153 infra) la forma originale si ottiene a mio avviso incrociando i dati del Marc gr 313 e dei tre apografi del Vat gr 1594 αφ anche se lrsquoassenza dello spirito potrebbe essere semplicemente dovuta alla pratica del copista del codice veneziano di economizzare nei diacritici
iv Segno per i resti Un lambda completato da una barra a sormon-tare o da un apice che rinvia alle abbreviazioni per sospensione di una forma opportuna di λοιπός laquorestoraquo In realtagrave la forma che troviamo nella tabella egrave differente (tav 2b) e coincide con quella offerta quasi unanimemente dai manoscritti nella descrizione e in almeno un caso nella tabella del metodo di divisione attribuito a Pappo (tav 4) un lambda che accoglie al di sotto una legatura omicron-iota () sbarrata da uno slash di troncamento Qualcosa di simile si trova nel PVindob G 19996 (sec I) una specie di lambda maiuscolo molto aperto e dal vertice arrotondato che include un circoletto interpretato dagli editori come segno per περίεστιν o per λοιπόν59 Lo stesso segno si rintraccia ad esempio in un medesimo scolio tabellare di prima mano ad Alma-gestum nel Vat gr 1594 f 93v e nel Marc gr 313 f 135r ma stavolta la forma del lambda egrave molto ben definita
Fin qui i segni Ma il gioco egrave piugrave complesso La descrizione si muo-ve pericolosamente sulla linea di confine non sempre ben definita tra segno convenzionale e abbreviazione il primo ndash e il repertorio grafico matematico-astronomico ne egrave particolarmente fornito60 ndash puograve anche
59 Ho consultato lrsquoedizione Gerstinger ndash Vogel 1932 pp 46 e 48 la porzione rilevante del papiro egrave riprodotta nella tav 11 di Fowler 1999 Si veda ancora ivi pp 253-257 per la trascrizione di questo segmento di testo (con correzioni rispetto alla princeps) e per una messa a punto recente inclusa la proposta di datazione che ho riportato qui sopra Il verso del papiro che contiene una tavola aritmetica del tutto scorrelata dalla tematica del recto egrave edito come PRain Unterricht 151
60 La pratica di ridurre lo spazio occupato da un testo tecnico per mezzo di abbreviazioni e segni convenzionali era molto diffusa nei manoscritti in maiuscola contrariamente a quanto avviene per altri generi letterari vedremo tra breve cosa accade negli Arithmetica di Diofanto ma si leggano in proposito anche le considerazioni di Hei-berg nei prolegomena alla propria edizione dellrsquoAlmagesto in particolare riguardo al ricorso massiccio ad espedienti brachigrafici nel modello del Vat gr 180 POO II pp lxxxiv-xciii civ-cv cxxvii cxxxviii-cxxxix Agli elenchi dettagliati forniti da Heiberg possiamo aggiungere il piccolo prontuario stampato in Hultsch 1876-1878 III 2 pp 126-132 e basato sul testo e sugli scolii alla Collectio di Pappo nel Vat gr 218 (sec X in) Si vedano infine le osservazioni del copista del Par gr 2360 f 120v trascritte da Heiberg in AOO III pp x-xi sulle laquonotazioni tipiche a scopo di tagliar corto nello scrivereraquo impiegate nel pro-
Fabio Acerbi146
derivare dalla seconda (un caso egrave appunto il segno per ἐλάσσων che probabilmente trae origine da una legatura epsilon-lambda) ma poi il rapporto referente-relato si fissa convenzionalmente Quelli definiti nel testo che abbiamo letto sono appunto segni convenzionali non ci sarebbe bisogno di spiegarne forma e funzione se fossero intesi come abbreviazioni assumono nella tabella una funzione denotativa non esplicativa o discorsiva (come accade invece nella tav 1a) Ma come vengono descritti questi segni
I referenti delle descrizioni sono i segni sono introdotti da οὕτως (item i-ii) o in alternativa da un τό con il ruolo di lsquooperatore di citazionersquo (item iii-iv) che corrisponde esattamente alle nostre virgolette In entram-bi i casi gli enti sono menzionati e svolgono una funzione metalinguistica sono collocati materialmente nel testo ma egrave come se si trovassero fuori e la loro descrizione li additasse ndash in effetti i segni convenzionali scritti nel testo sono a loro volta i relata di quelli che si trovano nella tabella
I relata dei segni scritti nel testo sono di due tipi singoli vocaboli (item i-ii) o descrizioni della funzione dei segni per mezzo di clausole sintaticamente complesse (item ii e iv) I singoli vocaboli sono γίνεται e παρά e sono entrambi preceduti dal τό lsquocitazionalersquo in quanto relata di segni convenzionali le forme abbreviate con cui sono tracciati nei manoscritti vanno forzatamente sciolte Bisogna ammettere che la per-spicacia e le risorse grafiche dei copisti ndash di cui tutto si puograve dire fuor che commettano qui degli errori ndash sono messe a dura prova con lrsquointrodurre segni identici ad abbreviazioni o con lrsquoattivare un gioco metalinguistico particolarmente serrato in un contesto meno lsquonaturalersquo di come potreb-be esserlo ad esempio quello di un trattato grammaticale Lrsquoitem iii che presenta direttamente un segno identico ad unrsquoabbreviazione non egrave sorretto da una descrizione ma da una giustificazione in διὰ τό Lrsquoartico-lo τό vi assume una funzione metalinguistica anche se non lsquocitazionalersquo poicheacute al tempo stesso genera un infinito sostantivato e lo singolarizza per questo ho scritto laquosono sottrattiraquo in corsivo nella mia traduzione
prio modello archimedeo (nota 32 supra) egli ne compila anche una breve lista Un elenco antico di laquosegni della geometriaraquo sicuramente redatto per assistere il copista si trova anche al f 3v del ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 vergato da Efrem negli anni 950-960 (tav 8 in Acerbi 2010) Possiamo farci unrsquoidea quantitativa del guadagno di spazio in rapporto ad un testo privo di abbreviazioni e con le parole separate da spazi sulla base del fragmentum mathematicum Bobiense il testo vi egrave disposto a tutta pagina su 36 righe di circa 30 segni ciascuna nelle due pagine in questione figurano 2038 segni con 15 mezze righe occupate dalle due figure Ora nel testo dellrsquoedizione stabilita in Heiberg 1927 pp 87-90 le stesse pagine contano 4455 segni spazi compresi Ne risulta che la dimensione in caratteri di un testo matematico puograve essere ridotta di piugrave della metagrave con lrsquoimpiego di compendi e segni convenzionali
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 147
Negli item ii e iv il segno si collega ad una descrizione nel secondo caso in via esclusiva le descrizioni pertanto rinforzano o sostituiscono lrsquoidentificazione con lrsquoente linguistico denotato Le clausole descrittive sono precedute da ἀντί e dallrsquoarticolo τό con funzione di lsquooperatore di citazionersquo esse sono παρ᾿ ἃ δεῖ τὸν μερισμὸν γίνεσθαι (item ii) e λοιποὶ οἱ μέλλοντες ἐπιμερίζεσθαι (item iv) Nella descrizione della divisione lsquoalla Papporsquo che leggeremo tra breve i segni negli item iii e iv rice-vono lo stesso trattamento degli altri due il loro relatum egrave un singolo vocabolo e non una clausola descrittiva rispettivamente nelle espres-sioni τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε (sul participio ritorneremo nel punto 1 infra) e τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά (la forma del segno notato con λ οι egrave descritta supra nellrsquoitem iv) La descrizione del segno oslash per il divisore merita una discussione piugrave dettagliata In origine si trovava probabilmente scritto Π(ΑΡΑ)ΕΧΟΝ successivamente letto come π(αρ[α])έχον ndash dato che lrsquoabbreviazione per il preverbo egrave identica a quella per la preposizione (che sia Π᾽ o un pi seguito dal segno per ἄρα a sormontare) ndash invece di π(αρὰ) ἔχον I copisti e i correttori si dettero a tutte le possibili contorsioni per restituire un testo dotato di senso leggere appunto una forma verbale con preverbo modificare il preverbo (ma forse il segno per ἄρα era insidiosamente simile ad uno epsilon) correggere il testo rileggiamo lrsquoapparato sub τὸ παρὰ ἔχον οὕτως τὸ παρέχον οὕτως M et π(αρ-) comp Z οὕτως τὸ περιέχον S τὸ περιέχον οὕτως C προγράφοντας οὕτως ex corr m 2 P Nella clausola descrittiva seguente la presenza liminare di παρὰ (che ho corretto in παρ᾿ ἃ nella speranza di restituire una frase che abbia un senso senza intervenire sul testo) innesca un bel corto circuito il Π(ΑΡΑ) che sicuramente figu-rava nellrsquoarchetipo egrave un sintagma complesso una preposizione unrsquoab-breviazione o un segno per unrsquoabbreviazione Se lrsquoeditore si trova in conflitto con la propria inclinazione alla critica conservativa i copisti si rifiutarono di mettere mano ad un testo che doveva stridere anche per loro essendo il compito demandato al ritocco del revisore del Par gr 2390 o alla riscrittura radicale del recensore bizantino Il problema egrave che ci troviamo di fronte ad unrsquoespressione che descrive la funzione dellrsquooggetto denotato non lrsquooggetto stesso ma che lo contiene al suo interno per soprammercato qui il Π(ΑΡΑ) egrave usato per giustificare una menzione a sua volta relatum di un segno
Evidentemente questa maniera di procedere che giagrave aveva attirato interventi da parte di copisti e correttori della recensione di base parve insostenibilmente opaca allrsquoautore della recensione bizantina61 Egli
61 Uno dei manoscritti di questa recensione propone anche una tabella di divisione
Fabio Acerbi148
modifica tutte le descrizioni diluendo lrsquoidiomatismo dellrsquoarticolo lsquocita-zionalersquo con lrsquointroduzione sistematica del verbo δηλόω e di frasi atte a chiarire quale sia il segno denotante e quale il vocabolo (o il segno) denotato Egli introduce allo scopo di rendere esplicita la funzione de-notativa dei segni introdotti il termine σημείου curiosamente in tutte le sue tre occorrenze esso compare a sua volta nella forma dellrsquoabbrevia-zione per sospensione σΗ´ Egli traccia il segno per i massimi multipli ἀφ e quello per i resti λ οι` in modo che non vi siano ambiguitagrave quanto al loro carattere di abbreviazione Si faccia infine attenzione al residuo di barra sul παρᾱ con funzione denotativa (2 occorrenze) contenuto nella descrizione del segno per il divisore sostituita dallrsquoaccento grave nel παρὰ con funzione discorsiva (la differenza egrave nettissima nei manoscritti da me consultati) Questa osservazione ci permette di passare direttamente allrsquoitem seguente
b) Le barre sui numerali e sulle lettere denotative Egrave opportuno discutere questo punto adesso esattamente percheacute di barre siffatte che pure troviamo in tutti i manoscritti i nostri testi non fanno mai menzione si tratta infatti di una pratica condivisa sin dallrsquoantichitagrave La barra identifica una stringa di lettere dellrsquoalfabeto che non svolge una funzione grammaticale o sintattica propria allrsquointerno del discorso Ciograve avviene in particolare e si tratta della fattispecie piugrave frequente se la stringa di lettere non dagrave origine a un vocabolo della lingua greca lette-re denotative e numerali certo ma anche termini provenienti da altri idiomi e contrazioni di parole greche come i nomina sacra62 tali termi-ni possono essere o no preceduti da un articolo lsquocitazionalersquo a seconda dellrsquouso che ne viene fatto allrsquointerno del discorso Ma non si tratta dellrsquounica fattispecie i papiri grammaticali ed i manoscritti piugrave antichi dei trattati dello stesso argomento segnalano gli esempi delle parti del discorso (cioegrave di lsquoverersquo parole greche) per mezzo di barre sormontanti63 La differenza insomma egrave tra menzione e uso (come parte del discorso in atto) di una stringa di caratteri tra il porre le lsquovirgolettersquo e il non porle tra funzione denotativa e non Apparentemente la convenzione si limi-
corredata dei segni opportuni e contrariamente alle indicazioni della descrizione svilup-pata lsquoin verticalersquo ma per motivi misteriosi non completa (tav 7a Laur Plut 89 sup 48 f 13r)
62 Tutto ciograve egrave spiegato con estrema chiarezza giagrave in Traube 1907 pp 45-4763 Si veda il Par gr 2548 codex vetustissimus e testimone unico delle lsquoopere minorirsquo
di Apollonio Discolo il f 106v con le barre ben visibili egrave riprodotto come tav 19 in De Gregorio 2000 (ivi pp 137-138 per la datazione) Per la testimonianza dei papiri grammaticali si veda Wouters 1979 passim essi contengono di norma elenchi di parti del discorso nessuna delle quali egrave preceduta dallrsquoarticolo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 149
tava in questo secondo caso a segnalare con la barra singoli vocaboli le menzioni di frasi o di sintagmi complessi sono di norma identificate dallrsquoarticolo lsquocitazionalersquo Drsquoaltra parte le abbreviazioni convenzionali non rientrano nella casistica percheacute la loro resa grafica che contiene elementi non alfabetici come compendi per desinenze lettere supra li-neam marche di contrazione o sospensione quali slashes o barre sotto-poste o sormontanti eventualmente solo un sottinsieme della stringa di segni alfabetici le esclude automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
Venendo al discorso matematico una barra sormonta senza ecce-zione le lettere denotative64 che sia in papiri o in manoscritti in maiu-scola65 o minuscola ma solo allrsquointerno del testo comrsquoegrave da attendersi nei diagrammi esse la perdono per il semplice motivo che non crsquoegrave alcun testo ambiente un diagramma ha unicamente una funzione denotati-va Drsquoaltra parte le lettere numerali che a volte figurano nei diagrammi della tradizione metrica66 allo scopo di indicare la lunghezza dei seg-menti mantengono la barra in un diagramma il contesto denotativo geometrico egrave prevalente e i numerali vengono percepiti come entitagrave grafiche lsquoesternersquo al discorso Va da seacute a fortiori che le lettere numerali inserite in un testo dovranno essere segnalate da barre che a loro volta non servono nelle tavole67 in quanto queste ultime sono come abbiamo visto un vero e proprio testo che perograve funge da ambiente a quello al-fabetico limitato alle titolazioni e non a caso tracciato in unrsquoopportuna lsquomaiuscola distintivarsquo allo scopo di segnalarne il carattere denotativo e non discorsivo68 Una tabella operazionale egrave invece un paratesto e quindi le barre sulle lettere numerali che rappresentano gli interi sono
64 La notazione per le lettere denotative subigrave unrsquoevoluzione (il cui risultato finale egrave descritto per sommi capi nella nota 3 supra) di cui non mette conto occuparsi qui
65 I papiri di contenuto geometrico (o astronomici ma che presentano argomenti geometrici) sono rari si vedano il PHerc 1061 (sec II aC Demetrio Lacone De geome-tria) e il PFay 9 (sec II ex Elementi I 39 e 41) Gli importanti ostraka OBerl 12002 e 12609 (sec III aC m Elementi XIII) non pongono le barre sopra le lettere denotative Per i manoscritti in maiuscola si veda ad esempio passim nel Par gr 2389 una cui riproduzione digitale egrave consultabile in rete allrsquoindirizzo httpgallicabnffrark12148btv1b8470171d o il fragmentum mathematicum Bobiense
66 Si veda ancora il ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 codex unicus dei Metrica di Erone e contenente una raccolta importante di problemi del corpus metrologico
67 Si vedano come esempio le tavole citate alle note 10 e 14 supra Discorso a parte per il segno di lsquoposto vuotorsquo si veda il punto c che segue
68 Queste regole generali vanno prese cum grano salis si dagrave naturalmente un certo dominio di variabilitagrave legato verosimilmente al grado di cultura grafica del copista nel PMich III 144 i numerali sono quasi tutti senza barra sia nel testo che nelle tabelle ope-razionali
Fabio Acerbi150
necessarie esse mancano invece sui segni convenzionali che ho descrit-to nel punto precedente e fatto rilevante sulle lettere numerali relative agli ordini sessagesimali quando esse siano identificate da uno o piugrave apici la presenza di questo segno grafico non alfabetico69 le esclude ancora una volta automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo Unrsquoultima osservazione che ci saragrave utile nel seacuteguito la descrizio-ne di una stringa di lettere lsquoagrammaticalersquo non puograve prevedere la men-zione della presenza della barra che le pertiene in quanto tale si tratta di una pratica denotativa che egrave possibile formulare soltanto ad un livello di discorso superiore sia a quello dellrsquouso che a quello della menzione70
c) Il segno di lsquoposto vuotorsquo Si noti nella tav 2b la forma ŏ per il segno di lsquoposto vuotorsquo in un ordine sessagesimale coerentemente con la propria notazione il copista del Marc gr 313 lo scioglie talvolta allrsquoin-terno del testo principale come unrsquoabbreviazione per οὐδέν laquonienteraquo Altre convenzioni di scrittura del tratto che accompagna il circoletto e che si badi bene fa parte integrante del segno di lsquoposto vuotorsquo ndash e infatti nelle tavole troviamo sempre il segno completo mentre tutti gli altri numerali sono come abbiamo visto nel punto precedente privi di barra o di apice a causa del fatto che i vari ordini sessagesimali sono univocamente determinati dalle linee di giustificazione ndash un tratto an-golare anteposto (tav 3 Lar Plut 2818 f 136v)71 o una semplice barra a sormontare (tavv 4-9) si produce in questo modo il segno 65926 che sembra essere stata la forma di base72
69 Occorre dunque supporre come testimoniano papiri e manoscritti in maiuscola che la convenzione relativa allrsquouso della barra si sia consolidata ben prima dellrsquointroduzione di segni diacritici quali accenti e spiriti
70 Si veda il punto 2 infra per maggiori dettagli sulla questione delle barre e degli apici e per le indicazioni in merito che leggiamo in Diofanto
71 Come accennato questa tavola dei sottomultipli coincide con quella descritta ed esposta nei Prolegomena Fatto molto rilevante i numerali nella prima non recano neacute barre neacute apici contrariamente a quanto accade a tutte le istanze della seconda nei manoscritti Quella del Laur Plut 2818 preserva a mio avviso la forma originaria come abbiamo visto una tavola non richiede segni aggiuntivi sulle lettere numerali
72 Si vedano come esempio ancora le tavole citate alle note 10 e 14 supra oppure per una rassegna delle forme che il segno assume nei manoscritti piugrave antichi delle Tavole facili Tihon 2011 pp 58-59 e per quelle che assume nei papiri Jones 1999 I pp 61-62 Ovviamente non possiamo leggere il segno 65926 come un omicron con una barra in quanto ο = 70 nella notazione greca e la barra egrave di rigore quando il numerale figuri allrsquointerno di un testo Occorre ammettere che si dagrave origine ad un bel corto circuito notazionale con il concepire un segno con funzione di lsquoposto vuotorsquo ma che lsquosomigliarsquo ad una lettera dellrsquoalfabeto sormontata da una barra cioegrave ad un numerale in piugrave quando il lsquoposto vuotorsquo non corrisponda ad un intero ma ad una specie sessagesimale la presenza della barra a priori indistinguibile da quella che sormonta gli interi introduce unrsquoincongruenza con la notazione a mezzo di apici vista nellrsquoitem precedente
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 151
d) Errori di copia La tabella riprodotta nella tav 2b ha una forma simmetrica ma si tratta di una forzatura il grande rettangolo in basso a destra drsquoaltronde assente nella descrizione contiene uno scolio che fa notare come lrsquoultimo resto parziale ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ͵γτνζ´´´´´ κζ´´´´´´ cioegrave 0 0 0 0 0 3357 27 siano ἔγγιστα λ´λ´ δ´δ´ ξ laquocon ottima approssimazione 60 minuti quartiraquo dove si notino gli apici semplici per indicare il pas-saggio allrsquoordinale e il raddoppiamento del sistema segno + apice per significare il plurale Lo scolio debitamente accompagnato dal segno di rimando in forma di simbolo solare egrave stato probabilmente incluso nella tabella proprio allo scopo di renderla simmetrica A sua volta un errore precedente spiega lo spazio eccessivo accordato al rettangolo contenente lo scolio il secondo massimo multiplo ŏ λβ´ ξδ´´ ριβ´´´ σιϛ´´´´ egrave trascritto anche al di sotto del risultato
Passiamo ora alla descrizione del metodo di divisione attribuito a Pappo
ἵνα οὖν ταῦτα συναχθῇ τὰ ἐκ τοῦ μερισμοῦ ὁ εἰρημένος Πάππος εὐδιατύπῳ τινὶ καὶ πρὸς τοῦτο τάξει χρησάμενος ποιεῖται τὴν τῆς συλλήψεως τοῦ ζητουμένου ἀνεύρεσιν οὕτως ἐκθέμενος γὰρ τὸν μέλλοντα μερίζεσθαι τουτέστι τὰς τξ μοίρας ἐν ἀρχῇ ἀφαιρεῖ ἀπ᾽ αὐτῶν τὸν ἐν τῇ σελίδι τυγχάνοντα ἐλάττονα τουτέστι τὸν τδ κβ´ κ´´ ὄντα τῶν ἐγγὺς ἐλασσόνων ὡς πρὸς τοὺς ἐκκειμένους διὸ καὶ γράφει αὐτὸν προγράφων αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε καὶ εὑρίσκων τὰ παρακείμενα αὐτῷ τῷ ἀπογραφέντι ἐν τῷ σελιδίῳ λεπτὰ πρῶτα ν´ συναπογράφεται παρατιθῶν αὐτοῖς τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον ἀνατείνουσαν σημαῖνον τὸ εἶδος ὅτι πρῶτα λεπτά εὑρίσκει οὖν οὕτως τὸ τῶν τξ μέρος τὸ τδ κβ´ κ´´ ὃ μεριζόμενον παρὰ τὰς τξε ιδ´ μη´´ ἡμέρας καὶ ποιοῦν τὸν ἐκ τοῦ μερισμοῦ ἀριθμὸν πρῶτα λεπτὰ ν´ καὶ τὸν λοιπὸν ἀπογραφόμενος τὸν νε λζ´ μ´´ προτάσσει αὐτοῦ τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά τάσσει δὲ καὶ ἁπλῆν τινα διατείνουσαν γραμμὴν ὡς ἀπὸ τοῦ τξ ἐπὶ τὸν ἑξῆς ἐκτεθειμένον ἐγγὺς
1
5
10
1 εὐδιατύπῳ] ZSPC εὐδιατύπωτ M 4 ἀφαιρεῖ] MZSP ἀφ ι C 5 ἐλάττονα] P comp MZSC 6 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | αφ ] αφ ε M ἀφ ZS ἀφαί P ἄφ C | ἀντὶ] om C | ἄφελε] MZSP ἄφ C 8 ἀπογραφέντι] MZSP ἐγγραφέντι C | λεπτὰ πρῶτα] P λε πρωτα SC λεπτῶν πρωτ MZ | παρατιθῶν] MZS παρατιθεὶς C et ex corr m 2 P 9 ᾱ] Z αο P α´ MS α C | ἔχον] MPC ἔχων ZS 9-10 πρῶτα λεπτά] ZP πρωτ λ´λ´ M πρωτα λε S αα λε C 11 ἡμέρας] comp codd | ἀριθμὸν] P et comp MZ καὶ C et comp S 12 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M πρωτ λεπτ(α) Z πρωτ λ εᾱ S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C | ἀπογραφόμενος] MZSP ἐγγραφόμενος C | νε λζ´] MZSP λζ νζ C 13 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | λ οι] MZSC ex λ fecit λ οι P | προσσημαῖνον] MC et προσ- comp ZS προση- P | τὸ] MZC τὰ S et fecit m 2 P 14 ἀπὸ] MZSP πρὸς C ἐλάττονα] P comp MZSC
1 εὐδιατύπῳ] εὐδιατυπώτω K 6-7 αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ] τὸ ἀφ K 8 παρατιθῶν mdash 10 λεπτά] τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ σημαίνουσαν τὸ εἶδος αὐτῶν ὅτι ᾱ λεπτά εἰσιν K | τὸ (sec)] τὰ K 12 πρῶτα] πρώτων K | τε λ ] λ οι` K | προσσημαῖνον mdash
Fabio Acerbi152
ἐλάττονα τὸν τδ κβ´ κ´´ ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις καὶ ταύτην ἐπιδεικνύουσαν τὴν τάξιν τῆς προόδου τῆς ἐκθέσεως ἧστινος κλωμένης γραμμῆς πρὸς τῷ ἐγγὺς ἐλάσσονι ἡ ἀντανάκλασις ἐπὶ τὸν λοιπὸν γέγραπται φερομένη ὡς εἴρηται διὰ τὸ εὔτακτον τῆς προκοπῆς οὕτως τε ποιήσας ἑξῆς τὸ αφ ποιῶν ὃ προσσημαίνει ὡς εἴρηται τὸ ὅτι δεῖ ἀφελεῖν ὁμοίως ἀπὸ τοῦ λοιποῦ καὶ δὴ τὸν ἐγγὺς πάλιν ἐλάσσονα ὡς πρὸς τὴν ἐν τῷ σελιδίῳ ἔκθεσιν εὑρισκόμενον λαμβάνων ἑξῆς προγράφει αὐτὸν ὄντα νδ μζ´ ιγ´´ ιβ´´´ καὶ εὑρίσκει αὐτοῖς παρακείμενα ἐν τῷ σελιδίῳ πρῶτα λεπτὰ θ´ ἅτινα καὶ αὐτὰ προσαπογράφεται σὺν τῇ παρασημειώσει τῶν πρώτων γράφων τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον τὴν ἀνατείνουσαν καὶ ὡς εἴρηται τὴν γραμμὴν πάλιν διὰ τὴν τάξιν κλωμένην κατὰ δευτέραν κλάσιν προσέλκει γινομένου τοῦ μέρους αὐτῆς τούτου παραλλήλου τῷ ἐξ ἀρχῆς
16 ante κλωμένης add ἐπὶ C 18 τε] MZP om SC | αφ ] M ἀφ ZSC ἀφαί P 19 προσσημαίνει] MS προση- ZC et ex corr P | ὅτι] ZP comp MSC 20 δὴ] MZSC διὰ fecit m 2 P 21 πρὸς] MSP et supra lineam C ex ἀπὸ fecit m 2 Z | ιγ´´] MZSP νγ´´ C 22 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M ᾱᾱ λεπτὰ Z άάα λε S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C 23 προσαπο- γράφεται] απο suprascr in comp M 24 ᾱ] ZP α´ MS α C 25 κλάσιν] MP τάξιν ZSC | τοῦ] ZSPC τούτου M 26 τούτου] τοῦ bis ZSPC sed prius erasit m 2 P τοῦ M
mdash 18 προκοπῆς] om K | τε ποιήσας] ποιήσας καὶ K | αφ ] ἀφ K 19 τὸ] om K 21 προ-γράφει] γράφει K 22 σελιδίῳ] α´ σελιδίῳ K | ἅτινα] ἃ K 23 προσαπογράφεται] ἀπογράφεται K | τῶν πρώτων mdash 26 ἐξ ἀρχῆς] om K
lsquoAllo scopo di raccogliere ciograve che risulta dalla divisione il detto Pappo utilizzando anche in questo caso una certa disposizione ben strutturata determina nel modo seguente il lsaquonumerorsaquo cercato preso nel suo insieme collocando73 in testa il lsaquonumerorsaquo che sta per essere diviso cioegrave i 360 gradi iniziali sottrae loro tra i piugrave prossimi dei lsaquonumerirsaquo minori rispetto a quelli esposti quello che si trova essere minore nella colonna (cioegrave 304 22 20) Questo egrave il motivo per cui lo trascrive scrivendogli davanti lrsquoabbreviazio-ne laquosottrraquo per laquosottrairaquo e trovando che 50 minuti primi sono collocati accanto a quello stesso lsaquonumerorsaquo che egrave stato trascritto nella colonna li trascrive al tempo stesso collocando accanto74 ad essi la lettera A con un lsaquotrattorsaquo75 sopra che significa la specie minuti primi Trova dunque in que-sto modo la parte di 360 che egrave 304 22 20 la quale divisa per 365 giorni 14 48 fa il numero lsaquoche risultarsaquo dalla divisione 50 minuti primi Trascrivendo
73 La descrizione egrave strutturata come una procedura Acerbi 201274 Il purismo del correttore del Par gr 2390 di Clostomalle nel Marc gr 314 e
dellrsquoautore della recensione bizantina impone loro di modificare la terminazione ma forme tematiche e contratte di τιθεῖν sono correnti nel greco tardivo
75 Il testo greco ha solo il participio con γραμμήν sottinteso Per il significato del participio si veda il punto 2
15
20
25
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 153
poi il resto 55 37 40 gli pone altresigrave76 a prefisso laquoReraquo che significa laquorestiraquo e dispone anche una certa linea semplice77 che va da 360 al piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori che egrave esposto di seacuteguito 304 22 20 come nello lsaquoschemarsaquo esposto linea che mostra lrsquoordine del percorso dellrsquoesposizione Questa linea spezzata lagrave dove si trova il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori egrave tracciata inflessa allrsquoindietro lsaquoersaquo punta verso il resto come egrave stato detto in vista di una progressione ordinata E cosigrave facendo prendendo di seacuteguito il laquosottrraquo che significa come egrave stato detto laquoche occorre similmente sottrarre dal re-storaquo e ovviamente prendendo di nuovo il lsaquonumerorsaquo che egrave trovato essere il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori in relazione alla disposizione nella colonna ndash 54 47 13 12 ndash lo scrive di seacuteguito e trova che 9 minuti primi sono posti loro accanto nella colonna trascrive78 anche questi con la segnaletica dei primi scrivendo la lettera A con un lsaquotrattorsaquo sopra e come egrave stato detto prolunga di nuovo la linea spezzata in vista di una buona disposizione tramite una seconda inflessione essendo questa sua parte parallela a quella inizialersquo
La descrizione continua con una serie di laquoe cosigrave viaraquo e non fa ulte-riore riferimento alla tabella
1) La forma verbale ἐξεσμένον Egrave il neutro del participio perfetto medio-passivo di ξέω lett laquopialloraquo laquolevigoraquo Si danno tre possibilitagrave si tratta di un termine canonico per quanto non altrove attestato per designare unrsquoabbreviazione oppure lrsquoautore anonimo improvvisa sul piano metaforico come se unrsquoabbreviazione non fosse altro che la paro-la completa lsquoaccorciata a colpi di piallarsquo in maniera opportuna oppure il testo egrave corrotto e srsquoimpone una correzione ad esempio τὸ ἑξῆς μένον laquociograve che sta di seacuteguitoraquo Questrsquoultima strada mi pare chiusa dal senso delle frase lrsquoabbreviazione non lsquosta di seacuteguitorsquo a niente ma anzi precede la perifrasi τὸ ἑξῆς μένον se impiegata semplicemente per rimandare al segno αφ immediatamente seguente costituirebbe un intollerabile solecismo Se accettiamo la prima di queste letture considerando quin-di lrsquoabbreviazione αφ in posizione predicativa abbiamo a che fare con
76 Rendo in questo modo il τε isolato77 La linea egrave laquosempliceraquo in quanto egrave una retta la precisazione intende evidenziare per
anticipazione il carattere lsquonon semplicersquo che essa assumeragrave alla prima inflessione quando diventeragrave una spezzata linee siffatte erano in effetti concepite dallrsquoanonimo e prima di lui da tutta la tradizione matematica greca come una singola linea spezzata nei punti drsquoinfles-sione I due segmenti paralleli menzionati al termine del passo sono orizzontali
78 Il verbo egrave al medio in variatio rispetto ai due che precedono e che seguono egrave il matematico che lsquosirsquo trascrive le cifre
Fabio Acerbi154
uno hapax semantico nella grecitagrave superstite come egrave facile verificare con una ricerca sul TLG in rete La recensione bizantina risolve il pro-blema sopprimendo semplicemente τὸ ἐξεσμένον
2) La notazione per le specie numeriche Nella terminologia matema-tica greca gli ordini sessagesimali sono εἴδη laquospecieraquo numerici essi corri- spondono agli ordini di grandezza nel nostro sistema decimale e indica-no in analogia con il caso geometrico la lsquoformarsquo che assume un numero quadrato cubo ecc Centinaia e migliaia sono quindi degli εἴδη rispet-tivamente quadrati (100 egrave il quadrato di 10) e cubi (1000 egrave il cubo di 10) sono specie numeriche ma non numeri particolari e drsquoaltronde 300 non egrave un quadrato ma 3 item dellrsquoεἶδος lsquoquadratorsquo 100 3 egrave il numerale di molteplicitagrave della specie quadrata lsquocentinaiarsquo i due 0 che seguono il 3 segnalano esattamente questo fatto che la notazione greca per gli interi non posizionale fa scomparire al livello denotativo Ciograve non vale soltan-to per i numeri interi ma anche per le loro parti i minuti secondi appar-tengono alla specie lsquoquadratorsquo in quanto 13600 egrave il quadrato di 160
La concezione appare interamente dispiegata nellrsquointroduzione degli Arithmetica diofantei79 che si rivela giova farlo rimarcare un te-stimone fondamentale per la ricostruzione della notazione matematica antica Alle specie usate in questrsquoopera vengono assegnati una denomi-nazione ed un segno convenzionale costituito dallrsquoiniziale (di ognuno dei componenti) della denominazione al quadrato o δύναμις il segno ΔΥ al κύβος il segno ΚΥ alla lsquoquarta potenzarsquo o δυναμοδύναμις il segno ΔΥΔ ecc La descrizione di tali segni egrave del tipo καὶ ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον Κ ἐπίσημον ἔχον Υ ΚΥ κύβος laquoe il suo segno egrave un Κ che ha come indice un Υ ΚΥ cuboraquo dove in accordo con quanto abbiamo visto nel punto b supra e pur nel comprensibile imbarazzo del copista della prima parte del Matritensis (o di un suo passato collega) a districarsi in questo formidabile ginepraio notazionale80 le due lettere Κ e Υ ricevono una barra mentre ΚΥ non la richiede a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον il quale ancora una volta esclude automaticamente il segno dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
79 In particolare a DOO I pp 214-62180 Nel Matr 4678 riscontriamo i seguenti fenomeni nelle poche righe a cavallo dei ff
58r-v 1) accento acuto posto su tutti i segni come se fossero abbreviazioni 2) ripetizione sistematica segnodenominazione come in ΚΥ κύβος appena letto dovuta sicuramente allrsquointrusione di glosse interlineari esplicative dei segni ndash e successivo pentimento (δύναμις e κύβος sono in effetti cancellati dalla prima mano il primo con un tratto il secondo con dei punti supra lineam poi il copista si stanca di correggere) 3) nella descrizione del segno per la δυναμοδύναμις menzione di un δέλτα δύο che saragrave molto probabilmente stato ΔΔ subito dopo nella descrizione del κυβόκυβος si legge un incongruo δύο KK
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 155
Diofanto introduce poi dei segni anche per le specie delle parti dellrsquounitagrave (le nostre frazioni) che egli chiama ὁμώνυμα μορία laquoparti omonimeraquo di cui quelle sessagesimali sono casi particolari81 Egli spie-ga appunto che le loro denominazioni sono ottenute da quelle delle specie degli interi per sinonimia passando ad un lsquoordinalersquo82 formato semplicemente aggiungendo il suffisso -στον δυναμοστόν κυβοστόν δυναμοδυναμοστόν ecc (sott μόριον) I loro segni convenzionali sono invece ottenuti da quelli per le specie degli interi aggiungendo una γραμμὴν διαστέλλουσαν τὸ εἶδος laquolinea che distingue la specieraquo83 Una linea sui segni delle specie delle parti egrave richiesta si badi bene per distinguerli dai segni di quelle degli interi come giagrave osservato questi ultimi sono giagrave lsquoagrammaticalirsquo a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον a fortiori lo saranno anche i primi Si tratta della traduzione semio-tica del passaggio dal cardinale allrsquoordinale che a livello grammaticale egrave effettuato con il suffisso -στον Che forma ha questa linea Barra o apice (Egrave cervellotico pensare a forme piugrave complesse) La domanda non ammette una risposta immediata in quanto delle specie diofantee nessuno piugrave si occupa nellrsquoantichitagrave84 Se egrave vero che la prima risposta darebbe origine ad un conflitto tra due convenzioni denotative diffe-renti la barra lsquocitazionalersquo e la barra che distingue la specie lrsquoevidenza grafica del Matritensis lascia lievemente sgomenti (ricordiamoci che giagrave i segni di base sono indebitamente dotati di un accento dal copista) Le poche occorrenze del segno per le specie delle parti85 vedono lrsquoaggiunta di uno slash di sospensione di un doppio apice inverso ndash in tutta evi-
81 Questo fatto era giagrave chiaro nellrsquoantichitagrave Teone in Alm I 10 in iA p 45310-1682 Il parallelo con i cardinali e gli ordinali relativi agli interi egrave reso esplicito da Dio-
fanto ὥσπερ δὲ τῶν ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια παρομοίως καλεῖται τοῖς ἀριθμοῖς τοῦ μὲν τρία τὸ τρίτον τοῦ δὲ τέσσαρα τὸ τέταρτον οὕτως καὶ τῶν νῦν ἐπονομασθέντων ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια κληθήσεται παρομοίως τοῖς ἀριθμοῖς laquocome le parti omonime dei numeri sono chia-mate per assonanza con i numeri di lsquotrersquo lsquolsaquounrsaquo terzorsquo di lsquoquattrorsquo lsquolsaquounrsaquo quartorsquo cosigrave le parti omonime dei numeri appena nominati saranno chiamate per assonanza con i numeriraquo (DOO I p 69-13 si noti lrsquoarticolo lsquocitazionalersquo al singolare in τοῦ τρία e τοῦ τέσσαρα) Il parallelo prosegue anche al livello dei segni che rappresentano queste specie come vedremo tra un attimo
83 Diofanto Arithmetica prefazione in DOO I p 620-21 un passaggio maltrattato in questa edizione occorre espungere il participio ἔχον senza introdurre segni ulteriori oppure eliminare un precedente ἐπί come fa un correttore del Matritensis f 58v
84 Unica parzialissima eccezione lrsquoaccenno di Teone menzionato nella nota 81 supra85 Al f 59r e per di piugrave nel margine per sanare un lungo saut du mecircme au mecircme La
collocazione in margine egrave il motivo per cui troviamo una notazione abbreviata nel resto del trattato il primo copista scioglie tutti i segni prendendoli per abbreviazioni mentre il secondo elimina sistematicamente il tratto aggiuntivo delle specie delle parti dellrsquounitagrave Drsquoaltronde egli scrive ad esempio ΔΥ invece di ΔΥ ed egrave quindi indotto a porre la barra al di sopra della stringa di lettere risultante (passim ma si veda ad esempio il f 72r)
Fabio Acerbi156
denza il compendio per la desinenza -ον accentata il copista interpreta il segno come unrsquoabbreviazione ndash e di una barra a sormontare lo Υ Potremmo forse interpretarlo come il segno di contrazione del grafema -στ- lrsquounico tassello mancante in unrsquoabbreviazione come ad esempio (δυναμοδυναμο)(στ)(ὸν) ma uno scolio di prima mano al f 58v rela-tivo alle specie degli interi inficia questrsquoipotesi esse sono dotate di slash di sospensione accento acuto in un caso del compendio canonico per la terminazione -ον hellip ma tutti gli Υ a esponente sono a loro volta sormontati da una barra
Meno legata al singolo manoscritto ma nondimeno non uniforme si presenta la pratica di notazione dei segni che rappresentano gli enti numerici sessagesimali86 da una parte sta lrsquoevidenza del testo dei Pro-legomena e delle sue tabelle apici ndash drsquoaltronde come abbiamo visto la notazione universalmente impiegata per i numerali ordinali e per le fra-zioni unitarie ndash dallrsquoaltra sta lrsquoevidenza del testo dellrsquoAlmagesto in tutti i manoscritti piugrave antichi e lo stesso si dica del commentario teonino a questrsquoopera o del suo lsquoGrande commentariorsquo alle Tavole facili e dei testi astronomici su papiro barre87 Sembra insomma che la nostra docu-
86 Sia le molteplicitagrave che le specie ahimeacute entrambe rappresentate da lettere dellrsquoalfabeto Come osservato allrsquoinizio della sezione 3 ci sono in effetti due tipi di lettere numerali in gioco se facciamo astrazione da apici o barre lsquo4 minuti secondirsquo si trova scritto δ β la prima lettera numerale denota la molteplicitagrave degli item di una certa specie la se-conda la specie nei Prolegomena entrambe sono accompagnate da un doppio apice il che rende inutile la presenza delle seconde Si noti che la descrizione della tabella non fa parola della notazione da usare per le lettere numerali che denotano la molteplicitagrave barre o apici e quanti apici hellip In questo caso fa interamente fede la tabella cioegrave la pratica grafica condivisa instauratasi non egrave chiaro quando
87 I manoscritti piugrave antichi dellrsquoAlmagesto sono menzionati nella nota 10 supra quelli dei due commentarii teonini sono il Laur Plut 2818 e il celeberrimo Vat gr 190 (sec IX in Euclide Elementi Data Teone lsquoGrande commentariorsquo) per la notazione dei pa-piri astronomici si veda Jones 1999 II passim La notazione non sembra lsquoinquinatarsquo dalla pratica dei copisti bizantini e pare dipendere soltanto dalla data di composizione Tro-viamo ad esempio barre sopra tutti i numerali di molteplicitagrave (interi o sessagesimali) nel frammento di un commentario alle Tavole facili contenente un calcolo relativo al 24 aprile 213 (Par gr 2841 sec XIII ex-XIV in oltre al frammento ai ff 32r l 11-34v l 23 contiene Arato Phaenomena ed Efestione Apotelesmatica edizione in Jones 1990) Nel commentario alle Tavole facili composto ca 610-617 ed attribuito a Stefano di Alessandria la situazione egrave la seguente (Jean Lempire per litteras per lrsquoedizione si veda Lempire 2014 ho controllato il Vat gr 304 ff 135r-171v sec XIV am contiene in aggiunta Teone in Almagestum I-II lsquoPiccolo commentariorsquo alle Tavole facili Diofanto Arithmetica e De polygo-nis numeris varia astronomica tabulae) barre sopra gli interi sporadicamente rimpiazzate da apici apici sopra le parti sessagesimali in numero uguale alla denominazione doppio () apice per le frazioni unitarie Sono impiegate barre sopra gli interi e apici sopra le parti sessagesimali nei manoscritti principali di tutti i trattati di introduzione allrsquoAlmagesto o comunque di argomento logistico redatti in epoca bizantina Giorgio Pachimere (1242-ca 1310) Quadrivium (autografo nel manoscritto Roma Biblioteca Angelica gr 38 [RGK III nr 115] si veda Tannery ndash Steacutephanou 1940 per lrsquoedizione) Teodoro Metochita (1270-
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 157
mentazione si faccia testimone di un cambio notazionale avvenuto nel periodo intercorrente fra Teone (sec IV pm) e la scuola alessandrina di Ammonio e dei suoi allievi (sec VI in) e probabilmente innescato da questrsquoultimo ambiente lrsquoaspetto paradossale egrave che nello stesso codice si rintraccino due notazioni differenti per gli enti numerici sessagesimali e lrsquouna (apici) sia adottata sistematicamente e coerentemente in uno scritto (i Prolegomena) che si presenta esattamente come unrsquointroduzione tecnica alla pratica numerico-algoritmica del trattato (lrsquoAlmagesto) in cui egrave adottata lrsquoaltra (barre che ritroviamo senza eccezioni anche negli scolii)
Torniamo ai Prolegomena la descrizione del segno da porre a fianco di ogni singolo quoziente parziale e denotante la sua specie numerica (minuti primi minuti secondi ecc) solleva tre problemi
Primo problema Ci vuole una barra o un apice su τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquola lettera A [hellip] che significa la specieraquo quando lo scriviamo nella tabella Tutta la nostra discussione precedente fa pro-pendere per lrsquoapice e si ricordi anche la forma verbale ἀνατείνουσαν che suggerisce qualcosa che si lsquoestende verso lrsquoaltorsquo (la mia traduzione egrave volutamente neutra) se fosse apposta una barra la cosa dovrebbe passare
1231332) Compendium astronomicum (copia lsquoautorizzatarsquo coeva nei Vat gr 182 e 181 da parte del copista che integrograve le parti mancanti del Par gr 2389 [ff 207-210 255-270 374-375] Bianconi 2005a pp 425-427 Peacuterez Martiacuten 2008 p 436 e n 177) Teodoro Meliteniota (morto lrsquo831393) Tribiblos astronomica (autografo nel Vat gr 792 si vedano Leurquin 1991 per unrsquoanalisi del manoscritto Leurquin 1990 per lrsquoedizione) una com-pilazione anonima (per cui ho consultato il Par gr 2396 ff 87r-92v limitatamente a questi fogli manu Costantino Trivoli [RGK II nr 318 ma ovviamente questo codice non vi egrave segnalato] terzo quarto del XV secolo il resto del codice annotato da Niceforo Gregora egrave di etagrave planudea e parzialmente [ff 33v-76v] un autografo di Planude stesso contiene Teone in Almagestum I II IV Mondrain 2002 il codice va completato ndash limitatamente a stralci dei libri VIII-X XII-XIII del commentario teonino la cui parte intermedia si egrave persa ndash con 26 carte [ff 123-147] inserite nel Vat gr 1087 anchrsquoesso contenente anno-tazioni di Gregora Rome 1927 per la figura del copista dei ff 77r-86r del Par gr 2396 e dei ff appena nominati del Vat gr 1087 un anonimo collaboratore di Gregora si veda in ultimo Bianconi 2006a pp 147-151) si veda anche il calcolo effettuato da Niceforo Gre-gora (12921295-13581361) dellrsquoeclisse di sole del 16 luglio 1330 (attestata unicamente ai ff 1r-8v della miscellanea astronomica Marc gr 325 databile ca 1324-1329 in parte vergata e ovunque fittamente annotata da Gregora stesso edizione del testo in Mogenet et al 1983 annotazioni di Gregora elencate in Bianconi 2005a p 413) Unrsquoeccezione apparente il lsquoPiccolo commentariorsquo di Teone alle Tavole facili le parti sessagesimali sono segnalate da apici (ad esempio nel Vat gr 175 vergato da Giovanni Catrario e completato nel 1321-1322 sulla figura di Catrario si vedano in ultimo Bianconi 2005b pp 141-156 e 2006b) lrsquoopera egrave antica ma la sua tradizione non rimonta oltre la fine del XIII secolo a parte un frammento nel Leiden BPG 78 ff 156r-161v (minuscola del IX-X secolo) e in effetti in questo manoscritto tutti i numerali di molteplicitagrave sono sormontati da barre Unrsquoeccezione effettiva egrave il De hypotesibus planetarum nel Vat gr 1594 barre sugli interi e apici sulle parti sessagesimali
Fabio Acerbi158
sotto silenzio e la presenza dellrsquoapice la rende inutile88 Si tratta della stessa convenzione diofantea e coincide ancora con la notazione per i numerali ordinali e per le frazioni unitarie che egrave corrente nei mano- scritti matematici greci per questo motivo non percheacute la descrizione sia particolarmente perspicua nessuno dei copisti della recensione an-tica ha incertezze apici Ma questi apici si rintracciano soltanto sulle indicazioni di specie non contemplate dalla descrizione che sono ante-poste ai resti parziali a fianco dei quozienti parziali i segni di specie sono invece trasformati in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordi-nali corrispondenti del tipo πρωτ tavv 5 e 7b-8 Il recensore bizantino taglia invece la testa al toro elimina dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali elimina la seconda menzione della laquolet-tera Araquo contestualmente allrsquoazzeramento dellrsquoespediente della linea a zig-zag (si veda il punto seguente) modifica la descrizione che contiene la prima menzione in quella dellrsquoapice associato direttamente ai nume-rali di molteplicitagrave riciclando addirittura lrsquoalpha per adibirlo a desi-gnare un numero cardinale (come sorprendersi) τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ laquoponendo al di sopra di essi [scil dei 50 minuti primi] 1 solo lsaquoaccentorsaquo acutoraquo La scelta del recensore egrave assennata che rechi una barra o un apice in una tabella un alpha denota un numero non un numero drsquoordine
Secondo problema da tenere ben distinto dal precedente Cosa ci vuole sul segno α per la lettera alpha menzionata nella frase τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquolettera A [hellip] che significa la specieraquo89 Unrsquooc-chiata allrsquoapparato critico rivela una bella incertezza nei manoscritti Z scrive sempre ᾱ e in un caso lo fa anche P MS optano sempre per α´ C per α P scrive nellrsquoaltro caso αο Per quanto solo la barra sia congrua con il senso della frase in quanto la lettera alpha egrave qui menzionata (si tratta di un oggetto che compare nella tabella) e non cambia niente se essa egrave accompagnata dal suo nome di genere στοιχεῖον ad un livello grafico lrsquoincertezza fra il segno ᾱ che denota laquola lettera αraquo e il segno α´ (o lrsquoabbreviazione αο) per una forma di πρῶτος egrave per piugrave versi giustificata
88 Detto in altri termini la barra egrave uno strumento grafico non matematico e quindi la sua presenza non va segnalata mentre un apice lo egrave e la sua presenza lo deve
89 Notare che in questa frase il primo α non vuole la barra (egrave menzionato allrsquointerno di una frase che impiega convenzioni moderne) il secondo sigrave (idem ma con convenzioni antiche) ndash e nella traduzione la scelta di denotarlo con A (senza virgolette) e non con lsquoArsquo (con virgolette) egrave del tutto arbitraria ndash si noti inoltre che le necessarie precisazioni laquosenzacon virgoletteraquo mostrano che le lingue moderne palesano difficoltagrave analoghe a quelle del greco antico per quanto riguarda i livelli denotativi in ambito metadiscorsivo per non usare le due parentetiche avrei dovuto scrivere rispettivamente lsquoArsquo e lsquolsquoArsquorsquo (doppie virgolette semplici)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 159
ᾱ coincide con il numerale 1 α egrave la prima lettera dellrsquoalfabeto ed inoltre α´ egrave esattamente quello che va scritto nella tabella Potremmo dirci che il sostantivo στοιχεῖον chiude la questione la sua presenza congiunta ad un ipotetico α´ renderebbe la descrizione ridondante o inappropriata90 Ma a parte il fatto che α egrave proprio τὸ πρῶτον στοιχεῖον il segno α´ cat-tura in fondo il cuore della descrizione di uno στοιχεῖον ἔχον lsaquoγραμμὴνrsaquo ἀνατείνουσαν
Terzo problema Lrsquoautore dei Prolegomena che si arresta allrsquoesem-pio dei minuti primi non dice quanti apici occorre mettere sulle lettere numerali che identificano gli ordini superiori al primo se uno soltanto come nel caso diofanteo e delle frazioni unitarie o in numero uguale alla loro denominazione (cioegrave pari al numero denotato dal numerale stesso su cui vanno posti) come effettivamente avviene nei mano-scritti dei Prolegomena La tabella egrave quindi sottodeterminata dalla sua descrizione anzi in un certo senso prende il sopravvento su di essa la pratica di marcare i numerali di molteplicitagrave con gli apici che compe-tono allrsquoordine cui appartengono viene trasferita ai segni per gli ordini stessi per supplire ad una descrizione carente di questi ultimi E la tabella egrave sottodeterminata dalla descrizione in quanto egrave la descrizione di una tabella reale ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις laquocome nello lsaquoschemarsaquo espostoraquo leggiamo a un certo punto del testo
3) La linea a zig-zag Non possiamo che applaudire a questo geniale espediente grafico lo troviamo messo in opera solo nel Marc gr 313 Per quanto lrsquoautore non faccia parola di ciograve nel corso della sua descrizione la linea spezzata egrave intesa dover lsquosaltarersquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue Il copista del codice marciano effettua correttamente due salti nella prima delle sue tabelle (tav 4) ma inserisce un lsquodentersquo in piugrave in quella che considera corretta (tav 5) La linea a zig-zag egrave incompatibile con la presenza di linee di giustificazione nella tabella che in effetti mancano nel Marc gr 313 ciograve induce gli errori di allineamento dei primi 5 quozienti parziali di cui egrave vittima il copista Probabilmente per questo motivo in nessuno degli apografi del Vat gr 1594 la linea a zig-zag figura nella tabella inquadrata come si conviene da una (doppia) cornice esterna e le cui colonne sono appunto separate da linee verticali (tav 7b Vat gr 184 f 17v e tav 8 Par gr 2390 f 9v cui egrave sostanzialmente identica la tabella del Marc gr 314 che si trova
90 Trascuro lrsquoabbreviazione αο = πρῶτος percheacute la desinenza non egrave quella richiesta neacute nella frase (egrave richiesto πρῶτον) neacute nella tabella (πρῶτα)
Fabio Acerbi160
al f 248r ndash ma la mancanza di linee orizzontali causa un gigantesco pa-sticcio nel codice vaticano) Alla recensione bizantina che dipende per il suo testo di base dal Vat gr 1594 e quindi non trova la linea a zig-zag nella tabella non resta che sopprimere la sua descrizione ndash ma proprio per questo motivo e finalmente diventa possibile tracciare un apparato completo di linee di giustificazione (tav 9 Laur Plut 89 sup 48 f 14v) Dato che la descrizione di Teone di questo procedimento di divi-sione non fa cenno allrsquoesistenza della linea a zig-zag viene da chiedersi se essa non costituisca un espediente escogitato dallrsquoautore dei Prolegomena per vivacizzare la procedura originale di Pappo
4) Discrepanze tra descrizione e tabella Il gioco delle minime va-rianti mostra che la divisione era stata eseguita (e trasmessa) corret-tamente tutti i valori numerici sono esatti La tabella nel Marc gr 313 presenta perograve alcune discrepanze con la propria descrizione Essa omette (ma non nella versione lsquoscorrettarsquo lrsquoomissione non si riscontra neanche nel Par gr 2390) il segno per laquorestoraquo di fronte ai resti par-ziali ma aggiunge lrsquoindicazione della loro specie Essa trasforma invece come abbiamo visto le indicazioni di specie che seguono i quozienti parziali in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordinali corri-spondenti La descrizione prevede di chiudere la tabella con il risultato καὶ συνάγων ἅπαντα τὰ ἐκ τῶν μερισθέντων μερῶν λεπτὰ σημειοῦται ὑπὸ πάντας οὕτως γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoe raccogliendo tutti i minuti che provengono dalle parti divise lsaquoPapporsaquo nota sotto tutto cosigrave Ris 0 59 8 17 13 12 31raquo ma sotto la tabella tutta la tradizione ci consegna qualcosa di piugrave articolato ὁ ζητούμενος καθ᾽ ὃν μερίζεται ὁ τξε ιδ´ μη´´ π(αρὰ) τὸν τξ γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoil lsaquonumerorsaquo cercato secondo cui 365 14 48 egrave diviso per 360 risulta 0 59 8 17 13 12 31raquo frase che del resto contiene due errori lrsquoinversione del dividendo e del divisore e la confusione tra segno convenzionale (iuxta descrizione) e abbreviazione (come nella frase) nel caso di γι Oltre ad eliminare la linea a zig-zag91 la recensione bizantina sopprime dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali e modifica come abbiamo visto al punto 2 le loro descrizioni in quelle di apici associati diretta-mente ai numerali di molteplicitagrave
91 Le due righe che nella recensione di base contengono solo i resti parziali minori di 160 del divisore ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue sono in parte completate con lrsquoindicazione abbreviata ἀνάλ(υσις) laquoanalisiraquo il termine greco per questa procedura di riduzione In un sussulto di ipercorrettismo matematico tali resti parziali ridotti non sono preceduti dal segno per laquorestoraquo come nel Par gr 2390 ma da quello per laquorisultatoraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 161
Gli esempi che abbiamo discusso mostrano come i problemi di notazione pesino e non poco sullrsquoespressione discorsiva di un algorit-mo matematico lrsquoente di riferimento per lsquoformularersquo il procedimento di divisione fu considerata la tabella cioegrave un oggetto la cui costitu-zione egrave legata piugrave ad una pratica grafica che a considerazioni logico- algoritmiche non la sua descrizione che in effetti finisce per determi-nare la tabella in maniera non univoca Di questa sottodeterminazione si fa testimone la traiettoria che abbiamo cercato di seguire nelle mani di copisti e revisori il procedimento di divisione si modifica a volte in aspetti secondari a volte in punti piugrave sostanziali ndash fino a rendere neces-saria una radicale revisione della sua descrizione per renderla conforme alla tabella ndash in ogni caso mai per ragioni squisitamente matematiche92
Abstract
The article presents and discusses in detail two passages from the anonymous Prolegomena to the Almagest a VIth century primer to the elementary procedures of calculation needed in Ptolemyrsquos Almagest In the two passages we may follow the complex interplay between mathematical notation the auctor who employed and described it the tachygrapher who transcribed it in vivo copyists who reproduced it correctors who modified it Along this path misgivings and errors arise in the transmission of abbreviations and paratextual units such as diagrams tables operational schemes
Fabio AcerbiCNRS UMR8560 Centre Alexandre Koyreacute
fabacerbigmailcom
92 Sono grato a Daniele Bianconi Lucio del Corso Jean Lempire per alcune preziose indicazioni
AOO = Archimedis opera omnia cum commentariis Eutocii ed J L Heiberg I-III Lipsiae 1910-1915
DOO = Diophanti Alexandrini opera omnia cum Graecis commentariis ed P Tannery I-II Lipsiae 1893-1895
GC = Le laquoGrand Commentaireraquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Mogenet ndash A Tihon I-III Cittagrave del Vaticano 1985-1999
iA = Commentaires de Pappus et de Theacuteon drsquoAlexandrie sur lrsquoAlmageste ed A Rome I-III con paginazione continua Cittagrave del Vaticano 1931-1943
HOO = Heronis Alexandrini opera quae supersunt omnia ed G Schmidt ndash L Nix ndash W Schmidt ndash H Schoene ndash J L Heiberg I-V Lipsiae 1899-1914
PC = Le ldquoPetit Commentairerdquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed A Tihon Cittagrave del Vaticano 1978
POO = Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia ed J L Heiberg I-II in 3 parti Lipsiae 1898-1907
RGK = Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600 I Handschriften aus Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln II Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs und Nachtraumlge zu den Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln III Handschriften aus Bibliotheken Roms mit dem Vatikan A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg unter Mitarbeit von D Harlfinger und P Eleuteri B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln Wien 1981-1997 (Oumlsterreichische Akademie der Wissenschaften Veroumlffentlichungen der Kommission fuumlr Byzantinistik III1-3 A-C)
Sigla
Acerbi 2010 = F Acerbi Il silenzio delle sirene La matematica greca antica Roma 2010
Acerbi 2012 = F Acerbi I codici stilistici della matematica greca dimostrazioni procedure algoritmi laquoQUCCraquo 1012 (2012) pp 167-214
Acerbi et al 2010 = F Acerbi ndash N Vinel ndash B Vitrac Les Proleacutegomegravenes agrave lrsquoAlmageste Une eacutedition agrave partir des manuscrits les plus anciens Introduction geacuteneacuterale ndash Parties I-III laquoSCIAMVSraquo 11 (2010) pp 53-210
Agati 1992 = M L Agati La minuscola laquoBouleteacuteeraquo Cittagrave del Vaticano 1992
Belger 1881 = C Belger Ein neues Fragmentum mathematicum Bobiense laquoHermesraquo 16 (1881) pp 261-284
Bianconi 2005a = D Bianconi La biblioteca di Cora tra Massimo Planude e Niceforo Gregora Una questione di mani laquoSampTraquo 3 (2005) pp 391-438
Bianconi 2005b = D Bianconi Tessalonica nellrsquoetagrave dei Paleologi Le pratiche intellettuali nel riflesso della cultura scritta Paris 2005
Bianconi 2006a = D Bianconi Le pietre e il ponte ovvero identificazioni di mani e storia della cultura laquoBizantinisticaraquo 8 (2006) pp 135-181
Bianconi 2006b = D Bianconi Qualcosa di nuovo su Giovanni Catrario laquoMEGraquo 6 (2006) pp 69-91
Cavallo 1977 = G Cavallo Funzione e strutture della maiuscola greca tra i secoli VIII-XI in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Colloque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 95-137
Cereteli 1904 = G F Cereteli De compendiis scripturae codicum Graecorum praecipue Petropolitanorum et Mosquensium anni nota instructorum Sankt-Petersburg 1904
De Gregorio 2000 = G De Gregorio Materiali vecchi e nuovi per uno studio della minu-scola greca fra VII e IX secolo in G Prato (a cura di) I manoscritti greci tra riflessione e dibattito Atti del V Colloquio Internazionale di Paleografia Greca Cremona 4-10 ottobre 1998 Firenze 2000 pp 83-151
Follieri 1977 = E Follieri La minuscola libraria dei secoli IX e X in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Col-loque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 139-165
Fonkič 2005 = B Fonkič Venecianskaia rukopisrsquo laquoAlrsquomagestaraquo Ptolemeja (Marc gr 313690) o datirovke i proischoždenii kodeksa laquoVDIraquo s III 254 (2005) pp 162-167
Fowler 1999 = D H Fowler The Mathematics of Platorsquos Academy A New Reconstruction Second Edition Oxford 1999
Bibliografia
Fabio Acerbi164
Gerstinger ndash Vogel 1932 = H Gerstinger ndash K Vogel Eine stereometrische Aufgaben-sammlung im Papyrus Graecus [sic] Vindobonensis 19996 laquoMitteilungen aus der Papy-russammlung der Nationalbibliothek in Wienraquo Neue Serie Folge 1 Griechische literarische Papyri 1 Wien 1932 pp 11-76
Heiberg 1927 = Mathematici Graeci Minores ed J L Heiberg Kjoslashbenhavn 1927
Hultsch 1876-1878 = Pappi Alexandrini Collectionis quae supersunt ed F Hultsch I-III Berlin 1876-1878
Janz 2003 = T Janz The Scribes and the Date of the Vat gr 1291 in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae X Cittagrave del Vaticano 2003 pp 159-180
Jones 1990 = Ptolemyrsquos First Commentator ed A Jones Philadelphia 1990
Jones 1999 = Astronomical Papyri from Oxyrhynchus ed A Jones I-II Philadelphia 1999
Jones 2005 = A Jones Ptolemyrsquos Canobic Inscription and Heliodorusrsquo Observation Reports laquoSCIAMVSraquo 6 (2005) pp 53-97
Lempire 2014 = Steacutephanos drsquoAlexandrie Le commentaire aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Lempire Louvain 2014
Leurquin 1990 = Theacuteodore Meacuteliteacuteniote Tribiblos astronomique Livre I ed R Leurquin Amsterdam 1990
Leurquin 1991 = R Leurquin Un manuscrit autographe de la Tribiblos Astronomique de Theacuteodore Meacuteliteacuteniote le Vaticanus graecus 792 laquoScriptoriumraquo 45 (1991) pp 145-162
Maas 1927 = P Maas Griechische Palaeographie in A Gercke ndash E Norden (hrsg von) Einleitung in die Altertumswissenschaft I9 Leipzig 1927 pp 69-80
Martinelli Tempesta 2010 = S Martinelli Tempesta Il codice Milano Biblioteca Am-brosiana B 75 sup (gr 104) e lrsquoevoluzione della scrittura di Giovanni Scutariota in A B Garciacutea ndash I Peacuterez Martiacuten (ed by) The Legacy of Bernard de Montfaucon Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting Proceedings of the Seventh Inter-national Colloquium of Greek Palaeography Madrid-Salamanca 15-20 September 2008 Turnhout 2010 pp 171-186
Mazzucchi 1994 = C M Mazzucchi Leggere i classici durante la catastrofe (Costantino-poli maggio-agosto 1203) le note marginali al Diodoro Siculo Vaticano gr 130 Parte prima stratigrafia laquoAevumraquo 68 (1994) pp 164-218
Mioni 1976 = E Mioni Bessarione scriba e alcuni suoi collaboratori in Miscellanea marcia-na di studi bessarionei Padova 1976 pp 263-323
Mioni 1985 = Codices graeci manuscripti Bibliothecae Divi Marci Venetiarum II Thesaurus Antiquus Codices 300-625 recensuit E Mioni Roma 1985
Mogenet 1962 = J Mogenet Une scholie ineacutedite du Vat gr 1594 sur les rapports entre lrsquoastronomie arabe et Byzance laquoOsirisraquo 14 (1962) pp 198-221
Mogenet et al 1983 = Niceacutephore Greacutegoras Calcul de lrsquoeacuteclipse de soleil du 16 juillet 1330 ed J Mogenet ndash A Tihon ndash R Royez ndash A Berg Amsterdam 1983
Mondrain 2002 = B Mondrain Maxime Planude Niceacutephore Greacutegoras et Ptoleacutemeacutee laquoPa-laeoslavicaraquo 10 (2002) pp 312-322
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 165
Mondrain 2004 = B Mondrain Lrsquoancien empereur Jean VI Cantacuzegravene et ses copistes in A Rigo (a cura di) Gregorio Palamas e oltre Studi e documenti sulle controversie teologiche del XIV secolo bizantino Firenze 2004 pp 249-296
Mondrain 2007 = B Mondrain Les eacutecritures dans les manuscrits byzantins du XIV e siegravecle Quelques probleacutematiques laquoRSBNraquo n s 44 (2007) pp 157-196
Peacuterez Martiacuten 2006 = I Peacuterez Martiacuten Maxime Planude et le Diophantus Matritensis (Madrid Biblioteca Nacional ms 4678) un paradigme de la reacutecupeacuteration des textes anciens dans la ldquorenaissance paleacuteologuerdquo laquoByzantionraquo 76 (2006) pp 433-462
Peacuterez Martiacuten 2008 = I Peacuterez Martiacuten El lsquoestilo Hodegosrsquo y su proyeccioacuten en las escrituras constantinopolitanas laquoSampTraquo 6 (2008) pp 389-458
Perria 1991 = L Perria Scrittura e ornamentazione nei codici della laquocollezione filosoficaraquo laquoRSBNraquo n s 28 (1991) pp 45-111
Rollo 2012 = A Rollo LrsquoArchimede di Giorgio Valla in V Fera ndash D Gionta ndash A Rollo (a cura di) Archimede e le sue fortune Atti del Convegno di Siracusa-Messina 24-26 giugno 2008 Messina 2012 pp 99-147
Rome 1927 = A Rome Membra disjecta laquoRBenraquo 39 (1927) pp 187-188
Rome 1938 = A Rome Un manuscrit de la bibliothegraveque de Boniface VIII agrave la Meacutediceacuteenne de Florence laquoACraquo 7 (1938) pp 261-268
Ronconi 2013 = F Ronconi La collection philosophique un fantocircme historique laquoScripto-riumraquo 67 (2013) pp 119-140
Tannery ndash Steacutephanou 1940 = Quadrivium de Georges Pachymegravere ed P Tannery ndash E Steacutephanou Cittagrave del Vaticano 1940
Tihon 2011 = Πτολεμαίου Πρόχειροι Κανόνες Les Tables faciles de Ptoleacutemeacutee vol Ia Tables A1-A2 ed A Tihon Leuven 2011
Traube 1907 = L Traube Nomina Sacra Versuch einer Geschichte der christlichen Kuumlrzung Muumlnchen 1907
Vogel 1936 = K Vogel Beitraumlge zur griechischen Logistik laquoSBAWraquo Mathematisch-natur-wissenschaftliche Abteilung Jahrgang 1936 pp 357-472
Wouters 1979 = A Wouters The Grammatical Papyri from Graeco-Roman Egypt Contri-butions to the Study of the lsquoArs Grammaticarsquo in Antiquity Brussel 1979
F ACERBI Tav 1
b Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 65r
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 284 f 160r
F ACERBITav 2
b Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 13r
a Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 19v
F ACERBI Tav 3
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 136v
F ACERBITav 4
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17r
F ACERBI Tav 5
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17v
F ACERBITav 6
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 7v
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 129
e nella terza tavola il numero di righe egrave piugrave basso percheacute occorre pre-vedere uno spazio per il titolo addizionale Per mantenerne il formato tripartito Heiberg egrave costretto a stampare le tavole ruotate di 90ordm
Che le tavole siano dei testi egrave confermato da due fatti aggiuntivi e strettamente connessi15 Primo il lsquomanuale di istruzionirsquo alle Tavole facili che Tolomeo stesso redasse fu scritto ed ha circolato come opera a parte Secondo dalla descrizione delle tavole dettagliata ma priva di costruzione contenuta nello stesso lsquomanualersquo egrave impossibile ricavarne il contenuto numerico e la maniera drsquoimpiego16 a illustrare questrsquoultima provvederagrave una ricchissima tradizione di commentari di cui leggiamo ancora quelli di Teone il lsquoPiccolo Commentariorsquo spiega come usarle per scopi specifici il lsquoGrande Commentariorsquo come dedurle dallrsquoAlmagesto17 Le Tavole facili sono insomma unrsquoopera il cui testo egrave interamente strut-turato in formato tabulare
3) Tabelle operazionali Una lsquotabella operazionalersquo egrave una disposi-zione ordinata di lettere numerali e altri segni grafici che rappresenta lrsquoalgoritmo di unrsquooperazione aritmetica Ci troviamo in realtagrave di fronte a due modi di eseguire lrsquooperazione la tabella intende in qualche mi-sura riprodurre la dinamica operazionale dellrsquoalgoritmo questrsquoultimo si risolve a sua volta in una descrizione della tabella che senza tale de-scrizione risulterebbe incomprensibile e quindi non adattabile ad una differente operazione una tabella operazionale ha in questo caso una funzione paratestuale Si presuppone perograve che il discente apprenda a ri-produrre lrsquooperazione direttamente nel formato tabellare non in quello algoritmico In questo secondo caso una tabella operazionale assume una funzione testuale piena18 Lo statuto (para)testuale delle tabelle operazionali egrave pertanto oscillante nei commentari teonini allrsquoAlmagesto e soprattutto nei Prolegomena ad Almagestum di cui andremo ad occu-parci esse sono descritte in dettaglio e si configurano pertanto come genuini paratesti in Eutocio in Circ esse sono semplicemente eseguite e quindi assumono un ruolo testuale Nei manoscritti medievali la col-locazione di una tabella operazionale originaria egrave variabile e dipende dalle sue dimensioni e dalla capacitagrave del copista di identificarla come
15 Per un argomento ulteriore si veda la sezione 4 punto b16 POO II pp 159-18517 Nessuno dei due titoli ha fondamento nella trasmissione manoscritta la seconda
opera era detta realizzare una συμφωνία tra lrsquoAlmagesto e le Tavole facili Entrambi i com-mentari sono stati editi criticamente PC GC I-III
18 Resta il fatto che la quasi totalitagrave delle tabelle operazionali che rintracciamo nei manoscritti egrave relegata nei margini dellrsquoattivitagrave di annotazione degli scoliasti
Fabio Acerbi130
tale di solito le troviamo nei margini ma possono occupare lrsquointero specchio di scrittura e ciograve indipendentemente dalla determinazione del loro statuto paratestuale sulla base del criterio della presenzaassenza di una descrizione
Lo statuto meno elevato dei genuini paratesti (diagrammi e tabelle) rispetto ai testi (catene algoritmico-argomentative e tavole) indusse un atteggiamento differenziato in copisti ed editori attenti a rispettare lrsquointegritagrave dei secondi ma non dei primi ciograve che conta sono le informa-zioni veicolate dalle strutture discorsive e dalle porzioni alfanumeriche di diagrammi tavole e tabelle il resto egrave ritenuto adattabile alle esigenze dellrsquoedizione moderna19 o semplicemente ignorato nel corso del pro-cesso di copia in questa maniera si perdono perograve informazioni e strut-tura Come vedremo puograve avvenire che una parte della descrizione di unrsquooperazione resti senza relato nella resa grafica tabellare lrsquooperazione eseguita in forma algoritmica non corrisponde piugrave a quella eseguita in forma di tabella
3 Testi logistici e disposizione tabellare delle operazioni
Nessun testo matematico primario di etagrave ellenistica o imperiale contiene operazioni aritmetiche eseguite con una sola eccezione la de-scrizione che non ammette una rappresentazione tabellare del procedi-mento di estrazione approssimata di radice quadrata in Erone Metr I 8 Drsquoaltro canto abbiamo giagrave osservato che lrsquoAlmagesto di Tolomeo for-nisce il risultato di migliaia di operazioni ma nessuna di esse egrave eseguita Attestazioni di questi procedimenti sono pertanto legate ad iniziative editoriali di secondo livello come i commentari alla loro prima occor-renza oppure in casi paradigmatici gli algoritmi di calcolo omessi nel testo primario vi sono resi espliciti Di fatto e con una sola eccezione la nostra documentazione consiste in commentari allrsquoAlmagesto quello di Teone e i Prolegomena ad Almagestum
19 Abbiamo giagrave visto alcuni esempi di modifiche del formato delle tavole Quanto ai diagrammi quelli tracciati nelle edizioni moderne rappresentano il caso piugrave generale pos-sibile Le figure che troviamo nei manoscritti greci hanno invece la caratteristica opposta illustrano spesso casi particolari e sono metricamente scorrette Sono in effetti tracciati triangoli rettangoli isosceli cerchi uguali rette perpendicolari dove tutto ciograve non egrave richiesto dallrsquoenunciato e inoltre rettangoli invece di parallelogrammi segmenti uguali quando sia-no disuguali addirittura linee rette al posto di curve (in Archimede Meth 14 un arco di parabola egrave rappresentato da un angolo rettilineo) e in generale figure con proprietagrave di simmetria non richieste
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 131
LrsquoAlmagesto e con esso tutta la tradizione astronomica adotta il sistema sessagesimale per esprimere la parte non intera di un nu-mero che siano valori angolari o lineari non fa differenza20 come noi scriviamo 36524 e intendiamo 365 + 2 decimi + 4 centesimi (cioegrave 4102) cosigrave nel sistema sessagesimale 365 14 48 significa21 365 + 14 sessantesimi + 48 tremilaseicentesimi (cioegrave 48602) ovverosia nel lessico antico e nostro 365 14 πρῶτα λεπτά laquominuti primiraquo 48 δεύτερα λεπτά laquominuti secondiraquo dove laquoprimoraquo e laquosecondoraquo sono le laquodenominazioniraquo degli ordini (sono cioegrave numeri ordinali) 14 e 48 i lsquonumerali di molteplicitagraversquo relativi ai due ordini numerale di mol-teplicitagrave e relativa denominazione costituiscono insieme una lsquoparte sessagesimalersquo di un numero Drsquoaltronde per gli antichi come per noi lrsquoespressione di una parte non intera (ovvero di una frazione)
20 Trascuro il fatto ai nostri fini irrilevante che essendo i numerali greci lettere alfabetiche la notazione che ne risulta per i numeri interi non egrave posizionale nonostante le cifre scagravelino di un posto ad ogni potenza di dieci il segno μ per 4 (decine) non egrave identico al segno δ per 4 (unitagrave) Drsquoaltra parte una volta adottata la notazione decimale per i numerali di molteplicitagrave la notazione complessiva per la parte non intera espressa nel sistema sessa-gesimale non egrave posizionale neanche introducendo un segno di lsquoposto vuotorsquo una cui parte egrave nel caso greco analoga in forma al nostro 0 (su questo segno si veda ancora la sezione 4 punto c) occorre avvalersi di accorgimenti ulteriori quali lrsquointroduzione di spaziature fra le differenti parti sessagesimali (come viene fatto nei manoscritti greci ed in questrsquoarticolo) o di segni tipografici (come suggerito da Otto Neugebauer che avrebbe scritto 3651448 il numerale che leggeremo tra un attimo nel testo) Il problema egrave che altrimenti lrsquoordine associato ad un numerale di molteplicitagrave di una parte sessagesimale puograve non risultare uni-vocamente determinato dalla sua posizione Esempio scrivendo 0129 per un numero non intero nel sistema sessagesimale il numerale di molteplicitagrave 129 potrebbe rappresentare 1 minuto primo e 29 secondi oppure 12 minuti primi e 9 secondi ecc e la stessa difficoltagrave si presenta nella notazione greca (per la nozione di lsquonumerale di molteplicitagraversquo si veda infra nel testo) Il problema scomparirebbe se adottassimo singoli segni differenti per tutti i nu-merali da 1 a 59 ndash ma neacute noi neacute i greci siamo stati disposti a introdurre una complicazione siffatta Si ricordi infine che al di fuori dei contesti astronomici il sistema di numerazione greco egrave decimale
21 Scriverograve i numerali in cifre arabe sempre in questo modo parte intera seguita dalle parti sessagesimali (minuti primi secondi ecc) con ogni ordine separato da uno spazio bianco Se la parte intera egrave assente il numerale inzia con uno 0 Nella trascrizione dei numerali in greco ogni numerale di molteplicitagrave sessagesimale o frazione unitaria saragrave identificato come nei manoscritti piugrave antichi dei Prolegomena da un opportuno numero di apici (uno per ogni unitagrave dellrsquoordine avendo le frazioni unitarie un solo apice come vedremo nellrsquoAlmagesto contenuto negli stessi codici troviamo barre non apici con questa funzione) mentre la parte intera saragrave priva della barra che la sormonta invariabilmente nei manoscritti In questo modo 365 14 48 egrave la conversione in cifre arabe di τξε ιδ´ μη´´ La pratica dei manoscritti medievali egrave di collocare gli apici (quando presenti) sopra le lettere numerali per ragioni tipografiche li porrograve di seacuteguito al gruppo di lettere cui si riferiscono Si noti che nella notazione greca il segno ιδ´ per 1460 in sessagesimale egrave identico a quello per 114 in decimale Nel caso delle frazioni unitarie la presenza dellrsquo(unico) apice egrave la traduzione semiotica della trasformazione che a livello grammaticale egrave effettuata con il pas-saggio dal cardinale allrsquoordinale (ad esempio da τὰ τρία laquotreraquo a τὸ τρίτον laquoun terzoraquo) si veda anche la sezione 4 punto 1 e note 82 e 86 ivi incluse
Fabio Acerbi132
richiede sempre lrsquointroduzione di due numerali il lsquonumeratorersquo e il lsquodenominatorersquo
Il motivo della scelta del sistema sessagesimale che fu mutuato dallrsquoastronomia matematica babilonese egrave presto detto lrsquoelevato numero di divisori di 60 e cioegrave 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 Poicheacute i divi-sori di 10 sono un sottinsieme di quelli di 60 molti piugrave numeri hanno una rappresentazione finita nel sistema sessagesimale che in quello deci-male Calcolare in sessagesimale lungi dal creare difficoltagrave offre quindi un vantaggio cruciale22 che risulta piugrave facilmente comprensibile sulla base dellrsquoesempio seguente La lunghezza dellrsquoanno solare egrave stabilita da Tolomeo in 365 giorni + 14 ndash 1300 di giorno Per calcolare il moto giornaliero del sole si rende necessario dividere 360 per questo numero Noi avremmo due opzioni se non potessimo usare la calcolatrice ri-durre il divisore ad una singola frazione tramite passaggio al denomi-natore comune invertire questa frazione e moltiplicarla per 360 sem-plificare gli eventuali fattori comuni e finalmente eseguire la divisione a piugrave cifre tra numeri interi (nel nostro caso 5400054787) oppure scrivere il divisore come numero decimale periodico (365246666 hellip) e poi eseguire la divisione Nel sistema sessagesimale egrave tutto molto piugrave semplice 365 + 14 ndash 1300 ha una rappresentazione finita cioegrave 365 14 48 come eseguire la divisione lo vedremo tra un attimo
Passiamo dunque in rassegna il contenuto del lsquomanuale di logisticarsquo incluso nei Prolegomena ad Almagestum riportando in nota per ogni item anche esposizioni parallele in altri commentatori23
a) Costruzione del sistema sessagesimale24
22 E uno svantaggio se le molteplicitagrave dei singoli ordini vengono espresse in no-tazione decimale (come facciamo noi e facevano i greci) il numero di cifre necessario per raggiungere una precisione assegnata egrave maggiore nel sistema sessagesimale in quanto per esprimere i numerali da 10 a 59 occorrono due cifre mentre per quelli da 1 a 9 (o da α a θ e le decine da ι a ν nel caso greco) ne basta una e ciograve indipendentemente dal fatto che la notazione sia posizionale oppure no La differenza si fa perograve sentire solo a partire dal quinto ordine sessagesimale
23 Trascuro la parte finale del lsquomanualersquo dove sono esposte le regole di interpolazione (cui era legata la lsquoterza colonnarsquo della tavola delle corde tolemaica) e il procedimento di lsquosottrazionersquo di rapporti cioegrave la divisione di un rapporto per un altro
24 Per a-b cf Teone in Alm I 10 in iA pp 44919-45814 PC pp 2007-2014 GC I pp 10910-11124 e le definizioni e regole diofantee di manipolazione delle varie specie numeriche in Arithmetica prefazione in DOO I pp 214-1218 Le porzioni a-b sono giagrave state pubblicate da Paul Tannery in DOO II pp 318-1517 sulla base del Par gr 453 apografo ad opera di Giovanni Santamaura di un Vat gr 1594 giagrave mutilo (RGK II nr 238 ma lrsquoautore trascritto vi egrave indicato come lsquoPtolemaiosrsquo) Evidentemente il committente non fu soddisfatto della prima trascrizione (ff 67-76) che crivella di tratti rossi a segnalarne gli errori di copia Ne fu dunque eseguita una seconda (ff 78-86) cui Santamaura antepose
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 133
b) Regole di moltiplicazione e divisione degli ordini sessagesimali defini-zione generale di moltiplicazione moltiplicazione di ordini come somma delle loro laquodenominazioniraquo Definizione generale di divisione divisione di ordini uguali e di un ordine per quello che lo precede immediata-mente divisione di ordini come sottrazione delle loro laquodenominazioniraquo divisione per 60 come divisione per 1 accompagnata dallo slittamento di un posto dellrsquoordine
c) Problemi che sorgono nella divisione di una parte sessagesimale per una di quelle che seguono divisione breve per riduzione allo stesso ordine (metodo laquoper analisiraquo) due algoritmi differenti il secondo con riduzione dei fattori comuni attribuito a Siriano
d) laquoAltroraquo metodo di divisione breve in realtagrave divisione tra somme di parti sessagesimali appartenenti ad ordini differenti per riduzione allo stesso ordine e applicazione dei metodi precedenti esempio della divisione di 0 2 0 4 per 0 0 2 0 240
e) Metodo di moltiplicazione tra numeri con parti non intere disposizione tabellare dei termini esempio della moltiplicazione di 5 4 6 per 8 0 3 0 525
f ) Primo metodo di divisione lunga descrizione della disposizione tabellare ed esempio di algoritmo applicato alla divisione di 50 48 26 30 per 8 16 28 5426
g) Metodo di divisione lunga tratto da Pappo in Alm III descrizione della disposizione tabellare ed esempio di algoritmo applicato alla divisione di 360 per 365 14 48 come verifica del valore 0 59 8 17 13 12 31 fornito nellrsquoAlmagesto per il moto medio giornaliero del sole27
h) Metodo di approssimazione di una radice quadrata secondo Erone Metr I 8 con giustificazione geometrica di Teone (attualmente non attestata in suoi scritti)
i) Verifica tramite moltiplicazione della correttezza del valore tolemaico28 di 67 4 55 come radice quadrata approssimata di 4500 Metodo di estrazio-ne di radici quadrate secondo Teone basato su applicazioni successive di Elementi II 4 la procedura termina dopo un numero finito di passi nel caso di quadrati perfetti Applicazione al calcolo della radice quadrata di 450029
unrsquoannotazione spazientita laquoIl texto di questo 2do quinterno egrave stato recopiato fidelmente dallrsquooriginale a chi volesse vedere la prova lo potragrave conferire con detto originale le pagine del qual texto corrispondono con quelle dellrsquooriginale tanti versi che pagine [hellip]raquo (Moge-net 1962 p 200)
25 Teone in Alm I 10 e I 14 in iA pp 45815-4604 e 57911-5811026 Teone in Alm I 10 in iA pp 4611-46217 applicato alla divisione di 1515 20
15 per 25 12 1027 Teone in Alm III 1 e IV 3 in iA pp 84112-84422 (stesso calcolo dei Prolego-
mena) e 102916-10327 idem in Alm IX pp 377-378 dellrsquoedizione di Basilea del 1538 approntata dai tipografi di Walderus Lrsquooriginale pappiano non ci egrave pervenuto
28 Alm I 10 in POO I 1 p 341129 Teone in Alm I 10 in iA pp 46916-4738
Fabio Acerbi134
Lrsquounico testo non elencato qui sopra o nelle note e che contenga tabelle operazionali egrave il commentario eutociano a Circ 3-4 Il testo ar-chimedeo che Eutocio e noi con lui leggeva egrave particolarmente conciso ed egli verifica esplicitamente il sussistere di certe relazioni numeriche Si tratta in ognuno dei nove casi presenti di mostrare che il lsquoteorema di Pitagorarsquo egrave verificato con ottima approssimazione dai valori numerici di opportune terne di rette Eutocio esegue le tre moltiplicazioni dei valori per se stessi e mostra che la somma o la differenza di due dei risultati si discosta di poco dal terzo30 I numeri in questione sono interi seguiti o no da una parte non intera espressa come somma di frazioni unita-rie31 I nove gruppi di tre moltiplicazioni una a fianco allrsquoaltra sono organizzati in forma tabellare ma senza lrsquoausilio di linee separatrici32 le operazioni sono eseguite disponendo lsquoin colonnarsquo i risultati delle mol-tiplicazioni parziali e sommandoli esattamente come facciamo oggi poicheacute sono in gioco numeri interi con parti frazionarie unitarie e la notazione non egrave posizionale non egrave necessario che gli incolonnamenti siano esatti (unitagrave di un risultato parziale sotto le decine del precedente ecc) Sono inclusi nella tabella istruzioni e commenti in linguaggio corrente33 le prime relative allrsquooperazione da affettuare sui risultati delle
30 Eutocio non calcola radici quadrate approssimate per quanto ciograve si renda piugrave volte necessario fornisce il risultato e verifica la sua correttezza moltiplicandolo per se stesso Egli dichiara che il lettore interessato a questo procedimento di calcolo puograve rivolgersi Ἥρωνι ἐν τοῖς μετρικοῖς [hellip] Πάππῳ καὶ Θέωνι καὶ ἑτέροις πλείοσιν ἐξηγουμένοις τὴν μεγάλην σύνταξιν τοῦ Κλαυδίου Πτολεμαίου laquoa Erone nei Metrica [hellip] a Pappo e Teone e a svariati altri inter-preti della Grande composizione di Claudio Tolomeoraquo (AOO III p 23213-17)
31 Troviamo ad esempio ͵αωλη θ´ ια´ cioegrave 1838 + 19 + 111 notare il singolo apice per le frazioni unitarie
32 Essi sono editi in AOO III pp 234-256 La tradizione medievale del commentario eutociano che coincide con un ramo di quella archimedea e deriva da un codice appar-tenuto a Giorgio Valla perduto in etagrave rinascimentale ma riprodotto a volte con fedeltagrave assoluta negli apografi (si veda ad esempio nella tav 1a la riproduzione dellrsquoerronea di-sposizione di cifre e parte algoritmica nel primo gruppo di moltiplicazioni offerta dal Laur Plut 284 f 160r) egrave costituita da Marc gr 305 ff 142v-146v Laur Plut 284 ff 159r-164r Par gr 2360 ff 109v-113v Par gr 2361 pp 410-421 Nel codice veneziano in cui la disposizione per righe e colonne egrave irrimediabilmente alterata dal copista le operazioni sono cancellate con tratti di penna Il primo manoscritto fu esemplato per Bessarione da Giorgio Trivizias tra il 1455 e il 1468 (Mioni 1976 pp 309-312) il secondo fu vergato da Giovanni Scutariota in scrittura di imitazione (Martinelli Tempesta 2010 p 173 n 7 Rollo 2012) ca 1491-1492 il terzo fu trascritto per il cardinale di Firenze Niccolograve Ridolfi dopo che la biblioteca di Valla era stata acquistata a seacuteguito della sua morte avve-nuta il 23 gennaio 1500 per 800 scudi drsquooro da Alberto Pio di Carpi (nota del copista al f 120v) il quarto fu terminato per mano di Christopher Auer su commissione di Georges drsquoArmagnac il primo gennaio 1544 (sottoscrizione a p 474 del codice si veda RGK II nr 525)
33 A questi va aggiunto posto davanti al risultato finale di ogni moltiplicazione il segno convenzionale per ὁμοῦ laquoinsiemeraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 135
prime due moltiplicazioni34 i secondi alla bontagrave dellrsquoapprossimazione ottenuta35 Ogni gruppo di operazioni che chiude unrsquounitagrave esegetica ed egrave seguito dalla citazione che apre la successiva egrave trascritto come se facesse parte del testo a tutta pagina e preceduto dallrsquoindicazione οἱ δὲ πολλαπλασιασμοὶ ὑπόκεινται laquole moltiplicazioni sono poste qui sottoraquo Questi due fatti suggeriscono che tutte le operazioni cui Eutocio non fa alcun riferimento nel corpo del suo commentario siano unrsquoaggiunta editoriale risalente a Isidoro di Mileto che si occupograve della revisione del testo36
Gli incolonnamenti esatti sono invece necessari quando siano moltiplicati numeri con parti non intere espresse nel sistema sessage-simale in quanto la somma finale dei prodotti parziali va effettuata ordine per ordine Tale somma eccederagrave di norma il valore di 60 per un ordine dato nella tabella occorre pertanto trovare posto anche per i riporti che vanno sommati ai prodotti parziali dellrsquoordine preceden-te e quindi incolonnati con essi I testi ci offrono alcuni esempi di tabelle operazionali moltiplicative di questo tipo Teone afferma espli-citamente che la prima moltiplicazione che va a descrivere ha una rap-presentazione tabellare la cui disposizione ritroviamo pesantemente ingarbugliata nel Laur Plut 2818 f 35r37 Alla seconda occorrenza di una moltiplicazione eseguita (tav 1b Laur Plut 2818 f 65r) gli incolonnamenti sono meglio rispettati anche se il risultato finale egrave fatto erroneamente slittare di un posto verso destra i riporti (con un errore) si trovano nella penultima riga38 Nei Prolegomena ad Alma-gestum alcune moltiplicazioni sono accompagnate da tabelle quella meglio attestata egrave associata alla moltiplicazione di 67 4 55 per se stesso (sezione i nel riassunto fornito supra) ed egrave descritta additando sempli-cemente ad un ente materiale oramai inaccessibile forse tracciato in loquendo lsquoalla lavagnarsquo
34 Come λοιπὸν τὸ ἀπὸ ΕΓ laquoresta quello su ΕΓraquo seguito dal risultato della sottrazione di due quadrati
35 Come λείπει ἄρα μο β εἰς τὸ ἀκριβές laquomancano quindi 2 u(nitagrave) al risultato esattoraquo36 Si legga la sottoscrizione spuria ad AOO III p 26010-1237 Si legga la frase ἐκτίθεμαι αὐτὴν καὶ πάλιν αὐτὴν ὑφ᾽ αὑτὴν ὡς ὑπογέγραπται laquolo [scil il
valore del lato da moltiplicare per se stesso] dispongo lsaquouna voltarsaquo e di nuovo al sotto di se stesso come trascritto qui sottoraquo in iA p 45817 Il Laur Plut 2818 (Teone e Pappo Commentaria in Almagestum) egrave uno dei piugrave antichi manoscritti in minuscola sicuramente assegnabile alla prima metagrave del IX secolo (Follieri 1977 p 144 n 23 Maas 1927 p 76 n 17 riteneva che fosse piugrave antico del Tetraevangelo Uspenskij) per una sua analisi si veda Rome 1938
38 In nessuno dei due casi i numerali di molteplicitagrave sono segnalati con apici sono tutti sormontati da una barra si veda la sezione 4 punto b
Fabio Acerbi136
προκείσθω δὶς τὸ μῆκος αὐτῆς ὀφεῖλον τὴν τάξιν τοῦ κατὰ τοὺς πολλαπλασιασμοὺς κανόνος ἀποδοῦναι καὶ ἐκκείσθω ἐπὶ σελιδίων διαγεγραμμένων οὕτω καὶ δὴ αὐτῆς ἐφ᾽ ἑαυτὴν πολ-λαπλασιασθείσης γεγονέτωσαν τὰ ἐν τοῖς οἰκείοις σελιδίοις εἴδη ταῦτα δὴ συναγόμενα καθ᾽ ἣν ὑπεδείξαμεν τάξιν ποιήσει τὰς ὑπογεγραμμένας μοίρας ἢ καὶ λεπτά τινα εἴσι ͵δυϙθ νθ´ ιδ´´ ι´´´ κε´´´´ ὡς λείπειν τοῦ ἐπιμερισθῆναι ŏ ŏ με´´ μθ´´´ λε´´´´
che sia prescritto che la sua lunghezza debba figurare due volte nella disposizione della tavola delle moltiplicazioni e che lsaquoquestrsquoultimarsaquo sia disposta su colonne delimitate da linee cosigrave mdash E pertanto una volta moltiplicato lsaquoil latorsaquo per se stesso che le specie trovino posto nelle colonne appropriate quelle che vengono cosigrave raccolte secondo la disposizione che abbiamo indicato produrranno dunque i gradi o anche i minuti qui sotto trascritti 4499 59 14 10 25 in modo che dalle divisioni successive resti39 0 0 45 49 35
La tabella associata (tav 2a Marc gr 313 f 19v) contiene una sola svista grossolana reca 51 invece di 55 in ognuno dei due fattori posti affiancati sopra di essa Al di sotto preceduto dal segno convenzionale per ὁμοῦ egrave collocato il risultato incongruamente sfalsato di un paio di colonne e con la lettera numerale ͵δ priva di barra sormontante in-naturalmente disconnessa da υϙθ I riporti sono indicati dai numerali ι ρκγ´ η´´ ν´´´ posti al fondo delle prime quattro colonne Il calcolo egrave corretto in ogni sua parte
Il clou in questo piccolo spaccato delle interazioni testo-paratesto matematico risiede nella descrizione contenuta nei Prolegomena della disposizione tabellare di due procedimenti di divisione il primo ano-nimo e quindi da supporre tradizionale il secondo piugrave efficiente ed attribuito al matematico del IV secolo Pappo
Il primo metodo di divisione egrave sostanzialmente analogo a quello che usiamo attualmente Dividendo e divisore questrsquoultimo preceduto da un segno su cui ritorneremo nella prossima sezione sono posti uno sotto lrsquoaltro intervallati da una riga inizialmente vuota Primo passo viene reperito il massimo multiplo del divisore che sia minore del di-videndo esso viene trascritto sotto il dividendo nella prima lsquocasellarsquo della riga vuota recante in testa un segno per laquosottrairaquo il fattore mol-tiplicativo (o quoziente parziale) viene trascritto in una lsquocasellarsquo pre-ceduta da un segno per laquorisultaraquo sotto il divisore Secondo passo il massimo multiplo viene sottratto dal dividendo il resto cosigrave ottenuto egrave trascritto preceduto da un segno per laquorestoraquo in una casella posta
39 Lrsquoautore concettualizza il procedimento di estrazione di radice quadrata come una forma di divisione
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 137
accanto al dividendo40 I due passi precedenti sono quindi ripetuti con la sola differenza che il resto appena ottenuto prende il posto del divi-dendo il quoziente parziale scala di un ordine sessagesimale ad ogni passo41 E cosigrave via aggiungendo ogni volta due caselle La debolezza di questo metodo come di quello che utilizziamo attualmente risiede nel fatto che il reperimento dei quozienti parziali (ovverosia dei massimi multipli) viene effettuato per tentativi non riuscire a farlo al primo colpo appesantisce notevolmente i calcoli successivi e costringe ad un lavoro di riordino e addizione dei quozienti parziali stessi La tabella risultante dove appunto osserviamo questo fenomeno in parallelo con identiche inaccuratezze nella descrizione ha la forma riprodotta unico tra i manoscritti della recensione antica nel Marc gr 313 f 13r (tav 2b invito il lettore a non rivolgersi alle tavole se non dopo aver termi-nato questa sezione sarebbe anzi auspicabile che tentasse di ricostruire questa tabella e le due successive a partire dalla mia descrizione)42
Il secondo metodo di divisione attribuito a Pappo egrave congegnato in modo da rendere non aleatoria la ricerca dei quozienti parziali Come altrove nei Prolegomena la descrizione della procedura di calcolo si riag-gancia esplicitamente a una frase di Tolomeo laquouna volta dimostrato che il periodo di una singola rivoluzione lsaquodel solersaquo egrave di 365 giorni 14 48 se di-vidiamo per essi i 360 gradi di un singolo cerchio avremo il moto medio giornaliero del sole circa 0 gradi 59 8 17 13 12 31raquo43 Questrsquoaffermazione si trova nel terzo libro dellrsquoAlmagesto si tratta della prima occasione in cui viene effettuata una divisione in cui il divisore egrave maggiore del dividendo e i commentatori del trattato tolemaico non si fecero sfuggire lrsquooccasione di mostrare come eseguirla Ora il terzo libro del commentario di Pappo non ci egrave pervenuto Ci resta dunque come testo parallelo a quello dei Prolegomena la descrizione rigidamente formulare in Teone sicuramente un calco di quella pappiana Teone qui come nelle altre applicazioni del metodo (Laur Plut 2818 ff 136v [tav 3] e 190r) descrive brevemente ed espone esplicitamente la stessa tavola dei sottomultipli del divisore che
40 Esempio nella divisione di 378 per 17 il massimo multiplo egrave 374 il quoziente parziale egrave 22 il resto 4 e in effetti 378 = 374 + 4 = 17times22 + 4 Si noti che il segno per laquorestoraquo non egrave apposto in testa di riga ma davanti a ogni resto parziale e in effetti il dividendo che si trova in prima posizione in questa riga non egrave un resto
41 Analogamente nellrsquoalgoritmo moderno poniamo la virgola o scaliamo la cifra di un posto
42 Nei Prolegomena la descrizione della tabella associata al metodo anonimo egrave pre-ceduta da una breve sinossi dellrsquooperazione in stile procedurale (cioegrave senza riferimenti alla tabella) e seguita dalla sua esecuzione accurata ma con pochi riferimenti alla tabella se non quello ai due segni da apporre ai resti parziali e ai massimi multipli
43 Alm III 1 in POO I 1 p 2091-4
Fabio Acerbi138
troviamo nei Prolegomena ma non offre alcuna descrizione della disposi-zione tabellare della divisione stessa neacute vi fa riferimento
A questa procedura sono in effetti associate una tavola e una tabel-la costruite come segue (tavv 4 e 5 Marc gr 313 ff 17r e 17v il co-pista era ndash giustamente ndash insoddisfatto della prima versione) La tavola le cui righe e colonne sono delimitate da linee contiene sottomultipli44 del divisore 365 14 48 9 righe che riportano i valori da 160 a 960 piugrave altre 6 con i valori per decine da 1060 a 6060 la prima colonna elenca le 15 parti sessagesimali omettendo come drsquoabitudine la laquodenomina-zioneraquo dellrsquoordine (i numerali elencati sono quindi α β γ δ ε ϛ ζ η θ ι κ λ μ ν ξ) la seconda i sottomultipli corrispondenti organizzati su quattro colonne per tener conto dei tre ordini sessagesimali (il primo sottomultiplo egrave quindi ϛ ε´ ιδ´´ μη´´´ cioegrave 160 di τξε ιδ´ μη´´) La tabella priva di linee delimitanti espone la vera divisione Nella prima colonna troviamo i resti parziali ognuno preceduto dallrsquoindicazione del proprio ordine sessagesimale e da un segno per laquorestoraquo Nella seconda preceduti da un segno per laquosottrairaquo i sottraendi ognuno coincide ovviamente con uno dei sottomultipli nella tavola La terza colonna contiene se-guiti dallrsquoindicazione del proprio ordine sessagesimale i quozienti par-ziali ottenuti trascrivendo dalla prima riga della tavola il numerale corrispondente al sottraendo affiancato ed assegnando come ordine sessagesimale il successivo a quello posto in testa di riga Il risultato preceduto da un segno per laquorisultaraquo e posto al di sotto della tabella si ottiene sommando i quozienti parziali il procedimento non permette in generale di determinare lrsquointero quoziente parziale relativo ad un ordine sessagesimale fissato se non dopo due passi Una linea spezzata unisce i resti parziali successivi e i relativi sottraendi per evidenziare la laquoprogressione della proceduraraquo la spezzata lsquosaltarsquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore (le cui righe sono per il resto vuote) e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue di conseguenza anche il quoziente parziale relativo a questo resto appartiene allrsquoordine sessagesimale successivo
A questo punto possiamo rivolgerci alle tavv 4-5 e verificare se le immagini che ci siamo formati sulla base della mia descrizione corri-spondono a quelle che troviamo nel Marc gr 313 Non si tratta di un giochetto sterile egrave al contrario il cuore di un intrico di problemi Un primo ordine di problemi deriva dal fatto che nei Prolegomena lrsquoalgo-
44 Sottomultipli e non multipli in quanto il divisore egrave maggiore del dividendo Drsquoaltronde nel sistema sessagesimale come in quello decimale un sottomultiplo si ottiene dal multiplo corrispondente semplicemente scalando tutte le cifre di un posto (ad esempio 1360 di 365 14 48 si ottiene in questa maniera da 13 volte 365 14 48)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 139
ritmo della divisione lsquoalla Papporsquo non egrave mai eseguito (cioegrave formulato verbalmente) in maniera indipendente dalla descrizione della tabella Comrsquoegrave dunque possibile descrivere una tabella operazionale che non ha uno statuto testuale indipendente sulla base di un algoritmo in corso di esecuzione E drsquoaltro canto come non rilevare unrsquoanomalia in un algoritmo eseguito nella sua forma primaria sotto forma di descrizione di una tabella Ci potremmo chiedere se viene descritto lrsquoalgoritmo o la tabella La tensione fra i due enti grafici egrave acuita dal fatto che nei nostri testi tutto ciograve (esposizione o descrizione di un algoritmo o della tabella associata) avviene sempre e solo sulla base di un esempio numerico para-digmatico Per questo motivo la tabella in quanto struttura (cioegrave privata dei dati numerici accidentali) non puograve fare a meno della descrizione45 Dal canto suo Teone come forse Pappo ancor prima descrive ed espone la tavola dei (sotto)multipli ma non la tabella di divisione lrsquoalgoritmo relativo a questrsquoultima egrave espresso come per controbilanciare in maniera eccezionalmente trasparente e formulare Se ciograve comporta un guada-gno a livello verbale-argomentativo sorge un problema operativo grave come e dove sistemare i resti e i quozienti parziali ndash cioegrave tutti i numeri in output dellrsquoalgoritmo differenti dai (sotto)multipli ndash che la tabella si incarica di disporre in modo lsquonaturalersquo Teone prescrive soltanto di confrontare i resti con la seconda colonna della tavola dei sottomultipli e di trascrivere via via il quoziente ottenuto dopo ogni passo Insomma come eseguire materialmente una divisione Non certo adattando ad un nuovo caso specifico la formulazione dellrsquoalgoritmo che Teone propone
Un secondo ordine di problemi e una trappola micidiale per il co-pista egrave interno alla dialettica lsquotabellarsquolsquosua descrizionersquo ed egrave in assenza di simbolismo quello dei riferimenti linguistici da adottarsi nella seconda agli enti grafici che figurano nella prima Occorre ricercare la massima generalitagrave fornita da una descrizione definita di un ente numerico (ad esempio impiegando il termine laquorestoraquo o la perifrasi laquomassimo sotto-multiplo minoranteraquo) o basta assumere direttamente il suo valore speci-fico come esempio paradigmatico E in che modo risolvere il conflitto tra uso e menzione se come nel nostro caso la tabella contiene segni convenzionali ed occorre fornirne una descrizione Si rende ad esempio necessario introdurre un lsquooperatore di citazionersquo noi useremmo le virgo-lette la lingua greca premette lrsquoarticolo neutro Drsquoaccordo ma nel caso
45 Questa caratteristica non egrave connaturata alla matematica degli algoritmi la risorsa dello lsquostile proceduralersquo serve esattamente ad aggirare questo problema al di lagrave di un certo livello di dettaglio perograve essa condurrebbe ad un appesantimento insostenibile della for-mulazione dovuto alla pluralitagrave dei riferimenti agli oggetti matematici in gioco sulla que-stione dei diversi stili della matematica greca si veda Acerbi 2012
Fabio Acerbi140
greco qual egrave il suo range E come distinguerlo nei casi ambigui da un semplice articolo che precede un sostantivo quando questrsquoultimo lo ri-chieda Nel corso del processo di copia del testo della descrizione infine possono generarsi tensioni tra enti grafici interpretabili vuoi come segno convenzionale vuoi come abbreviazione Ambiguitagrave relative a questi punti opacizzano la descrizione Un problema analogo si porrebbe a priori nella dialettica tra uso delle lettere denotative per designare enti geometrici e loro menzione nella costruzione di un diagramma ma esso egrave risolto con lrsquoazzeramento della seconda funzione le lettere denota-tive sono sempre usate allrsquointerno del testo (sono cioegrave il referente degli oggetti geometrici di cui tratta il discorso matematico) mai menzionate (come accadrebbe se fossero il referente di oggetti grafici posti nel dia-gramma) Insomma il codice adottato per la costituzione dei diagrammi geometrici egrave condiviso (cioegrave canonizzato) semplice e perspicuo mentre quello per le tabelle operazionali non lo egrave da qui le sviste dei copisti e le trascuratezze di correttori ed editori
Infine chi vuole apprendere da questi testi come eseguire una divi-sione a cosa deve prestar fede se ad esempio a causa di errori di copia la descrizione finisce per non coincidere con la tabella operazionale visto che sono entrambe due maniere valide di eseguire lo stesso algoritmo Dopo tutto lo scopo di tutta questa macchina grafico-argomentativa egrave di insegnare a eseguire divisioni in formato tabellare Questo problema si fa particolarmente acuto se la tabella non egrave trasparente nel metodo di Pappo lo egrave quasi completamente in quello anonimo no E gli errori che riscontreremo nella (doppia) tabella ai ff 17r-v del Marc gr 313 a chi sono attribuibili Allrsquoautore al trascrittore o al copista medievale
Questo groviglio di problemi riceve alcune risposte sorprendenti dalla tradizione manoscritta come andiamo finalmente a vedere
4 Analisi delle testimonianze
I codici che ho adibito per lrsquoedizione sono i seguenti M = Marc gr 31346 C = Marc gr 314 (Tolomeo Tetrabiblos et opera minora cum commentariis Vezio Valente Anthologiae)47 Z = Vat gr 2326 (fattizio
46 Riferibile al sec IX ex-X in accolgo la datazione suggeritami per litteras il 522005 da Nigel G Wilson si veda anche Agati 1992 pp 141-142 La presenza non sistematica degli accenti che fa anticipare a Wilson la datazione di laquosaec X medraquo fornita in Mioni 1985 p 24 indusse Boris Fonkič (2005 non vidi) ad assegnare il codice allrsquoinizio del IX secolo
47 Il manoscritto riferibile alla seconda o terza decade della prima metagrave del XIV secolo fu vergato da Michele Clostomalle olim lsquoMetochitesschreiberrsquo Bianconi 2005a pp 428-430 Il titolo dei Prolegomena in questa trascrizione identico in grafia ma non in formulazione a
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 141
e mutilo Tolomeo Almagestum) S = Vat gr 184 (varia astronomica scholia miscellanea ad Almagestum Tolomeo Almagestum) P = Par gr 2390 (varia astronomica) gli ultimi tre riferibili allo scorcio del XIII secolo48 e apografi sicuri del Vat gr 159449 attualmente mutilo di due fascicoli che ci privano dei due terzi finali dei Prolegomena M e il Vat gr 1594 ammettono un modello comune il resto della tradizione (25 trascrizioni in tutto) dipende dagli apografi appena citati del Vat gr 1594 Le varianti della recensione bizantina che leggiamo tra lrsquoaltro nei Vat gr 198 Marc gr 310 (Tolomeo Almagestum cum commentariis Pappi Theonis et Cabasilae) e con ulteriori modifiche Laur Plut 89 sup 48 (varia astronomica Tolomeo Almagestum Barlaam Logistica) sono identificate dal siglum K e si trovano punteggiatura originale in-clusa nel secondo apparato50 Lrsquoanalisi delle testimonianze51 costituite ovviamente anche dalle tabelle associate saragrave condotta nella forma di una sequenza di osservazioni indicizzate da numerali o lettere oltre che di alcune note a piersquo di pagina
Iniziamo dalla descrizione del metodo di divisione anonimo
quello che leggiamo nel Vat gr 1594 (questrsquoultimo coincide con quello adottato nella recen-sione bizantina) fu apposto da Niceforo Gregora e successivamente corretto da Bessarione
48 Sto studiando il primo e il terzo codice in collaborazione rispettivamente con Daniele Bianconi e Inmaculada Peacuterez Martiacuten
49 Su questo codice risalente alla seconda metagrave del IX secolo e sulla sua collocazione nella lsquocollezione filosoficarsquo per prima proposta in Follieri 1977 pp 145-146 si vedano almeno Perria 1991 pp 82-88 Ronconi 2013 Che il titolo dei Prolegomena nel Vat gr 1594 sia stato apposto da Niceforo Gregora egrave stato riconosciuto per la prima volta in Mazzucchi 1994 p 211 n 196 si veda Bianconi 2005a p 418 per altri interventi di Gregora nello stesso manoscritto
50 Il Vat gr 198 egrave stato vergato dal copista Malachia nel corso del terzo quarto del XIV secolo Mondrain 2004 pp 278-290 e 292 Allo stesso copista (denominato non a caso prima dellrsquoidentificazione anonymus Aristotelicus) dobbiamo un buon numero di trascrizioni aristoteliche con i relativi commentari in margine Gli dobbiamo anche il Par gr 2342 secondo tomo di un quadrivium quasi completo di cui il Vat gr 198 egrave il primo nellrsquoordine aritmetica armonica astronomia (Almagesto e commentari relativi) nel codice vaticano geometria ed ancora astronomia (corpus astronomico minore) in quello parigino le opere trascritte sono sempre accompagnate in margine dai relativi commentari Il copista del Marc gr 310 egrave Isacco Argiro (ca 1300-1375) Mondrain 2007 p 166 Allo stesso Argiro dobbiamo il codice laurenziano (Daniele Bianconi per litteras) Poicheacute la recensione modificata che leggiamo nel Laur Plut 89 sup 48 egrave senza alcun dubbio basata su quella nel Marc gr 310 e non viceversa ci troviamo di fronte ad un copista che trascrive due volte lo stesso testo in due versioni leggermente differenti la conclusione naturale egrave che la seconda recensione egrave dovuta ad Argiro stesso la questione andragrave studiata in dettaglio
51 Nei manoscritti citati i Prolegomena si trovano ai fogli seguenti Vat gr 1594 ff 1r-8v (mutilo mancano due fascicoli su tre) Marc gr 313 ff 1r-28r (incompleto man-cano due fogli allrsquoinizio e il f 6 attualmente rimpiazzato da uno bianco) Marc gr 314 ff 235r-255r Vat gr 2326 ff 19r-40v e 43r-v (incompleto e con i fascicoli in disordine) Vat gr 184 ff 10r-23v Par gr 2390 ff 1r-13v Vat gr 198 ff 127r-136v Marc gr 310 ff 1r-13r Laur Plut 89 sup 48 ff 7r-19r
Fabio Acerbi142
ἐκθέμενοι οὖν διάγραμμα τῶν ἀριθμῶν ὡς ὑπόκειται προτάσσομεν τὸν μεριζόμενον καὶ μικρὸν ὑπ᾽ αὐτὸν τὸν μερίζοντα ὡς ἔχει τὸ διάγραμμα ἐν στίχοις διοριζομένοις ὑπὸ γραμμῶν [hellip] καὶ τὰ μὲν γινόμενα ἐγγὺς ἐλάττονα ἐν τῇ μεταξὺ θέσει τοῦ μεριζομένου καὶ τοῦ μερίζοντος ἐν στίχοις παρασημειοῦσθαι πρὸς τὸ ἀσύγχυτον εἶναι τὴν τάξιν τὰ δὲ μεθ᾿ ὧν ὁ μερίζων ἐποίει τοὺς ἀεὶ ἐλάσσονας ὑπὸ τὸν μερίζοντα σημειοῦσθαι προγράφοντας ἐπὶ τοῦ στίχου αὐτῶν τὸ γίνεται οὕτως γι ἐν δὲ τῷ στίχῳ τῶν μεριζόντων τὸ παρὰ ἔχον οὕτως oslash ἀντὶ τοῦ παρ᾿ ἃ δεῖ τὸν μερισμὸν γίνεσθαι ἐν δὲ τῷ στίχῳ τῶν ἐλασσόνων τὸ αφ διὰ τὸ τούτους ἀεὶ ἀφαιρεῖσθαι ἀπὸ τῶν ἐπάνω τῶν μεριζομένων ἐν δὲ τοῖς τοῦ μεριζομένου λοιπάσμασι τοῖς καὶ ἐπιοφείλουσι τὸ λ κατὰ τὸ ἴδιον τῶν διαστάσεων ἑκάστης ndash λέγω δὴ λοιπάδος ndash ἀντὶ τοῦ λοιποὶ οἱ μέλλοντες ἐπιμερίζεσθαι
2 post τὸν suprascr τὸν ἐλάττονα m 2 S 5 πρὸς] MP et ex corr Z κατὰ S om C | ἀσύγχυτον] MSPC -χητον Z 6 ἀεὶ] MZPC ὡσεὶ S 7 γίνεται οὕτως γι ] γι τ οὕτως γι τ M γί οὕτως γί Z γι οὕτως γί SC τὸ γινόμενον οὕτως γίνεται P 8 τὸ παρὰ ἔχον οὕτως] scripsi τὸ παρέχον οὕτως M et π(αρ-) comp Z οὕτως τὸ περιέχον S προγράφοντας οὕτως ex corr m 2 P τὸ περιέχον οὕτως C | oslash] MZSC (sed ο fecit | Z) ἐλάττων comp ex corr m 2 P | παρ᾿ ἃ] scripsi παρα M π(αρα) comp ZSC ex παρα fe-cit παρὰ et τοῦτον suprascr m 2 P 9 γίνεσθαι] comp C | αφ ] αφ ε M ἀφ ZSC ἀφαί P | ἀεὶ] om M 11 ἐπιοφείλουσι] MZSC ex ἐπιο- fecit ἐπο- m 2 P | λ] MZPC λ´ S 12 λοιποὶ] PC λοιποῦ MZS
3 στίχοις] στίχῳ K 5 πρὸς] διὰ K 7 ἐπὶ mdash γι ] τὸ γίνεται διὰ τοιούτου σ(ημείου) γί K 8 τὸ παρὰ ἔχον mdash παρ᾿ ἃ] τὸ παρᾱ διὰ σ(ημείου) τοιούτου καὶ τοῦτο oslash δηλοῦντος τοῦ παρᾱ ὅτι παρὰ τὸν τοιοῦτον (ἀριθμὸν) K 9 αφ διὰ τὸ τούτους] ἀφ δηλοῖ δὲ τοῦτο ἀφαίρεσ(ιν) ὅτι τούτους ἀεὶ δεῖ K 11 ἐπιοφείλουσι] ἐπιμερίζεσθαι ὀφείλουσι K | λ] λ οι` K 12 ἀντὶ τοῦ] δηλοῦντος τοῦ σ(ημείου) τὸ K
lsquoRendendo esplicito un diagramma numerico come lo troviamo qui sotto disponiamo in primo luogo il dividendo e un poco al di sotto di esso il divisore come li ha il diagramma in righe delimitate da linee [hellip] e lsaquooccorreragraversaquo nella posizione tra il dividendo e il divisore annotare lrsquouno accanto allrsquoaltro i piugrave vicini lsaquodei numerirsaquo minori che risultano affincheacute la disposizione non sia confusa quelli con cui il divisore faceva ogni volta i lsaquonumerirsaquo minori annotarli sotto il divisore scrivendo in prima posizione sulla loro riga laquorisultaraquo cosigrave Ris nella riga dei diviso-ri52 invece laquoperraquo fatto cosigrave53 P in luogo di laquoquelli per cui deve farsi la divisioneraquo nella riga dei lsaquonumerirsaquo minori laquosottrraquo in quanto questi sono sempre sottratti dai dividendi che si trovano sopra nei residuli del dividendo (occorre ben farlo anche per loro) laquoReraquo in accordo con ciograve
52 I laquodivisoriraquo sono al plurale ma siamo semplicemente di fronte a un tratto idioma-tico della lingua greca nel caso di espressioni generalizzanti crsquoegrave soltanto un divisore che occupa lrsquounica colonna di cui si compone la sua riga
53 Si intenda ἔχον οὕτως = ita se habens
1
5
10
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 143
che egrave proprio agli scarti di ciascuno ndash intendo qui lsaquociascunrsaquo residuo54 ndash in luogo di laquoresti che vanno a essere divisi ulteriormenteraquorsquo
a) Operatori di citazione e segni convenzionali I segni introdotti sono quattro la mia discussione egrave condotta dando per scontato che essi siano identici a quelli impiegati dallrsquoautore dei Prolegomena anche se si tratta di unrsquoipotesi non corroborabile neacute falsificabile
i Segno per il risultato Lrsquoabbreviazione convenzionale per γίνεται egrave identica al segno introdotto dallrsquoautore e i copisti si dividono tra i due errori possibili scrivere due abbreviazioni o risolverle entrambe Un fenomeno del tutto analogo si riscontra nel Matr 4678 il manoscritto alla base di tutta la tradizione degli Arithmetica di Diofanto al momen-to della definizione dellrsquoἀριθμός (lrsquolsquoincognitarsquo nel nostro linguaggio) ὁ δὲ μηδὲν τούτων τῶν ἰδιωμάτων κτησάμενος ἔχων δὲ ἐν ἑαυτῷ πλῆθος μονάδων ἄλογος ςο` καλεῖται ς` ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον τὸ ς` laquoil lsaquonumerorsaquo che non possiede nessuna di queste proprietagrave ma che ha in seacute una molteplicitagrave indefinita di unitagrave egrave chiamato lsquonumerorsquo e il suo segno egrave ς`raquo Qui solo il terzo dei tre ς ha una barra a sormontare per segnalarne il carattere puramente denotativo (cioegrave di segno convenzionale e non di abbreviazione si veda il punto successivo)55 il primo egrave una delle abbreviazioni piugrave diffuse per ἀριθμός (e infatti egrave dotato del compendio per la desinenza e dellrsquoaccento grave) il secondo egrave una delle piugrave comu-ni per καὶ () Giovanni Cortasmeno autore di capillari annotazioni infra lineam agli Arithmetica nel codice madrileno scioglie il primo ςο`
54 Doppia variatio che impiega al posto di λοιπόν laquorestoraquo i due termini decisamente non canonici τὸ λοίπασμα e ἡ λοιπάς (piugrave oltre leggiamo anche il participio λοιπασθέντα) Una ricerca sul TLG in rete non ha fornito occorrenze del primo si tratta dunque di uno hapax Quanto al secondo che ricorre anche nella sezione sulla divisione lsquoalla Papporsquo lo si rintraccia giagrave nei papiri documentari il termine diventeragrave perograve canonico nelle esposizioni bizantine drsquointroduzione allrsquoAlmagesto ricalcate sul modello dei Prolegomena (si veda la nota 87 infra) Questi due termini designano i resti parziali prodotti nel corso di una divisione lunga li ho tradotti rispettivamente con il neologismo laquoresiduloraquo e con il sostantivo pari-menti non canonico laquoresiduoraquo
55 Il copista interpreta erroneamente il terzo segno come unrsquoabbreviazione e qui ag-giunge un apice inverso (cioegrave un accento grave) altrove lo scioglie direttamente in forme opportune di ἀριθμός Matr 4678 f 58v La frase come la leggiamo nel manoscritto egrave cor-rotta sulla base di una parafrasi in Psello (edita in DOO II p 3710-12) Tannery emendograve ἄλογος in ἀόριστον DOO I p 64-5 et app Il Matritensis vergato da due copisti differenti (cambio di mano a tre righe dalla fine del f 62r) contiene lrsquoIntroductio arithmetica di Nicomaco e le opere diofantee oltre ad alcuni brevi opuscoli musicali la sua data egrave stata recentemente corretta dal XIII al secolo XI pm in Peacuterez Martiacuten 2006 (una riproduzione digitale del manoscritto si trova allrsquoindirizzo httpbdhbneesbnesearchbibliotecaDio-fanto20de20AlejandrC3ADa)
Fabio Acerbi144
in ἀριθμός ed aggiunge un altro segno56 sopra il terzo anteponendovi lrsquoindicazione καὶ ἔστιν αὐτοῦ σ(ημεῖον) τόδε Va da seacute che non abbiamo nessuna garanzia che il segno originariamente introdotto da Diofanto coincidesse realmente con unrsquoabbreviazione convenzionale per ἀριθμός Lrsquoevidenza del PMich III 144 (sec II in) suggerisce drsquoaltronde che il Matritensis e con esso tutta la tradizione medievale di Diofanto ripro-duca fedelmente pur accentuandone la sinuositagrave il segno originario
ii Segno per il divisore Un cerchiolino sbarrato da non confondere con il segno per ὁμοῦ che nei manoscritti matematici ha di norma due barre trasversali (cf tav 2a) Non sono riuscito a rintracciarne ulteriori occorrenze in altre opere la forma che esso assume nel Vat gr 2326 e la correzione apportata nel Par gr 2390 lasciano aperta la possibilitagrave per quanto a mio avviso remota che la forma originaria non fosse lon-tana da unrsquoabbreviazione di παρά registrata nei repertori57 Il correttore del Par gr 2390 trasforma in effetti il segno oslash nellrsquoaffine abbreviazione canonica per (forme di) ἐλάσσων laquominoreraquo58 e si incarica diligente-mente di farlo notare ricapitolando i segni nella porzione superiore del margine esterno del f 7v Nello stesso margine egli traccia anche uno lsquoscolio tabellarersquo ed egrave lrsquounico a porre il (proprio) segno dove indicato dalla descrizione (tav 6 Par gr 2390 f 7v) Oltre a ciograve adattando la tabella al margine ristretto lo scoliaste trascrive come colonne affian-cate le due righe dei resti parziali e dei massimi multipli e aggiunge le indicazioni ὁ μεριζόμενος laquodividendoraquo e ὁ μερίζων laquodivisoreraquo ma vi introduce alcune incongruenze di formato il risultato scritto in verti-cale e la linea verticale di sinistra che separa il divisore dal segno che lo dovrebbe precedere direttamente
iii Segno per i massimi multipli Corrisponde alla semplice abbre-viazione per sospensione della forma verbale ἄφελε laquosottrairaquo in questo
56 Si tratta del segno di ampio uso praticamente identico allrsquoabbreviazione canonica per οὖν
57 Si tratta di un pi a forma di gancio sbarrato da uno slash di troncamento Ce-reteli 1904 tav IX item 7 sub ΠΑΡΑ che rinvia al PVindRain 423 cf anche la forma π` nel POxy LXI 4142 edito in Jones 1999 II pp 26-34 In generale nei papiri e nei manoscritti matematici in maiuscola le preposizioni sono abbreviate facendo seguire un lsquoapostroforsquo alla loro prima lettera Α᾽ Υ᾽ ecc Per la seconda fattispecie di supporto libra-rio si veda in particolare il cosiddetto fragmentum mathematicum Bobiense scriptio inferior databile al V-VI secolo del palinsesto Milano Biblioteca Ambrosiana L 99 sup (Isidoro di Siviglia Etymologiae datazione Cavallo 1977 p 100) pp 113-114 che sono stampate in riproduzione apografa conforme in Belger 1881 (la p 114 egrave riprodotta anche nella tav 10 di Acerbi 2010)
58 Se questa era lrsquointenzione si tratta ovviamente di una forzatura il divisore puograve ben essere maggiore del dividendo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 145
caso lo slash di troncamento taglia orizzontalmente il tratto verticale del phi I copisti offrono molteplici varianti apponendo chi uno spirito dolce chi un ε chi un αί accentato a sormontare Tutti questi segni svolgono la funzione di abbreviazioni vere e proprie (e cosigrave doveva essere anche per lrsquoautore si veda il punto 1 di p 153 infra) la forma originale si ottiene a mio avviso incrociando i dati del Marc gr 313 e dei tre apografi del Vat gr 1594 αφ anche se lrsquoassenza dello spirito potrebbe essere semplicemente dovuta alla pratica del copista del codice veneziano di economizzare nei diacritici
iv Segno per i resti Un lambda completato da una barra a sormon-tare o da un apice che rinvia alle abbreviazioni per sospensione di una forma opportuna di λοιπός laquorestoraquo In realtagrave la forma che troviamo nella tabella egrave differente (tav 2b) e coincide con quella offerta quasi unanimemente dai manoscritti nella descrizione e in almeno un caso nella tabella del metodo di divisione attribuito a Pappo (tav 4) un lambda che accoglie al di sotto una legatura omicron-iota () sbarrata da uno slash di troncamento Qualcosa di simile si trova nel PVindob G 19996 (sec I) una specie di lambda maiuscolo molto aperto e dal vertice arrotondato che include un circoletto interpretato dagli editori come segno per περίεστιν o per λοιπόν59 Lo stesso segno si rintraccia ad esempio in un medesimo scolio tabellare di prima mano ad Alma-gestum nel Vat gr 1594 f 93v e nel Marc gr 313 f 135r ma stavolta la forma del lambda egrave molto ben definita
Fin qui i segni Ma il gioco egrave piugrave complesso La descrizione si muo-ve pericolosamente sulla linea di confine non sempre ben definita tra segno convenzionale e abbreviazione il primo ndash e il repertorio grafico matematico-astronomico ne egrave particolarmente fornito60 ndash puograve anche
59 Ho consultato lrsquoedizione Gerstinger ndash Vogel 1932 pp 46 e 48 la porzione rilevante del papiro egrave riprodotta nella tav 11 di Fowler 1999 Si veda ancora ivi pp 253-257 per la trascrizione di questo segmento di testo (con correzioni rispetto alla princeps) e per una messa a punto recente inclusa la proposta di datazione che ho riportato qui sopra Il verso del papiro che contiene una tavola aritmetica del tutto scorrelata dalla tematica del recto egrave edito come PRain Unterricht 151
60 La pratica di ridurre lo spazio occupato da un testo tecnico per mezzo di abbreviazioni e segni convenzionali era molto diffusa nei manoscritti in maiuscola contrariamente a quanto avviene per altri generi letterari vedremo tra breve cosa accade negli Arithmetica di Diofanto ma si leggano in proposito anche le considerazioni di Hei-berg nei prolegomena alla propria edizione dellrsquoAlmagesto in particolare riguardo al ricorso massiccio ad espedienti brachigrafici nel modello del Vat gr 180 POO II pp lxxxiv-xciii civ-cv cxxvii cxxxviii-cxxxix Agli elenchi dettagliati forniti da Heiberg possiamo aggiungere il piccolo prontuario stampato in Hultsch 1876-1878 III 2 pp 126-132 e basato sul testo e sugli scolii alla Collectio di Pappo nel Vat gr 218 (sec X in) Si vedano infine le osservazioni del copista del Par gr 2360 f 120v trascritte da Heiberg in AOO III pp x-xi sulle laquonotazioni tipiche a scopo di tagliar corto nello scrivereraquo impiegate nel pro-
Fabio Acerbi146
derivare dalla seconda (un caso egrave appunto il segno per ἐλάσσων che probabilmente trae origine da una legatura epsilon-lambda) ma poi il rapporto referente-relato si fissa convenzionalmente Quelli definiti nel testo che abbiamo letto sono appunto segni convenzionali non ci sarebbe bisogno di spiegarne forma e funzione se fossero intesi come abbreviazioni assumono nella tabella una funzione denotativa non esplicativa o discorsiva (come accade invece nella tav 1a) Ma come vengono descritti questi segni
I referenti delle descrizioni sono i segni sono introdotti da οὕτως (item i-ii) o in alternativa da un τό con il ruolo di lsquooperatore di citazionersquo (item iii-iv) che corrisponde esattamente alle nostre virgolette In entram-bi i casi gli enti sono menzionati e svolgono una funzione metalinguistica sono collocati materialmente nel testo ma egrave come se si trovassero fuori e la loro descrizione li additasse ndash in effetti i segni convenzionali scritti nel testo sono a loro volta i relata di quelli che si trovano nella tabella
I relata dei segni scritti nel testo sono di due tipi singoli vocaboli (item i-ii) o descrizioni della funzione dei segni per mezzo di clausole sintaticamente complesse (item ii e iv) I singoli vocaboli sono γίνεται e παρά e sono entrambi preceduti dal τό lsquocitazionalersquo in quanto relata di segni convenzionali le forme abbreviate con cui sono tracciati nei manoscritti vanno forzatamente sciolte Bisogna ammettere che la per-spicacia e le risorse grafiche dei copisti ndash di cui tutto si puograve dire fuor che commettano qui degli errori ndash sono messe a dura prova con lrsquointrodurre segni identici ad abbreviazioni o con lrsquoattivare un gioco metalinguistico particolarmente serrato in un contesto meno lsquonaturalersquo di come potreb-be esserlo ad esempio quello di un trattato grammaticale Lrsquoitem iii che presenta direttamente un segno identico ad unrsquoabbreviazione non egrave sorretto da una descrizione ma da una giustificazione in διὰ τό Lrsquoartico-lo τό vi assume una funzione metalinguistica anche se non lsquocitazionalersquo poicheacute al tempo stesso genera un infinito sostantivato e lo singolarizza per questo ho scritto laquosono sottrattiraquo in corsivo nella mia traduzione
prio modello archimedeo (nota 32 supra) egli ne compila anche una breve lista Un elenco antico di laquosegni della geometriaraquo sicuramente redatto per assistere il copista si trova anche al f 3v del ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 vergato da Efrem negli anni 950-960 (tav 8 in Acerbi 2010) Possiamo farci unrsquoidea quantitativa del guadagno di spazio in rapporto ad un testo privo di abbreviazioni e con le parole separate da spazi sulla base del fragmentum mathematicum Bobiense il testo vi egrave disposto a tutta pagina su 36 righe di circa 30 segni ciascuna nelle due pagine in questione figurano 2038 segni con 15 mezze righe occupate dalle due figure Ora nel testo dellrsquoedizione stabilita in Heiberg 1927 pp 87-90 le stesse pagine contano 4455 segni spazi compresi Ne risulta che la dimensione in caratteri di un testo matematico puograve essere ridotta di piugrave della metagrave con lrsquoimpiego di compendi e segni convenzionali
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 147
Negli item ii e iv il segno si collega ad una descrizione nel secondo caso in via esclusiva le descrizioni pertanto rinforzano o sostituiscono lrsquoidentificazione con lrsquoente linguistico denotato Le clausole descrittive sono precedute da ἀντί e dallrsquoarticolo τό con funzione di lsquooperatore di citazionersquo esse sono παρ᾿ ἃ δεῖ τὸν μερισμὸν γίνεσθαι (item ii) e λοιποὶ οἱ μέλλοντες ἐπιμερίζεσθαι (item iv) Nella descrizione della divisione lsquoalla Papporsquo che leggeremo tra breve i segni negli item iii e iv rice-vono lo stesso trattamento degli altri due il loro relatum egrave un singolo vocabolo e non una clausola descrittiva rispettivamente nelle espres-sioni τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε (sul participio ritorneremo nel punto 1 infra) e τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά (la forma del segno notato con λ οι egrave descritta supra nellrsquoitem iv) La descrizione del segno oslash per il divisore merita una discussione piugrave dettagliata In origine si trovava probabilmente scritto Π(ΑΡΑ)ΕΧΟΝ successivamente letto come π(αρ[α])έχον ndash dato che lrsquoabbreviazione per il preverbo egrave identica a quella per la preposizione (che sia Π᾽ o un pi seguito dal segno per ἄρα a sormontare) ndash invece di π(αρὰ) ἔχον I copisti e i correttori si dettero a tutte le possibili contorsioni per restituire un testo dotato di senso leggere appunto una forma verbale con preverbo modificare il preverbo (ma forse il segno per ἄρα era insidiosamente simile ad uno epsilon) correggere il testo rileggiamo lrsquoapparato sub τὸ παρὰ ἔχον οὕτως τὸ παρέχον οὕτως M et π(αρ-) comp Z οὕτως τὸ περιέχον S τὸ περιέχον οὕτως C προγράφοντας οὕτως ex corr m 2 P Nella clausola descrittiva seguente la presenza liminare di παρὰ (che ho corretto in παρ᾿ ἃ nella speranza di restituire una frase che abbia un senso senza intervenire sul testo) innesca un bel corto circuito il Π(ΑΡΑ) che sicuramente figu-rava nellrsquoarchetipo egrave un sintagma complesso una preposizione unrsquoab-breviazione o un segno per unrsquoabbreviazione Se lrsquoeditore si trova in conflitto con la propria inclinazione alla critica conservativa i copisti si rifiutarono di mettere mano ad un testo che doveva stridere anche per loro essendo il compito demandato al ritocco del revisore del Par gr 2390 o alla riscrittura radicale del recensore bizantino Il problema egrave che ci troviamo di fronte ad unrsquoespressione che descrive la funzione dellrsquooggetto denotato non lrsquooggetto stesso ma che lo contiene al suo interno per soprammercato qui il Π(ΑΡΑ) egrave usato per giustificare una menzione a sua volta relatum di un segno
Evidentemente questa maniera di procedere che giagrave aveva attirato interventi da parte di copisti e correttori della recensione di base parve insostenibilmente opaca allrsquoautore della recensione bizantina61 Egli
61 Uno dei manoscritti di questa recensione propone anche una tabella di divisione
Fabio Acerbi148
modifica tutte le descrizioni diluendo lrsquoidiomatismo dellrsquoarticolo lsquocita-zionalersquo con lrsquointroduzione sistematica del verbo δηλόω e di frasi atte a chiarire quale sia il segno denotante e quale il vocabolo (o il segno) denotato Egli introduce allo scopo di rendere esplicita la funzione de-notativa dei segni introdotti il termine σημείου curiosamente in tutte le sue tre occorrenze esso compare a sua volta nella forma dellrsquoabbrevia-zione per sospensione σΗ´ Egli traccia il segno per i massimi multipli ἀφ e quello per i resti λ οι` in modo che non vi siano ambiguitagrave quanto al loro carattere di abbreviazione Si faccia infine attenzione al residuo di barra sul παρᾱ con funzione denotativa (2 occorrenze) contenuto nella descrizione del segno per il divisore sostituita dallrsquoaccento grave nel παρὰ con funzione discorsiva (la differenza egrave nettissima nei manoscritti da me consultati) Questa osservazione ci permette di passare direttamente allrsquoitem seguente
b) Le barre sui numerali e sulle lettere denotative Egrave opportuno discutere questo punto adesso esattamente percheacute di barre siffatte che pure troviamo in tutti i manoscritti i nostri testi non fanno mai menzione si tratta infatti di una pratica condivisa sin dallrsquoantichitagrave La barra identifica una stringa di lettere dellrsquoalfabeto che non svolge una funzione grammaticale o sintattica propria allrsquointerno del discorso Ciograve avviene in particolare e si tratta della fattispecie piugrave frequente se la stringa di lettere non dagrave origine a un vocabolo della lingua greca lette-re denotative e numerali certo ma anche termini provenienti da altri idiomi e contrazioni di parole greche come i nomina sacra62 tali termi-ni possono essere o no preceduti da un articolo lsquocitazionalersquo a seconda dellrsquouso che ne viene fatto allrsquointerno del discorso Ma non si tratta dellrsquounica fattispecie i papiri grammaticali ed i manoscritti piugrave antichi dei trattati dello stesso argomento segnalano gli esempi delle parti del discorso (cioegrave di lsquoverersquo parole greche) per mezzo di barre sormontanti63 La differenza insomma egrave tra menzione e uso (come parte del discorso in atto) di una stringa di caratteri tra il porre le lsquovirgolettersquo e il non porle tra funzione denotativa e non Apparentemente la convenzione si limi-
corredata dei segni opportuni e contrariamente alle indicazioni della descrizione svilup-pata lsquoin verticalersquo ma per motivi misteriosi non completa (tav 7a Laur Plut 89 sup 48 f 13r)
62 Tutto ciograve egrave spiegato con estrema chiarezza giagrave in Traube 1907 pp 45-4763 Si veda il Par gr 2548 codex vetustissimus e testimone unico delle lsquoopere minorirsquo
di Apollonio Discolo il f 106v con le barre ben visibili egrave riprodotto come tav 19 in De Gregorio 2000 (ivi pp 137-138 per la datazione) Per la testimonianza dei papiri grammaticali si veda Wouters 1979 passim essi contengono di norma elenchi di parti del discorso nessuna delle quali egrave preceduta dallrsquoarticolo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 149
tava in questo secondo caso a segnalare con la barra singoli vocaboli le menzioni di frasi o di sintagmi complessi sono di norma identificate dallrsquoarticolo lsquocitazionalersquo Drsquoaltra parte le abbreviazioni convenzionali non rientrano nella casistica percheacute la loro resa grafica che contiene elementi non alfabetici come compendi per desinenze lettere supra li-neam marche di contrazione o sospensione quali slashes o barre sotto-poste o sormontanti eventualmente solo un sottinsieme della stringa di segni alfabetici le esclude automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
Venendo al discorso matematico una barra sormonta senza ecce-zione le lettere denotative64 che sia in papiri o in manoscritti in maiu-scola65 o minuscola ma solo allrsquointerno del testo comrsquoegrave da attendersi nei diagrammi esse la perdono per il semplice motivo che non crsquoegrave alcun testo ambiente un diagramma ha unicamente una funzione denotati-va Drsquoaltra parte le lettere numerali che a volte figurano nei diagrammi della tradizione metrica66 allo scopo di indicare la lunghezza dei seg-menti mantengono la barra in un diagramma il contesto denotativo geometrico egrave prevalente e i numerali vengono percepiti come entitagrave grafiche lsquoesternersquo al discorso Va da seacute a fortiori che le lettere numerali inserite in un testo dovranno essere segnalate da barre che a loro volta non servono nelle tavole67 in quanto queste ultime sono come abbiamo visto un vero e proprio testo che perograve funge da ambiente a quello al-fabetico limitato alle titolazioni e non a caso tracciato in unrsquoopportuna lsquomaiuscola distintivarsquo allo scopo di segnalarne il carattere denotativo e non discorsivo68 Una tabella operazionale egrave invece un paratesto e quindi le barre sulle lettere numerali che rappresentano gli interi sono
64 La notazione per le lettere denotative subigrave unrsquoevoluzione (il cui risultato finale egrave descritto per sommi capi nella nota 3 supra) di cui non mette conto occuparsi qui
65 I papiri di contenuto geometrico (o astronomici ma che presentano argomenti geometrici) sono rari si vedano il PHerc 1061 (sec II aC Demetrio Lacone De geome-tria) e il PFay 9 (sec II ex Elementi I 39 e 41) Gli importanti ostraka OBerl 12002 e 12609 (sec III aC m Elementi XIII) non pongono le barre sopra le lettere denotative Per i manoscritti in maiuscola si veda ad esempio passim nel Par gr 2389 una cui riproduzione digitale egrave consultabile in rete allrsquoindirizzo httpgallicabnffrark12148btv1b8470171d o il fragmentum mathematicum Bobiense
66 Si veda ancora il ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 codex unicus dei Metrica di Erone e contenente una raccolta importante di problemi del corpus metrologico
67 Si vedano come esempio le tavole citate alle note 10 e 14 supra Discorso a parte per il segno di lsquoposto vuotorsquo si veda il punto c che segue
68 Queste regole generali vanno prese cum grano salis si dagrave naturalmente un certo dominio di variabilitagrave legato verosimilmente al grado di cultura grafica del copista nel PMich III 144 i numerali sono quasi tutti senza barra sia nel testo che nelle tabelle ope-razionali
Fabio Acerbi150
necessarie esse mancano invece sui segni convenzionali che ho descrit-to nel punto precedente e fatto rilevante sulle lettere numerali relative agli ordini sessagesimali quando esse siano identificate da uno o piugrave apici la presenza di questo segno grafico non alfabetico69 le esclude ancora una volta automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo Unrsquoultima osservazione che ci saragrave utile nel seacuteguito la descrizio-ne di una stringa di lettere lsquoagrammaticalersquo non puograve prevedere la men-zione della presenza della barra che le pertiene in quanto tale si tratta di una pratica denotativa che egrave possibile formulare soltanto ad un livello di discorso superiore sia a quello dellrsquouso che a quello della menzione70
c) Il segno di lsquoposto vuotorsquo Si noti nella tav 2b la forma ŏ per il segno di lsquoposto vuotorsquo in un ordine sessagesimale coerentemente con la propria notazione il copista del Marc gr 313 lo scioglie talvolta allrsquoin-terno del testo principale come unrsquoabbreviazione per οὐδέν laquonienteraquo Altre convenzioni di scrittura del tratto che accompagna il circoletto e che si badi bene fa parte integrante del segno di lsquoposto vuotorsquo ndash e infatti nelle tavole troviamo sempre il segno completo mentre tutti gli altri numerali sono come abbiamo visto nel punto precedente privi di barra o di apice a causa del fatto che i vari ordini sessagesimali sono univocamente determinati dalle linee di giustificazione ndash un tratto an-golare anteposto (tav 3 Lar Plut 2818 f 136v)71 o una semplice barra a sormontare (tavv 4-9) si produce in questo modo il segno 65926 che sembra essere stata la forma di base72
69 Occorre dunque supporre come testimoniano papiri e manoscritti in maiuscola che la convenzione relativa allrsquouso della barra si sia consolidata ben prima dellrsquointroduzione di segni diacritici quali accenti e spiriti
70 Si veda il punto 2 infra per maggiori dettagli sulla questione delle barre e degli apici e per le indicazioni in merito che leggiamo in Diofanto
71 Come accennato questa tavola dei sottomultipli coincide con quella descritta ed esposta nei Prolegomena Fatto molto rilevante i numerali nella prima non recano neacute barre neacute apici contrariamente a quanto accade a tutte le istanze della seconda nei manoscritti Quella del Laur Plut 2818 preserva a mio avviso la forma originaria come abbiamo visto una tavola non richiede segni aggiuntivi sulle lettere numerali
72 Si vedano come esempio ancora le tavole citate alle note 10 e 14 supra oppure per una rassegna delle forme che il segno assume nei manoscritti piugrave antichi delle Tavole facili Tihon 2011 pp 58-59 e per quelle che assume nei papiri Jones 1999 I pp 61-62 Ovviamente non possiamo leggere il segno 65926 come un omicron con una barra in quanto ο = 70 nella notazione greca e la barra egrave di rigore quando il numerale figuri allrsquointerno di un testo Occorre ammettere che si dagrave origine ad un bel corto circuito notazionale con il concepire un segno con funzione di lsquoposto vuotorsquo ma che lsquosomigliarsquo ad una lettera dellrsquoalfabeto sormontata da una barra cioegrave ad un numerale in piugrave quando il lsquoposto vuotorsquo non corrisponda ad un intero ma ad una specie sessagesimale la presenza della barra a priori indistinguibile da quella che sormonta gli interi introduce unrsquoincongruenza con la notazione a mezzo di apici vista nellrsquoitem precedente
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 151
d) Errori di copia La tabella riprodotta nella tav 2b ha una forma simmetrica ma si tratta di una forzatura il grande rettangolo in basso a destra drsquoaltronde assente nella descrizione contiene uno scolio che fa notare come lrsquoultimo resto parziale ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ͵γτνζ´´´´´ κζ´´´´´´ cioegrave 0 0 0 0 0 3357 27 siano ἔγγιστα λ´λ´ δ´δ´ ξ laquocon ottima approssimazione 60 minuti quartiraquo dove si notino gli apici semplici per indicare il pas-saggio allrsquoordinale e il raddoppiamento del sistema segno + apice per significare il plurale Lo scolio debitamente accompagnato dal segno di rimando in forma di simbolo solare egrave stato probabilmente incluso nella tabella proprio allo scopo di renderla simmetrica A sua volta un errore precedente spiega lo spazio eccessivo accordato al rettangolo contenente lo scolio il secondo massimo multiplo ŏ λβ´ ξδ´´ ριβ´´´ σιϛ´´´´ egrave trascritto anche al di sotto del risultato
Passiamo ora alla descrizione del metodo di divisione attribuito a Pappo
ἵνα οὖν ταῦτα συναχθῇ τὰ ἐκ τοῦ μερισμοῦ ὁ εἰρημένος Πάππος εὐδιατύπῳ τινὶ καὶ πρὸς τοῦτο τάξει χρησάμενος ποιεῖται τὴν τῆς συλλήψεως τοῦ ζητουμένου ἀνεύρεσιν οὕτως ἐκθέμενος γὰρ τὸν μέλλοντα μερίζεσθαι τουτέστι τὰς τξ μοίρας ἐν ἀρχῇ ἀφαιρεῖ ἀπ᾽ αὐτῶν τὸν ἐν τῇ σελίδι τυγχάνοντα ἐλάττονα τουτέστι τὸν τδ κβ´ κ´´ ὄντα τῶν ἐγγὺς ἐλασσόνων ὡς πρὸς τοὺς ἐκκειμένους διὸ καὶ γράφει αὐτὸν προγράφων αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε καὶ εὑρίσκων τὰ παρακείμενα αὐτῷ τῷ ἀπογραφέντι ἐν τῷ σελιδίῳ λεπτὰ πρῶτα ν´ συναπογράφεται παρατιθῶν αὐτοῖς τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον ἀνατείνουσαν σημαῖνον τὸ εἶδος ὅτι πρῶτα λεπτά εὑρίσκει οὖν οὕτως τὸ τῶν τξ μέρος τὸ τδ κβ´ κ´´ ὃ μεριζόμενον παρὰ τὰς τξε ιδ´ μη´´ ἡμέρας καὶ ποιοῦν τὸν ἐκ τοῦ μερισμοῦ ἀριθμὸν πρῶτα λεπτὰ ν´ καὶ τὸν λοιπὸν ἀπογραφόμενος τὸν νε λζ´ μ´´ προτάσσει αὐτοῦ τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά τάσσει δὲ καὶ ἁπλῆν τινα διατείνουσαν γραμμὴν ὡς ἀπὸ τοῦ τξ ἐπὶ τὸν ἑξῆς ἐκτεθειμένον ἐγγὺς
1
5
10
1 εὐδιατύπῳ] ZSPC εὐδιατύπωτ M 4 ἀφαιρεῖ] MZSP ἀφ ι C 5 ἐλάττονα] P comp MZSC 6 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | αφ ] αφ ε M ἀφ ZS ἀφαί P ἄφ C | ἀντὶ] om C | ἄφελε] MZSP ἄφ C 8 ἀπογραφέντι] MZSP ἐγγραφέντι C | λεπτὰ πρῶτα] P λε πρωτα SC λεπτῶν πρωτ MZ | παρατιθῶν] MZS παρατιθεὶς C et ex corr m 2 P 9 ᾱ] Z αο P α´ MS α C | ἔχον] MPC ἔχων ZS 9-10 πρῶτα λεπτά] ZP πρωτ λ´λ´ M πρωτα λε S αα λε C 11 ἡμέρας] comp codd | ἀριθμὸν] P et comp MZ καὶ C et comp S 12 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M πρωτ λεπτ(α) Z πρωτ λ εᾱ S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C | ἀπογραφόμενος] MZSP ἐγγραφόμενος C | νε λζ´] MZSP λζ νζ C 13 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | λ οι] MZSC ex λ fecit λ οι P | προσσημαῖνον] MC et προσ- comp ZS προση- P | τὸ] MZC τὰ S et fecit m 2 P 14 ἀπὸ] MZSP πρὸς C ἐλάττονα] P comp MZSC
1 εὐδιατύπῳ] εὐδιατυπώτω K 6-7 αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ] τὸ ἀφ K 8 παρατιθῶν mdash 10 λεπτά] τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ σημαίνουσαν τὸ εἶδος αὐτῶν ὅτι ᾱ λεπτά εἰσιν K | τὸ (sec)] τὰ K 12 πρῶτα] πρώτων K | τε λ ] λ οι` K | προσσημαῖνον mdash
Fabio Acerbi152
ἐλάττονα τὸν τδ κβ´ κ´´ ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις καὶ ταύτην ἐπιδεικνύουσαν τὴν τάξιν τῆς προόδου τῆς ἐκθέσεως ἧστινος κλωμένης γραμμῆς πρὸς τῷ ἐγγὺς ἐλάσσονι ἡ ἀντανάκλασις ἐπὶ τὸν λοιπὸν γέγραπται φερομένη ὡς εἴρηται διὰ τὸ εὔτακτον τῆς προκοπῆς οὕτως τε ποιήσας ἑξῆς τὸ αφ ποιῶν ὃ προσσημαίνει ὡς εἴρηται τὸ ὅτι δεῖ ἀφελεῖν ὁμοίως ἀπὸ τοῦ λοιποῦ καὶ δὴ τὸν ἐγγὺς πάλιν ἐλάσσονα ὡς πρὸς τὴν ἐν τῷ σελιδίῳ ἔκθεσιν εὑρισκόμενον λαμβάνων ἑξῆς προγράφει αὐτὸν ὄντα νδ μζ´ ιγ´´ ιβ´´´ καὶ εὑρίσκει αὐτοῖς παρακείμενα ἐν τῷ σελιδίῳ πρῶτα λεπτὰ θ´ ἅτινα καὶ αὐτὰ προσαπογράφεται σὺν τῇ παρασημειώσει τῶν πρώτων γράφων τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον τὴν ἀνατείνουσαν καὶ ὡς εἴρηται τὴν γραμμὴν πάλιν διὰ τὴν τάξιν κλωμένην κατὰ δευτέραν κλάσιν προσέλκει γινομένου τοῦ μέρους αὐτῆς τούτου παραλλήλου τῷ ἐξ ἀρχῆς
16 ante κλωμένης add ἐπὶ C 18 τε] MZP om SC | αφ ] M ἀφ ZSC ἀφαί P 19 προσσημαίνει] MS προση- ZC et ex corr P | ὅτι] ZP comp MSC 20 δὴ] MZSC διὰ fecit m 2 P 21 πρὸς] MSP et supra lineam C ex ἀπὸ fecit m 2 Z | ιγ´´] MZSP νγ´´ C 22 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M ᾱᾱ λεπτὰ Z άάα λε S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C 23 προσαπο- γράφεται] απο suprascr in comp M 24 ᾱ] ZP α´ MS α C 25 κλάσιν] MP τάξιν ZSC | τοῦ] ZSPC τούτου M 26 τούτου] τοῦ bis ZSPC sed prius erasit m 2 P τοῦ M
mdash 18 προκοπῆς] om K | τε ποιήσας] ποιήσας καὶ K | αφ ] ἀφ K 19 τὸ] om K 21 προ-γράφει] γράφει K 22 σελιδίῳ] α´ σελιδίῳ K | ἅτινα] ἃ K 23 προσαπογράφεται] ἀπογράφεται K | τῶν πρώτων mdash 26 ἐξ ἀρχῆς] om K
lsquoAllo scopo di raccogliere ciograve che risulta dalla divisione il detto Pappo utilizzando anche in questo caso una certa disposizione ben strutturata determina nel modo seguente il lsaquonumerorsaquo cercato preso nel suo insieme collocando73 in testa il lsaquonumerorsaquo che sta per essere diviso cioegrave i 360 gradi iniziali sottrae loro tra i piugrave prossimi dei lsaquonumerirsaquo minori rispetto a quelli esposti quello che si trova essere minore nella colonna (cioegrave 304 22 20) Questo egrave il motivo per cui lo trascrive scrivendogli davanti lrsquoabbreviazio-ne laquosottrraquo per laquosottrairaquo e trovando che 50 minuti primi sono collocati accanto a quello stesso lsaquonumerorsaquo che egrave stato trascritto nella colonna li trascrive al tempo stesso collocando accanto74 ad essi la lettera A con un lsaquotrattorsaquo75 sopra che significa la specie minuti primi Trova dunque in que-sto modo la parte di 360 che egrave 304 22 20 la quale divisa per 365 giorni 14 48 fa il numero lsaquoche risultarsaquo dalla divisione 50 minuti primi Trascrivendo
73 La descrizione egrave strutturata come una procedura Acerbi 201274 Il purismo del correttore del Par gr 2390 di Clostomalle nel Marc gr 314 e
dellrsquoautore della recensione bizantina impone loro di modificare la terminazione ma forme tematiche e contratte di τιθεῖν sono correnti nel greco tardivo
75 Il testo greco ha solo il participio con γραμμήν sottinteso Per il significato del participio si veda il punto 2
15
20
25
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 153
poi il resto 55 37 40 gli pone altresigrave76 a prefisso laquoReraquo che significa laquorestiraquo e dispone anche una certa linea semplice77 che va da 360 al piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori che egrave esposto di seacuteguito 304 22 20 come nello lsaquoschemarsaquo esposto linea che mostra lrsquoordine del percorso dellrsquoesposizione Questa linea spezzata lagrave dove si trova il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori egrave tracciata inflessa allrsquoindietro lsaquoersaquo punta verso il resto come egrave stato detto in vista di una progressione ordinata E cosigrave facendo prendendo di seacuteguito il laquosottrraquo che significa come egrave stato detto laquoche occorre similmente sottrarre dal re-storaquo e ovviamente prendendo di nuovo il lsaquonumerorsaquo che egrave trovato essere il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori in relazione alla disposizione nella colonna ndash 54 47 13 12 ndash lo scrive di seacuteguito e trova che 9 minuti primi sono posti loro accanto nella colonna trascrive78 anche questi con la segnaletica dei primi scrivendo la lettera A con un lsaquotrattorsaquo sopra e come egrave stato detto prolunga di nuovo la linea spezzata in vista di una buona disposizione tramite una seconda inflessione essendo questa sua parte parallela a quella inizialersquo
La descrizione continua con una serie di laquoe cosigrave viaraquo e non fa ulte-riore riferimento alla tabella
1) La forma verbale ἐξεσμένον Egrave il neutro del participio perfetto medio-passivo di ξέω lett laquopialloraquo laquolevigoraquo Si danno tre possibilitagrave si tratta di un termine canonico per quanto non altrove attestato per designare unrsquoabbreviazione oppure lrsquoautore anonimo improvvisa sul piano metaforico come se unrsquoabbreviazione non fosse altro che la paro-la completa lsquoaccorciata a colpi di piallarsquo in maniera opportuna oppure il testo egrave corrotto e srsquoimpone una correzione ad esempio τὸ ἑξῆς μένον laquociograve che sta di seacuteguitoraquo Questrsquoultima strada mi pare chiusa dal senso delle frase lrsquoabbreviazione non lsquosta di seacuteguitorsquo a niente ma anzi precede la perifrasi τὸ ἑξῆς μένον se impiegata semplicemente per rimandare al segno αφ immediatamente seguente costituirebbe un intollerabile solecismo Se accettiamo la prima di queste letture considerando quin-di lrsquoabbreviazione αφ in posizione predicativa abbiamo a che fare con
76 Rendo in questo modo il τε isolato77 La linea egrave laquosempliceraquo in quanto egrave una retta la precisazione intende evidenziare per
anticipazione il carattere lsquonon semplicersquo che essa assumeragrave alla prima inflessione quando diventeragrave una spezzata linee siffatte erano in effetti concepite dallrsquoanonimo e prima di lui da tutta la tradizione matematica greca come una singola linea spezzata nei punti drsquoinfles-sione I due segmenti paralleli menzionati al termine del passo sono orizzontali
78 Il verbo egrave al medio in variatio rispetto ai due che precedono e che seguono egrave il matematico che lsquosirsquo trascrive le cifre
Fabio Acerbi154
uno hapax semantico nella grecitagrave superstite come egrave facile verificare con una ricerca sul TLG in rete La recensione bizantina risolve il pro-blema sopprimendo semplicemente τὸ ἐξεσμένον
2) La notazione per le specie numeriche Nella terminologia matema-tica greca gli ordini sessagesimali sono εἴδη laquospecieraquo numerici essi corri- spondono agli ordini di grandezza nel nostro sistema decimale e indica-no in analogia con il caso geometrico la lsquoformarsquo che assume un numero quadrato cubo ecc Centinaia e migliaia sono quindi degli εἴδη rispet-tivamente quadrati (100 egrave il quadrato di 10) e cubi (1000 egrave il cubo di 10) sono specie numeriche ma non numeri particolari e drsquoaltronde 300 non egrave un quadrato ma 3 item dellrsquoεἶδος lsquoquadratorsquo 100 3 egrave il numerale di molteplicitagrave della specie quadrata lsquocentinaiarsquo i due 0 che seguono il 3 segnalano esattamente questo fatto che la notazione greca per gli interi non posizionale fa scomparire al livello denotativo Ciograve non vale soltan-to per i numeri interi ma anche per le loro parti i minuti secondi appar-tengono alla specie lsquoquadratorsquo in quanto 13600 egrave il quadrato di 160
La concezione appare interamente dispiegata nellrsquointroduzione degli Arithmetica diofantei79 che si rivela giova farlo rimarcare un te-stimone fondamentale per la ricostruzione della notazione matematica antica Alle specie usate in questrsquoopera vengono assegnati una denomi-nazione ed un segno convenzionale costituito dallrsquoiniziale (di ognuno dei componenti) della denominazione al quadrato o δύναμις il segno ΔΥ al κύβος il segno ΚΥ alla lsquoquarta potenzarsquo o δυναμοδύναμις il segno ΔΥΔ ecc La descrizione di tali segni egrave del tipo καὶ ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον Κ ἐπίσημον ἔχον Υ ΚΥ κύβος laquoe il suo segno egrave un Κ che ha come indice un Υ ΚΥ cuboraquo dove in accordo con quanto abbiamo visto nel punto b supra e pur nel comprensibile imbarazzo del copista della prima parte del Matritensis (o di un suo passato collega) a districarsi in questo formidabile ginepraio notazionale80 le due lettere Κ e Υ ricevono una barra mentre ΚΥ non la richiede a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον il quale ancora una volta esclude automaticamente il segno dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
79 In particolare a DOO I pp 214-62180 Nel Matr 4678 riscontriamo i seguenti fenomeni nelle poche righe a cavallo dei ff
58r-v 1) accento acuto posto su tutti i segni come se fossero abbreviazioni 2) ripetizione sistematica segnodenominazione come in ΚΥ κύβος appena letto dovuta sicuramente allrsquointrusione di glosse interlineari esplicative dei segni ndash e successivo pentimento (δύναμις e κύβος sono in effetti cancellati dalla prima mano il primo con un tratto il secondo con dei punti supra lineam poi il copista si stanca di correggere) 3) nella descrizione del segno per la δυναμοδύναμις menzione di un δέλτα δύο che saragrave molto probabilmente stato ΔΔ subito dopo nella descrizione del κυβόκυβος si legge un incongruo δύο KK
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 155
Diofanto introduce poi dei segni anche per le specie delle parti dellrsquounitagrave (le nostre frazioni) che egli chiama ὁμώνυμα μορία laquoparti omonimeraquo di cui quelle sessagesimali sono casi particolari81 Egli spie-ga appunto che le loro denominazioni sono ottenute da quelle delle specie degli interi per sinonimia passando ad un lsquoordinalersquo82 formato semplicemente aggiungendo il suffisso -στον δυναμοστόν κυβοστόν δυναμοδυναμοστόν ecc (sott μόριον) I loro segni convenzionali sono invece ottenuti da quelli per le specie degli interi aggiungendo una γραμμὴν διαστέλλουσαν τὸ εἶδος laquolinea che distingue la specieraquo83 Una linea sui segni delle specie delle parti egrave richiesta si badi bene per distinguerli dai segni di quelle degli interi come giagrave osservato questi ultimi sono giagrave lsquoagrammaticalirsquo a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον a fortiori lo saranno anche i primi Si tratta della traduzione semio-tica del passaggio dal cardinale allrsquoordinale che a livello grammaticale egrave effettuato con il suffisso -στον Che forma ha questa linea Barra o apice (Egrave cervellotico pensare a forme piugrave complesse) La domanda non ammette una risposta immediata in quanto delle specie diofantee nessuno piugrave si occupa nellrsquoantichitagrave84 Se egrave vero che la prima risposta darebbe origine ad un conflitto tra due convenzioni denotative diffe-renti la barra lsquocitazionalersquo e la barra che distingue la specie lrsquoevidenza grafica del Matritensis lascia lievemente sgomenti (ricordiamoci che giagrave i segni di base sono indebitamente dotati di un accento dal copista) Le poche occorrenze del segno per le specie delle parti85 vedono lrsquoaggiunta di uno slash di sospensione di un doppio apice inverso ndash in tutta evi-
81 Questo fatto era giagrave chiaro nellrsquoantichitagrave Teone in Alm I 10 in iA p 45310-1682 Il parallelo con i cardinali e gli ordinali relativi agli interi egrave reso esplicito da Dio-
fanto ὥσπερ δὲ τῶν ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια παρομοίως καλεῖται τοῖς ἀριθμοῖς τοῦ μὲν τρία τὸ τρίτον τοῦ δὲ τέσσαρα τὸ τέταρτον οὕτως καὶ τῶν νῦν ἐπονομασθέντων ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια κληθήσεται παρομοίως τοῖς ἀριθμοῖς laquocome le parti omonime dei numeri sono chia-mate per assonanza con i numeri di lsquotrersquo lsquolsaquounrsaquo terzorsquo di lsquoquattrorsquo lsquolsaquounrsaquo quartorsquo cosigrave le parti omonime dei numeri appena nominati saranno chiamate per assonanza con i numeriraquo (DOO I p 69-13 si noti lrsquoarticolo lsquocitazionalersquo al singolare in τοῦ τρία e τοῦ τέσσαρα) Il parallelo prosegue anche al livello dei segni che rappresentano queste specie come vedremo tra un attimo
83 Diofanto Arithmetica prefazione in DOO I p 620-21 un passaggio maltrattato in questa edizione occorre espungere il participio ἔχον senza introdurre segni ulteriori oppure eliminare un precedente ἐπί come fa un correttore del Matritensis f 58v
84 Unica parzialissima eccezione lrsquoaccenno di Teone menzionato nella nota 81 supra85 Al f 59r e per di piugrave nel margine per sanare un lungo saut du mecircme au mecircme La
collocazione in margine egrave il motivo per cui troviamo una notazione abbreviata nel resto del trattato il primo copista scioglie tutti i segni prendendoli per abbreviazioni mentre il secondo elimina sistematicamente il tratto aggiuntivo delle specie delle parti dellrsquounitagrave Drsquoaltronde egli scrive ad esempio ΔΥ invece di ΔΥ ed egrave quindi indotto a porre la barra al di sopra della stringa di lettere risultante (passim ma si veda ad esempio il f 72r)
Fabio Acerbi156
denza il compendio per la desinenza -ον accentata il copista interpreta il segno come unrsquoabbreviazione ndash e di una barra a sormontare lo Υ Potremmo forse interpretarlo come il segno di contrazione del grafema -στ- lrsquounico tassello mancante in unrsquoabbreviazione come ad esempio (δυναμοδυναμο)(στ)(ὸν) ma uno scolio di prima mano al f 58v rela-tivo alle specie degli interi inficia questrsquoipotesi esse sono dotate di slash di sospensione accento acuto in un caso del compendio canonico per la terminazione -ον hellip ma tutti gli Υ a esponente sono a loro volta sormontati da una barra
Meno legata al singolo manoscritto ma nondimeno non uniforme si presenta la pratica di notazione dei segni che rappresentano gli enti numerici sessagesimali86 da una parte sta lrsquoevidenza del testo dei Pro-legomena e delle sue tabelle apici ndash drsquoaltronde come abbiamo visto la notazione universalmente impiegata per i numerali ordinali e per le fra-zioni unitarie ndash dallrsquoaltra sta lrsquoevidenza del testo dellrsquoAlmagesto in tutti i manoscritti piugrave antichi e lo stesso si dica del commentario teonino a questrsquoopera o del suo lsquoGrande commentariorsquo alle Tavole facili e dei testi astronomici su papiro barre87 Sembra insomma che la nostra docu-
86 Sia le molteplicitagrave che le specie ahimeacute entrambe rappresentate da lettere dellrsquoalfabeto Come osservato allrsquoinizio della sezione 3 ci sono in effetti due tipi di lettere numerali in gioco se facciamo astrazione da apici o barre lsquo4 minuti secondirsquo si trova scritto δ β la prima lettera numerale denota la molteplicitagrave degli item di una certa specie la se-conda la specie nei Prolegomena entrambe sono accompagnate da un doppio apice il che rende inutile la presenza delle seconde Si noti che la descrizione della tabella non fa parola della notazione da usare per le lettere numerali che denotano la molteplicitagrave barre o apici e quanti apici hellip In questo caso fa interamente fede la tabella cioegrave la pratica grafica condivisa instauratasi non egrave chiaro quando
87 I manoscritti piugrave antichi dellrsquoAlmagesto sono menzionati nella nota 10 supra quelli dei due commentarii teonini sono il Laur Plut 2818 e il celeberrimo Vat gr 190 (sec IX in Euclide Elementi Data Teone lsquoGrande commentariorsquo) per la notazione dei pa-piri astronomici si veda Jones 1999 II passim La notazione non sembra lsquoinquinatarsquo dalla pratica dei copisti bizantini e pare dipendere soltanto dalla data di composizione Tro-viamo ad esempio barre sopra tutti i numerali di molteplicitagrave (interi o sessagesimali) nel frammento di un commentario alle Tavole facili contenente un calcolo relativo al 24 aprile 213 (Par gr 2841 sec XIII ex-XIV in oltre al frammento ai ff 32r l 11-34v l 23 contiene Arato Phaenomena ed Efestione Apotelesmatica edizione in Jones 1990) Nel commentario alle Tavole facili composto ca 610-617 ed attribuito a Stefano di Alessandria la situazione egrave la seguente (Jean Lempire per litteras per lrsquoedizione si veda Lempire 2014 ho controllato il Vat gr 304 ff 135r-171v sec XIV am contiene in aggiunta Teone in Almagestum I-II lsquoPiccolo commentariorsquo alle Tavole facili Diofanto Arithmetica e De polygo-nis numeris varia astronomica tabulae) barre sopra gli interi sporadicamente rimpiazzate da apici apici sopra le parti sessagesimali in numero uguale alla denominazione doppio () apice per le frazioni unitarie Sono impiegate barre sopra gli interi e apici sopra le parti sessagesimali nei manoscritti principali di tutti i trattati di introduzione allrsquoAlmagesto o comunque di argomento logistico redatti in epoca bizantina Giorgio Pachimere (1242-ca 1310) Quadrivium (autografo nel manoscritto Roma Biblioteca Angelica gr 38 [RGK III nr 115] si veda Tannery ndash Steacutephanou 1940 per lrsquoedizione) Teodoro Metochita (1270-
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 157
mentazione si faccia testimone di un cambio notazionale avvenuto nel periodo intercorrente fra Teone (sec IV pm) e la scuola alessandrina di Ammonio e dei suoi allievi (sec VI in) e probabilmente innescato da questrsquoultimo ambiente lrsquoaspetto paradossale egrave che nello stesso codice si rintraccino due notazioni differenti per gli enti numerici sessagesimali e lrsquouna (apici) sia adottata sistematicamente e coerentemente in uno scritto (i Prolegomena) che si presenta esattamente come unrsquointroduzione tecnica alla pratica numerico-algoritmica del trattato (lrsquoAlmagesto) in cui egrave adottata lrsquoaltra (barre che ritroviamo senza eccezioni anche negli scolii)
Torniamo ai Prolegomena la descrizione del segno da porre a fianco di ogni singolo quoziente parziale e denotante la sua specie numerica (minuti primi minuti secondi ecc) solleva tre problemi
Primo problema Ci vuole una barra o un apice su τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquola lettera A [hellip] che significa la specieraquo quando lo scriviamo nella tabella Tutta la nostra discussione precedente fa pro-pendere per lrsquoapice e si ricordi anche la forma verbale ἀνατείνουσαν che suggerisce qualcosa che si lsquoestende verso lrsquoaltorsquo (la mia traduzione egrave volutamente neutra) se fosse apposta una barra la cosa dovrebbe passare
1231332) Compendium astronomicum (copia lsquoautorizzatarsquo coeva nei Vat gr 182 e 181 da parte del copista che integrograve le parti mancanti del Par gr 2389 [ff 207-210 255-270 374-375] Bianconi 2005a pp 425-427 Peacuterez Martiacuten 2008 p 436 e n 177) Teodoro Meliteniota (morto lrsquo831393) Tribiblos astronomica (autografo nel Vat gr 792 si vedano Leurquin 1991 per unrsquoanalisi del manoscritto Leurquin 1990 per lrsquoedizione) una com-pilazione anonima (per cui ho consultato il Par gr 2396 ff 87r-92v limitatamente a questi fogli manu Costantino Trivoli [RGK II nr 318 ma ovviamente questo codice non vi egrave segnalato] terzo quarto del XV secolo il resto del codice annotato da Niceforo Gregora egrave di etagrave planudea e parzialmente [ff 33v-76v] un autografo di Planude stesso contiene Teone in Almagestum I II IV Mondrain 2002 il codice va completato ndash limitatamente a stralci dei libri VIII-X XII-XIII del commentario teonino la cui parte intermedia si egrave persa ndash con 26 carte [ff 123-147] inserite nel Vat gr 1087 anchrsquoesso contenente anno-tazioni di Gregora Rome 1927 per la figura del copista dei ff 77r-86r del Par gr 2396 e dei ff appena nominati del Vat gr 1087 un anonimo collaboratore di Gregora si veda in ultimo Bianconi 2006a pp 147-151) si veda anche il calcolo effettuato da Niceforo Gre-gora (12921295-13581361) dellrsquoeclisse di sole del 16 luglio 1330 (attestata unicamente ai ff 1r-8v della miscellanea astronomica Marc gr 325 databile ca 1324-1329 in parte vergata e ovunque fittamente annotata da Gregora stesso edizione del testo in Mogenet et al 1983 annotazioni di Gregora elencate in Bianconi 2005a p 413) Unrsquoeccezione apparente il lsquoPiccolo commentariorsquo di Teone alle Tavole facili le parti sessagesimali sono segnalate da apici (ad esempio nel Vat gr 175 vergato da Giovanni Catrario e completato nel 1321-1322 sulla figura di Catrario si vedano in ultimo Bianconi 2005b pp 141-156 e 2006b) lrsquoopera egrave antica ma la sua tradizione non rimonta oltre la fine del XIII secolo a parte un frammento nel Leiden BPG 78 ff 156r-161v (minuscola del IX-X secolo) e in effetti in questo manoscritto tutti i numerali di molteplicitagrave sono sormontati da barre Unrsquoeccezione effettiva egrave il De hypotesibus planetarum nel Vat gr 1594 barre sugli interi e apici sulle parti sessagesimali
Fabio Acerbi158
sotto silenzio e la presenza dellrsquoapice la rende inutile88 Si tratta della stessa convenzione diofantea e coincide ancora con la notazione per i numerali ordinali e per le frazioni unitarie che egrave corrente nei mano- scritti matematici greci per questo motivo non percheacute la descrizione sia particolarmente perspicua nessuno dei copisti della recensione an-tica ha incertezze apici Ma questi apici si rintracciano soltanto sulle indicazioni di specie non contemplate dalla descrizione che sono ante-poste ai resti parziali a fianco dei quozienti parziali i segni di specie sono invece trasformati in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordi-nali corrispondenti del tipo πρωτ tavv 5 e 7b-8 Il recensore bizantino taglia invece la testa al toro elimina dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali elimina la seconda menzione della laquolet-tera Araquo contestualmente allrsquoazzeramento dellrsquoespediente della linea a zig-zag (si veda il punto seguente) modifica la descrizione che contiene la prima menzione in quella dellrsquoapice associato direttamente ai nume-rali di molteplicitagrave riciclando addirittura lrsquoalpha per adibirlo a desi-gnare un numero cardinale (come sorprendersi) τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ laquoponendo al di sopra di essi [scil dei 50 minuti primi] 1 solo lsaquoaccentorsaquo acutoraquo La scelta del recensore egrave assennata che rechi una barra o un apice in una tabella un alpha denota un numero non un numero drsquoordine
Secondo problema da tenere ben distinto dal precedente Cosa ci vuole sul segno α per la lettera alpha menzionata nella frase τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquolettera A [hellip] che significa la specieraquo89 Unrsquooc-chiata allrsquoapparato critico rivela una bella incertezza nei manoscritti Z scrive sempre ᾱ e in un caso lo fa anche P MS optano sempre per α´ C per α P scrive nellrsquoaltro caso αο Per quanto solo la barra sia congrua con il senso della frase in quanto la lettera alpha egrave qui menzionata (si tratta di un oggetto che compare nella tabella) e non cambia niente se essa egrave accompagnata dal suo nome di genere στοιχεῖον ad un livello grafico lrsquoincertezza fra il segno ᾱ che denota laquola lettera αraquo e il segno α´ (o lrsquoabbreviazione αο) per una forma di πρῶτος egrave per piugrave versi giustificata
88 Detto in altri termini la barra egrave uno strumento grafico non matematico e quindi la sua presenza non va segnalata mentre un apice lo egrave e la sua presenza lo deve
89 Notare che in questa frase il primo α non vuole la barra (egrave menzionato allrsquointerno di una frase che impiega convenzioni moderne) il secondo sigrave (idem ma con convenzioni antiche) ndash e nella traduzione la scelta di denotarlo con A (senza virgolette) e non con lsquoArsquo (con virgolette) egrave del tutto arbitraria ndash si noti inoltre che le necessarie precisazioni laquosenzacon virgoletteraquo mostrano che le lingue moderne palesano difficoltagrave analoghe a quelle del greco antico per quanto riguarda i livelli denotativi in ambito metadiscorsivo per non usare le due parentetiche avrei dovuto scrivere rispettivamente lsquoArsquo e lsquolsquoArsquorsquo (doppie virgolette semplici)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 159
ᾱ coincide con il numerale 1 α egrave la prima lettera dellrsquoalfabeto ed inoltre α´ egrave esattamente quello che va scritto nella tabella Potremmo dirci che il sostantivo στοιχεῖον chiude la questione la sua presenza congiunta ad un ipotetico α´ renderebbe la descrizione ridondante o inappropriata90 Ma a parte il fatto che α egrave proprio τὸ πρῶτον στοιχεῖον il segno α´ cat-tura in fondo il cuore della descrizione di uno στοιχεῖον ἔχον lsaquoγραμμὴνrsaquo ἀνατείνουσαν
Terzo problema Lrsquoautore dei Prolegomena che si arresta allrsquoesem-pio dei minuti primi non dice quanti apici occorre mettere sulle lettere numerali che identificano gli ordini superiori al primo se uno soltanto come nel caso diofanteo e delle frazioni unitarie o in numero uguale alla loro denominazione (cioegrave pari al numero denotato dal numerale stesso su cui vanno posti) come effettivamente avviene nei mano-scritti dei Prolegomena La tabella egrave quindi sottodeterminata dalla sua descrizione anzi in un certo senso prende il sopravvento su di essa la pratica di marcare i numerali di molteplicitagrave con gli apici che compe-tono allrsquoordine cui appartengono viene trasferita ai segni per gli ordini stessi per supplire ad una descrizione carente di questi ultimi E la tabella egrave sottodeterminata dalla descrizione in quanto egrave la descrizione di una tabella reale ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις laquocome nello lsaquoschemarsaquo espostoraquo leggiamo a un certo punto del testo
3) La linea a zig-zag Non possiamo che applaudire a questo geniale espediente grafico lo troviamo messo in opera solo nel Marc gr 313 Per quanto lrsquoautore non faccia parola di ciograve nel corso della sua descrizione la linea spezzata egrave intesa dover lsquosaltarersquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue Il copista del codice marciano effettua correttamente due salti nella prima delle sue tabelle (tav 4) ma inserisce un lsquodentersquo in piugrave in quella che considera corretta (tav 5) La linea a zig-zag egrave incompatibile con la presenza di linee di giustificazione nella tabella che in effetti mancano nel Marc gr 313 ciograve induce gli errori di allineamento dei primi 5 quozienti parziali di cui egrave vittima il copista Probabilmente per questo motivo in nessuno degli apografi del Vat gr 1594 la linea a zig-zag figura nella tabella inquadrata come si conviene da una (doppia) cornice esterna e le cui colonne sono appunto separate da linee verticali (tav 7b Vat gr 184 f 17v e tav 8 Par gr 2390 f 9v cui egrave sostanzialmente identica la tabella del Marc gr 314 che si trova
90 Trascuro lrsquoabbreviazione αο = πρῶτος percheacute la desinenza non egrave quella richiesta neacute nella frase (egrave richiesto πρῶτον) neacute nella tabella (πρῶτα)
Fabio Acerbi160
al f 248r ndash ma la mancanza di linee orizzontali causa un gigantesco pa-sticcio nel codice vaticano) Alla recensione bizantina che dipende per il suo testo di base dal Vat gr 1594 e quindi non trova la linea a zig-zag nella tabella non resta che sopprimere la sua descrizione ndash ma proprio per questo motivo e finalmente diventa possibile tracciare un apparato completo di linee di giustificazione (tav 9 Laur Plut 89 sup 48 f 14v) Dato che la descrizione di Teone di questo procedimento di divi-sione non fa cenno allrsquoesistenza della linea a zig-zag viene da chiedersi se essa non costituisca un espediente escogitato dallrsquoautore dei Prolegomena per vivacizzare la procedura originale di Pappo
4) Discrepanze tra descrizione e tabella Il gioco delle minime va-rianti mostra che la divisione era stata eseguita (e trasmessa) corret-tamente tutti i valori numerici sono esatti La tabella nel Marc gr 313 presenta perograve alcune discrepanze con la propria descrizione Essa omette (ma non nella versione lsquoscorrettarsquo lrsquoomissione non si riscontra neanche nel Par gr 2390) il segno per laquorestoraquo di fronte ai resti par-ziali ma aggiunge lrsquoindicazione della loro specie Essa trasforma invece come abbiamo visto le indicazioni di specie che seguono i quozienti parziali in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordinali corri-spondenti La descrizione prevede di chiudere la tabella con il risultato καὶ συνάγων ἅπαντα τὰ ἐκ τῶν μερισθέντων μερῶν λεπτὰ σημειοῦται ὑπὸ πάντας οὕτως γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoe raccogliendo tutti i minuti che provengono dalle parti divise lsaquoPapporsaquo nota sotto tutto cosigrave Ris 0 59 8 17 13 12 31raquo ma sotto la tabella tutta la tradizione ci consegna qualcosa di piugrave articolato ὁ ζητούμενος καθ᾽ ὃν μερίζεται ὁ τξε ιδ´ μη´´ π(αρὰ) τὸν τξ γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoil lsaquonumerorsaquo cercato secondo cui 365 14 48 egrave diviso per 360 risulta 0 59 8 17 13 12 31raquo frase che del resto contiene due errori lrsquoinversione del dividendo e del divisore e la confusione tra segno convenzionale (iuxta descrizione) e abbreviazione (come nella frase) nel caso di γι Oltre ad eliminare la linea a zig-zag91 la recensione bizantina sopprime dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali e modifica come abbiamo visto al punto 2 le loro descrizioni in quelle di apici associati diretta-mente ai numerali di molteplicitagrave
91 Le due righe che nella recensione di base contengono solo i resti parziali minori di 160 del divisore ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue sono in parte completate con lrsquoindicazione abbreviata ἀνάλ(υσις) laquoanalisiraquo il termine greco per questa procedura di riduzione In un sussulto di ipercorrettismo matematico tali resti parziali ridotti non sono preceduti dal segno per laquorestoraquo come nel Par gr 2390 ma da quello per laquorisultatoraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 161
Gli esempi che abbiamo discusso mostrano come i problemi di notazione pesino e non poco sullrsquoespressione discorsiva di un algorit-mo matematico lrsquoente di riferimento per lsquoformularersquo il procedimento di divisione fu considerata la tabella cioegrave un oggetto la cui costitu-zione egrave legata piugrave ad una pratica grafica che a considerazioni logico- algoritmiche non la sua descrizione che in effetti finisce per determi-nare la tabella in maniera non univoca Di questa sottodeterminazione si fa testimone la traiettoria che abbiamo cercato di seguire nelle mani di copisti e revisori il procedimento di divisione si modifica a volte in aspetti secondari a volte in punti piugrave sostanziali ndash fino a rendere neces-saria una radicale revisione della sua descrizione per renderla conforme alla tabella ndash in ogni caso mai per ragioni squisitamente matematiche92
Abstract
The article presents and discusses in detail two passages from the anonymous Prolegomena to the Almagest a VIth century primer to the elementary procedures of calculation needed in Ptolemyrsquos Almagest In the two passages we may follow the complex interplay between mathematical notation the auctor who employed and described it the tachygrapher who transcribed it in vivo copyists who reproduced it correctors who modified it Along this path misgivings and errors arise in the transmission of abbreviations and paratextual units such as diagrams tables operational schemes
Fabio AcerbiCNRS UMR8560 Centre Alexandre Koyreacute
fabacerbigmailcom
92 Sono grato a Daniele Bianconi Lucio del Corso Jean Lempire per alcune preziose indicazioni
AOO = Archimedis opera omnia cum commentariis Eutocii ed J L Heiberg I-III Lipsiae 1910-1915
DOO = Diophanti Alexandrini opera omnia cum Graecis commentariis ed P Tannery I-II Lipsiae 1893-1895
GC = Le laquoGrand Commentaireraquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Mogenet ndash A Tihon I-III Cittagrave del Vaticano 1985-1999
iA = Commentaires de Pappus et de Theacuteon drsquoAlexandrie sur lrsquoAlmageste ed A Rome I-III con paginazione continua Cittagrave del Vaticano 1931-1943
HOO = Heronis Alexandrini opera quae supersunt omnia ed G Schmidt ndash L Nix ndash W Schmidt ndash H Schoene ndash J L Heiberg I-V Lipsiae 1899-1914
PC = Le ldquoPetit Commentairerdquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed A Tihon Cittagrave del Vaticano 1978
POO = Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia ed J L Heiberg I-II in 3 parti Lipsiae 1898-1907
RGK = Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600 I Handschriften aus Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln II Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs und Nachtraumlge zu den Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln III Handschriften aus Bibliotheken Roms mit dem Vatikan A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg unter Mitarbeit von D Harlfinger und P Eleuteri B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln Wien 1981-1997 (Oumlsterreichische Akademie der Wissenschaften Veroumlffentlichungen der Kommission fuumlr Byzantinistik III1-3 A-C)
Sigla
Acerbi 2010 = F Acerbi Il silenzio delle sirene La matematica greca antica Roma 2010
Acerbi 2012 = F Acerbi I codici stilistici della matematica greca dimostrazioni procedure algoritmi laquoQUCCraquo 1012 (2012) pp 167-214
Acerbi et al 2010 = F Acerbi ndash N Vinel ndash B Vitrac Les Proleacutegomegravenes agrave lrsquoAlmageste Une eacutedition agrave partir des manuscrits les plus anciens Introduction geacuteneacuterale ndash Parties I-III laquoSCIAMVSraquo 11 (2010) pp 53-210
Agati 1992 = M L Agati La minuscola laquoBouleteacuteeraquo Cittagrave del Vaticano 1992
Belger 1881 = C Belger Ein neues Fragmentum mathematicum Bobiense laquoHermesraquo 16 (1881) pp 261-284
Bianconi 2005a = D Bianconi La biblioteca di Cora tra Massimo Planude e Niceforo Gregora Una questione di mani laquoSampTraquo 3 (2005) pp 391-438
Bianconi 2005b = D Bianconi Tessalonica nellrsquoetagrave dei Paleologi Le pratiche intellettuali nel riflesso della cultura scritta Paris 2005
Bianconi 2006a = D Bianconi Le pietre e il ponte ovvero identificazioni di mani e storia della cultura laquoBizantinisticaraquo 8 (2006) pp 135-181
Bianconi 2006b = D Bianconi Qualcosa di nuovo su Giovanni Catrario laquoMEGraquo 6 (2006) pp 69-91
Cavallo 1977 = G Cavallo Funzione e strutture della maiuscola greca tra i secoli VIII-XI in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Colloque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 95-137
Cereteli 1904 = G F Cereteli De compendiis scripturae codicum Graecorum praecipue Petropolitanorum et Mosquensium anni nota instructorum Sankt-Petersburg 1904
De Gregorio 2000 = G De Gregorio Materiali vecchi e nuovi per uno studio della minu-scola greca fra VII e IX secolo in G Prato (a cura di) I manoscritti greci tra riflessione e dibattito Atti del V Colloquio Internazionale di Paleografia Greca Cremona 4-10 ottobre 1998 Firenze 2000 pp 83-151
Follieri 1977 = E Follieri La minuscola libraria dei secoli IX e X in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Col-loque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 139-165
Fonkič 2005 = B Fonkič Venecianskaia rukopisrsquo laquoAlrsquomagestaraquo Ptolemeja (Marc gr 313690) o datirovke i proischoždenii kodeksa laquoVDIraquo s III 254 (2005) pp 162-167
Fowler 1999 = D H Fowler The Mathematics of Platorsquos Academy A New Reconstruction Second Edition Oxford 1999
Bibliografia
Fabio Acerbi164
Gerstinger ndash Vogel 1932 = H Gerstinger ndash K Vogel Eine stereometrische Aufgaben-sammlung im Papyrus Graecus [sic] Vindobonensis 19996 laquoMitteilungen aus der Papy-russammlung der Nationalbibliothek in Wienraquo Neue Serie Folge 1 Griechische literarische Papyri 1 Wien 1932 pp 11-76
Heiberg 1927 = Mathematici Graeci Minores ed J L Heiberg Kjoslashbenhavn 1927
Hultsch 1876-1878 = Pappi Alexandrini Collectionis quae supersunt ed F Hultsch I-III Berlin 1876-1878
Janz 2003 = T Janz The Scribes and the Date of the Vat gr 1291 in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae X Cittagrave del Vaticano 2003 pp 159-180
Jones 1990 = Ptolemyrsquos First Commentator ed A Jones Philadelphia 1990
Jones 1999 = Astronomical Papyri from Oxyrhynchus ed A Jones I-II Philadelphia 1999
Jones 2005 = A Jones Ptolemyrsquos Canobic Inscription and Heliodorusrsquo Observation Reports laquoSCIAMVSraquo 6 (2005) pp 53-97
Lempire 2014 = Steacutephanos drsquoAlexandrie Le commentaire aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Lempire Louvain 2014
Leurquin 1990 = Theacuteodore Meacuteliteacuteniote Tribiblos astronomique Livre I ed R Leurquin Amsterdam 1990
Leurquin 1991 = R Leurquin Un manuscrit autographe de la Tribiblos Astronomique de Theacuteodore Meacuteliteacuteniote le Vaticanus graecus 792 laquoScriptoriumraquo 45 (1991) pp 145-162
Maas 1927 = P Maas Griechische Palaeographie in A Gercke ndash E Norden (hrsg von) Einleitung in die Altertumswissenschaft I9 Leipzig 1927 pp 69-80
Martinelli Tempesta 2010 = S Martinelli Tempesta Il codice Milano Biblioteca Am-brosiana B 75 sup (gr 104) e lrsquoevoluzione della scrittura di Giovanni Scutariota in A B Garciacutea ndash I Peacuterez Martiacuten (ed by) The Legacy of Bernard de Montfaucon Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting Proceedings of the Seventh Inter-national Colloquium of Greek Palaeography Madrid-Salamanca 15-20 September 2008 Turnhout 2010 pp 171-186
Mazzucchi 1994 = C M Mazzucchi Leggere i classici durante la catastrofe (Costantino-poli maggio-agosto 1203) le note marginali al Diodoro Siculo Vaticano gr 130 Parte prima stratigrafia laquoAevumraquo 68 (1994) pp 164-218
Mioni 1976 = E Mioni Bessarione scriba e alcuni suoi collaboratori in Miscellanea marcia-na di studi bessarionei Padova 1976 pp 263-323
Mioni 1985 = Codices graeci manuscripti Bibliothecae Divi Marci Venetiarum II Thesaurus Antiquus Codices 300-625 recensuit E Mioni Roma 1985
Mogenet 1962 = J Mogenet Une scholie ineacutedite du Vat gr 1594 sur les rapports entre lrsquoastronomie arabe et Byzance laquoOsirisraquo 14 (1962) pp 198-221
Mogenet et al 1983 = Niceacutephore Greacutegoras Calcul de lrsquoeacuteclipse de soleil du 16 juillet 1330 ed J Mogenet ndash A Tihon ndash R Royez ndash A Berg Amsterdam 1983
Mondrain 2002 = B Mondrain Maxime Planude Niceacutephore Greacutegoras et Ptoleacutemeacutee laquoPa-laeoslavicaraquo 10 (2002) pp 312-322
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 165
Mondrain 2004 = B Mondrain Lrsquoancien empereur Jean VI Cantacuzegravene et ses copistes in A Rigo (a cura di) Gregorio Palamas e oltre Studi e documenti sulle controversie teologiche del XIV secolo bizantino Firenze 2004 pp 249-296
Mondrain 2007 = B Mondrain Les eacutecritures dans les manuscrits byzantins du XIV e siegravecle Quelques probleacutematiques laquoRSBNraquo n s 44 (2007) pp 157-196
Peacuterez Martiacuten 2006 = I Peacuterez Martiacuten Maxime Planude et le Diophantus Matritensis (Madrid Biblioteca Nacional ms 4678) un paradigme de la reacutecupeacuteration des textes anciens dans la ldquorenaissance paleacuteologuerdquo laquoByzantionraquo 76 (2006) pp 433-462
Peacuterez Martiacuten 2008 = I Peacuterez Martiacuten El lsquoestilo Hodegosrsquo y su proyeccioacuten en las escrituras constantinopolitanas laquoSampTraquo 6 (2008) pp 389-458
Perria 1991 = L Perria Scrittura e ornamentazione nei codici della laquocollezione filosoficaraquo laquoRSBNraquo n s 28 (1991) pp 45-111
Rollo 2012 = A Rollo LrsquoArchimede di Giorgio Valla in V Fera ndash D Gionta ndash A Rollo (a cura di) Archimede e le sue fortune Atti del Convegno di Siracusa-Messina 24-26 giugno 2008 Messina 2012 pp 99-147
Rome 1927 = A Rome Membra disjecta laquoRBenraquo 39 (1927) pp 187-188
Rome 1938 = A Rome Un manuscrit de la bibliothegraveque de Boniface VIII agrave la Meacutediceacuteenne de Florence laquoACraquo 7 (1938) pp 261-268
Ronconi 2013 = F Ronconi La collection philosophique un fantocircme historique laquoScripto-riumraquo 67 (2013) pp 119-140
Tannery ndash Steacutephanou 1940 = Quadrivium de Georges Pachymegravere ed P Tannery ndash E Steacutephanou Cittagrave del Vaticano 1940
Tihon 2011 = Πτολεμαίου Πρόχειροι Κανόνες Les Tables faciles de Ptoleacutemeacutee vol Ia Tables A1-A2 ed A Tihon Leuven 2011
Traube 1907 = L Traube Nomina Sacra Versuch einer Geschichte der christlichen Kuumlrzung Muumlnchen 1907
Vogel 1936 = K Vogel Beitraumlge zur griechischen Logistik laquoSBAWraquo Mathematisch-natur-wissenschaftliche Abteilung Jahrgang 1936 pp 357-472
Wouters 1979 = A Wouters The Grammatical Papyri from Graeco-Roman Egypt Contri-butions to the Study of the lsquoArs Grammaticarsquo in Antiquity Brussel 1979
F ACERBI Tav 1
b Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 65r
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 284 f 160r
F ACERBITav 2
b Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 13r
a Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 19v
F ACERBI Tav 3
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 136v
F ACERBITav 4
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17r
F ACERBI Tav 5
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17v
F ACERBITav 6
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 7v
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
Fabio Acerbi130
tale di solito le troviamo nei margini ma possono occupare lrsquointero specchio di scrittura e ciograve indipendentemente dalla determinazione del loro statuto paratestuale sulla base del criterio della presenzaassenza di una descrizione
Lo statuto meno elevato dei genuini paratesti (diagrammi e tabelle) rispetto ai testi (catene algoritmico-argomentative e tavole) indusse un atteggiamento differenziato in copisti ed editori attenti a rispettare lrsquointegritagrave dei secondi ma non dei primi ciograve che conta sono le informa-zioni veicolate dalle strutture discorsive e dalle porzioni alfanumeriche di diagrammi tavole e tabelle il resto egrave ritenuto adattabile alle esigenze dellrsquoedizione moderna19 o semplicemente ignorato nel corso del pro-cesso di copia in questa maniera si perdono perograve informazioni e strut-tura Come vedremo puograve avvenire che una parte della descrizione di unrsquooperazione resti senza relato nella resa grafica tabellare lrsquooperazione eseguita in forma algoritmica non corrisponde piugrave a quella eseguita in forma di tabella
3 Testi logistici e disposizione tabellare delle operazioni
Nessun testo matematico primario di etagrave ellenistica o imperiale contiene operazioni aritmetiche eseguite con una sola eccezione la de-scrizione che non ammette una rappresentazione tabellare del procedi-mento di estrazione approssimata di radice quadrata in Erone Metr I 8 Drsquoaltro canto abbiamo giagrave osservato che lrsquoAlmagesto di Tolomeo for-nisce il risultato di migliaia di operazioni ma nessuna di esse egrave eseguita Attestazioni di questi procedimenti sono pertanto legate ad iniziative editoriali di secondo livello come i commentari alla loro prima occor-renza oppure in casi paradigmatici gli algoritmi di calcolo omessi nel testo primario vi sono resi espliciti Di fatto e con una sola eccezione la nostra documentazione consiste in commentari allrsquoAlmagesto quello di Teone e i Prolegomena ad Almagestum
19 Abbiamo giagrave visto alcuni esempi di modifiche del formato delle tavole Quanto ai diagrammi quelli tracciati nelle edizioni moderne rappresentano il caso piugrave generale pos-sibile Le figure che troviamo nei manoscritti greci hanno invece la caratteristica opposta illustrano spesso casi particolari e sono metricamente scorrette Sono in effetti tracciati triangoli rettangoli isosceli cerchi uguali rette perpendicolari dove tutto ciograve non egrave richiesto dallrsquoenunciato e inoltre rettangoli invece di parallelogrammi segmenti uguali quando sia-no disuguali addirittura linee rette al posto di curve (in Archimede Meth 14 un arco di parabola egrave rappresentato da un angolo rettilineo) e in generale figure con proprietagrave di simmetria non richieste
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 131
LrsquoAlmagesto e con esso tutta la tradizione astronomica adotta il sistema sessagesimale per esprimere la parte non intera di un nu-mero che siano valori angolari o lineari non fa differenza20 come noi scriviamo 36524 e intendiamo 365 + 2 decimi + 4 centesimi (cioegrave 4102) cosigrave nel sistema sessagesimale 365 14 48 significa21 365 + 14 sessantesimi + 48 tremilaseicentesimi (cioegrave 48602) ovverosia nel lessico antico e nostro 365 14 πρῶτα λεπτά laquominuti primiraquo 48 δεύτερα λεπτά laquominuti secondiraquo dove laquoprimoraquo e laquosecondoraquo sono le laquodenominazioniraquo degli ordini (sono cioegrave numeri ordinali) 14 e 48 i lsquonumerali di molteplicitagraversquo relativi ai due ordini numerale di mol-teplicitagrave e relativa denominazione costituiscono insieme una lsquoparte sessagesimalersquo di un numero Drsquoaltronde per gli antichi come per noi lrsquoespressione di una parte non intera (ovvero di una frazione)
20 Trascuro il fatto ai nostri fini irrilevante che essendo i numerali greci lettere alfabetiche la notazione che ne risulta per i numeri interi non egrave posizionale nonostante le cifre scagravelino di un posto ad ogni potenza di dieci il segno μ per 4 (decine) non egrave identico al segno δ per 4 (unitagrave) Drsquoaltra parte una volta adottata la notazione decimale per i numerali di molteplicitagrave la notazione complessiva per la parte non intera espressa nel sistema sessa-gesimale non egrave posizionale neanche introducendo un segno di lsquoposto vuotorsquo una cui parte egrave nel caso greco analoga in forma al nostro 0 (su questo segno si veda ancora la sezione 4 punto c) occorre avvalersi di accorgimenti ulteriori quali lrsquointroduzione di spaziature fra le differenti parti sessagesimali (come viene fatto nei manoscritti greci ed in questrsquoarticolo) o di segni tipografici (come suggerito da Otto Neugebauer che avrebbe scritto 3651448 il numerale che leggeremo tra un attimo nel testo) Il problema egrave che altrimenti lrsquoordine associato ad un numerale di molteplicitagrave di una parte sessagesimale puograve non risultare uni-vocamente determinato dalla sua posizione Esempio scrivendo 0129 per un numero non intero nel sistema sessagesimale il numerale di molteplicitagrave 129 potrebbe rappresentare 1 minuto primo e 29 secondi oppure 12 minuti primi e 9 secondi ecc e la stessa difficoltagrave si presenta nella notazione greca (per la nozione di lsquonumerale di molteplicitagraversquo si veda infra nel testo) Il problema scomparirebbe se adottassimo singoli segni differenti per tutti i nu-merali da 1 a 59 ndash ma neacute noi neacute i greci siamo stati disposti a introdurre una complicazione siffatta Si ricordi infine che al di fuori dei contesti astronomici il sistema di numerazione greco egrave decimale
21 Scriverograve i numerali in cifre arabe sempre in questo modo parte intera seguita dalle parti sessagesimali (minuti primi secondi ecc) con ogni ordine separato da uno spazio bianco Se la parte intera egrave assente il numerale inzia con uno 0 Nella trascrizione dei numerali in greco ogni numerale di molteplicitagrave sessagesimale o frazione unitaria saragrave identificato come nei manoscritti piugrave antichi dei Prolegomena da un opportuno numero di apici (uno per ogni unitagrave dellrsquoordine avendo le frazioni unitarie un solo apice come vedremo nellrsquoAlmagesto contenuto negli stessi codici troviamo barre non apici con questa funzione) mentre la parte intera saragrave priva della barra che la sormonta invariabilmente nei manoscritti In questo modo 365 14 48 egrave la conversione in cifre arabe di τξε ιδ´ μη´´ La pratica dei manoscritti medievali egrave di collocare gli apici (quando presenti) sopra le lettere numerali per ragioni tipografiche li porrograve di seacuteguito al gruppo di lettere cui si riferiscono Si noti che nella notazione greca il segno ιδ´ per 1460 in sessagesimale egrave identico a quello per 114 in decimale Nel caso delle frazioni unitarie la presenza dellrsquo(unico) apice egrave la traduzione semiotica della trasformazione che a livello grammaticale egrave effettuata con il pas-saggio dal cardinale allrsquoordinale (ad esempio da τὰ τρία laquotreraquo a τὸ τρίτον laquoun terzoraquo) si veda anche la sezione 4 punto 1 e note 82 e 86 ivi incluse
Fabio Acerbi132
richiede sempre lrsquointroduzione di due numerali il lsquonumeratorersquo e il lsquodenominatorersquo
Il motivo della scelta del sistema sessagesimale che fu mutuato dallrsquoastronomia matematica babilonese egrave presto detto lrsquoelevato numero di divisori di 60 e cioegrave 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 Poicheacute i divi-sori di 10 sono un sottinsieme di quelli di 60 molti piugrave numeri hanno una rappresentazione finita nel sistema sessagesimale che in quello deci-male Calcolare in sessagesimale lungi dal creare difficoltagrave offre quindi un vantaggio cruciale22 che risulta piugrave facilmente comprensibile sulla base dellrsquoesempio seguente La lunghezza dellrsquoanno solare egrave stabilita da Tolomeo in 365 giorni + 14 ndash 1300 di giorno Per calcolare il moto giornaliero del sole si rende necessario dividere 360 per questo numero Noi avremmo due opzioni se non potessimo usare la calcolatrice ri-durre il divisore ad una singola frazione tramite passaggio al denomi-natore comune invertire questa frazione e moltiplicarla per 360 sem-plificare gli eventuali fattori comuni e finalmente eseguire la divisione a piugrave cifre tra numeri interi (nel nostro caso 5400054787) oppure scrivere il divisore come numero decimale periodico (365246666 hellip) e poi eseguire la divisione Nel sistema sessagesimale egrave tutto molto piugrave semplice 365 + 14 ndash 1300 ha una rappresentazione finita cioegrave 365 14 48 come eseguire la divisione lo vedremo tra un attimo
Passiamo dunque in rassegna il contenuto del lsquomanuale di logisticarsquo incluso nei Prolegomena ad Almagestum riportando in nota per ogni item anche esposizioni parallele in altri commentatori23
a) Costruzione del sistema sessagesimale24
22 E uno svantaggio se le molteplicitagrave dei singoli ordini vengono espresse in no-tazione decimale (come facciamo noi e facevano i greci) il numero di cifre necessario per raggiungere una precisione assegnata egrave maggiore nel sistema sessagesimale in quanto per esprimere i numerali da 10 a 59 occorrono due cifre mentre per quelli da 1 a 9 (o da α a θ e le decine da ι a ν nel caso greco) ne basta una e ciograve indipendentemente dal fatto che la notazione sia posizionale oppure no La differenza si fa perograve sentire solo a partire dal quinto ordine sessagesimale
23 Trascuro la parte finale del lsquomanualersquo dove sono esposte le regole di interpolazione (cui era legata la lsquoterza colonnarsquo della tavola delle corde tolemaica) e il procedimento di lsquosottrazionersquo di rapporti cioegrave la divisione di un rapporto per un altro
24 Per a-b cf Teone in Alm I 10 in iA pp 44919-45814 PC pp 2007-2014 GC I pp 10910-11124 e le definizioni e regole diofantee di manipolazione delle varie specie numeriche in Arithmetica prefazione in DOO I pp 214-1218 Le porzioni a-b sono giagrave state pubblicate da Paul Tannery in DOO II pp 318-1517 sulla base del Par gr 453 apografo ad opera di Giovanni Santamaura di un Vat gr 1594 giagrave mutilo (RGK II nr 238 ma lrsquoautore trascritto vi egrave indicato come lsquoPtolemaiosrsquo) Evidentemente il committente non fu soddisfatto della prima trascrizione (ff 67-76) che crivella di tratti rossi a segnalarne gli errori di copia Ne fu dunque eseguita una seconda (ff 78-86) cui Santamaura antepose
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 133
b) Regole di moltiplicazione e divisione degli ordini sessagesimali defini-zione generale di moltiplicazione moltiplicazione di ordini come somma delle loro laquodenominazioniraquo Definizione generale di divisione divisione di ordini uguali e di un ordine per quello che lo precede immediata-mente divisione di ordini come sottrazione delle loro laquodenominazioniraquo divisione per 60 come divisione per 1 accompagnata dallo slittamento di un posto dellrsquoordine
c) Problemi che sorgono nella divisione di una parte sessagesimale per una di quelle che seguono divisione breve per riduzione allo stesso ordine (metodo laquoper analisiraquo) due algoritmi differenti il secondo con riduzione dei fattori comuni attribuito a Siriano
d) laquoAltroraquo metodo di divisione breve in realtagrave divisione tra somme di parti sessagesimali appartenenti ad ordini differenti per riduzione allo stesso ordine e applicazione dei metodi precedenti esempio della divisione di 0 2 0 4 per 0 0 2 0 240
e) Metodo di moltiplicazione tra numeri con parti non intere disposizione tabellare dei termini esempio della moltiplicazione di 5 4 6 per 8 0 3 0 525
f ) Primo metodo di divisione lunga descrizione della disposizione tabellare ed esempio di algoritmo applicato alla divisione di 50 48 26 30 per 8 16 28 5426
g) Metodo di divisione lunga tratto da Pappo in Alm III descrizione della disposizione tabellare ed esempio di algoritmo applicato alla divisione di 360 per 365 14 48 come verifica del valore 0 59 8 17 13 12 31 fornito nellrsquoAlmagesto per il moto medio giornaliero del sole27
h) Metodo di approssimazione di una radice quadrata secondo Erone Metr I 8 con giustificazione geometrica di Teone (attualmente non attestata in suoi scritti)
i) Verifica tramite moltiplicazione della correttezza del valore tolemaico28 di 67 4 55 come radice quadrata approssimata di 4500 Metodo di estrazio-ne di radici quadrate secondo Teone basato su applicazioni successive di Elementi II 4 la procedura termina dopo un numero finito di passi nel caso di quadrati perfetti Applicazione al calcolo della radice quadrata di 450029
unrsquoannotazione spazientita laquoIl texto di questo 2do quinterno egrave stato recopiato fidelmente dallrsquooriginale a chi volesse vedere la prova lo potragrave conferire con detto originale le pagine del qual texto corrispondono con quelle dellrsquooriginale tanti versi che pagine [hellip]raquo (Moge-net 1962 p 200)
25 Teone in Alm I 10 e I 14 in iA pp 45815-4604 e 57911-5811026 Teone in Alm I 10 in iA pp 4611-46217 applicato alla divisione di 1515 20
15 per 25 12 1027 Teone in Alm III 1 e IV 3 in iA pp 84112-84422 (stesso calcolo dei Prolego-
mena) e 102916-10327 idem in Alm IX pp 377-378 dellrsquoedizione di Basilea del 1538 approntata dai tipografi di Walderus Lrsquooriginale pappiano non ci egrave pervenuto
28 Alm I 10 in POO I 1 p 341129 Teone in Alm I 10 in iA pp 46916-4738
Fabio Acerbi134
Lrsquounico testo non elencato qui sopra o nelle note e che contenga tabelle operazionali egrave il commentario eutociano a Circ 3-4 Il testo ar-chimedeo che Eutocio e noi con lui leggeva egrave particolarmente conciso ed egli verifica esplicitamente il sussistere di certe relazioni numeriche Si tratta in ognuno dei nove casi presenti di mostrare che il lsquoteorema di Pitagorarsquo egrave verificato con ottima approssimazione dai valori numerici di opportune terne di rette Eutocio esegue le tre moltiplicazioni dei valori per se stessi e mostra che la somma o la differenza di due dei risultati si discosta di poco dal terzo30 I numeri in questione sono interi seguiti o no da una parte non intera espressa come somma di frazioni unita-rie31 I nove gruppi di tre moltiplicazioni una a fianco allrsquoaltra sono organizzati in forma tabellare ma senza lrsquoausilio di linee separatrici32 le operazioni sono eseguite disponendo lsquoin colonnarsquo i risultati delle mol-tiplicazioni parziali e sommandoli esattamente come facciamo oggi poicheacute sono in gioco numeri interi con parti frazionarie unitarie e la notazione non egrave posizionale non egrave necessario che gli incolonnamenti siano esatti (unitagrave di un risultato parziale sotto le decine del precedente ecc) Sono inclusi nella tabella istruzioni e commenti in linguaggio corrente33 le prime relative allrsquooperazione da affettuare sui risultati delle
30 Eutocio non calcola radici quadrate approssimate per quanto ciograve si renda piugrave volte necessario fornisce il risultato e verifica la sua correttezza moltiplicandolo per se stesso Egli dichiara che il lettore interessato a questo procedimento di calcolo puograve rivolgersi Ἥρωνι ἐν τοῖς μετρικοῖς [hellip] Πάππῳ καὶ Θέωνι καὶ ἑτέροις πλείοσιν ἐξηγουμένοις τὴν μεγάλην σύνταξιν τοῦ Κλαυδίου Πτολεμαίου laquoa Erone nei Metrica [hellip] a Pappo e Teone e a svariati altri inter-preti della Grande composizione di Claudio Tolomeoraquo (AOO III p 23213-17)
31 Troviamo ad esempio ͵αωλη θ´ ια´ cioegrave 1838 + 19 + 111 notare il singolo apice per le frazioni unitarie
32 Essi sono editi in AOO III pp 234-256 La tradizione medievale del commentario eutociano che coincide con un ramo di quella archimedea e deriva da un codice appar-tenuto a Giorgio Valla perduto in etagrave rinascimentale ma riprodotto a volte con fedeltagrave assoluta negli apografi (si veda ad esempio nella tav 1a la riproduzione dellrsquoerronea di-sposizione di cifre e parte algoritmica nel primo gruppo di moltiplicazioni offerta dal Laur Plut 284 f 160r) egrave costituita da Marc gr 305 ff 142v-146v Laur Plut 284 ff 159r-164r Par gr 2360 ff 109v-113v Par gr 2361 pp 410-421 Nel codice veneziano in cui la disposizione per righe e colonne egrave irrimediabilmente alterata dal copista le operazioni sono cancellate con tratti di penna Il primo manoscritto fu esemplato per Bessarione da Giorgio Trivizias tra il 1455 e il 1468 (Mioni 1976 pp 309-312) il secondo fu vergato da Giovanni Scutariota in scrittura di imitazione (Martinelli Tempesta 2010 p 173 n 7 Rollo 2012) ca 1491-1492 il terzo fu trascritto per il cardinale di Firenze Niccolograve Ridolfi dopo che la biblioteca di Valla era stata acquistata a seacuteguito della sua morte avve-nuta il 23 gennaio 1500 per 800 scudi drsquooro da Alberto Pio di Carpi (nota del copista al f 120v) il quarto fu terminato per mano di Christopher Auer su commissione di Georges drsquoArmagnac il primo gennaio 1544 (sottoscrizione a p 474 del codice si veda RGK II nr 525)
33 A questi va aggiunto posto davanti al risultato finale di ogni moltiplicazione il segno convenzionale per ὁμοῦ laquoinsiemeraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 135
prime due moltiplicazioni34 i secondi alla bontagrave dellrsquoapprossimazione ottenuta35 Ogni gruppo di operazioni che chiude unrsquounitagrave esegetica ed egrave seguito dalla citazione che apre la successiva egrave trascritto come se facesse parte del testo a tutta pagina e preceduto dallrsquoindicazione οἱ δὲ πολλαπλασιασμοὶ ὑπόκεινται laquole moltiplicazioni sono poste qui sottoraquo Questi due fatti suggeriscono che tutte le operazioni cui Eutocio non fa alcun riferimento nel corpo del suo commentario siano unrsquoaggiunta editoriale risalente a Isidoro di Mileto che si occupograve della revisione del testo36
Gli incolonnamenti esatti sono invece necessari quando siano moltiplicati numeri con parti non intere espresse nel sistema sessage-simale in quanto la somma finale dei prodotti parziali va effettuata ordine per ordine Tale somma eccederagrave di norma il valore di 60 per un ordine dato nella tabella occorre pertanto trovare posto anche per i riporti che vanno sommati ai prodotti parziali dellrsquoordine preceden-te e quindi incolonnati con essi I testi ci offrono alcuni esempi di tabelle operazionali moltiplicative di questo tipo Teone afferma espli-citamente che la prima moltiplicazione che va a descrivere ha una rap-presentazione tabellare la cui disposizione ritroviamo pesantemente ingarbugliata nel Laur Plut 2818 f 35r37 Alla seconda occorrenza di una moltiplicazione eseguita (tav 1b Laur Plut 2818 f 65r) gli incolonnamenti sono meglio rispettati anche se il risultato finale egrave fatto erroneamente slittare di un posto verso destra i riporti (con un errore) si trovano nella penultima riga38 Nei Prolegomena ad Alma-gestum alcune moltiplicazioni sono accompagnate da tabelle quella meglio attestata egrave associata alla moltiplicazione di 67 4 55 per se stesso (sezione i nel riassunto fornito supra) ed egrave descritta additando sempli-cemente ad un ente materiale oramai inaccessibile forse tracciato in loquendo lsquoalla lavagnarsquo
34 Come λοιπὸν τὸ ἀπὸ ΕΓ laquoresta quello su ΕΓraquo seguito dal risultato della sottrazione di due quadrati
35 Come λείπει ἄρα μο β εἰς τὸ ἀκριβές laquomancano quindi 2 u(nitagrave) al risultato esattoraquo36 Si legga la sottoscrizione spuria ad AOO III p 26010-1237 Si legga la frase ἐκτίθεμαι αὐτὴν καὶ πάλιν αὐτὴν ὑφ᾽ αὑτὴν ὡς ὑπογέγραπται laquolo [scil il
valore del lato da moltiplicare per se stesso] dispongo lsaquouna voltarsaquo e di nuovo al sotto di se stesso come trascritto qui sottoraquo in iA p 45817 Il Laur Plut 2818 (Teone e Pappo Commentaria in Almagestum) egrave uno dei piugrave antichi manoscritti in minuscola sicuramente assegnabile alla prima metagrave del IX secolo (Follieri 1977 p 144 n 23 Maas 1927 p 76 n 17 riteneva che fosse piugrave antico del Tetraevangelo Uspenskij) per una sua analisi si veda Rome 1938
38 In nessuno dei due casi i numerali di molteplicitagrave sono segnalati con apici sono tutti sormontati da una barra si veda la sezione 4 punto b
Fabio Acerbi136
προκείσθω δὶς τὸ μῆκος αὐτῆς ὀφεῖλον τὴν τάξιν τοῦ κατὰ τοὺς πολλαπλασιασμοὺς κανόνος ἀποδοῦναι καὶ ἐκκείσθω ἐπὶ σελιδίων διαγεγραμμένων οὕτω καὶ δὴ αὐτῆς ἐφ᾽ ἑαυτὴν πολ-λαπλασιασθείσης γεγονέτωσαν τὰ ἐν τοῖς οἰκείοις σελιδίοις εἴδη ταῦτα δὴ συναγόμενα καθ᾽ ἣν ὑπεδείξαμεν τάξιν ποιήσει τὰς ὑπογεγραμμένας μοίρας ἢ καὶ λεπτά τινα εἴσι ͵δυϙθ νθ´ ιδ´´ ι´´´ κε´´´´ ὡς λείπειν τοῦ ἐπιμερισθῆναι ŏ ŏ με´´ μθ´´´ λε´´´´
che sia prescritto che la sua lunghezza debba figurare due volte nella disposizione della tavola delle moltiplicazioni e che lsaquoquestrsquoultimarsaquo sia disposta su colonne delimitate da linee cosigrave mdash E pertanto una volta moltiplicato lsaquoil latorsaquo per se stesso che le specie trovino posto nelle colonne appropriate quelle che vengono cosigrave raccolte secondo la disposizione che abbiamo indicato produrranno dunque i gradi o anche i minuti qui sotto trascritti 4499 59 14 10 25 in modo che dalle divisioni successive resti39 0 0 45 49 35
La tabella associata (tav 2a Marc gr 313 f 19v) contiene una sola svista grossolana reca 51 invece di 55 in ognuno dei due fattori posti affiancati sopra di essa Al di sotto preceduto dal segno convenzionale per ὁμοῦ egrave collocato il risultato incongruamente sfalsato di un paio di colonne e con la lettera numerale ͵δ priva di barra sormontante in-naturalmente disconnessa da υϙθ I riporti sono indicati dai numerali ι ρκγ´ η´´ ν´´´ posti al fondo delle prime quattro colonne Il calcolo egrave corretto in ogni sua parte
Il clou in questo piccolo spaccato delle interazioni testo-paratesto matematico risiede nella descrizione contenuta nei Prolegomena della disposizione tabellare di due procedimenti di divisione il primo ano-nimo e quindi da supporre tradizionale il secondo piugrave efficiente ed attribuito al matematico del IV secolo Pappo
Il primo metodo di divisione egrave sostanzialmente analogo a quello che usiamo attualmente Dividendo e divisore questrsquoultimo preceduto da un segno su cui ritorneremo nella prossima sezione sono posti uno sotto lrsquoaltro intervallati da una riga inizialmente vuota Primo passo viene reperito il massimo multiplo del divisore che sia minore del di-videndo esso viene trascritto sotto il dividendo nella prima lsquocasellarsquo della riga vuota recante in testa un segno per laquosottrairaquo il fattore mol-tiplicativo (o quoziente parziale) viene trascritto in una lsquocasellarsquo pre-ceduta da un segno per laquorisultaraquo sotto il divisore Secondo passo il massimo multiplo viene sottratto dal dividendo il resto cosigrave ottenuto egrave trascritto preceduto da un segno per laquorestoraquo in una casella posta
39 Lrsquoautore concettualizza il procedimento di estrazione di radice quadrata come una forma di divisione
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 137
accanto al dividendo40 I due passi precedenti sono quindi ripetuti con la sola differenza che il resto appena ottenuto prende il posto del divi-dendo il quoziente parziale scala di un ordine sessagesimale ad ogni passo41 E cosigrave via aggiungendo ogni volta due caselle La debolezza di questo metodo come di quello che utilizziamo attualmente risiede nel fatto che il reperimento dei quozienti parziali (ovverosia dei massimi multipli) viene effettuato per tentativi non riuscire a farlo al primo colpo appesantisce notevolmente i calcoli successivi e costringe ad un lavoro di riordino e addizione dei quozienti parziali stessi La tabella risultante dove appunto osserviamo questo fenomeno in parallelo con identiche inaccuratezze nella descrizione ha la forma riprodotta unico tra i manoscritti della recensione antica nel Marc gr 313 f 13r (tav 2b invito il lettore a non rivolgersi alle tavole se non dopo aver termi-nato questa sezione sarebbe anzi auspicabile che tentasse di ricostruire questa tabella e le due successive a partire dalla mia descrizione)42
Il secondo metodo di divisione attribuito a Pappo egrave congegnato in modo da rendere non aleatoria la ricerca dei quozienti parziali Come altrove nei Prolegomena la descrizione della procedura di calcolo si riag-gancia esplicitamente a una frase di Tolomeo laquouna volta dimostrato che il periodo di una singola rivoluzione lsaquodel solersaquo egrave di 365 giorni 14 48 se di-vidiamo per essi i 360 gradi di un singolo cerchio avremo il moto medio giornaliero del sole circa 0 gradi 59 8 17 13 12 31raquo43 Questrsquoaffermazione si trova nel terzo libro dellrsquoAlmagesto si tratta della prima occasione in cui viene effettuata una divisione in cui il divisore egrave maggiore del dividendo e i commentatori del trattato tolemaico non si fecero sfuggire lrsquooccasione di mostrare come eseguirla Ora il terzo libro del commentario di Pappo non ci egrave pervenuto Ci resta dunque come testo parallelo a quello dei Prolegomena la descrizione rigidamente formulare in Teone sicuramente un calco di quella pappiana Teone qui come nelle altre applicazioni del metodo (Laur Plut 2818 ff 136v [tav 3] e 190r) descrive brevemente ed espone esplicitamente la stessa tavola dei sottomultipli del divisore che
40 Esempio nella divisione di 378 per 17 il massimo multiplo egrave 374 il quoziente parziale egrave 22 il resto 4 e in effetti 378 = 374 + 4 = 17times22 + 4 Si noti che il segno per laquorestoraquo non egrave apposto in testa di riga ma davanti a ogni resto parziale e in effetti il dividendo che si trova in prima posizione in questa riga non egrave un resto
41 Analogamente nellrsquoalgoritmo moderno poniamo la virgola o scaliamo la cifra di un posto
42 Nei Prolegomena la descrizione della tabella associata al metodo anonimo egrave pre-ceduta da una breve sinossi dellrsquooperazione in stile procedurale (cioegrave senza riferimenti alla tabella) e seguita dalla sua esecuzione accurata ma con pochi riferimenti alla tabella se non quello ai due segni da apporre ai resti parziali e ai massimi multipli
43 Alm III 1 in POO I 1 p 2091-4
Fabio Acerbi138
troviamo nei Prolegomena ma non offre alcuna descrizione della disposi-zione tabellare della divisione stessa neacute vi fa riferimento
A questa procedura sono in effetti associate una tavola e una tabel-la costruite come segue (tavv 4 e 5 Marc gr 313 ff 17r e 17v il co-pista era ndash giustamente ndash insoddisfatto della prima versione) La tavola le cui righe e colonne sono delimitate da linee contiene sottomultipli44 del divisore 365 14 48 9 righe che riportano i valori da 160 a 960 piugrave altre 6 con i valori per decine da 1060 a 6060 la prima colonna elenca le 15 parti sessagesimali omettendo come drsquoabitudine la laquodenomina-zioneraquo dellrsquoordine (i numerali elencati sono quindi α β γ δ ε ϛ ζ η θ ι κ λ μ ν ξ) la seconda i sottomultipli corrispondenti organizzati su quattro colonne per tener conto dei tre ordini sessagesimali (il primo sottomultiplo egrave quindi ϛ ε´ ιδ´´ μη´´´ cioegrave 160 di τξε ιδ´ μη´´) La tabella priva di linee delimitanti espone la vera divisione Nella prima colonna troviamo i resti parziali ognuno preceduto dallrsquoindicazione del proprio ordine sessagesimale e da un segno per laquorestoraquo Nella seconda preceduti da un segno per laquosottrairaquo i sottraendi ognuno coincide ovviamente con uno dei sottomultipli nella tavola La terza colonna contiene se-guiti dallrsquoindicazione del proprio ordine sessagesimale i quozienti par-ziali ottenuti trascrivendo dalla prima riga della tavola il numerale corrispondente al sottraendo affiancato ed assegnando come ordine sessagesimale il successivo a quello posto in testa di riga Il risultato preceduto da un segno per laquorisultaraquo e posto al di sotto della tabella si ottiene sommando i quozienti parziali il procedimento non permette in generale di determinare lrsquointero quoziente parziale relativo ad un ordine sessagesimale fissato se non dopo due passi Una linea spezzata unisce i resti parziali successivi e i relativi sottraendi per evidenziare la laquoprogressione della proceduraraquo la spezzata lsquosaltarsquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore (le cui righe sono per il resto vuote) e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue di conseguenza anche il quoziente parziale relativo a questo resto appartiene allrsquoordine sessagesimale successivo
A questo punto possiamo rivolgerci alle tavv 4-5 e verificare se le immagini che ci siamo formati sulla base della mia descrizione corri-spondono a quelle che troviamo nel Marc gr 313 Non si tratta di un giochetto sterile egrave al contrario il cuore di un intrico di problemi Un primo ordine di problemi deriva dal fatto che nei Prolegomena lrsquoalgo-
44 Sottomultipli e non multipli in quanto il divisore egrave maggiore del dividendo Drsquoaltronde nel sistema sessagesimale come in quello decimale un sottomultiplo si ottiene dal multiplo corrispondente semplicemente scalando tutte le cifre di un posto (ad esempio 1360 di 365 14 48 si ottiene in questa maniera da 13 volte 365 14 48)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 139
ritmo della divisione lsquoalla Papporsquo non egrave mai eseguito (cioegrave formulato verbalmente) in maniera indipendente dalla descrizione della tabella Comrsquoegrave dunque possibile descrivere una tabella operazionale che non ha uno statuto testuale indipendente sulla base di un algoritmo in corso di esecuzione E drsquoaltro canto come non rilevare unrsquoanomalia in un algoritmo eseguito nella sua forma primaria sotto forma di descrizione di una tabella Ci potremmo chiedere se viene descritto lrsquoalgoritmo o la tabella La tensione fra i due enti grafici egrave acuita dal fatto che nei nostri testi tutto ciograve (esposizione o descrizione di un algoritmo o della tabella associata) avviene sempre e solo sulla base di un esempio numerico para-digmatico Per questo motivo la tabella in quanto struttura (cioegrave privata dei dati numerici accidentali) non puograve fare a meno della descrizione45 Dal canto suo Teone come forse Pappo ancor prima descrive ed espone la tavola dei (sotto)multipli ma non la tabella di divisione lrsquoalgoritmo relativo a questrsquoultima egrave espresso come per controbilanciare in maniera eccezionalmente trasparente e formulare Se ciograve comporta un guada-gno a livello verbale-argomentativo sorge un problema operativo grave come e dove sistemare i resti e i quozienti parziali ndash cioegrave tutti i numeri in output dellrsquoalgoritmo differenti dai (sotto)multipli ndash che la tabella si incarica di disporre in modo lsquonaturalersquo Teone prescrive soltanto di confrontare i resti con la seconda colonna della tavola dei sottomultipli e di trascrivere via via il quoziente ottenuto dopo ogni passo Insomma come eseguire materialmente una divisione Non certo adattando ad un nuovo caso specifico la formulazione dellrsquoalgoritmo che Teone propone
Un secondo ordine di problemi e una trappola micidiale per il co-pista egrave interno alla dialettica lsquotabellarsquolsquosua descrizionersquo ed egrave in assenza di simbolismo quello dei riferimenti linguistici da adottarsi nella seconda agli enti grafici che figurano nella prima Occorre ricercare la massima generalitagrave fornita da una descrizione definita di un ente numerico (ad esempio impiegando il termine laquorestoraquo o la perifrasi laquomassimo sotto-multiplo minoranteraquo) o basta assumere direttamente il suo valore speci-fico come esempio paradigmatico E in che modo risolvere il conflitto tra uso e menzione se come nel nostro caso la tabella contiene segni convenzionali ed occorre fornirne una descrizione Si rende ad esempio necessario introdurre un lsquooperatore di citazionersquo noi useremmo le virgo-lette la lingua greca premette lrsquoarticolo neutro Drsquoaccordo ma nel caso
45 Questa caratteristica non egrave connaturata alla matematica degli algoritmi la risorsa dello lsquostile proceduralersquo serve esattamente ad aggirare questo problema al di lagrave di un certo livello di dettaglio perograve essa condurrebbe ad un appesantimento insostenibile della for-mulazione dovuto alla pluralitagrave dei riferimenti agli oggetti matematici in gioco sulla que-stione dei diversi stili della matematica greca si veda Acerbi 2012
Fabio Acerbi140
greco qual egrave il suo range E come distinguerlo nei casi ambigui da un semplice articolo che precede un sostantivo quando questrsquoultimo lo ri-chieda Nel corso del processo di copia del testo della descrizione infine possono generarsi tensioni tra enti grafici interpretabili vuoi come segno convenzionale vuoi come abbreviazione Ambiguitagrave relative a questi punti opacizzano la descrizione Un problema analogo si porrebbe a priori nella dialettica tra uso delle lettere denotative per designare enti geometrici e loro menzione nella costruzione di un diagramma ma esso egrave risolto con lrsquoazzeramento della seconda funzione le lettere denota-tive sono sempre usate allrsquointerno del testo (sono cioegrave il referente degli oggetti geometrici di cui tratta il discorso matematico) mai menzionate (come accadrebbe se fossero il referente di oggetti grafici posti nel dia-gramma) Insomma il codice adottato per la costituzione dei diagrammi geometrici egrave condiviso (cioegrave canonizzato) semplice e perspicuo mentre quello per le tabelle operazionali non lo egrave da qui le sviste dei copisti e le trascuratezze di correttori ed editori
Infine chi vuole apprendere da questi testi come eseguire una divi-sione a cosa deve prestar fede se ad esempio a causa di errori di copia la descrizione finisce per non coincidere con la tabella operazionale visto che sono entrambe due maniere valide di eseguire lo stesso algoritmo Dopo tutto lo scopo di tutta questa macchina grafico-argomentativa egrave di insegnare a eseguire divisioni in formato tabellare Questo problema si fa particolarmente acuto se la tabella non egrave trasparente nel metodo di Pappo lo egrave quasi completamente in quello anonimo no E gli errori che riscontreremo nella (doppia) tabella ai ff 17r-v del Marc gr 313 a chi sono attribuibili Allrsquoautore al trascrittore o al copista medievale
Questo groviglio di problemi riceve alcune risposte sorprendenti dalla tradizione manoscritta come andiamo finalmente a vedere
4 Analisi delle testimonianze
I codici che ho adibito per lrsquoedizione sono i seguenti M = Marc gr 31346 C = Marc gr 314 (Tolomeo Tetrabiblos et opera minora cum commentariis Vezio Valente Anthologiae)47 Z = Vat gr 2326 (fattizio
46 Riferibile al sec IX ex-X in accolgo la datazione suggeritami per litteras il 522005 da Nigel G Wilson si veda anche Agati 1992 pp 141-142 La presenza non sistematica degli accenti che fa anticipare a Wilson la datazione di laquosaec X medraquo fornita in Mioni 1985 p 24 indusse Boris Fonkič (2005 non vidi) ad assegnare il codice allrsquoinizio del IX secolo
47 Il manoscritto riferibile alla seconda o terza decade della prima metagrave del XIV secolo fu vergato da Michele Clostomalle olim lsquoMetochitesschreiberrsquo Bianconi 2005a pp 428-430 Il titolo dei Prolegomena in questa trascrizione identico in grafia ma non in formulazione a
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 141
e mutilo Tolomeo Almagestum) S = Vat gr 184 (varia astronomica scholia miscellanea ad Almagestum Tolomeo Almagestum) P = Par gr 2390 (varia astronomica) gli ultimi tre riferibili allo scorcio del XIII secolo48 e apografi sicuri del Vat gr 159449 attualmente mutilo di due fascicoli che ci privano dei due terzi finali dei Prolegomena M e il Vat gr 1594 ammettono un modello comune il resto della tradizione (25 trascrizioni in tutto) dipende dagli apografi appena citati del Vat gr 1594 Le varianti della recensione bizantina che leggiamo tra lrsquoaltro nei Vat gr 198 Marc gr 310 (Tolomeo Almagestum cum commentariis Pappi Theonis et Cabasilae) e con ulteriori modifiche Laur Plut 89 sup 48 (varia astronomica Tolomeo Almagestum Barlaam Logistica) sono identificate dal siglum K e si trovano punteggiatura originale in-clusa nel secondo apparato50 Lrsquoanalisi delle testimonianze51 costituite ovviamente anche dalle tabelle associate saragrave condotta nella forma di una sequenza di osservazioni indicizzate da numerali o lettere oltre che di alcune note a piersquo di pagina
Iniziamo dalla descrizione del metodo di divisione anonimo
quello che leggiamo nel Vat gr 1594 (questrsquoultimo coincide con quello adottato nella recen-sione bizantina) fu apposto da Niceforo Gregora e successivamente corretto da Bessarione
48 Sto studiando il primo e il terzo codice in collaborazione rispettivamente con Daniele Bianconi e Inmaculada Peacuterez Martiacuten
49 Su questo codice risalente alla seconda metagrave del IX secolo e sulla sua collocazione nella lsquocollezione filosoficarsquo per prima proposta in Follieri 1977 pp 145-146 si vedano almeno Perria 1991 pp 82-88 Ronconi 2013 Che il titolo dei Prolegomena nel Vat gr 1594 sia stato apposto da Niceforo Gregora egrave stato riconosciuto per la prima volta in Mazzucchi 1994 p 211 n 196 si veda Bianconi 2005a p 418 per altri interventi di Gregora nello stesso manoscritto
50 Il Vat gr 198 egrave stato vergato dal copista Malachia nel corso del terzo quarto del XIV secolo Mondrain 2004 pp 278-290 e 292 Allo stesso copista (denominato non a caso prima dellrsquoidentificazione anonymus Aristotelicus) dobbiamo un buon numero di trascrizioni aristoteliche con i relativi commentari in margine Gli dobbiamo anche il Par gr 2342 secondo tomo di un quadrivium quasi completo di cui il Vat gr 198 egrave il primo nellrsquoordine aritmetica armonica astronomia (Almagesto e commentari relativi) nel codice vaticano geometria ed ancora astronomia (corpus astronomico minore) in quello parigino le opere trascritte sono sempre accompagnate in margine dai relativi commentari Il copista del Marc gr 310 egrave Isacco Argiro (ca 1300-1375) Mondrain 2007 p 166 Allo stesso Argiro dobbiamo il codice laurenziano (Daniele Bianconi per litteras) Poicheacute la recensione modificata che leggiamo nel Laur Plut 89 sup 48 egrave senza alcun dubbio basata su quella nel Marc gr 310 e non viceversa ci troviamo di fronte ad un copista che trascrive due volte lo stesso testo in due versioni leggermente differenti la conclusione naturale egrave che la seconda recensione egrave dovuta ad Argiro stesso la questione andragrave studiata in dettaglio
51 Nei manoscritti citati i Prolegomena si trovano ai fogli seguenti Vat gr 1594 ff 1r-8v (mutilo mancano due fascicoli su tre) Marc gr 313 ff 1r-28r (incompleto man-cano due fogli allrsquoinizio e il f 6 attualmente rimpiazzato da uno bianco) Marc gr 314 ff 235r-255r Vat gr 2326 ff 19r-40v e 43r-v (incompleto e con i fascicoli in disordine) Vat gr 184 ff 10r-23v Par gr 2390 ff 1r-13v Vat gr 198 ff 127r-136v Marc gr 310 ff 1r-13r Laur Plut 89 sup 48 ff 7r-19r
Fabio Acerbi142
ἐκθέμενοι οὖν διάγραμμα τῶν ἀριθμῶν ὡς ὑπόκειται προτάσσομεν τὸν μεριζόμενον καὶ μικρὸν ὑπ᾽ αὐτὸν τὸν μερίζοντα ὡς ἔχει τὸ διάγραμμα ἐν στίχοις διοριζομένοις ὑπὸ γραμμῶν [hellip] καὶ τὰ μὲν γινόμενα ἐγγὺς ἐλάττονα ἐν τῇ μεταξὺ θέσει τοῦ μεριζομένου καὶ τοῦ μερίζοντος ἐν στίχοις παρασημειοῦσθαι πρὸς τὸ ἀσύγχυτον εἶναι τὴν τάξιν τὰ δὲ μεθ᾿ ὧν ὁ μερίζων ἐποίει τοὺς ἀεὶ ἐλάσσονας ὑπὸ τὸν μερίζοντα σημειοῦσθαι προγράφοντας ἐπὶ τοῦ στίχου αὐτῶν τὸ γίνεται οὕτως γι ἐν δὲ τῷ στίχῳ τῶν μεριζόντων τὸ παρὰ ἔχον οὕτως oslash ἀντὶ τοῦ παρ᾿ ἃ δεῖ τὸν μερισμὸν γίνεσθαι ἐν δὲ τῷ στίχῳ τῶν ἐλασσόνων τὸ αφ διὰ τὸ τούτους ἀεὶ ἀφαιρεῖσθαι ἀπὸ τῶν ἐπάνω τῶν μεριζομένων ἐν δὲ τοῖς τοῦ μεριζομένου λοιπάσμασι τοῖς καὶ ἐπιοφείλουσι τὸ λ κατὰ τὸ ἴδιον τῶν διαστάσεων ἑκάστης ndash λέγω δὴ λοιπάδος ndash ἀντὶ τοῦ λοιποὶ οἱ μέλλοντες ἐπιμερίζεσθαι
2 post τὸν suprascr τὸν ἐλάττονα m 2 S 5 πρὸς] MP et ex corr Z κατὰ S om C | ἀσύγχυτον] MSPC -χητον Z 6 ἀεὶ] MZPC ὡσεὶ S 7 γίνεται οὕτως γι ] γι τ οὕτως γι τ M γί οὕτως γί Z γι οὕτως γί SC τὸ γινόμενον οὕτως γίνεται P 8 τὸ παρὰ ἔχον οὕτως] scripsi τὸ παρέχον οὕτως M et π(αρ-) comp Z οὕτως τὸ περιέχον S προγράφοντας οὕτως ex corr m 2 P τὸ περιέχον οὕτως C | oslash] MZSC (sed ο fecit | Z) ἐλάττων comp ex corr m 2 P | παρ᾿ ἃ] scripsi παρα M π(αρα) comp ZSC ex παρα fe-cit παρὰ et τοῦτον suprascr m 2 P 9 γίνεσθαι] comp C | αφ ] αφ ε M ἀφ ZSC ἀφαί P | ἀεὶ] om M 11 ἐπιοφείλουσι] MZSC ex ἐπιο- fecit ἐπο- m 2 P | λ] MZPC λ´ S 12 λοιποὶ] PC λοιποῦ MZS
3 στίχοις] στίχῳ K 5 πρὸς] διὰ K 7 ἐπὶ mdash γι ] τὸ γίνεται διὰ τοιούτου σ(ημείου) γί K 8 τὸ παρὰ ἔχον mdash παρ᾿ ἃ] τὸ παρᾱ διὰ σ(ημείου) τοιούτου καὶ τοῦτο oslash δηλοῦντος τοῦ παρᾱ ὅτι παρὰ τὸν τοιοῦτον (ἀριθμὸν) K 9 αφ διὰ τὸ τούτους] ἀφ δηλοῖ δὲ τοῦτο ἀφαίρεσ(ιν) ὅτι τούτους ἀεὶ δεῖ K 11 ἐπιοφείλουσι] ἐπιμερίζεσθαι ὀφείλουσι K | λ] λ οι` K 12 ἀντὶ τοῦ] δηλοῦντος τοῦ σ(ημείου) τὸ K
lsquoRendendo esplicito un diagramma numerico come lo troviamo qui sotto disponiamo in primo luogo il dividendo e un poco al di sotto di esso il divisore come li ha il diagramma in righe delimitate da linee [hellip] e lsaquooccorreragraversaquo nella posizione tra il dividendo e il divisore annotare lrsquouno accanto allrsquoaltro i piugrave vicini lsaquodei numerirsaquo minori che risultano affincheacute la disposizione non sia confusa quelli con cui il divisore faceva ogni volta i lsaquonumerirsaquo minori annotarli sotto il divisore scrivendo in prima posizione sulla loro riga laquorisultaraquo cosigrave Ris nella riga dei diviso-ri52 invece laquoperraquo fatto cosigrave53 P in luogo di laquoquelli per cui deve farsi la divisioneraquo nella riga dei lsaquonumerirsaquo minori laquosottrraquo in quanto questi sono sempre sottratti dai dividendi che si trovano sopra nei residuli del dividendo (occorre ben farlo anche per loro) laquoReraquo in accordo con ciograve
52 I laquodivisoriraquo sono al plurale ma siamo semplicemente di fronte a un tratto idioma-tico della lingua greca nel caso di espressioni generalizzanti crsquoegrave soltanto un divisore che occupa lrsquounica colonna di cui si compone la sua riga
53 Si intenda ἔχον οὕτως = ita se habens
1
5
10
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 143
che egrave proprio agli scarti di ciascuno ndash intendo qui lsaquociascunrsaquo residuo54 ndash in luogo di laquoresti che vanno a essere divisi ulteriormenteraquorsquo
a) Operatori di citazione e segni convenzionali I segni introdotti sono quattro la mia discussione egrave condotta dando per scontato che essi siano identici a quelli impiegati dallrsquoautore dei Prolegomena anche se si tratta di unrsquoipotesi non corroborabile neacute falsificabile
i Segno per il risultato Lrsquoabbreviazione convenzionale per γίνεται egrave identica al segno introdotto dallrsquoautore e i copisti si dividono tra i due errori possibili scrivere due abbreviazioni o risolverle entrambe Un fenomeno del tutto analogo si riscontra nel Matr 4678 il manoscritto alla base di tutta la tradizione degli Arithmetica di Diofanto al momen-to della definizione dellrsquoἀριθμός (lrsquolsquoincognitarsquo nel nostro linguaggio) ὁ δὲ μηδὲν τούτων τῶν ἰδιωμάτων κτησάμενος ἔχων δὲ ἐν ἑαυτῷ πλῆθος μονάδων ἄλογος ςο` καλεῖται ς` ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον τὸ ς` laquoil lsaquonumerorsaquo che non possiede nessuna di queste proprietagrave ma che ha in seacute una molteplicitagrave indefinita di unitagrave egrave chiamato lsquonumerorsquo e il suo segno egrave ς`raquo Qui solo il terzo dei tre ς ha una barra a sormontare per segnalarne il carattere puramente denotativo (cioegrave di segno convenzionale e non di abbreviazione si veda il punto successivo)55 il primo egrave una delle abbreviazioni piugrave diffuse per ἀριθμός (e infatti egrave dotato del compendio per la desinenza e dellrsquoaccento grave) il secondo egrave una delle piugrave comu-ni per καὶ () Giovanni Cortasmeno autore di capillari annotazioni infra lineam agli Arithmetica nel codice madrileno scioglie il primo ςο`
54 Doppia variatio che impiega al posto di λοιπόν laquorestoraquo i due termini decisamente non canonici τὸ λοίπασμα e ἡ λοιπάς (piugrave oltre leggiamo anche il participio λοιπασθέντα) Una ricerca sul TLG in rete non ha fornito occorrenze del primo si tratta dunque di uno hapax Quanto al secondo che ricorre anche nella sezione sulla divisione lsquoalla Papporsquo lo si rintraccia giagrave nei papiri documentari il termine diventeragrave perograve canonico nelle esposizioni bizantine drsquointroduzione allrsquoAlmagesto ricalcate sul modello dei Prolegomena (si veda la nota 87 infra) Questi due termini designano i resti parziali prodotti nel corso di una divisione lunga li ho tradotti rispettivamente con il neologismo laquoresiduloraquo e con il sostantivo pari-menti non canonico laquoresiduoraquo
55 Il copista interpreta erroneamente il terzo segno come unrsquoabbreviazione e qui ag-giunge un apice inverso (cioegrave un accento grave) altrove lo scioglie direttamente in forme opportune di ἀριθμός Matr 4678 f 58v La frase come la leggiamo nel manoscritto egrave cor-rotta sulla base di una parafrasi in Psello (edita in DOO II p 3710-12) Tannery emendograve ἄλογος in ἀόριστον DOO I p 64-5 et app Il Matritensis vergato da due copisti differenti (cambio di mano a tre righe dalla fine del f 62r) contiene lrsquoIntroductio arithmetica di Nicomaco e le opere diofantee oltre ad alcuni brevi opuscoli musicali la sua data egrave stata recentemente corretta dal XIII al secolo XI pm in Peacuterez Martiacuten 2006 (una riproduzione digitale del manoscritto si trova allrsquoindirizzo httpbdhbneesbnesearchbibliotecaDio-fanto20de20AlejandrC3ADa)
Fabio Acerbi144
in ἀριθμός ed aggiunge un altro segno56 sopra il terzo anteponendovi lrsquoindicazione καὶ ἔστιν αὐτοῦ σ(ημεῖον) τόδε Va da seacute che non abbiamo nessuna garanzia che il segno originariamente introdotto da Diofanto coincidesse realmente con unrsquoabbreviazione convenzionale per ἀριθμός Lrsquoevidenza del PMich III 144 (sec II in) suggerisce drsquoaltronde che il Matritensis e con esso tutta la tradizione medievale di Diofanto ripro-duca fedelmente pur accentuandone la sinuositagrave il segno originario
ii Segno per il divisore Un cerchiolino sbarrato da non confondere con il segno per ὁμοῦ che nei manoscritti matematici ha di norma due barre trasversali (cf tav 2a) Non sono riuscito a rintracciarne ulteriori occorrenze in altre opere la forma che esso assume nel Vat gr 2326 e la correzione apportata nel Par gr 2390 lasciano aperta la possibilitagrave per quanto a mio avviso remota che la forma originaria non fosse lon-tana da unrsquoabbreviazione di παρά registrata nei repertori57 Il correttore del Par gr 2390 trasforma in effetti il segno oslash nellrsquoaffine abbreviazione canonica per (forme di) ἐλάσσων laquominoreraquo58 e si incarica diligente-mente di farlo notare ricapitolando i segni nella porzione superiore del margine esterno del f 7v Nello stesso margine egli traccia anche uno lsquoscolio tabellarersquo ed egrave lrsquounico a porre il (proprio) segno dove indicato dalla descrizione (tav 6 Par gr 2390 f 7v) Oltre a ciograve adattando la tabella al margine ristretto lo scoliaste trascrive come colonne affian-cate le due righe dei resti parziali e dei massimi multipli e aggiunge le indicazioni ὁ μεριζόμενος laquodividendoraquo e ὁ μερίζων laquodivisoreraquo ma vi introduce alcune incongruenze di formato il risultato scritto in verti-cale e la linea verticale di sinistra che separa il divisore dal segno che lo dovrebbe precedere direttamente
iii Segno per i massimi multipli Corrisponde alla semplice abbre-viazione per sospensione della forma verbale ἄφελε laquosottrairaquo in questo
56 Si tratta del segno di ampio uso praticamente identico allrsquoabbreviazione canonica per οὖν
57 Si tratta di un pi a forma di gancio sbarrato da uno slash di troncamento Ce-reteli 1904 tav IX item 7 sub ΠΑΡΑ che rinvia al PVindRain 423 cf anche la forma π` nel POxy LXI 4142 edito in Jones 1999 II pp 26-34 In generale nei papiri e nei manoscritti matematici in maiuscola le preposizioni sono abbreviate facendo seguire un lsquoapostroforsquo alla loro prima lettera Α᾽ Υ᾽ ecc Per la seconda fattispecie di supporto libra-rio si veda in particolare il cosiddetto fragmentum mathematicum Bobiense scriptio inferior databile al V-VI secolo del palinsesto Milano Biblioteca Ambrosiana L 99 sup (Isidoro di Siviglia Etymologiae datazione Cavallo 1977 p 100) pp 113-114 che sono stampate in riproduzione apografa conforme in Belger 1881 (la p 114 egrave riprodotta anche nella tav 10 di Acerbi 2010)
58 Se questa era lrsquointenzione si tratta ovviamente di una forzatura il divisore puograve ben essere maggiore del dividendo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 145
caso lo slash di troncamento taglia orizzontalmente il tratto verticale del phi I copisti offrono molteplici varianti apponendo chi uno spirito dolce chi un ε chi un αί accentato a sormontare Tutti questi segni svolgono la funzione di abbreviazioni vere e proprie (e cosigrave doveva essere anche per lrsquoautore si veda il punto 1 di p 153 infra) la forma originale si ottiene a mio avviso incrociando i dati del Marc gr 313 e dei tre apografi del Vat gr 1594 αφ anche se lrsquoassenza dello spirito potrebbe essere semplicemente dovuta alla pratica del copista del codice veneziano di economizzare nei diacritici
iv Segno per i resti Un lambda completato da una barra a sormon-tare o da un apice che rinvia alle abbreviazioni per sospensione di una forma opportuna di λοιπός laquorestoraquo In realtagrave la forma che troviamo nella tabella egrave differente (tav 2b) e coincide con quella offerta quasi unanimemente dai manoscritti nella descrizione e in almeno un caso nella tabella del metodo di divisione attribuito a Pappo (tav 4) un lambda che accoglie al di sotto una legatura omicron-iota () sbarrata da uno slash di troncamento Qualcosa di simile si trova nel PVindob G 19996 (sec I) una specie di lambda maiuscolo molto aperto e dal vertice arrotondato che include un circoletto interpretato dagli editori come segno per περίεστιν o per λοιπόν59 Lo stesso segno si rintraccia ad esempio in un medesimo scolio tabellare di prima mano ad Alma-gestum nel Vat gr 1594 f 93v e nel Marc gr 313 f 135r ma stavolta la forma del lambda egrave molto ben definita
Fin qui i segni Ma il gioco egrave piugrave complesso La descrizione si muo-ve pericolosamente sulla linea di confine non sempre ben definita tra segno convenzionale e abbreviazione il primo ndash e il repertorio grafico matematico-astronomico ne egrave particolarmente fornito60 ndash puograve anche
59 Ho consultato lrsquoedizione Gerstinger ndash Vogel 1932 pp 46 e 48 la porzione rilevante del papiro egrave riprodotta nella tav 11 di Fowler 1999 Si veda ancora ivi pp 253-257 per la trascrizione di questo segmento di testo (con correzioni rispetto alla princeps) e per una messa a punto recente inclusa la proposta di datazione che ho riportato qui sopra Il verso del papiro che contiene una tavola aritmetica del tutto scorrelata dalla tematica del recto egrave edito come PRain Unterricht 151
60 La pratica di ridurre lo spazio occupato da un testo tecnico per mezzo di abbreviazioni e segni convenzionali era molto diffusa nei manoscritti in maiuscola contrariamente a quanto avviene per altri generi letterari vedremo tra breve cosa accade negli Arithmetica di Diofanto ma si leggano in proposito anche le considerazioni di Hei-berg nei prolegomena alla propria edizione dellrsquoAlmagesto in particolare riguardo al ricorso massiccio ad espedienti brachigrafici nel modello del Vat gr 180 POO II pp lxxxiv-xciii civ-cv cxxvii cxxxviii-cxxxix Agli elenchi dettagliati forniti da Heiberg possiamo aggiungere il piccolo prontuario stampato in Hultsch 1876-1878 III 2 pp 126-132 e basato sul testo e sugli scolii alla Collectio di Pappo nel Vat gr 218 (sec X in) Si vedano infine le osservazioni del copista del Par gr 2360 f 120v trascritte da Heiberg in AOO III pp x-xi sulle laquonotazioni tipiche a scopo di tagliar corto nello scrivereraquo impiegate nel pro-
Fabio Acerbi146
derivare dalla seconda (un caso egrave appunto il segno per ἐλάσσων che probabilmente trae origine da una legatura epsilon-lambda) ma poi il rapporto referente-relato si fissa convenzionalmente Quelli definiti nel testo che abbiamo letto sono appunto segni convenzionali non ci sarebbe bisogno di spiegarne forma e funzione se fossero intesi come abbreviazioni assumono nella tabella una funzione denotativa non esplicativa o discorsiva (come accade invece nella tav 1a) Ma come vengono descritti questi segni
I referenti delle descrizioni sono i segni sono introdotti da οὕτως (item i-ii) o in alternativa da un τό con il ruolo di lsquooperatore di citazionersquo (item iii-iv) che corrisponde esattamente alle nostre virgolette In entram-bi i casi gli enti sono menzionati e svolgono una funzione metalinguistica sono collocati materialmente nel testo ma egrave come se si trovassero fuori e la loro descrizione li additasse ndash in effetti i segni convenzionali scritti nel testo sono a loro volta i relata di quelli che si trovano nella tabella
I relata dei segni scritti nel testo sono di due tipi singoli vocaboli (item i-ii) o descrizioni della funzione dei segni per mezzo di clausole sintaticamente complesse (item ii e iv) I singoli vocaboli sono γίνεται e παρά e sono entrambi preceduti dal τό lsquocitazionalersquo in quanto relata di segni convenzionali le forme abbreviate con cui sono tracciati nei manoscritti vanno forzatamente sciolte Bisogna ammettere che la per-spicacia e le risorse grafiche dei copisti ndash di cui tutto si puograve dire fuor che commettano qui degli errori ndash sono messe a dura prova con lrsquointrodurre segni identici ad abbreviazioni o con lrsquoattivare un gioco metalinguistico particolarmente serrato in un contesto meno lsquonaturalersquo di come potreb-be esserlo ad esempio quello di un trattato grammaticale Lrsquoitem iii che presenta direttamente un segno identico ad unrsquoabbreviazione non egrave sorretto da una descrizione ma da una giustificazione in διὰ τό Lrsquoartico-lo τό vi assume una funzione metalinguistica anche se non lsquocitazionalersquo poicheacute al tempo stesso genera un infinito sostantivato e lo singolarizza per questo ho scritto laquosono sottrattiraquo in corsivo nella mia traduzione
prio modello archimedeo (nota 32 supra) egli ne compila anche una breve lista Un elenco antico di laquosegni della geometriaraquo sicuramente redatto per assistere il copista si trova anche al f 3v del ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 vergato da Efrem negli anni 950-960 (tav 8 in Acerbi 2010) Possiamo farci unrsquoidea quantitativa del guadagno di spazio in rapporto ad un testo privo di abbreviazioni e con le parole separate da spazi sulla base del fragmentum mathematicum Bobiense il testo vi egrave disposto a tutta pagina su 36 righe di circa 30 segni ciascuna nelle due pagine in questione figurano 2038 segni con 15 mezze righe occupate dalle due figure Ora nel testo dellrsquoedizione stabilita in Heiberg 1927 pp 87-90 le stesse pagine contano 4455 segni spazi compresi Ne risulta che la dimensione in caratteri di un testo matematico puograve essere ridotta di piugrave della metagrave con lrsquoimpiego di compendi e segni convenzionali
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 147
Negli item ii e iv il segno si collega ad una descrizione nel secondo caso in via esclusiva le descrizioni pertanto rinforzano o sostituiscono lrsquoidentificazione con lrsquoente linguistico denotato Le clausole descrittive sono precedute da ἀντί e dallrsquoarticolo τό con funzione di lsquooperatore di citazionersquo esse sono παρ᾿ ἃ δεῖ τὸν μερισμὸν γίνεσθαι (item ii) e λοιποὶ οἱ μέλλοντες ἐπιμερίζεσθαι (item iv) Nella descrizione della divisione lsquoalla Papporsquo che leggeremo tra breve i segni negli item iii e iv rice-vono lo stesso trattamento degli altri due il loro relatum egrave un singolo vocabolo e non una clausola descrittiva rispettivamente nelle espres-sioni τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε (sul participio ritorneremo nel punto 1 infra) e τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά (la forma del segno notato con λ οι egrave descritta supra nellrsquoitem iv) La descrizione del segno oslash per il divisore merita una discussione piugrave dettagliata In origine si trovava probabilmente scritto Π(ΑΡΑ)ΕΧΟΝ successivamente letto come π(αρ[α])έχον ndash dato che lrsquoabbreviazione per il preverbo egrave identica a quella per la preposizione (che sia Π᾽ o un pi seguito dal segno per ἄρα a sormontare) ndash invece di π(αρὰ) ἔχον I copisti e i correttori si dettero a tutte le possibili contorsioni per restituire un testo dotato di senso leggere appunto una forma verbale con preverbo modificare il preverbo (ma forse il segno per ἄρα era insidiosamente simile ad uno epsilon) correggere il testo rileggiamo lrsquoapparato sub τὸ παρὰ ἔχον οὕτως τὸ παρέχον οὕτως M et π(αρ-) comp Z οὕτως τὸ περιέχον S τὸ περιέχον οὕτως C προγράφοντας οὕτως ex corr m 2 P Nella clausola descrittiva seguente la presenza liminare di παρὰ (che ho corretto in παρ᾿ ἃ nella speranza di restituire una frase che abbia un senso senza intervenire sul testo) innesca un bel corto circuito il Π(ΑΡΑ) che sicuramente figu-rava nellrsquoarchetipo egrave un sintagma complesso una preposizione unrsquoab-breviazione o un segno per unrsquoabbreviazione Se lrsquoeditore si trova in conflitto con la propria inclinazione alla critica conservativa i copisti si rifiutarono di mettere mano ad un testo che doveva stridere anche per loro essendo il compito demandato al ritocco del revisore del Par gr 2390 o alla riscrittura radicale del recensore bizantino Il problema egrave che ci troviamo di fronte ad unrsquoespressione che descrive la funzione dellrsquooggetto denotato non lrsquooggetto stesso ma che lo contiene al suo interno per soprammercato qui il Π(ΑΡΑ) egrave usato per giustificare una menzione a sua volta relatum di un segno
Evidentemente questa maniera di procedere che giagrave aveva attirato interventi da parte di copisti e correttori della recensione di base parve insostenibilmente opaca allrsquoautore della recensione bizantina61 Egli
61 Uno dei manoscritti di questa recensione propone anche una tabella di divisione
Fabio Acerbi148
modifica tutte le descrizioni diluendo lrsquoidiomatismo dellrsquoarticolo lsquocita-zionalersquo con lrsquointroduzione sistematica del verbo δηλόω e di frasi atte a chiarire quale sia il segno denotante e quale il vocabolo (o il segno) denotato Egli introduce allo scopo di rendere esplicita la funzione de-notativa dei segni introdotti il termine σημείου curiosamente in tutte le sue tre occorrenze esso compare a sua volta nella forma dellrsquoabbrevia-zione per sospensione σΗ´ Egli traccia il segno per i massimi multipli ἀφ e quello per i resti λ οι` in modo che non vi siano ambiguitagrave quanto al loro carattere di abbreviazione Si faccia infine attenzione al residuo di barra sul παρᾱ con funzione denotativa (2 occorrenze) contenuto nella descrizione del segno per il divisore sostituita dallrsquoaccento grave nel παρὰ con funzione discorsiva (la differenza egrave nettissima nei manoscritti da me consultati) Questa osservazione ci permette di passare direttamente allrsquoitem seguente
b) Le barre sui numerali e sulle lettere denotative Egrave opportuno discutere questo punto adesso esattamente percheacute di barre siffatte che pure troviamo in tutti i manoscritti i nostri testi non fanno mai menzione si tratta infatti di una pratica condivisa sin dallrsquoantichitagrave La barra identifica una stringa di lettere dellrsquoalfabeto che non svolge una funzione grammaticale o sintattica propria allrsquointerno del discorso Ciograve avviene in particolare e si tratta della fattispecie piugrave frequente se la stringa di lettere non dagrave origine a un vocabolo della lingua greca lette-re denotative e numerali certo ma anche termini provenienti da altri idiomi e contrazioni di parole greche come i nomina sacra62 tali termi-ni possono essere o no preceduti da un articolo lsquocitazionalersquo a seconda dellrsquouso che ne viene fatto allrsquointerno del discorso Ma non si tratta dellrsquounica fattispecie i papiri grammaticali ed i manoscritti piugrave antichi dei trattati dello stesso argomento segnalano gli esempi delle parti del discorso (cioegrave di lsquoverersquo parole greche) per mezzo di barre sormontanti63 La differenza insomma egrave tra menzione e uso (come parte del discorso in atto) di una stringa di caratteri tra il porre le lsquovirgolettersquo e il non porle tra funzione denotativa e non Apparentemente la convenzione si limi-
corredata dei segni opportuni e contrariamente alle indicazioni della descrizione svilup-pata lsquoin verticalersquo ma per motivi misteriosi non completa (tav 7a Laur Plut 89 sup 48 f 13r)
62 Tutto ciograve egrave spiegato con estrema chiarezza giagrave in Traube 1907 pp 45-4763 Si veda il Par gr 2548 codex vetustissimus e testimone unico delle lsquoopere minorirsquo
di Apollonio Discolo il f 106v con le barre ben visibili egrave riprodotto come tav 19 in De Gregorio 2000 (ivi pp 137-138 per la datazione) Per la testimonianza dei papiri grammaticali si veda Wouters 1979 passim essi contengono di norma elenchi di parti del discorso nessuna delle quali egrave preceduta dallrsquoarticolo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 149
tava in questo secondo caso a segnalare con la barra singoli vocaboli le menzioni di frasi o di sintagmi complessi sono di norma identificate dallrsquoarticolo lsquocitazionalersquo Drsquoaltra parte le abbreviazioni convenzionali non rientrano nella casistica percheacute la loro resa grafica che contiene elementi non alfabetici come compendi per desinenze lettere supra li-neam marche di contrazione o sospensione quali slashes o barre sotto-poste o sormontanti eventualmente solo un sottinsieme della stringa di segni alfabetici le esclude automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
Venendo al discorso matematico una barra sormonta senza ecce-zione le lettere denotative64 che sia in papiri o in manoscritti in maiu-scola65 o minuscola ma solo allrsquointerno del testo comrsquoegrave da attendersi nei diagrammi esse la perdono per il semplice motivo che non crsquoegrave alcun testo ambiente un diagramma ha unicamente una funzione denotati-va Drsquoaltra parte le lettere numerali che a volte figurano nei diagrammi della tradizione metrica66 allo scopo di indicare la lunghezza dei seg-menti mantengono la barra in un diagramma il contesto denotativo geometrico egrave prevalente e i numerali vengono percepiti come entitagrave grafiche lsquoesternersquo al discorso Va da seacute a fortiori che le lettere numerali inserite in un testo dovranno essere segnalate da barre che a loro volta non servono nelle tavole67 in quanto queste ultime sono come abbiamo visto un vero e proprio testo che perograve funge da ambiente a quello al-fabetico limitato alle titolazioni e non a caso tracciato in unrsquoopportuna lsquomaiuscola distintivarsquo allo scopo di segnalarne il carattere denotativo e non discorsivo68 Una tabella operazionale egrave invece un paratesto e quindi le barre sulle lettere numerali che rappresentano gli interi sono
64 La notazione per le lettere denotative subigrave unrsquoevoluzione (il cui risultato finale egrave descritto per sommi capi nella nota 3 supra) di cui non mette conto occuparsi qui
65 I papiri di contenuto geometrico (o astronomici ma che presentano argomenti geometrici) sono rari si vedano il PHerc 1061 (sec II aC Demetrio Lacone De geome-tria) e il PFay 9 (sec II ex Elementi I 39 e 41) Gli importanti ostraka OBerl 12002 e 12609 (sec III aC m Elementi XIII) non pongono le barre sopra le lettere denotative Per i manoscritti in maiuscola si veda ad esempio passim nel Par gr 2389 una cui riproduzione digitale egrave consultabile in rete allrsquoindirizzo httpgallicabnffrark12148btv1b8470171d o il fragmentum mathematicum Bobiense
66 Si veda ancora il ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 codex unicus dei Metrica di Erone e contenente una raccolta importante di problemi del corpus metrologico
67 Si vedano come esempio le tavole citate alle note 10 e 14 supra Discorso a parte per il segno di lsquoposto vuotorsquo si veda il punto c che segue
68 Queste regole generali vanno prese cum grano salis si dagrave naturalmente un certo dominio di variabilitagrave legato verosimilmente al grado di cultura grafica del copista nel PMich III 144 i numerali sono quasi tutti senza barra sia nel testo che nelle tabelle ope-razionali
Fabio Acerbi150
necessarie esse mancano invece sui segni convenzionali che ho descrit-to nel punto precedente e fatto rilevante sulle lettere numerali relative agli ordini sessagesimali quando esse siano identificate da uno o piugrave apici la presenza di questo segno grafico non alfabetico69 le esclude ancora una volta automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo Unrsquoultima osservazione che ci saragrave utile nel seacuteguito la descrizio-ne di una stringa di lettere lsquoagrammaticalersquo non puograve prevedere la men-zione della presenza della barra che le pertiene in quanto tale si tratta di una pratica denotativa che egrave possibile formulare soltanto ad un livello di discorso superiore sia a quello dellrsquouso che a quello della menzione70
c) Il segno di lsquoposto vuotorsquo Si noti nella tav 2b la forma ŏ per il segno di lsquoposto vuotorsquo in un ordine sessagesimale coerentemente con la propria notazione il copista del Marc gr 313 lo scioglie talvolta allrsquoin-terno del testo principale come unrsquoabbreviazione per οὐδέν laquonienteraquo Altre convenzioni di scrittura del tratto che accompagna il circoletto e che si badi bene fa parte integrante del segno di lsquoposto vuotorsquo ndash e infatti nelle tavole troviamo sempre il segno completo mentre tutti gli altri numerali sono come abbiamo visto nel punto precedente privi di barra o di apice a causa del fatto che i vari ordini sessagesimali sono univocamente determinati dalle linee di giustificazione ndash un tratto an-golare anteposto (tav 3 Lar Plut 2818 f 136v)71 o una semplice barra a sormontare (tavv 4-9) si produce in questo modo il segno 65926 che sembra essere stata la forma di base72
69 Occorre dunque supporre come testimoniano papiri e manoscritti in maiuscola che la convenzione relativa allrsquouso della barra si sia consolidata ben prima dellrsquointroduzione di segni diacritici quali accenti e spiriti
70 Si veda il punto 2 infra per maggiori dettagli sulla questione delle barre e degli apici e per le indicazioni in merito che leggiamo in Diofanto
71 Come accennato questa tavola dei sottomultipli coincide con quella descritta ed esposta nei Prolegomena Fatto molto rilevante i numerali nella prima non recano neacute barre neacute apici contrariamente a quanto accade a tutte le istanze della seconda nei manoscritti Quella del Laur Plut 2818 preserva a mio avviso la forma originaria come abbiamo visto una tavola non richiede segni aggiuntivi sulle lettere numerali
72 Si vedano come esempio ancora le tavole citate alle note 10 e 14 supra oppure per una rassegna delle forme che il segno assume nei manoscritti piugrave antichi delle Tavole facili Tihon 2011 pp 58-59 e per quelle che assume nei papiri Jones 1999 I pp 61-62 Ovviamente non possiamo leggere il segno 65926 come un omicron con una barra in quanto ο = 70 nella notazione greca e la barra egrave di rigore quando il numerale figuri allrsquointerno di un testo Occorre ammettere che si dagrave origine ad un bel corto circuito notazionale con il concepire un segno con funzione di lsquoposto vuotorsquo ma che lsquosomigliarsquo ad una lettera dellrsquoalfabeto sormontata da una barra cioegrave ad un numerale in piugrave quando il lsquoposto vuotorsquo non corrisponda ad un intero ma ad una specie sessagesimale la presenza della barra a priori indistinguibile da quella che sormonta gli interi introduce unrsquoincongruenza con la notazione a mezzo di apici vista nellrsquoitem precedente
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 151
d) Errori di copia La tabella riprodotta nella tav 2b ha una forma simmetrica ma si tratta di una forzatura il grande rettangolo in basso a destra drsquoaltronde assente nella descrizione contiene uno scolio che fa notare come lrsquoultimo resto parziale ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ͵γτνζ´´´´´ κζ´´´´´´ cioegrave 0 0 0 0 0 3357 27 siano ἔγγιστα λ´λ´ δ´δ´ ξ laquocon ottima approssimazione 60 minuti quartiraquo dove si notino gli apici semplici per indicare il pas-saggio allrsquoordinale e il raddoppiamento del sistema segno + apice per significare il plurale Lo scolio debitamente accompagnato dal segno di rimando in forma di simbolo solare egrave stato probabilmente incluso nella tabella proprio allo scopo di renderla simmetrica A sua volta un errore precedente spiega lo spazio eccessivo accordato al rettangolo contenente lo scolio il secondo massimo multiplo ŏ λβ´ ξδ´´ ριβ´´´ σιϛ´´´´ egrave trascritto anche al di sotto del risultato
Passiamo ora alla descrizione del metodo di divisione attribuito a Pappo
ἵνα οὖν ταῦτα συναχθῇ τὰ ἐκ τοῦ μερισμοῦ ὁ εἰρημένος Πάππος εὐδιατύπῳ τινὶ καὶ πρὸς τοῦτο τάξει χρησάμενος ποιεῖται τὴν τῆς συλλήψεως τοῦ ζητουμένου ἀνεύρεσιν οὕτως ἐκθέμενος γὰρ τὸν μέλλοντα μερίζεσθαι τουτέστι τὰς τξ μοίρας ἐν ἀρχῇ ἀφαιρεῖ ἀπ᾽ αὐτῶν τὸν ἐν τῇ σελίδι τυγχάνοντα ἐλάττονα τουτέστι τὸν τδ κβ´ κ´´ ὄντα τῶν ἐγγὺς ἐλασσόνων ὡς πρὸς τοὺς ἐκκειμένους διὸ καὶ γράφει αὐτὸν προγράφων αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε καὶ εὑρίσκων τὰ παρακείμενα αὐτῷ τῷ ἀπογραφέντι ἐν τῷ σελιδίῳ λεπτὰ πρῶτα ν´ συναπογράφεται παρατιθῶν αὐτοῖς τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον ἀνατείνουσαν σημαῖνον τὸ εἶδος ὅτι πρῶτα λεπτά εὑρίσκει οὖν οὕτως τὸ τῶν τξ μέρος τὸ τδ κβ´ κ´´ ὃ μεριζόμενον παρὰ τὰς τξε ιδ´ μη´´ ἡμέρας καὶ ποιοῦν τὸν ἐκ τοῦ μερισμοῦ ἀριθμὸν πρῶτα λεπτὰ ν´ καὶ τὸν λοιπὸν ἀπογραφόμενος τὸν νε λζ´ μ´´ προτάσσει αὐτοῦ τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά τάσσει δὲ καὶ ἁπλῆν τινα διατείνουσαν γραμμὴν ὡς ἀπὸ τοῦ τξ ἐπὶ τὸν ἑξῆς ἐκτεθειμένον ἐγγὺς
1
5
10
1 εὐδιατύπῳ] ZSPC εὐδιατύπωτ M 4 ἀφαιρεῖ] MZSP ἀφ ι C 5 ἐλάττονα] P comp MZSC 6 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | αφ ] αφ ε M ἀφ ZS ἀφαί P ἄφ C | ἀντὶ] om C | ἄφελε] MZSP ἄφ C 8 ἀπογραφέντι] MZSP ἐγγραφέντι C | λεπτὰ πρῶτα] P λε πρωτα SC λεπτῶν πρωτ MZ | παρατιθῶν] MZS παρατιθεὶς C et ex corr m 2 P 9 ᾱ] Z αο P α´ MS α C | ἔχον] MPC ἔχων ZS 9-10 πρῶτα λεπτά] ZP πρωτ λ´λ´ M πρωτα λε S αα λε C 11 ἡμέρας] comp codd | ἀριθμὸν] P et comp MZ καὶ C et comp S 12 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M πρωτ λεπτ(α) Z πρωτ λ εᾱ S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C | ἀπογραφόμενος] MZSP ἐγγραφόμενος C | νε λζ´] MZSP λζ νζ C 13 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | λ οι] MZSC ex λ fecit λ οι P | προσσημαῖνον] MC et προσ- comp ZS προση- P | τὸ] MZC τὰ S et fecit m 2 P 14 ἀπὸ] MZSP πρὸς C ἐλάττονα] P comp MZSC
1 εὐδιατύπῳ] εὐδιατυπώτω K 6-7 αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ] τὸ ἀφ K 8 παρατιθῶν mdash 10 λεπτά] τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ σημαίνουσαν τὸ εἶδος αὐτῶν ὅτι ᾱ λεπτά εἰσιν K | τὸ (sec)] τὰ K 12 πρῶτα] πρώτων K | τε λ ] λ οι` K | προσσημαῖνον mdash
Fabio Acerbi152
ἐλάττονα τὸν τδ κβ´ κ´´ ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις καὶ ταύτην ἐπιδεικνύουσαν τὴν τάξιν τῆς προόδου τῆς ἐκθέσεως ἧστινος κλωμένης γραμμῆς πρὸς τῷ ἐγγὺς ἐλάσσονι ἡ ἀντανάκλασις ἐπὶ τὸν λοιπὸν γέγραπται φερομένη ὡς εἴρηται διὰ τὸ εὔτακτον τῆς προκοπῆς οὕτως τε ποιήσας ἑξῆς τὸ αφ ποιῶν ὃ προσσημαίνει ὡς εἴρηται τὸ ὅτι δεῖ ἀφελεῖν ὁμοίως ἀπὸ τοῦ λοιποῦ καὶ δὴ τὸν ἐγγὺς πάλιν ἐλάσσονα ὡς πρὸς τὴν ἐν τῷ σελιδίῳ ἔκθεσιν εὑρισκόμενον λαμβάνων ἑξῆς προγράφει αὐτὸν ὄντα νδ μζ´ ιγ´´ ιβ´´´ καὶ εὑρίσκει αὐτοῖς παρακείμενα ἐν τῷ σελιδίῳ πρῶτα λεπτὰ θ´ ἅτινα καὶ αὐτὰ προσαπογράφεται σὺν τῇ παρασημειώσει τῶν πρώτων γράφων τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον τὴν ἀνατείνουσαν καὶ ὡς εἴρηται τὴν γραμμὴν πάλιν διὰ τὴν τάξιν κλωμένην κατὰ δευτέραν κλάσιν προσέλκει γινομένου τοῦ μέρους αὐτῆς τούτου παραλλήλου τῷ ἐξ ἀρχῆς
16 ante κλωμένης add ἐπὶ C 18 τε] MZP om SC | αφ ] M ἀφ ZSC ἀφαί P 19 προσσημαίνει] MS προση- ZC et ex corr P | ὅτι] ZP comp MSC 20 δὴ] MZSC διὰ fecit m 2 P 21 πρὸς] MSP et supra lineam C ex ἀπὸ fecit m 2 Z | ιγ´´] MZSP νγ´´ C 22 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M ᾱᾱ λεπτὰ Z άάα λε S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C 23 προσαπο- γράφεται] απο suprascr in comp M 24 ᾱ] ZP α´ MS α C 25 κλάσιν] MP τάξιν ZSC | τοῦ] ZSPC τούτου M 26 τούτου] τοῦ bis ZSPC sed prius erasit m 2 P τοῦ M
mdash 18 προκοπῆς] om K | τε ποιήσας] ποιήσας καὶ K | αφ ] ἀφ K 19 τὸ] om K 21 προ-γράφει] γράφει K 22 σελιδίῳ] α´ σελιδίῳ K | ἅτινα] ἃ K 23 προσαπογράφεται] ἀπογράφεται K | τῶν πρώτων mdash 26 ἐξ ἀρχῆς] om K
lsquoAllo scopo di raccogliere ciograve che risulta dalla divisione il detto Pappo utilizzando anche in questo caso una certa disposizione ben strutturata determina nel modo seguente il lsaquonumerorsaquo cercato preso nel suo insieme collocando73 in testa il lsaquonumerorsaquo che sta per essere diviso cioegrave i 360 gradi iniziali sottrae loro tra i piugrave prossimi dei lsaquonumerirsaquo minori rispetto a quelli esposti quello che si trova essere minore nella colonna (cioegrave 304 22 20) Questo egrave il motivo per cui lo trascrive scrivendogli davanti lrsquoabbreviazio-ne laquosottrraquo per laquosottrairaquo e trovando che 50 minuti primi sono collocati accanto a quello stesso lsaquonumerorsaquo che egrave stato trascritto nella colonna li trascrive al tempo stesso collocando accanto74 ad essi la lettera A con un lsaquotrattorsaquo75 sopra che significa la specie minuti primi Trova dunque in que-sto modo la parte di 360 che egrave 304 22 20 la quale divisa per 365 giorni 14 48 fa il numero lsaquoche risultarsaquo dalla divisione 50 minuti primi Trascrivendo
73 La descrizione egrave strutturata come una procedura Acerbi 201274 Il purismo del correttore del Par gr 2390 di Clostomalle nel Marc gr 314 e
dellrsquoautore della recensione bizantina impone loro di modificare la terminazione ma forme tematiche e contratte di τιθεῖν sono correnti nel greco tardivo
75 Il testo greco ha solo il participio con γραμμήν sottinteso Per il significato del participio si veda il punto 2
15
20
25
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 153
poi il resto 55 37 40 gli pone altresigrave76 a prefisso laquoReraquo che significa laquorestiraquo e dispone anche una certa linea semplice77 che va da 360 al piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori che egrave esposto di seacuteguito 304 22 20 come nello lsaquoschemarsaquo esposto linea che mostra lrsquoordine del percorso dellrsquoesposizione Questa linea spezzata lagrave dove si trova il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori egrave tracciata inflessa allrsquoindietro lsaquoersaquo punta verso il resto come egrave stato detto in vista di una progressione ordinata E cosigrave facendo prendendo di seacuteguito il laquosottrraquo che significa come egrave stato detto laquoche occorre similmente sottrarre dal re-storaquo e ovviamente prendendo di nuovo il lsaquonumerorsaquo che egrave trovato essere il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori in relazione alla disposizione nella colonna ndash 54 47 13 12 ndash lo scrive di seacuteguito e trova che 9 minuti primi sono posti loro accanto nella colonna trascrive78 anche questi con la segnaletica dei primi scrivendo la lettera A con un lsaquotrattorsaquo sopra e come egrave stato detto prolunga di nuovo la linea spezzata in vista di una buona disposizione tramite una seconda inflessione essendo questa sua parte parallela a quella inizialersquo
La descrizione continua con una serie di laquoe cosigrave viaraquo e non fa ulte-riore riferimento alla tabella
1) La forma verbale ἐξεσμένον Egrave il neutro del participio perfetto medio-passivo di ξέω lett laquopialloraquo laquolevigoraquo Si danno tre possibilitagrave si tratta di un termine canonico per quanto non altrove attestato per designare unrsquoabbreviazione oppure lrsquoautore anonimo improvvisa sul piano metaforico come se unrsquoabbreviazione non fosse altro che la paro-la completa lsquoaccorciata a colpi di piallarsquo in maniera opportuna oppure il testo egrave corrotto e srsquoimpone una correzione ad esempio τὸ ἑξῆς μένον laquociograve che sta di seacuteguitoraquo Questrsquoultima strada mi pare chiusa dal senso delle frase lrsquoabbreviazione non lsquosta di seacuteguitorsquo a niente ma anzi precede la perifrasi τὸ ἑξῆς μένον se impiegata semplicemente per rimandare al segno αφ immediatamente seguente costituirebbe un intollerabile solecismo Se accettiamo la prima di queste letture considerando quin-di lrsquoabbreviazione αφ in posizione predicativa abbiamo a che fare con
76 Rendo in questo modo il τε isolato77 La linea egrave laquosempliceraquo in quanto egrave una retta la precisazione intende evidenziare per
anticipazione il carattere lsquonon semplicersquo che essa assumeragrave alla prima inflessione quando diventeragrave una spezzata linee siffatte erano in effetti concepite dallrsquoanonimo e prima di lui da tutta la tradizione matematica greca come una singola linea spezzata nei punti drsquoinfles-sione I due segmenti paralleli menzionati al termine del passo sono orizzontali
78 Il verbo egrave al medio in variatio rispetto ai due che precedono e che seguono egrave il matematico che lsquosirsquo trascrive le cifre
Fabio Acerbi154
uno hapax semantico nella grecitagrave superstite come egrave facile verificare con una ricerca sul TLG in rete La recensione bizantina risolve il pro-blema sopprimendo semplicemente τὸ ἐξεσμένον
2) La notazione per le specie numeriche Nella terminologia matema-tica greca gli ordini sessagesimali sono εἴδη laquospecieraquo numerici essi corri- spondono agli ordini di grandezza nel nostro sistema decimale e indica-no in analogia con il caso geometrico la lsquoformarsquo che assume un numero quadrato cubo ecc Centinaia e migliaia sono quindi degli εἴδη rispet-tivamente quadrati (100 egrave il quadrato di 10) e cubi (1000 egrave il cubo di 10) sono specie numeriche ma non numeri particolari e drsquoaltronde 300 non egrave un quadrato ma 3 item dellrsquoεἶδος lsquoquadratorsquo 100 3 egrave il numerale di molteplicitagrave della specie quadrata lsquocentinaiarsquo i due 0 che seguono il 3 segnalano esattamente questo fatto che la notazione greca per gli interi non posizionale fa scomparire al livello denotativo Ciograve non vale soltan-to per i numeri interi ma anche per le loro parti i minuti secondi appar-tengono alla specie lsquoquadratorsquo in quanto 13600 egrave il quadrato di 160
La concezione appare interamente dispiegata nellrsquointroduzione degli Arithmetica diofantei79 che si rivela giova farlo rimarcare un te-stimone fondamentale per la ricostruzione della notazione matematica antica Alle specie usate in questrsquoopera vengono assegnati una denomi-nazione ed un segno convenzionale costituito dallrsquoiniziale (di ognuno dei componenti) della denominazione al quadrato o δύναμις il segno ΔΥ al κύβος il segno ΚΥ alla lsquoquarta potenzarsquo o δυναμοδύναμις il segno ΔΥΔ ecc La descrizione di tali segni egrave del tipo καὶ ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον Κ ἐπίσημον ἔχον Υ ΚΥ κύβος laquoe il suo segno egrave un Κ che ha come indice un Υ ΚΥ cuboraquo dove in accordo con quanto abbiamo visto nel punto b supra e pur nel comprensibile imbarazzo del copista della prima parte del Matritensis (o di un suo passato collega) a districarsi in questo formidabile ginepraio notazionale80 le due lettere Κ e Υ ricevono una barra mentre ΚΥ non la richiede a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον il quale ancora una volta esclude automaticamente il segno dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
79 In particolare a DOO I pp 214-62180 Nel Matr 4678 riscontriamo i seguenti fenomeni nelle poche righe a cavallo dei ff
58r-v 1) accento acuto posto su tutti i segni come se fossero abbreviazioni 2) ripetizione sistematica segnodenominazione come in ΚΥ κύβος appena letto dovuta sicuramente allrsquointrusione di glosse interlineari esplicative dei segni ndash e successivo pentimento (δύναμις e κύβος sono in effetti cancellati dalla prima mano il primo con un tratto il secondo con dei punti supra lineam poi il copista si stanca di correggere) 3) nella descrizione del segno per la δυναμοδύναμις menzione di un δέλτα δύο che saragrave molto probabilmente stato ΔΔ subito dopo nella descrizione del κυβόκυβος si legge un incongruo δύο KK
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 155
Diofanto introduce poi dei segni anche per le specie delle parti dellrsquounitagrave (le nostre frazioni) che egli chiama ὁμώνυμα μορία laquoparti omonimeraquo di cui quelle sessagesimali sono casi particolari81 Egli spie-ga appunto che le loro denominazioni sono ottenute da quelle delle specie degli interi per sinonimia passando ad un lsquoordinalersquo82 formato semplicemente aggiungendo il suffisso -στον δυναμοστόν κυβοστόν δυναμοδυναμοστόν ecc (sott μόριον) I loro segni convenzionali sono invece ottenuti da quelli per le specie degli interi aggiungendo una γραμμὴν διαστέλλουσαν τὸ εἶδος laquolinea che distingue la specieraquo83 Una linea sui segni delle specie delle parti egrave richiesta si badi bene per distinguerli dai segni di quelle degli interi come giagrave osservato questi ultimi sono giagrave lsquoagrammaticalirsquo a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον a fortiori lo saranno anche i primi Si tratta della traduzione semio-tica del passaggio dal cardinale allrsquoordinale che a livello grammaticale egrave effettuato con il suffisso -στον Che forma ha questa linea Barra o apice (Egrave cervellotico pensare a forme piugrave complesse) La domanda non ammette una risposta immediata in quanto delle specie diofantee nessuno piugrave si occupa nellrsquoantichitagrave84 Se egrave vero che la prima risposta darebbe origine ad un conflitto tra due convenzioni denotative diffe-renti la barra lsquocitazionalersquo e la barra che distingue la specie lrsquoevidenza grafica del Matritensis lascia lievemente sgomenti (ricordiamoci che giagrave i segni di base sono indebitamente dotati di un accento dal copista) Le poche occorrenze del segno per le specie delle parti85 vedono lrsquoaggiunta di uno slash di sospensione di un doppio apice inverso ndash in tutta evi-
81 Questo fatto era giagrave chiaro nellrsquoantichitagrave Teone in Alm I 10 in iA p 45310-1682 Il parallelo con i cardinali e gli ordinali relativi agli interi egrave reso esplicito da Dio-
fanto ὥσπερ δὲ τῶν ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια παρομοίως καλεῖται τοῖς ἀριθμοῖς τοῦ μὲν τρία τὸ τρίτον τοῦ δὲ τέσσαρα τὸ τέταρτον οὕτως καὶ τῶν νῦν ἐπονομασθέντων ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια κληθήσεται παρομοίως τοῖς ἀριθμοῖς laquocome le parti omonime dei numeri sono chia-mate per assonanza con i numeri di lsquotrersquo lsquolsaquounrsaquo terzorsquo di lsquoquattrorsquo lsquolsaquounrsaquo quartorsquo cosigrave le parti omonime dei numeri appena nominati saranno chiamate per assonanza con i numeriraquo (DOO I p 69-13 si noti lrsquoarticolo lsquocitazionalersquo al singolare in τοῦ τρία e τοῦ τέσσαρα) Il parallelo prosegue anche al livello dei segni che rappresentano queste specie come vedremo tra un attimo
83 Diofanto Arithmetica prefazione in DOO I p 620-21 un passaggio maltrattato in questa edizione occorre espungere il participio ἔχον senza introdurre segni ulteriori oppure eliminare un precedente ἐπί come fa un correttore del Matritensis f 58v
84 Unica parzialissima eccezione lrsquoaccenno di Teone menzionato nella nota 81 supra85 Al f 59r e per di piugrave nel margine per sanare un lungo saut du mecircme au mecircme La
collocazione in margine egrave il motivo per cui troviamo una notazione abbreviata nel resto del trattato il primo copista scioglie tutti i segni prendendoli per abbreviazioni mentre il secondo elimina sistematicamente il tratto aggiuntivo delle specie delle parti dellrsquounitagrave Drsquoaltronde egli scrive ad esempio ΔΥ invece di ΔΥ ed egrave quindi indotto a porre la barra al di sopra della stringa di lettere risultante (passim ma si veda ad esempio il f 72r)
Fabio Acerbi156
denza il compendio per la desinenza -ον accentata il copista interpreta il segno come unrsquoabbreviazione ndash e di una barra a sormontare lo Υ Potremmo forse interpretarlo come il segno di contrazione del grafema -στ- lrsquounico tassello mancante in unrsquoabbreviazione come ad esempio (δυναμοδυναμο)(στ)(ὸν) ma uno scolio di prima mano al f 58v rela-tivo alle specie degli interi inficia questrsquoipotesi esse sono dotate di slash di sospensione accento acuto in un caso del compendio canonico per la terminazione -ον hellip ma tutti gli Υ a esponente sono a loro volta sormontati da una barra
Meno legata al singolo manoscritto ma nondimeno non uniforme si presenta la pratica di notazione dei segni che rappresentano gli enti numerici sessagesimali86 da una parte sta lrsquoevidenza del testo dei Pro-legomena e delle sue tabelle apici ndash drsquoaltronde come abbiamo visto la notazione universalmente impiegata per i numerali ordinali e per le fra-zioni unitarie ndash dallrsquoaltra sta lrsquoevidenza del testo dellrsquoAlmagesto in tutti i manoscritti piugrave antichi e lo stesso si dica del commentario teonino a questrsquoopera o del suo lsquoGrande commentariorsquo alle Tavole facili e dei testi astronomici su papiro barre87 Sembra insomma che la nostra docu-
86 Sia le molteplicitagrave che le specie ahimeacute entrambe rappresentate da lettere dellrsquoalfabeto Come osservato allrsquoinizio della sezione 3 ci sono in effetti due tipi di lettere numerali in gioco se facciamo astrazione da apici o barre lsquo4 minuti secondirsquo si trova scritto δ β la prima lettera numerale denota la molteplicitagrave degli item di una certa specie la se-conda la specie nei Prolegomena entrambe sono accompagnate da un doppio apice il che rende inutile la presenza delle seconde Si noti che la descrizione della tabella non fa parola della notazione da usare per le lettere numerali che denotano la molteplicitagrave barre o apici e quanti apici hellip In questo caso fa interamente fede la tabella cioegrave la pratica grafica condivisa instauratasi non egrave chiaro quando
87 I manoscritti piugrave antichi dellrsquoAlmagesto sono menzionati nella nota 10 supra quelli dei due commentarii teonini sono il Laur Plut 2818 e il celeberrimo Vat gr 190 (sec IX in Euclide Elementi Data Teone lsquoGrande commentariorsquo) per la notazione dei pa-piri astronomici si veda Jones 1999 II passim La notazione non sembra lsquoinquinatarsquo dalla pratica dei copisti bizantini e pare dipendere soltanto dalla data di composizione Tro-viamo ad esempio barre sopra tutti i numerali di molteplicitagrave (interi o sessagesimali) nel frammento di un commentario alle Tavole facili contenente un calcolo relativo al 24 aprile 213 (Par gr 2841 sec XIII ex-XIV in oltre al frammento ai ff 32r l 11-34v l 23 contiene Arato Phaenomena ed Efestione Apotelesmatica edizione in Jones 1990) Nel commentario alle Tavole facili composto ca 610-617 ed attribuito a Stefano di Alessandria la situazione egrave la seguente (Jean Lempire per litteras per lrsquoedizione si veda Lempire 2014 ho controllato il Vat gr 304 ff 135r-171v sec XIV am contiene in aggiunta Teone in Almagestum I-II lsquoPiccolo commentariorsquo alle Tavole facili Diofanto Arithmetica e De polygo-nis numeris varia astronomica tabulae) barre sopra gli interi sporadicamente rimpiazzate da apici apici sopra le parti sessagesimali in numero uguale alla denominazione doppio () apice per le frazioni unitarie Sono impiegate barre sopra gli interi e apici sopra le parti sessagesimali nei manoscritti principali di tutti i trattati di introduzione allrsquoAlmagesto o comunque di argomento logistico redatti in epoca bizantina Giorgio Pachimere (1242-ca 1310) Quadrivium (autografo nel manoscritto Roma Biblioteca Angelica gr 38 [RGK III nr 115] si veda Tannery ndash Steacutephanou 1940 per lrsquoedizione) Teodoro Metochita (1270-
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 157
mentazione si faccia testimone di un cambio notazionale avvenuto nel periodo intercorrente fra Teone (sec IV pm) e la scuola alessandrina di Ammonio e dei suoi allievi (sec VI in) e probabilmente innescato da questrsquoultimo ambiente lrsquoaspetto paradossale egrave che nello stesso codice si rintraccino due notazioni differenti per gli enti numerici sessagesimali e lrsquouna (apici) sia adottata sistematicamente e coerentemente in uno scritto (i Prolegomena) che si presenta esattamente come unrsquointroduzione tecnica alla pratica numerico-algoritmica del trattato (lrsquoAlmagesto) in cui egrave adottata lrsquoaltra (barre che ritroviamo senza eccezioni anche negli scolii)
Torniamo ai Prolegomena la descrizione del segno da porre a fianco di ogni singolo quoziente parziale e denotante la sua specie numerica (minuti primi minuti secondi ecc) solleva tre problemi
Primo problema Ci vuole una barra o un apice su τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquola lettera A [hellip] che significa la specieraquo quando lo scriviamo nella tabella Tutta la nostra discussione precedente fa pro-pendere per lrsquoapice e si ricordi anche la forma verbale ἀνατείνουσαν che suggerisce qualcosa che si lsquoestende verso lrsquoaltorsquo (la mia traduzione egrave volutamente neutra) se fosse apposta una barra la cosa dovrebbe passare
1231332) Compendium astronomicum (copia lsquoautorizzatarsquo coeva nei Vat gr 182 e 181 da parte del copista che integrograve le parti mancanti del Par gr 2389 [ff 207-210 255-270 374-375] Bianconi 2005a pp 425-427 Peacuterez Martiacuten 2008 p 436 e n 177) Teodoro Meliteniota (morto lrsquo831393) Tribiblos astronomica (autografo nel Vat gr 792 si vedano Leurquin 1991 per unrsquoanalisi del manoscritto Leurquin 1990 per lrsquoedizione) una com-pilazione anonima (per cui ho consultato il Par gr 2396 ff 87r-92v limitatamente a questi fogli manu Costantino Trivoli [RGK II nr 318 ma ovviamente questo codice non vi egrave segnalato] terzo quarto del XV secolo il resto del codice annotato da Niceforo Gregora egrave di etagrave planudea e parzialmente [ff 33v-76v] un autografo di Planude stesso contiene Teone in Almagestum I II IV Mondrain 2002 il codice va completato ndash limitatamente a stralci dei libri VIII-X XII-XIII del commentario teonino la cui parte intermedia si egrave persa ndash con 26 carte [ff 123-147] inserite nel Vat gr 1087 anchrsquoesso contenente anno-tazioni di Gregora Rome 1927 per la figura del copista dei ff 77r-86r del Par gr 2396 e dei ff appena nominati del Vat gr 1087 un anonimo collaboratore di Gregora si veda in ultimo Bianconi 2006a pp 147-151) si veda anche il calcolo effettuato da Niceforo Gre-gora (12921295-13581361) dellrsquoeclisse di sole del 16 luglio 1330 (attestata unicamente ai ff 1r-8v della miscellanea astronomica Marc gr 325 databile ca 1324-1329 in parte vergata e ovunque fittamente annotata da Gregora stesso edizione del testo in Mogenet et al 1983 annotazioni di Gregora elencate in Bianconi 2005a p 413) Unrsquoeccezione apparente il lsquoPiccolo commentariorsquo di Teone alle Tavole facili le parti sessagesimali sono segnalate da apici (ad esempio nel Vat gr 175 vergato da Giovanni Catrario e completato nel 1321-1322 sulla figura di Catrario si vedano in ultimo Bianconi 2005b pp 141-156 e 2006b) lrsquoopera egrave antica ma la sua tradizione non rimonta oltre la fine del XIII secolo a parte un frammento nel Leiden BPG 78 ff 156r-161v (minuscola del IX-X secolo) e in effetti in questo manoscritto tutti i numerali di molteplicitagrave sono sormontati da barre Unrsquoeccezione effettiva egrave il De hypotesibus planetarum nel Vat gr 1594 barre sugli interi e apici sulle parti sessagesimali
Fabio Acerbi158
sotto silenzio e la presenza dellrsquoapice la rende inutile88 Si tratta della stessa convenzione diofantea e coincide ancora con la notazione per i numerali ordinali e per le frazioni unitarie che egrave corrente nei mano- scritti matematici greci per questo motivo non percheacute la descrizione sia particolarmente perspicua nessuno dei copisti della recensione an-tica ha incertezze apici Ma questi apici si rintracciano soltanto sulle indicazioni di specie non contemplate dalla descrizione che sono ante-poste ai resti parziali a fianco dei quozienti parziali i segni di specie sono invece trasformati in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordi-nali corrispondenti del tipo πρωτ tavv 5 e 7b-8 Il recensore bizantino taglia invece la testa al toro elimina dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali elimina la seconda menzione della laquolet-tera Araquo contestualmente allrsquoazzeramento dellrsquoespediente della linea a zig-zag (si veda il punto seguente) modifica la descrizione che contiene la prima menzione in quella dellrsquoapice associato direttamente ai nume-rali di molteplicitagrave riciclando addirittura lrsquoalpha per adibirlo a desi-gnare un numero cardinale (come sorprendersi) τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ laquoponendo al di sopra di essi [scil dei 50 minuti primi] 1 solo lsaquoaccentorsaquo acutoraquo La scelta del recensore egrave assennata che rechi una barra o un apice in una tabella un alpha denota un numero non un numero drsquoordine
Secondo problema da tenere ben distinto dal precedente Cosa ci vuole sul segno α per la lettera alpha menzionata nella frase τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquolettera A [hellip] che significa la specieraquo89 Unrsquooc-chiata allrsquoapparato critico rivela una bella incertezza nei manoscritti Z scrive sempre ᾱ e in un caso lo fa anche P MS optano sempre per α´ C per α P scrive nellrsquoaltro caso αο Per quanto solo la barra sia congrua con il senso della frase in quanto la lettera alpha egrave qui menzionata (si tratta di un oggetto che compare nella tabella) e non cambia niente se essa egrave accompagnata dal suo nome di genere στοιχεῖον ad un livello grafico lrsquoincertezza fra il segno ᾱ che denota laquola lettera αraquo e il segno α´ (o lrsquoabbreviazione αο) per una forma di πρῶτος egrave per piugrave versi giustificata
88 Detto in altri termini la barra egrave uno strumento grafico non matematico e quindi la sua presenza non va segnalata mentre un apice lo egrave e la sua presenza lo deve
89 Notare che in questa frase il primo α non vuole la barra (egrave menzionato allrsquointerno di una frase che impiega convenzioni moderne) il secondo sigrave (idem ma con convenzioni antiche) ndash e nella traduzione la scelta di denotarlo con A (senza virgolette) e non con lsquoArsquo (con virgolette) egrave del tutto arbitraria ndash si noti inoltre che le necessarie precisazioni laquosenzacon virgoletteraquo mostrano che le lingue moderne palesano difficoltagrave analoghe a quelle del greco antico per quanto riguarda i livelli denotativi in ambito metadiscorsivo per non usare le due parentetiche avrei dovuto scrivere rispettivamente lsquoArsquo e lsquolsquoArsquorsquo (doppie virgolette semplici)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 159
ᾱ coincide con il numerale 1 α egrave la prima lettera dellrsquoalfabeto ed inoltre α´ egrave esattamente quello che va scritto nella tabella Potremmo dirci che il sostantivo στοιχεῖον chiude la questione la sua presenza congiunta ad un ipotetico α´ renderebbe la descrizione ridondante o inappropriata90 Ma a parte il fatto che α egrave proprio τὸ πρῶτον στοιχεῖον il segno α´ cat-tura in fondo il cuore della descrizione di uno στοιχεῖον ἔχον lsaquoγραμμὴνrsaquo ἀνατείνουσαν
Terzo problema Lrsquoautore dei Prolegomena che si arresta allrsquoesem-pio dei minuti primi non dice quanti apici occorre mettere sulle lettere numerali che identificano gli ordini superiori al primo se uno soltanto come nel caso diofanteo e delle frazioni unitarie o in numero uguale alla loro denominazione (cioegrave pari al numero denotato dal numerale stesso su cui vanno posti) come effettivamente avviene nei mano-scritti dei Prolegomena La tabella egrave quindi sottodeterminata dalla sua descrizione anzi in un certo senso prende il sopravvento su di essa la pratica di marcare i numerali di molteplicitagrave con gli apici che compe-tono allrsquoordine cui appartengono viene trasferita ai segni per gli ordini stessi per supplire ad una descrizione carente di questi ultimi E la tabella egrave sottodeterminata dalla descrizione in quanto egrave la descrizione di una tabella reale ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις laquocome nello lsaquoschemarsaquo espostoraquo leggiamo a un certo punto del testo
3) La linea a zig-zag Non possiamo che applaudire a questo geniale espediente grafico lo troviamo messo in opera solo nel Marc gr 313 Per quanto lrsquoautore non faccia parola di ciograve nel corso della sua descrizione la linea spezzata egrave intesa dover lsquosaltarersquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue Il copista del codice marciano effettua correttamente due salti nella prima delle sue tabelle (tav 4) ma inserisce un lsquodentersquo in piugrave in quella che considera corretta (tav 5) La linea a zig-zag egrave incompatibile con la presenza di linee di giustificazione nella tabella che in effetti mancano nel Marc gr 313 ciograve induce gli errori di allineamento dei primi 5 quozienti parziali di cui egrave vittima il copista Probabilmente per questo motivo in nessuno degli apografi del Vat gr 1594 la linea a zig-zag figura nella tabella inquadrata come si conviene da una (doppia) cornice esterna e le cui colonne sono appunto separate da linee verticali (tav 7b Vat gr 184 f 17v e tav 8 Par gr 2390 f 9v cui egrave sostanzialmente identica la tabella del Marc gr 314 che si trova
90 Trascuro lrsquoabbreviazione αο = πρῶτος percheacute la desinenza non egrave quella richiesta neacute nella frase (egrave richiesto πρῶτον) neacute nella tabella (πρῶτα)
Fabio Acerbi160
al f 248r ndash ma la mancanza di linee orizzontali causa un gigantesco pa-sticcio nel codice vaticano) Alla recensione bizantina che dipende per il suo testo di base dal Vat gr 1594 e quindi non trova la linea a zig-zag nella tabella non resta che sopprimere la sua descrizione ndash ma proprio per questo motivo e finalmente diventa possibile tracciare un apparato completo di linee di giustificazione (tav 9 Laur Plut 89 sup 48 f 14v) Dato che la descrizione di Teone di questo procedimento di divi-sione non fa cenno allrsquoesistenza della linea a zig-zag viene da chiedersi se essa non costituisca un espediente escogitato dallrsquoautore dei Prolegomena per vivacizzare la procedura originale di Pappo
4) Discrepanze tra descrizione e tabella Il gioco delle minime va-rianti mostra che la divisione era stata eseguita (e trasmessa) corret-tamente tutti i valori numerici sono esatti La tabella nel Marc gr 313 presenta perograve alcune discrepanze con la propria descrizione Essa omette (ma non nella versione lsquoscorrettarsquo lrsquoomissione non si riscontra neanche nel Par gr 2390) il segno per laquorestoraquo di fronte ai resti par-ziali ma aggiunge lrsquoindicazione della loro specie Essa trasforma invece come abbiamo visto le indicazioni di specie che seguono i quozienti parziali in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordinali corri-spondenti La descrizione prevede di chiudere la tabella con il risultato καὶ συνάγων ἅπαντα τὰ ἐκ τῶν μερισθέντων μερῶν λεπτὰ σημειοῦται ὑπὸ πάντας οὕτως γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoe raccogliendo tutti i minuti che provengono dalle parti divise lsaquoPapporsaquo nota sotto tutto cosigrave Ris 0 59 8 17 13 12 31raquo ma sotto la tabella tutta la tradizione ci consegna qualcosa di piugrave articolato ὁ ζητούμενος καθ᾽ ὃν μερίζεται ὁ τξε ιδ´ μη´´ π(αρὰ) τὸν τξ γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoil lsaquonumerorsaquo cercato secondo cui 365 14 48 egrave diviso per 360 risulta 0 59 8 17 13 12 31raquo frase che del resto contiene due errori lrsquoinversione del dividendo e del divisore e la confusione tra segno convenzionale (iuxta descrizione) e abbreviazione (come nella frase) nel caso di γι Oltre ad eliminare la linea a zig-zag91 la recensione bizantina sopprime dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali e modifica come abbiamo visto al punto 2 le loro descrizioni in quelle di apici associati diretta-mente ai numerali di molteplicitagrave
91 Le due righe che nella recensione di base contengono solo i resti parziali minori di 160 del divisore ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue sono in parte completate con lrsquoindicazione abbreviata ἀνάλ(υσις) laquoanalisiraquo il termine greco per questa procedura di riduzione In un sussulto di ipercorrettismo matematico tali resti parziali ridotti non sono preceduti dal segno per laquorestoraquo come nel Par gr 2390 ma da quello per laquorisultatoraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 161
Gli esempi che abbiamo discusso mostrano come i problemi di notazione pesino e non poco sullrsquoespressione discorsiva di un algorit-mo matematico lrsquoente di riferimento per lsquoformularersquo il procedimento di divisione fu considerata la tabella cioegrave un oggetto la cui costitu-zione egrave legata piugrave ad una pratica grafica che a considerazioni logico- algoritmiche non la sua descrizione che in effetti finisce per determi-nare la tabella in maniera non univoca Di questa sottodeterminazione si fa testimone la traiettoria che abbiamo cercato di seguire nelle mani di copisti e revisori il procedimento di divisione si modifica a volte in aspetti secondari a volte in punti piugrave sostanziali ndash fino a rendere neces-saria una radicale revisione della sua descrizione per renderla conforme alla tabella ndash in ogni caso mai per ragioni squisitamente matematiche92
Abstract
The article presents and discusses in detail two passages from the anonymous Prolegomena to the Almagest a VIth century primer to the elementary procedures of calculation needed in Ptolemyrsquos Almagest In the two passages we may follow the complex interplay between mathematical notation the auctor who employed and described it the tachygrapher who transcribed it in vivo copyists who reproduced it correctors who modified it Along this path misgivings and errors arise in the transmission of abbreviations and paratextual units such as diagrams tables operational schemes
Fabio AcerbiCNRS UMR8560 Centre Alexandre Koyreacute
fabacerbigmailcom
92 Sono grato a Daniele Bianconi Lucio del Corso Jean Lempire per alcune preziose indicazioni
AOO = Archimedis opera omnia cum commentariis Eutocii ed J L Heiberg I-III Lipsiae 1910-1915
DOO = Diophanti Alexandrini opera omnia cum Graecis commentariis ed P Tannery I-II Lipsiae 1893-1895
GC = Le laquoGrand Commentaireraquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Mogenet ndash A Tihon I-III Cittagrave del Vaticano 1985-1999
iA = Commentaires de Pappus et de Theacuteon drsquoAlexandrie sur lrsquoAlmageste ed A Rome I-III con paginazione continua Cittagrave del Vaticano 1931-1943
HOO = Heronis Alexandrini opera quae supersunt omnia ed G Schmidt ndash L Nix ndash W Schmidt ndash H Schoene ndash J L Heiberg I-V Lipsiae 1899-1914
PC = Le ldquoPetit Commentairerdquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed A Tihon Cittagrave del Vaticano 1978
POO = Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia ed J L Heiberg I-II in 3 parti Lipsiae 1898-1907
RGK = Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600 I Handschriften aus Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln II Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs und Nachtraumlge zu den Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln III Handschriften aus Bibliotheken Roms mit dem Vatikan A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg unter Mitarbeit von D Harlfinger und P Eleuteri B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln Wien 1981-1997 (Oumlsterreichische Akademie der Wissenschaften Veroumlffentlichungen der Kommission fuumlr Byzantinistik III1-3 A-C)
Sigla
Acerbi 2010 = F Acerbi Il silenzio delle sirene La matematica greca antica Roma 2010
Acerbi 2012 = F Acerbi I codici stilistici della matematica greca dimostrazioni procedure algoritmi laquoQUCCraquo 1012 (2012) pp 167-214
Acerbi et al 2010 = F Acerbi ndash N Vinel ndash B Vitrac Les Proleacutegomegravenes agrave lrsquoAlmageste Une eacutedition agrave partir des manuscrits les plus anciens Introduction geacuteneacuterale ndash Parties I-III laquoSCIAMVSraquo 11 (2010) pp 53-210
Agati 1992 = M L Agati La minuscola laquoBouleteacuteeraquo Cittagrave del Vaticano 1992
Belger 1881 = C Belger Ein neues Fragmentum mathematicum Bobiense laquoHermesraquo 16 (1881) pp 261-284
Bianconi 2005a = D Bianconi La biblioteca di Cora tra Massimo Planude e Niceforo Gregora Una questione di mani laquoSampTraquo 3 (2005) pp 391-438
Bianconi 2005b = D Bianconi Tessalonica nellrsquoetagrave dei Paleologi Le pratiche intellettuali nel riflesso della cultura scritta Paris 2005
Bianconi 2006a = D Bianconi Le pietre e il ponte ovvero identificazioni di mani e storia della cultura laquoBizantinisticaraquo 8 (2006) pp 135-181
Bianconi 2006b = D Bianconi Qualcosa di nuovo su Giovanni Catrario laquoMEGraquo 6 (2006) pp 69-91
Cavallo 1977 = G Cavallo Funzione e strutture della maiuscola greca tra i secoli VIII-XI in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Colloque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 95-137
Cereteli 1904 = G F Cereteli De compendiis scripturae codicum Graecorum praecipue Petropolitanorum et Mosquensium anni nota instructorum Sankt-Petersburg 1904
De Gregorio 2000 = G De Gregorio Materiali vecchi e nuovi per uno studio della minu-scola greca fra VII e IX secolo in G Prato (a cura di) I manoscritti greci tra riflessione e dibattito Atti del V Colloquio Internazionale di Paleografia Greca Cremona 4-10 ottobre 1998 Firenze 2000 pp 83-151
Follieri 1977 = E Follieri La minuscola libraria dei secoli IX e X in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Col-loque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 139-165
Fonkič 2005 = B Fonkič Venecianskaia rukopisrsquo laquoAlrsquomagestaraquo Ptolemeja (Marc gr 313690) o datirovke i proischoždenii kodeksa laquoVDIraquo s III 254 (2005) pp 162-167
Fowler 1999 = D H Fowler The Mathematics of Platorsquos Academy A New Reconstruction Second Edition Oxford 1999
Bibliografia
Fabio Acerbi164
Gerstinger ndash Vogel 1932 = H Gerstinger ndash K Vogel Eine stereometrische Aufgaben-sammlung im Papyrus Graecus [sic] Vindobonensis 19996 laquoMitteilungen aus der Papy-russammlung der Nationalbibliothek in Wienraquo Neue Serie Folge 1 Griechische literarische Papyri 1 Wien 1932 pp 11-76
Heiberg 1927 = Mathematici Graeci Minores ed J L Heiberg Kjoslashbenhavn 1927
Hultsch 1876-1878 = Pappi Alexandrini Collectionis quae supersunt ed F Hultsch I-III Berlin 1876-1878
Janz 2003 = T Janz The Scribes and the Date of the Vat gr 1291 in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae X Cittagrave del Vaticano 2003 pp 159-180
Jones 1990 = Ptolemyrsquos First Commentator ed A Jones Philadelphia 1990
Jones 1999 = Astronomical Papyri from Oxyrhynchus ed A Jones I-II Philadelphia 1999
Jones 2005 = A Jones Ptolemyrsquos Canobic Inscription and Heliodorusrsquo Observation Reports laquoSCIAMVSraquo 6 (2005) pp 53-97
Lempire 2014 = Steacutephanos drsquoAlexandrie Le commentaire aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Lempire Louvain 2014
Leurquin 1990 = Theacuteodore Meacuteliteacuteniote Tribiblos astronomique Livre I ed R Leurquin Amsterdam 1990
Leurquin 1991 = R Leurquin Un manuscrit autographe de la Tribiblos Astronomique de Theacuteodore Meacuteliteacuteniote le Vaticanus graecus 792 laquoScriptoriumraquo 45 (1991) pp 145-162
Maas 1927 = P Maas Griechische Palaeographie in A Gercke ndash E Norden (hrsg von) Einleitung in die Altertumswissenschaft I9 Leipzig 1927 pp 69-80
Martinelli Tempesta 2010 = S Martinelli Tempesta Il codice Milano Biblioteca Am-brosiana B 75 sup (gr 104) e lrsquoevoluzione della scrittura di Giovanni Scutariota in A B Garciacutea ndash I Peacuterez Martiacuten (ed by) The Legacy of Bernard de Montfaucon Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting Proceedings of the Seventh Inter-national Colloquium of Greek Palaeography Madrid-Salamanca 15-20 September 2008 Turnhout 2010 pp 171-186
Mazzucchi 1994 = C M Mazzucchi Leggere i classici durante la catastrofe (Costantino-poli maggio-agosto 1203) le note marginali al Diodoro Siculo Vaticano gr 130 Parte prima stratigrafia laquoAevumraquo 68 (1994) pp 164-218
Mioni 1976 = E Mioni Bessarione scriba e alcuni suoi collaboratori in Miscellanea marcia-na di studi bessarionei Padova 1976 pp 263-323
Mioni 1985 = Codices graeci manuscripti Bibliothecae Divi Marci Venetiarum II Thesaurus Antiquus Codices 300-625 recensuit E Mioni Roma 1985
Mogenet 1962 = J Mogenet Une scholie ineacutedite du Vat gr 1594 sur les rapports entre lrsquoastronomie arabe et Byzance laquoOsirisraquo 14 (1962) pp 198-221
Mogenet et al 1983 = Niceacutephore Greacutegoras Calcul de lrsquoeacuteclipse de soleil du 16 juillet 1330 ed J Mogenet ndash A Tihon ndash R Royez ndash A Berg Amsterdam 1983
Mondrain 2002 = B Mondrain Maxime Planude Niceacutephore Greacutegoras et Ptoleacutemeacutee laquoPa-laeoslavicaraquo 10 (2002) pp 312-322
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 165
Mondrain 2004 = B Mondrain Lrsquoancien empereur Jean VI Cantacuzegravene et ses copistes in A Rigo (a cura di) Gregorio Palamas e oltre Studi e documenti sulle controversie teologiche del XIV secolo bizantino Firenze 2004 pp 249-296
Mondrain 2007 = B Mondrain Les eacutecritures dans les manuscrits byzantins du XIV e siegravecle Quelques probleacutematiques laquoRSBNraquo n s 44 (2007) pp 157-196
Peacuterez Martiacuten 2006 = I Peacuterez Martiacuten Maxime Planude et le Diophantus Matritensis (Madrid Biblioteca Nacional ms 4678) un paradigme de la reacutecupeacuteration des textes anciens dans la ldquorenaissance paleacuteologuerdquo laquoByzantionraquo 76 (2006) pp 433-462
Peacuterez Martiacuten 2008 = I Peacuterez Martiacuten El lsquoestilo Hodegosrsquo y su proyeccioacuten en las escrituras constantinopolitanas laquoSampTraquo 6 (2008) pp 389-458
Perria 1991 = L Perria Scrittura e ornamentazione nei codici della laquocollezione filosoficaraquo laquoRSBNraquo n s 28 (1991) pp 45-111
Rollo 2012 = A Rollo LrsquoArchimede di Giorgio Valla in V Fera ndash D Gionta ndash A Rollo (a cura di) Archimede e le sue fortune Atti del Convegno di Siracusa-Messina 24-26 giugno 2008 Messina 2012 pp 99-147
Rome 1927 = A Rome Membra disjecta laquoRBenraquo 39 (1927) pp 187-188
Rome 1938 = A Rome Un manuscrit de la bibliothegraveque de Boniface VIII agrave la Meacutediceacuteenne de Florence laquoACraquo 7 (1938) pp 261-268
Ronconi 2013 = F Ronconi La collection philosophique un fantocircme historique laquoScripto-riumraquo 67 (2013) pp 119-140
Tannery ndash Steacutephanou 1940 = Quadrivium de Georges Pachymegravere ed P Tannery ndash E Steacutephanou Cittagrave del Vaticano 1940
Tihon 2011 = Πτολεμαίου Πρόχειροι Κανόνες Les Tables faciles de Ptoleacutemeacutee vol Ia Tables A1-A2 ed A Tihon Leuven 2011
Traube 1907 = L Traube Nomina Sacra Versuch einer Geschichte der christlichen Kuumlrzung Muumlnchen 1907
Vogel 1936 = K Vogel Beitraumlge zur griechischen Logistik laquoSBAWraquo Mathematisch-natur-wissenschaftliche Abteilung Jahrgang 1936 pp 357-472
Wouters 1979 = A Wouters The Grammatical Papyri from Graeco-Roman Egypt Contri-butions to the Study of the lsquoArs Grammaticarsquo in Antiquity Brussel 1979
F ACERBI Tav 1
b Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 65r
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 284 f 160r
F ACERBITav 2
b Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 13r
a Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 19v
F ACERBI Tav 3
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 136v
F ACERBITav 4
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17r
F ACERBI Tav 5
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17v
F ACERBITav 6
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 7v
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 131
LrsquoAlmagesto e con esso tutta la tradizione astronomica adotta il sistema sessagesimale per esprimere la parte non intera di un nu-mero che siano valori angolari o lineari non fa differenza20 come noi scriviamo 36524 e intendiamo 365 + 2 decimi + 4 centesimi (cioegrave 4102) cosigrave nel sistema sessagesimale 365 14 48 significa21 365 + 14 sessantesimi + 48 tremilaseicentesimi (cioegrave 48602) ovverosia nel lessico antico e nostro 365 14 πρῶτα λεπτά laquominuti primiraquo 48 δεύτερα λεπτά laquominuti secondiraquo dove laquoprimoraquo e laquosecondoraquo sono le laquodenominazioniraquo degli ordini (sono cioegrave numeri ordinali) 14 e 48 i lsquonumerali di molteplicitagraversquo relativi ai due ordini numerale di mol-teplicitagrave e relativa denominazione costituiscono insieme una lsquoparte sessagesimalersquo di un numero Drsquoaltronde per gli antichi come per noi lrsquoespressione di una parte non intera (ovvero di una frazione)
20 Trascuro il fatto ai nostri fini irrilevante che essendo i numerali greci lettere alfabetiche la notazione che ne risulta per i numeri interi non egrave posizionale nonostante le cifre scagravelino di un posto ad ogni potenza di dieci il segno μ per 4 (decine) non egrave identico al segno δ per 4 (unitagrave) Drsquoaltra parte una volta adottata la notazione decimale per i numerali di molteplicitagrave la notazione complessiva per la parte non intera espressa nel sistema sessa-gesimale non egrave posizionale neanche introducendo un segno di lsquoposto vuotorsquo una cui parte egrave nel caso greco analoga in forma al nostro 0 (su questo segno si veda ancora la sezione 4 punto c) occorre avvalersi di accorgimenti ulteriori quali lrsquointroduzione di spaziature fra le differenti parti sessagesimali (come viene fatto nei manoscritti greci ed in questrsquoarticolo) o di segni tipografici (come suggerito da Otto Neugebauer che avrebbe scritto 3651448 il numerale che leggeremo tra un attimo nel testo) Il problema egrave che altrimenti lrsquoordine associato ad un numerale di molteplicitagrave di una parte sessagesimale puograve non risultare uni-vocamente determinato dalla sua posizione Esempio scrivendo 0129 per un numero non intero nel sistema sessagesimale il numerale di molteplicitagrave 129 potrebbe rappresentare 1 minuto primo e 29 secondi oppure 12 minuti primi e 9 secondi ecc e la stessa difficoltagrave si presenta nella notazione greca (per la nozione di lsquonumerale di molteplicitagraversquo si veda infra nel testo) Il problema scomparirebbe se adottassimo singoli segni differenti per tutti i nu-merali da 1 a 59 ndash ma neacute noi neacute i greci siamo stati disposti a introdurre una complicazione siffatta Si ricordi infine che al di fuori dei contesti astronomici il sistema di numerazione greco egrave decimale
21 Scriverograve i numerali in cifre arabe sempre in questo modo parte intera seguita dalle parti sessagesimali (minuti primi secondi ecc) con ogni ordine separato da uno spazio bianco Se la parte intera egrave assente il numerale inzia con uno 0 Nella trascrizione dei numerali in greco ogni numerale di molteplicitagrave sessagesimale o frazione unitaria saragrave identificato come nei manoscritti piugrave antichi dei Prolegomena da un opportuno numero di apici (uno per ogni unitagrave dellrsquoordine avendo le frazioni unitarie un solo apice come vedremo nellrsquoAlmagesto contenuto negli stessi codici troviamo barre non apici con questa funzione) mentre la parte intera saragrave priva della barra che la sormonta invariabilmente nei manoscritti In questo modo 365 14 48 egrave la conversione in cifre arabe di τξε ιδ´ μη´´ La pratica dei manoscritti medievali egrave di collocare gli apici (quando presenti) sopra le lettere numerali per ragioni tipografiche li porrograve di seacuteguito al gruppo di lettere cui si riferiscono Si noti che nella notazione greca il segno ιδ´ per 1460 in sessagesimale egrave identico a quello per 114 in decimale Nel caso delle frazioni unitarie la presenza dellrsquo(unico) apice egrave la traduzione semiotica della trasformazione che a livello grammaticale egrave effettuata con il pas-saggio dal cardinale allrsquoordinale (ad esempio da τὰ τρία laquotreraquo a τὸ τρίτον laquoun terzoraquo) si veda anche la sezione 4 punto 1 e note 82 e 86 ivi incluse
Fabio Acerbi132
richiede sempre lrsquointroduzione di due numerali il lsquonumeratorersquo e il lsquodenominatorersquo
Il motivo della scelta del sistema sessagesimale che fu mutuato dallrsquoastronomia matematica babilonese egrave presto detto lrsquoelevato numero di divisori di 60 e cioegrave 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 Poicheacute i divi-sori di 10 sono un sottinsieme di quelli di 60 molti piugrave numeri hanno una rappresentazione finita nel sistema sessagesimale che in quello deci-male Calcolare in sessagesimale lungi dal creare difficoltagrave offre quindi un vantaggio cruciale22 che risulta piugrave facilmente comprensibile sulla base dellrsquoesempio seguente La lunghezza dellrsquoanno solare egrave stabilita da Tolomeo in 365 giorni + 14 ndash 1300 di giorno Per calcolare il moto giornaliero del sole si rende necessario dividere 360 per questo numero Noi avremmo due opzioni se non potessimo usare la calcolatrice ri-durre il divisore ad una singola frazione tramite passaggio al denomi-natore comune invertire questa frazione e moltiplicarla per 360 sem-plificare gli eventuali fattori comuni e finalmente eseguire la divisione a piugrave cifre tra numeri interi (nel nostro caso 5400054787) oppure scrivere il divisore come numero decimale periodico (365246666 hellip) e poi eseguire la divisione Nel sistema sessagesimale egrave tutto molto piugrave semplice 365 + 14 ndash 1300 ha una rappresentazione finita cioegrave 365 14 48 come eseguire la divisione lo vedremo tra un attimo
Passiamo dunque in rassegna il contenuto del lsquomanuale di logisticarsquo incluso nei Prolegomena ad Almagestum riportando in nota per ogni item anche esposizioni parallele in altri commentatori23
a) Costruzione del sistema sessagesimale24
22 E uno svantaggio se le molteplicitagrave dei singoli ordini vengono espresse in no-tazione decimale (come facciamo noi e facevano i greci) il numero di cifre necessario per raggiungere una precisione assegnata egrave maggiore nel sistema sessagesimale in quanto per esprimere i numerali da 10 a 59 occorrono due cifre mentre per quelli da 1 a 9 (o da α a θ e le decine da ι a ν nel caso greco) ne basta una e ciograve indipendentemente dal fatto che la notazione sia posizionale oppure no La differenza si fa perograve sentire solo a partire dal quinto ordine sessagesimale
23 Trascuro la parte finale del lsquomanualersquo dove sono esposte le regole di interpolazione (cui era legata la lsquoterza colonnarsquo della tavola delle corde tolemaica) e il procedimento di lsquosottrazionersquo di rapporti cioegrave la divisione di un rapporto per un altro
24 Per a-b cf Teone in Alm I 10 in iA pp 44919-45814 PC pp 2007-2014 GC I pp 10910-11124 e le definizioni e regole diofantee di manipolazione delle varie specie numeriche in Arithmetica prefazione in DOO I pp 214-1218 Le porzioni a-b sono giagrave state pubblicate da Paul Tannery in DOO II pp 318-1517 sulla base del Par gr 453 apografo ad opera di Giovanni Santamaura di un Vat gr 1594 giagrave mutilo (RGK II nr 238 ma lrsquoautore trascritto vi egrave indicato come lsquoPtolemaiosrsquo) Evidentemente il committente non fu soddisfatto della prima trascrizione (ff 67-76) che crivella di tratti rossi a segnalarne gli errori di copia Ne fu dunque eseguita una seconda (ff 78-86) cui Santamaura antepose
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 133
b) Regole di moltiplicazione e divisione degli ordini sessagesimali defini-zione generale di moltiplicazione moltiplicazione di ordini come somma delle loro laquodenominazioniraquo Definizione generale di divisione divisione di ordini uguali e di un ordine per quello che lo precede immediata-mente divisione di ordini come sottrazione delle loro laquodenominazioniraquo divisione per 60 come divisione per 1 accompagnata dallo slittamento di un posto dellrsquoordine
c) Problemi che sorgono nella divisione di una parte sessagesimale per una di quelle che seguono divisione breve per riduzione allo stesso ordine (metodo laquoper analisiraquo) due algoritmi differenti il secondo con riduzione dei fattori comuni attribuito a Siriano
d) laquoAltroraquo metodo di divisione breve in realtagrave divisione tra somme di parti sessagesimali appartenenti ad ordini differenti per riduzione allo stesso ordine e applicazione dei metodi precedenti esempio della divisione di 0 2 0 4 per 0 0 2 0 240
e) Metodo di moltiplicazione tra numeri con parti non intere disposizione tabellare dei termini esempio della moltiplicazione di 5 4 6 per 8 0 3 0 525
f ) Primo metodo di divisione lunga descrizione della disposizione tabellare ed esempio di algoritmo applicato alla divisione di 50 48 26 30 per 8 16 28 5426
g) Metodo di divisione lunga tratto da Pappo in Alm III descrizione della disposizione tabellare ed esempio di algoritmo applicato alla divisione di 360 per 365 14 48 come verifica del valore 0 59 8 17 13 12 31 fornito nellrsquoAlmagesto per il moto medio giornaliero del sole27
h) Metodo di approssimazione di una radice quadrata secondo Erone Metr I 8 con giustificazione geometrica di Teone (attualmente non attestata in suoi scritti)
i) Verifica tramite moltiplicazione della correttezza del valore tolemaico28 di 67 4 55 come radice quadrata approssimata di 4500 Metodo di estrazio-ne di radici quadrate secondo Teone basato su applicazioni successive di Elementi II 4 la procedura termina dopo un numero finito di passi nel caso di quadrati perfetti Applicazione al calcolo della radice quadrata di 450029
unrsquoannotazione spazientita laquoIl texto di questo 2do quinterno egrave stato recopiato fidelmente dallrsquooriginale a chi volesse vedere la prova lo potragrave conferire con detto originale le pagine del qual texto corrispondono con quelle dellrsquooriginale tanti versi che pagine [hellip]raquo (Moge-net 1962 p 200)
25 Teone in Alm I 10 e I 14 in iA pp 45815-4604 e 57911-5811026 Teone in Alm I 10 in iA pp 4611-46217 applicato alla divisione di 1515 20
15 per 25 12 1027 Teone in Alm III 1 e IV 3 in iA pp 84112-84422 (stesso calcolo dei Prolego-
mena) e 102916-10327 idem in Alm IX pp 377-378 dellrsquoedizione di Basilea del 1538 approntata dai tipografi di Walderus Lrsquooriginale pappiano non ci egrave pervenuto
28 Alm I 10 in POO I 1 p 341129 Teone in Alm I 10 in iA pp 46916-4738
Fabio Acerbi134
Lrsquounico testo non elencato qui sopra o nelle note e che contenga tabelle operazionali egrave il commentario eutociano a Circ 3-4 Il testo ar-chimedeo che Eutocio e noi con lui leggeva egrave particolarmente conciso ed egli verifica esplicitamente il sussistere di certe relazioni numeriche Si tratta in ognuno dei nove casi presenti di mostrare che il lsquoteorema di Pitagorarsquo egrave verificato con ottima approssimazione dai valori numerici di opportune terne di rette Eutocio esegue le tre moltiplicazioni dei valori per se stessi e mostra che la somma o la differenza di due dei risultati si discosta di poco dal terzo30 I numeri in questione sono interi seguiti o no da una parte non intera espressa come somma di frazioni unita-rie31 I nove gruppi di tre moltiplicazioni una a fianco allrsquoaltra sono organizzati in forma tabellare ma senza lrsquoausilio di linee separatrici32 le operazioni sono eseguite disponendo lsquoin colonnarsquo i risultati delle mol-tiplicazioni parziali e sommandoli esattamente come facciamo oggi poicheacute sono in gioco numeri interi con parti frazionarie unitarie e la notazione non egrave posizionale non egrave necessario che gli incolonnamenti siano esatti (unitagrave di un risultato parziale sotto le decine del precedente ecc) Sono inclusi nella tabella istruzioni e commenti in linguaggio corrente33 le prime relative allrsquooperazione da affettuare sui risultati delle
30 Eutocio non calcola radici quadrate approssimate per quanto ciograve si renda piugrave volte necessario fornisce il risultato e verifica la sua correttezza moltiplicandolo per se stesso Egli dichiara che il lettore interessato a questo procedimento di calcolo puograve rivolgersi Ἥρωνι ἐν τοῖς μετρικοῖς [hellip] Πάππῳ καὶ Θέωνι καὶ ἑτέροις πλείοσιν ἐξηγουμένοις τὴν μεγάλην σύνταξιν τοῦ Κλαυδίου Πτολεμαίου laquoa Erone nei Metrica [hellip] a Pappo e Teone e a svariati altri inter-preti della Grande composizione di Claudio Tolomeoraquo (AOO III p 23213-17)
31 Troviamo ad esempio ͵αωλη θ´ ια´ cioegrave 1838 + 19 + 111 notare il singolo apice per le frazioni unitarie
32 Essi sono editi in AOO III pp 234-256 La tradizione medievale del commentario eutociano che coincide con un ramo di quella archimedea e deriva da un codice appar-tenuto a Giorgio Valla perduto in etagrave rinascimentale ma riprodotto a volte con fedeltagrave assoluta negli apografi (si veda ad esempio nella tav 1a la riproduzione dellrsquoerronea di-sposizione di cifre e parte algoritmica nel primo gruppo di moltiplicazioni offerta dal Laur Plut 284 f 160r) egrave costituita da Marc gr 305 ff 142v-146v Laur Plut 284 ff 159r-164r Par gr 2360 ff 109v-113v Par gr 2361 pp 410-421 Nel codice veneziano in cui la disposizione per righe e colonne egrave irrimediabilmente alterata dal copista le operazioni sono cancellate con tratti di penna Il primo manoscritto fu esemplato per Bessarione da Giorgio Trivizias tra il 1455 e il 1468 (Mioni 1976 pp 309-312) il secondo fu vergato da Giovanni Scutariota in scrittura di imitazione (Martinelli Tempesta 2010 p 173 n 7 Rollo 2012) ca 1491-1492 il terzo fu trascritto per il cardinale di Firenze Niccolograve Ridolfi dopo che la biblioteca di Valla era stata acquistata a seacuteguito della sua morte avve-nuta il 23 gennaio 1500 per 800 scudi drsquooro da Alberto Pio di Carpi (nota del copista al f 120v) il quarto fu terminato per mano di Christopher Auer su commissione di Georges drsquoArmagnac il primo gennaio 1544 (sottoscrizione a p 474 del codice si veda RGK II nr 525)
33 A questi va aggiunto posto davanti al risultato finale di ogni moltiplicazione il segno convenzionale per ὁμοῦ laquoinsiemeraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 135
prime due moltiplicazioni34 i secondi alla bontagrave dellrsquoapprossimazione ottenuta35 Ogni gruppo di operazioni che chiude unrsquounitagrave esegetica ed egrave seguito dalla citazione che apre la successiva egrave trascritto come se facesse parte del testo a tutta pagina e preceduto dallrsquoindicazione οἱ δὲ πολλαπλασιασμοὶ ὑπόκεινται laquole moltiplicazioni sono poste qui sottoraquo Questi due fatti suggeriscono che tutte le operazioni cui Eutocio non fa alcun riferimento nel corpo del suo commentario siano unrsquoaggiunta editoriale risalente a Isidoro di Mileto che si occupograve della revisione del testo36
Gli incolonnamenti esatti sono invece necessari quando siano moltiplicati numeri con parti non intere espresse nel sistema sessage-simale in quanto la somma finale dei prodotti parziali va effettuata ordine per ordine Tale somma eccederagrave di norma il valore di 60 per un ordine dato nella tabella occorre pertanto trovare posto anche per i riporti che vanno sommati ai prodotti parziali dellrsquoordine preceden-te e quindi incolonnati con essi I testi ci offrono alcuni esempi di tabelle operazionali moltiplicative di questo tipo Teone afferma espli-citamente che la prima moltiplicazione che va a descrivere ha una rap-presentazione tabellare la cui disposizione ritroviamo pesantemente ingarbugliata nel Laur Plut 2818 f 35r37 Alla seconda occorrenza di una moltiplicazione eseguita (tav 1b Laur Plut 2818 f 65r) gli incolonnamenti sono meglio rispettati anche se il risultato finale egrave fatto erroneamente slittare di un posto verso destra i riporti (con un errore) si trovano nella penultima riga38 Nei Prolegomena ad Alma-gestum alcune moltiplicazioni sono accompagnate da tabelle quella meglio attestata egrave associata alla moltiplicazione di 67 4 55 per se stesso (sezione i nel riassunto fornito supra) ed egrave descritta additando sempli-cemente ad un ente materiale oramai inaccessibile forse tracciato in loquendo lsquoalla lavagnarsquo
34 Come λοιπὸν τὸ ἀπὸ ΕΓ laquoresta quello su ΕΓraquo seguito dal risultato della sottrazione di due quadrati
35 Come λείπει ἄρα μο β εἰς τὸ ἀκριβές laquomancano quindi 2 u(nitagrave) al risultato esattoraquo36 Si legga la sottoscrizione spuria ad AOO III p 26010-1237 Si legga la frase ἐκτίθεμαι αὐτὴν καὶ πάλιν αὐτὴν ὑφ᾽ αὑτὴν ὡς ὑπογέγραπται laquolo [scil il
valore del lato da moltiplicare per se stesso] dispongo lsaquouna voltarsaquo e di nuovo al sotto di se stesso come trascritto qui sottoraquo in iA p 45817 Il Laur Plut 2818 (Teone e Pappo Commentaria in Almagestum) egrave uno dei piugrave antichi manoscritti in minuscola sicuramente assegnabile alla prima metagrave del IX secolo (Follieri 1977 p 144 n 23 Maas 1927 p 76 n 17 riteneva che fosse piugrave antico del Tetraevangelo Uspenskij) per una sua analisi si veda Rome 1938
38 In nessuno dei due casi i numerali di molteplicitagrave sono segnalati con apici sono tutti sormontati da una barra si veda la sezione 4 punto b
Fabio Acerbi136
προκείσθω δὶς τὸ μῆκος αὐτῆς ὀφεῖλον τὴν τάξιν τοῦ κατὰ τοὺς πολλαπλασιασμοὺς κανόνος ἀποδοῦναι καὶ ἐκκείσθω ἐπὶ σελιδίων διαγεγραμμένων οὕτω καὶ δὴ αὐτῆς ἐφ᾽ ἑαυτὴν πολ-λαπλασιασθείσης γεγονέτωσαν τὰ ἐν τοῖς οἰκείοις σελιδίοις εἴδη ταῦτα δὴ συναγόμενα καθ᾽ ἣν ὑπεδείξαμεν τάξιν ποιήσει τὰς ὑπογεγραμμένας μοίρας ἢ καὶ λεπτά τινα εἴσι ͵δυϙθ νθ´ ιδ´´ ι´´´ κε´´´´ ὡς λείπειν τοῦ ἐπιμερισθῆναι ŏ ŏ με´´ μθ´´´ λε´´´´
che sia prescritto che la sua lunghezza debba figurare due volte nella disposizione della tavola delle moltiplicazioni e che lsaquoquestrsquoultimarsaquo sia disposta su colonne delimitate da linee cosigrave mdash E pertanto una volta moltiplicato lsaquoil latorsaquo per se stesso che le specie trovino posto nelle colonne appropriate quelle che vengono cosigrave raccolte secondo la disposizione che abbiamo indicato produrranno dunque i gradi o anche i minuti qui sotto trascritti 4499 59 14 10 25 in modo che dalle divisioni successive resti39 0 0 45 49 35
La tabella associata (tav 2a Marc gr 313 f 19v) contiene una sola svista grossolana reca 51 invece di 55 in ognuno dei due fattori posti affiancati sopra di essa Al di sotto preceduto dal segno convenzionale per ὁμοῦ egrave collocato il risultato incongruamente sfalsato di un paio di colonne e con la lettera numerale ͵δ priva di barra sormontante in-naturalmente disconnessa da υϙθ I riporti sono indicati dai numerali ι ρκγ´ η´´ ν´´´ posti al fondo delle prime quattro colonne Il calcolo egrave corretto in ogni sua parte
Il clou in questo piccolo spaccato delle interazioni testo-paratesto matematico risiede nella descrizione contenuta nei Prolegomena della disposizione tabellare di due procedimenti di divisione il primo ano-nimo e quindi da supporre tradizionale il secondo piugrave efficiente ed attribuito al matematico del IV secolo Pappo
Il primo metodo di divisione egrave sostanzialmente analogo a quello che usiamo attualmente Dividendo e divisore questrsquoultimo preceduto da un segno su cui ritorneremo nella prossima sezione sono posti uno sotto lrsquoaltro intervallati da una riga inizialmente vuota Primo passo viene reperito il massimo multiplo del divisore che sia minore del di-videndo esso viene trascritto sotto il dividendo nella prima lsquocasellarsquo della riga vuota recante in testa un segno per laquosottrairaquo il fattore mol-tiplicativo (o quoziente parziale) viene trascritto in una lsquocasellarsquo pre-ceduta da un segno per laquorisultaraquo sotto il divisore Secondo passo il massimo multiplo viene sottratto dal dividendo il resto cosigrave ottenuto egrave trascritto preceduto da un segno per laquorestoraquo in una casella posta
39 Lrsquoautore concettualizza il procedimento di estrazione di radice quadrata come una forma di divisione
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 137
accanto al dividendo40 I due passi precedenti sono quindi ripetuti con la sola differenza che il resto appena ottenuto prende il posto del divi-dendo il quoziente parziale scala di un ordine sessagesimale ad ogni passo41 E cosigrave via aggiungendo ogni volta due caselle La debolezza di questo metodo come di quello che utilizziamo attualmente risiede nel fatto che il reperimento dei quozienti parziali (ovverosia dei massimi multipli) viene effettuato per tentativi non riuscire a farlo al primo colpo appesantisce notevolmente i calcoli successivi e costringe ad un lavoro di riordino e addizione dei quozienti parziali stessi La tabella risultante dove appunto osserviamo questo fenomeno in parallelo con identiche inaccuratezze nella descrizione ha la forma riprodotta unico tra i manoscritti della recensione antica nel Marc gr 313 f 13r (tav 2b invito il lettore a non rivolgersi alle tavole se non dopo aver termi-nato questa sezione sarebbe anzi auspicabile che tentasse di ricostruire questa tabella e le due successive a partire dalla mia descrizione)42
Il secondo metodo di divisione attribuito a Pappo egrave congegnato in modo da rendere non aleatoria la ricerca dei quozienti parziali Come altrove nei Prolegomena la descrizione della procedura di calcolo si riag-gancia esplicitamente a una frase di Tolomeo laquouna volta dimostrato che il periodo di una singola rivoluzione lsaquodel solersaquo egrave di 365 giorni 14 48 se di-vidiamo per essi i 360 gradi di un singolo cerchio avremo il moto medio giornaliero del sole circa 0 gradi 59 8 17 13 12 31raquo43 Questrsquoaffermazione si trova nel terzo libro dellrsquoAlmagesto si tratta della prima occasione in cui viene effettuata una divisione in cui il divisore egrave maggiore del dividendo e i commentatori del trattato tolemaico non si fecero sfuggire lrsquooccasione di mostrare come eseguirla Ora il terzo libro del commentario di Pappo non ci egrave pervenuto Ci resta dunque come testo parallelo a quello dei Prolegomena la descrizione rigidamente formulare in Teone sicuramente un calco di quella pappiana Teone qui come nelle altre applicazioni del metodo (Laur Plut 2818 ff 136v [tav 3] e 190r) descrive brevemente ed espone esplicitamente la stessa tavola dei sottomultipli del divisore che
40 Esempio nella divisione di 378 per 17 il massimo multiplo egrave 374 il quoziente parziale egrave 22 il resto 4 e in effetti 378 = 374 + 4 = 17times22 + 4 Si noti che il segno per laquorestoraquo non egrave apposto in testa di riga ma davanti a ogni resto parziale e in effetti il dividendo che si trova in prima posizione in questa riga non egrave un resto
41 Analogamente nellrsquoalgoritmo moderno poniamo la virgola o scaliamo la cifra di un posto
42 Nei Prolegomena la descrizione della tabella associata al metodo anonimo egrave pre-ceduta da una breve sinossi dellrsquooperazione in stile procedurale (cioegrave senza riferimenti alla tabella) e seguita dalla sua esecuzione accurata ma con pochi riferimenti alla tabella se non quello ai due segni da apporre ai resti parziali e ai massimi multipli
43 Alm III 1 in POO I 1 p 2091-4
Fabio Acerbi138
troviamo nei Prolegomena ma non offre alcuna descrizione della disposi-zione tabellare della divisione stessa neacute vi fa riferimento
A questa procedura sono in effetti associate una tavola e una tabel-la costruite come segue (tavv 4 e 5 Marc gr 313 ff 17r e 17v il co-pista era ndash giustamente ndash insoddisfatto della prima versione) La tavola le cui righe e colonne sono delimitate da linee contiene sottomultipli44 del divisore 365 14 48 9 righe che riportano i valori da 160 a 960 piugrave altre 6 con i valori per decine da 1060 a 6060 la prima colonna elenca le 15 parti sessagesimali omettendo come drsquoabitudine la laquodenomina-zioneraquo dellrsquoordine (i numerali elencati sono quindi α β γ δ ε ϛ ζ η θ ι κ λ μ ν ξ) la seconda i sottomultipli corrispondenti organizzati su quattro colonne per tener conto dei tre ordini sessagesimali (il primo sottomultiplo egrave quindi ϛ ε´ ιδ´´ μη´´´ cioegrave 160 di τξε ιδ´ μη´´) La tabella priva di linee delimitanti espone la vera divisione Nella prima colonna troviamo i resti parziali ognuno preceduto dallrsquoindicazione del proprio ordine sessagesimale e da un segno per laquorestoraquo Nella seconda preceduti da un segno per laquosottrairaquo i sottraendi ognuno coincide ovviamente con uno dei sottomultipli nella tavola La terza colonna contiene se-guiti dallrsquoindicazione del proprio ordine sessagesimale i quozienti par-ziali ottenuti trascrivendo dalla prima riga della tavola il numerale corrispondente al sottraendo affiancato ed assegnando come ordine sessagesimale il successivo a quello posto in testa di riga Il risultato preceduto da un segno per laquorisultaraquo e posto al di sotto della tabella si ottiene sommando i quozienti parziali il procedimento non permette in generale di determinare lrsquointero quoziente parziale relativo ad un ordine sessagesimale fissato se non dopo due passi Una linea spezzata unisce i resti parziali successivi e i relativi sottraendi per evidenziare la laquoprogressione della proceduraraquo la spezzata lsquosaltarsquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore (le cui righe sono per il resto vuote) e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue di conseguenza anche il quoziente parziale relativo a questo resto appartiene allrsquoordine sessagesimale successivo
A questo punto possiamo rivolgerci alle tavv 4-5 e verificare se le immagini che ci siamo formati sulla base della mia descrizione corri-spondono a quelle che troviamo nel Marc gr 313 Non si tratta di un giochetto sterile egrave al contrario il cuore di un intrico di problemi Un primo ordine di problemi deriva dal fatto che nei Prolegomena lrsquoalgo-
44 Sottomultipli e non multipli in quanto il divisore egrave maggiore del dividendo Drsquoaltronde nel sistema sessagesimale come in quello decimale un sottomultiplo si ottiene dal multiplo corrispondente semplicemente scalando tutte le cifre di un posto (ad esempio 1360 di 365 14 48 si ottiene in questa maniera da 13 volte 365 14 48)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 139
ritmo della divisione lsquoalla Papporsquo non egrave mai eseguito (cioegrave formulato verbalmente) in maniera indipendente dalla descrizione della tabella Comrsquoegrave dunque possibile descrivere una tabella operazionale che non ha uno statuto testuale indipendente sulla base di un algoritmo in corso di esecuzione E drsquoaltro canto come non rilevare unrsquoanomalia in un algoritmo eseguito nella sua forma primaria sotto forma di descrizione di una tabella Ci potremmo chiedere se viene descritto lrsquoalgoritmo o la tabella La tensione fra i due enti grafici egrave acuita dal fatto che nei nostri testi tutto ciograve (esposizione o descrizione di un algoritmo o della tabella associata) avviene sempre e solo sulla base di un esempio numerico para-digmatico Per questo motivo la tabella in quanto struttura (cioegrave privata dei dati numerici accidentali) non puograve fare a meno della descrizione45 Dal canto suo Teone come forse Pappo ancor prima descrive ed espone la tavola dei (sotto)multipli ma non la tabella di divisione lrsquoalgoritmo relativo a questrsquoultima egrave espresso come per controbilanciare in maniera eccezionalmente trasparente e formulare Se ciograve comporta un guada-gno a livello verbale-argomentativo sorge un problema operativo grave come e dove sistemare i resti e i quozienti parziali ndash cioegrave tutti i numeri in output dellrsquoalgoritmo differenti dai (sotto)multipli ndash che la tabella si incarica di disporre in modo lsquonaturalersquo Teone prescrive soltanto di confrontare i resti con la seconda colonna della tavola dei sottomultipli e di trascrivere via via il quoziente ottenuto dopo ogni passo Insomma come eseguire materialmente una divisione Non certo adattando ad un nuovo caso specifico la formulazione dellrsquoalgoritmo che Teone propone
Un secondo ordine di problemi e una trappola micidiale per il co-pista egrave interno alla dialettica lsquotabellarsquolsquosua descrizionersquo ed egrave in assenza di simbolismo quello dei riferimenti linguistici da adottarsi nella seconda agli enti grafici che figurano nella prima Occorre ricercare la massima generalitagrave fornita da una descrizione definita di un ente numerico (ad esempio impiegando il termine laquorestoraquo o la perifrasi laquomassimo sotto-multiplo minoranteraquo) o basta assumere direttamente il suo valore speci-fico come esempio paradigmatico E in che modo risolvere il conflitto tra uso e menzione se come nel nostro caso la tabella contiene segni convenzionali ed occorre fornirne una descrizione Si rende ad esempio necessario introdurre un lsquooperatore di citazionersquo noi useremmo le virgo-lette la lingua greca premette lrsquoarticolo neutro Drsquoaccordo ma nel caso
45 Questa caratteristica non egrave connaturata alla matematica degli algoritmi la risorsa dello lsquostile proceduralersquo serve esattamente ad aggirare questo problema al di lagrave di un certo livello di dettaglio perograve essa condurrebbe ad un appesantimento insostenibile della for-mulazione dovuto alla pluralitagrave dei riferimenti agli oggetti matematici in gioco sulla que-stione dei diversi stili della matematica greca si veda Acerbi 2012
Fabio Acerbi140
greco qual egrave il suo range E come distinguerlo nei casi ambigui da un semplice articolo che precede un sostantivo quando questrsquoultimo lo ri-chieda Nel corso del processo di copia del testo della descrizione infine possono generarsi tensioni tra enti grafici interpretabili vuoi come segno convenzionale vuoi come abbreviazione Ambiguitagrave relative a questi punti opacizzano la descrizione Un problema analogo si porrebbe a priori nella dialettica tra uso delle lettere denotative per designare enti geometrici e loro menzione nella costruzione di un diagramma ma esso egrave risolto con lrsquoazzeramento della seconda funzione le lettere denota-tive sono sempre usate allrsquointerno del testo (sono cioegrave il referente degli oggetti geometrici di cui tratta il discorso matematico) mai menzionate (come accadrebbe se fossero il referente di oggetti grafici posti nel dia-gramma) Insomma il codice adottato per la costituzione dei diagrammi geometrici egrave condiviso (cioegrave canonizzato) semplice e perspicuo mentre quello per le tabelle operazionali non lo egrave da qui le sviste dei copisti e le trascuratezze di correttori ed editori
Infine chi vuole apprendere da questi testi come eseguire una divi-sione a cosa deve prestar fede se ad esempio a causa di errori di copia la descrizione finisce per non coincidere con la tabella operazionale visto che sono entrambe due maniere valide di eseguire lo stesso algoritmo Dopo tutto lo scopo di tutta questa macchina grafico-argomentativa egrave di insegnare a eseguire divisioni in formato tabellare Questo problema si fa particolarmente acuto se la tabella non egrave trasparente nel metodo di Pappo lo egrave quasi completamente in quello anonimo no E gli errori che riscontreremo nella (doppia) tabella ai ff 17r-v del Marc gr 313 a chi sono attribuibili Allrsquoautore al trascrittore o al copista medievale
Questo groviglio di problemi riceve alcune risposte sorprendenti dalla tradizione manoscritta come andiamo finalmente a vedere
4 Analisi delle testimonianze
I codici che ho adibito per lrsquoedizione sono i seguenti M = Marc gr 31346 C = Marc gr 314 (Tolomeo Tetrabiblos et opera minora cum commentariis Vezio Valente Anthologiae)47 Z = Vat gr 2326 (fattizio
46 Riferibile al sec IX ex-X in accolgo la datazione suggeritami per litteras il 522005 da Nigel G Wilson si veda anche Agati 1992 pp 141-142 La presenza non sistematica degli accenti che fa anticipare a Wilson la datazione di laquosaec X medraquo fornita in Mioni 1985 p 24 indusse Boris Fonkič (2005 non vidi) ad assegnare il codice allrsquoinizio del IX secolo
47 Il manoscritto riferibile alla seconda o terza decade della prima metagrave del XIV secolo fu vergato da Michele Clostomalle olim lsquoMetochitesschreiberrsquo Bianconi 2005a pp 428-430 Il titolo dei Prolegomena in questa trascrizione identico in grafia ma non in formulazione a
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 141
e mutilo Tolomeo Almagestum) S = Vat gr 184 (varia astronomica scholia miscellanea ad Almagestum Tolomeo Almagestum) P = Par gr 2390 (varia astronomica) gli ultimi tre riferibili allo scorcio del XIII secolo48 e apografi sicuri del Vat gr 159449 attualmente mutilo di due fascicoli che ci privano dei due terzi finali dei Prolegomena M e il Vat gr 1594 ammettono un modello comune il resto della tradizione (25 trascrizioni in tutto) dipende dagli apografi appena citati del Vat gr 1594 Le varianti della recensione bizantina che leggiamo tra lrsquoaltro nei Vat gr 198 Marc gr 310 (Tolomeo Almagestum cum commentariis Pappi Theonis et Cabasilae) e con ulteriori modifiche Laur Plut 89 sup 48 (varia astronomica Tolomeo Almagestum Barlaam Logistica) sono identificate dal siglum K e si trovano punteggiatura originale in-clusa nel secondo apparato50 Lrsquoanalisi delle testimonianze51 costituite ovviamente anche dalle tabelle associate saragrave condotta nella forma di una sequenza di osservazioni indicizzate da numerali o lettere oltre che di alcune note a piersquo di pagina
Iniziamo dalla descrizione del metodo di divisione anonimo
quello che leggiamo nel Vat gr 1594 (questrsquoultimo coincide con quello adottato nella recen-sione bizantina) fu apposto da Niceforo Gregora e successivamente corretto da Bessarione
48 Sto studiando il primo e il terzo codice in collaborazione rispettivamente con Daniele Bianconi e Inmaculada Peacuterez Martiacuten
49 Su questo codice risalente alla seconda metagrave del IX secolo e sulla sua collocazione nella lsquocollezione filosoficarsquo per prima proposta in Follieri 1977 pp 145-146 si vedano almeno Perria 1991 pp 82-88 Ronconi 2013 Che il titolo dei Prolegomena nel Vat gr 1594 sia stato apposto da Niceforo Gregora egrave stato riconosciuto per la prima volta in Mazzucchi 1994 p 211 n 196 si veda Bianconi 2005a p 418 per altri interventi di Gregora nello stesso manoscritto
50 Il Vat gr 198 egrave stato vergato dal copista Malachia nel corso del terzo quarto del XIV secolo Mondrain 2004 pp 278-290 e 292 Allo stesso copista (denominato non a caso prima dellrsquoidentificazione anonymus Aristotelicus) dobbiamo un buon numero di trascrizioni aristoteliche con i relativi commentari in margine Gli dobbiamo anche il Par gr 2342 secondo tomo di un quadrivium quasi completo di cui il Vat gr 198 egrave il primo nellrsquoordine aritmetica armonica astronomia (Almagesto e commentari relativi) nel codice vaticano geometria ed ancora astronomia (corpus astronomico minore) in quello parigino le opere trascritte sono sempre accompagnate in margine dai relativi commentari Il copista del Marc gr 310 egrave Isacco Argiro (ca 1300-1375) Mondrain 2007 p 166 Allo stesso Argiro dobbiamo il codice laurenziano (Daniele Bianconi per litteras) Poicheacute la recensione modificata che leggiamo nel Laur Plut 89 sup 48 egrave senza alcun dubbio basata su quella nel Marc gr 310 e non viceversa ci troviamo di fronte ad un copista che trascrive due volte lo stesso testo in due versioni leggermente differenti la conclusione naturale egrave che la seconda recensione egrave dovuta ad Argiro stesso la questione andragrave studiata in dettaglio
51 Nei manoscritti citati i Prolegomena si trovano ai fogli seguenti Vat gr 1594 ff 1r-8v (mutilo mancano due fascicoli su tre) Marc gr 313 ff 1r-28r (incompleto man-cano due fogli allrsquoinizio e il f 6 attualmente rimpiazzato da uno bianco) Marc gr 314 ff 235r-255r Vat gr 2326 ff 19r-40v e 43r-v (incompleto e con i fascicoli in disordine) Vat gr 184 ff 10r-23v Par gr 2390 ff 1r-13v Vat gr 198 ff 127r-136v Marc gr 310 ff 1r-13r Laur Plut 89 sup 48 ff 7r-19r
Fabio Acerbi142
ἐκθέμενοι οὖν διάγραμμα τῶν ἀριθμῶν ὡς ὑπόκειται προτάσσομεν τὸν μεριζόμενον καὶ μικρὸν ὑπ᾽ αὐτὸν τὸν μερίζοντα ὡς ἔχει τὸ διάγραμμα ἐν στίχοις διοριζομένοις ὑπὸ γραμμῶν [hellip] καὶ τὰ μὲν γινόμενα ἐγγὺς ἐλάττονα ἐν τῇ μεταξὺ θέσει τοῦ μεριζομένου καὶ τοῦ μερίζοντος ἐν στίχοις παρασημειοῦσθαι πρὸς τὸ ἀσύγχυτον εἶναι τὴν τάξιν τὰ δὲ μεθ᾿ ὧν ὁ μερίζων ἐποίει τοὺς ἀεὶ ἐλάσσονας ὑπὸ τὸν μερίζοντα σημειοῦσθαι προγράφοντας ἐπὶ τοῦ στίχου αὐτῶν τὸ γίνεται οὕτως γι ἐν δὲ τῷ στίχῳ τῶν μεριζόντων τὸ παρὰ ἔχον οὕτως oslash ἀντὶ τοῦ παρ᾿ ἃ δεῖ τὸν μερισμὸν γίνεσθαι ἐν δὲ τῷ στίχῳ τῶν ἐλασσόνων τὸ αφ διὰ τὸ τούτους ἀεὶ ἀφαιρεῖσθαι ἀπὸ τῶν ἐπάνω τῶν μεριζομένων ἐν δὲ τοῖς τοῦ μεριζομένου λοιπάσμασι τοῖς καὶ ἐπιοφείλουσι τὸ λ κατὰ τὸ ἴδιον τῶν διαστάσεων ἑκάστης ndash λέγω δὴ λοιπάδος ndash ἀντὶ τοῦ λοιποὶ οἱ μέλλοντες ἐπιμερίζεσθαι
2 post τὸν suprascr τὸν ἐλάττονα m 2 S 5 πρὸς] MP et ex corr Z κατὰ S om C | ἀσύγχυτον] MSPC -χητον Z 6 ἀεὶ] MZPC ὡσεὶ S 7 γίνεται οὕτως γι ] γι τ οὕτως γι τ M γί οὕτως γί Z γι οὕτως γί SC τὸ γινόμενον οὕτως γίνεται P 8 τὸ παρὰ ἔχον οὕτως] scripsi τὸ παρέχον οὕτως M et π(αρ-) comp Z οὕτως τὸ περιέχον S προγράφοντας οὕτως ex corr m 2 P τὸ περιέχον οὕτως C | oslash] MZSC (sed ο fecit | Z) ἐλάττων comp ex corr m 2 P | παρ᾿ ἃ] scripsi παρα M π(αρα) comp ZSC ex παρα fe-cit παρὰ et τοῦτον suprascr m 2 P 9 γίνεσθαι] comp C | αφ ] αφ ε M ἀφ ZSC ἀφαί P | ἀεὶ] om M 11 ἐπιοφείλουσι] MZSC ex ἐπιο- fecit ἐπο- m 2 P | λ] MZPC λ´ S 12 λοιποὶ] PC λοιποῦ MZS
3 στίχοις] στίχῳ K 5 πρὸς] διὰ K 7 ἐπὶ mdash γι ] τὸ γίνεται διὰ τοιούτου σ(ημείου) γί K 8 τὸ παρὰ ἔχον mdash παρ᾿ ἃ] τὸ παρᾱ διὰ σ(ημείου) τοιούτου καὶ τοῦτο oslash δηλοῦντος τοῦ παρᾱ ὅτι παρὰ τὸν τοιοῦτον (ἀριθμὸν) K 9 αφ διὰ τὸ τούτους] ἀφ δηλοῖ δὲ τοῦτο ἀφαίρεσ(ιν) ὅτι τούτους ἀεὶ δεῖ K 11 ἐπιοφείλουσι] ἐπιμερίζεσθαι ὀφείλουσι K | λ] λ οι` K 12 ἀντὶ τοῦ] δηλοῦντος τοῦ σ(ημείου) τὸ K
lsquoRendendo esplicito un diagramma numerico come lo troviamo qui sotto disponiamo in primo luogo il dividendo e un poco al di sotto di esso il divisore come li ha il diagramma in righe delimitate da linee [hellip] e lsaquooccorreragraversaquo nella posizione tra il dividendo e il divisore annotare lrsquouno accanto allrsquoaltro i piugrave vicini lsaquodei numerirsaquo minori che risultano affincheacute la disposizione non sia confusa quelli con cui il divisore faceva ogni volta i lsaquonumerirsaquo minori annotarli sotto il divisore scrivendo in prima posizione sulla loro riga laquorisultaraquo cosigrave Ris nella riga dei diviso-ri52 invece laquoperraquo fatto cosigrave53 P in luogo di laquoquelli per cui deve farsi la divisioneraquo nella riga dei lsaquonumerirsaquo minori laquosottrraquo in quanto questi sono sempre sottratti dai dividendi che si trovano sopra nei residuli del dividendo (occorre ben farlo anche per loro) laquoReraquo in accordo con ciograve
52 I laquodivisoriraquo sono al plurale ma siamo semplicemente di fronte a un tratto idioma-tico della lingua greca nel caso di espressioni generalizzanti crsquoegrave soltanto un divisore che occupa lrsquounica colonna di cui si compone la sua riga
53 Si intenda ἔχον οὕτως = ita se habens
1
5
10
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 143
che egrave proprio agli scarti di ciascuno ndash intendo qui lsaquociascunrsaquo residuo54 ndash in luogo di laquoresti che vanno a essere divisi ulteriormenteraquorsquo
a) Operatori di citazione e segni convenzionali I segni introdotti sono quattro la mia discussione egrave condotta dando per scontato che essi siano identici a quelli impiegati dallrsquoautore dei Prolegomena anche se si tratta di unrsquoipotesi non corroborabile neacute falsificabile
i Segno per il risultato Lrsquoabbreviazione convenzionale per γίνεται egrave identica al segno introdotto dallrsquoautore e i copisti si dividono tra i due errori possibili scrivere due abbreviazioni o risolverle entrambe Un fenomeno del tutto analogo si riscontra nel Matr 4678 il manoscritto alla base di tutta la tradizione degli Arithmetica di Diofanto al momen-to della definizione dellrsquoἀριθμός (lrsquolsquoincognitarsquo nel nostro linguaggio) ὁ δὲ μηδὲν τούτων τῶν ἰδιωμάτων κτησάμενος ἔχων δὲ ἐν ἑαυτῷ πλῆθος μονάδων ἄλογος ςο` καλεῖται ς` ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον τὸ ς` laquoil lsaquonumerorsaquo che non possiede nessuna di queste proprietagrave ma che ha in seacute una molteplicitagrave indefinita di unitagrave egrave chiamato lsquonumerorsquo e il suo segno egrave ς`raquo Qui solo il terzo dei tre ς ha una barra a sormontare per segnalarne il carattere puramente denotativo (cioegrave di segno convenzionale e non di abbreviazione si veda il punto successivo)55 il primo egrave una delle abbreviazioni piugrave diffuse per ἀριθμός (e infatti egrave dotato del compendio per la desinenza e dellrsquoaccento grave) il secondo egrave una delle piugrave comu-ni per καὶ () Giovanni Cortasmeno autore di capillari annotazioni infra lineam agli Arithmetica nel codice madrileno scioglie il primo ςο`
54 Doppia variatio che impiega al posto di λοιπόν laquorestoraquo i due termini decisamente non canonici τὸ λοίπασμα e ἡ λοιπάς (piugrave oltre leggiamo anche il participio λοιπασθέντα) Una ricerca sul TLG in rete non ha fornito occorrenze del primo si tratta dunque di uno hapax Quanto al secondo che ricorre anche nella sezione sulla divisione lsquoalla Papporsquo lo si rintraccia giagrave nei papiri documentari il termine diventeragrave perograve canonico nelle esposizioni bizantine drsquointroduzione allrsquoAlmagesto ricalcate sul modello dei Prolegomena (si veda la nota 87 infra) Questi due termini designano i resti parziali prodotti nel corso di una divisione lunga li ho tradotti rispettivamente con il neologismo laquoresiduloraquo e con il sostantivo pari-menti non canonico laquoresiduoraquo
55 Il copista interpreta erroneamente il terzo segno come unrsquoabbreviazione e qui ag-giunge un apice inverso (cioegrave un accento grave) altrove lo scioglie direttamente in forme opportune di ἀριθμός Matr 4678 f 58v La frase come la leggiamo nel manoscritto egrave cor-rotta sulla base di una parafrasi in Psello (edita in DOO II p 3710-12) Tannery emendograve ἄλογος in ἀόριστον DOO I p 64-5 et app Il Matritensis vergato da due copisti differenti (cambio di mano a tre righe dalla fine del f 62r) contiene lrsquoIntroductio arithmetica di Nicomaco e le opere diofantee oltre ad alcuni brevi opuscoli musicali la sua data egrave stata recentemente corretta dal XIII al secolo XI pm in Peacuterez Martiacuten 2006 (una riproduzione digitale del manoscritto si trova allrsquoindirizzo httpbdhbneesbnesearchbibliotecaDio-fanto20de20AlejandrC3ADa)
Fabio Acerbi144
in ἀριθμός ed aggiunge un altro segno56 sopra il terzo anteponendovi lrsquoindicazione καὶ ἔστιν αὐτοῦ σ(ημεῖον) τόδε Va da seacute che non abbiamo nessuna garanzia che il segno originariamente introdotto da Diofanto coincidesse realmente con unrsquoabbreviazione convenzionale per ἀριθμός Lrsquoevidenza del PMich III 144 (sec II in) suggerisce drsquoaltronde che il Matritensis e con esso tutta la tradizione medievale di Diofanto ripro-duca fedelmente pur accentuandone la sinuositagrave il segno originario
ii Segno per il divisore Un cerchiolino sbarrato da non confondere con il segno per ὁμοῦ che nei manoscritti matematici ha di norma due barre trasversali (cf tav 2a) Non sono riuscito a rintracciarne ulteriori occorrenze in altre opere la forma che esso assume nel Vat gr 2326 e la correzione apportata nel Par gr 2390 lasciano aperta la possibilitagrave per quanto a mio avviso remota che la forma originaria non fosse lon-tana da unrsquoabbreviazione di παρά registrata nei repertori57 Il correttore del Par gr 2390 trasforma in effetti il segno oslash nellrsquoaffine abbreviazione canonica per (forme di) ἐλάσσων laquominoreraquo58 e si incarica diligente-mente di farlo notare ricapitolando i segni nella porzione superiore del margine esterno del f 7v Nello stesso margine egli traccia anche uno lsquoscolio tabellarersquo ed egrave lrsquounico a porre il (proprio) segno dove indicato dalla descrizione (tav 6 Par gr 2390 f 7v) Oltre a ciograve adattando la tabella al margine ristretto lo scoliaste trascrive come colonne affian-cate le due righe dei resti parziali e dei massimi multipli e aggiunge le indicazioni ὁ μεριζόμενος laquodividendoraquo e ὁ μερίζων laquodivisoreraquo ma vi introduce alcune incongruenze di formato il risultato scritto in verti-cale e la linea verticale di sinistra che separa il divisore dal segno che lo dovrebbe precedere direttamente
iii Segno per i massimi multipli Corrisponde alla semplice abbre-viazione per sospensione della forma verbale ἄφελε laquosottrairaquo in questo
56 Si tratta del segno di ampio uso praticamente identico allrsquoabbreviazione canonica per οὖν
57 Si tratta di un pi a forma di gancio sbarrato da uno slash di troncamento Ce-reteli 1904 tav IX item 7 sub ΠΑΡΑ che rinvia al PVindRain 423 cf anche la forma π` nel POxy LXI 4142 edito in Jones 1999 II pp 26-34 In generale nei papiri e nei manoscritti matematici in maiuscola le preposizioni sono abbreviate facendo seguire un lsquoapostroforsquo alla loro prima lettera Α᾽ Υ᾽ ecc Per la seconda fattispecie di supporto libra-rio si veda in particolare il cosiddetto fragmentum mathematicum Bobiense scriptio inferior databile al V-VI secolo del palinsesto Milano Biblioteca Ambrosiana L 99 sup (Isidoro di Siviglia Etymologiae datazione Cavallo 1977 p 100) pp 113-114 che sono stampate in riproduzione apografa conforme in Belger 1881 (la p 114 egrave riprodotta anche nella tav 10 di Acerbi 2010)
58 Se questa era lrsquointenzione si tratta ovviamente di una forzatura il divisore puograve ben essere maggiore del dividendo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 145
caso lo slash di troncamento taglia orizzontalmente il tratto verticale del phi I copisti offrono molteplici varianti apponendo chi uno spirito dolce chi un ε chi un αί accentato a sormontare Tutti questi segni svolgono la funzione di abbreviazioni vere e proprie (e cosigrave doveva essere anche per lrsquoautore si veda il punto 1 di p 153 infra) la forma originale si ottiene a mio avviso incrociando i dati del Marc gr 313 e dei tre apografi del Vat gr 1594 αφ anche se lrsquoassenza dello spirito potrebbe essere semplicemente dovuta alla pratica del copista del codice veneziano di economizzare nei diacritici
iv Segno per i resti Un lambda completato da una barra a sormon-tare o da un apice che rinvia alle abbreviazioni per sospensione di una forma opportuna di λοιπός laquorestoraquo In realtagrave la forma che troviamo nella tabella egrave differente (tav 2b) e coincide con quella offerta quasi unanimemente dai manoscritti nella descrizione e in almeno un caso nella tabella del metodo di divisione attribuito a Pappo (tav 4) un lambda che accoglie al di sotto una legatura omicron-iota () sbarrata da uno slash di troncamento Qualcosa di simile si trova nel PVindob G 19996 (sec I) una specie di lambda maiuscolo molto aperto e dal vertice arrotondato che include un circoletto interpretato dagli editori come segno per περίεστιν o per λοιπόν59 Lo stesso segno si rintraccia ad esempio in un medesimo scolio tabellare di prima mano ad Alma-gestum nel Vat gr 1594 f 93v e nel Marc gr 313 f 135r ma stavolta la forma del lambda egrave molto ben definita
Fin qui i segni Ma il gioco egrave piugrave complesso La descrizione si muo-ve pericolosamente sulla linea di confine non sempre ben definita tra segno convenzionale e abbreviazione il primo ndash e il repertorio grafico matematico-astronomico ne egrave particolarmente fornito60 ndash puograve anche
59 Ho consultato lrsquoedizione Gerstinger ndash Vogel 1932 pp 46 e 48 la porzione rilevante del papiro egrave riprodotta nella tav 11 di Fowler 1999 Si veda ancora ivi pp 253-257 per la trascrizione di questo segmento di testo (con correzioni rispetto alla princeps) e per una messa a punto recente inclusa la proposta di datazione che ho riportato qui sopra Il verso del papiro che contiene una tavola aritmetica del tutto scorrelata dalla tematica del recto egrave edito come PRain Unterricht 151
60 La pratica di ridurre lo spazio occupato da un testo tecnico per mezzo di abbreviazioni e segni convenzionali era molto diffusa nei manoscritti in maiuscola contrariamente a quanto avviene per altri generi letterari vedremo tra breve cosa accade negli Arithmetica di Diofanto ma si leggano in proposito anche le considerazioni di Hei-berg nei prolegomena alla propria edizione dellrsquoAlmagesto in particolare riguardo al ricorso massiccio ad espedienti brachigrafici nel modello del Vat gr 180 POO II pp lxxxiv-xciii civ-cv cxxvii cxxxviii-cxxxix Agli elenchi dettagliati forniti da Heiberg possiamo aggiungere il piccolo prontuario stampato in Hultsch 1876-1878 III 2 pp 126-132 e basato sul testo e sugli scolii alla Collectio di Pappo nel Vat gr 218 (sec X in) Si vedano infine le osservazioni del copista del Par gr 2360 f 120v trascritte da Heiberg in AOO III pp x-xi sulle laquonotazioni tipiche a scopo di tagliar corto nello scrivereraquo impiegate nel pro-
Fabio Acerbi146
derivare dalla seconda (un caso egrave appunto il segno per ἐλάσσων che probabilmente trae origine da una legatura epsilon-lambda) ma poi il rapporto referente-relato si fissa convenzionalmente Quelli definiti nel testo che abbiamo letto sono appunto segni convenzionali non ci sarebbe bisogno di spiegarne forma e funzione se fossero intesi come abbreviazioni assumono nella tabella una funzione denotativa non esplicativa o discorsiva (come accade invece nella tav 1a) Ma come vengono descritti questi segni
I referenti delle descrizioni sono i segni sono introdotti da οὕτως (item i-ii) o in alternativa da un τό con il ruolo di lsquooperatore di citazionersquo (item iii-iv) che corrisponde esattamente alle nostre virgolette In entram-bi i casi gli enti sono menzionati e svolgono una funzione metalinguistica sono collocati materialmente nel testo ma egrave come se si trovassero fuori e la loro descrizione li additasse ndash in effetti i segni convenzionali scritti nel testo sono a loro volta i relata di quelli che si trovano nella tabella
I relata dei segni scritti nel testo sono di due tipi singoli vocaboli (item i-ii) o descrizioni della funzione dei segni per mezzo di clausole sintaticamente complesse (item ii e iv) I singoli vocaboli sono γίνεται e παρά e sono entrambi preceduti dal τό lsquocitazionalersquo in quanto relata di segni convenzionali le forme abbreviate con cui sono tracciati nei manoscritti vanno forzatamente sciolte Bisogna ammettere che la per-spicacia e le risorse grafiche dei copisti ndash di cui tutto si puograve dire fuor che commettano qui degli errori ndash sono messe a dura prova con lrsquointrodurre segni identici ad abbreviazioni o con lrsquoattivare un gioco metalinguistico particolarmente serrato in un contesto meno lsquonaturalersquo di come potreb-be esserlo ad esempio quello di un trattato grammaticale Lrsquoitem iii che presenta direttamente un segno identico ad unrsquoabbreviazione non egrave sorretto da una descrizione ma da una giustificazione in διὰ τό Lrsquoartico-lo τό vi assume una funzione metalinguistica anche se non lsquocitazionalersquo poicheacute al tempo stesso genera un infinito sostantivato e lo singolarizza per questo ho scritto laquosono sottrattiraquo in corsivo nella mia traduzione
prio modello archimedeo (nota 32 supra) egli ne compila anche una breve lista Un elenco antico di laquosegni della geometriaraquo sicuramente redatto per assistere il copista si trova anche al f 3v del ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 vergato da Efrem negli anni 950-960 (tav 8 in Acerbi 2010) Possiamo farci unrsquoidea quantitativa del guadagno di spazio in rapporto ad un testo privo di abbreviazioni e con le parole separate da spazi sulla base del fragmentum mathematicum Bobiense il testo vi egrave disposto a tutta pagina su 36 righe di circa 30 segni ciascuna nelle due pagine in questione figurano 2038 segni con 15 mezze righe occupate dalle due figure Ora nel testo dellrsquoedizione stabilita in Heiberg 1927 pp 87-90 le stesse pagine contano 4455 segni spazi compresi Ne risulta che la dimensione in caratteri di un testo matematico puograve essere ridotta di piugrave della metagrave con lrsquoimpiego di compendi e segni convenzionali
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 147
Negli item ii e iv il segno si collega ad una descrizione nel secondo caso in via esclusiva le descrizioni pertanto rinforzano o sostituiscono lrsquoidentificazione con lrsquoente linguistico denotato Le clausole descrittive sono precedute da ἀντί e dallrsquoarticolo τό con funzione di lsquooperatore di citazionersquo esse sono παρ᾿ ἃ δεῖ τὸν μερισμὸν γίνεσθαι (item ii) e λοιποὶ οἱ μέλλοντες ἐπιμερίζεσθαι (item iv) Nella descrizione della divisione lsquoalla Papporsquo che leggeremo tra breve i segni negli item iii e iv rice-vono lo stesso trattamento degli altri due il loro relatum egrave un singolo vocabolo e non una clausola descrittiva rispettivamente nelle espres-sioni τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε (sul participio ritorneremo nel punto 1 infra) e τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά (la forma del segno notato con λ οι egrave descritta supra nellrsquoitem iv) La descrizione del segno oslash per il divisore merita una discussione piugrave dettagliata In origine si trovava probabilmente scritto Π(ΑΡΑ)ΕΧΟΝ successivamente letto come π(αρ[α])έχον ndash dato che lrsquoabbreviazione per il preverbo egrave identica a quella per la preposizione (che sia Π᾽ o un pi seguito dal segno per ἄρα a sormontare) ndash invece di π(αρὰ) ἔχον I copisti e i correttori si dettero a tutte le possibili contorsioni per restituire un testo dotato di senso leggere appunto una forma verbale con preverbo modificare il preverbo (ma forse il segno per ἄρα era insidiosamente simile ad uno epsilon) correggere il testo rileggiamo lrsquoapparato sub τὸ παρὰ ἔχον οὕτως τὸ παρέχον οὕτως M et π(αρ-) comp Z οὕτως τὸ περιέχον S τὸ περιέχον οὕτως C προγράφοντας οὕτως ex corr m 2 P Nella clausola descrittiva seguente la presenza liminare di παρὰ (che ho corretto in παρ᾿ ἃ nella speranza di restituire una frase che abbia un senso senza intervenire sul testo) innesca un bel corto circuito il Π(ΑΡΑ) che sicuramente figu-rava nellrsquoarchetipo egrave un sintagma complesso una preposizione unrsquoab-breviazione o un segno per unrsquoabbreviazione Se lrsquoeditore si trova in conflitto con la propria inclinazione alla critica conservativa i copisti si rifiutarono di mettere mano ad un testo che doveva stridere anche per loro essendo il compito demandato al ritocco del revisore del Par gr 2390 o alla riscrittura radicale del recensore bizantino Il problema egrave che ci troviamo di fronte ad unrsquoespressione che descrive la funzione dellrsquooggetto denotato non lrsquooggetto stesso ma che lo contiene al suo interno per soprammercato qui il Π(ΑΡΑ) egrave usato per giustificare una menzione a sua volta relatum di un segno
Evidentemente questa maniera di procedere che giagrave aveva attirato interventi da parte di copisti e correttori della recensione di base parve insostenibilmente opaca allrsquoautore della recensione bizantina61 Egli
61 Uno dei manoscritti di questa recensione propone anche una tabella di divisione
Fabio Acerbi148
modifica tutte le descrizioni diluendo lrsquoidiomatismo dellrsquoarticolo lsquocita-zionalersquo con lrsquointroduzione sistematica del verbo δηλόω e di frasi atte a chiarire quale sia il segno denotante e quale il vocabolo (o il segno) denotato Egli introduce allo scopo di rendere esplicita la funzione de-notativa dei segni introdotti il termine σημείου curiosamente in tutte le sue tre occorrenze esso compare a sua volta nella forma dellrsquoabbrevia-zione per sospensione σΗ´ Egli traccia il segno per i massimi multipli ἀφ e quello per i resti λ οι` in modo che non vi siano ambiguitagrave quanto al loro carattere di abbreviazione Si faccia infine attenzione al residuo di barra sul παρᾱ con funzione denotativa (2 occorrenze) contenuto nella descrizione del segno per il divisore sostituita dallrsquoaccento grave nel παρὰ con funzione discorsiva (la differenza egrave nettissima nei manoscritti da me consultati) Questa osservazione ci permette di passare direttamente allrsquoitem seguente
b) Le barre sui numerali e sulle lettere denotative Egrave opportuno discutere questo punto adesso esattamente percheacute di barre siffatte che pure troviamo in tutti i manoscritti i nostri testi non fanno mai menzione si tratta infatti di una pratica condivisa sin dallrsquoantichitagrave La barra identifica una stringa di lettere dellrsquoalfabeto che non svolge una funzione grammaticale o sintattica propria allrsquointerno del discorso Ciograve avviene in particolare e si tratta della fattispecie piugrave frequente se la stringa di lettere non dagrave origine a un vocabolo della lingua greca lette-re denotative e numerali certo ma anche termini provenienti da altri idiomi e contrazioni di parole greche come i nomina sacra62 tali termi-ni possono essere o no preceduti da un articolo lsquocitazionalersquo a seconda dellrsquouso che ne viene fatto allrsquointerno del discorso Ma non si tratta dellrsquounica fattispecie i papiri grammaticali ed i manoscritti piugrave antichi dei trattati dello stesso argomento segnalano gli esempi delle parti del discorso (cioegrave di lsquoverersquo parole greche) per mezzo di barre sormontanti63 La differenza insomma egrave tra menzione e uso (come parte del discorso in atto) di una stringa di caratteri tra il porre le lsquovirgolettersquo e il non porle tra funzione denotativa e non Apparentemente la convenzione si limi-
corredata dei segni opportuni e contrariamente alle indicazioni della descrizione svilup-pata lsquoin verticalersquo ma per motivi misteriosi non completa (tav 7a Laur Plut 89 sup 48 f 13r)
62 Tutto ciograve egrave spiegato con estrema chiarezza giagrave in Traube 1907 pp 45-4763 Si veda il Par gr 2548 codex vetustissimus e testimone unico delle lsquoopere minorirsquo
di Apollonio Discolo il f 106v con le barre ben visibili egrave riprodotto come tav 19 in De Gregorio 2000 (ivi pp 137-138 per la datazione) Per la testimonianza dei papiri grammaticali si veda Wouters 1979 passim essi contengono di norma elenchi di parti del discorso nessuna delle quali egrave preceduta dallrsquoarticolo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 149
tava in questo secondo caso a segnalare con la barra singoli vocaboli le menzioni di frasi o di sintagmi complessi sono di norma identificate dallrsquoarticolo lsquocitazionalersquo Drsquoaltra parte le abbreviazioni convenzionali non rientrano nella casistica percheacute la loro resa grafica che contiene elementi non alfabetici come compendi per desinenze lettere supra li-neam marche di contrazione o sospensione quali slashes o barre sotto-poste o sormontanti eventualmente solo un sottinsieme della stringa di segni alfabetici le esclude automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
Venendo al discorso matematico una barra sormonta senza ecce-zione le lettere denotative64 che sia in papiri o in manoscritti in maiu-scola65 o minuscola ma solo allrsquointerno del testo comrsquoegrave da attendersi nei diagrammi esse la perdono per il semplice motivo che non crsquoegrave alcun testo ambiente un diagramma ha unicamente una funzione denotati-va Drsquoaltra parte le lettere numerali che a volte figurano nei diagrammi della tradizione metrica66 allo scopo di indicare la lunghezza dei seg-menti mantengono la barra in un diagramma il contesto denotativo geometrico egrave prevalente e i numerali vengono percepiti come entitagrave grafiche lsquoesternersquo al discorso Va da seacute a fortiori che le lettere numerali inserite in un testo dovranno essere segnalate da barre che a loro volta non servono nelle tavole67 in quanto queste ultime sono come abbiamo visto un vero e proprio testo che perograve funge da ambiente a quello al-fabetico limitato alle titolazioni e non a caso tracciato in unrsquoopportuna lsquomaiuscola distintivarsquo allo scopo di segnalarne il carattere denotativo e non discorsivo68 Una tabella operazionale egrave invece un paratesto e quindi le barre sulle lettere numerali che rappresentano gli interi sono
64 La notazione per le lettere denotative subigrave unrsquoevoluzione (il cui risultato finale egrave descritto per sommi capi nella nota 3 supra) di cui non mette conto occuparsi qui
65 I papiri di contenuto geometrico (o astronomici ma che presentano argomenti geometrici) sono rari si vedano il PHerc 1061 (sec II aC Demetrio Lacone De geome-tria) e il PFay 9 (sec II ex Elementi I 39 e 41) Gli importanti ostraka OBerl 12002 e 12609 (sec III aC m Elementi XIII) non pongono le barre sopra le lettere denotative Per i manoscritti in maiuscola si veda ad esempio passim nel Par gr 2389 una cui riproduzione digitale egrave consultabile in rete allrsquoindirizzo httpgallicabnffrark12148btv1b8470171d o il fragmentum mathematicum Bobiense
66 Si veda ancora il ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 codex unicus dei Metrica di Erone e contenente una raccolta importante di problemi del corpus metrologico
67 Si vedano come esempio le tavole citate alle note 10 e 14 supra Discorso a parte per il segno di lsquoposto vuotorsquo si veda il punto c che segue
68 Queste regole generali vanno prese cum grano salis si dagrave naturalmente un certo dominio di variabilitagrave legato verosimilmente al grado di cultura grafica del copista nel PMich III 144 i numerali sono quasi tutti senza barra sia nel testo che nelle tabelle ope-razionali
Fabio Acerbi150
necessarie esse mancano invece sui segni convenzionali che ho descrit-to nel punto precedente e fatto rilevante sulle lettere numerali relative agli ordini sessagesimali quando esse siano identificate da uno o piugrave apici la presenza di questo segno grafico non alfabetico69 le esclude ancora una volta automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo Unrsquoultima osservazione che ci saragrave utile nel seacuteguito la descrizio-ne di una stringa di lettere lsquoagrammaticalersquo non puograve prevedere la men-zione della presenza della barra che le pertiene in quanto tale si tratta di una pratica denotativa che egrave possibile formulare soltanto ad un livello di discorso superiore sia a quello dellrsquouso che a quello della menzione70
c) Il segno di lsquoposto vuotorsquo Si noti nella tav 2b la forma ŏ per il segno di lsquoposto vuotorsquo in un ordine sessagesimale coerentemente con la propria notazione il copista del Marc gr 313 lo scioglie talvolta allrsquoin-terno del testo principale come unrsquoabbreviazione per οὐδέν laquonienteraquo Altre convenzioni di scrittura del tratto che accompagna il circoletto e che si badi bene fa parte integrante del segno di lsquoposto vuotorsquo ndash e infatti nelle tavole troviamo sempre il segno completo mentre tutti gli altri numerali sono come abbiamo visto nel punto precedente privi di barra o di apice a causa del fatto che i vari ordini sessagesimali sono univocamente determinati dalle linee di giustificazione ndash un tratto an-golare anteposto (tav 3 Lar Plut 2818 f 136v)71 o una semplice barra a sormontare (tavv 4-9) si produce in questo modo il segno 65926 che sembra essere stata la forma di base72
69 Occorre dunque supporre come testimoniano papiri e manoscritti in maiuscola che la convenzione relativa allrsquouso della barra si sia consolidata ben prima dellrsquointroduzione di segni diacritici quali accenti e spiriti
70 Si veda il punto 2 infra per maggiori dettagli sulla questione delle barre e degli apici e per le indicazioni in merito che leggiamo in Diofanto
71 Come accennato questa tavola dei sottomultipli coincide con quella descritta ed esposta nei Prolegomena Fatto molto rilevante i numerali nella prima non recano neacute barre neacute apici contrariamente a quanto accade a tutte le istanze della seconda nei manoscritti Quella del Laur Plut 2818 preserva a mio avviso la forma originaria come abbiamo visto una tavola non richiede segni aggiuntivi sulle lettere numerali
72 Si vedano come esempio ancora le tavole citate alle note 10 e 14 supra oppure per una rassegna delle forme che il segno assume nei manoscritti piugrave antichi delle Tavole facili Tihon 2011 pp 58-59 e per quelle che assume nei papiri Jones 1999 I pp 61-62 Ovviamente non possiamo leggere il segno 65926 come un omicron con una barra in quanto ο = 70 nella notazione greca e la barra egrave di rigore quando il numerale figuri allrsquointerno di un testo Occorre ammettere che si dagrave origine ad un bel corto circuito notazionale con il concepire un segno con funzione di lsquoposto vuotorsquo ma che lsquosomigliarsquo ad una lettera dellrsquoalfabeto sormontata da una barra cioegrave ad un numerale in piugrave quando il lsquoposto vuotorsquo non corrisponda ad un intero ma ad una specie sessagesimale la presenza della barra a priori indistinguibile da quella che sormonta gli interi introduce unrsquoincongruenza con la notazione a mezzo di apici vista nellrsquoitem precedente
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 151
d) Errori di copia La tabella riprodotta nella tav 2b ha una forma simmetrica ma si tratta di una forzatura il grande rettangolo in basso a destra drsquoaltronde assente nella descrizione contiene uno scolio che fa notare come lrsquoultimo resto parziale ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ͵γτνζ´´´´´ κζ´´´´´´ cioegrave 0 0 0 0 0 3357 27 siano ἔγγιστα λ´λ´ δ´δ´ ξ laquocon ottima approssimazione 60 minuti quartiraquo dove si notino gli apici semplici per indicare il pas-saggio allrsquoordinale e il raddoppiamento del sistema segno + apice per significare il plurale Lo scolio debitamente accompagnato dal segno di rimando in forma di simbolo solare egrave stato probabilmente incluso nella tabella proprio allo scopo di renderla simmetrica A sua volta un errore precedente spiega lo spazio eccessivo accordato al rettangolo contenente lo scolio il secondo massimo multiplo ŏ λβ´ ξδ´´ ριβ´´´ σιϛ´´´´ egrave trascritto anche al di sotto del risultato
Passiamo ora alla descrizione del metodo di divisione attribuito a Pappo
ἵνα οὖν ταῦτα συναχθῇ τὰ ἐκ τοῦ μερισμοῦ ὁ εἰρημένος Πάππος εὐδιατύπῳ τινὶ καὶ πρὸς τοῦτο τάξει χρησάμενος ποιεῖται τὴν τῆς συλλήψεως τοῦ ζητουμένου ἀνεύρεσιν οὕτως ἐκθέμενος γὰρ τὸν μέλλοντα μερίζεσθαι τουτέστι τὰς τξ μοίρας ἐν ἀρχῇ ἀφαιρεῖ ἀπ᾽ αὐτῶν τὸν ἐν τῇ σελίδι τυγχάνοντα ἐλάττονα τουτέστι τὸν τδ κβ´ κ´´ ὄντα τῶν ἐγγὺς ἐλασσόνων ὡς πρὸς τοὺς ἐκκειμένους διὸ καὶ γράφει αὐτὸν προγράφων αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε καὶ εὑρίσκων τὰ παρακείμενα αὐτῷ τῷ ἀπογραφέντι ἐν τῷ σελιδίῳ λεπτὰ πρῶτα ν´ συναπογράφεται παρατιθῶν αὐτοῖς τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον ἀνατείνουσαν σημαῖνον τὸ εἶδος ὅτι πρῶτα λεπτά εὑρίσκει οὖν οὕτως τὸ τῶν τξ μέρος τὸ τδ κβ´ κ´´ ὃ μεριζόμενον παρὰ τὰς τξε ιδ´ μη´´ ἡμέρας καὶ ποιοῦν τὸν ἐκ τοῦ μερισμοῦ ἀριθμὸν πρῶτα λεπτὰ ν´ καὶ τὸν λοιπὸν ἀπογραφόμενος τὸν νε λζ´ μ´´ προτάσσει αὐτοῦ τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά τάσσει δὲ καὶ ἁπλῆν τινα διατείνουσαν γραμμὴν ὡς ἀπὸ τοῦ τξ ἐπὶ τὸν ἑξῆς ἐκτεθειμένον ἐγγὺς
1
5
10
1 εὐδιατύπῳ] ZSPC εὐδιατύπωτ M 4 ἀφαιρεῖ] MZSP ἀφ ι C 5 ἐλάττονα] P comp MZSC 6 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | αφ ] αφ ε M ἀφ ZS ἀφαί P ἄφ C | ἀντὶ] om C | ἄφελε] MZSP ἄφ C 8 ἀπογραφέντι] MZSP ἐγγραφέντι C | λεπτὰ πρῶτα] P λε πρωτα SC λεπτῶν πρωτ MZ | παρατιθῶν] MZS παρατιθεὶς C et ex corr m 2 P 9 ᾱ] Z αο P α´ MS α C | ἔχον] MPC ἔχων ZS 9-10 πρῶτα λεπτά] ZP πρωτ λ´λ´ M πρωτα λε S αα λε C 11 ἡμέρας] comp codd | ἀριθμὸν] P et comp MZ καὶ C et comp S 12 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M πρωτ λεπτ(α) Z πρωτ λ εᾱ S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C | ἀπογραφόμενος] MZSP ἐγγραφόμενος C | νε λζ´] MZSP λζ νζ C 13 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | λ οι] MZSC ex λ fecit λ οι P | προσσημαῖνον] MC et προσ- comp ZS προση- P | τὸ] MZC τὰ S et fecit m 2 P 14 ἀπὸ] MZSP πρὸς C ἐλάττονα] P comp MZSC
1 εὐδιατύπῳ] εὐδιατυπώτω K 6-7 αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ] τὸ ἀφ K 8 παρατιθῶν mdash 10 λεπτά] τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ σημαίνουσαν τὸ εἶδος αὐτῶν ὅτι ᾱ λεπτά εἰσιν K | τὸ (sec)] τὰ K 12 πρῶτα] πρώτων K | τε λ ] λ οι` K | προσσημαῖνον mdash
Fabio Acerbi152
ἐλάττονα τὸν τδ κβ´ κ´´ ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις καὶ ταύτην ἐπιδεικνύουσαν τὴν τάξιν τῆς προόδου τῆς ἐκθέσεως ἧστινος κλωμένης γραμμῆς πρὸς τῷ ἐγγὺς ἐλάσσονι ἡ ἀντανάκλασις ἐπὶ τὸν λοιπὸν γέγραπται φερομένη ὡς εἴρηται διὰ τὸ εὔτακτον τῆς προκοπῆς οὕτως τε ποιήσας ἑξῆς τὸ αφ ποιῶν ὃ προσσημαίνει ὡς εἴρηται τὸ ὅτι δεῖ ἀφελεῖν ὁμοίως ἀπὸ τοῦ λοιποῦ καὶ δὴ τὸν ἐγγὺς πάλιν ἐλάσσονα ὡς πρὸς τὴν ἐν τῷ σελιδίῳ ἔκθεσιν εὑρισκόμενον λαμβάνων ἑξῆς προγράφει αὐτὸν ὄντα νδ μζ´ ιγ´´ ιβ´´´ καὶ εὑρίσκει αὐτοῖς παρακείμενα ἐν τῷ σελιδίῳ πρῶτα λεπτὰ θ´ ἅτινα καὶ αὐτὰ προσαπογράφεται σὺν τῇ παρασημειώσει τῶν πρώτων γράφων τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον τὴν ἀνατείνουσαν καὶ ὡς εἴρηται τὴν γραμμὴν πάλιν διὰ τὴν τάξιν κλωμένην κατὰ δευτέραν κλάσιν προσέλκει γινομένου τοῦ μέρους αὐτῆς τούτου παραλλήλου τῷ ἐξ ἀρχῆς
16 ante κλωμένης add ἐπὶ C 18 τε] MZP om SC | αφ ] M ἀφ ZSC ἀφαί P 19 προσσημαίνει] MS προση- ZC et ex corr P | ὅτι] ZP comp MSC 20 δὴ] MZSC διὰ fecit m 2 P 21 πρὸς] MSP et supra lineam C ex ἀπὸ fecit m 2 Z | ιγ´´] MZSP νγ´´ C 22 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M ᾱᾱ λεπτὰ Z άάα λε S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C 23 προσαπο- γράφεται] απο suprascr in comp M 24 ᾱ] ZP α´ MS α C 25 κλάσιν] MP τάξιν ZSC | τοῦ] ZSPC τούτου M 26 τούτου] τοῦ bis ZSPC sed prius erasit m 2 P τοῦ M
mdash 18 προκοπῆς] om K | τε ποιήσας] ποιήσας καὶ K | αφ ] ἀφ K 19 τὸ] om K 21 προ-γράφει] γράφει K 22 σελιδίῳ] α´ σελιδίῳ K | ἅτινα] ἃ K 23 προσαπογράφεται] ἀπογράφεται K | τῶν πρώτων mdash 26 ἐξ ἀρχῆς] om K
lsquoAllo scopo di raccogliere ciograve che risulta dalla divisione il detto Pappo utilizzando anche in questo caso una certa disposizione ben strutturata determina nel modo seguente il lsaquonumerorsaquo cercato preso nel suo insieme collocando73 in testa il lsaquonumerorsaquo che sta per essere diviso cioegrave i 360 gradi iniziali sottrae loro tra i piugrave prossimi dei lsaquonumerirsaquo minori rispetto a quelli esposti quello che si trova essere minore nella colonna (cioegrave 304 22 20) Questo egrave il motivo per cui lo trascrive scrivendogli davanti lrsquoabbreviazio-ne laquosottrraquo per laquosottrairaquo e trovando che 50 minuti primi sono collocati accanto a quello stesso lsaquonumerorsaquo che egrave stato trascritto nella colonna li trascrive al tempo stesso collocando accanto74 ad essi la lettera A con un lsaquotrattorsaquo75 sopra che significa la specie minuti primi Trova dunque in que-sto modo la parte di 360 che egrave 304 22 20 la quale divisa per 365 giorni 14 48 fa il numero lsaquoche risultarsaquo dalla divisione 50 minuti primi Trascrivendo
73 La descrizione egrave strutturata come una procedura Acerbi 201274 Il purismo del correttore del Par gr 2390 di Clostomalle nel Marc gr 314 e
dellrsquoautore della recensione bizantina impone loro di modificare la terminazione ma forme tematiche e contratte di τιθεῖν sono correnti nel greco tardivo
75 Il testo greco ha solo il participio con γραμμήν sottinteso Per il significato del participio si veda il punto 2
15
20
25
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 153
poi il resto 55 37 40 gli pone altresigrave76 a prefisso laquoReraquo che significa laquorestiraquo e dispone anche una certa linea semplice77 che va da 360 al piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori che egrave esposto di seacuteguito 304 22 20 come nello lsaquoschemarsaquo esposto linea che mostra lrsquoordine del percorso dellrsquoesposizione Questa linea spezzata lagrave dove si trova il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori egrave tracciata inflessa allrsquoindietro lsaquoersaquo punta verso il resto come egrave stato detto in vista di una progressione ordinata E cosigrave facendo prendendo di seacuteguito il laquosottrraquo che significa come egrave stato detto laquoche occorre similmente sottrarre dal re-storaquo e ovviamente prendendo di nuovo il lsaquonumerorsaquo che egrave trovato essere il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori in relazione alla disposizione nella colonna ndash 54 47 13 12 ndash lo scrive di seacuteguito e trova che 9 minuti primi sono posti loro accanto nella colonna trascrive78 anche questi con la segnaletica dei primi scrivendo la lettera A con un lsaquotrattorsaquo sopra e come egrave stato detto prolunga di nuovo la linea spezzata in vista di una buona disposizione tramite una seconda inflessione essendo questa sua parte parallela a quella inizialersquo
La descrizione continua con una serie di laquoe cosigrave viaraquo e non fa ulte-riore riferimento alla tabella
1) La forma verbale ἐξεσμένον Egrave il neutro del participio perfetto medio-passivo di ξέω lett laquopialloraquo laquolevigoraquo Si danno tre possibilitagrave si tratta di un termine canonico per quanto non altrove attestato per designare unrsquoabbreviazione oppure lrsquoautore anonimo improvvisa sul piano metaforico come se unrsquoabbreviazione non fosse altro che la paro-la completa lsquoaccorciata a colpi di piallarsquo in maniera opportuna oppure il testo egrave corrotto e srsquoimpone una correzione ad esempio τὸ ἑξῆς μένον laquociograve che sta di seacuteguitoraquo Questrsquoultima strada mi pare chiusa dal senso delle frase lrsquoabbreviazione non lsquosta di seacuteguitorsquo a niente ma anzi precede la perifrasi τὸ ἑξῆς μένον se impiegata semplicemente per rimandare al segno αφ immediatamente seguente costituirebbe un intollerabile solecismo Se accettiamo la prima di queste letture considerando quin-di lrsquoabbreviazione αφ in posizione predicativa abbiamo a che fare con
76 Rendo in questo modo il τε isolato77 La linea egrave laquosempliceraquo in quanto egrave una retta la precisazione intende evidenziare per
anticipazione il carattere lsquonon semplicersquo che essa assumeragrave alla prima inflessione quando diventeragrave una spezzata linee siffatte erano in effetti concepite dallrsquoanonimo e prima di lui da tutta la tradizione matematica greca come una singola linea spezzata nei punti drsquoinfles-sione I due segmenti paralleli menzionati al termine del passo sono orizzontali
78 Il verbo egrave al medio in variatio rispetto ai due che precedono e che seguono egrave il matematico che lsquosirsquo trascrive le cifre
Fabio Acerbi154
uno hapax semantico nella grecitagrave superstite come egrave facile verificare con una ricerca sul TLG in rete La recensione bizantina risolve il pro-blema sopprimendo semplicemente τὸ ἐξεσμένον
2) La notazione per le specie numeriche Nella terminologia matema-tica greca gli ordini sessagesimali sono εἴδη laquospecieraquo numerici essi corri- spondono agli ordini di grandezza nel nostro sistema decimale e indica-no in analogia con il caso geometrico la lsquoformarsquo che assume un numero quadrato cubo ecc Centinaia e migliaia sono quindi degli εἴδη rispet-tivamente quadrati (100 egrave il quadrato di 10) e cubi (1000 egrave il cubo di 10) sono specie numeriche ma non numeri particolari e drsquoaltronde 300 non egrave un quadrato ma 3 item dellrsquoεἶδος lsquoquadratorsquo 100 3 egrave il numerale di molteplicitagrave della specie quadrata lsquocentinaiarsquo i due 0 che seguono il 3 segnalano esattamente questo fatto che la notazione greca per gli interi non posizionale fa scomparire al livello denotativo Ciograve non vale soltan-to per i numeri interi ma anche per le loro parti i minuti secondi appar-tengono alla specie lsquoquadratorsquo in quanto 13600 egrave il quadrato di 160
La concezione appare interamente dispiegata nellrsquointroduzione degli Arithmetica diofantei79 che si rivela giova farlo rimarcare un te-stimone fondamentale per la ricostruzione della notazione matematica antica Alle specie usate in questrsquoopera vengono assegnati una denomi-nazione ed un segno convenzionale costituito dallrsquoiniziale (di ognuno dei componenti) della denominazione al quadrato o δύναμις il segno ΔΥ al κύβος il segno ΚΥ alla lsquoquarta potenzarsquo o δυναμοδύναμις il segno ΔΥΔ ecc La descrizione di tali segni egrave del tipo καὶ ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον Κ ἐπίσημον ἔχον Υ ΚΥ κύβος laquoe il suo segno egrave un Κ che ha come indice un Υ ΚΥ cuboraquo dove in accordo con quanto abbiamo visto nel punto b supra e pur nel comprensibile imbarazzo del copista della prima parte del Matritensis (o di un suo passato collega) a districarsi in questo formidabile ginepraio notazionale80 le due lettere Κ e Υ ricevono una barra mentre ΚΥ non la richiede a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον il quale ancora una volta esclude automaticamente il segno dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
79 In particolare a DOO I pp 214-62180 Nel Matr 4678 riscontriamo i seguenti fenomeni nelle poche righe a cavallo dei ff
58r-v 1) accento acuto posto su tutti i segni come se fossero abbreviazioni 2) ripetizione sistematica segnodenominazione come in ΚΥ κύβος appena letto dovuta sicuramente allrsquointrusione di glosse interlineari esplicative dei segni ndash e successivo pentimento (δύναμις e κύβος sono in effetti cancellati dalla prima mano il primo con un tratto il secondo con dei punti supra lineam poi il copista si stanca di correggere) 3) nella descrizione del segno per la δυναμοδύναμις menzione di un δέλτα δύο che saragrave molto probabilmente stato ΔΔ subito dopo nella descrizione del κυβόκυβος si legge un incongruo δύο KK
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 155
Diofanto introduce poi dei segni anche per le specie delle parti dellrsquounitagrave (le nostre frazioni) che egli chiama ὁμώνυμα μορία laquoparti omonimeraquo di cui quelle sessagesimali sono casi particolari81 Egli spie-ga appunto che le loro denominazioni sono ottenute da quelle delle specie degli interi per sinonimia passando ad un lsquoordinalersquo82 formato semplicemente aggiungendo il suffisso -στον δυναμοστόν κυβοστόν δυναμοδυναμοστόν ecc (sott μόριον) I loro segni convenzionali sono invece ottenuti da quelli per le specie degli interi aggiungendo una γραμμὴν διαστέλλουσαν τὸ εἶδος laquolinea che distingue la specieraquo83 Una linea sui segni delle specie delle parti egrave richiesta si badi bene per distinguerli dai segni di quelle degli interi come giagrave osservato questi ultimi sono giagrave lsquoagrammaticalirsquo a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον a fortiori lo saranno anche i primi Si tratta della traduzione semio-tica del passaggio dal cardinale allrsquoordinale che a livello grammaticale egrave effettuato con il suffisso -στον Che forma ha questa linea Barra o apice (Egrave cervellotico pensare a forme piugrave complesse) La domanda non ammette una risposta immediata in quanto delle specie diofantee nessuno piugrave si occupa nellrsquoantichitagrave84 Se egrave vero che la prima risposta darebbe origine ad un conflitto tra due convenzioni denotative diffe-renti la barra lsquocitazionalersquo e la barra che distingue la specie lrsquoevidenza grafica del Matritensis lascia lievemente sgomenti (ricordiamoci che giagrave i segni di base sono indebitamente dotati di un accento dal copista) Le poche occorrenze del segno per le specie delle parti85 vedono lrsquoaggiunta di uno slash di sospensione di un doppio apice inverso ndash in tutta evi-
81 Questo fatto era giagrave chiaro nellrsquoantichitagrave Teone in Alm I 10 in iA p 45310-1682 Il parallelo con i cardinali e gli ordinali relativi agli interi egrave reso esplicito da Dio-
fanto ὥσπερ δὲ τῶν ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια παρομοίως καλεῖται τοῖς ἀριθμοῖς τοῦ μὲν τρία τὸ τρίτον τοῦ δὲ τέσσαρα τὸ τέταρτον οὕτως καὶ τῶν νῦν ἐπονομασθέντων ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια κληθήσεται παρομοίως τοῖς ἀριθμοῖς laquocome le parti omonime dei numeri sono chia-mate per assonanza con i numeri di lsquotrersquo lsquolsaquounrsaquo terzorsquo di lsquoquattrorsquo lsquolsaquounrsaquo quartorsquo cosigrave le parti omonime dei numeri appena nominati saranno chiamate per assonanza con i numeriraquo (DOO I p 69-13 si noti lrsquoarticolo lsquocitazionalersquo al singolare in τοῦ τρία e τοῦ τέσσαρα) Il parallelo prosegue anche al livello dei segni che rappresentano queste specie come vedremo tra un attimo
83 Diofanto Arithmetica prefazione in DOO I p 620-21 un passaggio maltrattato in questa edizione occorre espungere il participio ἔχον senza introdurre segni ulteriori oppure eliminare un precedente ἐπί come fa un correttore del Matritensis f 58v
84 Unica parzialissima eccezione lrsquoaccenno di Teone menzionato nella nota 81 supra85 Al f 59r e per di piugrave nel margine per sanare un lungo saut du mecircme au mecircme La
collocazione in margine egrave il motivo per cui troviamo una notazione abbreviata nel resto del trattato il primo copista scioglie tutti i segni prendendoli per abbreviazioni mentre il secondo elimina sistematicamente il tratto aggiuntivo delle specie delle parti dellrsquounitagrave Drsquoaltronde egli scrive ad esempio ΔΥ invece di ΔΥ ed egrave quindi indotto a porre la barra al di sopra della stringa di lettere risultante (passim ma si veda ad esempio il f 72r)
Fabio Acerbi156
denza il compendio per la desinenza -ον accentata il copista interpreta il segno come unrsquoabbreviazione ndash e di una barra a sormontare lo Υ Potremmo forse interpretarlo come il segno di contrazione del grafema -στ- lrsquounico tassello mancante in unrsquoabbreviazione come ad esempio (δυναμοδυναμο)(στ)(ὸν) ma uno scolio di prima mano al f 58v rela-tivo alle specie degli interi inficia questrsquoipotesi esse sono dotate di slash di sospensione accento acuto in un caso del compendio canonico per la terminazione -ον hellip ma tutti gli Υ a esponente sono a loro volta sormontati da una barra
Meno legata al singolo manoscritto ma nondimeno non uniforme si presenta la pratica di notazione dei segni che rappresentano gli enti numerici sessagesimali86 da una parte sta lrsquoevidenza del testo dei Pro-legomena e delle sue tabelle apici ndash drsquoaltronde come abbiamo visto la notazione universalmente impiegata per i numerali ordinali e per le fra-zioni unitarie ndash dallrsquoaltra sta lrsquoevidenza del testo dellrsquoAlmagesto in tutti i manoscritti piugrave antichi e lo stesso si dica del commentario teonino a questrsquoopera o del suo lsquoGrande commentariorsquo alle Tavole facili e dei testi astronomici su papiro barre87 Sembra insomma che la nostra docu-
86 Sia le molteplicitagrave che le specie ahimeacute entrambe rappresentate da lettere dellrsquoalfabeto Come osservato allrsquoinizio della sezione 3 ci sono in effetti due tipi di lettere numerali in gioco se facciamo astrazione da apici o barre lsquo4 minuti secondirsquo si trova scritto δ β la prima lettera numerale denota la molteplicitagrave degli item di una certa specie la se-conda la specie nei Prolegomena entrambe sono accompagnate da un doppio apice il che rende inutile la presenza delle seconde Si noti che la descrizione della tabella non fa parola della notazione da usare per le lettere numerali che denotano la molteplicitagrave barre o apici e quanti apici hellip In questo caso fa interamente fede la tabella cioegrave la pratica grafica condivisa instauratasi non egrave chiaro quando
87 I manoscritti piugrave antichi dellrsquoAlmagesto sono menzionati nella nota 10 supra quelli dei due commentarii teonini sono il Laur Plut 2818 e il celeberrimo Vat gr 190 (sec IX in Euclide Elementi Data Teone lsquoGrande commentariorsquo) per la notazione dei pa-piri astronomici si veda Jones 1999 II passim La notazione non sembra lsquoinquinatarsquo dalla pratica dei copisti bizantini e pare dipendere soltanto dalla data di composizione Tro-viamo ad esempio barre sopra tutti i numerali di molteplicitagrave (interi o sessagesimali) nel frammento di un commentario alle Tavole facili contenente un calcolo relativo al 24 aprile 213 (Par gr 2841 sec XIII ex-XIV in oltre al frammento ai ff 32r l 11-34v l 23 contiene Arato Phaenomena ed Efestione Apotelesmatica edizione in Jones 1990) Nel commentario alle Tavole facili composto ca 610-617 ed attribuito a Stefano di Alessandria la situazione egrave la seguente (Jean Lempire per litteras per lrsquoedizione si veda Lempire 2014 ho controllato il Vat gr 304 ff 135r-171v sec XIV am contiene in aggiunta Teone in Almagestum I-II lsquoPiccolo commentariorsquo alle Tavole facili Diofanto Arithmetica e De polygo-nis numeris varia astronomica tabulae) barre sopra gli interi sporadicamente rimpiazzate da apici apici sopra le parti sessagesimali in numero uguale alla denominazione doppio () apice per le frazioni unitarie Sono impiegate barre sopra gli interi e apici sopra le parti sessagesimali nei manoscritti principali di tutti i trattati di introduzione allrsquoAlmagesto o comunque di argomento logistico redatti in epoca bizantina Giorgio Pachimere (1242-ca 1310) Quadrivium (autografo nel manoscritto Roma Biblioteca Angelica gr 38 [RGK III nr 115] si veda Tannery ndash Steacutephanou 1940 per lrsquoedizione) Teodoro Metochita (1270-
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 157
mentazione si faccia testimone di un cambio notazionale avvenuto nel periodo intercorrente fra Teone (sec IV pm) e la scuola alessandrina di Ammonio e dei suoi allievi (sec VI in) e probabilmente innescato da questrsquoultimo ambiente lrsquoaspetto paradossale egrave che nello stesso codice si rintraccino due notazioni differenti per gli enti numerici sessagesimali e lrsquouna (apici) sia adottata sistematicamente e coerentemente in uno scritto (i Prolegomena) che si presenta esattamente come unrsquointroduzione tecnica alla pratica numerico-algoritmica del trattato (lrsquoAlmagesto) in cui egrave adottata lrsquoaltra (barre che ritroviamo senza eccezioni anche negli scolii)
Torniamo ai Prolegomena la descrizione del segno da porre a fianco di ogni singolo quoziente parziale e denotante la sua specie numerica (minuti primi minuti secondi ecc) solleva tre problemi
Primo problema Ci vuole una barra o un apice su τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquola lettera A [hellip] che significa la specieraquo quando lo scriviamo nella tabella Tutta la nostra discussione precedente fa pro-pendere per lrsquoapice e si ricordi anche la forma verbale ἀνατείνουσαν che suggerisce qualcosa che si lsquoestende verso lrsquoaltorsquo (la mia traduzione egrave volutamente neutra) se fosse apposta una barra la cosa dovrebbe passare
1231332) Compendium astronomicum (copia lsquoautorizzatarsquo coeva nei Vat gr 182 e 181 da parte del copista che integrograve le parti mancanti del Par gr 2389 [ff 207-210 255-270 374-375] Bianconi 2005a pp 425-427 Peacuterez Martiacuten 2008 p 436 e n 177) Teodoro Meliteniota (morto lrsquo831393) Tribiblos astronomica (autografo nel Vat gr 792 si vedano Leurquin 1991 per unrsquoanalisi del manoscritto Leurquin 1990 per lrsquoedizione) una com-pilazione anonima (per cui ho consultato il Par gr 2396 ff 87r-92v limitatamente a questi fogli manu Costantino Trivoli [RGK II nr 318 ma ovviamente questo codice non vi egrave segnalato] terzo quarto del XV secolo il resto del codice annotato da Niceforo Gregora egrave di etagrave planudea e parzialmente [ff 33v-76v] un autografo di Planude stesso contiene Teone in Almagestum I II IV Mondrain 2002 il codice va completato ndash limitatamente a stralci dei libri VIII-X XII-XIII del commentario teonino la cui parte intermedia si egrave persa ndash con 26 carte [ff 123-147] inserite nel Vat gr 1087 anchrsquoesso contenente anno-tazioni di Gregora Rome 1927 per la figura del copista dei ff 77r-86r del Par gr 2396 e dei ff appena nominati del Vat gr 1087 un anonimo collaboratore di Gregora si veda in ultimo Bianconi 2006a pp 147-151) si veda anche il calcolo effettuato da Niceforo Gre-gora (12921295-13581361) dellrsquoeclisse di sole del 16 luglio 1330 (attestata unicamente ai ff 1r-8v della miscellanea astronomica Marc gr 325 databile ca 1324-1329 in parte vergata e ovunque fittamente annotata da Gregora stesso edizione del testo in Mogenet et al 1983 annotazioni di Gregora elencate in Bianconi 2005a p 413) Unrsquoeccezione apparente il lsquoPiccolo commentariorsquo di Teone alle Tavole facili le parti sessagesimali sono segnalate da apici (ad esempio nel Vat gr 175 vergato da Giovanni Catrario e completato nel 1321-1322 sulla figura di Catrario si vedano in ultimo Bianconi 2005b pp 141-156 e 2006b) lrsquoopera egrave antica ma la sua tradizione non rimonta oltre la fine del XIII secolo a parte un frammento nel Leiden BPG 78 ff 156r-161v (minuscola del IX-X secolo) e in effetti in questo manoscritto tutti i numerali di molteplicitagrave sono sormontati da barre Unrsquoeccezione effettiva egrave il De hypotesibus planetarum nel Vat gr 1594 barre sugli interi e apici sulle parti sessagesimali
Fabio Acerbi158
sotto silenzio e la presenza dellrsquoapice la rende inutile88 Si tratta della stessa convenzione diofantea e coincide ancora con la notazione per i numerali ordinali e per le frazioni unitarie che egrave corrente nei mano- scritti matematici greci per questo motivo non percheacute la descrizione sia particolarmente perspicua nessuno dei copisti della recensione an-tica ha incertezze apici Ma questi apici si rintracciano soltanto sulle indicazioni di specie non contemplate dalla descrizione che sono ante-poste ai resti parziali a fianco dei quozienti parziali i segni di specie sono invece trasformati in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordi-nali corrispondenti del tipo πρωτ tavv 5 e 7b-8 Il recensore bizantino taglia invece la testa al toro elimina dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali elimina la seconda menzione della laquolet-tera Araquo contestualmente allrsquoazzeramento dellrsquoespediente della linea a zig-zag (si veda il punto seguente) modifica la descrizione che contiene la prima menzione in quella dellrsquoapice associato direttamente ai nume-rali di molteplicitagrave riciclando addirittura lrsquoalpha per adibirlo a desi-gnare un numero cardinale (come sorprendersi) τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ laquoponendo al di sopra di essi [scil dei 50 minuti primi] 1 solo lsaquoaccentorsaquo acutoraquo La scelta del recensore egrave assennata che rechi una barra o un apice in una tabella un alpha denota un numero non un numero drsquoordine
Secondo problema da tenere ben distinto dal precedente Cosa ci vuole sul segno α per la lettera alpha menzionata nella frase τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquolettera A [hellip] che significa la specieraquo89 Unrsquooc-chiata allrsquoapparato critico rivela una bella incertezza nei manoscritti Z scrive sempre ᾱ e in un caso lo fa anche P MS optano sempre per α´ C per α P scrive nellrsquoaltro caso αο Per quanto solo la barra sia congrua con il senso della frase in quanto la lettera alpha egrave qui menzionata (si tratta di un oggetto che compare nella tabella) e non cambia niente se essa egrave accompagnata dal suo nome di genere στοιχεῖον ad un livello grafico lrsquoincertezza fra il segno ᾱ che denota laquola lettera αraquo e il segno α´ (o lrsquoabbreviazione αο) per una forma di πρῶτος egrave per piugrave versi giustificata
88 Detto in altri termini la barra egrave uno strumento grafico non matematico e quindi la sua presenza non va segnalata mentre un apice lo egrave e la sua presenza lo deve
89 Notare che in questa frase il primo α non vuole la barra (egrave menzionato allrsquointerno di una frase che impiega convenzioni moderne) il secondo sigrave (idem ma con convenzioni antiche) ndash e nella traduzione la scelta di denotarlo con A (senza virgolette) e non con lsquoArsquo (con virgolette) egrave del tutto arbitraria ndash si noti inoltre che le necessarie precisazioni laquosenzacon virgoletteraquo mostrano che le lingue moderne palesano difficoltagrave analoghe a quelle del greco antico per quanto riguarda i livelli denotativi in ambito metadiscorsivo per non usare le due parentetiche avrei dovuto scrivere rispettivamente lsquoArsquo e lsquolsquoArsquorsquo (doppie virgolette semplici)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 159
ᾱ coincide con il numerale 1 α egrave la prima lettera dellrsquoalfabeto ed inoltre α´ egrave esattamente quello che va scritto nella tabella Potremmo dirci che il sostantivo στοιχεῖον chiude la questione la sua presenza congiunta ad un ipotetico α´ renderebbe la descrizione ridondante o inappropriata90 Ma a parte il fatto che α egrave proprio τὸ πρῶτον στοιχεῖον il segno α´ cat-tura in fondo il cuore della descrizione di uno στοιχεῖον ἔχον lsaquoγραμμὴνrsaquo ἀνατείνουσαν
Terzo problema Lrsquoautore dei Prolegomena che si arresta allrsquoesem-pio dei minuti primi non dice quanti apici occorre mettere sulle lettere numerali che identificano gli ordini superiori al primo se uno soltanto come nel caso diofanteo e delle frazioni unitarie o in numero uguale alla loro denominazione (cioegrave pari al numero denotato dal numerale stesso su cui vanno posti) come effettivamente avviene nei mano-scritti dei Prolegomena La tabella egrave quindi sottodeterminata dalla sua descrizione anzi in un certo senso prende il sopravvento su di essa la pratica di marcare i numerali di molteplicitagrave con gli apici che compe-tono allrsquoordine cui appartengono viene trasferita ai segni per gli ordini stessi per supplire ad una descrizione carente di questi ultimi E la tabella egrave sottodeterminata dalla descrizione in quanto egrave la descrizione di una tabella reale ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις laquocome nello lsaquoschemarsaquo espostoraquo leggiamo a un certo punto del testo
3) La linea a zig-zag Non possiamo che applaudire a questo geniale espediente grafico lo troviamo messo in opera solo nel Marc gr 313 Per quanto lrsquoautore non faccia parola di ciograve nel corso della sua descrizione la linea spezzata egrave intesa dover lsquosaltarersquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue Il copista del codice marciano effettua correttamente due salti nella prima delle sue tabelle (tav 4) ma inserisce un lsquodentersquo in piugrave in quella che considera corretta (tav 5) La linea a zig-zag egrave incompatibile con la presenza di linee di giustificazione nella tabella che in effetti mancano nel Marc gr 313 ciograve induce gli errori di allineamento dei primi 5 quozienti parziali di cui egrave vittima il copista Probabilmente per questo motivo in nessuno degli apografi del Vat gr 1594 la linea a zig-zag figura nella tabella inquadrata come si conviene da una (doppia) cornice esterna e le cui colonne sono appunto separate da linee verticali (tav 7b Vat gr 184 f 17v e tav 8 Par gr 2390 f 9v cui egrave sostanzialmente identica la tabella del Marc gr 314 che si trova
90 Trascuro lrsquoabbreviazione αο = πρῶτος percheacute la desinenza non egrave quella richiesta neacute nella frase (egrave richiesto πρῶτον) neacute nella tabella (πρῶτα)
Fabio Acerbi160
al f 248r ndash ma la mancanza di linee orizzontali causa un gigantesco pa-sticcio nel codice vaticano) Alla recensione bizantina che dipende per il suo testo di base dal Vat gr 1594 e quindi non trova la linea a zig-zag nella tabella non resta che sopprimere la sua descrizione ndash ma proprio per questo motivo e finalmente diventa possibile tracciare un apparato completo di linee di giustificazione (tav 9 Laur Plut 89 sup 48 f 14v) Dato che la descrizione di Teone di questo procedimento di divi-sione non fa cenno allrsquoesistenza della linea a zig-zag viene da chiedersi se essa non costituisca un espediente escogitato dallrsquoautore dei Prolegomena per vivacizzare la procedura originale di Pappo
4) Discrepanze tra descrizione e tabella Il gioco delle minime va-rianti mostra che la divisione era stata eseguita (e trasmessa) corret-tamente tutti i valori numerici sono esatti La tabella nel Marc gr 313 presenta perograve alcune discrepanze con la propria descrizione Essa omette (ma non nella versione lsquoscorrettarsquo lrsquoomissione non si riscontra neanche nel Par gr 2390) il segno per laquorestoraquo di fronte ai resti par-ziali ma aggiunge lrsquoindicazione della loro specie Essa trasforma invece come abbiamo visto le indicazioni di specie che seguono i quozienti parziali in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordinali corri-spondenti La descrizione prevede di chiudere la tabella con il risultato καὶ συνάγων ἅπαντα τὰ ἐκ τῶν μερισθέντων μερῶν λεπτὰ σημειοῦται ὑπὸ πάντας οὕτως γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoe raccogliendo tutti i minuti che provengono dalle parti divise lsaquoPapporsaquo nota sotto tutto cosigrave Ris 0 59 8 17 13 12 31raquo ma sotto la tabella tutta la tradizione ci consegna qualcosa di piugrave articolato ὁ ζητούμενος καθ᾽ ὃν μερίζεται ὁ τξε ιδ´ μη´´ π(αρὰ) τὸν τξ γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoil lsaquonumerorsaquo cercato secondo cui 365 14 48 egrave diviso per 360 risulta 0 59 8 17 13 12 31raquo frase che del resto contiene due errori lrsquoinversione del dividendo e del divisore e la confusione tra segno convenzionale (iuxta descrizione) e abbreviazione (come nella frase) nel caso di γι Oltre ad eliminare la linea a zig-zag91 la recensione bizantina sopprime dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali e modifica come abbiamo visto al punto 2 le loro descrizioni in quelle di apici associati diretta-mente ai numerali di molteplicitagrave
91 Le due righe che nella recensione di base contengono solo i resti parziali minori di 160 del divisore ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue sono in parte completate con lrsquoindicazione abbreviata ἀνάλ(υσις) laquoanalisiraquo il termine greco per questa procedura di riduzione In un sussulto di ipercorrettismo matematico tali resti parziali ridotti non sono preceduti dal segno per laquorestoraquo come nel Par gr 2390 ma da quello per laquorisultatoraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 161
Gli esempi che abbiamo discusso mostrano come i problemi di notazione pesino e non poco sullrsquoespressione discorsiva di un algorit-mo matematico lrsquoente di riferimento per lsquoformularersquo il procedimento di divisione fu considerata la tabella cioegrave un oggetto la cui costitu-zione egrave legata piugrave ad una pratica grafica che a considerazioni logico- algoritmiche non la sua descrizione che in effetti finisce per determi-nare la tabella in maniera non univoca Di questa sottodeterminazione si fa testimone la traiettoria che abbiamo cercato di seguire nelle mani di copisti e revisori il procedimento di divisione si modifica a volte in aspetti secondari a volte in punti piugrave sostanziali ndash fino a rendere neces-saria una radicale revisione della sua descrizione per renderla conforme alla tabella ndash in ogni caso mai per ragioni squisitamente matematiche92
Abstract
The article presents and discusses in detail two passages from the anonymous Prolegomena to the Almagest a VIth century primer to the elementary procedures of calculation needed in Ptolemyrsquos Almagest In the two passages we may follow the complex interplay between mathematical notation the auctor who employed and described it the tachygrapher who transcribed it in vivo copyists who reproduced it correctors who modified it Along this path misgivings and errors arise in the transmission of abbreviations and paratextual units such as diagrams tables operational schemes
Fabio AcerbiCNRS UMR8560 Centre Alexandre Koyreacute
fabacerbigmailcom
92 Sono grato a Daniele Bianconi Lucio del Corso Jean Lempire per alcune preziose indicazioni
AOO = Archimedis opera omnia cum commentariis Eutocii ed J L Heiberg I-III Lipsiae 1910-1915
DOO = Diophanti Alexandrini opera omnia cum Graecis commentariis ed P Tannery I-II Lipsiae 1893-1895
GC = Le laquoGrand Commentaireraquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Mogenet ndash A Tihon I-III Cittagrave del Vaticano 1985-1999
iA = Commentaires de Pappus et de Theacuteon drsquoAlexandrie sur lrsquoAlmageste ed A Rome I-III con paginazione continua Cittagrave del Vaticano 1931-1943
HOO = Heronis Alexandrini opera quae supersunt omnia ed G Schmidt ndash L Nix ndash W Schmidt ndash H Schoene ndash J L Heiberg I-V Lipsiae 1899-1914
PC = Le ldquoPetit Commentairerdquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed A Tihon Cittagrave del Vaticano 1978
POO = Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia ed J L Heiberg I-II in 3 parti Lipsiae 1898-1907
RGK = Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600 I Handschriften aus Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln II Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs und Nachtraumlge zu den Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln III Handschriften aus Bibliotheken Roms mit dem Vatikan A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg unter Mitarbeit von D Harlfinger und P Eleuteri B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln Wien 1981-1997 (Oumlsterreichische Akademie der Wissenschaften Veroumlffentlichungen der Kommission fuumlr Byzantinistik III1-3 A-C)
Sigla
Acerbi 2010 = F Acerbi Il silenzio delle sirene La matematica greca antica Roma 2010
Acerbi 2012 = F Acerbi I codici stilistici della matematica greca dimostrazioni procedure algoritmi laquoQUCCraquo 1012 (2012) pp 167-214
Acerbi et al 2010 = F Acerbi ndash N Vinel ndash B Vitrac Les Proleacutegomegravenes agrave lrsquoAlmageste Une eacutedition agrave partir des manuscrits les plus anciens Introduction geacuteneacuterale ndash Parties I-III laquoSCIAMVSraquo 11 (2010) pp 53-210
Agati 1992 = M L Agati La minuscola laquoBouleteacuteeraquo Cittagrave del Vaticano 1992
Belger 1881 = C Belger Ein neues Fragmentum mathematicum Bobiense laquoHermesraquo 16 (1881) pp 261-284
Bianconi 2005a = D Bianconi La biblioteca di Cora tra Massimo Planude e Niceforo Gregora Una questione di mani laquoSampTraquo 3 (2005) pp 391-438
Bianconi 2005b = D Bianconi Tessalonica nellrsquoetagrave dei Paleologi Le pratiche intellettuali nel riflesso della cultura scritta Paris 2005
Bianconi 2006a = D Bianconi Le pietre e il ponte ovvero identificazioni di mani e storia della cultura laquoBizantinisticaraquo 8 (2006) pp 135-181
Bianconi 2006b = D Bianconi Qualcosa di nuovo su Giovanni Catrario laquoMEGraquo 6 (2006) pp 69-91
Cavallo 1977 = G Cavallo Funzione e strutture della maiuscola greca tra i secoli VIII-XI in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Colloque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 95-137
Cereteli 1904 = G F Cereteli De compendiis scripturae codicum Graecorum praecipue Petropolitanorum et Mosquensium anni nota instructorum Sankt-Petersburg 1904
De Gregorio 2000 = G De Gregorio Materiali vecchi e nuovi per uno studio della minu-scola greca fra VII e IX secolo in G Prato (a cura di) I manoscritti greci tra riflessione e dibattito Atti del V Colloquio Internazionale di Paleografia Greca Cremona 4-10 ottobre 1998 Firenze 2000 pp 83-151
Follieri 1977 = E Follieri La minuscola libraria dei secoli IX e X in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Col-loque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 139-165
Fonkič 2005 = B Fonkič Venecianskaia rukopisrsquo laquoAlrsquomagestaraquo Ptolemeja (Marc gr 313690) o datirovke i proischoždenii kodeksa laquoVDIraquo s III 254 (2005) pp 162-167
Fowler 1999 = D H Fowler The Mathematics of Platorsquos Academy A New Reconstruction Second Edition Oxford 1999
Bibliografia
Fabio Acerbi164
Gerstinger ndash Vogel 1932 = H Gerstinger ndash K Vogel Eine stereometrische Aufgaben-sammlung im Papyrus Graecus [sic] Vindobonensis 19996 laquoMitteilungen aus der Papy-russammlung der Nationalbibliothek in Wienraquo Neue Serie Folge 1 Griechische literarische Papyri 1 Wien 1932 pp 11-76
Heiberg 1927 = Mathematici Graeci Minores ed J L Heiberg Kjoslashbenhavn 1927
Hultsch 1876-1878 = Pappi Alexandrini Collectionis quae supersunt ed F Hultsch I-III Berlin 1876-1878
Janz 2003 = T Janz The Scribes and the Date of the Vat gr 1291 in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae X Cittagrave del Vaticano 2003 pp 159-180
Jones 1990 = Ptolemyrsquos First Commentator ed A Jones Philadelphia 1990
Jones 1999 = Astronomical Papyri from Oxyrhynchus ed A Jones I-II Philadelphia 1999
Jones 2005 = A Jones Ptolemyrsquos Canobic Inscription and Heliodorusrsquo Observation Reports laquoSCIAMVSraquo 6 (2005) pp 53-97
Lempire 2014 = Steacutephanos drsquoAlexandrie Le commentaire aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Lempire Louvain 2014
Leurquin 1990 = Theacuteodore Meacuteliteacuteniote Tribiblos astronomique Livre I ed R Leurquin Amsterdam 1990
Leurquin 1991 = R Leurquin Un manuscrit autographe de la Tribiblos Astronomique de Theacuteodore Meacuteliteacuteniote le Vaticanus graecus 792 laquoScriptoriumraquo 45 (1991) pp 145-162
Maas 1927 = P Maas Griechische Palaeographie in A Gercke ndash E Norden (hrsg von) Einleitung in die Altertumswissenschaft I9 Leipzig 1927 pp 69-80
Martinelli Tempesta 2010 = S Martinelli Tempesta Il codice Milano Biblioteca Am-brosiana B 75 sup (gr 104) e lrsquoevoluzione della scrittura di Giovanni Scutariota in A B Garciacutea ndash I Peacuterez Martiacuten (ed by) The Legacy of Bernard de Montfaucon Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting Proceedings of the Seventh Inter-national Colloquium of Greek Palaeography Madrid-Salamanca 15-20 September 2008 Turnhout 2010 pp 171-186
Mazzucchi 1994 = C M Mazzucchi Leggere i classici durante la catastrofe (Costantino-poli maggio-agosto 1203) le note marginali al Diodoro Siculo Vaticano gr 130 Parte prima stratigrafia laquoAevumraquo 68 (1994) pp 164-218
Mioni 1976 = E Mioni Bessarione scriba e alcuni suoi collaboratori in Miscellanea marcia-na di studi bessarionei Padova 1976 pp 263-323
Mioni 1985 = Codices graeci manuscripti Bibliothecae Divi Marci Venetiarum II Thesaurus Antiquus Codices 300-625 recensuit E Mioni Roma 1985
Mogenet 1962 = J Mogenet Une scholie ineacutedite du Vat gr 1594 sur les rapports entre lrsquoastronomie arabe et Byzance laquoOsirisraquo 14 (1962) pp 198-221
Mogenet et al 1983 = Niceacutephore Greacutegoras Calcul de lrsquoeacuteclipse de soleil du 16 juillet 1330 ed J Mogenet ndash A Tihon ndash R Royez ndash A Berg Amsterdam 1983
Mondrain 2002 = B Mondrain Maxime Planude Niceacutephore Greacutegoras et Ptoleacutemeacutee laquoPa-laeoslavicaraquo 10 (2002) pp 312-322
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 165
Mondrain 2004 = B Mondrain Lrsquoancien empereur Jean VI Cantacuzegravene et ses copistes in A Rigo (a cura di) Gregorio Palamas e oltre Studi e documenti sulle controversie teologiche del XIV secolo bizantino Firenze 2004 pp 249-296
Mondrain 2007 = B Mondrain Les eacutecritures dans les manuscrits byzantins du XIV e siegravecle Quelques probleacutematiques laquoRSBNraquo n s 44 (2007) pp 157-196
Peacuterez Martiacuten 2006 = I Peacuterez Martiacuten Maxime Planude et le Diophantus Matritensis (Madrid Biblioteca Nacional ms 4678) un paradigme de la reacutecupeacuteration des textes anciens dans la ldquorenaissance paleacuteologuerdquo laquoByzantionraquo 76 (2006) pp 433-462
Peacuterez Martiacuten 2008 = I Peacuterez Martiacuten El lsquoestilo Hodegosrsquo y su proyeccioacuten en las escrituras constantinopolitanas laquoSampTraquo 6 (2008) pp 389-458
Perria 1991 = L Perria Scrittura e ornamentazione nei codici della laquocollezione filosoficaraquo laquoRSBNraquo n s 28 (1991) pp 45-111
Rollo 2012 = A Rollo LrsquoArchimede di Giorgio Valla in V Fera ndash D Gionta ndash A Rollo (a cura di) Archimede e le sue fortune Atti del Convegno di Siracusa-Messina 24-26 giugno 2008 Messina 2012 pp 99-147
Rome 1927 = A Rome Membra disjecta laquoRBenraquo 39 (1927) pp 187-188
Rome 1938 = A Rome Un manuscrit de la bibliothegraveque de Boniface VIII agrave la Meacutediceacuteenne de Florence laquoACraquo 7 (1938) pp 261-268
Ronconi 2013 = F Ronconi La collection philosophique un fantocircme historique laquoScripto-riumraquo 67 (2013) pp 119-140
Tannery ndash Steacutephanou 1940 = Quadrivium de Georges Pachymegravere ed P Tannery ndash E Steacutephanou Cittagrave del Vaticano 1940
Tihon 2011 = Πτολεμαίου Πρόχειροι Κανόνες Les Tables faciles de Ptoleacutemeacutee vol Ia Tables A1-A2 ed A Tihon Leuven 2011
Traube 1907 = L Traube Nomina Sacra Versuch einer Geschichte der christlichen Kuumlrzung Muumlnchen 1907
Vogel 1936 = K Vogel Beitraumlge zur griechischen Logistik laquoSBAWraquo Mathematisch-natur-wissenschaftliche Abteilung Jahrgang 1936 pp 357-472
Wouters 1979 = A Wouters The Grammatical Papyri from Graeco-Roman Egypt Contri-butions to the Study of the lsquoArs Grammaticarsquo in Antiquity Brussel 1979
F ACERBI Tav 1
b Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 65r
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 284 f 160r
F ACERBITav 2
b Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 13r
a Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 19v
F ACERBI Tav 3
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 136v
F ACERBITav 4
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17r
F ACERBI Tav 5
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17v
F ACERBITav 6
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 7v
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
Fabio Acerbi132
richiede sempre lrsquointroduzione di due numerali il lsquonumeratorersquo e il lsquodenominatorersquo
Il motivo della scelta del sistema sessagesimale che fu mutuato dallrsquoastronomia matematica babilonese egrave presto detto lrsquoelevato numero di divisori di 60 e cioegrave 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 Poicheacute i divi-sori di 10 sono un sottinsieme di quelli di 60 molti piugrave numeri hanno una rappresentazione finita nel sistema sessagesimale che in quello deci-male Calcolare in sessagesimale lungi dal creare difficoltagrave offre quindi un vantaggio cruciale22 che risulta piugrave facilmente comprensibile sulla base dellrsquoesempio seguente La lunghezza dellrsquoanno solare egrave stabilita da Tolomeo in 365 giorni + 14 ndash 1300 di giorno Per calcolare il moto giornaliero del sole si rende necessario dividere 360 per questo numero Noi avremmo due opzioni se non potessimo usare la calcolatrice ri-durre il divisore ad una singola frazione tramite passaggio al denomi-natore comune invertire questa frazione e moltiplicarla per 360 sem-plificare gli eventuali fattori comuni e finalmente eseguire la divisione a piugrave cifre tra numeri interi (nel nostro caso 5400054787) oppure scrivere il divisore come numero decimale periodico (365246666 hellip) e poi eseguire la divisione Nel sistema sessagesimale egrave tutto molto piugrave semplice 365 + 14 ndash 1300 ha una rappresentazione finita cioegrave 365 14 48 come eseguire la divisione lo vedremo tra un attimo
Passiamo dunque in rassegna il contenuto del lsquomanuale di logisticarsquo incluso nei Prolegomena ad Almagestum riportando in nota per ogni item anche esposizioni parallele in altri commentatori23
a) Costruzione del sistema sessagesimale24
22 E uno svantaggio se le molteplicitagrave dei singoli ordini vengono espresse in no-tazione decimale (come facciamo noi e facevano i greci) il numero di cifre necessario per raggiungere una precisione assegnata egrave maggiore nel sistema sessagesimale in quanto per esprimere i numerali da 10 a 59 occorrono due cifre mentre per quelli da 1 a 9 (o da α a θ e le decine da ι a ν nel caso greco) ne basta una e ciograve indipendentemente dal fatto che la notazione sia posizionale oppure no La differenza si fa perograve sentire solo a partire dal quinto ordine sessagesimale
23 Trascuro la parte finale del lsquomanualersquo dove sono esposte le regole di interpolazione (cui era legata la lsquoterza colonnarsquo della tavola delle corde tolemaica) e il procedimento di lsquosottrazionersquo di rapporti cioegrave la divisione di un rapporto per un altro
24 Per a-b cf Teone in Alm I 10 in iA pp 44919-45814 PC pp 2007-2014 GC I pp 10910-11124 e le definizioni e regole diofantee di manipolazione delle varie specie numeriche in Arithmetica prefazione in DOO I pp 214-1218 Le porzioni a-b sono giagrave state pubblicate da Paul Tannery in DOO II pp 318-1517 sulla base del Par gr 453 apografo ad opera di Giovanni Santamaura di un Vat gr 1594 giagrave mutilo (RGK II nr 238 ma lrsquoautore trascritto vi egrave indicato come lsquoPtolemaiosrsquo) Evidentemente il committente non fu soddisfatto della prima trascrizione (ff 67-76) che crivella di tratti rossi a segnalarne gli errori di copia Ne fu dunque eseguita una seconda (ff 78-86) cui Santamaura antepose
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 133
b) Regole di moltiplicazione e divisione degli ordini sessagesimali defini-zione generale di moltiplicazione moltiplicazione di ordini come somma delle loro laquodenominazioniraquo Definizione generale di divisione divisione di ordini uguali e di un ordine per quello che lo precede immediata-mente divisione di ordini come sottrazione delle loro laquodenominazioniraquo divisione per 60 come divisione per 1 accompagnata dallo slittamento di un posto dellrsquoordine
c) Problemi che sorgono nella divisione di una parte sessagesimale per una di quelle che seguono divisione breve per riduzione allo stesso ordine (metodo laquoper analisiraquo) due algoritmi differenti il secondo con riduzione dei fattori comuni attribuito a Siriano
d) laquoAltroraquo metodo di divisione breve in realtagrave divisione tra somme di parti sessagesimali appartenenti ad ordini differenti per riduzione allo stesso ordine e applicazione dei metodi precedenti esempio della divisione di 0 2 0 4 per 0 0 2 0 240
e) Metodo di moltiplicazione tra numeri con parti non intere disposizione tabellare dei termini esempio della moltiplicazione di 5 4 6 per 8 0 3 0 525
f ) Primo metodo di divisione lunga descrizione della disposizione tabellare ed esempio di algoritmo applicato alla divisione di 50 48 26 30 per 8 16 28 5426
g) Metodo di divisione lunga tratto da Pappo in Alm III descrizione della disposizione tabellare ed esempio di algoritmo applicato alla divisione di 360 per 365 14 48 come verifica del valore 0 59 8 17 13 12 31 fornito nellrsquoAlmagesto per il moto medio giornaliero del sole27
h) Metodo di approssimazione di una radice quadrata secondo Erone Metr I 8 con giustificazione geometrica di Teone (attualmente non attestata in suoi scritti)
i) Verifica tramite moltiplicazione della correttezza del valore tolemaico28 di 67 4 55 come radice quadrata approssimata di 4500 Metodo di estrazio-ne di radici quadrate secondo Teone basato su applicazioni successive di Elementi II 4 la procedura termina dopo un numero finito di passi nel caso di quadrati perfetti Applicazione al calcolo della radice quadrata di 450029
unrsquoannotazione spazientita laquoIl texto di questo 2do quinterno egrave stato recopiato fidelmente dallrsquooriginale a chi volesse vedere la prova lo potragrave conferire con detto originale le pagine del qual texto corrispondono con quelle dellrsquooriginale tanti versi che pagine [hellip]raquo (Moge-net 1962 p 200)
25 Teone in Alm I 10 e I 14 in iA pp 45815-4604 e 57911-5811026 Teone in Alm I 10 in iA pp 4611-46217 applicato alla divisione di 1515 20
15 per 25 12 1027 Teone in Alm III 1 e IV 3 in iA pp 84112-84422 (stesso calcolo dei Prolego-
mena) e 102916-10327 idem in Alm IX pp 377-378 dellrsquoedizione di Basilea del 1538 approntata dai tipografi di Walderus Lrsquooriginale pappiano non ci egrave pervenuto
28 Alm I 10 in POO I 1 p 341129 Teone in Alm I 10 in iA pp 46916-4738
Fabio Acerbi134
Lrsquounico testo non elencato qui sopra o nelle note e che contenga tabelle operazionali egrave il commentario eutociano a Circ 3-4 Il testo ar-chimedeo che Eutocio e noi con lui leggeva egrave particolarmente conciso ed egli verifica esplicitamente il sussistere di certe relazioni numeriche Si tratta in ognuno dei nove casi presenti di mostrare che il lsquoteorema di Pitagorarsquo egrave verificato con ottima approssimazione dai valori numerici di opportune terne di rette Eutocio esegue le tre moltiplicazioni dei valori per se stessi e mostra che la somma o la differenza di due dei risultati si discosta di poco dal terzo30 I numeri in questione sono interi seguiti o no da una parte non intera espressa come somma di frazioni unita-rie31 I nove gruppi di tre moltiplicazioni una a fianco allrsquoaltra sono organizzati in forma tabellare ma senza lrsquoausilio di linee separatrici32 le operazioni sono eseguite disponendo lsquoin colonnarsquo i risultati delle mol-tiplicazioni parziali e sommandoli esattamente come facciamo oggi poicheacute sono in gioco numeri interi con parti frazionarie unitarie e la notazione non egrave posizionale non egrave necessario che gli incolonnamenti siano esatti (unitagrave di un risultato parziale sotto le decine del precedente ecc) Sono inclusi nella tabella istruzioni e commenti in linguaggio corrente33 le prime relative allrsquooperazione da affettuare sui risultati delle
30 Eutocio non calcola radici quadrate approssimate per quanto ciograve si renda piugrave volte necessario fornisce il risultato e verifica la sua correttezza moltiplicandolo per se stesso Egli dichiara che il lettore interessato a questo procedimento di calcolo puograve rivolgersi Ἥρωνι ἐν τοῖς μετρικοῖς [hellip] Πάππῳ καὶ Θέωνι καὶ ἑτέροις πλείοσιν ἐξηγουμένοις τὴν μεγάλην σύνταξιν τοῦ Κλαυδίου Πτολεμαίου laquoa Erone nei Metrica [hellip] a Pappo e Teone e a svariati altri inter-preti della Grande composizione di Claudio Tolomeoraquo (AOO III p 23213-17)
31 Troviamo ad esempio ͵αωλη θ´ ια´ cioegrave 1838 + 19 + 111 notare il singolo apice per le frazioni unitarie
32 Essi sono editi in AOO III pp 234-256 La tradizione medievale del commentario eutociano che coincide con un ramo di quella archimedea e deriva da un codice appar-tenuto a Giorgio Valla perduto in etagrave rinascimentale ma riprodotto a volte con fedeltagrave assoluta negli apografi (si veda ad esempio nella tav 1a la riproduzione dellrsquoerronea di-sposizione di cifre e parte algoritmica nel primo gruppo di moltiplicazioni offerta dal Laur Plut 284 f 160r) egrave costituita da Marc gr 305 ff 142v-146v Laur Plut 284 ff 159r-164r Par gr 2360 ff 109v-113v Par gr 2361 pp 410-421 Nel codice veneziano in cui la disposizione per righe e colonne egrave irrimediabilmente alterata dal copista le operazioni sono cancellate con tratti di penna Il primo manoscritto fu esemplato per Bessarione da Giorgio Trivizias tra il 1455 e il 1468 (Mioni 1976 pp 309-312) il secondo fu vergato da Giovanni Scutariota in scrittura di imitazione (Martinelli Tempesta 2010 p 173 n 7 Rollo 2012) ca 1491-1492 il terzo fu trascritto per il cardinale di Firenze Niccolograve Ridolfi dopo che la biblioteca di Valla era stata acquistata a seacuteguito della sua morte avve-nuta il 23 gennaio 1500 per 800 scudi drsquooro da Alberto Pio di Carpi (nota del copista al f 120v) il quarto fu terminato per mano di Christopher Auer su commissione di Georges drsquoArmagnac il primo gennaio 1544 (sottoscrizione a p 474 del codice si veda RGK II nr 525)
33 A questi va aggiunto posto davanti al risultato finale di ogni moltiplicazione il segno convenzionale per ὁμοῦ laquoinsiemeraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 135
prime due moltiplicazioni34 i secondi alla bontagrave dellrsquoapprossimazione ottenuta35 Ogni gruppo di operazioni che chiude unrsquounitagrave esegetica ed egrave seguito dalla citazione che apre la successiva egrave trascritto come se facesse parte del testo a tutta pagina e preceduto dallrsquoindicazione οἱ δὲ πολλαπλασιασμοὶ ὑπόκεινται laquole moltiplicazioni sono poste qui sottoraquo Questi due fatti suggeriscono che tutte le operazioni cui Eutocio non fa alcun riferimento nel corpo del suo commentario siano unrsquoaggiunta editoriale risalente a Isidoro di Mileto che si occupograve della revisione del testo36
Gli incolonnamenti esatti sono invece necessari quando siano moltiplicati numeri con parti non intere espresse nel sistema sessage-simale in quanto la somma finale dei prodotti parziali va effettuata ordine per ordine Tale somma eccederagrave di norma il valore di 60 per un ordine dato nella tabella occorre pertanto trovare posto anche per i riporti che vanno sommati ai prodotti parziali dellrsquoordine preceden-te e quindi incolonnati con essi I testi ci offrono alcuni esempi di tabelle operazionali moltiplicative di questo tipo Teone afferma espli-citamente che la prima moltiplicazione che va a descrivere ha una rap-presentazione tabellare la cui disposizione ritroviamo pesantemente ingarbugliata nel Laur Plut 2818 f 35r37 Alla seconda occorrenza di una moltiplicazione eseguita (tav 1b Laur Plut 2818 f 65r) gli incolonnamenti sono meglio rispettati anche se il risultato finale egrave fatto erroneamente slittare di un posto verso destra i riporti (con un errore) si trovano nella penultima riga38 Nei Prolegomena ad Alma-gestum alcune moltiplicazioni sono accompagnate da tabelle quella meglio attestata egrave associata alla moltiplicazione di 67 4 55 per se stesso (sezione i nel riassunto fornito supra) ed egrave descritta additando sempli-cemente ad un ente materiale oramai inaccessibile forse tracciato in loquendo lsquoalla lavagnarsquo
34 Come λοιπὸν τὸ ἀπὸ ΕΓ laquoresta quello su ΕΓraquo seguito dal risultato della sottrazione di due quadrati
35 Come λείπει ἄρα μο β εἰς τὸ ἀκριβές laquomancano quindi 2 u(nitagrave) al risultato esattoraquo36 Si legga la sottoscrizione spuria ad AOO III p 26010-1237 Si legga la frase ἐκτίθεμαι αὐτὴν καὶ πάλιν αὐτὴν ὑφ᾽ αὑτὴν ὡς ὑπογέγραπται laquolo [scil il
valore del lato da moltiplicare per se stesso] dispongo lsaquouna voltarsaquo e di nuovo al sotto di se stesso come trascritto qui sottoraquo in iA p 45817 Il Laur Plut 2818 (Teone e Pappo Commentaria in Almagestum) egrave uno dei piugrave antichi manoscritti in minuscola sicuramente assegnabile alla prima metagrave del IX secolo (Follieri 1977 p 144 n 23 Maas 1927 p 76 n 17 riteneva che fosse piugrave antico del Tetraevangelo Uspenskij) per una sua analisi si veda Rome 1938
38 In nessuno dei due casi i numerali di molteplicitagrave sono segnalati con apici sono tutti sormontati da una barra si veda la sezione 4 punto b
Fabio Acerbi136
προκείσθω δὶς τὸ μῆκος αὐτῆς ὀφεῖλον τὴν τάξιν τοῦ κατὰ τοὺς πολλαπλασιασμοὺς κανόνος ἀποδοῦναι καὶ ἐκκείσθω ἐπὶ σελιδίων διαγεγραμμένων οὕτω καὶ δὴ αὐτῆς ἐφ᾽ ἑαυτὴν πολ-λαπλασιασθείσης γεγονέτωσαν τὰ ἐν τοῖς οἰκείοις σελιδίοις εἴδη ταῦτα δὴ συναγόμενα καθ᾽ ἣν ὑπεδείξαμεν τάξιν ποιήσει τὰς ὑπογεγραμμένας μοίρας ἢ καὶ λεπτά τινα εἴσι ͵δυϙθ νθ´ ιδ´´ ι´´´ κε´´´´ ὡς λείπειν τοῦ ἐπιμερισθῆναι ŏ ŏ με´´ μθ´´´ λε´´´´
che sia prescritto che la sua lunghezza debba figurare due volte nella disposizione della tavola delle moltiplicazioni e che lsaquoquestrsquoultimarsaquo sia disposta su colonne delimitate da linee cosigrave mdash E pertanto una volta moltiplicato lsaquoil latorsaquo per se stesso che le specie trovino posto nelle colonne appropriate quelle che vengono cosigrave raccolte secondo la disposizione che abbiamo indicato produrranno dunque i gradi o anche i minuti qui sotto trascritti 4499 59 14 10 25 in modo che dalle divisioni successive resti39 0 0 45 49 35
La tabella associata (tav 2a Marc gr 313 f 19v) contiene una sola svista grossolana reca 51 invece di 55 in ognuno dei due fattori posti affiancati sopra di essa Al di sotto preceduto dal segno convenzionale per ὁμοῦ egrave collocato il risultato incongruamente sfalsato di un paio di colonne e con la lettera numerale ͵δ priva di barra sormontante in-naturalmente disconnessa da υϙθ I riporti sono indicati dai numerali ι ρκγ´ η´´ ν´´´ posti al fondo delle prime quattro colonne Il calcolo egrave corretto in ogni sua parte
Il clou in questo piccolo spaccato delle interazioni testo-paratesto matematico risiede nella descrizione contenuta nei Prolegomena della disposizione tabellare di due procedimenti di divisione il primo ano-nimo e quindi da supporre tradizionale il secondo piugrave efficiente ed attribuito al matematico del IV secolo Pappo
Il primo metodo di divisione egrave sostanzialmente analogo a quello che usiamo attualmente Dividendo e divisore questrsquoultimo preceduto da un segno su cui ritorneremo nella prossima sezione sono posti uno sotto lrsquoaltro intervallati da una riga inizialmente vuota Primo passo viene reperito il massimo multiplo del divisore che sia minore del di-videndo esso viene trascritto sotto il dividendo nella prima lsquocasellarsquo della riga vuota recante in testa un segno per laquosottrairaquo il fattore mol-tiplicativo (o quoziente parziale) viene trascritto in una lsquocasellarsquo pre-ceduta da un segno per laquorisultaraquo sotto il divisore Secondo passo il massimo multiplo viene sottratto dal dividendo il resto cosigrave ottenuto egrave trascritto preceduto da un segno per laquorestoraquo in una casella posta
39 Lrsquoautore concettualizza il procedimento di estrazione di radice quadrata come una forma di divisione
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 137
accanto al dividendo40 I due passi precedenti sono quindi ripetuti con la sola differenza che il resto appena ottenuto prende il posto del divi-dendo il quoziente parziale scala di un ordine sessagesimale ad ogni passo41 E cosigrave via aggiungendo ogni volta due caselle La debolezza di questo metodo come di quello che utilizziamo attualmente risiede nel fatto che il reperimento dei quozienti parziali (ovverosia dei massimi multipli) viene effettuato per tentativi non riuscire a farlo al primo colpo appesantisce notevolmente i calcoli successivi e costringe ad un lavoro di riordino e addizione dei quozienti parziali stessi La tabella risultante dove appunto osserviamo questo fenomeno in parallelo con identiche inaccuratezze nella descrizione ha la forma riprodotta unico tra i manoscritti della recensione antica nel Marc gr 313 f 13r (tav 2b invito il lettore a non rivolgersi alle tavole se non dopo aver termi-nato questa sezione sarebbe anzi auspicabile che tentasse di ricostruire questa tabella e le due successive a partire dalla mia descrizione)42
Il secondo metodo di divisione attribuito a Pappo egrave congegnato in modo da rendere non aleatoria la ricerca dei quozienti parziali Come altrove nei Prolegomena la descrizione della procedura di calcolo si riag-gancia esplicitamente a una frase di Tolomeo laquouna volta dimostrato che il periodo di una singola rivoluzione lsaquodel solersaquo egrave di 365 giorni 14 48 se di-vidiamo per essi i 360 gradi di un singolo cerchio avremo il moto medio giornaliero del sole circa 0 gradi 59 8 17 13 12 31raquo43 Questrsquoaffermazione si trova nel terzo libro dellrsquoAlmagesto si tratta della prima occasione in cui viene effettuata una divisione in cui il divisore egrave maggiore del dividendo e i commentatori del trattato tolemaico non si fecero sfuggire lrsquooccasione di mostrare come eseguirla Ora il terzo libro del commentario di Pappo non ci egrave pervenuto Ci resta dunque come testo parallelo a quello dei Prolegomena la descrizione rigidamente formulare in Teone sicuramente un calco di quella pappiana Teone qui come nelle altre applicazioni del metodo (Laur Plut 2818 ff 136v [tav 3] e 190r) descrive brevemente ed espone esplicitamente la stessa tavola dei sottomultipli del divisore che
40 Esempio nella divisione di 378 per 17 il massimo multiplo egrave 374 il quoziente parziale egrave 22 il resto 4 e in effetti 378 = 374 + 4 = 17times22 + 4 Si noti che il segno per laquorestoraquo non egrave apposto in testa di riga ma davanti a ogni resto parziale e in effetti il dividendo che si trova in prima posizione in questa riga non egrave un resto
41 Analogamente nellrsquoalgoritmo moderno poniamo la virgola o scaliamo la cifra di un posto
42 Nei Prolegomena la descrizione della tabella associata al metodo anonimo egrave pre-ceduta da una breve sinossi dellrsquooperazione in stile procedurale (cioegrave senza riferimenti alla tabella) e seguita dalla sua esecuzione accurata ma con pochi riferimenti alla tabella se non quello ai due segni da apporre ai resti parziali e ai massimi multipli
43 Alm III 1 in POO I 1 p 2091-4
Fabio Acerbi138
troviamo nei Prolegomena ma non offre alcuna descrizione della disposi-zione tabellare della divisione stessa neacute vi fa riferimento
A questa procedura sono in effetti associate una tavola e una tabel-la costruite come segue (tavv 4 e 5 Marc gr 313 ff 17r e 17v il co-pista era ndash giustamente ndash insoddisfatto della prima versione) La tavola le cui righe e colonne sono delimitate da linee contiene sottomultipli44 del divisore 365 14 48 9 righe che riportano i valori da 160 a 960 piugrave altre 6 con i valori per decine da 1060 a 6060 la prima colonna elenca le 15 parti sessagesimali omettendo come drsquoabitudine la laquodenomina-zioneraquo dellrsquoordine (i numerali elencati sono quindi α β γ δ ε ϛ ζ η θ ι κ λ μ ν ξ) la seconda i sottomultipli corrispondenti organizzati su quattro colonne per tener conto dei tre ordini sessagesimali (il primo sottomultiplo egrave quindi ϛ ε´ ιδ´´ μη´´´ cioegrave 160 di τξε ιδ´ μη´´) La tabella priva di linee delimitanti espone la vera divisione Nella prima colonna troviamo i resti parziali ognuno preceduto dallrsquoindicazione del proprio ordine sessagesimale e da un segno per laquorestoraquo Nella seconda preceduti da un segno per laquosottrairaquo i sottraendi ognuno coincide ovviamente con uno dei sottomultipli nella tavola La terza colonna contiene se-guiti dallrsquoindicazione del proprio ordine sessagesimale i quozienti par-ziali ottenuti trascrivendo dalla prima riga della tavola il numerale corrispondente al sottraendo affiancato ed assegnando come ordine sessagesimale il successivo a quello posto in testa di riga Il risultato preceduto da un segno per laquorisultaraquo e posto al di sotto della tabella si ottiene sommando i quozienti parziali il procedimento non permette in generale di determinare lrsquointero quoziente parziale relativo ad un ordine sessagesimale fissato se non dopo due passi Una linea spezzata unisce i resti parziali successivi e i relativi sottraendi per evidenziare la laquoprogressione della proceduraraquo la spezzata lsquosaltarsquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore (le cui righe sono per il resto vuote) e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue di conseguenza anche il quoziente parziale relativo a questo resto appartiene allrsquoordine sessagesimale successivo
A questo punto possiamo rivolgerci alle tavv 4-5 e verificare se le immagini che ci siamo formati sulla base della mia descrizione corri-spondono a quelle che troviamo nel Marc gr 313 Non si tratta di un giochetto sterile egrave al contrario il cuore di un intrico di problemi Un primo ordine di problemi deriva dal fatto che nei Prolegomena lrsquoalgo-
44 Sottomultipli e non multipli in quanto il divisore egrave maggiore del dividendo Drsquoaltronde nel sistema sessagesimale come in quello decimale un sottomultiplo si ottiene dal multiplo corrispondente semplicemente scalando tutte le cifre di un posto (ad esempio 1360 di 365 14 48 si ottiene in questa maniera da 13 volte 365 14 48)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 139
ritmo della divisione lsquoalla Papporsquo non egrave mai eseguito (cioegrave formulato verbalmente) in maniera indipendente dalla descrizione della tabella Comrsquoegrave dunque possibile descrivere una tabella operazionale che non ha uno statuto testuale indipendente sulla base di un algoritmo in corso di esecuzione E drsquoaltro canto come non rilevare unrsquoanomalia in un algoritmo eseguito nella sua forma primaria sotto forma di descrizione di una tabella Ci potremmo chiedere se viene descritto lrsquoalgoritmo o la tabella La tensione fra i due enti grafici egrave acuita dal fatto che nei nostri testi tutto ciograve (esposizione o descrizione di un algoritmo o della tabella associata) avviene sempre e solo sulla base di un esempio numerico para-digmatico Per questo motivo la tabella in quanto struttura (cioegrave privata dei dati numerici accidentali) non puograve fare a meno della descrizione45 Dal canto suo Teone come forse Pappo ancor prima descrive ed espone la tavola dei (sotto)multipli ma non la tabella di divisione lrsquoalgoritmo relativo a questrsquoultima egrave espresso come per controbilanciare in maniera eccezionalmente trasparente e formulare Se ciograve comporta un guada-gno a livello verbale-argomentativo sorge un problema operativo grave come e dove sistemare i resti e i quozienti parziali ndash cioegrave tutti i numeri in output dellrsquoalgoritmo differenti dai (sotto)multipli ndash che la tabella si incarica di disporre in modo lsquonaturalersquo Teone prescrive soltanto di confrontare i resti con la seconda colonna della tavola dei sottomultipli e di trascrivere via via il quoziente ottenuto dopo ogni passo Insomma come eseguire materialmente una divisione Non certo adattando ad un nuovo caso specifico la formulazione dellrsquoalgoritmo che Teone propone
Un secondo ordine di problemi e una trappola micidiale per il co-pista egrave interno alla dialettica lsquotabellarsquolsquosua descrizionersquo ed egrave in assenza di simbolismo quello dei riferimenti linguistici da adottarsi nella seconda agli enti grafici che figurano nella prima Occorre ricercare la massima generalitagrave fornita da una descrizione definita di un ente numerico (ad esempio impiegando il termine laquorestoraquo o la perifrasi laquomassimo sotto-multiplo minoranteraquo) o basta assumere direttamente il suo valore speci-fico come esempio paradigmatico E in che modo risolvere il conflitto tra uso e menzione se come nel nostro caso la tabella contiene segni convenzionali ed occorre fornirne una descrizione Si rende ad esempio necessario introdurre un lsquooperatore di citazionersquo noi useremmo le virgo-lette la lingua greca premette lrsquoarticolo neutro Drsquoaccordo ma nel caso
45 Questa caratteristica non egrave connaturata alla matematica degli algoritmi la risorsa dello lsquostile proceduralersquo serve esattamente ad aggirare questo problema al di lagrave di un certo livello di dettaglio perograve essa condurrebbe ad un appesantimento insostenibile della for-mulazione dovuto alla pluralitagrave dei riferimenti agli oggetti matematici in gioco sulla que-stione dei diversi stili della matematica greca si veda Acerbi 2012
Fabio Acerbi140
greco qual egrave il suo range E come distinguerlo nei casi ambigui da un semplice articolo che precede un sostantivo quando questrsquoultimo lo ri-chieda Nel corso del processo di copia del testo della descrizione infine possono generarsi tensioni tra enti grafici interpretabili vuoi come segno convenzionale vuoi come abbreviazione Ambiguitagrave relative a questi punti opacizzano la descrizione Un problema analogo si porrebbe a priori nella dialettica tra uso delle lettere denotative per designare enti geometrici e loro menzione nella costruzione di un diagramma ma esso egrave risolto con lrsquoazzeramento della seconda funzione le lettere denota-tive sono sempre usate allrsquointerno del testo (sono cioegrave il referente degli oggetti geometrici di cui tratta il discorso matematico) mai menzionate (come accadrebbe se fossero il referente di oggetti grafici posti nel dia-gramma) Insomma il codice adottato per la costituzione dei diagrammi geometrici egrave condiviso (cioegrave canonizzato) semplice e perspicuo mentre quello per le tabelle operazionali non lo egrave da qui le sviste dei copisti e le trascuratezze di correttori ed editori
Infine chi vuole apprendere da questi testi come eseguire una divi-sione a cosa deve prestar fede se ad esempio a causa di errori di copia la descrizione finisce per non coincidere con la tabella operazionale visto che sono entrambe due maniere valide di eseguire lo stesso algoritmo Dopo tutto lo scopo di tutta questa macchina grafico-argomentativa egrave di insegnare a eseguire divisioni in formato tabellare Questo problema si fa particolarmente acuto se la tabella non egrave trasparente nel metodo di Pappo lo egrave quasi completamente in quello anonimo no E gli errori che riscontreremo nella (doppia) tabella ai ff 17r-v del Marc gr 313 a chi sono attribuibili Allrsquoautore al trascrittore o al copista medievale
Questo groviglio di problemi riceve alcune risposte sorprendenti dalla tradizione manoscritta come andiamo finalmente a vedere
4 Analisi delle testimonianze
I codici che ho adibito per lrsquoedizione sono i seguenti M = Marc gr 31346 C = Marc gr 314 (Tolomeo Tetrabiblos et opera minora cum commentariis Vezio Valente Anthologiae)47 Z = Vat gr 2326 (fattizio
46 Riferibile al sec IX ex-X in accolgo la datazione suggeritami per litteras il 522005 da Nigel G Wilson si veda anche Agati 1992 pp 141-142 La presenza non sistematica degli accenti che fa anticipare a Wilson la datazione di laquosaec X medraquo fornita in Mioni 1985 p 24 indusse Boris Fonkič (2005 non vidi) ad assegnare il codice allrsquoinizio del IX secolo
47 Il manoscritto riferibile alla seconda o terza decade della prima metagrave del XIV secolo fu vergato da Michele Clostomalle olim lsquoMetochitesschreiberrsquo Bianconi 2005a pp 428-430 Il titolo dei Prolegomena in questa trascrizione identico in grafia ma non in formulazione a
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 141
e mutilo Tolomeo Almagestum) S = Vat gr 184 (varia astronomica scholia miscellanea ad Almagestum Tolomeo Almagestum) P = Par gr 2390 (varia astronomica) gli ultimi tre riferibili allo scorcio del XIII secolo48 e apografi sicuri del Vat gr 159449 attualmente mutilo di due fascicoli che ci privano dei due terzi finali dei Prolegomena M e il Vat gr 1594 ammettono un modello comune il resto della tradizione (25 trascrizioni in tutto) dipende dagli apografi appena citati del Vat gr 1594 Le varianti della recensione bizantina che leggiamo tra lrsquoaltro nei Vat gr 198 Marc gr 310 (Tolomeo Almagestum cum commentariis Pappi Theonis et Cabasilae) e con ulteriori modifiche Laur Plut 89 sup 48 (varia astronomica Tolomeo Almagestum Barlaam Logistica) sono identificate dal siglum K e si trovano punteggiatura originale in-clusa nel secondo apparato50 Lrsquoanalisi delle testimonianze51 costituite ovviamente anche dalle tabelle associate saragrave condotta nella forma di una sequenza di osservazioni indicizzate da numerali o lettere oltre che di alcune note a piersquo di pagina
Iniziamo dalla descrizione del metodo di divisione anonimo
quello che leggiamo nel Vat gr 1594 (questrsquoultimo coincide con quello adottato nella recen-sione bizantina) fu apposto da Niceforo Gregora e successivamente corretto da Bessarione
48 Sto studiando il primo e il terzo codice in collaborazione rispettivamente con Daniele Bianconi e Inmaculada Peacuterez Martiacuten
49 Su questo codice risalente alla seconda metagrave del IX secolo e sulla sua collocazione nella lsquocollezione filosoficarsquo per prima proposta in Follieri 1977 pp 145-146 si vedano almeno Perria 1991 pp 82-88 Ronconi 2013 Che il titolo dei Prolegomena nel Vat gr 1594 sia stato apposto da Niceforo Gregora egrave stato riconosciuto per la prima volta in Mazzucchi 1994 p 211 n 196 si veda Bianconi 2005a p 418 per altri interventi di Gregora nello stesso manoscritto
50 Il Vat gr 198 egrave stato vergato dal copista Malachia nel corso del terzo quarto del XIV secolo Mondrain 2004 pp 278-290 e 292 Allo stesso copista (denominato non a caso prima dellrsquoidentificazione anonymus Aristotelicus) dobbiamo un buon numero di trascrizioni aristoteliche con i relativi commentari in margine Gli dobbiamo anche il Par gr 2342 secondo tomo di un quadrivium quasi completo di cui il Vat gr 198 egrave il primo nellrsquoordine aritmetica armonica astronomia (Almagesto e commentari relativi) nel codice vaticano geometria ed ancora astronomia (corpus astronomico minore) in quello parigino le opere trascritte sono sempre accompagnate in margine dai relativi commentari Il copista del Marc gr 310 egrave Isacco Argiro (ca 1300-1375) Mondrain 2007 p 166 Allo stesso Argiro dobbiamo il codice laurenziano (Daniele Bianconi per litteras) Poicheacute la recensione modificata che leggiamo nel Laur Plut 89 sup 48 egrave senza alcun dubbio basata su quella nel Marc gr 310 e non viceversa ci troviamo di fronte ad un copista che trascrive due volte lo stesso testo in due versioni leggermente differenti la conclusione naturale egrave che la seconda recensione egrave dovuta ad Argiro stesso la questione andragrave studiata in dettaglio
51 Nei manoscritti citati i Prolegomena si trovano ai fogli seguenti Vat gr 1594 ff 1r-8v (mutilo mancano due fascicoli su tre) Marc gr 313 ff 1r-28r (incompleto man-cano due fogli allrsquoinizio e il f 6 attualmente rimpiazzato da uno bianco) Marc gr 314 ff 235r-255r Vat gr 2326 ff 19r-40v e 43r-v (incompleto e con i fascicoli in disordine) Vat gr 184 ff 10r-23v Par gr 2390 ff 1r-13v Vat gr 198 ff 127r-136v Marc gr 310 ff 1r-13r Laur Plut 89 sup 48 ff 7r-19r
Fabio Acerbi142
ἐκθέμενοι οὖν διάγραμμα τῶν ἀριθμῶν ὡς ὑπόκειται προτάσσομεν τὸν μεριζόμενον καὶ μικρὸν ὑπ᾽ αὐτὸν τὸν μερίζοντα ὡς ἔχει τὸ διάγραμμα ἐν στίχοις διοριζομένοις ὑπὸ γραμμῶν [hellip] καὶ τὰ μὲν γινόμενα ἐγγὺς ἐλάττονα ἐν τῇ μεταξὺ θέσει τοῦ μεριζομένου καὶ τοῦ μερίζοντος ἐν στίχοις παρασημειοῦσθαι πρὸς τὸ ἀσύγχυτον εἶναι τὴν τάξιν τὰ δὲ μεθ᾿ ὧν ὁ μερίζων ἐποίει τοὺς ἀεὶ ἐλάσσονας ὑπὸ τὸν μερίζοντα σημειοῦσθαι προγράφοντας ἐπὶ τοῦ στίχου αὐτῶν τὸ γίνεται οὕτως γι ἐν δὲ τῷ στίχῳ τῶν μεριζόντων τὸ παρὰ ἔχον οὕτως oslash ἀντὶ τοῦ παρ᾿ ἃ δεῖ τὸν μερισμὸν γίνεσθαι ἐν δὲ τῷ στίχῳ τῶν ἐλασσόνων τὸ αφ διὰ τὸ τούτους ἀεὶ ἀφαιρεῖσθαι ἀπὸ τῶν ἐπάνω τῶν μεριζομένων ἐν δὲ τοῖς τοῦ μεριζομένου λοιπάσμασι τοῖς καὶ ἐπιοφείλουσι τὸ λ κατὰ τὸ ἴδιον τῶν διαστάσεων ἑκάστης ndash λέγω δὴ λοιπάδος ndash ἀντὶ τοῦ λοιποὶ οἱ μέλλοντες ἐπιμερίζεσθαι
2 post τὸν suprascr τὸν ἐλάττονα m 2 S 5 πρὸς] MP et ex corr Z κατὰ S om C | ἀσύγχυτον] MSPC -χητον Z 6 ἀεὶ] MZPC ὡσεὶ S 7 γίνεται οὕτως γι ] γι τ οὕτως γι τ M γί οὕτως γί Z γι οὕτως γί SC τὸ γινόμενον οὕτως γίνεται P 8 τὸ παρὰ ἔχον οὕτως] scripsi τὸ παρέχον οὕτως M et π(αρ-) comp Z οὕτως τὸ περιέχον S προγράφοντας οὕτως ex corr m 2 P τὸ περιέχον οὕτως C | oslash] MZSC (sed ο fecit | Z) ἐλάττων comp ex corr m 2 P | παρ᾿ ἃ] scripsi παρα M π(αρα) comp ZSC ex παρα fe-cit παρὰ et τοῦτον suprascr m 2 P 9 γίνεσθαι] comp C | αφ ] αφ ε M ἀφ ZSC ἀφαί P | ἀεὶ] om M 11 ἐπιοφείλουσι] MZSC ex ἐπιο- fecit ἐπο- m 2 P | λ] MZPC λ´ S 12 λοιποὶ] PC λοιποῦ MZS
3 στίχοις] στίχῳ K 5 πρὸς] διὰ K 7 ἐπὶ mdash γι ] τὸ γίνεται διὰ τοιούτου σ(ημείου) γί K 8 τὸ παρὰ ἔχον mdash παρ᾿ ἃ] τὸ παρᾱ διὰ σ(ημείου) τοιούτου καὶ τοῦτο oslash δηλοῦντος τοῦ παρᾱ ὅτι παρὰ τὸν τοιοῦτον (ἀριθμὸν) K 9 αφ διὰ τὸ τούτους] ἀφ δηλοῖ δὲ τοῦτο ἀφαίρεσ(ιν) ὅτι τούτους ἀεὶ δεῖ K 11 ἐπιοφείλουσι] ἐπιμερίζεσθαι ὀφείλουσι K | λ] λ οι` K 12 ἀντὶ τοῦ] δηλοῦντος τοῦ σ(ημείου) τὸ K
lsquoRendendo esplicito un diagramma numerico come lo troviamo qui sotto disponiamo in primo luogo il dividendo e un poco al di sotto di esso il divisore come li ha il diagramma in righe delimitate da linee [hellip] e lsaquooccorreragraversaquo nella posizione tra il dividendo e il divisore annotare lrsquouno accanto allrsquoaltro i piugrave vicini lsaquodei numerirsaquo minori che risultano affincheacute la disposizione non sia confusa quelli con cui il divisore faceva ogni volta i lsaquonumerirsaquo minori annotarli sotto il divisore scrivendo in prima posizione sulla loro riga laquorisultaraquo cosigrave Ris nella riga dei diviso-ri52 invece laquoperraquo fatto cosigrave53 P in luogo di laquoquelli per cui deve farsi la divisioneraquo nella riga dei lsaquonumerirsaquo minori laquosottrraquo in quanto questi sono sempre sottratti dai dividendi che si trovano sopra nei residuli del dividendo (occorre ben farlo anche per loro) laquoReraquo in accordo con ciograve
52 I laquodivisoriraquo sono al plurale ma siamo semplicemente di fronte a un tratto idioma-tico della lingua greca nel caso di espressioni generalizzanti crsquoegrave soltanto un divisore che occupa lrsquounica colonna di cui si compone la sua riga
53 Si intenda ἔχον οὕτως = ita se habens
1
5
10
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 143
che egrave proprio agli scarti di ciascuno ndash intendo qui lsaquociascunrsaquo residuo54 ndash in luogo di laquoresti che vanno a essere divisi ulteriormenteraquorsquo
a) Operatori di citazione e segni convenzionali I segni introdotti sono quattro la mia discussione egrave condotta dando per scontato che essi siano identici a quelli impiegati dallrsquoautore dei Prolegomena anche se si tratta di unrsquoipotesi non corroborabile neacute falsificabile
i Segno per il risultato Lrsquoabbreviazione convenzionale per γίνεται egrave identica al segno introdotto dallrsquoautore e i copisti si dividono tra i due errori possibili scrivere due abbreviazioni o risolverle entrambe Un fenomeno del tutto analogo si riscontra nel Matr 4678 il manoscritto alla base di tutta la tradizione degli Arithmetica di Diofanto al momen-to della definizione dellrsquoἀριθμός (lrsquolsquoincognitarsquo nel nostro linguaggio) ὁ δὲ μηδὲν τούτων τῶν ἰδιωμάτων κτησάμενος ἔχων δὲ ἐν ἑαυτῷ πλῆθος μονάδων ἄλογος ςο` καλεῖται ς` ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον τὸ ς` laquoil lsaquonumerorsaquo che non possiede nessuna di queste proprietagrave ma che ha in seacute una molteplicitagrave indefinita di unitagrave egrave chiamato lsquonumerorsquo e il suo segno egrave ς`raquo Qui solo il terzo dei tre ς ha una barra a sormontare per segnalarne il carattere puramente denotativo (cioegrave di segno convenzionale e non di abbreviazione si veda il punto successivo)55 il primo egrave una delle abbreviazioni piugrave diffuse per ἀριθμός (e infatti egrave dotato del compendio per la desinenza e dellrsquoaccento grave) il secondo egrave una delle piugrave comu-ni per καὶ () Giovanni Cortasmeno autore di capillari annotazioni infra lineam agli Arithmetica nel codice madrileno scioglie il primo ςο`
54 Doppia variatio che impiega al posto di λοιπόν laquorestoraquo i due termini decisamente non canonici τὸ λοίπασμα e ἡ λοιπάς (piugrave oltre leggiamo anche il participio λοιπασθέντα) Una ricerca sul TLG in rete non ha fornito occorrenze del primo si tratta dunque di uno hapax Quanto al secondo che ricorre anche nella sezione sulla divisione lsquoalla Papporsquo lo si rintraccia giagrave nei papiri documentari il termine diventeragrave perograve canonico nelle esposizioni bizantine drsquointroduzione allrsquoAlmagesto ricalcate sul modello dei Prolegomena (si veda la nota 87 infra) Questi due termini designano i resti parziali prodotti nel corso di una divisione lunga li ho tradotti rispettivamente con il neologismo laquoresiduloraquo e con il sostantivo pari-menti non canonico laquoresiduoraquo
55 Il copista interpreta erroneamente il terzo segno come unrsquoabbreviazione e qui ag-giunge un apice inverso (cioegrave un accento grave) altrove lo scioglie direttamente in forme opportune di ἀριθμός Matr 4678 f 58v La frase come la leggiamo nel manoscritto egrave cor-rotta sulla base di una parafrasi in Psello (edita in DOO II p 3710-12) Tannery emendograve ἄλογος in ἀόριστον DOO I p 64-5 et app Il Matritensis vergato da due copisti differenti (cambio di mano a tre righe dalla fine del f 62r) contiene lrsquoIntroductio arithmetica di Nicomaco e le opere diofantee oltre ad alcuni brevi opuscoli musicali la sua data egrave stata recentemente corretta dal XIII al secolo XI pm in Peacuterez Martiacuten 2006 (una riproduzione digitale del manoscritto si trova allrsquoindirizzo httpbdhbneesbnesearchbibliotecaDio-fanto20de20AlejandrC3ADa)
Fabio Acerbi144
in ἀριθμός ed aggiunge un altro segno56 sopra il terzo anteponendovi lrsquoindicazione καὶ ἔστιν αὐτοῦ σ(ημεῖον) τόδε Va da seacute che non abbiamo nessuna garanzia che il segno originariamente introdotto da Diofanto coincidesse realmente con unrsquoabbreviazione convenzionale per ἀριθμός Lrsquoevidenza del PMich III 144 (sec II in) suggerisce drsquoaltronde che il Matritensis e con esso tutta la tradizione medievale di Diofanto ripro-duca fedelmente pur accentuandone la sinuositagrave il segno originario
ii Segno per il divisore Un cerchiolino sbarrato da non confondere con il segno per ὁμοῦ che nei manoscritti matematici ha di norma due barre trasversali (cf tav 2a) Non sono riuscito a rintracciarne ulteriori occorrenze in altre opere la forma che esso assume nel Vat gr 2326 e la correzione apportata nel Par gr 2390 lasciano aperta la possibilitagrave per quanto a mio avviso remota che la forma originaria non fosse lon-tana da unrsquoabbreviazione di παρά registrata nei repertori57 Il correttore del Par gr 2390 trasforma in effetti il segno oslash nellrsquoaffine abbreviazione canonica per (forme di) ἐλάσσων laquominoreraquo58 e si incarica diligente-mente di farlo notare ricapitolando i segni nella porzione superiore del margine esterno del f 7v Nello stesso margine egli traccia anche uno lsquoscolio tabellarersquo ed egrave lrsquounico a porre il (proprio) segno dove indicato dalla descrizione (tav 6 Par gr 2390 f 7v) Oltre a ciograve adattando la tabella al margine ristretto lo scoliaste trascrive come colonne affian-cate le due righe dei resti parziali e dei massimi multipli e aggiunge le indicazioni ὁ μεριζόμενος laquodividendoraquo e ὁ μερίζων laquodivisoreraquo ma vi introduce alcune incongruenze di formato il risultato scritto in verti-cale e la linea verticale di sinistra che separa il divisore dal segno che lo dovrebbe precedere direttamente
iii Segno per i massimi multipli Corrisponde alla semplice abbre-viazione per sospensione della forma verbale ἄφελε laquosottrairaquo in questo
56 Si tratta del segno di ampio uso praticamente identico allrsquoabbreviazione canonica per οὖν
57 Si tratta di un pi a forma di gancio sbarrato da uno slash di troncamento Ce-reteli 1904 tav IX item 7 sub ΠΑΡΑ che rinvia al PVindRain 423 cf anche la forma π` nel POxy LXI 4142 edito in Jones 1999 II pp 26-34 In generale nei papiri e nei manoscritti matematici in maiuscola le preposizioni sono abbreviate facendo seguire un lsquoapostroforsquo alla loro prima lettera Α᾽ Υ᾽ ecc Per la seconda fattispecie di supporto libra-rio si veda in particolare il cosiddetto fragmentum mathematicum Bobiense scriptio inferior databile al V-VI secolo del palinsesto Milano Biblioteca Ambrosiana L 99 sup (Isidoro di Siviglia Etymologiae datazione Cavallo 1977 p 100) pp 113-114 che sono stampate in riproduzione apografa conforme in Belger 1881 (la p 114 egrave riprodotta anche nella tav 10 di Acerbi 2010)
58 Se questa era lrsquointenzione si tratta ovviamente di una forzatura il divisore puograve ben essere maggiore del dividendo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 145
caso lo slash di troncamento taglia orizzontalmente il tratto verticale del phi I copisti offrono molteplici varianti apponendo chi uno spirito dolce chi un ε chi un αί accentato a sormontare Tutti questi segni svolgono la funzione di abbreviazioni vere e proprie (e cosigrave doveva essere anche per lrsquoautore si veda il punto 1 di p 153 infra) la forma originale si ottiene a mio avviso incrociando i dati del Marc gr 313 e dei tre apografi del Vat gr 1594 αφ anche se lrsquoassenza dello spirito potrebbe essere semplicemente dovuta alla pratica del copista del codice veneziano di economizzare nei diacritici
iv Segno per i resti Un lambda completato da una barra a sormon-tare o da un apice che rinvia alle abbreviazioni per sospensione di una forma opportuna di λοιπός laquorestoraquo In realtagrave la forma che troviamo nella tabella egrave differente (tav 2b) e coincide con quella offerta quasi unanimemente dai manoscritti nella descrizione e in almeno un caso nella tabella del metodo di divisione attribuito a Pappo (tav 4) un lambda che accoglie al di sotto una legatura omicron-iota () sbarrata da uno slash di troncamento Qualcosa di simile si trova nel PVindob G 19996 (sec I) una specie di lambda maiuscolo molto aperto e dal vertice arrotondato che include un circoletto interpretato dagli editori come segno per περίεστιν o per λοιπόν59 Lo stesso segno si rintraccia ad esempio in un medesimo scolio tabellare di prima mano ad Alma-gestum nel Vat gr 1594 f 93v e nel Marc gr 313 f 135r ma stavolta la forma del lambda egrave molto ben definita
Fin qui i segni Ma il gioco egrave piugrave complesso La descrizione si muo-ve pericolosamente sulla linea di confine non sempre ben definita tra segno convenzionale e abbreviazione il primo ndash e il repertorio grafico matematico-astronomico ne egrave particolarmente fornito60 ndash puograve anche
59 Ho consultato lrsquoedizione Gerstinger ndash Vogel 1932 pp 46 e 48 la porzione rilevante del papiro egrave riprodotta nella tav 11 di Fowler 1999 Si veda ancora ivi pp 253-257 per la trascrizione di questo segmento di testo (con correzioni rispetto alla princeps) e per una messa a punto recente inclusa la proposta di datazione che ho riportato qui sopra Il verso del papiro che contiene una tavola aritmetica del tutto scorrelata dalla tematica del recto egrave edito come PRain Unterricht 151
60 La pratica di ridurre lo spazio occupato da un testo tecnico per mezzo di abbreviazioni e segni convenzionali era molto diffusa nei manoscritti in maiuscola contrariamente a quanto avviene per altri generi letterari vedremo tra breve cosa accade negli Arithmetica di Diofanto ma si leggano in proposito anche le considerazioni di Hei-berg nei prolegomena alla propria edizione dellrsquoAlmagesto in particolare riguardo al ricorso massiccio ad espedienti brachigrafici nel modello del Vat gr 180 POO II pp lxxxiv-xciii civ-cv cxxvii cxxxviii-cxxxix Agli elenchi dettagliati forniti da Heiberg possiamo aggiungere il piccolo prontuario stampato in Hultsch 1876-1878 III 2 pp 126-132 e basato sul testo e sugli scolii alla Collectio di Pappo nel Vat gr 218 (sec X in) Si vedano infine le osservazioni del copista del Par gr 2360 f 120v trascritte da Heiberg in AOO III pp x-xi sulle laquonotazioni tipiche a scopo di tagliar corto nello scrivereraquo impiegate nel pro-
Fabio Acerbi146
derivare dalla seconda (un caso egrave appunto il segno per ἐλάσσων che probabilmente trae origine da una legatura epsilon-lambda) ma poi il rapporto referente-relato si fissa convenzionalmente Quelli definiti nel testo che abbiamo letto sono appunto segni convenzionali non ci sarebbe bisogno di spiegarne forma e funzione se fossero intesi come abbreviazioni assumono nella tabella una funzione denotativa non esplicativa o discorsiva (come accade invece nella tav 1a) Ma come vengono descritti questi segni
I referenti delle descrizioni sono i segni sono introdotti da οὕτως (item i-ii) o in alternativa da un τό con il ruolo di lsquooperatore di citazionersquo (item iii-iv) che corrisponde esattamente alle nostre virgolette In entram-bi i casi gli enti sono menzionati e svolgono una funzione metalinguistica sono collocati materialmente nel testo ma egrave come se si trovassero fuori e la loro descrizione li additasse ndash in effetti i segni convenzionali scritti nel testo sono a loro volta i relata di quelli che si trovano nella tabella
I relata dei segni scritti nel testo sono di due tipi singoli vocaboli (item i-ii) o descrizioni della funzione dei segni per mezzo di clausole sintaticamente complesse (item ii e iv) I singoli vocaboli sono γίνεται e παρά e sono entrambi preceduti dal τό lsquocitazionalersquo in quanto relata di segni convenzionali le forme abbreviate con cui sono tracciati nei manoscritti vanno forzatamente sciolte Bisogna ammettere che la per-spicacia e le risorse grafiche dei copisti ndash di cui tutto si puograve dire fuor che commettano qui degli errori ndash sono messe a dura prova con lrsquointrodurre segni identici ad abbreviazioni o con lrsquoattivare un gioco metalinguistico particolarmente serrato in un contesto meno lsquonaturalersquo di come potreb-be esserlo ad esempio quello di un trattato grammaticale Lrsquoitem iii che presenta direttamente un segno identico ad unrsquoabbreviazione non egrave sorretto da una descrizione ma da una giustificazione in διὰ τό Lrsquoartico-lo τό vi assume una funzione metalinguistica anche se non lsquocitazionalersquo poicheacute al tempo stesso genera un infinito sostantivato e lo singolarizza per questo ho scritto laquosono sottrattiraquo in corsivo nella mia traduzione
prio modello archimedeo (nota 32 supra) egli ne compila anche una breve lista Un elenco antico di laquosegni della geometriaraquo sicuramente redatto per assistere il copista si trova anche al f 3v del ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 vergato da Efrem negli anni 950-960 (tav 8 in Acerbi 2010) Possiamo farci unrsquoidea quantitativa del guadagno di spazio in rapporto ad un testo privo di abbreviazioni e con le parole separate da spazi sulla base del fragmentum mathematicum Bobiense il testo vi egrave disposto a tutta pagina su 36 righe di circa 30 segni ciascuna nelle due pagine in questione figurano 2038 segni con 15 mezze righe occupate dalle due figure Ora nel testo dellrsquoedizione stabilita in Heiberg 1927 pp 87-90 le stesse pagine contano 4455 segni spazi compresi Ne risulta che la dimensione in caratteri di un testo matematico puograve essere ridotta di piugrave della metagrave con lrsquoimpiego di compendi e segni convenzionali
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 147
Negli item ii e iv il segno si collega ad una descrizione nel secondo caso in via esclusiva le descrizioni pertanto rinforzano o sostituiscono lrsquoidentificazione con lrsquoente linguistico denotato Le clausole descrittive sono precedute da ἀντί e dallrsquoarticolo τό con funzione di lsquooperatore di citazionersquo esse sono παρ᾿ ἃ δεῖ τὸν μερισμὸν γίνεσθαι (item ii) e λοιποὶ οἱ μέλλοντες ἐπιμερίζεσθαι (item iv) Nella descrizione della divisione lsquoalla Papporsquo che leggeremo tra breve i segni negli item iii e iv rice-vono lo stesso trattamento degli altri due il loro relatum egrave un singolo vocabolo e non una clausola descrittiva rispettivamente nelle espres-sioni τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε (sul participio ritorneremo nel punto 1 infra) e τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά (la forma del segno notato con λ οι egrave descritta supra nellrsquoitem iv) La descrizione del segno oslash per il divisore merita una discussione piugrave dettagliata In origine si trovava probabilmente scritto Π(ΑΡΑ)ΕΧΟΝ successivamente letto come π(αρ[α])έχον ndash dato che lrsquoabbreviazione per il preverbo egrave identica a quella per la preposizione (che sia Π᾽ o un pi seguito dal segno per ἄρα a sormontare) ndash invece di π(αρὰ) ἔχον I copisti e i correttori si dettero a tutte le possibili contorsioni per restituire un testo dotato di senso leggere appunto una forma verbale con preverbo modificare il preverbo (ma forse il segno per ἄρα era insidiosamente simile ad uno epsilon) correggere il testo rileggiamo lrsquoapparato sub τὸ παρὰ ἔχον οὕτως τὸ παρέχον οὕτως M et π(αρ-) comp Z οὕτως τὸ περιέχον S τὸ περιέχον οὕτως C προγράφοντας οὕτως ex corr m 2 P Nella clausola descrittiva seguente la presenza liminare di παρὰ (che ho corretto in παρ᾿ ἃ nella speranza di restituire una frase che abbia un senso senza intervenire sul testo) innesca un bel corto circuito il Π(ΑΡΑ) che sicuramente figu-rava nellrsquoarchetipo egrave un sintagma complesso una preposizione unrsquoab-breviazione o un segno per unrsquoabbreviazione Se lrsquoeditore si trova in conflitto con la propria inclinazione alla critica conservativa i copisti si rifiutarono di mettere mano ad un testo che doveva stridere anche per loro essendo il compito demandato al ritocco del revisore del Par gr 2390 o alla riscrittura radicale del recensore bizantino Il problema egrave che ci troviamo di fronte ad unrsquoespressione che descrive la funzione dellrsquooggetto denotato non lrsquooggetto stesso ma che lo contiene al suo interno per soprammercato qui il Π(ΑΡΑ) egrave usato per giustificare una menzione a sua volta relatum di un segno
Evidentemente questa maniera di procedere che giagrave aveva attirato interventi da parte di copisti e correttori della recensione di base parve insostenibilmente opaca allrsquoautore della recensione bizantina61 Egli
61 Uno dei manoscritti di questa recensione propone anche una tabella di divisione
Fabio Acerbi148
modifica tutte le descrizioni diluendo lrsquoidiomatismo dellrsquoarticolo lsquocita-zionalersquo con lrsquointroduzione sistematica del verbo δηλόω e di frasi atte a chiarire quale sia il segno denotante e quale il vocabolo (o il segno) denotato Egli introduce allo scopo di rendere esplicita la funzione de-notativa dei segni introdotti il termine σημείου curiosamente in tutte le sue tre occorrenze esso compare a sua volta nella forma dellrsquoabbrevia-zione per sospensione σΗ´ Egli traccia il segno per i massimi multipli ἀφ e quello per i resti λ οι` in modo che non vi siano ambiguitagrave quanto al loro carattere di abbreviazione Si faccia infine attenzione al residuo di barra sul παρᾱ con funzione denotativa (2 occorrenze) contenuto nella descrizione del segno per il divisore sostituita dallrsquoaccento grave nel παρὰ con funzione discorsiva (la differenza egrave nettissima nei manoscritti da me consultati) Questa osservazione ci permette di passare direttamente allrsquoitem seguente
b) Le barre sui numerali e sulle lettere denotative Egrave opportuno discutere questo punto adesso esattamente percheacute di barre siffatte che pure troviamo in tutti i manoscritti i nostri testi non fanno mai menzione si tratta infatti di una pratica condivisa sin dallrsquoantichitagrave La barra identifica una stringa di lettere dellrsquoalfabeto che non svolge una funzione grammaticale o sintattica propria allrsquointerno del discorso Ciograve avviene in particolare e si tratta della fattispecie piugrave frequente se la stringa di lettere non dagrave origine a un vocabolo della lingua greca lette-re denotative e numerali certo ma anche termini provenienti da altri idiomi e contrazioni di parole greche come i nomina sacra62 tali termi-ni possono essere o no preceduti da un articolo lsquocitazionalersquo a seconda dellrsquouso che ne viene fatto allrsquointerno del discorso Ma non si tratta dellrsquounica fattispecie i papiri grammaticali ed i manoscritti piugrave antichi dei trattati dello stesso argomento segnalano gli esempi delle parti del discorso (cioegrave di lsquoverersquo parole greche) per mezzo di barre sormontanti63 La differenza insomma egrave tra menzione e uso (come parte del discorso in atto) di una stringa di caratteri tra il porre le lsquovirgolettersquo e il non porle tra funzione denotativa e non Apparentemente la convenzione si limi-
corredata dei segni opportuni e contrariamente alle indicazioni della descrizione svilup-pata lsquoin verticalersquo ma per motivi misteriosi non completa (tav 7a Laur Plut 89 sup 48 f 13r)
62 Tutto ciograve egrave spiegato con estrema chiarezza giagrave in Traube 1907 pp 45-4763 Si veda il Par gr 2548 codex vetustissimus e testimone unico delle lsquoopere minorirsquo
di Apollonio Discolo il f 106v con le barre ben visibili egrave riprodotto come tav 19 in De Gregorio 2000 (ivi pp 137-138 per la datazione) Per la testimonianza dei papiri grammaticali si veda Wouters 1979 passim essi contengono di norma elenchi di parti del discorso nessuna delle quali egrave preceduta dallrsquoarticolo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 149
tava in questo secondo caso a segnalare con la barra singoli vocaboli le menzioni di frasi o di sintagmi complessi sono di norma identificate dallrsquoarticolo lsquocitazionalersquo Drsquoaltra parte le abbreviazioni convenzionali non rientrano nella casistica percheacute la loro resa grafica che contiene elementi non alfabetici come compendi per desinenze lettere supra li-neam marche di contrazione o sospensione quali slashes o barre sotto-poste o sormontanti eventualmente solo un sottinsieme della stringa di segni alfabetici le esclude automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
Venendo al discorso matematico una barra sormonta senza ecce-zione le lettere denotative64 che sia in papiri o in manoscritti in maiu-scola65 o minuscola ma solo allrsquointerno del testo comrsquoegrave da attendersi nei diagrammi esse la perdono per il semplice motivo che non crsquoegrave alcun testo ambiente un diagramma ha unicamente una funzione denotati-va Drsquoaltra parte le lettere numerali che a volte figurano nei diagrammi della tradizione metrica66 allo scopo di indicare la lunghezza dei seg-menti mantengono la barra in un diagramma il contesto denotativo geometrico egrave prevalente e i numerali vengono percepiti come entitagrave grafiche lsquoesternersquo al discorso Va da seacute a fortiori che le lettere numerali inserite in un testo dovranno essere segnalate da barre che a loro volta non servono nelle tavole67 in quanto queste ultime sono come abbiamo visto un vero e proprio testo che perograve funge da ambiente a quello al-fabetico limitato alle titolazioni e non a caso tracciato in unrsquoopportuna lsquomaiuscola distintivarsquo allo scopo di segnalarne il carattere denotativo e non discorsivo68 Una tabella operazionale egrave invece un paratesto e quindi le barre sulle lettere numerali che rappresentano gli interi sono
64 La notazione per le lettere denotative subigrave unrsquoevoluzione (il cui risultato finale egrave descritto per sommi capi nella nota 3 supra) di cui non mette conto occuparsi qui
65 I papiri di contenuto geometrico (o astronomici ma che presentano argomenti geometrici) sono rari si vedano il PHerc 1061 (sec II aC Demetrio Lacone De geome-tria) e il PFay 9 (sec II ex Elementi I 39 e 41) Gli importanti ostraka OBerl 12002 e 12609 (sec III aC m Elementi XIII) non pongono le barre sopra le lettere denotative Per i manoscritti in maiuscola si veda ad esempio passim nel Par gr 2389 una cui riproduzione digitale egrave consultabile in rete allrsquoindirizzo httpgallicabnffrark12148btv1b8470171d o il fragmentum mathematicum Bobiense
66 Si veda ancora il ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 codex unicus dei Metrica di Erone e contenente una raccolta importante di problemi del corpus metrologico
67 Si vedano come esempio le tavole citate alle note 10 e 14 supra Discorso a parte per il segno di lsquoposto vuotorsquo si veda il punto c che segue
68 Queste regole generali vanno prese cum grano salis si dagrave naturalmente un certo dominio di variabilitagrave legato verosimilmente al grado di cultura grafica del copista nel PMich III 144 i numerali sono quasi tutti senza barra sia nel testo che nelle tabelle ope-razionali
Fabio Acerbi150
necessarie esse mancano invece sui segni convenzionali che ho descrit-to nel punto precedente e fatto rilevante sulle lettere numerali relative agli ordini sessagesimali quando esse siano identificate da uno o piugrave apici la presenza di questo segno grafico non alfabetico69 le esclude ancora una volta automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo Unrsquoultima osservazione che ci saragrave utile nel seacuteguito la descrizio-ne di una stringa di lettere lsquoagrammaticalersquo non puograve prevedere la men-zione della presenza della barra che le pertiene in quanto tale si tratta di una pratica denotativa che egrave possibile formulare soltanto ad un livello di discorso superiore sia a quello dellrsquouso che a quello della menzione70
c) Il segno di lsquoposto vuotorsquo Si noti nella tav 2b la forma ŏ per il segno di lsquoposto vuotorsquo in un ordine sessagesimale coerentemente con la propria notazione il copista del Marc gr 313 lo scioglie talvolta allrsquoin-terno del testo principale come unrsquoabbreviazione per οὐδέν laquonienteraquo Altre convenzioni di scrittura del tratto che accompagna il circoletto e che si badi bene fa parte integrante del segno di lsquoposto vuotorsquo ndash e infatti nelle tavole troviamo sempre il segno completo mentre tutti gli altri numerali sono come abbiamo visto nel punto precedente privi di barra o di apice a causa del fatto che i vari ordini sessagesimali sono univocamente determinati dalle linee di giustificazione ndash un tratto an-golare anteposto (tav 3 Lar Plut 2818 f 136v)71 o una semplice barra a sormontare (tavv 4-9) si produce in questo modo il segno 65926 che sembra essere stata la forma di base72
69 Occorre dunque supporre come testimoniano papiri e manoscritti in maiuscola che la convenzione relativa allrsquouso della barra si sia consolidata ben prima dellrsquointroduzione di segni diacritici quali accenti e spiriti
70 Si veda il punto 2 infra per maggiori dettagli sulla questione delle barre e degli apici e per le indicazioni in merito che leggiamo in Diofanto
71 Come accennato questa tavola dei sottomultipli coincide con quella descritta ed esposta nei Prolegomena Fatto molto rilevante i numerali nella prima non recano neacute barre neacute apici contrariamente a quanto accade a tutte le istanze della seconda nei manoscritti Quella del Laur Plut 2818 preserva a mio avviso la forma originaria come abbiamo visto una tavola non richiede segni aggiuntivi sulle lettere numerali
72 Si vedano come esempio ancora le tavole citate alle note 10 e 14 supra oppure per una rassegna delle forme che il segno assume nei manoscritti piugrave antichi delle Tavole facili Tihon 2011 pp 58-59 e per quelle che assume nei papiri Jones 1999 I pp 61-62 Ovviamente non possiamo leggere il segno 65926 come un omicron con una barra in quanto ο = 70 nella notazione greca e la barra egrave di rigore quando il numerale figuri allrsquointerno di un testo Occorre ammettere che si dagrave origine ad un bel corto circuito notazionale con il concepire un segno con funzione di lsquoposto vuotorsquo ma che lsquosomigliarsquo ad una lettera dellrsquoalfabeto sormontata da una barra cioegrave ad un numerale in piugrave quando il lsquoposto vuotorsquo non corrisponda ad un intero ma ad una specie sessagesimale la presenza della barra a priori indistinguibile da quella che sormonta gli interi introduce unrsquoincongruenza con la notazione a mezzo di apici vista nellrsquoitem precedente
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 151
d) Errori di copia La tabella riprodotta nella tav 2b ha una forma simmetrica ma si tratta di una forzatura il grande rettangolo in basso a destra drsquoaltronde assente nella descrizione contiene uno scolio che fa notare come lrsquoultimo resto parziale ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ͵γτνζ´´´´´ κζ´´´´´´ cioegrave 0 0 0 0 0 3357 27 siano ἔγγιστα λ´λ´ δ´δ´ ξ laquocon ottima approssimazione 60 minuti quartiraquo dove si notino gli apici semplici per indicare il pas-saggio allrsquoordinale e il raddoppiamento del sistema segno + apice per significare il plurale Lo scolio debitamente accompagnato dal segno di rimando in forma di simbolo solare egrave stato probabilmente incluso nella tabella proprio allo scopo di renderla simmetrica A sua volta un errore precedente spiega lo spazio eccessivo accordato al rettangolo contenente lo scolio il secondo massimo multiplo ŏ λβ´ ξδ´´ ριβ´´´ σιϛ´´´´ egrave trascritto anche al di sotto del risultato
Passiamo ora alla descrizione del metodo di divisione attribuito a Pappo
ἵνα οὖν ταῦτα συναχθῇ τὰ ἐκ τοῦ μερισμοῦ ὁ εἰρημένος Πάππος εὐδιατύπῳ τινὶ καὶ πρὸς τοῦτο τάξει χρησάμενος ποιεῖται τὴν τῆς συλλήψεως τοῦ ζητουμένου ἀνεύρεσιν οὕτως ἐκθέμενος γὰρ τὸν μέλλοντα μερίζεσθαι τουτέστι τὰς τξ μοίρας ἐν ἀρχῇ ἀφαιρεῖ ἀπ᾽ αὐτῶν τὸν ἐν τῇ σελίδι τυγχάνοντα ἐλάττονα τουτέστι τὸν τδ κβ´ κ´´ ὄντα τῶν ἐγγὺς ἐλασσόνων ὡς πρὸς τοὺς ἐκκειμένους διὸ καὶ γράφει αὐτὸν προγράφων αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε καὶ εὑρίσκων τὰ παρακείμενα αὐτῷ τῷ ἀπογραφέντι ἐν τῷ σελιδίῳ λεπτὰ πρῶτα ν´ συναπογράφεται παρατιθῶν αὐτοῖς τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον ἀνατείνουσαν σημαῖνον τὸ εἶδος ὅτι πρῶτα λεπτά εὑρίσκει οὖν οὕτως τὸ τῶν τξ μέρος τὸ τδ κβ´ κ´´ ὃ μεριζόμενον παρὰ τὰς τξε ιδ´ μη´´ ἡμέρας καὶ ποιοῦν τὸν ἐκ τοῦ μερισμοῦ ἀριθμὸν πρῶτα λεπτὰ ν´ καὶ τὸν λοιπὸν ἀπογραφόμενος τὸν νε λζ´ μ´´ προτάσσει αὐτοῦ τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά τάσσει δὲ καὶ ἁπλῆν τινα διατείνουσαν γραμμὴν ὡς ἀπὸ τοῦ τξ ἐπὶ τὸν ἑξῆς ἐκτεθειμένον ἐγγὺς
1
5
10
1 εὐδιατύπῳ] ZSPC εὐδιατύπωτ M 4 ἀφαιρεῖ] MZSP ἀφ ι C 5 ἐλάττονα] P comp MZSC 6 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | αφ ] αφ ε M ἀφ ZS ἀφαί P ἄφ C | ἀντὶ] om C | ἄφελε] MZSP ἄφ C 8 ἀπογραφέντι] MZSP ἐγγραφέντι C | λεπτὰ πρῶτα] P λε πρωτα SC λεπτῶν πρωτ MZ | παρατιθῶν] MZS παρατιθεὶς C et ex corr m 2 P 9 ᾱ] Z αο P α´ MS α C | ἔχον] MPC ἔχων ZS 9-10 πρῶτα λεπτά] ZP πρωτ λ´λ´ M πρωτα λε S αα λε C 11 ἡμέρας] comp codd | ἀριθμὸν] P et comp MZ καὶ C et comp S 12 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M πρωτ λεπτ(α) Z πρωτ λ εᾱ S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C | ἀπογραφόμενος] MZSP ἐγγραφόμενος C | νε λζ´] MZSP λζ νζ C 13 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | λ οι] MZSC ex λ fecit λ οι P | προσσημαῖνον] MC et προσ- comp ZS προση- P | τὸ] MZC τὰ S et fecit m 2 P 14 ἀπὸ] MZSP πρὸς C ἐλάττονα] P comp MZSC
1 εὐδιατύπῳ] εὐδιατυπώτω K 6-7 αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ] τὸ ἀφ K 8 παρατιθῶν mdash 10 λεπτά] τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ σημαίνουσαν τὸ εἶδος αὐτῶν ὅτι ᾱ λεπτά εἰσιν K | τὸ (sec)] τὰ K 12 πρῶτα] πρώτων K | τε λ ] λ οι` K | προσσημαῖνον mdash
Fabio Acerbi152
ἐλάττονα τὸν τδ κβ´ κ´´ ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις καὶ ταύτην ἐπιδεικνύουσαν τὴν τάξιν τῆς προόδου τῆς ἐκθέσεως ἧστινος κλωμένης γραμμῆς πρὸς τῷ ἐγγὺς ἐλάσσονι ἡ ἀντανάκλασις ἐπὶ τὸν λοιπὸν γέγραπται φερομένη ὡς εἴρηται διὰ τὸ εὔτακτον τῆς προκοπῆς οὕτως τε ποιήσας ἑξῆς τὸ αφ ποιῶν ὃ προσσημαίνει ὡς εἴρηται τὸ ὅτι δεῖ ἀφελεῖν ὁμοίως ἀπὸ τοῦ λοιποῦ καὶ δὴ τὸν ἐγγὺς πάλιν ἐλάσσονα ὡς πρὸς τὴν ἐν τῷ σελιδίῳ ἔκθεσιν εὑρισκόμενον λαμβάνων ἑξῆς προγράφει αὐτὸν ὄντα νδ μζ´ ιγ´´ ιβ´´´ καὶ εὑρίσκει αὐτοῖς παρακείμενα ἐν τῷ σελιδίῳ πρῶτα λεπτὰ θ´ ἅτινα καὶ αὐτὰ προσαπογράφεται σὺν τῇ παρασημειώσει τῶν πρώτων γράφων τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον τὴν ἀνατείνουσαν καὶ ὡς εἴρηται τὴν γραμμὴν πάλιν διὰ τὴν τάξιν κλωμένην κατὰ δευτέραν κλάσιν προσέλκει γινομένου τοῦ μέρους αὐτῆς τούτου παραλλήλου τῷ ἐξ ἀρχῆς
16 ante κλωμένης add ἐπὶ C 18 τε] MZP om SC | αφ ] M ἀφ ZSC ἀφαί P 19 προσσημαίνει] MS προση- ZC et ex corr P | ὅτι] ZP comp MSC 20 δὴ] MZSC διὰ fecit m 2 P 21 πρὸς] MSP et supra lineam C ex ἀπὸ fecit m 2 Z | ιγ´´] MZSP νγ´´ C 22 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M ᾱᾱ λεπτὰ Z άάα λε S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C 23 προσαπο- γράφεται] απο suprascr in comp M 24 ᾱ] ZP α´ MS α C 25 κλάσιν] MP τάξιν ZSC | τοῦ] ZSPC τούτου M 26 τούτου] τοῦ bis ZSPC sed prius erasit m 2 P τοῦ M
mdash 18 προκοπῆς] om K | τε ποιήσας] ποιήσας καὶ K | αφ ] ἀφ K 19 τὸ] om K 21 προ-γράφει] γράφει K 22 σελιδίῳ] α´ σελιδίῳ K | ἅτινα] ἃ K 23 προσαπογράφεται] ἀπογράφεται K | τῶν πρώτων mdash 26 ἐξ ἀρχῆς] om K
lsquoAllo scopo di raccogliere ciograve che risulta dalla divisione il detto Pappo utilizzando anche in questo caso una certa disposizione ben strutturata determina nel modo seguente il lsaquonumerorsaquo cercato preso nel suo insieme collocando73 in testa il lsaquonumerorsaquo che sta per essere diviso cioegrave i 360 gradi iniziali sottrae loro tra i piugrave prossimi dei lsaquonumerirsaquo minori rispetto a quelli esposti quello che si trova essere minore nella colonna (cioegrave 304 22 20) Questo egrave il motivo per cui lo trascrive scrivendogli davanti lrsquoabbreviazio-ne laquosottrraquo per laquosottrairaquo e trovando che 50 minuti primi sono collocati accanto a quello stesso lsaquonumerorsaquo che egrave stato trascritto nella colonna li trascrive al tempo stesso collocando accanto74 ad essi la lettera A con un lsaquotrattorsaquo75 sopra che significa la specie minuti primi Trova dunque in que-sto modo la parte di 360 che egrave 304 22 20 la quale divisa per 365 giorni 14 48 fa il numero lsaquoche risultarsaquo dalla divisione 50 minuti primi Trascrivendo
73 La descrizione egrave strutturata come una procedura Acerbi 201274 Il purismo del correttore del Par gr 2390 di Clostomalle nel Marc gr 314 e
dellrsquoautore della recensione bizantina impone loro di modificare la terminazione ma forme tematiche e contratte di τιθεῖν sono correnti nel greco tardivo
75 Il testo greco ha solo il participio con γραμμήν sottinteso Per il significato del participio si veda il punto 2
15
20
25
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 153
poi il resto 55 37 40 gli pone altresigrave76 a prefisso laquoReraquo che significa laquorestiraquo e dispone anche una certa linea semplice77 che va da 360 al piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori che egrave esposto di seacuteguito 304 22 20 come nello lsaquoschemarsaquo esposto linea che mostra lrsquoordine del percorso dellrsquoesposizione Questa linea spezzata lagrave dove si trova il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori egrave tracciata inflessa allrsquoindietro lsaquoersaquo punta verso il resto come egrave stato detto in vista di una progressione ordinata E cosigrave facendo prendendo di seacuteguito il laquosottrraquo che significa come egrave stato detto laquoche occorre similmente sottrarre dal re-storaquo e ovviamente prendendo di nuovo il lsaquonumerorsaquo che egrave trovato essere il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori in relazione alla disposizione nella colonna ndash 54 47 13 12 ndash lo scrive di seacuteguito e trova che 9 minuti primi sono posti loro accanto nella colonna trascrive78 anche questi con la segnaletica dei primi scrivendo la lettera A con un lsaquotrattorsaquo sopra e come egrave stato detto prolunga di nuovo la linea spezzata in vista di una buona disposizione tramite una seconda inflessione essendo questa sua parte parallela a quella inizialersquo
La descrizione continua con una serie di laquoe cosigrave viaraquo e non fa ulte-riore riferimento alla tabella
1) La forma verbale ἐξεσμένον Egrave il neutro del participio perfetto medio-passivo di ξέω lett laquopialloraquo laquolevigoraquo Si danno tre possibilitagrave si tratta di un termine canonico per quanto non altrove attestato per designare unrsquoabbreviazione oppure lrsquoautore anonimo improvvisa sul piano metaforico come se unrsquoabbreviazione non fosse altro che la paro-la completa lsquoaccorciata a colpi di piallarsquo in maniera opportuna oppure il testo egrave corrotto e srsquoimpone una correzione ad esempio τὸ ἑξῆς μένον laquociograve che sta di seacuteguitoraquo Questrsquoultima strada mi pare chiusa dal senso delle frase lrsquoabbreviazione non lsquosta di seacuteguitorsquo a niente ma anzi precede la perifrasi τὸ ἑξῆς μένον se impiegata semplicemente per rimandare al segno αφ immediatamente seguente costituirebbe un intollerabile solecismo Se accettiamo la prima di queste letture considerando quin-di lrsquoabbreviazione αφ in posizione predicativa abbiamo a che fare con
76 Rendo in questo modo il τε isolato77 La linea egrave laquosempliceraquo in quanto egrave una retta la precisazione intende evidenziare per
anticipazione il carattere lsquonon semplicersquo che essa assumeragrave alla prima inflessione quando diventeragrave una spezzata linee siffatte erano in effetti concepite dallrsquoanonimo e prima di lui da tutta la tradizione matematica greca come una singola linea spezzata nei punti drsquoinfles-sione I due segmenti paralleli menzionati al termine del passo sono orizzontali
78 Il verbo egrave al medio in variatio rispetto ai due che precedono e che seguono egrave il matematico che lsquosirsquo trascrive le cifre
Fabio Acerbi154
uno hapax semantico nella grecitagrave superstite come egrave facile verificare con una ricerca sul TLG in rete La recensione bizantina risolve il pro-blema sopprimendo semplicemente τὸ ἐξεσμένον
2) La notazione per le specie numeriche Nella terminologia matema-tica greca gli ordini sessagesimali sono εἴδη laquospecieraquo numerici essi corri- spondono agli ordini di grandezza nel nostro sistema decimale e indica-no in analogia con il caso geometrico la lsquoformarsquo che assume un numero quadrato cubo ecc Centinaia e migliaia sono quindi degli εἴδη rispet-tivamente quadrati (100 egrave il quadrato di 10) e cubi (1000 egrave il cubo di 10) sono specie numeriche ma non numeri particolari e drsquoaltronde 300 non egrave un quadrato ma 3 item dellrsquoεἶδος lsquoquadratorsquo 100 3 egrave il numerale di molteplicitagrave della specie quadrata lsquocentinaiarsquo i due 0 che seguono il 3 segnalano esattamente questo fatto che la notazione greca per gli interi non posizionale fa scomparire al livello denotativo Ciograve non vale soltan-to per i numeri interi ma anche per le loro parti i minuti secondi appar-tengono alla specie lsquoquadratorsquo in quanto 13600 egrave il quadrato di 160
La concezione appare interamente dispiegata nellrsquointroduzione degli Arithmetica diofantei79 che si rivela giova farlo rimarcare un te-stimone fondamentale per la ricostruzione della notazione matematica antica Alle specie usate in questrsquoopera vengono assegnati una denomi-nazione ed un segno convenzionale costituito dallrsquoiniziale (di ognuno dei componenti) della denominazione al quadrato o δύναμις il segno ΔΥ al κύβος il segno ΚΥ alla lsquoquarta potenzarsquo o δυναμοδύναμις il segno ΔΥΔ ecc La descrizione di tali segni egrave del tipo καὶ ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον Κ ἐπίσημον ἔχον Υ ΚΥ κύβος laquoe il suo segno egrave un Κ che ha come indice un Υ ΚΥ cuboraquo dove in accordo con quanto abbiamo visto nel punto b supra e pur nel comprensibile imbarazzo del copista della prima parte del Matritensis (o di un suo passato collega) a districarsi in questo formidabile ginepraio notazionale80 le due lettere Κ e Υ ricevono una barra mentre ΚΥ non la richiede a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον il quale ancora una volta esclude automaticamente il segno dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
79 In particolare a DOO I pp 214-62180 Nel Matr 4678 riscontriamo i seguenti fenomeni nelle poche righe a cavallo dei ff
58r-v 1) accento acuto posto su tutti i segni come se fossero abbreviazioni 2) ripetizione sistematica segnodenominazione come in ΚΥ κύβος appena letto dovuta sicuramente allrsquointrusione di glosse interlineari esplicative dei segni ndash e successivo pentimento (δύναμις e κύβος sono in effetti cancellati dalla prima mano il primo con un tratto il secondo con dei punti supra lineam poi il copista si stanca di correggere) 3) nella descrizione del segno per la δυναμοδύναμις menzione di un δέλτα δύο che saragrave molto probabilmente stato ΔΔ subito dopo nella descrizione del κυβόκυβος si legge un incongruo δύο KK
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 155
Diofanto introduce poi dei segni anche per le specie delle parti dellrsquounitagrave (le nostre frazioni) che egli chiama ὁμώνυμα μορία laquoparti omonimeraquo di cui quelle sessagesimali sono casi particolari81 Egli spie-ga appunto che le loro denominazioni sono ottenute da quelle delle specie degli interi per sinonimia passando ad un lsquoordinalersquo82 formato semplicemente aggiungendo il suffisso -στον δυναμοστόν κυβοστόν δυναμοδυναμοστόν ecc (sott μόριον) I loro segni convenzionali sono invece ottenuti da quelli per le specie degli interi aggiungendo una γραμμὴν διαστέλλουσαν τὸ εἶδος laquolinea che distingue la specieraquo83 Una linea sui segni delle specie delle parti egrave richiesta si badi bene per distinguerli dai segni di quelle degli interi come giagrave osservato questi ultimi sono giagrave lsquoagrammaticalirsquo a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον a fortiori lo saranno anche i primi Si tratta della traduzione semio-tica del passaggio dal cardinale allrsquoordinale che a livello grammaticale egrave effettuato con il suffisso -στον Che forma ha questa linea Barra o apice (Egrave cervellotico pensare a forme piugrave complesse) La domanda non ammette una risposta immediata in quanto delle specie diofantee nessuno piugrave si occupa nellrsquoantichitagrave84 Se egrave vero che la prima risposta darebbe origine ad un conflitto tra due convenzioni denotative diffe-renti la barra lsquocitazionalersquo e la barra che distingue la specie lrsquoevidenza grafica del Matritensis lascia lievemente sgomenti (ricordiamoci che giagrave i segni di base sono indebitamente dotati di un accento dal copista) Le poche occorrenze del segno per le specie delle parti85 vedono lrsquoaggiunta di uno slash di sospensione di un doppio apice inverso ndash in tutta evi-
81 Questo fatto era giagrave chiaro nellrsquoantichitagrave Teone in Alm I 10 in iA p 45310-1682 Il parallelo con i cardinali e gli ordinali relativi agli interi egrave reso esplicito da Dio-
fanto ὥσπερ δὲ τῶν ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια παρομοίως καλεῖται τοῖς ἀριθμοῖς τοῦ μὲν τρία τὸ τρίτον τοῦ δὲ τέσσαρα τὸ τέταρτον οὕτως καὶ τῶν νῦν ἐπονομασθέντων ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια κληθήσεται παρομοίως τοῖς ἀριθμοῖς laquocome le parti omonime dei numeri sono chia-mate per assonanza con i numeri di lsquotrersquo lsquolsaquounrsaquo terzorsquo di lsquoquattrorsquo lsquolsaquounrsaquo quartorsquo cosigrave le parti omonime dei numeri appena nominati saranno chiamate per assonanza con i numeriraquo (DOO I p 69-13 si noti lrsquoarticolo lsquocitazionalersquo al singolare in τοῦ τρία e τοῦ τέσσαρα) Il parallelo prosegue anche al livello dei segni che rappresentano queste specie come vedremo tra un attimo
83 Diofanto Arithmetica prefazione in DOO I p 620-21 un passaggio maltrattato in questa edizione occorre espungere il participio ἔχον senza introdurre segni ulteriori oppure eliminare un precedente ἐπί come fa un correttore del Matritensis f 58v
84 Unica parzialissima eccezione lrsquoaccenno di Teone menzionato nella nota 81 supra85 Al f 59r e per di piugrave nel margine per sanare un lungo saut du mecircme au mecircme La
collocazione in margine egrave il motivo per cui troviamo una notazione abbreviata nel resto del trattato il primo copista scioglie tutti i segni prendendoli per abbreviazioni mentre il secondo elimina sistematicamente il tratto aggiuntivo delle specie delle parti dellrsquounitagrave Drsquoaltronde egli scrive ad esempio ΔΥ invece di ΔΥ ed egrave quindi indotto a porre la barra al di sopra della stringa di lettere risultante (passim ma si veda ad esempio il f 72r)
Fabio Acerbi156
denza il compendio per la desinenza -ον accentata il copista interpreta il segno come unrsquoabbreviazione ndash e di una barra a sormontare lo Υ Potremmo forse interpretarlo come il segno di contrazione del grafema -στ- lrsquounico tassello mancante in unrsquoabbreviazione come ad esempio (δυναμοδυναμο)(στ)(ὸν) ma uno scolio di prima mano al f 58v rela-tivo alle specie degli interi inficia questrsquoipotesi esse sono dotate di slash di sospensione accento acuto in un caso del compendio canonico per la terminazione -ον hellip ma tutti gli Υ a esponente sono a loro volta sormontati da una barra
Meno legata al singolo manoscritto ma nondimeno non uniforme si presenta la pratica di notazione dei segni che rappresentano gli enti numerici sessagesimali86 da una parte sta lrsquoevidenza del testo dei Pro-legomena e delle sue tabelle apici ndash drsquoaltronde come abbiamo visto la notazione universalmente impiegata per i numerali ordinali e per le fra-zioni unitarie ndash dallrsquoaltra sta lrsquoevidenza del testo dellrsquoAlmagesto in tutti i manoscritti piugrave antichi e lo stesso si dica del commentario teonino a questrsquoopera o del suo lsquoGrande commentariorsquo alle Tavole facili e dei testi astronomici su papiro barre87 Sembra insomma che la nostra docu-
86 Sia le molteplicitagrave che le specie ahimeacute entrambe rappresentate da lettere dellrsquoalfabeto Come osservato allrsquoinizio della sezione 3 ci sono in effetti due tipi di lettere numerali in gioco se facciamo astrazione da apici o barre lsquo4 minuti secondirsquo si trova scritto δ β la prima lettera numerale denota la molteplicitagrave degli item di una certa specie la se-conda la specie nei Prolegomena entrambe sono accompagnate da un doppio apice il che rende inutile la presenza delle seconde Si noti che la descrizione della tabella non fa parola della notazione da usare per le lettere numerali che denotano la molteplicitagrave barre o apici e quanti apici hellip In questo caso fa interamente fede la tabella cioegrave la pratica grafica condivisa instauratasi non egrave chiaro quando
87 I manoscritti piugrave antichi dellrsquoAlmagesto sono menzionati nella nota 10 supra quelli dei due commentarii teonini sono il Laur Plut 2818 e il celeberrimo Vat gr 190 (sec IX in Euclide Elementi Data Teone lsquoGrande commentariorsquo) per la notazione dei pa-piri astronomici si veda Jones 1999 II passim La notazione non sembra lsquoinquinatarsquo dalla pratica dei copisti bizantini e pare dipendere soltanto dalla data di composizione Tro-viamo ad esempio barre sopra tutti i numerali di molteplicitagrave (interi o sessagesimali) nel frammento di un commentario alle Tavole facili contenente un calcolo relativo al 24 aprile 213 (Par gr 2841 sec XIII ex-XIV in oltre al frammento ai ff 32r l 11-34v l 23 contiene Arato Phaenomena ed Efestione Apotelesmatica edizione in Jones 1990) Nel commentario alle Tavole facili composto ca 610-617 ed attribuito a Stefano di Alessandria la situazione egrave la seguente (Jean Lempire per litteras per lrsquoedizione si veda Lempire 2014 ho controllato il Vat gr 304 ff 135r-171v sec XIV am contiene in aggiunta Teone in Almagestum I-II lsquoPiccolo commentariorsquo alle Tavole facili Diofanto Arithmetica e De polygo-nis numeris varia astronomica tabulae) barre sopra gli interi sporadicamente rimpiazzate da apici apici sopra le parti sessagesimali in numero uguale alla denominazione doppio () apice per le frazioni unitarie Sono impiegate barre sopra gli interi e apici sopra le parti sessagesimali nei manoscritti principali di tutti i trattati di introduzione allrsquoAlmagesto o comunque di argomento logistico redatti in epoca bizantina Giorgio Pachimere (1242-ca 1310) Quadrivium (autografo nel manoscritto Roma Biblioteca Angelica gr 38 [RGK III nr 115] si veda Tannery ndash Steacutephanou 1940 per lrsquoedizione) Teodoro Metochita (1270-
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 157
mentazione si faccia testimone di un cambio notazionale avvenuto nel periodo intercorrente fra Teone (sec IV pm) e la scuola alessandrina di Ammonio e dei suoi allievi (sec VI in) e probabilmente innescato da questrsquoultimo ambiente lrsquoaspetto paradossale egrave che nello stesso codice si rintraccino due notazioni differenti per gli enti numerici sessagesimali e lrsquouna (apici) sia adottata sistematicamente e coerentemente in uno scritto (i Prolegomena) che si presenta esattamente come unrsquointroduzione tecnica alla pratica numerico-algoritmica del trattato (lrsquoAlmagesto) in cui egrave adottata lrsquoaltra (barre che ritroviamo senza eccezioni anche negli scolii)
Torniamo ai Prolegomena la descrizione del segno da porre a fianco di ogni singolo quoziente parziale e denotante la sua specie numerica (minuti primi minuti secondi ecc) solleva tre problemi
Primo problema Ci vuole una barra o un apice su τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquola lettera A [hellip] che significa la specieraquo quando lo scriviamo nella tabella Tutta la nostra discussione precedente fa pro-pendere per lrsquoapice e si ricordi anche la forma verbale ἀνατείνουσαν che suggerisce qualcosa che si lsquoestende verso lrsquoaltorsquo (la mia traduzione egrave volutamente neutra) se fosse apposta una barra la cosa dovrebbe passare
1231332) Compendium astronomicum (copia lsquoautorizzatarsquo coeva nei Vat gr 182 e 181 da parte del copista che integrograve le parti mancanti del Par gr 2389 [ff 207-210 255-270 374-375] Bianconi 2005a pp 425-427 Peacuterez Martiacuten 2008 p 436 e n 177) Teodoro Meliteniota (morto lrsquo831393) Tribiblos astronomica (autografo nel Vat gr 792 si vedano Leurquin 1991 per unrsquoanalisi del manoscritto Leurquin 1990 per lrsquoedizione) una com-pilazione anonima (per cui ho consultato il Par gr 2396 ff 87r-92v limitatamente a questi fogli manu Costantino Trivoli [RGK II nr 318 ma ovviamente questo codice non vi egrave segnalato] terzo quarto del XV secolo il resto del codice annotato da Niceforo Gregora egrave di etagrave planudea e parzialmente [ff 33v-76v] un autografo di Planude stesso contiene Teone in Almagestum I II IV Mondrain 2002 il codice va completato ndash limitatamente a stralci dei libri VIII-X XII-XIII del commentario teonino la cui parte intermedia si egrave persa ndash con 26 carte [ff 123-147] inserite nel Vat gr 1087 anchrsquoesso contenente anno-tazioni di Gregora Rome 1927 per la figura del copista dei ff 77r-86r del Par gr 2396 e dei ff appena nominati del Vat gr 1087 un anonimo collaboratore di Gregora si veda in ultimo Bianconi 2006a pp 147-151) si veda anche il calcolo effettuato da Niceforo Gre-gora (12921295-13581361) dellrsquoeclisse di sole del 16 luglio 1330 (attestata unicamente ai ff 1r-8v della miscellanea astronomica Marc gr 325 databile ca 1324-1329 in parte vergata e ovunque fittamente annotata da Gregora stesso edizione del testo in Mogenet et al 1983 annotazioni di Gregora elencate in Bianconi 2005a p 413) Unrsquoeccezione apparente il lsquoPiccolo commentariorsquo di Teone alle Tavole facili le parti sessagesimali sono segnalate da apici (ad esempio nel Vat gr 175 vergato da Giovanni Catrario e completato nel 1321-1322 sulla figura di Catrario si vedano in ultimo Bianconi 2005b pp 141-156 e 2006b) lrsquoopera egrave antica ma la sua tradizione non rimonta oltre la fine del XIII secolo a parte un frammento nel Leiden BPG 78 ff 156r-161v (minuscola del IX-X secolo) e in effetti in questo manoscritto tutti i numerali di molteplicitagrave sono sormontati da barre Unrsquoeccezione effettiva egrave il De hypotesibus planetarum nel Vat gr 1594 barre sugli interi e apici sulle parti sessagesimali
Fabio Acerbi158
sotto silenzio e la presenza dellrsquoapice la rende inutile88 Si tratta della stessa convenzione diofantea e coincide ancora con la notazione per i numerali ordinali e per le frazioni unitarie che egrave corrente nei mano- scritti matematici greci per questo motivo non percheacute la descrizione sia particolarmente perspicua nessuno dei copisti della recensione an-tica ha incertezze apici Ma questi apici si rintracciano soltanto sulle indicazioni di specie non contemplate dalla descrizione che sono ante-poste ai resti parziali a fianco dei quozienti parziali i segni di specie sono invece trasformati in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordi-nali corrispondenti del tipo πρωτ tavv 5 e 7b-8 Il recensore bizantino taglia invece la testa al toro elimina dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali elimina la seconda menzione della laquolet-tera Araquo contestualmente allrsquoazzeramento dellrsquoespediente della linea a zig-zag (si veda il punto seguente) modifica la descrizione che contiene la prima menzione in quella dellrsquoapice associato direttamente ai nume-rali di molteplicitagrave riciclando addirittura lrsquoalpha per adibirlo a desi-gnare un numero cardinale (come sorprendersi) τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ laquoponendo al di sopra di essi [scil dei 50 minuti primi] 1 solo lsaquoaccentorsaquo acutoraquo La scelta del recensore egrave assennata che rechi una barra o un apice in una tabella un alpha denota un numero non un numero drsquoordine
Secondo problema da tenere ben distinto dal precedente Cosa ci vuole sul segno α per la lettera alpha menzionata nella frase τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquolettera A [hellip] che significa la specieraquo89 Unrsquooc-chiata allrsquoapparato critico rivela una bella incertezza nei manoscritti Z scrive sempre ᾱ e in un caso lo fa anche P MS optano sempre per α´ C per α P scrive nellrsquoaltro caso αο Per quanto solo la barra sia congrua con il senso della frase in quanto la lettera alpha egrave qui menzionata (si tratta di un oggetto che compare nella tabella) e non cambia niente se essa egrave accompagnata dal suo nome di genere στοιχεῖον ad un livello grafico lrsquoincertezza fra il segno ᾱ che denota laquola lettera αraquo e il segno α´ (o lrsquoabbreviazione αο) per una forma di πρῶτος egrave per piugrave versi giustificata
88 Detto in altri termini la barra egrave uno strumento grafico non matematico e quindi la sua presenza non va segnalata mentre un apice lo egrave e la sua presenza lo deve
89 Notare che in questa frase il primo α non vuole la barra (egrave menzionato allrsquointerno di una frase che impiega convenzioni moderne) il secondo sigrave (idem ma con convenzioni antiche) ndash e nella traduzione la scelta di denotarlo con A (senza virgolette) e non con lsquoArsquo (con virgolette) egrave del tutto arbitraria ndash si noti inoltre che le necessarie precisazioni laquosenzacon virgoletteraquo mostrano che le lingue moderne palesano difficoltagrave analoghe a quelle del greco antico per quanto riguarda i livelli denotativi in ambito metadiscorsivo per non usare le due parentetiche avrei dovuto scrivere rispettivamente lsquoArsquo e lsquolsquoArsquorsquo (doppie virgolette semplici)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 159
ᾱ coincide con il numerale 1 α egrave la prima lettera dellrsquoalfabeto ed inoltre α´ egrave esattamente quello che va scritto nella tabella Potremmo dirci che il sostantivo στοιχεῖον chiude la questione la sua presenza congiunta ad un ipotetico α´ renderebbe la descrizione ridondante o inappropriata90 Ma a parte il fatto che α egrave proprio τὸ πρῶτον στοιχεῖον il segno α´ cat-tura in fondo il cuore della descrizione di uno στοιχεῖον ἔχον lsaquoγραμμὴνrsaquo ἀνατείνουσαν
Terzo problema Lrsquoautore dei Prolegomena che si arresta allrsquoesem-pio dei minuti primi non dice quanti apici occorre mettere sulle lettere numerali che identificano gli ordini superiori al primo se uno soltanto come nel caso diofanteo e delle frazioni unitarie o in numero uguale alla loro denominazione (cioegrave pari al numero denotato dal numerale stesso su cui vanno posti) come effettivamente avviene nei mano-scritti dei Prolegomena La tabella egrave quindi sottodeterminata dalla sua descrizione anzi in un certo senso prende il sopravvento su di essa la pratica di marcare i numerali di molteplicitagrave con gli apici che compe-tono allrsquoordine cui appartengono viene trasferita ai segni per gli ordini stessi per supplire ad una descrizione carente di questi ultimi E la tabella egrave sottodeterminata dalla descrizione in quanto egrave la descrizione di una tabella reale ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις laquocome nello lsaquoschemarsaquo espostoraquo leggiamo a un certo punto del testo
3) La linea a zig-zag Non possiamo che applaudire a questo geniale espediente grafico lo troviamo messo in opera solo nel Marc gr 313 Per quanto lrsquoautore non faccia parola di ciograve nel corso della sua descrizione la linea spezzata egrave intesa dover lsquosaltarersquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue Il copista del codice marciano effettua correttamente due salti nella prima delle sue tabelle (tav 4) ma inserisce un lsquodentersquo in piugrave in quella che considera corretta (tav 5) La linea a zig-zag egrave incompatibile con la presenza di linee di giustificazione nella tabella che in effetti mancano nel Marc gr 313 ciograve induce gli errori di allineamento dei primi 5 quozienti parziali di cui egrave vittima il copista Probabilmente per questo motivo in nessuno degli apografi del Vat gr 1594 la linea a zig-zag figura nella tabella inquadrata come si conviene da una (doppia) cornice esterna e le cui colonne sono appunto separate da linee verticali (tav 7b Vat gr 184 f 17v e tav 8 Par gr 2390 f 9v cui egrave sostanzialmente identica la tabella del Marc gr 314 che si trova
90 Trascuro lrsquoabbreviazione αο = πρῶτος percheacute la desinenza non egrave quella richiesta neacute nella frase (egrave richiesto πρῶτον) neacute nella tabella (πρῶτα)
Fabio Acerbi160
al f 248r ndash ma la mancanza di linee orizzontali causa un gigantesco pa-sticcio nel codice vaticano) Alla recensione bizantina che dipende per il suo testo di base dal Vat gr 1594 e quindi non trova la linea a zig-zag nella tabella non resta che sopprimere la sua descrizione ndash ma proprio per questo motivo e finalmente diventa possibile tracciare un apparato completo di linee di giustificazione (tav 9 Laur Plut 89 sup 48 f 14v) Dato che la descrizione di Teone di questo procedimento di divi-sione non fa cenno allrsquoesistenza della linea a zig-zag viene da chiedersi se essa non costituisca un espediente escogitato dallrsquoautore dei Prolegomena per vivacizzare la procedura originale di Pappo
4) Discrepanze tra descrizione e tabella Il gioco delle minime va-rianti mostra che la divisione era stata eseguita (e trasmessa) corret-tamente tutti i valori numerici sono esatti La tabella nel Marc gr 313 presenta perograve alcune discrepanze con la propria descrizione Essa omette (ma non nella versione lsquoscorrettarsquo lrsquoomissione non si riscontra neanche nel Par gr 2390) il segno per laquorestoraquo di fronte ai resti par-ziali ma aggiunge lrsquoindicazione della loro specie Essa trasforma invece come abbiamo visto le indicazioni di specie che seguono i quozienti parziali in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordinali corri-spondenti La descrizione prevede di chiudere la tabella con il risultato καὶ συνάγων ἅπαντα τὰ ἐκ τῶν μερισθέντων μερῶν λεπτὰ σημειοῦται ὑπὸ πάντας οὕτως γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoe raccogliendo tutti i minuti che provengono dalle parti divise lsaquoPapporsaquo nota sotto tutto cosigrave Ris 0 59 8 17 13 12 31raquo ma sotto la tabella tutta la tradizione ci consegna qualcosa di piugrave articolato ὁ ζητούμενος καθ᾽ ὃν μερίζεται ὁ τξε ιδ´ μη´´ π(αρὰ) τὸν τξ γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoil lsaquonumerorsaquo cercato secondo cui 365 14 48 egrave diviso per 360 risulta 0 59 8 17 13 12 31raquo frase che del resto contiene due errori lrsquoinversione del dividendo e del divisore e la confusione tra segno convenzionale (iuxta descrizione) e abbreviazione (come nella frase) nel caso di γι Oltre ad eliminare la linea a zig-zag91 la recensione bizantina sopprime dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali e modifica come abbiamo visto al punto 2 le loro descrizioni in quelle di apici associati diretta-mente ai numerali di molteplicitagrave
91 Le due righe che nella recensione di base contengono solo i resti parziali minori di 160 del divisore ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue sono in parte completate con lrsquoindicazione abbreviata ἀνάλ(υσις) laquoanalisiraquo il termine greco per questa procedura di riduzione In un sussulto di ipercorrettismo matematico tali resti parziali ridotti non sono preceduti dal segno per laquorestoraquo come nel Par gr 2390 ma da quello per laquorisultatoraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 161
Gli esempi che abbiamo discusso mostrano come i problemi di notazione pesino e non poco sullrsquoespressione discorsiva di un algorit-mo matematico lrsquoente di riferimento per lsquoformularersquo il procedimento di divisione fu considerata la tabella cioegrave un oggetto la cui costitu-zione egrave legata piugrave ad una pratica grafica che a considerazioni logico- algoritmiche non la sua descrizione che in effetti finisce per determi-nare la tabella in maniera non univoca Di questa sottodeterminazione si fa testimone la traiettoria che abbiamo cercato di seguire nelle mani di copisti e revisori il procedimento di divisione si modifica a volte in aspetti secondari a volte in punti piugrave sostanziali ndash fino a rendere neces-saria una radicale revisione della sua descrizione per renderla conforme alla tabella ndash in ogni caso mai per ragioni squisitamente matematiche92
Abstract
The article presents and discusses in detail two passages from the anonymous Prolegomena to the Almagest a VIth century primer to the elementary procedures of calculation needed in Ptolemyrsquos Almagest In the two passages we may follow the complex interplay between mathematical notation the auctor who employed and described it the tachygrapher who transcribed it in vivo copyists who reproduced it correctors who modified it Along this path misgivings and errors arise in the transmission of abbreviations and paratextual units such as diagrams tables operational schemes
Fabio AcerbiCNRS UMR8560 Centre Alexandre Koyreacute
fabacerbigmailcom
92 Sono grato a Daniele Bianconi Lucio del Corso Jean Lempire per alcune preziose indicazioni
AOO = Archimedis opera omnia cum commentariis Eutocii ed J L Heiberg I-III Lipsiae 1910-1915
DOO = Diophanti Alexandrini opera omnia cum Graecis commentariis ed P Tannery I-II Lipsiae 1893-1895
GC = Le laquoGrand Commentaireraquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Mogenet ndash A Tihon I-III Cittagrave del Vaticano 1985-1999
iA = Commentaires de Pappus et de Theacuteon drsquoAlexandrie sur lrsquoAlmageste ed A Rome I-III con paginazione continua Cittagrave del Vaticano 1931-1943
HOO = Heronis Alexandrini opera quae supersunt omnia ed G Schmidt ndash L Nix ndash W Schmidt ndash H Schoene ndash J L Heiberg I-V Lipsiae 1899-1914
PC = Le ldquoPetit Commentairerdquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed A Tihon Cittagrave del Vaticano 1978
POO = Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia ed J L Heiberg I-II in 3 parti Lipsiae 1898-1907
RGK = Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600 I Handschriften aus Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln II Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs und Nachtraumlge zu den Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln III Handschriften aus Bibliotheken Roms mit dem Vatikan A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg unter Mitarbeit von D Harlfinger und P Eleuteri B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln Wien 1981-1997 (Oumlsterreichische Akademie der Wissenschaften Veroumlffentlichungen der Kommission fuumlr Byzantinistik III1-3 A-C)
Sigla
Acerbi 2010 = F Acerbi Il silenzio delle sirene La matematica greca antica Roma 2010
Acerbi 2012 = F Acerbi I codici stilistici della matematica greca dimostrazioni procedure algoritmi laquoQUCCraquo 1012 (2012) pp 167-214
Acerbi et al 2010 = F Acerbi ndash N Vinel ndash B Vitrac Les Proleacutegomegravenes agrave lrsquoAlmageste Une eacutedition agrave partir des manuscrits les plus anciens Introduction geacuteneacuterale ndash Parties I-III laquoSCIAMVSraquo 11 (2010) pp 53-210
Agati 1992 = M L Agati La minuscola laquoBouleteacuteeraquo Cittagrave del Vaticano 1992
Belger 1881 = C Belger Ein neues Fragmentum mathematicum Bobiense laquoHermesraquo 16 (1881) pp 261-284
Bianconi 2005a = D Bianconi La biblioteca di Cora tra Massimo Planude e Niceforo Gregora Una questione di mani laquoSampTraquo 3 (2005) pp 391-438
Bianconi 2005b = D Bianconi Tessalonica nellrsquoetagrave dei Paleologi Le pratiche intellettuali nel riflesso della cultura scritta Paris 2005
Bianconi 2006a = D Bianconi Le pietre e il ponte ovvero identificazioni di mani e storia della cultura laquoBizantinisticaraquo 8 (2006) pp 135-181
Bianconi 2006b = D Bianconi Qualcosa di nuovo su Giovanni Catrario laquoMEGraquo 6 (2006) pp 69-91
Cavallo 1977 = G Cavallo Funzione e strutture della maiuscola greca tra i secoli VIII-XI in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Colloque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 95-137
Cereteli 1904 = G F Cereteli De compendiis scripturae codicum Graecorum praecipue Petropolitanorum et Mosquensium anni nota instructorum Sankt-Petersburg 1904
De Gregorio 2000 = G De Gregorio Materiali vecchi e nuovi per uno studio della minu-scola greca fra VII e IX secolo in G Prato (a cura di) I manoscritti greci tra riflessione e dibattito Atti del V Colloquio Internazionale di Paleografia Greca Cremona 4-10 ottobre 1998 Firenze 2000 pp 83-151
Follieri 1977 = E Follieri La minuscola libraria dei secoli IX e X in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Col-loque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 139-165
Fonkič 2005 = B Fonkič Venecianskaia rukopisrsquo laquoAlrsquomagestaraquo Ptolemeja (Marc gr 313690) o datirovke i proischoždenii kodeksa laquoVDIraquo s III 254 (2005) pp 162-167
Fowler 1999 = D H Fowler The Mathematics of Platorsquos Academy A New Reconstruction Second Edition Oxford 1999
Bibliografia
Fabio Acerbi164
Gerstinger ndash Vogel 1932 = H Gerstinger ndash K Vogel Eine stereometrische Aufgaben-sammlung im Papyrus Graecus [sic] Vindobonensis 19996 laquoMitteilungen aus der Papy-russammlung der Nationalbibliothek in Wienraquo Neue Serie Folge 1 Griechische literarische Papyri 1 Wien 1932 pp 11-76
Heiberg 1927 = Mathematici Graeci Minores ed J L Heiberg Kjoslashbenhavn 1927
Hultsch 1876-1878 = Pappi Alexandrini Collectionis quae supersunt ed F Hultsch I-III Berlin 1876-1878
Janz 2003 = T Janz The Scribes and the Date of the Vat gr 1291 in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae X Cittagrave del Vaticano 2003 pp 159-180
Jones 1990 = Ptolemyrsquos First Commentator ed A Jones Philadelphia 1990
Jones 1999 = Astronomical Papyri from Oxyrhynchus ed A Jones I-II Philadelphia 1999
Jones 2005 = A Jones Ptolemyrsquos Canobic Inscription and Heliodorusrsquo Observation Reports laquoSCIAMVSraquo 6 (2005) pp 53-97
Lempire 2014 = Steacutephanos drsquoAlexandrie Le commentaire aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Lempire Louvain 2014
Leurquin 1990 = Theacuteodore Meacuteliteacuteniote Tribiblos astronomique Livre I ed R Leurquin Amsterdam 1990
Leurquin 1991 = R Leurquin Un manuscrit autographe de la Tribiblos Astronomique de Theacuteodore Meacuteliteacuteniote le Vaticanus graecus 792 laquoScriptoriumraquo 45 (1991) pp 145-162
Maas 1927 = P Maas Griechische Palaeographie in A Gercke ndash E Norden (hrsg von) Einleitung in die Altertumswissenschaft I9 Leipzig 1927 pp 69-80
Martinelli Tempesta 2010 = S Martinelli Tempesta Il codice Milano Biblioteca Am-brosiana B 75 sup (gr 104) e lrsquoevoluzione della scrittura di Giovanni Scutariota in A B Garciacutea ndash I Peacuterez Martiacuten (ed by) The Legacy of Bernard de Montfaucon Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting Proceedings of the Seventh Inter-national Colloquium of Greek Palaeography Madrid-Salamanca 15-20 September 2008 Turnhout 2010 pp 171-186
Mazzucchi 1994 = C M Mazzucchi Leggere i classici durante la catastrofe (Costantino-poli maggio-agosto 1203) le note marginali al Diodoro Siculo Vaticano gr 130 Parte prima stratigrafia laquoAevumraquo 68 (1994) pp 164-218
Mioni 1976 = E Mioni Bessarione scriba e alcuni suoi collaboratori in Miscellanea marcia-na di studi bessarionei Padova 1976 pp 263-323
Mioni 1985 = Codices graeci manuscripti Bibliothecae Divi Marci Venetiarum II Thesaurus Antiquus Codices 300-625 recensuit E Mioni Roma 1985
Mogenet 1962 = J Mogenet Une scholie ineacutedite du Vat gr 1594 sur les rapports entre lrsquoastronomie arabe et Byzance laquoOsirisraquo 14 (1962) pp 198-221
Mogenet et al 1983 = Niceacutephore Greacutegoras Calcul de lrsquoeacuteclipse de soleil du 16 juillet 1330 ed J Mogenet ndash A Tihon ndash R Royez ndash A Berg Amsterdam 1983
Mondrain 2002 = B Mondrain Maxime Planude Niceacutephore Greacutegoras et Ptoleacutemeacutee laquoPa-laeoslavicaraquo 10 (2002) pp 312-322
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 165
Mondrain 2004 = B Mondrain Lrsquoancien empereur Jean VI Cantacuzegravene et ses copistes in A Rigo (a cura di) Gregorio Palamas e oltre Studi e documenti sulle controversie teologiche del XIV secolo bizantino Firenze 2004 pp 249-296
Mondrain 2007 = B Mondrain Les eacutecritures dans les manuscrits byzantins du XIV e siegravecle Quelques probleacutematiques laquoRSBNraquo n s 44 (2007) pp 157-196
Peacuterez Martiacuten 2006 = I Peacuterez Martiacuten Maxime Planude et le Diophantus Matritensis (Madrid Biblioteca Nacional ms 4678) un paradigme de la reacutecupeacuteration des textes anciens dans la ldquorenaissance paleacuteologuerdquo laquoByzantionraquo 76 (2006) pp 433-462
Peacuterez Martiacuten 2008 = I Peacuterez Martiacuten El lsquoestilo Hodegosrsquo y su proyeccioacuten en las escrituras constantinopolitanas laquoSampTraquo 6 (2008) pp 389-458
Perria 1991 = L Perria Scrittura e ornamentazione nei codici della laquocollezione filosoficaraquo laquoRSBNraquo n s 28 (1991) pp 45-111
Rollo 2012 = A Rollo LrsquoArchimede di Giorgio Valla in V Fera ndash D Gionta ndash A Rollo (a cura di) Archimede e le sue fortune Atti del Convegno di Siracusa-Messina 24-26 giugno 2008 Messina 2012 pp 99-147
Rome 1927 = A Rome Membra disjecta laquoRBenraquo 39 (1927) pp 187-188
Rome 1938 = A Rome Un manuscrit de la bibliothegraveque de Boniface VIII agrave la Meacutediceacuteenne de Florence laquoACraquo 7 (1938) pp 261-268
Ronconi 2013 = F Ronconi La collection philosophique un fantocircme historique laquoScripto-riumraquo 67 (2013) pp 119-140
Tannery ndash Steacutephanou 1940 = Quadrivium de Georges Pachymegravere ed P Tannery ndash E Steacutephanou Cittagrave del Vaticano 1940
Tihon 2011 = Πτολεμαίου Πρόχειροι Κανόνες Les Tables faciles de Ptoleacutemeacutee vol Ia Tables A1-A2 ed A Tihon Leuven 2011
Traube 1907 = L Traube Nomina Sacra Versuch einer Geschichte der christlichen Kuumlrzung Muumlnchen 1907
Vogel 1936 = K Vogel Beitraumlge zur griechischen Logistik laquoSBAWraquo Mathematisch-natur-wissenschaftliche Abteilung Jahrgang 1936 pp 357-472
Wouters 1979 = A Wouters The Grammatical Papyri from Graeco-Roman Egypt Contri-butions to the Study of the lsquoArs Grammaticarsquo in Antiquity Brussel 1979
F ACERBI Tav 1
b Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 65r
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 284 f 160r
F ACERBITav 2
b Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 13r
a Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 19v
F ACERBI Tav 3
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 136v
F ACERBITav 4
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17r
F ACERBI Tav 5
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17v
F ACERBITav 6
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 7v
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 133
b) Regole di moltiplicazione e divisione degli ordini sessagesimali defini-zione generale di moltiplicazione moltiplicazione di ordini come somma delle loro laquodenominazioniraquo Definizione generale di divisione divisione di ordini uguali e di un ordine per quello che lo precede immediata-mente divisione di ordini come sottrazione delle loro laquodenominazioniraquo divisione per 60 come divisione per 1 accompagnata dallo slittamento di un posto dellrsquoordine
c) Problemi che sorgono nella divisione di una parte sessagesimale per una di quelle che seguono divisione breve per riduzione allo stesso ordine (metodo laquoper analisiraquo) due algoritmi differenti il secondo con riduzione dei fattori comuni attribuito a Siriano
d) laquoAltroraquo metodo di divisione breve in realtagrave divisione tra somme di parti sessagesimali appartenenti ad ordini differenti per riduzione allo stesso ordine e applicazione dei metodi precedenti esempio della divisione di 0 2 0 4 per 0 0 2 0 240
e) Metodo di moltiplicazione tra numeri con parti non intere disposizione tabellare dei termini esempio della moltiplicazione di 5 4 6 per 8 0 3 0 525
f ) Primo metodo di divisione lunga descrizione della disposizione tabellare ed esempio di algoritmo applicato alla divisione di 50 48 26 30 per 8 16 28 5426
g) Metodo di divisione lunga tratto da Pappo in Alm III descrizione della disposizione tabellare ed esempio di algoritmo applicato alla divisione di 360 per 365 14 48 come verifica del valore 0 59 8 17 13 12 31 fornito nellrsquoAlmagesto per il moto medio giornaliero del sole27
h) Metodo di approssimazione di una radice quadrata secondo Erone Metr I 8 con giustificazione geometrica di Teone (attualmente non attestata in suoi scritti)
i) Verifica tramite moltiplicazione della correttezza del valore tolemaico28 di 67 4 55 come radice quadrata approssimata di 4500 Metodo di estrazio-ne di radici quadrate secondo Teone basato su applicazioni successive di Elementi II 4 la procedura termina dopo un numero finito di passi nel caso di quadrati perfetti Applicazione al calcolo della radice quadrata di 450029
unrsquoannotazione spazientita laquoIl texto di questo 2do quinterno egrave stato recopiato fidelmente dallrsquooriginale a chi volesse vedere la prova lo potragrave conferire con detto originale le pagine del qual texto corrispondono con quelle dellrsquooriginale tanti versi che pagine [hellip]raquo (Moge-net 1962 p 200)
25 Teone in Alm I 10 e I 14 in iA pp 45815-4604 e 57911-5811026 Teone in Alm I 10 in iA pp 4611-46217 applicato alla divisione di 1515 20
15 per 25 12 1027 Teone in Alm III 1 e IV 3 in iA pp 84112-84422 (stesso calcolo dei Prolego-
mena) e 102916-10327 idem in Alm IX pp 377-378 dellrsquoedizione di Basilea del 1538 approntata dai tipografi di Walderus Lrsquooriginale pappiano non ci egrave pervenuto
28 Alm I 10 in POO I 1 p 341129 Teone in Alm I 10 in iA pp 46916-4738
Fabio Acerbi134
Lrsquounico testo non elencato qui sopra o nelle note e che contenga tabelle operazionali egrave il commentario eutociano a Circ 3-4 Il testo ar-chimedeo che Eutocio e noi con lui leggeva egrave particolarmente conciso ed egli verifica esplicitamente il sussistere di certe relazioni numeriche Si tratta in ognuno dei nove casi presenti di mostrare che il lsquoteorema di Pitagorarsquo egrave verificato con ottima approssimazione dai valori numerici di opportune terne di rette Eutocio esegue le tre moltiplicazioni dei valori per se stessi e mostra che la somma o la differenza di due dei risultati si discosta di poco dal terzo30 I numeri in questione sono interi seguiti o no da una parte non intera espressa come somma di frazioni unita-rie31 I nove gruppi di tre moltiplicazioni una a fianco allrsquoaltra sono organizzati in forma tabellare ma senza lrsquoausilio di linee separatrici32 le operazioni sono eseguite disponendo lsquoin colonnarsquo i risultati delle mol-tiplicazioni parziali e sommandoli esattamente come facciamo oggi poicheacute sono in gioco numeri interi con parti frazionarie unitarie e la notazione non egrave posizionale non egrave necessario che gli incolonnamenti siano esatti (unitagrave di un risultato parziale sotto le decine del precedente ecc) Sono inclusi nella tabella istruzioni e commenti in linguaggio corrente33 le prime relative allrsquooperazione da affettuare sui risultati delle
30 Eutocio non calcola radici quadrate approssimate per quanto ciograve si renda piugrave volte necessario fornisce il risultato e verifica la sua correttezza moltiplicandolo per se stesso Egli dichiara che il lettore interessato a questo procedimento di calcolo puograve rivolgersi Ἥρωνι ἐν τοῖς μετρικοῖς [hellip] Πάππῳ καὶ Θέωνι καὶ ἑτέροις πλείοσιν ἐξηγουμένοις τὴν μεγάλην σύνταξιν τοῦ Κλαυδίου Πτολεμαίου laquoa Erone nei Metrica [hellip] a Pappo e Teone e a svariati altri inter-preti della Grande composizione di Claudio Tolomeoraquo (AOO III p 23213-17)
31 Troviamo ad esempio ͵αωλη θ´ ια´ cioegrave 1838 + 19 + 111 notare il singolo apice per le frazioni unitarie
32 Essi sono editi in AOO III pp 234-256 La tradizione medievale del commentario eutociano che coincide con un ramo di quella archimedea e deriva da un codice appar-tenuto a Giorgio Valla perduto in etagrave rinascimentale ma riprodotto a volte con fedeltagrave assoluta negli apografi (si veda ad esempio nella tav 1a la riproduzione dellrsquoerronea di-sposizione di cifre e parte algoritmica nel primo gruppo di moltiplicazioni offerta dal Laur Plut 284 f 160r) egrave costituita da Marc gr 305 ff 142v-146v Laur Plut 284 ff 159r-164r Par gr 2360 ff 109v-113v Par gr 2361 pp 410-421 Nel codice veneziano in cui la disposizione per righe e colonne egrave irrimediabilmente alterata dal copista le operazioni sono cancellate con tratti di penna Il primo manoscritto fu esemplato per Bessarione da Giorgio Trivizias tra il 1455 e il 1468 (Mioni 1976 pp 309-312) il secondo fu vergato da Giovanni Scutariota in scrittura di imitazione (Martinelli Tempesta 2010 p 173 n 7 Rollo 2012) ca 1491-1492 il terzo fu trascritto per il cardinale di Firenze Niccolograve Ridolfi dopo che la biblioteca di Valla era stata acquistata a seacuteguito della sua morte avve-nuta il 23 gennaio 1500 per 800 scudi drsquooro da Alberto Pio di Carpi (nota del copista al f 120v) il quarto fu terminato per mano di Christopher Auer su commissione di Georges drsquoArmagnac il primo gennaio 1544 (sottoscrizione a p 474 del codice si veda RGK II nr 525)
33 A questi va aggiunto posto davanti al risultato finale di ogni moltiplicazione il segno convenzionale per ὁμοῦ laquoinsiemeraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 135
prime due moltiplicazioni34 i secondi alla bontagrave dellrsquoapprossimazione ottenuta35 Ogni gruppo di operazioni che chiude unrsquounitagrave esegetica ed egrave seguito dalla citazione che apre la successiva egrave trascritto come se facesse parte del testo a tutta pagina e preceduto dallrsquoindicazione οἱ δὲ πολλαπλασιασμοὶ ὑπόκεινται laquole moltiplicazioni sono poste qui sottoraquo Questi due fatti suggeriscono che tutte le operazioni cui Eutocio non fa alcun riferimento nel corpo del suo commentario siano unrsquoaggiunta editoriale risalente a Isidoro di Mileto che si occupograve della revisione del testo36
Gli incolonnamenti esatti sono invece necessari quando siano moltiplicati numeri con parti non intere espresse nel sistema sessage-simale in quanto la somma finale dei prodotti parziali va effettuata ordine per ordine Tale somma eccederagrave di norma il valore di 60 per un ordine dato nella tabella occorre pertanto trovare posto anche per i riporti che vanno sommati ai prodotti parziali dellrsquoordine preceden-te e quindi incolonnati con essi I testi ci offrono alcuni esempi di tabelle operazionali moltiplicative di questo tipo Teone afferma espli-citamente che la prima moltiplicazione che va a descrivere ha una rap-presentazione tabellare la cui disposizione ritroviamo pesantemente ingarbugliata nel Laur Plut 2818 f 35r37 Alla seconda occorrenza di una moltiplicazione eseguita (tav 1b Laur Plut 2818 f 65r) gli incolonnamenti sono meglio rispettati anche se il risultato finale egrave fatto erroneamente slittare di un posto verso destra i riporti (con un errore) si trovano nella penultima riga38 Nei Prolegomena ad Alma-gestum alcune moltiplicazioni sono accompagnate da tabelle quella meglio attestata egrave associata alla moltiplicazione di 67 4 55 per se stesso (sezione i nel riassunto fornito supra) ed egrave descritta additando sempli-cemente ad un ente materiale oramai inaccessibile forse tracciato in loquendo lsquoalla lavagnarsquo
34 Come λοιπὸν τὸ ἀπὸ ΕΓ laquoresta quello su ΕΓraquo seguito dal risultato della sottrazione di due quadrati
35 Come λείπει ἄρα μο β εἰς τὸ ἀκριβές laquomancano quindi 2 u(nitagrave) al risultato esattoraquo36 Si legga la sottoscrizione spuria ad AOO III p 26010-1237 Si legga la frase ἐκτίθεμαι αὐτὴν καὶ πάλιν αὐτὴν ὑφ᾽ αὑτὴν ὡς ὑπογέγραπται laquolo [scil il
valore del lato da moltiplicare per se stesso] dispongo lsaquouna voltarsaquo e di nuovo al sotto di se stesso come trascritto qui sottoraquo in iA p 45817 Il Laur Plut 2818 (Teone e Pappo Commentaria in Almagestum) egrave uno dei piugrave antichi manoscritti in minuscola sicuramente assegnabile alla prima metagrave del IX secolo (Follieri 1977 p 144 n 23 Maas 1927 p 76 n 17 riteneva che fosse piugrave antico del Tetraevangelo Uspenskij) per una sua analisi si veda Rome 1938
38 In nessuno dei due casi i numerali di molteplicitagrave sono segnalati con apici sono tutti sormontati da una barra si veda la sezione 4 punto b
Fabio Acerbi136
προκείσθω δὶς τὸ μῆκος αὐτῆς ὀφεῖλον τὴν τάξιν τοῦ κατὰ τοὺς πολλαπλασιασμοὺς κανόνος ἀποδοῦναι καὶ ἐκκείσθω ἐπὶ σελιδίων διαγεγραμμένων οὕτω καὶ δὴ αὐτῆς ἐφ᾽ ἑαυτὴν πολ-λαπλασιασθείσης γεγονέτωσαν τὰ ἐν τοῖς οἰκείοις σελιδίοις εἴδη ταῦτα δὴ συναγόμενα καθ᾽ ἣν ὑπεδείξαμεν τάξιν ποιήσει τὰς ὑπογεγραμμένας μοίρας ἢ καὶ λεπτά τινα εἴσι ͵δυϙθ νθ´ ιδ´´ ι´´´ κε´´´´ ὡς λείπειν τοῦ ἐπιμερισθῆναι ŏ ŏ με´´ μθ´´´ λε´´´´
che sia prescritto che la sua lunghezza debba figurare due volte nella disposizione della tavola delle moltiplicazioni e che lsaquoquestrsquoultimarsaquo sia disposta su colonne delimitate da linee cosigrave mdash E pertanto una volta moltiplicato lsaquoil latorsaquo per se stesso che le specie trovino posto nelle colonne appropriate quelle che vengono cosigrave raccolte secondo la disposizione che abbiamo indicato produrranno dunque i gradi o anche i minuti qui sotto trascritti 4499 59 14 10 25 in modo che dalle divisioni successive resti39 0 0 45 49 35
La tabella associata (tav 2a Marc gr 313 f 19v) contiene una sola svista grossolana reca 51 invece di 55 in ognuno dei due fattori posti affiancati sopra di essa Al di sotto preceduto dal segno convenzionale per ὁμοῦ egrave collocato il risultato incongruamente sfalsato di un paio di colonne e con la lettera numerale ͵δ priva di barra sormontante in-naturalmente disconnessa da υϙθ I riporti sono indicati dai numerali ι ρκγ´ η´´ ν´´´ posti al fondo delle prime quattro colonne Il calcolo egrave corretto in ogni sua parte
Il clou in questo piccolo spaccato delle interazioni testo-paratesto matematico risiede nella descrizione contenuta nei Prolegomena della disposizione tabellare di due procedimenti di divisione il primo ano-nimo e quindi da supporre tradizionale il secondo piugrave efficiente ed attribuito al matematico del IV secolo Pappo
Il primo metodo di divisione egrave sostanzialmente analogo a quello che usiamo attualmente Dividendo e divisore questrsquoultimo preceduto da un segno su cui ritorneremo nella prossima sezione sono posti uno sotto lrsquoaltro intervallati da una riga inizialmente vuota Primo passo viene reperito il massimo multiplo del divisore che sia minore del di-videndo esso viene trascritto sotto il dividendo nella prima lsquocasellarsquo della riga vuota recante in testa un segno per laquosottrairaquo il fattore mol-tiplicativo (o quoziente parziale) viene trascritto in una lsquocasellarsquo pre-ceduta da un segno per laquorisultaraquo sotto il divisore Secondo passo il massimo multiplo viene sottratto dal dividendo il resto cosigrave ottenuto egrave trascritto preceduto da un segno per laquorestoraquo in una casella posta
39 Lrsquoautore concettualizza il procedimento di estrazione di radice quadrata come una forma di divisione
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 137
accanto al dividendo40 I due passi precedenti sono quindi ripetuti con la sola differenza che il resto appena ottenuto prende il posto del divi-dendo il quoziente parziale scala di un ordine sessagesimale ad ogni passo41 E cosigrave via aggiungendo ogni volta due caselle La debolezza di questo metodo come di quello che utilizziamo attualmente risiede nel fatto che il reperimento dei quozienti parziali (ovverosia dei massimi multipli) viene effettuato per tentativi non riuscire a farlo al primo colpo appesantisce notevolmente i calcoli successivi e costringe ad un lavoro di riordino e addizione dei quozienti parziali stessi La tabella risultante dove appunto osserviamo questo fenomeno in parallelo con identiche inaccuratezze nella descrizione ha la forma riprodotta unico tra i manoscritti della recensione antica nel Marc gr 313 f 13r (tav 2b invito il lettore a non rivolgersi alle tavole se non dopo aver termi-nato questa sezione sarebbe anzi auspicabile che tentasse di ricostruire questa tabella e le due successive a partire dalla mia descrizione)42
Il secondo metodo di divisione attribuito a Pappo egrave congegnato in modo da rendere non aleatoria la ricerca dei quozienti parziali Come altrove nei Prolegomena la descrizione della procedura di calcolo si riag-gancia esplicitamente a una frase di Tolomeo laquouna volta dimostrato che il periodo di una singola rivoluzione lsaquodel solersaquo egrave di 365 giorni 14 48 se di-vidiamo per essi i 360 gradi di un singolo cerchio avremo il moto medio giornaliero del sole circa 0 gradi 59 8 17 13 12 31raquo43 Questrsquoaffermazione si trova nel terzo libro dellrsquoAlmagesto si tratta della prima occasione in cui viene effettuata una divisione in cui il divisore egrave maggiore del dividendo e i commentatori del trattato tolemaico non si fecero sfuggire lrsquooccasione di mostrare come eseguirla Ora il terzo libro del commentario di Pappo non ci egrave pervenuto Ci resta dunque come testo parallelo a quello dei Prolegomena la descrizione rigidamente formulare in Teone sicuramente un calco di quella pappiana Teone qui come nelle altre applicazioni del metodo (Laur Plut 2818 ff 136v [tav 3] e 190r) descrive brevemente ed espone esplicitamente la stessa tavola dei sottomultipli del divisore che
40 Esempio nella divisione di 378 per 17 il massimo multiplo egrave 374 il quoziente parziale egrave 22 il resto 4 e in effetti 378 = 374 + 4 = 17times22 + 4 Si noti che il segno per laquorestoraquo non egrave apposto in testa di riga ma davanti a ogni resto parziale e in effetti il dividendo che si trova in prima posizione in questa riga non egrave un resto
41 Analogamente nellrsquoalgoritmo moderno poniamo la virgola o scaliamo la cifra di un posto
42 Nei Prolegomena la descrizione della tabella associata al metodo anonimo egrave pre-ceduta da una breve sinossi dellrsquooperazione in stile procedurale (cioegrave senza riferimenti alla tabella) e seguita dalla sua esecuzione accurata ma con pochi riferimenti alla tabella se non quello ai due segni da apporre ai resti parziali e ai massimi multipli
43 Alm III 1 in POO I 1 p 2091-4
Fabio Acerbi138
troviamo nei Prolegomena ma non offre alcuna descrizione della disposi-zione tabellare della divisione stessa neacute vi fa riferimento
A questa procedura sono in effetti associate una tavola e una tabel-la costruite come segue (tavv 4 e 5 Marc gr 313 ff 17r e 17v il co-pista era ndash giustamente ndash insoddisfatto della prima versione) La tavola le cui righe e colonne sono delimitate da linee contiene sottomultipli44 del divisore 365 14 48 9 righe che riportano i valori da 160 a 960 piugrave altre 6 con i valori per decine da 1060 a 6060 la prima colonna elenca le 15 parti sessagesimali omettendo come drsquoabitudine la laquodenomina-zioneraquo dellrsquoordine (i numerali elencati sono quindi α β γ δ ε ϛ ζ η θ ι κ λ μ ν ξ) la seconda i sottomultipli corrispondenti organizzati su quattro colonne per tener conto dei tre ordini sessagesimali (il primo sottomultiplo egrave quindi ϛ ε´ ιδ´´ μη´´´ cioegrave 160 di τξε ιδ´ μη´´) La tabella priva di linee delimitanti espone la vera divisione Nella prima colonna troviamo i resti parziali ognuno preceduto dallrsquoindicazione del proprio ordine sessagesimale e da un segno per laquorestoraquo Nella seconda preceduti da un segno per laquosottrairaquo i sottraendi ognuno coincide ovviamente con uno dei sottomultipli nella tavola La terza colonna contiene se-guiti dallrsquoindicazione del proprio ordine sessagesimale i quozienti par-ziali ottenuti trascrivendo dalla prima riga della tavola il numerale corrispondente al sottraendo affiancato ed assegnando come ordine sessagesimale il successivo a quello posto in testa di riga Il risultato preceduto da un segno per laquorisultaraquo e posto al di sotto della tabella si ottiene sommando i quozienti parziali il procedimento non permette in generale di determinare lrsquointero quoziente parziale relativo ad un ordine sessagesimale fissato se non dopo due passi Una linea spezzata unisce i resti parziali successivi e i relativi sottraendi per evidenziare la laquoprogressione della proceduraraquo la spezzata lsquosaltarsquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore (le cui righe sono per il resto vuote) e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue di conseguenza anche il quoziente parziale relativo a questo resto appartiene allrsquoordine sessagesimale successivo
A questo punto possiamo rivolgerci alle tavv 4-5 e verificare se le immagini che ci siamo formati sulla base della mia descrizione corri-spondono a quelle che troviamo nel Marc gr 313 Non si tratta di un giochetto sterile egrave al contrario il cuore di un intrico di problemi Un primo ordine di problemi deriva dal fatto che nei Prolegomena lrsquoalgo-
44 Sottomultipli e non multipli in quanto il divisore egrave maggiore del dividendo Drsquoaltronde nel sistema sessagesimale come in quello decimale un sottomultiplo si ottiene dal multiplo corrispondente semplicemente scalando tutte le cifre di un posto (ad esempio 1360 di 365 14 48 si ottiene in questa maniera da 13 volte 365 14 48)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 139
ritmo della divisione lsquoalla Papporsquo non egrave mai eseguito (cioegrave formulato verbalmente) in maniera indipendente dalla descrizione della tabella Comrsquoegrave dunque possibile descrivere una tabella operazionale che non ha uno statuto testuale indipendente sulla base di un algoritmo in corso di esecuzione E drsquoaltro canto come non rilevare unrsquoanomalia in un algoritmo eseguito nella sua forma primaria sotto forma di descrizione di una tabella Ci potremmo chiedere se viene descritto lrsquoalgoritmo o la tabella La tensione fra i due enti grafici egrave acuita dal fatto che nei nostri testi tutto ciograve (esposizione o descrizione di un algoritmo o della tabella associata) avviene sempre e solo sulla base di un esempio numerico para-digmatico Per questo motivo la tabella in quanto struttura (cioegrave privata dei dati numerici accidentali) non puograve fare a meno della descrizione45 Dal canto suo Teone come forse Pappo ancor prima descrive ed espone la tavola dei (sotto)multipli ma non la tabella di divisione lrsquoalgoritmo relativo a questrsquoultima egrave espresso come per controbilanciare in maniera eccezionalmente trasparente e formulare Se ciograve comporta un guada-gno a livello verbale-argomentativo sorge un problema operativo grave come e dove sistemare i resti e i quozienti parziali ndash cioegrave tutti i numeri in output dellrsquoalgoritmo differenti dai (sotto)multipli ndash che la tabella si incarica di disporre in modo lsquonaturalersquo Teone prescrive soltanto di confrontare i resti con la seconda colonna della tavola dei sottomultipli e di trascrivere via via il quoziente ottenuto dopo ogni passo Insomma come eseguire materialmente una divisione Non certo adattando ad un nuovo caso specifico la formulazione dellrsquoalgoritmo che Teone propone
Un secondo ordine di problemi e una trappola micidiale per il co-pista egrave interno alla dialettica lsquotabellarsquolsquosua descrizionersquo ed egrave in assenza di simbolismo quello dei riferimenti linguistici da adottarsi nella seconda agli enti grafici che figurano nella prima Occorre ricercare la massima generalitagrave fornita da una descrizione definita di un ente numerico (ad esempio impiegando il termine laquorestoraquo o la perifrasi laquomassimo sotto-multiplo minoranteraquo) o basta assumere direttamente il suo valore speci-fico come esempio paradigmatico E in che modo risolvere il conflitto tra uso e menzione se come nel nostro caso la tabella contiene segni convenzionali ed occorre fornirne una descrizione Si rende ad esempio necessario introdurre un lsquooperatore di citazionersquo noi useremmo le virgo-lette la lingua greca premette lrsquoarticolo neutro Drsquoaccordo ma nel caso
45 Questa caratteristica non egrave connaturata alla matematica degli algoritmi la risorsa dello lsquostile proceduralersquo serve esattamente ad aggirare questo problema al di lagrave di un certo livello di dettaglio perograve essa condurrebbe ad un appesantimento insostenibile della for-mulazione dovuto alla pluralitagrave dei riferimenti agli oggetti matematici in gioco sulla que-stione dei diversi stili della matematica greca si veda Acerbi 2012
Fabio Acerbi140
greco qual egrave il suo range E come distinguerlo nei casi ambigui da un semplice articolo che precede un sostantivo quando questrsquoultimo lo ri-chieda Nel corso del processo di copia del testo della descrizione infine possono generarsi tensioni tra enti grafici interpretabili vuoi come segno convenzionale vuoi come abbreviazione Ambiguitagrave relative a questi punti opacizzano la descrizione Un problema analogo si porrebbe a priori nella dialettica tra uso delle lettere denotative per designare enti geometrici e loro menzione nella costruzione di un diagramma ma esso egrave risolto con lrsquoazzeramento della seconda funzione le lettere denota-tive sono sempre usate allrsquointerno del testo (sono cioegrave il referente degli oggetti geometrici di cui tratta il discorso matematico) mai menzionate (come accadrebbe se fossero il referente di oggetti grafici posti nel dia-gramma) Insomma il codice adottato per la costituzione dei diagrammi geometrici egrave condiviso (cioegrave canonizzato) semplice e perspicuo mentre quello per le tabelle operazionali non lo egrave da qui le sviste dei copisti e le trascuratezze di correttori ed editori
Infine chi vuole apprendere da questi testi come eseguire una divi-sione a cosa deve prestar fede se ad esempio a causa di errori di copia la descrizione finisce per non coincidere con la tabella operazionale visto che sono entrambe due maniere valide di eseguire lo stesso algoritmo Dopo tutto lo scopo di tutta questa macchina grafico-argomentativa egrave di insegnare a eseguire divisioni in formato tabellare Questo problema si fa particolarmente acuto se la tabella non egrave trasparente nel metodo di Pappo lo egrave quasi completamente in quello anonimo no E gli errori che riscontreremo nella (doppia) tabella ai ff 17r-v del Marc gr 313 a chi sono attribuibili Allrsquoautore al trascrittore o al copista medievale
Questo groviglio di problemi riceve alcune risposte sorprendenti dalla tradizione manoscritta come andiamo finalmente a vedere
4 Analisi delle testimonianze
I codici che ho adibito per lrsquoedizione sono i seguenti M = Marc gr 31346 C = Marc gr 314 (Tolomeo Tetrabiblos et opera minora cum commentariis Vezio Valente Anthologiae)47 Z = Vat gr 2326 (fattizio
46 Riferibile al sec IX ex-X in accolgo la datazione suggeritami per litteras il 522005 da Nigel G Wilson si veda anche Agati 1992 pp 141-142 La presenza non sistematica degli accenti che fa anticipare a Wilson la datazione di laquosaec X medraquo fornita in Mioni 1985 p 24 indusse Boris Fonkič (2005 non vidi) ad assegnare il codice allrsquoinizio del IX secolo
47 Il manoscritto riferibile alla seconda o terza decade della prima metagrave del XIV secolo fu vergato da Michele Clostomalle olim lsquoMetochitesschreiberrsquo Bianconi 2005a pp 428-430 Il titolo dei Prolegomena in questa trascrizione identico in grafia ma non in formulazione a
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 141
e mutilo Tolomeo Almagestum) S = Vat gr 184 (varia astronomica scholia miscellanea ad Almagestum Tolomeo Almagestum) P = Par gr 2390 (varia astronomica) gli ultimi tre riferibili allo scorcio del XIII secolo48 e apografi sicuri del Vat gr 159449 attualmente mutilo di due fascicoli che ci privano dei due terzi finali dei Prolegomena M e il Vat gr 1594 ammettono un modello comune il resto della tradizione (25 trascrizioni in tutto) dipende dagli apografi appena citati del Vat gr 1594 Le varianti della recensione bizantina che leggiamo tra lrsquoaltro nei Vat gr 198 Marc gr 310 (Tolomeo Almagestum cum commentariis Pappi Theonis et Cabasilae) e con ulteriori modifiche Laur Plut 89 sup 48 (varia astronomica Tolomeo Almagestum Barlaam Logistica) sono identificate dal siglum K e si trovano punteggiatura originale in-clusa nel secondo apparato50 Lrsquoanalisi delle testimonianze51 costituite ovviamente anche dalle tabelle associate saragrave condotta nella forma di una sequenza di osservazioni indicizzate da numerali o lettere oltre che di alcune note a piersquo di pagina
Iniziamo dalla descrizione del metodo di divisione anonimo
quello che leggiamo nel Vat gr 1594 (questrsquoultimo coincide con quello adottato nella recen-sione bizantina) fu apposto da Niceforo Gregora e successivamente corretto da Bessarione
48 Sto studiando il primo e il terzo codice in collaborazione rispettivamente con Daniele Bianconi e Inmaculada Peacuterez Martiacuten
49 Su questo codice risalente alla seconda metagrave del IX secolo e sulla sua collocazione nella lsquocollezione filosoficarsquo per prima proposta in Follieri 1977 pp 145-146 si vedano almeno Perria 1991 pp 82-88 Ronconi 2013 Che il titolo dei Prolegomena nel Vat gr 1594 sia stato apposto da Niceforo Gregora egrave stato riconosciuto per la prima volta in Mazzucchi 1994 p 211 n 196 si veda Bianconi 2005a p 418 per altri interventi di Gregora nello stesso manoscritto
50 Il Vat gr 198 egrave stato vergato dal copista Malachia nel corso del terzo quarto del XIV secolo Mondrain 2004 pp 278-290 e 292 Allo stesso copista (denominato non a caso prima dellrsquoidentificazione anonymus Aristotelicus) dobbiamo un buon numero di trascrizioni aristoteliche con i relativi commentari in margine Gli dobbiamo anche il Par gr 2342 secondo tomo di un quadrivium quasi completo di cui il Vat gr 198 egrave il primo nellrsquoordine aritmetica armonica astronomia (Almagesto e commentari relativi) nel codice vaticano geometria ed ancora astronomia (corpus astronomico minore) in quello parigino le opere trascritte sono sempre accompagnate in margine dai relativi commentari Il copista del Marc gr 310 egrave Isacco Argiro (ca 1300-1375) Mondrain 2007 p 166 Allo stesso Argiro dobbiamo il codice laurenziano (Daniele Bianconi per litteras) Poicheacute la recensione modificata che leggiamo nel Laur Plut 89 sup 48 egrave senza alcun dubbio basata su quella nel Marc gr 310 e non viceversa ci troviamo di fronte ad un copista che trascrive due volte lo stesso testo in due versioni leggermente differenti la conclusione naturale egrave che la seconda recensione egrave dovuta ad Argiro stesso la questione andragrave studiata in dettaglio
51 Nei manoscritti citati i Prolegomena si trovano ai fogli seguenti Vat gr 1594 ff 1r-8v (mutilo mancano due fascicoli su tre) Marc gr 313 ff 1r-28r (incompleto man-cano due fogli allrsquoinizio e il f 6 attualmente rimpiazzato da uno bianco) Marc gr 314 ff 235r-255r Vat gr 2326 ff 19r-40v e 43r-v (incompleto e con i fascicoli in disordine) Vat gr 184 ff 10r-23v Par gr 2390 ff 1r-13v Vat gr 198 ff 127r-136v Marc gr 310 ff 1r-13r Laur Plut 89 sup 48 ff 7r-19r
Fabio Acerbi142
ἐκθέμενοι οὖν διάγραμμα τῶν ἀριθμῶν ὡς ὑπόκειται προτάσσομεν τὸν μεριζόμενον καὶ μικρὸν ὑπ᾽ αὐτὸν τὸν μερίζοντα ὡς ἔχει τὸ διάγραμμα ἐν στίχοις διοριζομένοις ὑπὸ γραμμῶν [hellip] καὶ τὰ μὲν γινόμενα ἐγγὺς ἐλάττονα ἐν τῇ μεταξὺ θέσει τοῦ μεριζομένου καὶ τοῦ μερίζοντος ἐν στίχοις παρασημειοῦσθαι πρὸς τὸ ἀσύγχυτον εἶναι τὴν τάξιν τὰ δὲ μεθ᾿ ὧν ὁ μερίζων ἐποίει τοὺς ἀεὶ ἐλάσσονας ὑπὸ τὸν μερίζοντα σημειοῦσθαι προγράφοντας ἐπὶ τοῦ στίχου αὐτῶν τὸ γίνεται οὕτως γι ἐν δὲ τῷ στίχῳ τῶν μεριζόντων τὸ παρὰ ἔχον οὕτως oslash ἀντὶ τοῦ παρ᾿ ἃ δεῖ τὸν μερισμὸν γίνεσθαι ἐν δὲ τῷ στίχῳ τῶν ἐλασσόνων τὸ αφ διὰ τὸ τούτους ἀεὶ ἀφαιρεῖσθαι ἀπὸ τῶν ἐπάνω τῶν μεριζομένων ἐν δὲ τοῖς τοῦ μεριζομένου λοιπάσμασι τοῖς καὶ ἐπιοφείλουσι τὸ λ κατὰ τὸ ἴδιον τῶν διαστάσεων ἑκάστης ndash λέγω δὴ λοιπάδος ndash ἀντὶ τοῦ λοιποὶ οἱ μέλλοντες ἐπιμερίζεσθαι
2 post τὸν suprascr τὸν ἐλάττονα m 2 S 5 πρὸς] MP et ex corr Z κατὰ S om C | ἀσύγχυτον] MSPC -χητον Z 6 ἀεὶ] MZPC ὡσεὶ S 7 γίνεται οὕτως γι ] γι τ οὕτως γι τ M γί οὕτως γί Z γι οὕτως γί SC τὸ γινόμενον οὕτως γίνεται P 8 τὸ παρὰ ἔχον οὕτως] scripsi τὸ παρέχον οὕτως M et π(αρ-) comp Z οὕτως τὸ περιέχον S προγράφοντας οὕτως ex corr m 2 P τὸ περιέχον οὕτως C | oslash] MZSC (sed ο fecit | Z) ἐλάττων comp ex corr m 2 P | παρ᾿ ἃ] scripsi παρα M π(αρα) comp ZSC ex παρα fe-cit παρὰ et τοῦτον suprascr m 2 P 9 γίνεσθαι] comp C | αφ ] αφ ε M ἀφ ZSC ἀφαί P | ἀεὶ] om M 11 ἐπιοφείλουσι] MZSC ex ἐπιο- fecit ἐπο- m 2 P | λ] MZPC λ´ S 12 λοιποὶ] PC λοιποῦ MZS
3 στίχοις] στίχῳ K 5 πρὸς] διὰ K 7 ἐπὶ mdash γι ] τὸ γίνεται διὰ τοιούτου σ(ημείου) γί K 8 τὸ παρὰ ἔχον mdash παρ᾿ ἃ] τὸ παρᾱ διὰ σ(ημείου) τοιούτου καὶ τοῦτο oslash δηλοῦντος τοῦ παρᾱ ὅτι παρὰ τὸν τοιοῦτον (ἀριθμὸν) K 9 αφ διὰ τὸ τούτους] ἀφ δηλοῖ δὲ τοῦτο ἀφαίρεσ(ιν) ὅτι τούτους ἀεὶ δεῖ K 11 ἐπιοφείλουσι] ἐπιμερίζεσθαι ὀφείλουσι K | λ] λ οι` K 12 ἀντὶ τοῦ] δηλοῦντος τοῦ σ(ημείου) τὸ K
lsquoRendendo esplicito un diagramma numerico come lo troviamo qui sotto disponiamo in primo luogo il dividendo e un poco al di sotto di esso il divisore come li ha il diagramma in righe delimitate da linee [hellip] e lsaquooccorreragraversaquo nella posizione tra il dividendo e il divisore annotare lrsquouno accanto allrsquoaltro i piugrave vicini lsaquodei numerirsaquo minori che risultano affincheacute la disposizione non sia confusa quelli con cui il divisore faceva ogni volta i lsaquonumerirsaquo minori annotarli sotto il divisore scrivendo in prima posizione sulla loro riga laquorisultaraquo cosigrave Ris nella riga dei diviso-ri52 invece laquoperraquo fatto cosigrave53 P in luogo di laquoquelli per cui deve farsi la divisioneraquo nella riga dei lsaquonumerirsaquo minori laquosottrraquo in quanto questi sono sempre sottratti dai dividendi che si trovano sopra nei residuli del dividendo (occorre ben farlo anche per loro) laquoReraquo in accordo con ciograve
52 I laquodivisoriraquo sono al plurale ma siamo semplicemente di fronte a un tratto idioma-tico della lingua greca nel caso di espressioni generalizzanti crsquoegrave soltanto un divisore che occupa lrsquounica colonna di cui si compone la sua riga
53 Si intenda ἔχον οὕτως = ita se habens
1
5
10
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 143
che egrave proprio agli scarti di ciascuno ndash intendo qui lsaquociascunrsaquo residuo54 ndash in luogo di laquoresti che vanno a essere divisi ulteriormenteraquorsquo
a) Operatori di citazione e segni convenzionali I segni introdotti sono quattro la mia discussione egrave condotta dando per scontato che essi siano identici a quelli impiegati dallrsquoautore dei Prolegomena anche se si tratta di unrsquoipotesi non corroborabile neacute falsificabile
i Segno per il risultato Lrsquoabbreviazione convenzionale per γίνεται egrave identica al segno introdotto dallrsquoautore e i copisti si dividono tra i due errori possibili scrivere due abbreviazioni o risolverle entrambe Un fenomeno del tutto analogo si riscontra nel Matr 4678 il manoscritto alla base di tutta la tradizione degli Arithmetica di Diofanto al momen-to della definizione dellrsquoἀριθμός (lrsquolsquoincognitarsquo nel nostro linguaggio) ὁ δὲ μηδὲν τούτων τῶν ἰδιωμάτων κτησάμενος ἔχων δὲ ἐν ἑαυτῷ πλῆθος μονάδων ἄλογος ςο` καλεῖται ς` ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον τὸ ς` laquoil lsaquonumerorsaquo che non possiede nessuna di queste proprietagrave ma che ha in seacute una molteplicitagrave indefinita di unitagrave egrave chiamato lsquonumerorsquo e il suo segno egrave ς`raquo Qui solo il terzo dei tre ς ha una barra a sormontare per segnalarne il carattere puramente denotativo (cioegrave di segno convenzionale e non di abbreviazione si veda il punto successivo)55 il primo egrave una delle abbreviazioni piugrave diffuse per ἀριθμός (e infatti egrave dotato del compendio per la desinenza e dellrsquoaccento grave) il secondo egrave una delle piugrave comu-ni per καὶ () Giovanni Cortasmeno autore di capillari annotazioni infra lineam agli Arithmetica nel codice madrileno scioglie il primo ςο`
54 Doppia variatio che impiega al posto di λοιπόν laquorestoraquo i due termini decisamente non canonici τὸ λοίπασμα e ἡ λοιπάς (piugrave oltre leggiamo anche il participio λοιπασθέντα) Una ricerca sul TLG in rete non ha fornito occorrenze del primo si tratta dunque di uno hapax Quanto al secondo che ricorre anche nella sezione sulla divisione lsquoalla Papporsquo lo si rintraccia giagrave nei papiri documentari il termine diventeragrave perograve canonico nelle esposizioni bizantine drsquointroduzione allrsquoAlmagesto ricalcate sul modello dei Prolegomena (si veda la nota 87 infra) Questi due termini designano i resti parziali prodotti nel corso di una divisione lunga li ho tradotti rispettivamente con il neologismo laquoresiduloraquo e con il sostantivo pari-menti non canonico laquoresiduoraquo
55 Il copista interpreta erroneamente il terzo segno come unrsquoabbreviazione e qui ag-giunge un apice inverso (cioegrave un accento grave) altrove lo scioglie direttamente in forme opportune di ἀριθμός Matr 4678 f 58v La frase come la leggiamo nel manoscritto egrave cor-rotta sulla base di una parafrasi in Psello (edita in DOO II p 3710-12) Tannery emendograve ἄλογος in ἀόριστον DOO I p 64-5 et app Il Matritensis vergato da due copisti differenti (cambio di mano a tre righe dalla fine del f 62r) contiene lrsquoIntroductio arithmetica di Nicomaco e le opere diofantee oltre ad alcuni brevi opuscoli musicali la sua data egrave stata recentemente corretta dal XIII al secolo XI pm in Peacuterez Martiacuten 2006 (una riproduzione digitale del manoscritto si trova allrsquoindirizzo httpbdhbneesbnesearchbibliotecaDio-fanto20de20AlejandrC3ADa)
Fabio Acerbi144
in ἀριθμός ed aggiunge un altro segno56 sopra il terzo anteponendovi lrsquoindicazione καὶ ἔστιν αὐτοῦ σ(ημεῖον) τόδε Va da seacute che non abbiamo nessuna garanzia che il segno originariamente introdotto da Diofanto coincidesse realmente con unrsquoabbreviazione convenzionale per ἀριθμός Lrsquoevidenza del PMich III 144 (sec II in) suggerisce drsquoaltronde che il Matritensis e con esso tutta la tradizione medievale di Diofanto ripro-duca fedelmente pur accentuandone la sinuositagrave il segno originario
ii Segno per il divisore Un cerchiolino sbarrato da non confondere con il segno per ὁμοῦ che nei manoscritti matematici ha di norma due barre trasversali (cf tav 2a) Non sono riuscito a rintracciarne ulteriori occorrenze in altre opere la forma che esso assume nel Vat gr 2326 e la correzione apportata nel Par gr 2390 lasciano aperta la possibilitagrave per quanto a mio avviso remota che la forma originaria non fosse lon-tana da unrsquoabbreviazione di παρά registrata nei repertori57 Il correttore del Par gr 2390 trasforma in effetti il segno oslash nellrsquoaffine abbreviazione canonica per (forme di) ἐλάσσων laquominoreraquo58 e si incarica diligente-mente di farlo notare ricapitolando i segni nella porzione superiore del margine esterno del f 7v Nello stesso margine egli traccia anche uno lsquoscolio tabellarersquo ed egrave lrsquounico a porre il (proprio) segno dove indicato dalla descrizione (tav 6 Par gr 2390 f 7v) Oltre a ciograve adattando la tabella al margine ristretto lo scoliaste trascrive come colonne affian-cate le due righe dei resti parziali e dei massimi multipli e aggiunge le indicazioni ὁ μεριζόμενος laquodividendoraquo e ὁ μερίζων laquodivisoreraquo ma vi introduce alcune incongruenze di formato il risultato scritto in verti-cale e la linea verticale di sinistra che separa il divisore dal segno che lo dovrebbe precedere direttamente
iii Segno per i massimi multipli Corrisponde alla semplice abbre-viazione per sospensione della forma verbale ἄφελε laquosottrairaquo in questo
56 Si tratta del segno di ampio uso praticamente identico allrsquoabbreviazione canonica per οὖν
57 Si tratta di un pi a forma di gancio sbarrato da uno slash di troncamento Ce-reteli 1904 tav IX item 7 sub ΠΑΡΑ che rinvia al PVindRain 423 cf anche la forma π` nel POxy LXI 4142 edito in Jones 1999 II pp 26-34 In generale nei papiri e nei manoscritti matematici in maiuscola le preposizioni sono abbreviate facendo seguire un lsquoapostroforsquo alla loro prima lettera Α᾽ Υ᾽ ecc Per la seconda fattispecie di supporto libra-rio si veda in particolare il cosiddetto fragmentum mathematicum Bobiense scriptio inferior databile al V-VI secolo del palinsesto Milano Biblioteca Ambrosiana L 99 sup (Isidoro di Siviglia Etymologiae datazione Cavallo 1977 p 100) pp 113-114 che sono stampate in riproduzione apografa conforme in Belger 1881 (la p 114 egrave riprodotta anche nella tav 10 di Acerbi 2010)
58 Se questa era lrsquointenzione si tratta ovviamente di una forzatura il divisore puograve ben essere maggiore del dividendo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 145
caso lo slash di troncamento taglia orizzontalmente il tratto verticale del phi I copisti offrono molteplici varianti apponendo chi uno spirito dolce chi un ε chi un αί accentato a sormontare Tutti questi segni svolgono la funzione di abbreviazioni vere e proprie (e cosigrave doveva essere anche per lrsquoautore si veda il punto 1 di p 153 infra) la forma originale si ottiene a mio avviso incrociando i dati del Marc gr 313 e dei tre apografi del Vat gr 1594 αφ anche se lrsquoassenza dello spirito potrebbe essere semplicemente dovuta alla pratica del copista del codice veneziano di economizzare nei diacritici
iv Segno per i resti Un lambda completato da una barra a sormon-tare o da un apice che rinvia alle abbreviazioni per sospensione di una forma opportuna di λοιπός laquorestoraquo In realtagrave la forma che troviamo nella tabella egrave differente (tav 2b) e coincide con quella offerta quasi unanimemente dai manoscritti nella descrizione e in almeno un caso nella tabella del metodo di divisione attribuito a Pappo (tav 4) un lambda che accoglie al di sotto una legatura omicron-iota () sbarrata da uno slash di troncamento Qualcosa di simile si trova nel PVindob G 19996 (sec I) una specie di lambda maiuscolo molto aperto e dal vertice arrotondato che include un circoletto interpretato dagli editori come segno per περίεστιν o per λοιπόν59 Lo stesso segno si rintraccia ad esempio in un medesimo scolio tabellare di prima mano ad Alma-gestum nel Vat gr 1594 f 93v e nel Marc gr 313 f 135r ma stavolta la forma del lambda egrave molto ben definita
Fin qui i segni Ma il gioco egrave piugrave complesso La descrizione si muo-ve pericolosamente sulla linea di confine non sempre ben definita tra segno convenzionale e abbreviazione il primo ndash e il repertorio grafico matematico-astronomico ne egrave particolarmente fornito60 ndash puograve anche
59 Ho consultato lrsquoedizione Gerstinger ndash Vogel 1932 pp 46 e 48 la porzione rilevante del papiro egrave riprodotta nella tav 11 di Fowler 1999 Si veda ancora ivi pp 253-257 per la trascrizione di questo segmento di testo (con correzioni rispetto alla princeps) e per una messa a punto recente inclusa la proposta di datazione che ho riportato qui sopra Il verso del papiro che contiene una tavola aritmetica del tutto scorrelata dalla tematica del recto egrave edito come PRain Unterricht 151
60 La pratica di ridurre lo spazio occupato da un testo tecnico per mezzo di abbreviazioni e segni convenzionali era molto diffusa nei manoscritti in maiuscola contrariamente a quanto avviene per altri generi letterari vedremo tra breve cosa accade negli Arithmetica di Diofanto ma si leggano in proposito anche le considerazioni di Hei-berg nei prolegomena alla propria edizione dellrsquoAlmagesto in particolare riguardo al ricorso massiccio ad espedienti brachigrafici nel modello del Vat gr 180 POO II pp lxxxiv-xciii civ-cv cxxvii cxxxviii-cxxxix Agli elenchi dettagliati forniti da Heiberg possiamo aggiungere il piccolo prontuario stampato in Hultsch 1876-1878 III 2 pp 126-132 e basato sul testo e sugli scolii alla Collectio di Pappo nel Vat gr 218 (sec X in) Si vedano infine le osservazioni del copista del Par gr 2360 f 120v trascritte da Heiberg in AOO III pp x-xi sulle laquonotazioni tipiche a scopo di tagliar corto nello scrivereraquo impiegate nel pro-
Fabio Acerbi146
derivare dalla seconda (un caso egrave appunto il segno per ἐλάσσων che probabilmente trae origine da una legatura epsilon-lambda) ma poi il rapporto referente-relato si fissa convenzionalmente Quelli definiti nel testo che abbiamo letto sono appunto segni convenzionali non ci sarebbe bisogno di spiegarne forma e funzione se fossero intesi come abbreviazioni assumono nella tabella una funzione denotativa non esplicativa o discorsiva (come accade invece nella tav 1a) Ma come vengono descritti questi segni
I referenti delle descrizioni sono i segni sono introdotti da οὕτως (item i-ii) o in alternativa da un τό con il ruolo di lsquooperatore di citazionersquo (item iii-iv) che corrisponde esattamente alle nostre virgolette In entram-bi i casi gli enti sono menzionati e svolgono una funzione metalinguistica sono collocati materialmente nel testo ma egrave come se si trovassero fuori e la loro descrizione li additasse ndash in effetti i segni convenzionali scritti nel testo sono a loro volta i relata di quelli che si trovano nella tabella
I relata dei segni scritti nel testo sono di due tipi singoli vocaboli (item i-ii) o descrizioni della funzione dei segni per mezzo di clausole sintaticamente complesse (item ii e iv) I singoli vocaboli sono γίνεται e παρά e sono entrambi preceduti dal τό lsquocitazionalersquo in quanto relata di segni convenzionali le forme abbreviate con cui sono tracciati nei manoscritti vanno forzatamente sciolte Bisogna ammettere che la per-spicacia e le risorse grafiche dei copisti ndash di cui tutto si puograve dire fuor che commettano qui degli errori ndash sono messe a dura prova con lrsquointrodurre segni identici ad abbreviazioni o con lrsquoattivare un gioco metalinguistico particolarmente serrato in un contesto meno lsquonaturalersquo di come potreb-be esserlo ad esempio quello di un trattato grammaticale Lrsquoitem iii che presenta direttamente un segno identico ad unrsquoabbreviazione non egrave sorretto da una descrizione ma da una giustificazione in διὰ τό Lrsquoartico-lo τό vi assume una funzione metalinguistica anche se non lsquocitazionalersquo poicheacute al tempo stesso genera un infinito sostantivato e lo singolarizza per questo ho scritto laquosono sottrattiraquo in corsivo nella mia traduzione
prio modello archimedeo (nota 32 supra) egli ne compila anche una breve lista Un elenco antico di laquosegni della geometriaraquo sicuramente redatto per assistere il copista si trova anche al f 3v del ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 vergato da Efrem negli anni 950-960 (tav 8 in Acerbi 2010) Possiamo farci unrsquoidea quantitativa del guadagno di spazio in rapporto ad un testo privo di abbreviazioni e con le parole separate da spazi sulla base del fragmentum mathematicum Bobiense il testo vi egrave disposto a tutta pagina su 36 righe di circa 30 segni ciascuna nelle due pagine in questione figurano 2038 segni con 15 mezze righe occupate dalle due figure Ora nel testo dellrsquoedizione stabilita in Heiberg 1927 pp 87-90 le stesse pagine contano 4455 segni spazi compresi Ne risulta che la dimensione in caratteri di un testo matematico puograve essere ridotta di piugrave della metagrave con lrsquoimpiego di compendi e segni convenzionali
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 147
Negli item ii e iv il segno si collega ad una descrizione nel secondo caso in via esclusiva le descrizioni pertanto rinforzano o sostituiscono lrsquoidentificazione con lrsquoente linguistico denotato Le clausole descrittive sono precedute da ἀντί e dallrsquoarticolo τό con funzione di lsquooperatore di citazionersquo esse sono παρ᾿ ἃ δεῖ τὸν μερισμὸν γίνεσθαι (item ii) e λοιποὶ οἱ μέλλοντες ἐπιμερίζεσθαι (item iv) Nella descrizione della divisione lsquoalla Papporsquo che leggeremo tra breve i segni negli item iii e iv rice-vono lo stesso trattamento degli altri due il loro relatum egrave un singolo vocabolo e non una clausola descrittiva rispettivamente nelle espres-sioni τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε (sul participio ritorneremo nel punto 1 infra) e τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά (la forma del segno notato con λ οι egrave descritta supra nellrsquoitem iv) La descrizione del segno oslash per il divisore merita una discussione piugrave dettagliata In origine si trovava probabilmente scritto Π(ΑΡΑ)ΕΧΟΝ successivamente letto come π(αρ[α])έχον ndash dato che lrsquoabbreviazione per il preverbo egrave identica a quella per la preposizione (che sia Π᾽ o un pi seguito dal segno per ἄρα a sormontare) ndash invece di π(αρὰ) ἔχον I copisti e i correttori si dettero a tutte le possibili contorsioni per restituire un testo dotato di senso leggere appunto una forma verbale con preverbo modificare il preverbo (ma forse il segno per ἄρα era insidiosamente simile ad uno epsilon) correggere il testo rileggiamo lrsquoapparato sub τὸ παρὰ ἔχον οὕτως τὸ παρέχον οὕτως M et π(αρ-) comp Z οὕτως τὸ περιέχον S τὸ περιέχον οὕτως C προγράφοντας οὕτως ex corr m 2 P Nella clausola descrittiva seguente la presenza liminare di παρὰ (che ho corretto in παρ᾿ ἃ nella speranza di restituire una frase che abbia un senso senza intervenire sul testo) innesca un bel corto circuito il Π(ΑΡΑ) che sicuramente figu-rava nellrsquoarchetipo egrave un sintagma complesso una preposizione unrsquoab-breviazione o un segno per unrsquoabbreviazione Se lrsquoeditore si trova in conflitto con la propria inclinazione alla critica conservativa i copisti si rifiutarono di mettere mano ad un testo che doveva stridere anche per loro essendo il compito demandato al ritocco del revisore del Par gr 2390 o alla riscrittura radicale del recensore bizantino Il problema egrave che ci troviamo di fronte ad unrsquoespressione che descrive la funzione dellrsquooggetto denotato non lrsquooggetto stesso ma che lo contiene al suo interno per soprammercato qui il Π(ΑΡΑ) egrave usato per giustificare una menzione a sua volta relatum di un segno
Evidentemente questa maniera di procedere che giagrave aveva attirato interventi da parte di copisti e correttori della recensione di base parve insostenibilmente opaca allrsquoautore della recensione bizantina61 Egli
61 Uno dei manoscritti di questa recensione propone anche una tabella di divisione
Fabio Acerbi148
modifica tutte le descrizioni diluendo lrsquoidiomatismo dellrsquoarticolo lsquocita-zionalersquo con lrsquointroduzione sistematica del verbo δηλόω e di frasi atte a chiarire quale sia il segno denotante e quale il vocabolo (o il segno) denotato Egli introduce allo scopo di rendere esplicita la funzione de-notativa dei segni introdotti il termine σημείου curiosamente in tutte le sue tre occorrenze esso compare a sua volta nella forma dellrsquoabbrevia-zione per sospensione σΗ´ Egli traccia il segno per i massimi multipli ἀφ e quello per i resti λ οι` in modo che non vi siano ambiguitagrave quanto al loro carattere di abbreviazione Si faccia infine attenzione al residuo di barra sul παρᾱ con funzione denotativa (2 occorrenze) contenuto nella descrizione del segno per il divisore sostituita dallrsquoaccento grave nel παρὰ con funzione discorsiva (la differenza egrave nettissima nei manoscritti da me consultati) Questa osservazione ci permette di passare direttamente allrsquoitem seguente
b) Le barre sui numerali e sulle lettere denotative Egrave opportuno discutere questo punto adesso esattamente percheacute di barre siffatte che pure troviamo in tutti i manoscritti i nostri testi non fanno mai menzione si tratta infatti di una pratica condivisa sin dallrsquoantichitagrave La barra identifica una stringa di lettere dellrsquoalfabeto che non svolge una funzione grammaticale o sintattica propria allrsquointerno del discorso Ciograve avviene in particolare e si tratta della fattispecie piugrave frequente se la stringa di lettere non dagrave origine a un vocabolo della lingua greca lette-re denotative e numerali certo ma anche termini provenienti da altri idiomi e contrazioni di parole greche come i nomina sacra62 tali termi-ni possono essere o no preceduti da un articolo lsquocitazionalersquo a seconda dellrsquouso che ne viene fatto allrsquointerno del discorso Ma non si tratta dellrsquounica fattispecie i papiri grammaticali ed i manoscritti piugrave antichi dei trattati dello stesso argomento segnalano gli esempi delle parti del discorso (cioegrave di lsquoverersquo parole greche) per mezzo di barre sormontanti63 La differenza insomma egrave tra menzione e uso (come parte del discorso in atto) di una stringa di caratteri tra il porre le lsquovirgolettersquo e il non porle tra funzione denotativa e non Apparentemente la convenzione si limi-
corredata dei segni opportuni e contrariamente alle indicazioni della descrizione svilup-pata lsquoin verticalersquo ma per motivi misteriosi non completa (tav 7a Laur Plut 89 sup 48 f 13r)
62 Tutto ciograve egrave spiegato con estrema chiarezza giagrave in Traube 1907 pp 45-4763 Si veda il Par gr 2548 codex vetustissimus e testimone unico delle lsquoopere minorirsquo
di Apollonio Discolo il f 106v con le barre ben visibili egrave riprodotto come tav 19 in De Gregorio 2000 (ivi pp 137-138 per la datazione) Per la testimonianza dei papiri grammaticali si veda Wouters 1979 passim essi contengono di norma elenchi di parti del discorso nessuna delle quali egrave preceduta dallrsquoarticolo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 149
tava in questo secondo caso a segnalare con la barra singoli vocaboli le menzioni di frasi o di sintagmi complessi sono di norma identificate dallrsquoarticolo lsquocitazionalersquo Drsquoaltra parte le abbreviazioni convenzionali non rientrano nella casistica percheacute la loro resa grafica che contiene elementi non alfabetici come compendi per desinenze lettere supra li-neam marche di contrazione o sospensione quali slashes o barre sotto-poste o sormontanti eventualmente solo un sottinsieme della stringa di segni alfabetici le esclude automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
Venendo al discorso matematico una barra sormonta senza ecce-zione le lettere denotative64 che sia in papiri o in manoscritti in maiu-scola65 o minuscola ma solo allrsquointerno del testo comrsquoegrave da attendersi nei diagrammi esse la perdono per il semplice motivo che non crsquoegrave alcun testo ambiente un diagramma ha unicamente una funzione denotati-va Drsquoaltra parte le lettere numerali che a volte figurano nei diagrammi della tradizione metrica66 allo scopo di indicare la lunghezza dei seg-menti mantengono la barra in un diagramma il contesto denotativo geometrico egrave prevalente e i numerali vengono percepiti come entitagrave grafiche lsquoesternersquo al discorso Va da seacute a fortiori che le lettere numerali inserite in un testo dovranno essere segnalate da barre che a loro volta non servono nelle tavole67 in quanto queste ultime sono come abbiamo visto un vero e proprio testo che perograve funge da ambiente a quello al-fabetico limitato alle titolazioni e non a caso tracciato in unrsquoopportuna lsquomaiuscola distintivarsquo allo scopo di segnalarne il carattere denotativo e non discorsivo68 Una tabella operazionale egrave invece un paratesto e quindi le barre sulle lettere numerali che rappresentano gli interi sono
64 La notazione per le lettere denotative subigrave unrsquoevoluzione (il cui risultato finale egrave descritto per sommi capi nella nota 3 supra) di cui non mette conto occuparsi qui
65 I papiri di contenuto geometrico (o astronomici ma che presentano argomenti geometrici) sono rari si vedano il PHerc 1061 (sec II aC Demetrio Lacone De geome-tria) e il PFay 9 (sec II ex Elementi I 39 e 41) Gli importanti ostraka OBerl 12002 e 12609 (sec III aC m Elementi XIII) non pongono le barre sopra le lettere denotative Per i manoscritti in maiuscola si veda ad esempio passim nel Par gr 2389 una cui riproduzione digitale egrave consultabile in rete allrsquoindirizzo httpgallicabnffrark12148btv1b8470171d o il fragmentum mathematicum Bobiense
66 Si veda ancora il ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 codex unicus dei Metrica di Erone e contenente una raccolta importante di problemi del corpus metrologico
67 Si vedano come esempio le tavole citate alle note 10 e 14 supra Discorso a parte per il segno di lsquoposto vuotorsquo si veda il punto c che segue
68 Queste regole generali vanno prese cum grano salis si dagrave naturalmente un certo dominio di variabilitagrave legato verosimilmente al grado di cultura grafica del copista nel PMich III 144 i numerali sono quasi tutti senza barra sia nel testo che nelle tabelle ope-razionali
Fabio Acerbi150
necessarie esse mancano invece sui segni convenzionali che ho descrit-to nel punto precedente e fatto rilevante sulle lettere numerali relative agli ordini sessagesimali quando esse siano identificate da uno o piugrave apici la presenza di questo segno grafico non alfabetico69 le esclude ancora una volta automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo Unrsquoultima osservazione che ci saragrave utile nel seacuteguito la descrizio-ne di una stringa di lettere lsquoagrammaticalersquo non puograve prevedere la men-zione della presenza della barra che le pertiene in quanto tale si tratta di una pratica denotativa che egrave possibile formulare soltanto ad un livello di discorso superiore sia a quello dellrsquouso che a quello della menzione70
c) Il segno di lsquoposto vuotorsquo Si noti nella tav 2b la forma ŏ per il segno di lsquoposto vuotorsquo in un ordine sessagesimale coerentemente con la propria notazione il copista del Marc gr 313 lo scioglie talvolta allrsquoin-terno del testo principale come unrsquoabbreviazione per οὐδέν laquonienteraquo Altre convenzioni di scrittura del tratto che accompagna il circoletto e che si badi bene fa parte integrante del segno di lsquoposto vuotorsquo ndash e infatti nelle tavole troviamo sempre il segno completo mentre tutti gli altri numerali sono come abbiamo visto nel punto precedente privi di barra o di apice a causa del fatto che i vari ordini sessagesimali sono univocamente determinati dalle linee di giustificazione ndash un tratto an-golare anteposto (tav 3 Lar Plut 2818 f 136v)71 o una semplice barra a sormontare (tavv 4-9) si produce in questo modo il segno 65926 che sembra essere stata la forma di base72
69 Occorre dunque supporre come testimoniano papiri e manoscritti in maiuscola che la convenzione relativa allrsquouso della barra si sia consolidata ben prima dellrsquointroduzione di segni diacritici quali accenti e spiriti
70 Si veda il punto 2 infra per maggiori dettagli sulla questione delle barre e degli apici e per le indicazioni in merito che leggiamo in Diofanto
71 Come accennato questa tavola dei sottomultipli coincide con quella descritta ed esposta nei Prolegomena Fatto molto rilevante i numerali nella prima non recano neacute barre neacute apici contrariamente a quanto accade a tutte le istanze della seconda nei manoscritti Quella del Laur Plut 2818 preserva a mio avviso la forma originaria come abbiamo visto una tavola non richiede segni aggiuntivi sulle lettere numerali
72 Si vedano come esempio ancora le tavole citate alle note 10 e 14 supra oppure per una rassegna delle forme che il segno assume nei manoscritti piugrave antichi delle Tavole facili Tihon 2011 pp 58-59 e per quelle che assume nei papiri Jones 1999 I pp 61-62 Ovviamente non possiamo leggere il segno 65926 come un omicron con una barra in quanto ο = 70 nella notazione greca e la barra egrave di rigore quando il numerale figuri allrsquointerno di un testo Occorre ammettere che si dagrave origine ad un bel corto circuito notazionale con il concepire un segno con funzione di lsquoposto vuotorsquo ma che lsquosomigliarsquo ad una lettera dellrsquoalfabeto sormontata da una barra cioegrave ad un numerale in piugrave quando il lsquoposto vuotorsquo non corrisponda ad un intero ma ad una specie sessagesimale la presenza della barra a priori indistinguibile da quella che sormonta gli interi introduce unrsquoincongruenza con la notazione a mezzo di apici vista nellrsquoitem precedente
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 151
d) Errori di copia La tabella riprodotta nella tav 2b ha una forma simmetrica ma si tratta di una forzatura il grande rettangolo in basso a destra drsquoaltronde assente nella descrizione contiene uno scolio che fa notare come lrsquoultimo resto parziale ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ͵γτνζ´´´´´ κζ´´´´´´ cioegrave 0 0 0 0 0 3357 27 siano ἔγγιστα λ´λ´ δ´δ´ ξ laquocon ottima approssimazione 60 minuti quartiraquo dove si notino gli apici semplici per indicare il pas-saggio allrsquoordinale e il raddoppiamento del sistema segno + apice per significare il plurale Lo scolio debitamente accompagnato dal segno di rimando in forma di simbolo solare egrave stato probabilmente incluso nella tabella proprio allo scopo di renderla simmetrica A sua volta un errore precedente spiega lo spazio eccessivo accordato al rettangolo contenente lo scolio il secondo massimo multiplo ŏ λβ´ ξδ´´ ριβ´´´ σιϛ´´´´ egrave trascritto anche al di sotto del risultato
Passiamo ora alla descrizione del metodo di divisione attribuito a Pappo
ἵνα οὖν ταῦτα συναχθῇ τὰ ἐκ τοῦ μερισμοῦ ὁ εἰρημένος Πάππος εὐδιατύπῳ τινὶ καὶ πρὸς τοῦτο τάξει χρησάμενος ποιεῖται τὴν τῆς συλλήψεως τοῦ ζητουμένου ἀνεύρεσιν οὕτως ἐκθέμενος γὰρ τὸν μέλλοντα μερίζεσθαι τουτέστι τὰς τξ μοίρας ἐν ἀρχῇ ἀφαιρεῖ ἀπ᾽ αὐτῶν τὸν ἐν τῇ σελίδι τυγχάνοντα ἐλάττονα τουτέστι τὸν τδ κβ´ κ´´ ὄντα τῶν ἐγγὺς ἐλασσόνων ὡς πρὸς τοὺς ἐκκειμένους διὸ καὶ γράφει αὐτὸν προγράφων αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε καὶ εὑρίσκων τὰ παρακείμενα αὐτῷ τῷ ἀπογραφέντι ἐν τῷ σελιδίῳ λεπτὰ πρῶτα ν´ συναπογράφεται παρατιθῶν αὐτοῖς τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον ἀνατείνουσαν σημαῖνον τὸ εἶδος ὅτι πρῶτα λεπτά εὑρίσκει οὖν οὕτως τὸ τῶν τξ μέρος τὸ τδ κβ´ κ´´ ὃ μεριζόμενον παρὰ τὰς τξε ιδ´ μη´´ ἡμέρας καὶ ποιοῦν τὸν ἐκ τοῦ μερισμοῦ ἀριθμὸν πρῶτα λεπτὰ ν´ καὶ τὸν λοιπὸν ἀπογραφόμενος τὸν νε λζ´ μ´´ προτάσσει αὐτοῦ τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά τάσσει δὲ καὶ ἁπλῆν τινα διατείνουσαν γραμμὴν ὡς ἀπὸ τοῦ τξ ἐπὶ τὸν ἑξῆς ἐκτεθειμένον ἐγγὺς
1
5
10
1 εὐδιατύπῳ] ZSPC εὐδιατύπωτ M 4 ἀφαιρεῖ] MZSP ἀφ ι C 5 ἐλάττονα] P comp MZSC 6 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | αφ ] αφ ε M ἀφ ZS ἀφαί P ἄφ C | ἀντὶ] om C | ἄφελε] MZSP ἄφ C 8 ἀπογραφέντι] MZSP ἐγγραφέντι C | λεπτὰ πρῶτα] P λε πρωτα SC λεπτῶν πρωτ MZ | παρατιθῶν] MZS παρατιθεὶς C et ex corr m 2 P 9 ᾱ] Z αο P α´ MS α C | ἔχον] MPC ἔχων ZS 9-10 πρῶτα λεπτά] ZP πρωτ λ´λ´ M πρωτα λε S αα λε C 11 ἡμέρας] comp codd | ἀριθμὸν] P et comp MZ καὶ C et comp S 12 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M πρωτ λεπτ(α) Z πρωτ λ εᾱ S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C | ἀπογραφόμενος] MZSP ἐγγραφόμενος C | νε λζ´] MZSP λζ νζ C 13 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | λ οι] MZSC ex λ fecit λ οι P | προσσημαῖνον] MC et προσ- comp ZS προση- P | τὸ] MZC τὰ S et fecit m 2 P 14 ἀπὸ] MZSP πρὸς C ἐλάττονα] P comp MZSC
1 εὐδιατύπῳ] εὐδιατυπώτω K 6-7 αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ] τὸ ἀφ K 8 παρατιθῶν mdash 10 λεπτά] τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ σημαίνουσαν τὸ εἶδος αὐτῶν ὅτι ᾱ λεπτά εἰσιν K | τὸ (sec)] τὰ K 12 πρῶτα] πρώτων K | τε λ ] λ οι` K | προσσημαῖνον mdash
Fabio Acerbi152
ἐλάττονα τὸν τδ κβ´ κ´´ ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις καὶ ταύτην ἐπιδεικνύουσαν τὴν τάξιν τῆς προόδου τῆς ἐκθέσεως ἧστινος κλωμένης γραμμῆς πρὸς τῷ ἐγγὺς ἐλάσσονι ἡ ἀντανάκλασις ἐπὶ τὸν λοιπὸν γέγραπται φερομένη ὡς εἴρηται διὰ τὸ εὔτακτον τῆς προκοπῆς οὕτως τε ποιήσας ἑξῆς τὸ αφ ποιῶν ὃ προσσημαίνει ὡς εἴρηται τὸ ὅτι δεῖ ἀφελεῖν ὁμοίως ἀπὸ τοῦ λοιποῦ καὶ δὴ τὸν ἐγγὺς πάλιν ἐλάσσονα ὡς πρὸς τὴν ἐν τῷ σελιδίῳ ἔκθεσιν εὑρισκόμενον λαμβάνων ἑξῆς προγράφει αὐτὸν ὄντα νδ μζ´ ιγ´´ ιβ´´´ καὶ εὑρίσκει αὐτοῖς παρακείμενα ἐν τῷ σελιδίῳ πρῶτα λεπτὰ θ´ ἅτινα καὶ αὐτὰ προσαπογράφεται σὺν τῇ παρασημειώσει τῶν πρώτων γράφων τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον τὴν ἀνατείνουσαν καὶ ὡς εἴρηται τὴν γραμμὴν πάλιν διὰ τὴν τάξιν κλωμένην κατὰ δευτέραν κλάσιν προσέλκει γινομένου τοῦ μέρους αὐτῆς τούτου παραλλήλου τῷ ἐξ ἀρχῆς
16 ante κλωμένης add ἐπὶ C 18 τε] MZP om SC | αφ ] M ἀφ ZSC ἀφαί P 19 προσσημαίνει] MS προση- ZC et ex corr P | ὅτι] ZP comp MSC 20 δὴ] MZSC διὰ fecit m 2 P 21 πρὸς] MSP et supra lineam C ex ἀπὸ fecit m 2 Z | ιγ´´] MZSP νγ´´ C 22 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M ᾱᾱ λεπτὰ Z άάα λε S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C 23 προσαπο- γράφεται] απο suprascr in comp M 24 ᾱ] ZP α´ MS α C 25 κλάσιν] MP τάξιν ZSC | τοῦ] ZSPC τούτου M 26 τούτου] τοῦ bis ZSPC sed prius erasit m 2 P τοῦ M
mdash 18 προκοπῆς] om K | τε ποιήσας] ποιήσας καὶ K | αφ ] ἀφ K 19 τὸ] om K 21 προ-γράφει] γράφει K 22 σελιδίῳ] α´ σελιδίῳ K | ἅτινα] ἃ K 23 προσαπογράφεται] ἀπογράφεται K | τῶν πρώτων mdash 26 ἐξ ἀρχῆς] om K
lsquoAllo scopo di raccogliere ciograve che risulta dalla divisione il detto Pappo utilizzando anche in questo caso una certa disposizione ben strutturata determina nel modo seguente il lsaquonumerorsaquo cercato preso nel suo insieme collocando73 in testa il lsaquonumerorsaquo che sta per essere diviso cioegrave i 360 gradi iniziali sottrae loro tra i piugrave prossimi dei lsaquonumerirsaquo minori rispetto a quelli esposti quello che si trova essere minore nella colonna (cioegrave 304 22 20) Questo egrave il motivo per cui lo trascrive scrivendogli davanti lrsquoabbreviazio-ne laquosottrraquo per laquosottrairaquo e trovando che 50 minuti primi sono collocati accanto a quello stesso lsaquonumerorsaquo che egrave stato trascritto nella colonna li trascrive al tempo stesso collocando accanto74 ad essi la lettera A con un lsaquotrattorsaquo75 sopra che significa la specie minuti primi Trova dunque in que-sto modo la parte di 360 che egrave 304 22 20 la quale divisa per 365 giorni 14 48 fa il numero lsaquoche risultarsaquo dalla divisione 50 minuti primi Trascrivendo
73 La descrizione egrave strutturata come una procedura Acerbi 201274 Il purismo del correttore del Par gr 2390 di Clostomalle nel Marc gr 314 e
dellrsquoautore della recensione bizantina impone loro di modificare la terminazione ma forme tematiche e contratte di τιθεῖν sono correnti nel greco tardivo
75 Il testo greco ha solo il participio con γραμμήν sottinteso Per il significato del participio si veda il punto 2
15
20
25
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 153
poi il resto 55 37 40 gli pone altresigrave76 a prefisso laquoReraquo che significa laquorestiraquo e dispone anche una certa linea semplice77 che va da 360 al piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori che egrave esposto di seacuteguito 304 22 20 come nello lsaquoschemarsaquo esposto linea che mostra lrsquoordine del percorso dellrsquoesposizione Questa linea spezzata lagrave dove si trova il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori egrave tracciata inflessa allrsquoindietro lsaquoersaquo punta verso il resto come egrave stato detto in vista di una progressione ordinata E cosigrave facendo prendendo di seacuteguito il laquosottrraquo che significa come egrave stato detto laquoche occorre similmente sottrarre dal re-storaquo e ovviamente prendendo di nuovo il lsaquonumerorsaquo che egrave trovato essere il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori in relazione alla disposizione nella colonna ndash 54 47 13 12 ndash lo scrive di seacuteguito e trova che 9 minuti primi sono posti loro accanto nella colonna trascrive78 anche questi con la segnaletica dei primi scrivendo la lettera A con un lsaquotrattorsaquo sopra e come egrave stato detto prolunga di nuovo la linea spezzata in vista di una buona disposizione tramite una seconda inflessione essendo questa sua parte parallela a quella inizialersquo
La descrizione continua con una serie di laquoe cosigrave viaraquo e non fa ulte-riore riferimento alla tabella
1) La forma verbale ἐξεσμένον Egrave il neutro del participio perfetto medio-passivo di ξέω lett laquopialloraquo laquolevigoraquo Si danno tre possibilitagrave si tratta di un termine canonico per quanto non altrove attestato per designare unrsquoabbreviazione oppure lrsquoautore anonimo improvvisa sul piano metaforico come se unrsquoabbreviazione non fosse altro che la paro-la completa lsquoaccorciata a colpi di piallarsquo in maniera opportuna oppure il testo egrave corrotto e srsquoimpone una correzione ad esempio τὸ ἑξῆς μένον laquociograve che sta di seacuteguitoraquo Questrsquoultima strada mi pare chiusa dal senso delle frase lrsquoabbreviazione non lsquosta di seacuteguitorsquo a niente ma anzi precede la perifrasi τὸ ἑξῆς μένον se impiegata semplicemente per rimandare al segno αφ immediatamente seguente costituirebbe un intollerabile solecismo Se accettiamo la prima di queste letture considerando quin-di lrsquoabbreviazione αφ in posizione predicativa abbiamo a che fare con
76 Rendo in questo modo il τε isolato77 La linea egrave laquosempliceraquo in quanto egrave una retta la precisazione intende evidenziare per
anticipazione il carattere lsquonon semplicersquo che essa assumeragrave alla prima inflessione quando diventeragrave una spezzata linee siffatte erano in effetti concepite dallrsquoanonimo e prima di lui da tutta la tradizione matematica greca come una singola linea spezzata nei punti drsquoinfles-sione I due segmenti paralleli menzionati al termine del passo sono orizzontali
78 Il verbo egrave al medio in variatio rispetto ai due che precedono e che seguono egrave il matematico che lsquosirsquo trascrive le cifre
Fabio Acerbi154
uno hapax semantico nella grecitagrave superstite come egrave facile verificare con una ricerca sul TLG in rete La recensione bizantina risolve il pro-blema sopprimendo semplicemente τὸ ἐξεσμένον
2) La notazione per le specie numeriche Nella terminologia matema-tica greca gli ordini sessagesimali sono εἴδη laquospecieraquo numerici essi corri- spondono agli ordini di grandezza nel nostro sistema decimale e indica-no in analogia con il caso geometrico la lsquoformarsquo che assume un numero quadrato cubo ecc Centinaia e migliaia sono quindi degli εἴδη rispet-tivamente quadrati (100 egrave il quadrato di 10) e cubi (1000 egrave il cubo di 10) sono specie numeriche ma non numeri particolari e drsquoaltronde 300 non egrave un quadrato ma 3 item dellrsquoεἶδος lsquoquadratorsquo 100 3 egrave il numerale di molteplicitagrave della specie quadrata lsquocentinaiarsquo i due 0 che seguono il 3 segnalano esattamente questo fatto che la notazione greca per gli interi non posizionale fa scomparire al livello denotativo Ciograve non vale soltan-to per i numeri interi ma anche per le loro parti i minuti secondi appar-tengono alla specie lsquoquadratorsquo in quanto 13600 egrave il quadrato di 160
La concezione appare interamente dispiegata nellrsquointroduzione degli Arithmetica diofantei79 che si rivela giova farlo rimarcare un te-stimone fondamentale per la ricostruzione della notazione matematica antica Alle specie usate in questrsquoopera vengono assegnati una denomi-nazione ed un segno convenzionale costituito dallrsquoiniziale (di ognuno dei componenti) della denominazione al quadrato o δύναμις il segno ΔΥ al κύβος il segno ΚΥ alla lsquoquarta potenzarsquo o δυναμοδύναμις il segno ΔΥΔ ecc La descrizione di tali segni egrave del tipo καὶ ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον Κ ἐπίσημον ἔχον Υ ΚΥ κύβος laquoe il suo segno egrave un Κ che ha come indice un Υ ΚΥ cuboraquo dove in accordo con quanto abbiamo visto nel punto b supra e pur nel comprensibile imbarazzo del copista della prima parte del Matritensis (o di un suo passato collega) a districarsi in questo formidabile ginepraio notazionale80 le due lettere Κ e Υ ricevono una barra mentre ΚΥ non la richiede a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον il quale ancora una volta esclude automaticamente il segno dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
79 In particolare a DOO I pp 214-62180 Nel Matr 4678 riscontriamo i seguenti fenomeni nelle poche righe a cavallo dei ff
58r-v 1) accento acuto posto su tutti i segni come se fossero abbreviazioni 2) ripetizione sistematica segnodenominazione come in ΚΥ κύβος appena letto dovuta sicuramente allrsquointrusione di glosse interlineari esplicative dei segni ndash e successivo pentimento (δύναμις e κύβος sono in effetti cancellati dalla prima mano il primo con un tratto il secondo con dei punti supra lineam poi il copista si stanca di correggere) 3) nella descrizione del segno per la δυναμοδύναμις menzione di un δέλτα δύο che saragrave molto probabilmente stato ΔΔ subito dopo nella descrizione del κυβόκυβος si legge un incongruo δύο KK
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 155
Diofanto introduce poi dei segni anche per le specie delle parti dellrsquounitagrave (le nostre frazioni) che egli chiama ὁμώνυμα μορία laquoparti omonimeraquo di cui quelle sessagesimali sono casi particolari81 Egli spie-ga appunto che le loro denominazioni sono ottenute da quelle delle specie degli interi per sinonimia passando ad un lsquoordinalersquo82 formato semplicemente aggiungendo il suffisso -στον δυναμοστόν κυβοστόν δυναμοδυναμοστόν ecc (sott μόριον) I loro segni convenzionali sono invece ottenuti da quelli per le specie degli interi aggiungendo una γραμμὴν διαστέλλουσαν τὸ εἶδος laquolinea che distingue la specieraquo83 Una linea sui segni delle specie delle parti egrave richiesta si badi bene per distinguerli dai segni di quelle degli interi come giagrave osservato questi ultimi sono giagrave lsquoagrammaticalirsquo a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον a fortiori lo saranno anche i primi Si tratta della traduzione semio-tica del passaggio dal cardinale allrsquoordinale che a livello grammaticale egrave effettuato con il suffisso -στον Che forma ha questa linea Barra o apice (Egrave cervellotico pensare a forme piugrave complesse) La domanda non ammette una risposta immediata in quanto delle specie diofantee nessuno piugrave si occupa nellrsquoantichitagrave84 Se egrave vero che la prima risposta darebbe origine ad un conflitto tra due convenzioni denotative diffe-renti la barra lsquocitazionalersquo e la barra che distingue la specie lrsquoevidenza grafica del Matritensis lascia lievemente sgomenti (ricordiamoci che giagrave i segni di base sono indebitamente dotati di un accento dal copista) Le poche occorrenze del segno per le specie delle parti85 vedono lrsquoaggiunta di uno slash di sospensione di un doppio apice inverso ndash in tutta evi-
81 Questo fatto era giagrave chiaro nellrsquoantichitagrave Teone in Alm I 10 in iA p 45310-1682 Il parallelo con i cardinali e gli ordinali relativi agli interi egrave reso esplicito da Dio-
fanto ὥσπερ δὲ τῶν ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια παρομοίως καλεῖται τοῖς ἀριθμοῖς τοῦ μὲν τρία τὸ τρίτον τοῦ δὲ τέσσαρα τὸ τέταρτον οὕτως καὶ τῶν νῦν ἐπονομασθέντων ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια κληθήσεται παρομοίως τοῖς ἀριθμοῖς laquocome le parti omonime dei numeri sono chia-mate per assonanza con i numeri di lsquotrersquo lsquolsaquounrsaquo terzorsquo di lsquoquattrorsquo lsquolsaquounrsaquo quartorsquo cosigrave le parti omonime dei numeri appena nominati saranno chiamate per assonanza con i numeriraquo (DOO I p 69-13 si noti lrsquoarticolo lsquocitazionalersquo al singolare in τοῦ τρία e τοῦ τέσσαρα) Il parallelo prosegue anche al livello dei segni che rappresentano queste specie come vedremo tra un attimo
83 Diofanto Arithmetica prefazione in DOO I p 620-21 un passaggio maltrattato in questa edizione occorre espungere il participio ἔχον senza introdurre segni ulteriori oppure eliminare un precedente ἐπί come fa un correttore del Matritensis f 58v
84 Unica parzialissima eccezione lrsquoaccenno di Teone menzionato nella nota 81 supra85 Al f 59r e per di piugrave nel margine per sanare un lungo saut du mecircme au mecircme La
collocazione in margine egrave il motivo per cui troviamo una notazione abbreviata nel resto del trattato il primo copista scioglie tutti i segni prendendoli per abbreviazioni mentre il secondo elimina sistematicamente il tratto aggiuntivo delle specie delle parti dellrsquounitagrave Drsquoaltronde egli scrive ad esempio ΔΥ invece di ΔΥ ed egrave quindi indotto a porre la barra al di sopra della stringa di lettere risultante (passim ma si veda ad esempio il f 72r)
Fabio Acerbi156
denza il compendio per la desinenza -ον accentata il copista interpreta il segno come unrsquoabbreviazione ndash e di una barra a sormontare lo Υ Potremmo forse interpretarlo come il segno di contrazione del grafema -στ- lrsquounico tassello mancante in unrsquoabbreviazione come ad esempio (δυναμοδυναμο)(στ)(ὸν) ma uno scolio di prima mano al f 58v rela-tivo alle specie degli interi inficia questrsquoipotesi esse sono dotate di slash di sospensione accento acuto in un caso del compendio canonico per la terminazione -ον hellip ma tutti gli Υ a esponente sono a loro volta sormontati da una barra
Meno legata al singolo manoscritto ma nondimeno non uniforme si presenta la pratica di notazione dei segni che rappresentano gli enti numerici sessagesimali86 da una parte sta lrsquoevidenza del testo dei Pro-legomena e delle sue tabelle apici ndash drsquoaltronde come abbiamo visto la notazione universalmente impiegata per i numerali ordinali e per le fra-zioni unitarie ndash dallrsquoaltra sta lrsquoevidenza del testo dellrsquoAlmagesto in tutti i manoscritti piugrave antichi e lo stesso si dica del commentario teonino a questrsquoopera o del suo lsquoGrande commentariorsquo alle Tavole facili e dei testi astronomici su papiro barre87 Sembra insomma che la nostra docu-
86 Sia le molteplicitagrave che le specie ahimeacute entrambe rappresentate da lettere dellrsquoalfabeto Come osservato allrsquoinizio della sezione 3 ci sono in effetti due tipi di lettere numerali in gioco se facciamo astrazione da apici o barre lsquo4 minuti secondirsquo si trova scritto δ β la prima lettera numerale denota la molteplicitagrave degli item di una certa specie la se-conda la specie nei Prolegomena entrambe sono accompagnate da un doppio apice il che rende inutile la presenza delle seconde Si noti che la descrizione della tabella non fa parola della notazione da usare per le lettere numerali che denotano la molteplicitagrave barre o apici e quanti apici hellip In questo caso fa interamente fede la tabella cioegrave la pratica grafica condivisa instauratasi non egrave chiaro quando
87 I manoscritti piugrave antichi dellrsquoAlmagesto sono menzionati nella nota 10 supra quelli dei due commentarii teonini sono il Laur Plut 2818 e il celeberrimo Vat gr 190 (sec IX in Euclide Elementi Data Teone lsquoGrande commentariorsquo) per la notazione dei pa-piri astronomici si veda Jones 1999 II passim La notazione non sembra lsquoinquinatarsquo dalla pratica dei copisti bizantini e pare dipendere soltanto dalla data di composizione Tro-viamo ad esempio barre sopra tutti i numerali di molteplicitagrave (interi o sessagesimali) nel frammento di un commentario alle Tavole facili contenente un calcolo relativo al 24 aprile 213 (Par gr 2841 sec XIII ex-XIV in oltre al frammento ai ff 32r l 11-34v l 23 contiene Arato Phaenomena ed Efestione Apotelesmatica edizione in Jones 1990) Nel commentario alle Tavole facili composto ca 610-617 ed attribuito a Stefano di Alessandria la situazione egrave la seguente (Jean Lempire per litteras per lrsquoedizione si veda Lempire 2014 ho controllato il Vat gr 304 ff 135r-171v sec XIV am contiene in aggiunta Teone in Almagestum I-II lsquoPiccolo commentariorsquo alle Tavole facili Diofanto Arithmetica e De polygo-nis numeris varia astronomica tabulae) barre sopra gli interi sporadicamente rimpiazzate da apici apici sopra le parti sessagesimali in numero uguale alla denominazione doppio () apice per le frazioni unitarie Sono impiegate barre sopra gli interi e apici sopra le parti sessagesimali nei manoscritti principali di tutti i trattati di introduzione allrsquoAlmagesto o comunque di argomento logistico redatti in epoca bizantina Giorgio Pachimere (1242-ca 1310) Quadrivium (autografo nel manoscritto Roma Biblioteca Angelica gr 38 [RGK III nr 115] si veda Tannery ndash Steacutephanou 1940 per lrsquoedizione) Teodoro Metochita (1270-
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 157
mentazione si faccia testimone di un cambio notazionale avvenuto nel periodo intercorrente fra Teone (sec IV pm) e la scuola alessandrina di Ammonio e dei suoi allievi (sec VI in) e probabilmente innescato da questrsquoultimo ambiente lrsquoaspetto paradossale egrave che nello stesso codice si rintraccino due notazioni differenti per gli enti numerici sessagesimali e lrsquouna (apici) sia adottata sistematicamente e coerentemente in uno scritto (i Prolegomena) che si presenta esattamente come unrsquointroduzione tecnica alla pratica numerico-algoritmica del trattato (lrsquoAlmagesto) in cui egrave adottata lrsquoaltra (barre che ritroviamo senza eccezioni anche negli scolii)
Torniamo ai Prolegomena la descrizione del segno da porre a fianco di ogni singolo quoziente parziale e denotante la sua specie numerica (minuti primi minuti secondi ecc) solleva tre problemi
Primo problema Ci vuole una barra o un apice su τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquola lettera A [hellip] che significa la specieraquo quando lo scriviamo nella tabella Tutta la nostra discussione precedente fa pro-pendere per lrsquoapice e si ricordi anche la forma verbale ἀνατείνουσαν che suggerisce qualcosa che si lsquoestende verso lrsquoaltorsquo (la mia traduzione egrave volutamente neutra) se fosse apposta una barra la cosa dovrebbe passare
1231332) Compendium astronomicum (copia lsquoautorizzatarsquo coeva nei Vat gr 182 e 181 da parte del copista che integrograve le parti mancanti del Par gr 2389 [ff 207-210 255-270 374-375] Bianconi 2005a pp 425-427 Peacuterez Martiacuten 2008 p 436 e n 177) Teodoro Meliteniota (morto lrsquo831393) Tribiblos astronomica (autografo nel Vat gr 792 si vedano Leurquin 1991 per unrsquoanalisi del manoscritto Leurquin 1990 per lrsquoedizione) una com-pilazione anonima (per cui ho consultato il Par gr 2396 ff 87r-92v limitatamente a questi fogli manu Costantino Trivoli [RGK II nr 318 ma ovviamente questo codice non vi egrave segnalato] terzo quarto del XV secolo il resto del codice annotato da Niceforo Gregora egrave di etagrave planudea e parzialmente [ff 33v-76v] un autografo di Planude stesso contiene Teone in Almagestum I II IV Mondrain 2002 il codice va completato ndash limitatamente a stralci dei libri VIII-X XII-XIII del commentario teonino la cui parte intermedia si egrave persa ndash con 26 carte [ff 123-147] inserite nel Vat gr 1087 anchrsquoesso contenente anno-tazioni di Gregora Rome 1927 per la figura del copista dei ff 77r-86r del Par gr 2396 e dei ff appena nominati del Vat gr 1087 un anonimo collaboratore di Gregora si veda in ultimo Bianconi 2006a pp 147-151) si veda anche il calcolo effettuato da Niceforo Gre-gora (12921295-13581361) dellrsquoeclisse di sole del 16 luglio 1330 (attestata unicamente ai ff 1r-8v della miscellanea astronomica Marc gr 325 databile ca 1324-1329 in parte vergata e ovunque fittamente annotata da Gregora stesso edizione del testo in Mogenet et al 1983 annotazioni di Gregora elencate in Bianconi 2005a p 413) Unrsquoeccezione apparente il lsquoPiccolo commentariorsquo di Teone alle Tavole facili le parti sessagesimali sono segnalate da apici (ad esempio nel Vat gr 175 vergato da Giovanni Catrario e completato nel 1321-1322 sulla figura di Catrario si vedano in ultimo Bianconi 2005b pp 141-156 e 2006b) lrsquoopera egrave antica ma la sua tradizione non rimonta oltre la fine del XIII secolo a parte un frammento nel Leiden BPG 78 ff 156r-161v (minuscola del IX-X secolo) e in effetti in questo manoscritto tutti i numerali di molteplicitagrave sono sormontati da barre Unrsquoeccezione effettiva egrave il De hypotesibus planetarum nel Vat gr 1594 barre sugli interi e apici sulle parti sessagesimali
Fabio Acerbi158
sotto silenzio e la presenza dellrsquoapice la rende inutile88 Si tratta della stessa convenzione diofantea e coincide ancora con la notazione per i numerali ordinali e per le frazioni unitarie che egrave corrente nei mano- scritti matematici greci per questo motivo non percheacute la descrizione sia particolarmente perspicua nessuno dei copisti della recensione an-tica ha incertezze apici Ma questi apici si rintracciano soltanto sulle indicazioni di specie non contemplate dalla descrizione che sono ante-poste ai resti parziali a fianco dei quozienti parziali i segni di specie sono invece trasformati in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordi-nali corrispondenti del tipo πρωτ tavv 5 e 7b-8 Il recensore bizantino taglia invece la testa al toro elimina dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali elimina la seconda menzione della laquolet-tera Araquo contestualmente allrsquoazzeramento dellrsquoespediente della linea a zig-zag (si veda il punto seguente) modifica la descrizione che contiene la prima menzione in quella dellrsquoapice associato direttamente ai nume-rali di molteplicitagrave riciclando addirittura lrsquoalpha per adibirlo a desi-gnare un numero cardinale (come sorprendersi) τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ laquoponendo al di sopra di essi [scil dei 50 minuti primi] 1 solo lsaquoaccentorsaquo acutoraquo La scelta del recensore egrave assennata che rechi una barra o un apice in una tabella un alpha denota un numero non un numero drsquoordine
Secondo problema da tenere ben distinto dal precedente Cosa ci vuole sul segno α per la lettera alpha menzionata nella frase τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquolettera A [hellip] che significa la specieraquo89 Unrsquooc-chiata allrsquoapparato critico rivela una bella incertezza nei manoscritti Z scrive sempre ᾱ e in un caso lo fa anche P MS optano sempre per α´ C per α P scrive nellrsquoaltro caso αο Per quanto solo la barra sia congrua con il senso della frase in quanto la lettera alpha egrave qui menzionata (si tratta di un oggetto che compare nella tabella) e non cambia niente se essa egrave accompagnata dal suo nome di genere στοιχεῖον ad un livello grafico lrsquoincertezza fra il segno ᾱ che denota laquola lettera αraquo e il segno α´ (o lrsquoabbreviazione αο) per una forma di πρῶτος egrave per piugrave versi giustificata
88 Detto in altri termini la barra egrave uno strumento grafico non matematico e quindi la sua presenza non va segnalata mentre un apice lo egrave e la sua presenza lo deve
89 Notare che in questa frase il primo α non vuole la barra (egrave menzionato allrsquointerno di una frase che impiega convenzioni moderne) il secondo sigrave (idem ma con convenzioni antiche) ndash e nella traduzione la scelta di denotarlo con A (senza virgolette) e non con lsquoArsquo (con virgolette) egrave del tutto arbitraria ndash si noti inoltre che le necessarie precisazioni laquosenzacon virgoletteraquo mostrano che le lingue moderne palesano difficoltagrave analoghe a quelle del greco antico per quanto riguarda i livelli denotativi in ambito metadiscorsivo per non usare le due parentetiche avrei dovuto scrivere rispettivamente lsquoArsquo e lsquolsquoArsquorsquo (doppie virgolette semplici)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 159
ᾱ coincide con il numerale 1 α egrave la prima lettera dellrsquoalfabeto ed inoltre α´ egrave esattamente quello che va scritto nella tabella Potremmo dirci che il sostantivo στοιχεῖον chiude la questione la sua presenza congiunta ad un ipotetico α´ renderebbe la descrizione ridondante o inappropriata90 Ma a parte il fatto che α egrave proprio τὸ πρῶτον στοιχεῖον il segno α´ cat-tura in fondo il cuore della descrizione di uno στοιχεῖον ἔχον lsaquoγραμμὴνrsaquo ἀνατείνουσαν
Terzo problema Lrsquoautore dei Prolegomena che si arresta allrsquoesem-pio dei minuti primi non dice quanti apici occorre mettere sulle lettere numerali che identificano gli ordini superiori al primo se uno soltanto come nel caso diofanteo e delle frazioni unitarie o in numero uguale alla loro denominazione (cioegrave pari al numero denotato dal numerale stesso su cui vanno posti) come effettivamente avviene nei mano-scritti dei Prolegomena La tabella egrave quindi sottodeterminata dalla sua descrizione anzi in un certo senso prende il sopravvento su di essa la pratica di marcare i numerali di molteplicitagrave con gli apici che compe-tono allrsquoordine cui appartengono viene trasferita ai segni per gli ordini stessi per supplire ad una descrizione carente di questi ultimi E la tabella egrave sottodeterminata dalla descrizione in quanto egrave la descrizione di una tabella reale ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις laquocome nello lsaquoschemarsaquo espostoraquo leggiamo a un certo punto del testo
3) La linea a zig-zag Non possiamo che applaudire a questo geniale espediente grafico lo troviamo messo in opera solo nel Marc gr 313 Per quanto lrsquoautore non faccia parola di ciograve nel corso della sua descrizione la linea spezzata egrave intesa dover lsquosaltarersquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue Il copista del codice marciano effettua correttamente due salti nella prima delle sue tabelle (tav 4) ma inserisce un lsquodentersquo in piugrave in quella che considera corretta (tav 5) La linea a zig-zag egrave incompatibile con la presenza di linee di giustificazione nella tabella che in effetti mancano nel Marc gr 313 ciograve induce gli errori di allineamento dei primi 5 quozienti parziali di cui egrave vittima il copista Probabilmente per questo motivo in nessuno degli apografi del Vat gr 1594 la linea a zig-zag figura nella tabella inquadrata come si conviene da una (doppia) cornice esterna e le cui colonne sono appunto separate da linee verticali (tav 7b Vat gr 184 f 17v e tav 8 Par gr 2390 f 9v cui egrave sostanzialmente identica la tabella del Marc gr 314 che si trova
90 Trascuro lrsquoabbreviazione αο = πρῶτος percheacute la desinenza non egrave quella richiesta neacute nella frase (egrave richiesto πρῶτον) neacute nella tabella (πρῶτα)
Fabio Acerbi160
al f 248r ndash ma la mancanza di linee orizzontali causa un gigantesco pa-sticcio nel codice vaticano) Alla recensione bizantina che dipende per il suo testo di base dal Vat gr 1594 e quindi non trova la linea a zig-zag nella tabella non resta che sopprimere la sua descrizione ndash ma proprio per questo motivo e finalmente diventa possibile tracciare un apparato completo di linee di giustificazione (tav 9 Laur Plut 89 sup 48 f 14v) Dato che la descrizione di Teone di questo procedimento di divi-sione non fa cenno allrsquoesistenza della linea a zig-zag viene da chiedersi se essa non costituisca un espediente escogitato dallrsquoautore dei Prolegomena per vivacizzare la procedura originale di Pappo
4) Discrepanze tra descrizione e tabella Il gioco delle minime va-rianti mostra che la divisione era stata eseguita (e trasmessa) corret-tamente tutti i valori numerici sono esatti La tabella nel Marc gr 313 presenta perograve alcune discrepanze con la propria descrizione Essa omette (ma non nella versione lsquoscorrettarsquo lrsquoomissione non si riscontra neanche nel Par gr 2390) il segno per laquorestoraquo di fronte ai resti par-ziali ma aggiunge lrsquoindicazione della loro specie Essa trasforma invece come abbiamo visto le indicazioni di specie che seguono i quozienti parziali in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordinali corri-spondenti La descrizione prevede di chiudere la tabella con il risultato καὶ συνάγων ἅπαντα τὰ ἐκ τῶν μερισθέντων μερῶν λεπτὰ σημειοῦται ὑπὸ πάντας οὕτως γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoe raccogliendo tutti i minuti che provengono dalle parti divise lsaquoPapporsaquo nota sotto tutto cosigrave Ris 0 59 8 17 13 12 31raquo ma sotto la tabella tutta la tradizione ci consegna qualcosa di piugrave articolato ὁ ζητούμενος καθ᾽ ὃν μερίζεται ὁ τξε ιδ´ μη´´ π(αρὰ) τὸν τξ γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoil lsaquonumerorsaquo cercato secondo cui 365 14 48 egrave diviso per 360 risulta 0 59 8 17 13 12 31raquo frase che del resto contiene due errori lrsquoinversione del dividendo e del divisore e la confusione tra segno convenzionale (iuxta descrizione) e abbreviazione (come nella frase) nel caso di γι Oltre ad eliminare la linea a zig-zag91 la recensione bizantina sopprime dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali e modifica come abbiamo visto al punto 2 le loro descrizioni in quelle di apici associati diretta-mente ai numerali di molteplicitagrave
91 Le due righe che nella recensione di base contengono solo i resti parziali minori di 160 del divisore ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue sono in parte completate con lrsquoindicazione abbreviata ἀνάλ(υσις) laquoanalisiraquo il termine greco per questa procedura di riduzione In un sussulto di ipercorrettismo matematico tali resti parziali ridotti non sono preceduti dal segno per laquorestoraquo come nel Par gr 2390 ma da quello per laquorisultatoraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 161
Gli esempi che abbiamo discusso mostrano come i problemi di notazione pesino e non poco sullrsquoespressione discorsiva di un algorit-mo matematico lrsquoente di riferimento per lsquoformularersquo il procedimento di divisione fu considerata la tabella cioegrave un oggetto la cui costitu-zione egrave legata piugrave ad una pratica grafica che a considerazioni logico- algoritmiche non la sua descrizione che in effetti finisce per determi-nare la tabella in maniera non univoca Di questa sottodeterminazione si fa testimone la traiettoria che abbiamo cercato di seguire nelle mani di copisti e revisori il procedimento di divisione si modifica a volte in aspetti secondari a volte in punti piugrave sostanziali ndash fino a rendere neces-saria una radicale revisione della sua descrizione per renderla conforme alla tabella ndash in ogni caso mai per ragioni squisitamente matematiche92
Abstract
The article presents and discusses in detail two passages from the anonymous Prolegomena to the Almagest a VIth century primer to the elementary procedures of calculation needed in Ptolemyrsquos Almagest In the two passages we may follow the complex interplay between mathematical notation the auctor who employed and described it the tachygrapher who transcribed it in vivo copyists who reproduced it correctors who modified it Along this path misgivings and errors arise in the transmission of abbreviations and paratextual units such as diagrams tables operational schemes
Fabio AcerbiCNRS UMR8560 Centre Alexandre Koyreacute
fabacerbigmailcom
92 Sono grato a Daniele Bianconi Lucio del Corso Jean Lempire per alcune preziose indicazioni
AOO = Archimedis opera omnia cum commentariis Eutocii ed J L Heiberg I-III Lipsiae 1910-1915
DOO = Diophanti Alexandrini opera omnia cum Graecis commentariis ed P Tannery I-II Lipsiae 1893-1895
GC = Le laquoGrand Commentaireraquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Mogenet ndash A Tihon I-III Cittagrave del Vaticano 1985-1999
iA = Commentaires de Pappus et de Theacuteon drsquoAlexandrie sur lrsquoAlmageste ed A Rome I-III con paginazione continua Cittagrave del Vaticano 1931-1943
HOO = Heronis Alexandrini opera quae supersunt omnia ed G Schmidt ndash L Nix ndash W Schmidt ndash H Schoene ndash J L Heiberg I-V Lipsiae 1899-1914
PC = Le ldquoPetit Commentairerdquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed A Tihon Cittagrave del Vaticano 1978
POO = Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia ed J L Heiberg I-II in 3 parti Lipsiae 1898-1907
RGK = Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600 I Handschriften aus Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln II Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs und Nachtraumlge zu den Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln III Handschriften aus Bibliotheken Roms mit dem Vatikan A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg unter Mitarbeit von D Harlfinger und P Eleuteri B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln Wien 1981-1997 (Oumlsterreichische Akademie der Wissenschaften Veroumlffentlichungen der Kommission fuumlr Byzantinistik III1-3 A-C)
Sigla
Acerbi 2010 = F Acerbi Il silenzio delle sirene La matematica greca antica Roma 2010
Acerbi 2012 = F Acerbi I codici stilistici della matematica greca dimostrazioni procedure algoritmi laquoQUCCraquo 1012 (2012) pp 167-214
Acerbi et al 2010 = F Acerbi ndash N Vinel ndash B Vitrac Les Proleacutegomegravenes agrave lrsquoAlmageste Une eacutedition agrave partir des manuscrits les plus anciens Introduction geacuteneacuterale ndash Parties I-III laquoSCIAMVSraquo 11 (2010) pp 53-210
Agati 1992 = M L Agati La minuscola laquoBouleteacuteeraquo Cittagrave del Vaticano 1992
Belger 1881 = C Belger Ein neues Fragmentum mathematicum Bobiense laquoHermesraquo 16 (1881) pp 261-284
Bianconi 2005a = D Bianconi La biblioteca di Cora tra Massimo Planude e Niceforo Gregora Una questione di mani laquoSampTraquo 3 (2005) pp 391-438
Bianconi 2005b = D Bianconi Tessalonica nellrsquoetagrave dei Paleologi Le pratiche intellettuali nel riflesso della cultura scritta Paris 2005
Bianconi 2006a = D Bianconi Le pietre e il ponte ovvero identificazioni di mani e storia della cultura laquoBizantinisticaraquo 8 (2006) pp 135-181
Bianconi 2006b = D Bianconi Qualcosa di nuovo su Giovanni Catrario laquoMEGraquo 6 (2006) pp 69-91
Cavallo 1977 = G Cavallo Funzione e strutture della maiuscola greca tra i secoli VIII-XI in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Colloque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 95-137
Cereteli 1904 = G F Cereteli De compendiis scripturae codicum Graecorum praecipue Petropolitanorum et Mosquensium anni nota instructorum Sankt-Petersburg 1904
De Gregorio 2000 = G De Gregorio Materiali vecchi e nuovi per uno studio della minu-scola greca fra VII e IX secolo in G Prato (a cura di) I manoscritti greci tra riflessione e dibattito Atti del V Colloquio Internazionale di Paleografia Greca Cremona 4-10 ottobre 1998 Firenze 2000 pp 83-151
Follieri 1977 = E Follieri La minuscola libraria dei secoli IX e X in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Col-loque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 139-165
Fonkič 2005 = B Fonkič Venecianskaia rukopisrsquo laquoAlrsquomagestaraquo Ptolemeja (Marc gr 313690) o datirovke i proischoždenii kodeksa laquoVDIraquo s III 254 (2005) pp 162-167
Fowler 1999 = D H Fowler The Mathematics of Platorsquos Academy A New Reconstruction Second Edition Oxford 1999
Bibliografia
Fabio Acerbi164
Gerstinger ndash Vogel 1932 = H Gerstinger ndash K Vogel Eine stereometrische Aufgaben-sammlung im Papyrus Graecus [sic] Vindobonensis 19996 laquoMitteilungen aus der Papy-russammlung der Nationalbibliothek in Wienraquo Neue Serie Folge 1 Griechische literarische Papyri 1 Wien 1932 pp 11-76
Heiberg 1927 = Mathematici Graeci Minores ed J L Heiberg Kjoslashbenhavn 1927
Hultsch 1876-1878 = Pappi Alexandrini Collectionis quae supersunt ed F Hultsch I-III Berlin 1876-1878
Janz 2003 = T Janz The Scribes and the Date of the Vat gr 1291 in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae X Cittagrave del Vaticano 2003 pp 159-180
Jones 1990 = Ptolemyrsquos First Commentator ed A Jones Philadelphia 1990
Jones 1999 = Astronomical Papyri from Oxyrhynchus ed A Jones I-II Philadelphia 1999
Jones 2005 = A Jones Ptolemyrsquos Canobic Inscription and Heliodorusrsquo Observation Reports laquoSCIAMVSraquo 6 (2005) pp 53-97
Lempire 2014 = Steacutephanos drsquoAlexandrie Le commentaire aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Lempire Louvain 2014
Leurquin 1990 = Theacuteodore Meacuteliteacuteniote Tribiblos astronomique Livre I ed R Leurquin Amsterdam 1990
Leurquin 1991 = R Leurquin Un manuscrit autographe de la Tribiblos Astronomique de Theacuteodore Meacuteliteacuteniote le Vaticanus graecus 792 laquoScriptoriumraquo 45 (1991) pp 145-162
Maas 1927 = P Maas Griechische Palaeographie in A Gercke ndash E Norden (hrsg von) Einleitung in die Altertumswissenschaft I9 Leipzig 1927 pp 69-80
Martinelli Tempesta 2010 = S Martinelli Tempesta Il codice Milano Biblioteca Am-brosiana B 75 sup (gr 104) e lrsquoevoluzione della scrittura di Giovanni Scutariota in A B Garciacutea ndash I Peacuterez Martiacuten (ed by) The Legacy of Bernard de Montfaucon Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting Proceedings of the Seventh Inter-national Colloquium of Greek Palaeography Madrid-Salamanca 15-20 September 2008 Turnhout 2010 pp 171-186
Mazzucchi 1994 = C M Mazzucchi Leggere i classici durante la catastrofe (Costantino-poli maggio-agosto 1203) le note marginali al Diodoro Siculo Vaticano gr 130 Parte prima stratigrafia laquoAevumraquo 68 (1994) pp 164-218
Mioni 1976 = E Mioni Bessarione scriba e alcuni suoi collaboratori in Miscellanea marcia-na di studi bessarionei Padova 1976 pp 263-323
Mioni 1985 = Codices graeci manuscripti Bibliothecae Divi Marci Venetiarum II Thesaurus Antiquus Codices 300-625 recensuit E Mioni Roma 1985
Mogenet 1962 = J Mogenet Une scholie ineacutedite du Vat gr 1594 sur les rapports entre lrsquoastronomie arabe et Byzance laquoOsirisraquo 14 (1962) pp 198-221
Mogenet et al 1983 = Niceacutephore Greacutegoras Calcul de lrsquoeacuteclipse de soleil du 16 juillet 1330 ed J Mogenet ndash A Tihon ndash R Royez ndash A Berg Amsterdam 1983
Mondrain 2002 = B Mondrain Maxime Planude Niceacutephore Greacutegoras et Ptoleacutemeacutee laquoPa-laeoslavicaraquo 10 (2002) pp 312-322
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 165
Mondrain 2004 = B Mondrain Lrsquoancien empereur Jean VI Cantacuzegravene et ses copistes in A Rigo (a cura di) Gregorio Palamas e oltre Studi e documenti sulle controversie teologiche del XIV secolo bizantino Firenze 2004 pp 249-296
Mondrain 2007 = B Mondrain Les eacutecritures dans les manuscrits byzantins du XIV e siegravecle Quelques probleacutematiques laquoRSBNraquo n s 44 (2007) pp 157-196
Peacuterez Martiacuten 2006 = I Peacuterez Martiacuten Maxime Planude et le Diophantus Matritensis (Madrid Biblioteca Nacional ms 4678) un paradigme de la reacutecupeacuteration des textes anciens dans la ldquorenaissance paleacuteologuerdquo laquoByzantionraquo 76 (2006) pp 433-462
Peacuterez Martiacuten 2008 = I Peacuterez Martiacuten El lsquoestilo Hodegosrsquo y su proyeccioacuten en las escrituras constantinopolitanas laquoSampTraquo 6 (2008) pp 389-458
Perria 1991 = L Perria Scrittura e ornamentazione nei codici della laquocollezione filosoficaraquo laquoRSBNraquo n s 28 (1991) pp 45-111
Rollo 2012 = A Rollo LrsquoArchimede di Giorgio Valla in V Fera ndash D Gionta ndash A Rollo (a cura di) Archimede e le sue fortune Atti del Convegno di Siracusa-Messina 24-26 giugno 2008 Messina 2012 pp 99-147
Rome 1927 = A Rome Membra disjecta laquoRBenraquo 39 (1927) pp 187-188
Rome 1938 = A Rome Un manuscrit de la bibliothegraveque de Boniface VIII agrave la Meacutediceacuteenne de Florence laquoACraquo 7 (1938) pp 261-268
Ronconi 2013 = F Ronconi La collection philosophique un fantocircme historique laquoScripto-riumraquo 67 (2013) pp 119-140
Tannery ndash Steacutephanou 1940 = Quadrivium de Georges Pachymegravere ed P Tannery ndash E Steacutephanou Cittagrave del Vaticano 1940
Tihon 2011 = Πτολεμαίου Πρόχειροι Κανόνες Les Tables faciles de Ptoleacutemeacutee vol Ia Tables A1-A2 ed A Tihon Leuven 2011
Traube 1907 = L Traube Nomina Sacra Versuch einer Geschichte der christlichen Kuumlrzung Muumlnchen 1907
Vogel 1936 = K Vogel Beitraumlge zur griechischen Logistik laquoSBAWraquo Mathematisch-natur-wissenschaftliche Abteilung Jahrgang 1936 pp 357-472
Wouters 1979 = A Wouters The Grammatical Papyri from Graeco-Roman Egypt Contri-butions to the Study of the lsquoArs Grammaticarsquo in Antiquity Brussel 1979
F ACERBI Tav 1
b Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 65r
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 284 f 160r
F ACERBITav 2
b Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 13r
a Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 19v
F ACERBI Tav 3
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 136v
F ACERBITav 4
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17r
F ACERBI Tav 5
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17v
F ACERBITav 6
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 7v
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
Fabio Acerbi134
Lrsquounico testo non elencato qui sopra o nelle note e che contenga tabelle operazionali egrave il commentario eutociano a Circ 3-4 Il testo ar-chimedeo che Eutocio e noi con lui leggeva egrave particolarmente conciso ed egli verifica esplicitamente il sussistere di certe relazioni numeriche Si tratta in ognuno dei nove casi presenti di mostrare che il lsquoteorema di Pitagorarsquo egrave verificato con ottima approssimazione dai valori numerici di opportune terne di rette Eutocio esegue le tre moltiplicazioni dei valori per se stessi e mostra che la somma o la differenza di due dei risultati si discosta di poco dal terzo30 I numeri in questione sono interi seguiti o no da una parte non intera espressa come somma di frazioni unita-rie31 I nove gruppi di tre moltiplicazioni una a fianco allrsquoaltra sono organizzati in forma tabellare ma senza lrsquoausilio di linee separatrici32 le operazioni sono eseguite disponendo lsquoin colonnarsquo i risultati delle mol-tiplicazioni parziali e sommandoli esattamente come facciamo oggi poicheacute sono in gioco numeri interi con parti frazionarie unitarie e la notazione non egrave posizionale non egrave necessario che gli incolonnamenti siano esatti (unitagrave di un risultato parziale sotto le decine del precedente ecc) Sono inclusi nella tabella istruzioni e commenti in linguaggio corrente33 le prime relative allrsquooperazione da affettuare sui risultati delle
30 Eutocio non calcola radici quadrate approssimate per quanto ciograve si renda piugrave volte necessario fornisce il risultato e verifica la sua correttezza moltiplicandolo per se stesso Egli dichiara che il lettore interessato a questo procedimento di calcolo puograve rivolgersi Ἥρωνι ἐν τοῖς μετρικοῖς [hellip] Πάππῳ καὶ Θέωνι καὶ ἑτέροις πλείοσιν ἐξηγουμένοις τὴν μεγάλην σύνταξιν τοῦ Κλαυδίου Πτολεμαίου laquoa Erone nei Metrica [hellip] a Pappo e Teone e a svariati altri inter-preti della Grande composizione di Claudio Tolomeoraquo (AOO III p 23213-17)
31 Troviamo ad esempio ͵αωλη θ´ ια´ cioegrave 1838 + 19 + 111 notare il singolo apice per le frazioni unitarie
32 Essi sono editi in AOO III pp 234-256 La tradizione medievale del commentario eutociano che coincide con un ramo di quella archimedea e deriva da un codice appar-tenuto a Giorgio Valla perduto in etagrave rinascimentale ma riprodotto a volte con fedeltagrave assoluta negli apografi (si veda ad esempio nella tav 1a la riproduzione dellrsquoerronea di-sposizione di cifre e parte algoritmica nel primo gruppo di moltiplicazioni offerta dal Laur Plut 284 f 160r) egrave costituita da Marc gr 305 ff 142v-146v Laur Plut 284 ff 159r-164r Par gr 2360 ff 109v-113v Par gr 2361 pp 410-421 Nel codice veneziano in cui la disposizione per righe e colonne egrave irrimediabilmente alterata dal copista le operazioni sono cancellate con tratti di penna Il primo manoscritto fu esemplato per Bessarione da Giorgio Trivizias tra il 1455 e il 1468 (Mioni 1976 pp 309-312) il secondo fu vergato da Giovanni Scutariota in scrittura di imitazione (Martinelli Tempesta 2010 p 173 n 7 Rollo 2012) ca 1491-1492 il terzo fu trascritto per il cardinale di Firenze Niccolograve Ridolfi dopo che la biblioteca di Valla era stata acquistata a seacuteguito della sua morte avve-nuta il 23 gennaio 1500 per 800 scudi drsquooro da Alberto Pio di Carpi (nota del copista al f 120v) il quarto fu terminato per mano di Christopher Auer su commissione di Georges drsquoArmagnac il primo gennaio 1544 (sottoscrizione a p 474 del codice si veda RGK II nr 525)
33 A questi va aggiunto posto davanti al risultato finale di ogni moltiplicazione il segno convenzionale per ὁμοῦ laquoinsiemeraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 135
prime due moltiplicazioni34 i secondi alla bontagrave dellrsquoapprossimazione ottenuta35 Ogni gruppo di operazioni che chiude unrsquounitagrave esegetica ed egrave seguito dalla citazione che apre la successiva egrave trascritto come se facesse parte del testo a tutta pagina e preceduto dallrsquoindicazione οἱ δὲ πολλαπλασιασμοὶ ὑπόκεινται laquole moltiplicazioni sono poste qui sottoraquo Questi due fatti suggeriscono che tutte le operazioni cui Eutocio non fa alcun riferimento nel corpo del suo commentario siano unrsquoaggiunta editoriale risalente a Isidoro di Mileto che si occupograve della revisione del testo36
Gli incolonnamenti esatti sono invece necessari quando siano moltiplicati numeri con parti non intere espresse nel sistema sessage-simale in quanto la somma finale dei prodotti parziali va effettuata ordine per ordine Tale somma eccederagrave di norma il valore di 60 per un ordine dato nella tabella occorre pertanto trovare posto anche per i riporti che vanno sommati ai prodotti parziali dellrsquoordine preceden-te e quindi incolonnati con essi I testi ci offrono alcuni esempi di tabelle operazionali moltiplicative di questo tipo Teone afferma espli-citamente che la prima moltiplicazione che va a descrivere ha una rap-presentazione tabellare la cui disposizione ritroviamo pesantemente ingarbugliata nel Laur Plut 2818 f 35r37 Alla seconda occorrenza di una moltiplicazione eseguita (tav 1b Laur Plut 2818 f 65r) gli incolonnamenti sono meglio rispettati anche se il risultato finale egrave fatto erroneamente slittare di un posto verso destra i riporti (con un errore) si trovano nella penultima riga38 Nei Prolegomena ad Alma-gestum alcune moltiplicazioni sono accompagnate da tabelle quella meglio attestata egrave associata alla moltiplicazione di 67 4 55 per se stesso (sezione i nel riassunto fornito supra) ed egrave descritta additando sempli-cemente ad un ente materiale oramai inaccessibile forse tracciato in loquendo lsquoalla lavagnarsquo
34 Come λοιπὸν τὸ ἀπὸ ΕΓ laquoresta quello su ΕΓraquo seguito dal risultato della sottrazione di due quadrati
35 Come λείπει ἄρα μο β εἰς τὸ ἀκριβές laquomancano quindi 2 u(nitagrave) al risultato esattoraquo36 Si legga la sottoscrizione spuria ad AOO III p 26010-1237 Si legga la frase ἐκτίθεμαι αὐτὴν καὶ πάλιν αὐτὴν ὑφ᾽ αὑτὴν ὡς ὑπογέγραπται laquolo [scil il
valore del lato da moltiplicare per se stesso] dispongo lsaquouna voltarsaquo e di nuovo al sotto di se stesso come trascritto qui sottoraquo in iA p 45817 Il Laur Plut 2818 (Teone e Pappo Commentaria in Almagestum) egrave uno dei piugrave antichi manoscritti in minuscola sicuramente assegnabile alla prima metagrave del IX secolo (Follieri 1977 p 144 n 23 Maas 1927 p 76 n 17 riteneva che fosse piugrave antico del Tetraevangelo Uspenskij) per una sua analisi si veda Rome 1938
38 In nessuno dei due casi i numerali di molteplicitagrave sono segnalati con apici sono tutti sormontati da una barra si veda la sezione 4 punto b
Fabio Acerbi136
προκείσθω δὶς τὸ μῆκος αὐτῆς ὀφεῖλον τὴν τάξιν τοῦ κατὰ τοὺς πολλαπλασιασμοὺς κανόνος ἀποδοῦναι καὶ ἐκκείσθω ἐπὶ σελιδίων διαγεγραμμένων οὕτω καὶ δὴ αὐτῆς ἐφ᾽ ἑαυτὴν πολ-λαπλασιασθείσης γεγονέτωσαν τὰ ἐν τοῖς οἰκείοις σελιδίοις εἴδη ταῦτα δὴ συναγόμενα καθ᾽ ἣν ὑπεδείξαμεν τάξιν ποιήσει τὰς ὑπογεγραμμένας μοίρας ἢ καὶ λεπτά τινα εἴσι ͵δυϙθ νθ´ ιδ´´ ι´´´ κε´´´´ ὡς λείπειν τοῦ ἐπιμερισθῆναι ŏ ŏ με´´ μθ´´´ λε´´´´
che sia prescritto che la sua lunghezza debba figurare due volte nella disposizione della tavola delle moltiplicazioni e che lsaquoquestrsquoultimarsaquo sia disposta su colonne delimitate da linee cosigrave mdash E pertanto una volta moltiplicato lsaquoil latorsaquo per se stesso che le specie trovino posto nelle colonne appropriate quelle che vengono cosigrave raccolte secondo la disposizione che abbiamo indicato produrranno dunque i gradi o anche i minuti qui sotto trascritti 4499 59 14 10 25 in modo che dalle divisioni successive resti39 0 0 45 49 35
La tabella associata (tav 2a Marc gr 313 f 19v) contiene una sola svista grossolana reca 51 invece di 55 in ognuno dei due fattori posti affiancati sopra di essa Al di sotto preceduto dal segno convenzionale per ὁμοῦ egrave collocato il risultato incongruamente sfalsato di un paio di colonne e con la lettera numerale ͵δ priva di barra sormontante in-naturalmente disconnessa da υϙθ I riporti sono indicati dai numerali ι ρκγ´ η´´ ν´´´ posti al fondo delle prime quattro colonne Il calcolo egrave corretto in ogni sua parte
Il clou in questo piccolo spaccato delle interazioni testo-paratesto matematico risiede nella descrizione contenuta nei Prolegomena della disposizione tabellare di due procedimenti di divisione il primo ano-nimo e quindi da supporre tradizionale il secondo piugrave efficiente ed attribuito al matematico del IV secolo Pappo
Il primo metodo di divisione egrave sostanzialmente analogo a quello che usiamo attualmente Dividendo e divisore questrsquoultimo preceduto da un segno su cui ritorneremo nella prossima sezione sono posti uno sotto lrsquoaltro intervallati da una riga inizialmente vuota Primo passo viene reperito il massimo multiplo del divisore che sia minore del di-videndo esso viene trascritto sotto il dividendo nella prima lsquocasellarsquo della riga vuota recante in testa un segno per laquosottrairaquo il fattore mol-tiplicativo (o quoziente parziale) viene trascritto in una lsquocasellarsquo pre-ceduta da un segno per laquorisultaraquo sotto il divisore Secondo passo il massimo multiplo viene sottratto dal dividendo il resto cosigrave ottenuto egrave trascritto preceduto da un segno per laquorestoraquo in una casella posta
39 Lrsquoautore concettualizza il procedimento di estrazione di radice quadrata come una forma di divisione
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 137
accanto al dividendo40 I due passi precedenti sono quindi ripetuti con la sola differenza che il resto appena ottenuto prende il posto del divi-dendo il quoziente parziale scala di un ordine sessagesimale ad ogni passo41 E cosigrave via aggiungendo ogni volta due caselle La debolezza di questo metodo come di quello che utilizziamo attualmente risiede nel fatto che il reperimento dei quozienti parziali (ovverosia dei massimi multipli) viene effettuato per tentativi non riuscire a farlo al primo colpo appesantisce notevolmente i calcoli successivi e costringe ad un lavoro di riordino e addizione dei quozienti parziali stessi La tabella risultante dove appunto osserviamo questo fenomeno in parallelo con identiche inaccuratezze nella descrizione ha la forma riprodotta unico tra i manoscritti della recensione antica nel Marc gr 313 f 13r (tav 2b invito il lettore a non rivolgersi alle tavole se non dopo aver termi-nato questa sezione sarebbe anzi auspicabile che tentasse di ricostruire questa tabella e le due successive a partire dalla mia descrizione)42
Il secondo metodo di divisione attribuito a Pappo egrave congegnato in modo da rendere non aleatoria la ricerca dei quozienti parziali Come altrove nei Prolegomena la descrizione della procedura di calcolo si riag-gancia esplicitamente a una frase di Tolomeo laquouna volta dimostrato che il periodo di una singola rivoluzione lsaquodel solersaquo egrave di 365 giorni 14 48 se di-vidiamo per essi i 360 gradi di un singolo cerchio avremo il moto medio giornaliero del sole circa 0 gradi 59 8 17 13 12 31raquo43 Questrsquoaffermazione si trova nel terzo libro dellrsquoAlmagesto si tratta della prima occasione in cui viene effettuata una divisione in cui il divisore egrave maggiore del dividendo e i commentatori del trattato tolemaico non si fecero sfuggire lrsquooccasione di mostrare come eseguirla Ora il terzo libro del commentario di Pappo non ci egrave pervenuto Ci resta dunque come testo parallelo a quello dei Prolegomena la descrizione rigidamente formulare in Teone sicuramente un calco di quella pappiana Teone qui come nelle altre applicazioni del metodo (Laur Plut 2818 ff 136v [tav 3] e 190r) descrive brevemente ed espone esplicitamente la stessa tavola dei sottomultipli del divisore che
40 Esempio nella divisione di 378 per 17 il massimo multiplo egrave 374 il quoziente parziale egrave 22 il resto 4 e in effetti 378 = 374 + 4 = 17times22 + 4 Si noti che il segno per laquorestoraquo non egrave apposto in testa di riga ma davanti a ogni resto parziale e in effetti il dividendo che si trova in prima posizione in questa riga non egrave un resto
41 Analogamente nellrsquoalgoritmo moderno poniamo la virgola o scaliamo la cifra di un posto
42 Nei Prolegomena la descrizione della tabella associata al metodo anonimo egrave pre-ceduta da una breve sinossi dellrsquooperazione in stile procedurale (cioegrave senza riferimenti alla tabella) e seguita dalla sua esecuzione accurata ma con pochi riferimenti alla tabella se non quello ai due segni da apporre ai resti parziali e ai massimi multipli
43 Alm III 1 in POO I 1 p 2091-4
Fabio Acerbi138
troviamo nei Prolegomena ma non offre alcuna descrizione della disposi-zione tabellare della divisione stessa neacute vi fa riferimento
A questa procedura sono in effetti associate una tavola e una tabel-la costruite come segue (tavv 4 e 5 Marc gr 313 ff 17r e 17v il co-pista era ndash giustamente ndash insoddisfatto della prima versione) La tavola le cui righe e colonne sono delimitate da linee contiene sottomultipli44 del divisore 365 14 48 9 righe che riportano i valori da 160 a 960 piugrave altre 6 con i valori per decine da 1060 a 6060 la prima colonna elenca le 15 parti sessagesimali omettendo come drsquoabitudine la laquodenomina-zioneraquo dellrsquoordine (i numerali elencati sono quindi α β γ δ ε ϛ ζ η θ ι κ λ μ ν ξ) la seconda i sottomultipli corrispondenti organizzati su quattro colonne per tener conto dei tre ordini sessagesimali (il primo sottomultiplo egrave quindi ϛ ε´ ιδ´´ μη´´´ cioegrave 160 di τξε ιδ´ μη´´) La tabella priva di linee delimitanti espone la vera divisione Nella prima colonna troviamo i resti parziali ognuno preceduto dallrsquoindicazione del proprio ordine sessagesimale e da un segno per laquorestoraquo Nella seconda preceduti da un segno per laquosottrairaquo i sottraendi ognuno coincide ovviamente con uno dei sottomultipli nella tavola La terza colonna contiene se-guiti dallrsquoindicazione del proprio ordine sessagesimale i quozienti par-ziali ottenuti trascrivendo dalla prima riga della tavola il numerale corrispondente al sottraendo affiancato ed assegnando come ordine sessagesimale il successivo a quello posto in testa di riga Il risultato preceduto da un segno per laquorisultaraquo e posto al di sotto della tabella si ottiene sommando i quozienti parziali il procedimento non permette in generale di determinare lrsquointero quoziente parziale relativo ad un ordine sessagesimale fissato se non dopo due passi Una linea spezzata unisce i resti parziali successivi e i relativi sottraendi per evidenziare la laquoprogressione della proceduraraquo la spezzata lsquosaltarsquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore (le cui righe sono per il resto vuote) e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue di conseguenza anche il quoziente parziale relativo a questo resto appartiene allrsquoordine sessagesimale successivo
A questo punto possiamo rivolgerci alle tavv 4-5 e verificare se le immagini che ci siamo formati sulla base della mia descrizione corri-spondono a quelle che troviamo nel Marc gr 313 Non si tratta di un giochetto sterile egrave al contrario il cuore di un intrico di problemi Un primo ordine di problemi deriva dal fatto che nei Prolegomena lrsquoalgo-
44 Sottomultipli e non multipli in quanto il divisore egrave maggiore del dividendo Drsquoaltronde nel sistema sessagesimale come in quello decimale un sottomultiplo si ottiene dal multiplo corrispondente semplicemente scalando tutte le cifre di un posto (ad esempio 1360 di 365 14 48 si ottiene in questa maniera da 13 volte 365 14 48)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 139
ritmo della divisione lsquoalla Papporsquo non egrave mai eseguito (cioegrave formulato verbalmente) in maniera indipendente dalla descrizione della tabella Comrsquoegrave dunque possibile descrivere una tabella operazionale che non ha uno statuto testuale indipendente sulla base di un algoritmo in corso di esecuzione E drsquoaltro canto come non rilevare unrsquoanomalia in un algoritmo eseguito nella sua forma primaria sotto forma di descrizione di una tabella Ci potremmo chiedere se viene descritto lrsquoalgoritmo o la tabella La tensione fra i due enti grafici egrave acuita dal fatto che nei nostri testi tutto ciograve (esposizione o descrizione di un algoritmo o della tabella associata) avviene sempre e solo sulla base di un esempio numerico para-digmatico Per questo motivo la tabella in quanto struttura (cioegrave privata dei dati numerici accidentali) non puograve fare a meno della descrizione45 Dal canto suo Teone come forse Pappo ancor prima descrive ed espone la tavola dei (sotto)multipli ma non la tabella di divisione lrsquoalgoritmo relativo a questrsquoultima egrave espresso come per controbilanciare in maniera eccezionalmente trasparente e formulare Se ciograve comporta un guada-gno a livello verbale-argomentativo sorge un problema operativo grave come e dove sistemare i resti e i quozienti parziali ndash cioegrave tutti i numeri in output dellrsquoalgoritmo differenti dai (sotto)multipli ndash che la tabella si incarica di disporre in modo lsquonaturalersquo Teone prescrive soltanto di confrontare i resti con la seconda colonna della tavola dei sottomultipli e di trascrivere via via il quoziente ottenuto dopo ogni passo Insomma come eseguire materialmente una divisione Non certo adattando ad un nuovo caso specifico la formulazione dellrsquoalgoritmo che Teone propone
Un secondo ordine di problemi e una trappola micidiale per il co-pista egrave interno alla dialettica lsquotabellarsquolsquosua descrizionersquo ed egrave in assenza di simbolismo quello dei riferimenti linguistici da adottarsi nella seconda agli enti grafici che figurano nella prima Occorre ricercare la massima generalitagrave fornita da una descrizione definita di un ente numerico (ad esempio impiegando il termine laquorestoraquo o la perifrasi laquomassimo sotto-multiplo minoranteraquo) o basta assumere direttamente il suo valore speci-fico come esempio paradigmatico E in che modo risolvere il conflitto tra uso e menzione se come nel nostro caso la tabella contiene segni convenzionali ed occorre fornirne una descrizione Si rende ad esempio necessario introdurre un lsquooperatore di citazionersquo noi useremmo le virgo-lette la lingua greca premette lrsquoarticolo neutro Drsquoaccordo ma nel caso
45 Questa caratteristica non egrave connaturata alla matematica degli algoritmi la risorsa dello lsquostile proceduralersquo serve esattamente ad aggirare questo problema al di lagrave di un certo livello di dettaglio perograve essa condurrebbe ad un appesantimento insostenibile della for-mulazione dovuto alla pluralitagrave dei riferimenti agli oggetti matematici in gioco sulla que-stione dei diversi stili della matematica greca si veda Acerbi 2012
Fabio Acerbi140
greco qual egrave il suo range E come distinguerlo nei casi ambigui da un semplice articolo che precede un sostantivo quando questrsquoultimo lo ri-chieda Nel corso del processo di copia del testo della descrizione infine possono generarsi tensioni tra enti grafici interpretabili vuoi come segno convenzionale vuoi come abbreviazione Ambiguitagrave relative a questi punti opacizzano la descrizione Un problema analogo si porrebbe a priori nella dialettica tra uso delle lettere denotative per designare enti geometrici e loro menzione nella costruzione di un diagramma ma esso egrave risolto con lrsquoazzeramento della seconda funzione le lettere denota-tive sono sempre usate allrsquointerno del testo (sono cioegrave il referente degli oggetti geometrici di cui tratta il discorso matematico) mai menzionate (come accadrebbe se fossero il referente di oggetti grafici posti nel dia-gramma) Insomma il codice adottato per la costituzione dei diagrammi geometrici egrave condiviso (cioegrave canonizzato) semplice e perspicuo mentre quello per le tabelle operazionali non lo egrave da qui le sviste dei copisti e le trascuratezze di correttori ed editori
Infine chi vuole apprendere da questi testi come eseguire una divi-sione a cosa deve prestar fede se ad esempio a causa di errori di copia la descrizione finisce per non coincidere con la tabella operazionale visto che sono entrambe due maniere valide di eseguire lo stesso algoritmo Dopo tutto lo scopo di tutta questa macchina grafico-argomentativa egrave di insegnare a eseguire divisioni in formato tabellare Questo problema si fa particolarmente acuto se la tabella non egrave trasparente nel metodo di Pappo lo egrave quasi completamente in quello anonimo no E gli errori che riscontreremo nella (doppia) tabella ai ff 17r-v del Marc gr 313 a chi sono attribuibili Allrsquoautore al trascrittore o al copista medievale
Questo groviglio di problemi riceve alcune risposte sorprendenti dalla tradizione manoscritta come andiamo finalmente a vedere
4 Analisi delle testimonianze
I codici che ho adibito per lrsquoedizione sono i seguenti M = Marc gr 31346 C = Marc gr 314 (Tolomeo Tetrabiblos et opera minora cum commentariis Vezio Valente Anthologiae)47 Z = Vat gr 2326 (fattizio
46 Riferibile al sec IX ex-X in accolgo la datazione suggeritami per litteras il 522005 da Nigel G Wilson si veda anche Agati 1992 pp 141-142 La presenza non sistematica degli accenti che fa anticipare a Wilson la datazione di laquosaec X medraquo fornita in Mioni 1985 p 24 indusse Boris Fonkič (2005 non vidi) ad assegnare il codice allrsquoinizio del IX secolo
47 Il manoscritto riferibile alla seconda o terza decade della prima metagrave del XIV secolo fu vergato da Michele Clostomalle olim lsquoMetochitesschreiberrsquo Bianconi 2005a pp 428-430 Il titolo dei Prolegomena in questa trascrizione identico in grafia ma non in formulazione a
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 141
e mutilo Tolomeo Almagestum) S = Vat gr 184 (varia astronomica scholia miscellanea ad Almagestum Tolomeo Almagestum) P = Par gr 2390 (varia astronomica) gli ultimi tre riferibili allo scorcio del XIII secolo48 e apografi sicuri del Vat gr 159449 attualmente mutilo di due fascicoli che ci privano dei due terzi finali dei Prolegomena M e il Vat gr 1594 ammettono un modello comune il resto della tradizione (25 trascrizioni in tutto) dipende dagli apografi appena citati del Vat gr 1594 Le varianti della recensione bizantina che leggiamo tra lrsquoaltro nei Vat gr 198 Marc gr 310 (Tolomeo Almagestum cum commentariis Pappi Theonis et Cabasilae) e con ulteriori modifiche Laur Plut 89 sup 48 (varia astronomica Tolomeo Almagestum Barlaam Logistica) sono identificate dal siglum K e si trovano punteggiatura originale in-clusa nel secondo apparato50 Lrsquoanalisi delle testimonianze51 costituite ovviamente anche dalle tabelle associate saragrave condotta nella forma di una sequenza di osservazioni indicizzate da numerali o lettere oltre che di alcune note a piersquo di pagina
Iniziamo dalla descrizione del metodo di divisione anonimo
quello che leggiamo nel Vat gr 1594 (questrsquoultimo coincide con quello adottato nella recen-sione bizantina) fu apposto da Niceforo Gregora e successivamente corretto da Bessarione
48 Sto studiando il primo e il terzo codice in collaborazione rispettivamente con Daniele Bianconi e Inmaculada Peacuterez Martiacuten
49 Su questo codice risalente alla seconda metagrave del IX secolo e sulla sua collocazione nella lsquocollezione filosoficarsquo per prima proposta in Follieri 1977 pp 145-146 si vedano almeno Perria 1991 pp 82-88 Ronconi 2013 Che il titolo dei Prolegomena nel Vat gr 1594 sia stato apposto da Niceforo Gregora egrave stato riconosciuto per la prima volta in Mazzucchi 1994 p 211 n 196 si veda Bianconi 2005a p 418 per altri interventi di Gregora nello stesso manoscritto
50 Il Vat gr 198 egrave stato vergato dal copista Malachia nel corso del terzo quarto del XIV secolo Mondrain 2004 pp 278-290 e 292 Allo stesso copista (denominato non a caso prima dellrsquoidentificazione anonymus Aristotelicus) dobbiamo un buon numero di trascrizioni aristoteliche con i relativi commentari in margine Gli dobbiamo anche il Par gr 2342 secondo tomo di un quadrivium quasi completo di cui il Vat gr 198 egrave il primo nellrsquoordine aritmetica armonica astronomia (Almagesto e commentari relativi) nel codice vaticano geometria ed ancora astronomia (corpus astronomico minore) in quello parigino le opere trascritte sono sempre accompagnate in margine dai relativi commentari Il copista del Marc gr 310 egrave Isacco Argiro (ca 1300-1375) Mondrain 2007 p 166 Allo stesso Argiro dobbiamo il codice laurenziano (Daniele Bianconi per litteras) Poicheacute la recensione modificata che leggiamo nel Laur Plut 89 sup 48 egrave senza alcun dubbio basata su quella nel Marc gr 310 e non viceversa ci troviamo di fronte ad un copista che trascrive due volte lo stesso testo in due versioni leggermente differenti la conclusione naturale egrave che la seconda recensione egrave dovuta ad Argiro stesso la questione andragrave studiata in dettaglio
51 Nei manoscritti citati i Prolegomena si trovano ai fogli seguenti Vat gr 1594 ff 1r-8v (mutilo mancano due fascicoli su tre) Marc gr 313 ff 1r-28r (incompleto man-cano due fogli allrsquoinizio e il f 6 attualmente rimpiazzato da uno bianco) Marc gr 314 ff 235r-255r Vat gr 2326 ff 19r-40v e 43r-v (incompleto e con i fascicoli in disordine) Vat gr 184 ff 10r-23v Par gr 2390 ff 1r-13v Vat gr 198 ff 127r-136v Marc gr 310 ff 1r-13r Laur Plut 89 sup 48 ff 7r-19r
Fabio Acerbi142
ἐκθέμενοι οὖν διάγραμμα τῶν ἀριθμῶν ὡς ὑπόκειται προτάσσομεν τὸν μεριζόμενον καὶ μικρὸν ὑπ᾽ αὐτὸν τὸν μερίζοντα ὡς ἔχει τὸ διάγραμμα ἐν στίχοις διοριζομένοις ὑπὸ γραμμῶν [hellip] καὶ τὰ μὲν γινόμενα ἐγγὺς ἐλάττονα ἐν τῇ μεταξὺ θέσει τοῦ μεριζομένου καὶ τοῦ μερίζοντος ἐν στίχοις παρασημειοῦσθαι πρὸς τὸ ἀσύγχυτον εἶναι τὴν τάξιν τὰ δὲ μεθ᾿ ὧν ὁ μερίζων ἐποίει τοὺς ἀεὶ ἐλάσσονας ὑπὸ τὸν μερίζοντα σημειοῦσθαι προγράφοντας ἐπὶ τοῦ στίχου αὐτῶν τὸ γίνεται οὕτως γι ἐν δὲ τῷ στίχῳ τῶν μεριζόντων τὸ παρὰ ἔχον οὕτως oslash ἀντὶ τοῦ παρ᾿ ἃ δεῖ τὸν μερισμὸν γίνεσθαι ἐν δὲ τῷ στίχῳ τῶν ἐλασσόνων τὸ αφ διὰ τὸ τούτους ἀεὶ ἀφαιρεῖσθαι ἀπὸ τῶν ἐπάνω τῶν μεριζομένων ἐν δὲ τοῖς τοῦ μεριζομένου λοιπάσμασι τοῖς καὶ ἐπιοφείλουσι τὸ λ κατὰ τὸ ἴδιον τῶν διαστάσεων ἑκάστης ndash λέγω δὴ λοιπάδος ndash ἀντὶ τοῦ λοιποὶ οἱ μέλλοντες ἐπιμερίζεσθαι
2 post τὸν suprascr τὸν ἐλάττονα m 2 S 5 πρὸς] MP et ex corr Z κατὰ S om C | ἀσύγχυτον] MSPC -χητον Z 6 ἀεὶ] MZPC ὡσεὶ S 7 γίνεται οὕτως γι ] γι τ οὕτως γι τ M γί οὕτως γί Z γι οὕτως γί SC τὸ γινόμενον οὕτως γίνεται P 8 τὸ παρὰ ἔχον οὕτως] scripsi τὸ παρέχον οὕτως M et π(αρ-) comp Z οὕτως τὸ περιέχον S προγράφοντας οὕτως ex corr m 2 P τὸ περιέχον οὕτως C | oslash] MZSC (sed ο fecit | Z) ἐλάττων comp ex corr m 2 P | παρ᾿ ἃ] scripsi παρα M π(αρα) comp ZSC ex παρα fe-cit παρὰ et τοῦτον suprascr m 2 P 9 γίνεσθαι] comp C | αφ ] αφ ε M ἀφ ZSC ἀφαί P | ἀεὶ] om M 11 ἐπιοφείλουσι] MZSC ex ἐπιο- fecit ἐπο- m 2 P | λ] MZPC λ´ S 12 λοιποὶ] PC λοιποῦ MZS
3 στίχοις] στίχῳ K 5 πρὸς] διὰ K 7 ἐπὶ mdash γι ] τὸ γίνεται διὰ τοιούτου σ(ημείου) γί K 8 τὸ παρὰ ἔχον mdash παρ᾿ ἃ] τὸ παρᾱ διὰ σ(ημείου) τοιούτου καὶ τοῦτο oslash δηλοῦντος τοῦ παρᾱ ὅτι παρὰ τὸν τοιοῦτον (ἀριθμὸν) K 9 αφ διὰ τὸ τούτους] ἀφ δηλοῖ δὲ τοῦτο ἀφαίρεσ(ιν) ὅτι τούτους ἀεὶ δεῖ K 11 ἐπιοφείλουσι] ἐπιμερίζεσθαι ὀφείλουσι K | λ] λ οι` K 12 ἀντὶ τοῦ] δηλοῦντος τοῦ σ(ημείου) τὸ K
lsquoRendendo esplicito un diagramma numerico come lo troviamo qui sotto disponiamo in primo luogo il dividendo e un poco al di sotto di esso il divisore come li ha il diagramma in righe delimitate da linee [hellip] e lsaquooccorreragraversaquo nella posizione tra il dividendo e il divisore annotare lrsquouno accanto allrsquoaltro i piugrave vicini lsaquodei numerirsaquo minori che risultano affincheacute la disposizione non sia confusa quelli con cui il divisore faceva ogni volta i lsaquonumerirsaquo minori annotarli sotto il divisore scrivendo in prima posizione sulla loro riga laquorisultaraquo cosigrave Ris nella riga dei diviso-ri52 invece laquoperraquo fatto cosigrave53 P in luogo di laquoquelli per cui deve farsi la divisioneraquo nella riga dei lsaquonumerirsaquo minori laquosottrraquo in quanto questi sono sempre sottratti dai dividendi che si trovano sopra nei residuli del dividendo (occorre ben farlo anche per loro) laquoReraquo in accordo con ciograve
52 I laquodivisoriraquo sono al plurale ma siamo semplicemente di fronte a un tratto idioma-tico della lingua greca nel caso di espressioni generalizzanti crsquoegrave soltanto un divisore che occupa lrsquounica colonna di cui si compone la sua riga
53 Si intenda ἔχον οὕτως = ita se habens
1
5
10
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 143
che egrave proprio agli scarti di ciascuno ndash intendo qui lsaquociascunrsaquo residuo54 ndash in luogo di laquoresti che vanno a essere divisi ulteriormenteraquorsquo
a) Operatori di citazione e segni convenzionali I segni introdotti sono quattro la mia discussione egrave condotta dando per scontato che essi siano identici a quelli impiegati dallrsquoautore dei Prolegomena anche se si tratta di unrsquoipotesi non corroborabile neacute falsificabile
i Segno per il risultato Lrsquoabbreviazione convenzionale per γίνεται egrave identica al segno introdotto dallrsquoautore e i copisti si dividono tra i due errori possibili scrivere due abbreviazioni o risolverle entrambe Un fenomeno del tutto analogo si riscontra nel Matr 4678 il manoscritto alla base di tutta la tradizione degli Arithmetica di Diofanto al momen-to della definizione dellrsquoἀριθμός (lrsquolsquoincognitarsquo nel nostro linguaggio) ὁ δὲ μηδὲν τούτων τῶν ἰδιωμάτων κτησάμενος ἔχων δὲ ἐν ἑαυτῷ πλῆθος μονάδων ἄλογος ςο` καλεῖται ς` ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον τὸ ς` laquoil lsaquonumerorsaquo che non possiede nessuna di queste proprietagrave ma che ha in seacute una molteplicitagrave indefinita di unitagrave egrave chiamato lsquonumerorsquo e il suo segno egrave ς`raquo Qui solo il terzo dei tre ς ha una barra a sormontare per segnalarne il carattere puramente denotativo (cioegrave di segno convenzionale e non di abbreviazione si veda il punto successivo)55 il primo egrave una delle abbreviazioni piugrave diffuse per ἀριθμός (e infatti egrave dotato del compendio per la desinenza e dellrsquoaccento grave) il secondo egrave una delle piugrave comu-ni per καὶ () Giovanni Cortasmeno autore di capillari annotazioni infra lineam agli Arithmetica nel codice madrileno scioglie il primo ςο`
54 Doppia variatio che impiega al posto di λοιπόν laquorestoraquo i due termini decisamente non canonici τὸ λοίπασμα e ἡ λοιπάς (piugrave oltre leggiamo anche il participio λοιπασθέντα) Una ricerca sul TLG in rete non ha fornito occorrenze del primo si tratta dunque di uno hapax Quanto al secondo che ricorre anche nella sezione sulla divisione lsquoalla Papporsquo lo si rintraccia giagrave nei papiri documentari il termine diventeragrave perograve canonico nelle esposizioni bizantine drsquointroduzione allrsquoAlmagesto ricalcate sul modello dei Prolegomena (si veda la nota 87 infra) Questi due termini designano i resti parziali prodotti nel corso di una divisione lunga li ho tradotti rispettivamente con il neologismo laquoresiduloraquo e con il sostantivo pari-menti non canonico laquoresiduoraquo
55 Il copista interpreta erroneamente il terzo segno come unrsquoabbreviazione e qui ag-giunge un apice inverso (cioegrave un accento grave) altrove lo scioglie direttamente in forme opportune di ἀριθμός Matr 4678 f 58v La frase come la leggiamo nel manoscritto egrave cor-rotta sulla base di una parafrasi in Psello (edita in DOO II p 3710-12) Tannery emendograve ἄλογος in ἀόριστον DOO I p 64-5 et app Il Matritensis vergato da due copisti differenti (cambio di mano a tre righe dalla fine del f 62r) contiene lrsquoIntroductio arithmetica di Nicomaco e le opere diofantee oltre ad alcuni brevi opuscoli musicali la sua data egrave stata recentemente corretta dal XIII al secolo XI pm in Peacuterez Martiacuten 2006 (una riproduzione digitale del manoscritto si trova allrsquoindirizzo httpbdhbneesbnesearchbibliotecaDio-fanto20de20AlejandrC3ADa)
Fabio Acerbi144
in ἀριθμός ed aggiunge un altro segno56 sopra il terzo anteponendovi lrsquoindicazione καὶ ἔστιν αὐτοῦ σ(ημεῖον) τόδε Va da seacute che non abbiamo nessuna garanzia che il segno originariamente introdotto da Diofanto coincidesse realmente con unrsquoabbreviazione convenzionale per ἀριθμός Lrsquoevidenza del PMich III 144 (sec II in) suggerisce drsquoaltronde che il Matritensis e con esso tutta la tradizione medievale di Diofanto ripro-duca fedelmente pur accentuandone la sinuositagrave il segno originario
ii Segno per il divisore Un cerchiolino sbarrato da non confondere con il segno per ὁμοῦ che nei manoscritti matematici ha di norma due barre trasversali (cf tav 2a) Non sono riuscito a rintracciarne ulteriori occorrenze in altre opere la forma che esso assume nel Vat gr 2326 e la correzione apportata nel Par gr 2390 lasciano aperta la possibilitagrave per quanto a mio avviso remota che la forma originaria non fosse lon-tana da unrsquoabbreviazione di παρά registrata nei repertori57 Il correttore del Par gr 2390 trasforma in effetti il segno oslash nellrsquoaffine abbreviazione canonica per (forme di) ἐλάσσων laquominoreraquo58 e si incarica diligente-mente di farlo notare ricapitolando i segni nella porzione superiore del margine esterno del f 7v Nello stesso margine egli traccia anche uno lsquoscolio tabellarersquo ed egrave lrsquounico a porre il (proprio) segno dove indicato dalla descrizione (tav 6 Par gr 2390 f 7v) Oltre a ciograve adattando la tabella al margine ristretto lo scoliaste trascrive come colonne affian-cate le due righe dei resti parziali e dei massimi multipli e aggiunge le indicazioni ὁ μεριζόμενος laquodividendoraquo e ὁ μερίζων laquodivisoreraquo ma vi introduce alcune incongruenze di formato il risultato scritto in verti-cale e la linea verticale di sinistra che separa il divisore dal segno che lo dovrebbe precedere direttamente
iii Segno per i massimi multipli Corrisponde alla semplice abbre-viazione per sospensione della forma verbale ἄφελε laquosottrairaquo in questo
56 Si tratta del segno di ampio uso praticamente identico allrsquoabbreviazione canonica per οὖν
57 Si tratta di un pi a forma di gancio sbarrato da uno slash di troncamento Ce-reteli 1904 tav IX item 7 sub ΠΑΡΑ che rinvia al PVindRain 423 cf anche la forma π` nel POxy LXI 4142 edito in Jones 1999 II pp 26-34 In generale nei papiri e nei manoscritti matematici in maiuscola le preposizioni sono abbreviate facendo seguire un lsquoapostroforsquo alla loro prima lettera Α᾽ Υ᾽ ecc Per la seconda fattispecie di supporto libra-rio si veda in particolare il cosiddetto fragmentum mathematicum Bobiense scriptio inferior databile al V-VI secolo del palinsesto Milano Biblioteca Ambrosiana L 99 sup (Isidoro di Siviglia Etymologiae datazione Cavallo 1977 p 100) pp 113-114 che sono stampate in riproduzione apografa conforme in Belger 1881 (la p 114 egrave riprodotta anche nella tav 10 di Acerbi 2010)
58 Se questa era lrsquointenzione si tratta ovviamente di una forzatura il divisore puograve ben essere maggiore del dividendo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 145
caso lo slash di troncamento taglia orizzontalmente il tratto verticale del phi I copisti offrono molteplici varianti apponendo chi uno spirito dolce chi un ε chi un αί accentato a sormontare Tutti questi segni svolgono la funzione di abbreviazioni vere e proprie (e cosigrave doveva essere anche per lrsquoautore si veda il punto 1 di p 153 infra) la forma originale si ottiene a mio avviso incrociando i dati del Marc gr 313 e dei tre apografi del Vat gr 1594 αφ anche se lrsquoassenza dello spirito potrebbe essere semplicemente dovuta alla pratica del copista del codice veneziano di economizzare nei diacritici
iv Segno per i resti Un lambda completato da una barra a sormon-tare o da un apice che rinvia alle abbreviazioni per sospensione di una forma opportuna di λοιπός laquorestoraquo In realtagrave la forma che troviamo nella tabella egrave differente (tav 2b) e coincide con quella offerta quasi unanimemente dai manoscritti nella descrizione e in almeno un caso nella tabella del metodo di divisione attribuito a Pappo (tav 4) un lambda che accoglie al di sotto una legatura omicron-iota () sbarrata da uno slash di troncamento Qualcosa di simile si trova nel PVindob G 19996 (sec I) una specie di lambda maiuscolo molto aperto e dal vertice arrotondato che include un circoletto interpretato dagli editori come segno per περίεστιν o per λοιπόν59 Lo stesso segno si rintraccia ad esempio in un medesimo scolio tabellare di prima mano ad Alma-gestum nel Vat gr 1594 f 93v e nel Marc gr 313 f 135r ma stavolta la forma del lambda egrave molto ben definita
Fin qui i segni Ma il gioco egrave piugrave complesso La descrizione si muo-ve pericolosamente sulla linea di confine non sempre ben definita tra segno convenzionale e abbreviazione il primo ndash e il repertorio grafico matematico-astronomico ne egrave particolarmente fornito60 ndash puograve anche
59 Ho consultato lrsquoedizione Gerstinger ndash Vogel 1932 pp 46 e 48 la porzione rilevante del papiro egrave riprodotta nella tav 11 di Fowler 1999 Si veda ancora ivi pp 253-257 per la trascrizione di questo segmento di testo (con correzioni rispetto alla princeps) e per una messa a punto recente inclusa la proposta di datazione che ho riportato qui sopra Il verso del papiro che contiene una tavola aritmetica del tutto scorrelata dalla tematica del recto egrave edito come PRain Unterricht 151
60 La pratica di ridurre lo spazio occupato da un testo tecnico per mezzo di abbreviazioni e segni convenzionali era molto diffusa nei manoscritti in maiuscola contrariamente a quanto avviene per altri generi letterari vedremo tra breve cosa accade negli Arithmetica di Diofanto ma si leggano in proposito anche le considerazioni di Hei-berg nei prolegomena alla propria edizione dellrsquoAlmagesto in particolare riguardo al ricorso massiccio ad espedienti brachigrafici nel modello del Vat gr 180 POO II pp lxxxiv-xciii civ-cv cxxvii cxxxviii-cxxxix Agli elenchi dettagliati forniti da Heiberg possiamo aggiungere il piccolo prontuario stampato in Hultsch 1876-1878 III 2 pp 126-132 e basato sul testo e sugli scolii alla Collectio di Pappo nel Vat gr 218 (sec X in) Si vedano infine le osservazioni del copista del Par gr 2360 f 120v trascritte da Heiberg in AOO III pp x-xi sulle laquonotazioni tipiche a scopo di tagliar corto nello scrivereraquo impiegate nel pro-
Fabio Acerbi146
derivare dalla seconda (un caso egrave appunto il segno per ἐλάσσων che probabilmente trae origine da una legatura epsilon-lambda) ma poi il rapporto referente-relato si fissa convenzionalmente Quelli definiti nel testo che abbiamo letto sono appunto segni convenzionali non ci sarebbe bisogno di spiegarne forma e funzione se fossero intesi come abbreviazioni assumono nella tabella una funzione denotativa non esplicativa o discorsiva (come accade invece nella tav 1a) Ma come vengono descritti questi segni
I referenti delle descrizioni sono i segni sono introdotti da οὕτως (item i-ii) o in alternativa da un τό con il ruolo di lsquooperatore di citazionersquo (item iii-iv) che corrisponde esattamente alle nostre virgolette In entram-bi i casi gli enti sono menzionati e svolgono una funzione metalinguistica sono collocati materialmente nel testo ma egrave come se si trovassero fuori e la loro descrizione li additasse ndash in effetti i segni convenzionali scritti nel testo sono a loro volta i relata di quelli che si trovano nella tabella
I relata dei segni scritti nel testo sono di due tipi singoli vocaboli (item i-ii) o descrizioni della funzione dei segni per mezzo di clausole sintaticamente complesse (item ii e iv) I singoli vocaboli sono γίνεται e παρά e sono entrambi preceduti dal τό lsquocitazionalersquo in quanto relata di segni convenzionali le forme abbreviate con cui sono tracciati nei manoscritti vanno forzatamente sciolte Bisogna ammettere che la per-spicacia e le risorse grafiche dei copisti ndash di cui tutto si puograve dire fuor che commettano qui degli errori ndash sono messe a dura prova con lrsquointrodurre segni identici ad abbreviazioni o con lrsquoattivare un gioco metalinguistico particolarmente serrato in un contesto meno lsquonaturalersquo di come potreb-be esserlo ad esempio quello di un trattato grammaticale Lrsquoitem iii che presenta direttamente un segno identico ad unrsquoabbreviazione non egrave sorretto da una descrizione ma da una giustificazione in διὰ τό Lrsquoartico-lo τό vi assume una funzione metalinguistica anche se non lsquocitazionalersquo poicheacute al tempo stesso genera un infinito sostantivato e lo singolarizza per questo ho scritto laquosono sottrattiraquo in corsivo nella mia traduzione
prio modello archimedeo (nota 32 supra) egli ne compila anche una breve lista Un elenco antico di laquosegni della geometriaraquo sicuramente redatto per assistere il copista si trova anche al f 3v del ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 vergato da Efrem negli anni 950-960 (tav 8 in Acerbi 2010) Possiamo farci unrsquoidea quantitativa del guadagno di spazio in rapporto ad un testo privo di abbreviazioni e con le parole separate da spazi sulla base del fragmentum mathematicum Bobiense il testo vi egrave disposto a tutta pagina su 36 righe di circa 30 segni ciascuna nelle due pagine in questione figurano 2038 segni con 15 mezze righe occupate dalle due figure Ora nel testo dellrsquoedizione stabilita in Heiberg 1927 pp 87-90 le stesse pagine contano 4455 segni spazi compresi Ne risulta che la dimensione in caratteri di un testo matematico puograve essere ridotta di piugrave della metagrave con lrsquoimpiego di compendi e segni convenzionali
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 147
Negli item ii e iv il segno si collega ad una descrizione nel secondo caso in via esclusiva le descrizioni pertanto rinforzano o sostituiscono lrsquoidentificazione con lrsquoente linguistico denotato Le clausole descrittive sono precedute da ἀντί e dallrsquoarticolo τό con funzione di lsquooperatore di citazionersquo esse sono παρ᾿ ἃ δεῖ τὸν μερισμὸν γίνεσθαι (item ii) e λοιποὶ οἱ μέλλοντες ἐπιμερίζεσθαι (item iv) Nella descrizione della divisione lsquoalla Papporsquo che leggeremo tra breve i segni negli item iii e iv rice-vono lo stesso trattamento degli altri due il loro relatum egrave un singolo vocabolo e non una clausola descrittiva rispettivamente nelle espres-sioni τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε (sul participio ritorneremo nel punto 1 infra) e τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά (la forma del segno notato con λ οι egrave descritta supra nellrsquoitem iv) La descrizione del segno oslash per il divisore merita una discussione piugrave dettagliata In origine si trovava probabilmente scritto Π(ΑΡΑ)ΕΧΟΝ successivamente letto come π(αρ[α])έχον ndash dato che lrsquoabbreviazione per il preverbo egrave identica a quella per la preposizione (che sia Π᾽ o un pi seguito dal segno per ἄρα a sormontare) ndash invece di π(αρὰ) ἔχον I copisti e i correttori si dettero a tutte le possibili contorsioni per restituire un testo dotato di senso leggere appunto una forma verbale con preverbo modificare il preverbo (ma forse il segno per ἄρα era insidiosamente simile ad uno epsilon) correggere il testo rileggiamo lrsquoapparato sub τὸ παρὰ ἔχον οὕτως τὸ παρέχον οὕτως M et π(αρ-) comp Z οὕτως τὸ περιέχον S τὸ περιέχον οὕτως C προγράφοντας οὕτως ex corr m 2 P Nella clausola descrittiva seguente la presenza liminare di παρὰ (che ho corretto in παρ᾿ ἃ nella speranza di restituire una frase che abbia un senso senza intervenire sul testo) innesca un bel corto circuito il Π(ΑΡΑ) che sicuramente figu-rava nellrsquoarchetipo egrave un sintagma complesso una preposizione unrsquoab-breviazione o un segno per unrsquoabbreviazione Se lrsquoeditore si trova in conflitto con la propria inclinazione alla critica conservativa i copisti si rifiutarono di mettere mano ad un testo che doveva stridere anche per loro essendo il compito demandato al ritocco del revisore del Par gr 2390 o alla riscrittura radicale del recensore bizantino Il problema egrave che ci troviamo di fronte ad unrsquoespressione che descrive la funzione dellrsquooggetto denotato non lrsquooggetto stesso ma che lo contiene al suo interno per soprammercato qui il Π(ΑΡΑ) egrave usato per giustificare una menzione a sua volta relatum di un segno
Evidentemente questa maniera di procedere che giagrave aveva attirato interventi da parte di copisti e correttori della recensione di base parve insostenibilmente opaca allrsquoautore della recensione bizantina61 Egli
61 Uno dei manoscritti di questa recensione propone anche una tabella di divisione
Fabio Acerbi148
modifica tutte le descrizioni diluendo lrsquoidiomatismo dellrsquoarticolo lsquocita-zionalersquo con lrsquointroduzione sistematica del verbo δηλόω e di frasi atte a chiarire quale sia il segno denotante e quale il vocabolo (o il segno) denotato Egli introduce allo scopo di rendere esplicita la funzione de-notativa dei segni introdotti il termine σημείου curiosamente in tutte le sue tre occorrenze esso compare a sua volta nella forma dellrsquoabbrevia-zione per sospensione σΗ´ Egli traccia il segno per i massimi multipli ἀφ e quello per i resti λ οι` in modo che non vi siano ambiguitagrave quanto al loro carattere di abbreviazione Si faccia infine attenzione al residuo di barra sul παρᾱ con funzione denotativa (2 occorrenze) contenuto nella descrizione del segno per il divisore sostituita dallrsquoaccento grave nel παρὰ con funzione discorsiva (la differenza egrave nettissima nei manoscritti da me consultati) Questa osservazione ci permette di passare direttamente allrsquoitem seguente
b) Le barre sui numerali e sulle lettere denotative Egrave opportuno discutere questo punto adesso esattamente percheacute di barre siffatte che pure troviamo in tutti i manoscritti i nostri testi non fanno mai menzione si tratta infatti di una pratica condivisa sin dallrsquoantichitagrave La barra identifica una stringa di lettere dellrsquoalfabeto che non svolge una funzione grammaticale o sintattica propria allrsquointerno del discorso Ciograve avviene in particolare e si tratta della fattispecie piugrave frequente se la stringa di lettere non dagrave origine a un vocabolo della lingua greca lette-re denotative e numerali certo ma anche termini provenienti da altri idiomi e contrazioni di parole greche come i nomina sacra62 tali termi-ni possono essere o no preceduti da un articolo lsquocitazionalersquo a seconda dellrsquouso che ne viene fatto allrsquointerno del discorso Ma non si tratta dellrsquounica fattispecie i papiri grammaticali ed i manoscritti piugrave antichi dei trattati dello stesso argomento segnalano gli esempi delle parti del discorso (cioegrave di lsquoverersquo parole greche) per mezzo di barre sormontanti63 La differenza insomma egrave tra menzione e uso (come parte del discorso in atto) di una stringa di caratteri tra il porre le lsquovirgolettersquo e il non porle tra funzione denotativa e non Apparentemente la convenzione si limi-
corredata dei segni opportuni e contrariamente alle indicazioni della descrizione svilup-pata lsquoin verticalersquo ma per motivi misteriosi non completa (tav 7a Laur Plut 89 sup 48 f 13r)
62 Tutto ciograve egrave spiegato con estrema chiarezza giagrave in Traube 1907 pp 45-4763 Si veda il Par gr 2548 codex vetustissimus e testimone unico delle lsquoopere minorirsquo
di Apollonio Discolo il f 106v con le barre ben visibili egrave riprodotto come tav 19 in De Gregorio 2000 (ivi pp 137-138 per la datazione) Per la testimonianza dei papiri grammaticali si veda Wouters 1979 passim essi contengono di norma elenchi di parti del discorso nessuna delle quali egrave preceduta dallrsquoarticolo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 149
tava in questo secondo caso a segnalare con la barra singoli vocaboli le menzioni di frasi o di sintagmi complessi sono di norma identificate dallrsquoarticolo lsquocitazionalersquo Drsquoaltra parte le abbreviazioni convenzionali non rientrano nella casistica percheacute la loro resa grafica che contiene elementi non alfabetici come compendi per desinenze lettere supra li-neam marche di contrazione o sospensione quali slashes o barre sotto-poste o sormontanti eventualmente solo un sottinsieme della stringa di segni alfabetici le esclude automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
Venendo al discorso matematico una barra sormonta senza ecce-zione le lettere denotative64 che sia in papiri o in manoscritti in maiu-scola65 o minuscola ma solo allrsquointerno del testo comrsquoegrave da attendersi nei diagrammi esse la perdono per il semplice motivo che non crsquoegrave alcun testo ambiente un diagramma ha unicamente una funzione denotati-va Drsquoaltra parte le lettere numerali che a volte figurano nei diagrammi della tradizione metrica66 allo scopo di indicare la lunghezza dei seg-menti mantengono la barra in un diagramma il contesto denotativo geometrico egrave prevalente e i numerali vengono percepiti come entitagrave grafiche lsquoesternersquo al discorso Va da seacute a fortiori che le lettere numerali inserite in un testo dovranno essere segnalate da barre che a loro volta non servono nelle tavole67 in quanto queste ultime sono come abbiamo visto un vero e proprio testo che perograve funge da ambiente a quello al-fabetico limitato alle titolazioni e non a caso tracciato in unrsquoopportuna lsquomaiuscola distintivarsquo allo scopo di segnalarne il carattere denotativo e non discorsivo68 Una tabella operazionale egrave invece un paratesto e quindi le barre sulle lettere numerali che rappresentano gli interi sono
64 La notazione per le lettere denotative subigrave unrsquoevoluzione (il cui risultato finale egrave descritto per sommi capi nella nota 3 supra) di cui non mette conto occuparsi qui
65 I papiri di contenuto geometrico (o astronomici ma che presentano argomenti geometrici) sono rari si vedano il PHerc 1061 (sec II aC Demetrio Lacone De geome-tria) e il PFay 9 (sec II ex Elementi I 39 e 41) Gli importanti ostraka OBerl 12002 e 12609 (sec III aC m Elementi XIII) non pongono le barre sopra le lettere denotative Per i manoscritti in maiuscola si veda ad esempio passim nel Par gr 2389 una cui riproduzione digitale egrave consultabile in rete allrsquoindirizzo httpgallicabnffrark12148btv1b8470171d o il fragmentum mathematicum Bobiense
66 Si veda ancora il ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 codex unicus dei Metrica di Erone e contenente una raccolta importante di problemi del corpus metrologico
67 Si vedano come esempio le tavole citate alle note 10 e 14 supra Discorso a parte per il segno di lsquoposto vuotorsquo si veda il punto c che segue
68 Queste regole generali vanno prese cum grano salis si dagrave naturalmente un certo dominio di variabilitagrave legato verosimilmente al grado di cultura grafica del copista nel PMich III 144 i numerali sono quasi tutti senza barra sia nel testo che nelle tabelle ope-razionali
Fabio Acerbi150
necessarie esse mancano invece sui segni convenzionali che ho descrit-to nel punto precedente e fatto rilevante sulle lettere numerali relative agli ordini sessagesimali quando esse siano identificate da uno o piugrave apici la presenza di questo segno grafico non alfabetico69 le esclude ancora una volta automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo Unrsquoultima osservazione che ci saragrave utile nel seacuteguito la descrizio-ne di una stringa di lettere lsquoagrammaticalersquo non puograve prevedere la men-zione della presenza della barra che le pertiene in quanto tale si tratta di una pratica denotativa che egrave possibile formulare soltanto ad un livello di discorso superiore sia a quello dellrsquouso che a quello della menzione70
c) Il segno di lsquoposto vuotorsquo Si noti nella tav 2b la forma ŏ per il segno di lsquoposto vuotorsquo in un ordine sessagesimale coerentemente con la propria notazione il copista del Marc gr 313 lo scioglie talvolta allrsquoin-terno del testo principale come unrsquoabbreviazione per οὐδέν laquonienteraquo Altre convenzioni di scrittura del tratto che accompagna il circoletto e che si badi bene fa parte integrante del segno di lsquoposto vuotorsquo ndash e infatti nelle tavole troviamo sempre il segno completo mentre tutti gli altri numerali sono come abbiamo visto nel punto precedente privi di barra o di apice a causa del fatto che i vari ordini sessagesimali sono univocamente determinati dalle linee di giustificazione ndash un tratto an-golare anteposto (tav 3 Lar Plut 2818 f 136v)71 o una semplice barra a sormontare (tavv 4-9) si produce in questo modo il segno 65926 che sembra essere stata la forma di base72
69 Occorre dunque supporre come testimoniano papiri e manoscritti in maiuscola che la convenzione relativa allrsquouso della barra si sia consolidata ben prima dellrsquointroduzione di segni diacritici quali accenti e spiriti
70 Si veda il punto 2 infra per maggiori dettagli sulla questione delle barre e degli apici e per le indicazioni in merito che leggiamo in Diofanto
71 Come accennato questa tavola dei sottomultipli coincide con quella descritta ed esposta nei Prolegomena Fatto molto rilevante i numerali nella prima non recano neacute barre neacute apici contrariamente a quanto accade a tutte le istanze della seconda nei manoscritti Quella del Laur Plut 2818 preserva a mio avviso la forma originaria come abbiamo visto una tavola non richiede segni aggiuntivi sulle lettere numerali
72 Si vedano come esempio ancora le tavole citate alle note 10 e 14 supra oppure per una rassegna delle forme che il segno assume nei manoscritti piugrave antichi delle Tavole facili Tihon 2011 pp 58-59 e per quelle che assume nei papiri Jones 1999 I pp 61-62 Ovviamente non possiamo leggere il segno 65926 come un omicron con una barra in quanto ο = 70 nella notazione greca e la barra egrave di rigore quando il numerale figuri allrsquointerno di un testo Occorre ammettere che si dagrave origine ad un bel corto circuito notazionale con il concepire un segno con funzione di lsquoposto vuotorsquo ma che lsquosomigliarsquo ad una lettera dellrsquoalfabeto sormontata da una barra cioegrave ad un numerale in piugrave quando il lsquoposto vuotorsquo non corrisponda ad un intero ma ad una specie sessagesimale la presenza della barra a priori indistinguibile da quella che sormonta gli interi introduce unrsquoincongruenza con la notazione a mezzo di apici vista nellrsquoitem precedente
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 151
d) Errori di copia La tabella riprodotta nella tav 2b ha una forma simmetrica ma si tratta di una forzatura il grande rettangolo in basso a destra drsquoaltronde assente nella descrizione contiene uno scolio che fa notare come lrsquoultimo resto parziale ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ͵γτνζ´´´´´ κζ´´´´´´ cioegrave 0 0 0 0 0 3357 27 siano ἔγγιστα λ´λ´ δ´δ´ ξ laquocon ottima approssimazione 60 minuti quartiraquo dove si notino gli apici semplici per indicare il pas-saggio allrsquoordinale e il raddoppiamento del sistema segno + apice per significare il plurale Lo scolio debitamente accompagnato dal segno di rimando in forma di simbolo solare egrave stato probabilmente incluso nella tabella proprio allo scopo di renderla simmetrica A sua volta un errore precedente spiega lo spazio eccessivo accordato al rettangolo contenente lo scolio il secondo massimo multiplo ŏ λβ´ ξδ´´ ριβ´´´ σιϛ´´´´ egrave trascritto anche al di sotto del risultato
Passiamo ora alla descrizione del metodo di divisione attribuito a Pappo
ἵνα οὖν ταῦτα συναχθῇ τὰ ἐκ τοῦ μερισμοῦ ὁ εἰρημένος Πάππος εὐδιατύπῳ τινὶ καὶ πρὸς τοῦτο τάξει χρησάμενος ποιεῖται τὴν τῆς συλλήψεως τοῦ ζητουμένου ἀνεύρεσιν οὕτως ἐκθέμενος γὰρ τὸν μέλλοντα μερίζεσθαι τουτέστι τὰς τξ μοίρας ἐν ἀρχῇ ἀφαιρεῖ ἀπ᾽ αὐτῶν τὸν ἐν τῇ σελίδι τυγχάνοντα ἐλάττονα τουτέστι τὸν τδ κβ´ κ´´ ὄντα τῶν ἐγγὺς ἐλασσόνων ὡς πρὸς τοὺς ἐκκειμένους διὸ καὶ γράφει αὐτὸν προγράφων αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε καὶ εὑρίσκων τὰ παρακείμενα αὐτῷ τῷ ἀπογραφέντι ἐν τῷ σελιδίῳ λεπτὰ πρῶτα ν´ συναπογράφεται παρατιθῶν αὐτοῖς τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον ἀνατείνουσαν σημαῖνον τὸ εἶδος ὅτι πρῶτα λεπτά εὑρίσκει οὖν οὕτως τὸ τῶν τξ μέρος τὸ τδ κβ´ κ´´ ὃ μεριζόμενον παρὰ τὰς τξε ιδ´ μη´´ ἡμέρας καὶ ποιοῦν τὸν ἐκ τοῦ μερισμοῦ ἀριθμὸν πρῶτα λεπτὰ ν´ καὶ τὸν λοιπὸν ἀπογραφόμενος τὸν νε λζ´ μ´´ προτάσσει αὐτοῦ τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά τάσσει δὲ καὶ ἁπλῆν τινα διατείνουσαν γραμμὴν ὡς ἀπὸ τοῦ τξ ἐπὶ τὸν ἑξῆς ἐκτεθειμένον ἐγγὺς
1
5
10
1 εὐδιατύπῳ] ZSPC εὐδιατύπωτ M 4 ἀφαιρεῖ] MZSP ἀφ ι C 5 ἐλάττονα] P comp MZSC 6 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | αφ ] αφ ε M ἀφ ZS ἀφαί P ἄφ C | ἀντὶ] om C | ἄφελε] MZSP ἄφ C 8 ἀπογραφέντι] MZSP ἐγγραφέντι C | λεπτὰ πρῶτα] P λε πρωτα SC λεπτῶν πρωτ MZ | παρατιθῶν] MZS παρατιθεὶς C et ex corr m 2 P 9 ᾱ] Z αο P α´ MS α C | ἔχον] MPC ἔχων ZS 9-10 πρῶτα λεπτά] ZP πρωτ λ´λ´ M πρωτα λε S αα λε C 11 ἡμέρας] comp codd | ἀριθμὸν] P et comp MZ καὶ C et comp S 12 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M πρωτ λεπτ(α) Z πρωτ λ εᾱ S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C | ἀπογραφόμενος] MZSP ἐγγραφόμενος C | νε λζ´] MZSP λζ νζ C 13 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | λ οι] MZSC ex λ fecit λ οι P | προσσημαῖνον] MC et προσ- comp ZS προση- P | τὸ] MZC τὰ S et fecit m 2 P 14 ἀπὸ] MZSP πρὸς C ἐλάττονα] P comp MZSC
1 εὐδιατύπῳ] εὐδιατυπώτω K 6-7 αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ] τὸ ἀφ K 8 παρατιθῶν mdash 10 λεπτά] τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ σημαίνουσαν τὸ εἶδος αὐτῶν ὅτι ᾱ λεπτά εἰσιν K | τὸ (sec)] τὰ K 12 πρῶτα] πρώτων K | τε λ ] λ οι` K | προσσημαῖνον mdash
Fabio Acerbi152
ἐλάττονα τὸν τδ κβ´ κ´´ ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις καὶ ταύτην ἐπιδεικνύουσαν τὴν τάξιν τῆς προόδου τῆς ἐκθέσεως ἧστινος κλωμένης γραμμῆς πρὸς τῷ ἐγγὺς ἐλάσσονι ἡ ἀντανάκλασις ἐπὶ τὸν λοιπὸν γέγραπται φερομένη ὡς εἴρηται διὰ τὸ εὔτακτον τῆς προκοπῆς οὕτως τε ποιήσας ἑξῆς τὸ αφ ποιῶν ὃ προσσημαίνει ὡς εἴρηται τὸ ὅτι δεῖ ἀφελεῖν ὁμοίως ἀπὸ τοῦ λοιποῦ καὶ δὴ τὸν ἐγγὺς πάλιν ἐλάσσονα ὡς πρὸς τὴν ἐν τῷ σελιδίῳ ἔκθεσιν εὑρισκόμενον λαμβάνων ἑξῆς προγράφει αὐτὸν ὄντα νδ μζ´ ιγ´´ ιβ´´´ καὶ εὑρίσκει αὐτοῖς παρακείμενα ἐν τῷ σελιδίῳ πρῶτα λεπτὰ θ´ ἅτινα καὶ αὐτὰ προσαπογράφεται σὺν τῇ παρασημειώσει τῶν πρώτων γράφων τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον τὴν ἀνατείνουσαν καὶ ὡς εἴρηται τὴν γραμμὴν πάλιν διὰ τὴν τάξιν κλωμένην κατὰ δευτέραν κλάσιν προσέλκει γινομένου τοῦ μέρους αὐτῆς τούτου παραλλήλου τῷ ἐξ ἀρχῆς
16 ante κλωμένης add ἐπὶ C 18 τε] MZP om SC | αφ ] M ἀφ ZSC ἀφαί P 19 προσσημαίνει] MS προση- ZC et ex corr P | ὅτι] ZP comp MSC 20 δὴ] MZSC διὰ fecit m 2 P 21 πρὸς] MSP et supra lineam C ex ἀπὸ fecit m 2 Z | ιγ´´] MZSP νγ´´ C 22 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M ᾱᾱ λεπτὰ Z άάα λε S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C 23 προσαπο- γράφεται] απο suprascr in comp M 24 ᾱ] ZP α´ MS α C 25 κλάσιν] MP τάξιν ZSC | τοῦ] ZSPC τούτου M 26 τούτου] τοῦ bis ZSPC sed prius erasit m 2 P τοῦ M
mdash 18 προκοπῆς] om K | τε ποιήσας] ποιήσας καὶ K | αφ ] ἀφ K 19 τὸ] om K 21 προ-γράφει] γράφει K 22 σελιδίῳ] α´ σελιδίῳ K | ἅτινα] ἃ K 23 προσαπογράφεται] ἀπογράφεται K | τῶν πρώτων mdash 26 ἐξ ἀρχῆς] om K
lsquoAllo scopo di raccogliere ciograve che risulta dalla divisione il detto Pappo utilizzando anche in questo caso una certa disposizione ben strutturata determina nel modo seguente il lsaquonumerorsaquo cercato preso nel suo insieme collocando73 in testa il lsaquonumerorsaquo che sta per essere diviso cioegrave i 360 gradi iniziali sottrae loro tra i piugrave prossimi dei lsaquonumerirsaquo minori rispetto a quelli esposti quello che si trova essere minore nella colonna (cioegrave 304 22 20) Questo egrave il motivo per cui lo trascrive scrivendogli davanti lrsquoabbreviazio-ne laquosottrraquo per laquosottrairaquo e trovando che 50 minuti primi sono collocati accanto a quello stesso lsaquonumerorsaquo che egrave stato trascritto nella colonna li trascrive al tempo stesso collocando accanto74 ad essi la lettera A con un lsaquotrattorsaquo75 sopra che significa la specie minuti primi Trova dunque in que-sto modo la parte di 360 che egrave 304 22 20 la quale divisa per 365 giorni 14 48 fa il numero lsaquoche risultarsaquo dalla divisione 50 minuti primi Trascrivendo
73 La descrizione egrave strutturata come una procedura Acerbi 201274 Il purismo del correttore del Par gr 2390 di Clostomalle nel Marc gr 314 e
dellrsquoautore della recensione bizantina impone loro di modificare la terminazione ma forme tematiche e contratte di τιθεῖν sono correnti nel greco tardivo
75 Il testo greco ha solo il participio con γραμμήν sottinteso Per il significato del participio si veda il punto 2
15
20
25
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 153
poi il resto 55 37 40 gli pone altresigrave76 a prefisso laquoReraquo che significa laquorestiraquo e dispone anche una certa linea semplice77 che va da 360 al piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori che egrave esposto di seacuteguito 304 22 20 come nello lsaquoschemarsaquo esposto linea che mostra lrsquoordine del percorso dellrsquoesposizione Questa linea spezzata lagrave dove si trova il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori egrave tracciata inflessa allrsquoindietro lsaquoersaquo punta verso il resto come egrave stato detto in vista di una progressione ordinata E cosigrave facendo prendendo di seacuteguito il laquosottrraquo che significa come egrave stato detto laquoche occorre similmente sottrarre dal re-storaquo e ovviamente prendendo di nuovo il lsaquonumerorsaquo che egrave trovato essere il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori in relazione alla disposizione nella colonna ndash 54 47 13 12 ndash lo scrive di seacuteguito e trova che 9 minuti primi sono posti loro accanto nella colonna trascrive78 anche questi con la segnaletica dei primi scrivendo la lettera A con un lsaquotrattorsaquo sopra e come egrave stato detto prolunga di nuovo la linea spezzata in vista di una buona disposizione tramite una seconda inflessione essendo questa sua parte parallela a quella inizialersquo
La descrizione continua con una serie di laquoe cosigrave viaraquo e non fa ulte-riore riferimento alla tabella
1) La forma verbale ἐξεσμένον Egrave il neutro del participio perfetto medio-passivo di ξέω lett laquopialloraquo laquolevigoraquo Si danno tre possibilitagrave si tratta di un termine canonico per quanto non altrove attestato per designare unrsquoabbreviazione oppure lrsquoautore anonimo improvvisa sul piano metaforico come se unrsquoabbreviazione non fosse altro che la paro-la completa lsquoaccorciata a colpi di piallarsquo in maniera opportuna oppure il testo egrave corrotto e srsquoimpone una correzione ad esempio τὸ ἑξῆς μένον laquociograve che sta di seacuteguitoraquo Questrsquoultima strada mi pare chiusa dal senso delle frase lrsquoabbreviazione non lsquosta di seacuteguitorsquo a niente ma anzi precede la perifrasi τὸ ἑξῆς μένον se impiegata semplicemente per rimandare al segno αφ immediatamente seguente costituirebbe un intollerabile solecismo Se accettiamo la prima di queste letture considerando quin-di lrsquoabbreviazione αφ in posizione predicativa abbiamo a che fare con
76 Rendo in questo modo il τε isolato77 La linea egrave laquosempliceraquo in quanto egrave una retta la precisazione intende evidenziare per
anticipazione il carattere lsquonon semplicersquo che essa assumeragrave alla prima inflessione quando diventeragrave una spezzata linee siffatte erano in effetti concepite dallrsquoanonimo e prima di lui da tutta la tradizione matematica greca come una singola linea spezzata nei punti drsquoinfles-sione I due segmenti paralleli menzionati al termine del passo sono orizzontali
78 Il verbo egrave al medio in variatio rispetto ai due che precedono e che seguono egrave il matematico che lsquosirsquo trascrive le cifre
Fabio Acerbi154
uno hapax semantico nella grecitagrave superstite come egrave facile verificare con una ricerca sul TLG in rete La recensione bizantina risolve il pro-blema sopprimendo semplicemente τὸ ἐξεσμένον
2) La notazione per le specie numeriche Nella terminologia matema-tica greca gli ordini sessagesimali sono εἴδη laquospecieraquo numerici essi corri- spondono agli ordini di grandezza nel nostro sistema decimale e indica-no in analogia con il caso geometrico la lsquoformarsquo che assume un numero quadrato cubo ecc Centinaia e migliaia sono quindi degli εἴδη rispet-tivamente quadrati (100 egrave il quadrato di 10) e cubi (1000 egrave il cubo di 10) sono specie numeriche ma non numeri particolari e drsquoaltronde 300 non egrave un quadrato ma 3 item dellrsquoεἶδος lsquoquadratorsquo 100 3 egrave il numerale di molteplicitagrave della specie quadrata lsquocentinaiarsquo i due 0 che seguono il 3 segnalano esattamente questo fatto che la notazione greca per gli interi non posizionale fa scomparire al livello denotativo Ciograve non vale soltan-to per i numeri interi ma anche per le loro parti i minuti secondi appar-tengono alla specie lsquoquadratorsquo in quanto 13600 egrave il quadrato di 160
La concezione appare interamente dispiegata nellrsquointroduzione degli Arithmetica diofantei79 che si rivela giova farlo rimarcare un te-stimone fondamentale per la ricostruzione della notazione matematica antica Alle specie usate in questrsquoopera vengono assegnati una denomi-nazione ed un segno convenzionale costituito dallrsquoiniziale (di ognuno dei componenti) della denominazione al quadrato o δύναμις il segno ΔΥ al κύβος il segno ΚΥ alla lsquoquarta potenzarsquo o δυναμοδύναμις il segno ΔΥΔ ecc La descrizione di tali segni egrave del tipo καὶ ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον Κ ἐπίσημον ἔχον Υ ΚΥ κύβος laquoe il suo segno egrave un Κ che ha come indice un Υ ΚΥ cuboraquo dove in accordo con quanto abbiamo visto nel punto b supra e pur nel comprensibile imbarazzo del copista della prima parte del Matritensis (o di un suo passato collega) a districarsi in questo formidabile ginepraio notazionale80 le due lettere Κ e Υ ricevono una barra mentre ΚΥ non la richiede a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον il quale ancora una volta esclude automaticamente il segno dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
79 In particolare a DOO I pp 214-62180 Nel Matr 4678 riscontriamo i seguenti fenomeni nelle poche righe a cavallo dei ff
58r-v 1) accento acuto posto su tutti i segni come se fossero abbreviazioni 2) ripetizione sistematica segnodenominazione come in ΚΥ κύβος appena letto dovuta sicuramente allrsquointrusione di glosse interlineari esplicative dei segni ndash e successivo pentimento (δύναμις e κύβος sono in effetti cancellati dalla prima mano il primo con un tratto il secondo con dei punti supra lineam poi il copista si stanca di correggere) 3) nella descrizione del segno per la δυναμοδύναμις menzione di un δέλτα δύο che saragrave molto probabilmente stato ΔΔ subito dopo nella descrizione del κυβόκυβος si legge un incongruo δύο KK
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 155
Diofanto introduce poi dei segni anche per le specie delle parti dellrsquounitagrave (le nostre frazioni) che egli chiama ὁμώνυμα μορία laquoparti omonimeraquo di cui quelle sessagesimali sono casi particolari81 Egli spie-ga appunto che le loro denominazioni sono ottenute da quelle delle specie degli interi per sinonimia passando ad un lsquoordinalersquo82 formato semplicemente aggiungendo il suffisso -στον δυναμοστόν κυβοστόν δυναμοδυναμοστόν ecc (sott μόριον) I loro segni convenzionali sono invece ottenuti da quelli per le specie degli interi aggiungendo una γραμμὴν διαστέλλουσαν τὸ εἶδος laquolinea che distingue la specieraquo83 Una linea sui segni delle specie delle parti egrave richiesta si badi bene per distinguerli dai segni di quelle degli interi come giagrave osservato questi ultimi sono giagrave lsquoagrammaticalirsquo a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον a fortiori lo saranno anche i primi Si tratta della traduzione semio-tica del passaggio dal cardinale allrsquoordinale che a livello grammaticale egrave effettuato con il suffisso -στον Che forma ha questa linea Barra o apice (Egrave cervellotico pensare a forme piugrave complesse) La domanda non ammette una risposta immediata in quanto delle specie diofantee nessuno piugrave si occupa nellrsquoantichitagrave84 Se egrave vero che la prima risposta darebbe origine ad un conflitto tra due convenzioni denotative diffe-renti la barra lsquocitazionalersquo e la barra che distingue la specie lrsquoevidenza grafica del Matritensis lascia lievemente sgomenti (ricordiamoci che giagrave i segni di base sono indebitamente dotati di un accento dal copista) Le poche occorrenze del segno per le specie delle parti85 vedono lrsquoaggiunta di uno slash di sospensione di un doppio apice inverso ndash in tutta evi-
81 Questo fatto era giagrave chiaro nellrsquoantichitagrave Teone in Alm I 10 in iA p 45310-1682 Il parallelo con i cardinali e gli ordinali relativi agli interi egrave reso esplicito da Dio-
fanto ὥσπερ δὲ τῶν ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια παρομοίως καλεῖται τοῖς ἀριθμοῖς τοῦ μὲν τρία τὸ τρίτον τοῦ δὲ τέσσαρα τὸ τέταρτον οὕτως καὶ τῶν νῦν ἐπονομασθέντων ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια κληθήσεται παρομοίως τοῖς ἀριθμοῖς laquocome le parti omonime dei numeri sono chia-mate per assonanza con i numeri di lsquotrersquo lsquolsaquounrsaquo terzorsquo di lsquoquattrorsquo lsquolsaquounrsaquo quartorsquo cosigrave le parti omonime dei numeri appena nominati saranno chiamate per assonanza con i numeriraquo (DOO I p 69-13 si noti lrsquoarticolo lsquocitazionalersquo al singolare in τοῦ τρία e τοῦ τέσσαρα) Il parallelo prosegue anche al livello dei segni che rappresentano queste specie come vedremo tra un attimo
83 Diofanto Arithmetica prefazione in DOO I p 620-21 un passaggio maltrattato in questa edizione occorre espungere il participio ἔχον senza introdurre segni ulteriori oppure eliminare un precedente ἐπί come fa un correttore del Matritensis f 58v
84 Unica parzialissima eccezione lrsquoaccenno di Teone menzionato nella nota 81 supra85 Al f 59r e per di piugrave nel margine per sanare un lungo saut du mecircme au mecircme La
collocazione in margine egrave il motivo per cui troviamo una notazione abbreviata nel resto del trattato il primo copista scioglie tutti i segni prendendoli per abbreviazioni mentre il secondo elimina sistematicamente il tratto aggiuntivo delle specie delle parti dellrsquounitagrave Drsquoaltronde egli scrive ad esempio ΔΥ invece di ΔΥ ed egrave quindi indotto a porre la barra al di sopra della stringa di lettere risultante (passim ma si veda ad esempio il f 72r)
Fabio Acerbi156
denza il compendio per la desinenza -ον accentata il copista interpreta il segno come unrsquoabbreviazione ndash e di una barra a sormontare lo Υ Potremmo forse interpretarlo come il segno di contrazione del grafema -στ- lrsquounico tassello mancante in unrsquoabbreviazione come ad esempio (δυναμοδυναμο)(στ)(ὸν) ma uno scolio di prima mano al f 58v rela-tivo alle specie degli interi inficia questrsquoipotesi esse sono dotate di slash di sospensione accento acuto in un caso del compendio canonico per la terminazione -ον hellip ma tutti gli Υ a esponente sono a loro volta sormontati da una barra
Meno legata al singolo manoscritto ma nondimeno non uniforme si presenta la pratica di notazione dei segni che rappresentano gli enti numerici sessagesimali86 da una parte sta lrsquoevidenza del testo dei Pro-legomena e delle sue tabelle apici ndash drsquoaltronde come abbiamo visto la notazione universalmente impiegata per i numerali ordinali e per le fra-zioni unitarie ndash dallrsquoaltra sta lrsquoevidenza del testo dellrsquoAlmagesto in tutti i manoscritti piugrave antichi e lo stesso si dica del commentario teonino a questrsquoopera o del suo lsquoGrande commentariorsquo alle Tavole facili e dei testi astronomici su papiro barre87 Sembra insomma che la nostra docu-
86 Sia le molteplicitagrave che le specie ahimeacute entrambe rappresentate da lettere dellrsquoalfabeto Come osservato allrsquoinizio della sezione 3 ci sono in effetti due tipi di lettere numerali in gioco se facciamo astrazione da apici o barre lsquo4 minuti secondirsquo si trova scritto δ β la prima lettera numerale denota la molteplicitagrave degli item di una certa specie la se-conda la specie nei Prolegomena entrambe sono accompagnate da un doppio apice il che rende inutile la presenza delle seconde Si noti che la descrizione della tabella non fa parola della notazione da usare per le lettere numerali che denotano la molteplicitagrave barre o apici e quanti apici hellip In questo caso fa interamente fede la tabella cioegrave la pratica grafica condivisa instauratasi non egrave chiaro quando
87 I manoscritti piugrave antichi dellrsquoAlmagesto sono menzionati nella nota 10 supra quelli dei due commentarii teonini sono il Laur Plut 2818 e il celeberrimo Vat gr 190 (sec IX in Euclide Elementi Data Teone lsquoGrande commentariorsquo) per la notazione dei pa-piri astronomici si veda Jones 1999 II passim La notazione non sembra lsquoinquinatarsquo dalla pratica dei copisti bizantini e pare dipendere soltanto dalla data di composizione Tro-viamo ad esempio barre sopra tutti i numerali di molteplicitagrave (interi o sessagesimali) nel frammento di un commentario alle Tavole facili contenente un calcolo relativo al 24 aprile 213 (Par gr 2841 sec XIII ex-XIV in oltre al frammento ai ff 32r l 11-34v l 23 contiene Arato Phaenomena ed Efestione Apotelesmatica edizione in Jones 1990) Nel commentario alle Tavole facili composto ca 610-617 ed attribuito a Stefano di Alessandria la situazione egrave la seguente (Jean Lempire per litteras per lrsquoedizione si veda Lempire 2014 ho controllato il Vat gr 304 ff 135r-171v sec XIV am contiene in aggiunta Teone in Almagestum I-II lsquoPiccolo commentariorsquo alle Tavole facili Diofanto Arithmetica e De polygo-nis numeris varia astronomica tabulae) barre sopra gli interi sporadicamente rimpiazzate da apici apici sopra le parti sessagesimali in numero uguale alla denominazione doppio () apice per le frazioni unitarie Sono impiegate barre sopra gli interi e apici sopra le parti sessagesimali nei manoscritti principali di tutti i trattati di introduzione allrsquoAlmagesto o comunque di argomento logistico redatti in epoca bizantina Giorgio Pachimere (1242-ca 1310) Quadrivium (autografo nel manoscritto Roma Biblioteca Angelica gr 38 [RGK III nr 115] si veda Tannery ndash Steacutephanou 1940 per lrsquoedizione) Teodoro Metochita (1270-
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 157
mentazione si faccia testimone di un cambio notazionale avvenuto nel periodo intercorrente fra Teone (sec IV pm) e la scuola alessandrina di Ammonio e dei suoi allievi (sec VI in) e probabilmente innescato da questrsquoultimo ambiente lrsquoaspetto paradossale egrave che nello stesso codice si rintraccino due notazioni differenti per gli enti numerici sessagesimali e lrsquouna (apici) sia adottata sistematicamente e coerentemente in uno scritto (i Prolegomena) che si presenta esattamente come unrsquointroduzione tecnica alla pratica numerico-algoritmica del trattato (lrsquoAlmagesto) in cui egrave adottata lrsquoaltra (barre che ritroviamo senza eccezioni anche negli scolii)
Torniamo ai Prolegomena la descrizione del segno da porre a fianco di ogni singolo quoziente parziale e denotante la sua specie numerica (minuti primi minuti secondi ecc) solleva tre problemi
Primo problema Ci vuole una barra o un apice su τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquola lettera A [hellip] che significa la specieraquo quando lo scriviamo nella tabella Tutta la nostra discussione precedente fa pro-pendere per lrsquoapice e si ricordi anche la forma verbale ἀνατείνουσαν che suggerisce qualcosa che si lsquoestende verso lrsquoaltorsquo (la mia traduzione egrave volutamente neutra) se fosse apposta una barra la cosa dovrebbe passare
1231332) Compendium astronomicum (copia lsquoautorizzatarsquo coeva nei Vat gr 182 e 181 da parte del copista che integrograve le parti mancanti del Par gr 2389 [ff 207-210 255-270 374-375] Bianconi 2005a pp 425-427 Peacuterez Martiacuten 2008 p 436 e n 177) Teodoro Meliteniota (morto lrsquo831393) Tribiblos astronomica (autografo nel Vat gr 792 si vedano Leurquin 1991 per unrsquoanalisi del manoscritto Leurquin 1990 per lrsquoedizione) una com-pilazione anonima (per cui ho consultato il Par gr 2396 ff 87r-92v limitatamente a questi fogli manu Costantino Trivoli [RGK II nr 318 ma ovviamente questo codice non vi egrave segnalato] terzo quarto del XV secolo il resto del codice annotato da Niceforo Gregora egrave di etagrave planudea e parzialmente [ff 33v-76v] un autografo di Planude stesso contiene Teone in Almagestum I II IV Mondrain 2002 il codice va completato ndash limitatamente a stralci dei libri VIII-X XII-XIII del commentario teonino la cui parte intermedia si egrave persa ndash con 26 carte [ff 123-147] inserite nel Vat gr 1087 anchrsquoesso contenente anno-tazioni di Gregora Rome 1927 per la figura del copista dei ff 77r-86r del Par gr 2396 e dei ff appena nominati del Vat gr 1087 un anonimo collaboratore di Gregora si veda in ultimo Bianconi 2006a pp 147-151) si veda anche il calcolo effettuato da Niceforo Gre-gora (12921295-13581361) dellrsquoeclisse di sole del 16 luglio 1330 (attestata unicamente ai ff 1r-8v della miscellanea astronomica Marc gr 325 databile ca 1324-1329 in parte vergata e ovunque fittamente annotata da Gregora stesso edizione del testo in Mogenet et al 1983 annotazioni di Gregora elencate in Bianconi 2005a p 413) Unrsquoeccezione apparente il lsquoPiccolo commentariorsquo di Teone alle Tavole facili le parti sessagesimali sono segnalate da apici (ad esempio nel Vat gr 175 vergato da Giovanni Catrario e completato nel 1321-1322 sulla figura di Catrario si vedano in ultimo Bianconi 2005b pp 141-156 e 2006b) lrsquoopera egrave antica ma la sua tradizione non rimonta oltre la fine del XIII secolo a parte un frammento nel Leiden BPG 78 ff 156r-161v (minuscola del IX-X secolo) e in effetti in questo manoscritto tutti i numerali di molteplicitagrave sono sormontati da barre Unrsquoeccezione effettiva egrave il De hypotesibus planetarum nel Vat gr 1594 barre sugli interi e apici sulle parti sessagesimali
Fabio Acerbi158
sotto silenzio e la presenza dellrsquoapice la rende inutile88 Si tratta della stessa convenzione diofantea e coincide ancora con la notazione per i numerali ordinali e per le frazioni unitarie che egrave corrente nei mano- scritti matematici greci per questo motivo non percheacute la descrizione sia particolarmente perspicua nessuno dei copisti della recensione an-tica ha incertezze apici Ma questi apici si rintracciano soltanto sulle indicazioni di specie non contemplate dalla descrizione che sono ante-poste ai resti parziali a fianco dei quozienti parziali i segni di specie sono invece trasformati in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordi-nali corrispondenti del tipo πρωτ tavv 5 e 7b-8 Il recensore bizantino taglia invece la testa al toro elimina dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali elimina la seconda menzione della laquolet-tera Araquo contestualmente allrsquoazzeramento dellrsquoespediente della linea a zig-zag (si veda il punto seguente) modifica la descrizione che contiene la prima menzione in quella dellrsquoapice associato direttamente ai nume-rali di molteplicitagrave riciclando addirittura lrsquoalpha per adibirlo a desi-gnare un numero cardinale (come sorprendersi) τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ laquoponendo al di sopra di essi [scil dei 50 minuti primi] 1 solo lsaquoaccentorsaquo acutoraquo La scelta del recensore egrave assennata che rechi una barra o un apice in una tabella un alpha denota un numero non un numero drsquoordine
Secondo problema da tenere ben distinto dal precedente Cosa ci vuole sul segno α per la lettera alpha menzionata nella frase τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquolettera A [hellip] che significa la specieraquo89 Unrsquooc-chiata allrsquoapparato critico rivela una bella incertezza nei manoscritti Z scrive sempre ᾱ e in un caso lo fa anche P MS optano sempre per α´ C per α P scrive nellrsquoaltro caso αο Per quanto solo la barra sia congrua con il senso della frase in quanto la lettera alpha egrave qui menzionata (si tratta di un oggetto che compare nella tabella) e non cambia niente se essa egrave accompagnata dal suo nome di genere στοιχεῖον ad un livello grafico lrsquoincertezza fra il segno ᾱ che denota laquola lettera αraquo e il segno α´ (o lrsquoabbreviazione αο) per una forma di πρῶτος egrave per piugrave versi giustificata
88 Detto in altri termini la barra egrave uno strumento grafico non matematico e quindi la sua presenza non va segnalata mentre un apice lo egrave e la sua presenza lo deve
89 Notare che in questa frase il primo α non vuole la barra (egrave menzionato allrsquointerno di una frase che impiega convenzioni moderne) il secondo sigrave (idem ma con convenzioni antiche) ndash e nella traduzione la scelta di denotarlo con A (senza virgolette) e non con lsquoArsquo (con virgolette) egrave del tutto arbitraria ndash si noti inoltre che le necessarie precisazioni laquosenzacon virgoletteraquo mostrano che le lingue moderne palesano difficoltagrave analoghe a quelle del greco antico per quanto riguarda i livelli denotativi in ambito metadiscorsivo per non usare le due parentetiche avrei dovuto scrivere rispettivamente lsquoArsquo e lsquolsquoArsquorsquo (doppie virgolette semplici)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 159
ᾱ coincide con il numerale 1 α egrave la prima lettera dellrsquoalfabeto ed inoltre α´ egrave esattamente quello che va scritto nella tabella Potremmo dirci che il sostantivo στοιχεῖον chiude la questione la sua presenza congiunta ad un ipotetico α´ renderebbe la descrizione ridondante o inappropriata90 Ma a parte il fatto che α egrave proprio τὸ πρῶτον στοιχεῖον il segno α´ cat-tura in fondo il cuore della descrizione di uno στοιχεῖον ἔχον lsaquoγραμμὴνrsaquo ἀνατείνουσαν
Terzo problema Lrsquoautore dei Prolegomena che si arresta allrsquoesem-pio dei minuti primi non dice quanti apici occorre mettere sulle lettere numerali che identificano gli ordini superiori al primo se uno soltanto come nel caso diofanteo e delle frazioni unitarie o in numero uguale alla loro denominazione (cioegrave pari al numero denotato dal numerale stesso su cui vanno posti) come effettivamente avviene nei mano-scritti dei Prolegomena La tabella egrave quindi sottodeterminata dalla sua descrizione anzi in un certo senso prende il sopravvento su di essa la pratica di marcare i numerali di molteplicitagrave con gli apici che compe-tono allrsquoordine cui appartengono viene trasferita ai segni per gli ordini stessi per supplire ad una descrizione carente di questi ultimi E la tabella egrave sottodeterminata dalla descrizione in quanto egrave la descrizione di una tabella reale ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις laquocome nello lsaquoschemarsaquo espostoraquo leggiamo a un certo punto del testo
3) La linea a zig-zag Non possiamo che applaudire a questo geniale espediente grafico lo troviamo messo in opera solo nel Marc gr 313 Per quanto lrsquoautore non faccia parola di ciograve nel corso della sua descrizione la linea spezzata egrave intesa dover lsquosaltarersquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue Il copista del codice marciano effettua correttamente due salti nella prima delle sue tabelle (tav 4) ma inserisce un lsquodentersquo in piugrave in quella che considera corretta (tav 5) La linea a zig-zag egrave incompatibile con la presenza di linee di giustificazione nella tabella che in effetti mancano nel Marc gr 313 ciograve induce gli errori di allineamento dei primi 5 quozienti parziali di cui egrave vittima il copista Probabilmente per questo motivo in nessuno degli apografi del Vat gr 1594 la linea a zig-zag figura nella tabella inquadrata come si conviene da una (doppia) cornice esterna e le cui colonne sono appunto separate da linee verticali (tav 7b Vat gr 184 f 17v e tav 8 Par gr 2390 f 9v cui egrave sostanzialmente identica la tabella del Marc gr 314 che si trova
90 Trascuro lrsquoabbreviazione αο = πρῶτος percheacute la desinenza non egrave quella richiesta neacute nella frase (egrave richiesto πρῶτον) neacute nella tabella (πρῶτα)
Fabio Acerbi160
al f 248r ndash ma la mancanza di linee orizzontali causa un gigantesco pa-sticcio nel codice vaticano) Alla recensione bizantina che dipende per il suo testo di base dal Vat gr 1594 e quindi non trova la linea a zig-zag nella tabella non resta che sopprimere la sua descrizione ndash ma proprio per questo motivo e finalmente diventa possibile tracciare un apparato completo di linee di giustificazione (tav 9 Laur Plut 89 sup 48 f 14v) Dato che la descrizione di Teone di questo procedimento di divi-sione non fa cenno allrsquoesistenza della linea a zig-zag viene da chiedersi se essa non costituisca un espediente escogitato dallrsquoautore dei Prolegomena per vivacizzare la procedura originale di Pappo
4) Discrepanze tra descrizione e tabella Il gioco delle minime va-rianti mostra che la divisione era stata eseguita (e trasmessa) corret-tamente tutti i valori numerici sono esatti La tabella nel Marc gr 313 presenta perograve alcune discrepanze con la propria descrizione Essa omette (ma non nella versione lsquoscorrettarsquo lrsquoomissione non si riscontra neanche nel Par gr 2390) il segno per laquorestoraquo di fronte ai resti par-ziali ma aggiunge lrsquoindicazione della loro specie Essa trasforma invece come abbiamo visto le indicazioni di specie che seguono i quozienti parziali in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordinali corri-spondenti La descrizione prevede di chiudere la tabella con il risultato καὶ συνάγων ἅπαντα τὰ ἐκ τῶν μερισθέντων μερῶν λεπτὰ σημειοῦται ὑπὸ πάντας οὕτως γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoe raccogliendo tutti i minuti che provengono dalle parti divise lsaquoPapporsaquo nota sotto tutto cosigrave Ris 0 59 8 17 13 12 31raquo ma sotto la tabella tutta la tradizione ci consegna qualcosa di piugrave articolato ὁ ζητούμενος καθ᾽ ὃν μερίζεται ὁ τξε ιδ´ μη´´ π(αρὰ) τὸν τξ γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoil lsaquonumerorsaquo cercato secondo cui 365 14 48 egrave diviso per 360 risulta 0 59 8 17 13 12 31raquo frase che del resto contiene due errori lrsquoinversione del dividendo e del divisore e la confusione tra segno convenzionale (iuxta descrizione) e abbreviazione (come nella frase) nel caso di γι Oltre ad eliminare la linea a zig-zag91 la recensione bizantina sopprime dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali e modifica come abbiamo visto al punto 2 le loro descrizioni in quelle di apici associati diretta-mente ai numerali di molteplicitagrave
91 Le due righe che nella recensione di base contengono solo i resti parziali minori di 160 del divisore ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue sono in parte completate con lrsquoindicazione abbreviata ἀνάλ(υσις) laquoanalisiraquo il termine greco per questa procedura di riduzione In un sussulto di ipercorrettismo matematico tali resti parziali ridotti non sono preceduti dal segno per laquorestoraquo come nel Par gr 2390 ma da quello per laquorisultatoraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 161
Gli esempi che abbiamo discusso mostrano come i problemi di notazione pesino e non poco sullrsquoespressione discorsiva di un algorit-mo matematico lrsquoente di riferimento per lsquoformularersquo il procedimento di divisione fu considerata la tabella cioegrave un oggetto la cui costitu-zione egrave legata piugrave ad una pratica grafica che a considerazioni logico- algoritmiche non la sua descrizione che in effetti finisce per determi-nare la tabella in maniera non univoca Di questa sottodeterminazione si fa testimone la traiettoria che abbiamo cercato di seguire nelle mani di copisti e revisori il procedimento di divisione si modifica a volte in aspetti secondari a volte in punti piugrave sostanziali ndash fino a rendere neces-saria una radicale revisione della sua descrizione per renderla conforme alla tabella ndash in ogni caso mai per ragioni squisitamente matematiche92
Abstract
The article presents and discusses in detail two passages from the anonymous Prolegomena to the Almagest a VIth century primer to the elementary procedures of calculation needed in Ptolemyrsquos Almagest In the two passages we may follow the complex interplay between mathematical notation the auctor who employed and described it the tachygrapher who transcribed it in vivo copyists who reproduced it correctors who modified it Along this path misgivings and errors arise in the transmission of abbreviations and paratextual units such as diagrams tables operational schemes
Fabio AcerbiCNRS UMR8560 Centre Alexandre Koyreacute
fabacerbigmailcom
92 Sono grato a Daniele Bianconi Lucio del Corso Jean Lempire per alcune preziose indicazioni
AOO = Archimedis opera omnia cum commentariis Eutocii ed J L Heiberg I-III Lipsiae 1910-1915
DOO = Diophanti Alexandrini opera omnia cum Graecis commentariis ed P Tannery I-II Lipsiae 1893-1895
GC = Le laquoGrand Commentaireraquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Mogenet ndash A Tihon I-III Cittagrave del Vaticano 1985-1999
iA = Commentaires de Pappus et de Theacuteon drsquoAlexandrie sur lrsquoAlmageste ed A Rome I-III con paginazione continua Cittagrave del Vaticano 1931-1943
HOO = Heronis Alexandrini opera quae supersunt omnia ed G Schmidt ndash L Nix ndash W Schmidt ndash H Schoene ndash J L Heiberg I-V Lipsiae 1899-1914
PC = Le ldquoPetit Commentairerdquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed A Tihon Cittagrave del Vaticano 1978
POO = Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia ed J L Heiberg I-II in 3 parti Lipsiae 1898-1907
RGK = Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600 I Handschriften aus Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln II Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs und Nachtraumlge zu den Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln III Handschriften aus Bibliotheken Roms mit dem Vatikan A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg unter Mitarbeit von D Harlfinger und P Eleuteri B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln Wien 1981-1997 (Oumlsterreichische Akademie der Wissenschaften Veroumlffentlichungen der Kommission fuumlr Byzantinistik III1-3 A-C)
Sigla
Acerbi 2010 = F Acerbi Il silenzio delle sirene La matematica greca antica Roma 2010
Acerbi 2012 = F Acerbi I codici stilistici della matematica greca dimostrazioni procedure algoritmi laquoQUCCraquo 1012 (2012) pp 167-214
Acerbi et al 2010 = F Acerbi ndash N Vinel ndash B Vitrac Les Proleacutegomegravenes agrave lrsquoAlmageste Une eacutedition agrave partir des manuscrits les plus anciens Introduction geacuteneacuterale ndash Parties I-III laquoSCIAMVSraquo 11 (2010) pp 53-210
Agati 1992 = M L Agati La minuscola laquoBouleteacuteeraquo Cittagrave del Vaticano 1992
Belger 1881 = C Belger Ein neues Fragmentum mathematicum Bobiense laquoHermesraquo 16 (1881) pp 261-284
Bianconi 2005a = D Bianconi La biblioteca di Cora tra Massimo Planude e Niceforo Gregora Una questione di mani laquoSampTraquo 3 (2005) pp 391-438
Bianconi 2005b = D Bianconi Tessalonica nellrsquoetagrave dei Paleologi Le pratiche intellettuali nel riflesso della cultura scritta Paris 2005
Bianconi 2006a = D Bianconi Le pietre e il ponte ovvero identificazioni di mani e storia della cultura laquoBizantinisticaraquo 8 (2006) pp 135-181
Bianconi 2006b = D Bianconi Qualcosa di nuovo su Giovanni Catrario laquoMEGraquo 6 (2006) pp 69-91
Cavallo 1977 = G Cavallo Funzione e strutture della maiuscola greca tra i secoli VIII-XI in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Colloque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 95-137
Cereteli 1904 = G F Cereteli De compendiis scripturae codicum Graecorum praecipue Petropolitanorum et Mosquensium anni nota instructorum Sankt-Petersburg 1904
De Gregorio 2000 = G De Gregorio Materiali vecchi e nuovi per uno studio della minu-scola greca fra VII e IX secolo in G Prato (a cura di) I manoscritti greci tra riflessione e dibattito Atti del V Colloquio Internazionale di Paleografia Greca Cremona 4-10 ottobre 1998 Firenze 2000 pp 83-151
Follieri 1977 = E Follieri La minuscola libraria dei secoli IX e X in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Col-loque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 139-165
Fonkič 2005 = B Fonkič Venecianskaia rukopisrsquo laquoAlrsquomagestaraquo Ptolemeja (Marc gr 313690) o datirovke i proischoždenii kodeksa laquoVDIraquo s III 254 (2005) pp 162-167
Fowler 1999 = D H Fowler The Mathematics of Platorsquos Academy A New Reconstruction Second Edition Oxford 1999
Bibliografia
Fabio Acerbi164
Gerstinger ndash Vogel 1932 = H Gerstinger ndash K Vogel Eine stereometrische Aufgaben-sammlung im Papyrus Graecus [sic] Vindobonensis 19996 laquoMitteilungen aus der Papy-russammlung der Nationalbibliothek in Wienraquo Neue Serie Folge 1 Griechische literarische Papyri 1 Wien 1932 pp 11-76
Heiberg 1927 = Mathematici Graeci Minores ed J L Heiberg Kjoslashbenhavn 1927
Hultsch 1876-1878 = Pappi Alexandrini Collectionis quae supersunt ed F Hultsch I-III Berlin 1876-1878
Janz 2003 = T Janz The Scribes and the Date of the Vat gr 1291 in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae X Cittagrave del Vaticano 2003 pp 159-180
Jones 1990 = Ptolemyrsquos First Commentator ed A Jones Philadelphia 1990
Jones 1999 = Astronomical Papyri from Oxyrhynchus ed A Jones I-II Philadelphia 1999
Jones 2005 = A Jones Ptolemyrsquos Canobic Inscription and Heliodorusrsquo Observation Reports laquoSCIAMVSraquo 6 (2005) pp 53-97
Lempire 2014 = Steacutephanos drsquoAlexandrie Le commentaire aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Lempire Louvain 2014
Leurquin 1990 = Theacuteodore Meacuteliteacuteniote Tribiblos astronomique Livre I ed R Leurquin Amsterdam 1990
Leurquin 1991 = R Leurquin Un manuscrit autographe de la Tribiblos Astronomique de Theacuteodore Meacuteliteacuteniote le Vaticanus graecus 792 laquoScriptoriumraquo 45 (1991) pp 145-162
Maas 1927 = P Maas Griechische Palaeographie in A Gercke ndash E Norden (hrsg von) Einleitung in die Altertumswissenschaft I9 Leipzig 1927 pp 69-80
Martinelli Tempesta 2010 = S Martinelli Tempesta Il codice Milano Biblioteca Am-brosiana B 75 sup (gr 104) e lrsquoevoluzione della scrittura di Giovanni Scutariota in A B Garciacutea ndash I Peacuterez Martiacuten (ed by) The Legacy of Bernard de Montfaucon Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting Proceedings of the Seventh Inter-national Colloquium of Greek Palaeography Madrid-Salamanca 15-20 September 2008 Turnhout 2010 pp 171-186
Mazzucchi 1994 = C M Mazzucchi Leggere i classici durante la catastrofe (Costantino-poli maggio-agosto 1203) le note marginali al Diodoro Siculo Vaticano gr 130 Parte prima stratigrafia laquoAevumraquo 68 (1994) pp 164-218
Mioni 1976 = E Mioni Bessarione scriba e alcuni suoi collaboratori in Miscellanea marcia-na di studi bessarionei Padova 1976 pp 263-323
Mioni 1985 = Codices graeci manuscripti Bibliothecae Divi Marci Venetiarum II Thesaurus Antiquus Codices 300-625 recensuit E Mioni Roma 1985
Mogenet 1962 = J Mogenet Une scholie ineacutedite du Vat gr 1594 sur les rapports entre lrsquoastronomie arabe et Byzance laquoOsirisraquo 14 (1962) pp 198-221
Mogenet et al 1983 = Niceacutephore Greacutegoras Calcul de lrsquoeacuteclipse de soleil du 16 juillet 1330 ed J Mogenet ndash A Tihon ndash R Royez ndash A Berg Amsterdam 1983
Mondrain 2002 = B Mondrain Maxime Planude Niceacutephore Greacutegoras et Ptoleacutemeacutee laquoPa-laeoslavicaraquo 10 (2002) pp 312-322
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 165
Mondrain 2004 = B Mondrain Lrsquoancien empereur Jean VI Cantacuzegravene et ses copistes in A Rigo (a cura di) Gregorio Palamas e oltre Studi e documenti sulle controversie teologiche del XIV secolo bizantino Firenze 2004 pp 249-296
Mondrain 2007 = B Mondrain Les eacutecritures dans les manuscrits byzantins du XIV e siegravecle Quelques probleacutematiques laquoRSBNraquo n s 44 (2007) pp 157-196
Peacuterez Martiacuten 2006 = I Peacuterez Martiacuten Maxime Planude et le Diophantus Matritensis (Madrid Biblioteca Nacional ms 4678) un paradigme de la reacutecupeacuteration des textes anciens dans la ldquorenaissance paleacuteologuerdquo laquoByzantionraquo 76 (2006) pp 433-462
Peacuterez Martiacuten 2008 = I Peacuterez Martiacuten El lsquoestilo Hodegosrsquo y su proyeccioacuten en las escrituras constantinopolitanas laquoSampTraquo 6 (2008) pp 389-458
Perria 1991 = L Perria Scrittura e ornamentazione nei codici della laquocollezione filosoficaraquo laquoRSBNraquo n s 28 (1991) pp 45-111
Rollo 2012 = A Rollo LrsquoArchimede di Giorgio Valla in V Fera ndash D Gionta ndash A Rollo (a cura di) Archimede e le sue fortune Atti del Convegno di Siracusa-Messina 24-26 giugno 2008 Messina 2012 pp 99-147
Rome 1927 = A Rome Membra disjecta laquoRBenraquo 39 (1927) pp 187-188
Rome 1938 = A Rome Un manuscrit de la bibliothegraveque de Boniface VIII agrave la Meacutediceacuteenne de Florence laquoACraquo 7 (1938) pp 261-268
Ronconi 2013 = F Ronconi La collection philosophique un fantocircme historique laquoScripto-riumraquo 67 (2013) pp 119-140
Tannery ndash Steacutephanou 1940 = Quadrivium de Georges Pachymegravere ed P Tannery ndash E Steacutephanou Cittagrave del Vaticano 1940
Tihon 2011 = Πτολεμαίου Πρόχειροι Κανόνες Les Tables faciles de Ptoleacutemeacutee vol Ia Tables A1-A2 ed A Tihon Leuven 2011
Traube 1907 = L Traube Nomina Sacra Versuch einer Geschichte der christlichen Kuumlrzung Muumlnchen 1907
Vogel 1936 = K Vogel Beitraumlge zur griechischen Logistik laquoSBAWraquo Mathematisch-natur-wissenschaftliche Abteilung Jahrgang 1936 pp 357-472
Wouters 1979 = A Wouters The Grammatical Papyri from Graeco-Roman Egypt Contri-butions to the Study of the lsquoArs Grammaticarsquo in Antiquity Brussel 1979
F ACERBI Tav 1
b Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 65r
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 284 f 160r
F ACERBITav 2
b Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 13r
a Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 19v
F ACERBI Tav 3
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 136v
F ACERBITav 4
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17r
F ACERBI Tav 5
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17v
F ACERBITav 6
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 7v
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 135
prime due moltiplicazioni34 i secondi alla bontagrave dellrsquoapprossimazione ottenuta35 Ogni gruppo di operazioni che chiude unrsquounitagrave esegetica ed egrave seguito dalla citazione che apre la successiva egrave trascritto come se facesse parte del testo a tutta pagina e preceduto dallrsquoindicazione οἱ δὲ πολλαπλασιασμοὶ ὑπόκεινται laquole moltiplicazioni sono poste qui sottoraquo Questi due fatti suggeriscono che tutte le operazioni cui Eutocio non fa alcun riferimento nel corpo del suo commentario siano unrsquoaggiunta editoriale risalente a Isidoro di Mileto che si occupograve della revisione del testo36
Gli incolonnamenti esatti sono invece necessari quando siano moltiplicati numeri con parti non intere espresse nel sistema sessage-simale in quanto la somma finale dei prodotti parziali va effettuata ordine per ordine Tale somma eccederagrave di norma il valore di 60 per un ordine dato nella tabella occorre pertanto trovare posto anche per i riporti che vanno sommati ai prodotti parziali dellrsquoordine preceden-te e quindi incolonnati con essi I testi ci offrono alcuni esempi di tabelle operazionali moltiplicative di questo tipo Teone afferma espli-citamente che la prima moltiplicazione che va a descrivere ha una rap-presentazione tabellare la cui disposizione ritroviamo pesantemente ingarbugliata nel Laur Plut 2818 f 35r37 Alla seconda occorrenza di una moltiplicazione eseguita (tav 1b Laur Plut 2818 f 65r) gli incolonnamenti sono meglio rispettati anche se il risultato finale egrave fatto erroneamente slittare di un posto verso destra i riporti (con un errore) si trovano nella penultima riga38 Nei Prolegomena ad Alma-gestum alcune moltiplicazioni sono accompagnate da tabelle quella meglio attestata egrave associata alla moltiplicazione di 67 4 55 per se stesso (sezione i nel riassunto fornito supra) ed egrave descritta additando sempli-cemente ad un ente materiale oramai inaccessibile forse tracciato in loquendo lsquoalla lavagnarsquo
34 Come λοιπὸν τὸ ἀπὸ ΕΓ laquoresta quello su ΕΓraquo seguito dal risultato della sottrazione di due quadrati
35 Come λείπει ἄρα μο β εἰς τὸ ἀκριβές laquomancano quindi 2 u(nitagrave) al risultato esattoraquo36 Si legga la sottoscrizione spuria ad AOO III p 26010-1237 Si legga la frase ἐκτίθεμαι αὐτὴν καὶ πάλιν αὐτὴν ὑφ᾽ αὑτὴν ὡς ὑπογέγραπται laquolo [scil il
valore del lato da moltiplicare per se stesso] dispongo lsaquouna voltarsaquo e di nuovo al sotto di se stesso come trascritto qui sottoraquo in iA p 45817 Il Laur Plut 2818 (Teone e Pappo Commentaria in Almagestum) egrave uno dei piugrave antichi manoscritti in minuscola sicuramente assegnabile alla prima metagrave del IX secolo (Follieri 1977 p 144 n 23 Maas 1927 p 76 n 17 riteneva che fosse piugrave antico del Tetraevangelo Uspenskij) per una sua analisi si veda Rome 1938
38 In nessuno dei due casi i numerali di molteplicitagrave sono segnalati con apici sono tutti sormontati da una barra si veda la sezione 4 punto b
Fabio Acerbi136
προκείσθω δὶς τὸ μῆκος αὐτῆς ὀφεῖλον τὴν τάξιν τοῦ κατὰ τοὺς πολλαπλασιασμοὺς κανόνος ἀποδοῦναι καὶ ἐκκείσθω ἐπὶ σελιδίων διαγεγραμμένων οὕτω καὶ δὴ αὐτῆς ἐφ᾽ ἑαυτὴν πολ-λαπλασιασθείσης γεγονέτωσαν τὰ ἐν τοῖς οἰκείοις σελιδίοις εἴδη ταῦτα δὴ συναγόμενα καθ᾽ ἣν ὑπεδείξαμεν τάξιν ποιήσει τὰς ὑπογεγραμμένας μοίρας ἢ καὶ λεπτά τινα εἴσι ͵δυϙθ νθ´ ιδ´´ ι´´´ κε´´´´ ὡς λείπειν τοῦ ἐπιμερισθῆναι ŏ ŏ με´´ μθ´´´ λε´´´´
che sia prescritto che la sua lunghezza debba figurare due volte nella disposizione della tavola delle moltiplicazioni e che lsaquoquestrsquoultimarsaquo sia disposta su colonne delimitate da linee cosigrave mdash E pertanto una volta moltiplicato lsaquoil latorsaquo per se stesso che le specie trovino posto nelle colonne appropriate quelle che vengono cosigrave raccolte secondo la disposizione che abbiamo indicato produrranno dunque i gradi o anche i minuti qui sotto trascritti 4499 59 14 10 25 in modo che dalle divisioni successive resti39 0 0 45 49 35
La tabella associata (tav 2a Marc gr 313 f 19v) contiene una sola svista grossolana reca 51 invece di 55 in ognuno dei due fattori posti affiancati sopra di essa Al di sotto preceduto dal segno convenzionale per ὁμοῦ egrave collocato il risultato incongruamente sfalsato di un paio di colonne e con la lettera numerale ͵δ priva di barra sormontante in-naturalmente disconnessa da υϙθ I riporti sono indicati dai numerali ι ρκγ´ η´´ ν´´´ posti al fondo delle prime quattro colonne Il calcolo egrave corretto in ogni sua parte
Il clou in questo piccolo spaccato delle interazioni testo-paratesto matematico risiede nella descrizione contenuta nei Prolegomena della disposizione tabellare di due procedimenti di divisione il primo ano-nimo e quindi da supporre tradizionale il secondo piugrave efficiente ed attribuito al matematico del IV secolo Pappo
Il primo metodo di divisione egrave sostanzialmente analogo a quello che usiamo attualmente Dividendo e divisore questrsquoultimo preceduto da un segno su cui ritorneremo nella prossima sezione sono posti uno sotto lrsquoaltro intervallati da una riga inizialmente vuota Primo passo viene reperito il massimo multiplo del divisore che sia minore del di-videndo esso viene trascritto sotto il dividendo nella prima lsquocasellarsquo della riga vuota recante in testa un segno per laquosottrairaquo il fattore mol-tiplicativo (o quoziente parziale) viene trascritto in una lsquocasellarsquo pre-ceduta da un segno per laquorisultaraquo sotto il divisore Secondo passo il massimo multiplo viene sottratto dal dividendo il resto cosigrave ottenuto egrave trascritto preceduto da un segno per laquorestoraquo in una casella posta
39 Lrsquoautore concettualizza il procedimento di estrazione di radice quadrata come una forma di divisione
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 137
accanto al dividendo40 I due passi precedenti sono quindi ripetuti con la sola differenza che il resto appena ottenuto prende il posto del divi-dendo il quoziente parziale scala di un ordine sessagesimale ad ogni passo41 E cosigrave via aggiungendo ogni volta due caselle La debolezza di questo metodo come di quello che utilizziamo attualmente risiede nel fatto che il reperimento dei quozienti parziali (ovverosia dei massimi multipli) viene effettuato per tentativi non riuscire a farlo al primo colpo appesantisce notevolmente i calcoli successivi e costringe ad un lavoro di riordino e addizione dei quozienti parziali stessi La tabella risultante dove appunto osserviamo questo fenomeno in parallelo con identiche inaccuratezze nella descrizione ha la forma riprodotta unico tra i manoscritti della recensione antica nel Marc gr 313 f 13r (tav 2b invito il lettore a non rivolgersi alle tavole se non dopo aver termi-nato questa sezione sarebbe anzi auspicabile che tentasse di ricostruire questa tabella e le due successive a partire dalla mia descrizione)42
Il secondo metodo di divisione attribuito a Pappo egrave congegnato in modo da rendere non aleatoria la ricerca dei quozienti parziali Come altrove nei Prolegomena la descrizione della procedura di calcolo si riag-gancia esplicitamente a una frase di Tolomeo laquouna volta dimostrato che il periodo di una singola rivoluzione lsaquodel solersaquo egrave di 365 giorni 14 48 se di-vidiamo per essi i 360 gradi di un singolo cerchio avremo il moto medio giornaliero del sole circa 0 gradi 59 8 17 13 12 31raquo43 Questrsquoaffermazione si trova nel terzo libro dellrsquoAlmagesto si tratta della prima occasione in cui viene effettuata una divisione in cui il divisore egrave maggiore del dividendo e i commentatori del trattato tolemaico non si fecero sfuggire lrsquooccasione di mostrare come eseguirla Ora il terzo libro del commentario di Pappo non ci egrave pervenuto Ci resta dunque come testo parallelo a quello dei Prolegomena la descrizione rigidamente formulare in Teone sicuramente un calco di quella pappiana Teone qui come nelle altre applicazioni del metodo (Laur Plut 2818 ff 136v [tav 3] e 190r) descrive brevemente ed espone esplicitamente la stessa tavola dei sottomultipli del divisore che
40 Esempio nella divisione di 378 per 17 il massimo multiplo egrave 374 il quoziente parziale egrave 22 il resto 4 e in effetti 378 = 374 + 4 = 17times22 + 4 Si noti che il segno per laquorestoraquo non egrave apposto in testa di riga ma davanti a ogni resto parziale e in effetti il dividendo che si trova in prima posizione in questa riga non egrave un resto
41 Analogamente nellrsquoalgoritmo moderno poniamo la virgola o scaliamo la cifra di un posto
42 Nei Prolegomena la descrizione della tabella associata al metodo anonimo egrave pre-ceduta da una breve sinossi dellrsquooperazione in stile procedurale (cioegrave senza riferimenti alla tabella) e seguita dalla sua esecuzione accurata ma con pochi riferimenti alla tabella se non quello ai due segni da apporre ai resti parziali e ai massimi multipli
43 Alm III 1 in POO I 1 p 2091-4
Fabio Acerbi138
troviamo nei Prolegomena ma non offre alcuna descrizione della disposi-zione tabellare della divisione stessa neacute vi fa riferimento
A questa procedura sono in effetti associate una tavola e una tabel-la costruite come segue (tavv 4 e 5 Marc gr 313 ff 17r e 17v il co-pista era ndash giustamente ndash insoddisfatto della prima versione) La tavola le cui righe e colonne sono delimitate da linee contiene sottomultipli44 del divisore 365 14 48 9 righe che riportano i valori da 160 a 960 piugrave altre 6 con i valori per decine da 1060 a 6060 la prima colonna elenca le 15 parti sessagesimali omettendo come drsquoabitudine la laquodenomina-zioneraquo dellrsquoordine (i numerali elencati sono quindi α β γ δ ε ϛ ζ η θ ι κ λ μ ν ξ) la seconda i sottomultipli corrispondenti organizzati su quattro colonne per tener conto dei tre ordini sessagesimali (il primo sottomultiplo egrave quindi ϛ ε´ ιδ´´ μη´´´ cioegrave 160 di τξε ιδ´ μη´´) La tabella priva di linee delimitanti espone la vera divisione Nella prima colonna troviamo i resti parziali ognuno preceduto dallrsquoindicazione del proprio ordine sessagesimale e da un segno per laquorestoraquo Nella seconda preceduti da un segno per laquosottrairaquo i sottraendi ognuno coincide ovviamente con uno dei sottomultipli nella tavola La terza colonna contiene se-guiti dallrsquoindicazione del proprio ordine sessagesimale i quozienti par-ziali ottenuti trascrivendo dalla prima riga della tavola il numerale corrispondente al sottraendo affiancato ed assegnando come ordine sessagesimale il successivo a quello posto in testa di riga Il risultato preceduto da un segno per laquorisultaraquo e posto al di sotto della tabella si ottiene sommando i quozienti parziali il procedimento non permette in generale di determinare lrsquointero quoziente parziale relativo ad un ordine sessagesimale fissato se non dopo due passi Una linea spezzata unisce i resti parziali successivi e i relativi sottraendi per evidenziare la laquoprogressione della proceduraraquo la spezzata lsquosaltarsquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore (le cui righe sono per il resto vuote) e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue di conseguenza anche il quoziente parziale relativo a questo resto appartiene allrsquoordine sessagesimale successivo
A questo punto possiamo rivolgerci alle tavv 4-5 e verificare se le immagini che ci siamo formati sulla base della mia descrizione corri-spondono a quelle che troviamo nel Marc gr 313 Non si tratta di un giochetto sterile egrave al contrario il cuore di un intrico di problemi Un primo ordine di problemi deriva dal fatto che nei Prolegomena lrsquoalgo-
44 Sottomultipli e non multipli in quanto il divisore egrave maggiore del dividendo Drsquoaltronde nel sistema sessagesimale come in quello decimale un sottomultiplo si ottiene dal multiplo corrispondente semplicemente scalando tutte le cifre di un posto (ad esempio 1360 di 365 14 48 si ottiene in questa maniera da 13 volte 365 14 48)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 139
ritmo della divisione lsquoalla Papporsquo non egrave mai eseguito (cioegrave formulato verbalmente) in maniera indipendente dalla descrizione della tabella Comrsquoegrave dunque possibile descrivere una tabella operazionale che non ha uno statuto testuale indipendente sulla base di un algoritmo in corso di esecuzione E drsquoaltro canto come non rilevare unrsquoanomalia in un algoritmo eseguito nella sua forma primaria sotto forma di descrizione di una tabella Ci potremmo chiedere se viene descritto lrsquoalgoritmo o la tabella La tensione fra i due enti grafici egrave acuita dal fatto che nei nostri testi tutto ciograve (esposizione o descrizione di un algoritmo o della tabella associata) avviene sempre e solo sulla base di un esempio numerico para-digmatico Per questo motivo la tabella in quanto struttura (cioegrave privata dei dati numerici accidentali) non puograve fare a meno della descrizione45 Dal canto suo Teone come forse Pappo ancor prima descrive ed espone la tavola dei (sotto)multipli ma non la tabella di divisione lrsquoalgoritmo relativo a questrsquoultima egrave espresso come per controbilanciare in maniera eccezionalmente trasparente e formulare Se ciograve comporta un guada-gno a livello verbale-argomentativo sorge un problema operativo grave come e dove sistemare i resti e i quozienti parziali ndash cioegrave tutti i numeri in output dellrsquoalgoritmo differenti dai (sotto)multipli ndash che la tabella si incarica di disporre in modo lsquonaturalersquo Teone prescrive soltanto di confrontare i resti con la seconda colonna della tavola dei sottomultipli e di trascrivere via via il quoziente ottenuto dopo ogni passo Insomma come eseguire materialmente una divisione Non certo adattando ad un nuovo caso specifico la formulazione dellrsquoalgoritmo che Teone propone
Un secondo ordine di problemi e una trappola micidiale per il co-pista egrave interno alla dialettica lsquotabellarsquolsquosua descrizionersquo ed egrave in assenza di simbolismo quello dei riferimenti linguistici da adottarsi nella seconda agli enti grafici che figurano nella prima Occorre ricercare la massima generalitagrave fornita da una descrizione definita di un ente numerico (ad esempio impiegando il termine laquorestoraquo o la perifrasi laquomassimo sotto-multiplo minoranteraquo) o basta assumere direttamente il suo valore speci-fico come esempio paradigmatico E in che modo risolvere il conflitto tra uso e menzione se come nel nostro caso la tabella contiene segni convenzionali ed occorre fornirne una descrizione Si rende ad esempio necessario introdurre un lsquooperatore di citazionersquo noi useremmo le virgo-lette la lingua greca premette lrsquoarticolo neutro Drsquoaccordo ma nel caso
45 Questa caratteristica non egrave connaturata alla matematica degli algoritmi la risorsa dello lsquostile proceduralersquo serve esattamente ad aggirare questo problema al di lagrave di un certo livello di dettaglio perograve essa condurrebbe ad un appesantimento insostenibile della for-mulazione dovuto alla pluralitagrave dei riferimenti agli oggetti matematici in gioco sulla que-stione dei diversi stili della matematica greca si veda Acerbi 2012
Fabio Acerbi140
greco qual egrave il suo range E come distinguerlo nei casi ambigui da un semplice articolo che precede un sostantivo quando questrsquoultimo lo ri-chieda Nel corso del processo di copia del testo della descrizione infine possono generarsi tensioni tra enti grafici interpretabili vuoi come segno convenzionale vuoi come abbreviazione Ambiguitagrave relative a questi punti opacizzano la descrizione Un problema analogo si porrebbe a priori nella dialettica tra uso delle lettere denotative per designare enti geometrici e loro menzione nella costruzione di un diagramma ma esso egrave risolto con lrsquoazzeramento della seconda funzione le lettere denota-tive sono sempre usate allrsquointerno del testo (sono cioegrave il referente degli oggetti geometrici di cui tratta il discorso matematico) mai menzionate (come accadrebbe se fossero il referente di oggetti grafici posti nel dia-gramma) Insomma il codice adottato per la costituzione dei diagrammi geometrici egrave condiviso (cioegrave canonizzato) semplice e perspicuo mentre quello per le tabelle operazionali non lo egrave da qui le sviste dei copisti e le trascuratezze di correttori ed editori
Infine chi vuole apprendere da questi testi come eseguire una divi-sione a cosa deve prestar fede se ad esempio a causa di errori di copia la descrizione finisce per non coincidere con la tabella operazionale visto che sono entrambe due maniere valide di eseguire lo stesso algoritmo Dopo tutto lo scopo di tutta questa macchina grafico-argomentativa egrave di insegnare a eseguire divisioni in formato tabellare Questo problema si fa particolarmente acuto se la tabella non egrave trasparente nel metodo di Pappo lo egrave quasi completamente in quello anonimo no E gli errori che riscontreremo nella (doppia) tabella ai ff 17r-v del Marc gr 313 a chi sono attribuibili Allrsquoautore al trascrittore o al copista medievale
Questo groviglio di problemi riceve alcune risposte sorprendenti dalla tradizione manoscritta come andiamo finalmente a vedere
4 Analisi delle testimonianze
I codici che ho adibito per lrsquoedizione sono i seguenti M = Marc gr 31346 C = Marc gr 314 (Tolomeo Tetrabiblos et opera minora cum commentariis Vezio Valente Anthologiae)47 Z = Vat gr 2326 (fattizio
46 Riferibile al sec IX ex-X in accolgo la datazione suggeritami per litteras il 522005 da Nigel G Wilson si veda anche Agati 1992 pp 141-142 La presenza non sistematica degli accenti che fa anticipare a Wilson la datazione di laquosaec X medraquo fornita in Mioni 1985 p 24 indusse Boris Fonkič (2005 non vidi) ad assegnare il codice allrsquoinizio del IX secolo
47 Il manoscritto riferibile alla seconda o terza decade della prima metagrave del XIV secolo fu vergato da Michele Clostomalle olim lsquoMetochitesschreiberrsquo Bianconi 2005a pp 428-430 Il titolo dei Prolegomena in questa trascrizione identico in grafia ma non in formulazione a
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 141
e mutilo Tolomeo Almagestum) S = Vat gr 184 (varia astronomica scholia miscellanea ad Almagestum Tolomeo Almagestum) P = Par gr 2390 (varia astronomica) gli ultimi tre riferibili allo scorcio del XIII secolo48 e apografi sicuri del Vat gr 159449 attualmente mutilo di due fascicoli che ci privano dei due terzi finali dei Prolegomena M e il Vat gr 1594 ammettono un modello comune il resto della tradizione (25 trascrizioni in tutto) dipende dagli apografi appena citati del Vat gr 1594 Le varianti della recensione bizantina che leggiamo tra lrsquoaltro nei Vat gr 198 Marc gr 310 (Tolomeo Almagestum cum commentariis Pappi Theonis et Cabasilae) e con ulteriori modifiche Laur Plut 89 sup 48 (varia astronomica Tolomeo Almagestum Barlaam Logistica) sono identificate dal siglum K e si trovano punteggiatura originale in-clusa nel secondo apparato50 Lrsquoanalisi delle testimonianze51 costituite ovviamente anche dalle tabelle associate saragrave condotta nella forma di una sequenza di osservazioni indicizzate da numerali o lettere oltre che di alcune note a piersquo di pagina
Iniziamo dalla descrizione del metodo di divisione anonimo
quello che leggiamo nel Vat gr 1594 (questrsquoultimo coincide con quello adottato nella recen-sione bizantina) fu apposto da Niceforo Gregora e successivamente corretto da Bessarione
48 Sto studiando il primo e il terzo codice in collaborazione rispettivamente con Daniele Bianconi e Inmaculada Peacuterez Martiacuten
49 Su questo codice risalente alla seconda metagrave del IX secolo e sulla sua collocazione nella lsquocollezione filosoficarsquo per prima proposta in Follieri 1977 pp 145-146 si vedano almeno Perria 1991 pp 82-88 Ronconi 2013 Che il titolo dei Prolegomena nel Vat gr 1594 sia stato apposto da Niceforo Gregora egrave stato riconosciuto per la prima volta in Mazzucchi 1994 p 211 n 196 si veda Bianconi 2005a p 418 per altri interventi di Gregora nello stesso manoscritto
50 Il Vat gr 198 egrave stato vergato dal copista Malachia nel corso del terzo quarto del XIV secolo Mondrain 2004 pp 278-290 e 292 Allo stesso copista (denominato non a caso prima dellrsquoidentificazione anonymus Aristotelicus) dobbiamo un buon numero di trascrizioni aristoteliche con i relativi commentari in margine Gli dobbiamo anche il Par gr 2342 secondo tomo di un quadrivium quasi completo di cui il Vat gr 198 egrave il primo nellrsquoordine aritmetica armonica astronomia (Almagesto e commentari relativi) nel codice vaticano geometria ed ancora astronomia (corpus astronomico minore) in quello parigino le opere trascritte sono sempre accompagnate in margine dai relativi commentari Il copista del Marc gr 310 egrave Isacco Argiro (ca 1300-1375) Mondrain 2007 p 166 Allo stesso Argiro dobbiamo il codice laurenziano (Daniele Bianconi per litteras) Poicheacute la recensione modificata che leggiamo nel Laur Plut 89 sup 48 egrave senza alcun dubbio basata su quella nel Marc gr 310 e non viceversa ci troviamo di fronte ad un copista che trascrive due volte lo stesso testo in due versioni leggermente differenti la conclusione naturale egrave che la seconda recensione egrave dovuta ad Argiro stesso la questione andragrave studiata in dettaglio
51 Nei manoscritti citati i Prolegomena si trovano ai fogli seguenti Vat gr 1594 ff 1r-8v (mutilo mancano due fascicoli su tre) Marc gr 313 ff 1r-28r (incompleto man-cano due fogli allrsquoinizio e il f 6 attualmente rimpiazzato da uno bianco) Marc gr 314 ff 235r-255r Vat gr 2326 ff 19r-40v e 43r-v (incompleto e con i fascicoli in disordine) Vat gr 184 ff 10r-23v Par gr 2390 ff 1r-13v Vat gr 198 ff 127r-136v Marc gr 310 ff 1r-13r Laur Plut 89 sup 48 ff 7r-19r
Fabio Acerbi142
ἐκθέμενοι οὖν διάγραμμα τῶν ἀριθμῶν ὡς ὑπόκειται προτάσσομεν τὸν μεριζόμενον καὶ μικρὸν ὑπ᾽ αὐτὸν τὸν μερίζοντα ὡς ἔχει τὸ διάγραμμα ἐν στίχοις διοριζομένοις ὑπὸ γραμμῶν [hellip] καὶ τὰ μὲν γινόμενα ἐγγὺς ἐλάττονα ἐν τῇ μεταξὺ θέσει τοῦ μεριζομένου καὶ τοῦ μερίζοντος ἐν στίχοις παρασημειοῦσθαι πρὸς τὸ ἀσύγχυτον εἶναι τὴν τάξιν τὰ δὲ μεθ᾿ ὧν ὁ μερίζων ἐποίει τοὺς ἀεὶ ἐλάσσονας ὑπὸ τὸν μερίζοντα σημειοῦσθαι προγράφοντας ἐπὶ τοῦ στίχου αὐτῶν τὸ γίνεται οὕτως γι ἐν δὲ τῷ στίχῳ τῶν μεριζόντων τὸ παρὰ ἔχον οὕτως oslash ἀντὶ τοῦ παρ᾿ ἃ δεῖ τὸν μερισμὸν γίνεσθαι ἐν δὲ τῷ στίχῳ τῶν ἐλασσόνων τὸ αφ διὰ τὸ τούτους ἀεὶ ἀφαιρεῖσθαι ἀπὸ τῶν ἐπάνω τῶν μεριζομένων ἐν δὲ τοῖς τοῦ μεριζομένου λοιπάσμασι τοῖς καὶ ἐπιοφείλουσι τὸ λ κατὰ τὸ ἴδιον τῶν διαστάσεων ἑκάστης ndash λέγω δὴ λοιπάδος ndash ἀντὶ τοῦ λοιποὶ οἱ μέλλοντες ἐπιμερίζεσθαι
2 post τὸν suprascr τὸν ἐλάττονα m 2 S 5 πρὸς] MP et ex corr Z κατὰ S om C | ἀσύγχυτον] MSPC -χητον Z 6 ἀεὶ] MZPC ὡσεὶ S 7 γίνεται οὕτως γι ] γι τ οὕτως γι τ M γί οὕτως γί Z γι οὕτως γί SC τὸ γινόμενον οὕτως γίνεται P 8 τὸ παρὰ ἔχον οὕτως] scripsi τὸ παρέχον οὕτως M et π(αρ-) comp Z οὕτως τὸ περιέχον S προγράφοντας οὕτως ex corr m 2 P τὸ περιέχον οὕτως C | oslash] MZSC (sed ο fecit | Z) ἐλάττων comp ex corr m 2 P | παρ᾿ ἃ] scripsi παρα M π(αρα) comp ZSC ex παρα fe-cit παρὰ et τοῦτον suprascr m 2 P 9 γίνεσθαι] comp C | αφ ] αφ ε M ἀφ ZSC ἀφαί P | ἀεὶ] om M 11 ἐπιοφείλουσι] MZSC ex ἐπιο- fecit ἐπο- m 2 P | λ] MZPC λ´ S 12 λοιποὶ] PC λοιποῦ MZS
3 στίχοις] στίχῳ K 5 πρὸς] διὰ K 7 ἐπὶ mdash γι ] τὸ γίνεται διὰ τοιούτου σ(ημείου) γί K 8 τὸ παρὰ ἔχον mdash παρ᾿ ἃ] τὸ παρᾱ διὰ σ(ημείου) τοιούτου καὶ τοῦτο oslash δηλοῦντος τοῦ παρᾱ ὅτι παρὰ τὸν τοιοῦτον (ἀριθμὸν) K 9 αφ διὰ τὸ τούτους] ἀφ δηλοῖ δὲ τοῦτο ἀφαίρεσ(ιν) ὅτι τούτους ἀεὶ δεῖ K 11 ἐπιοφείλουσι] ἐπιμερίζεσθαι ὀφείλουσι K | λ] λ οι` K 12 ἀντὶ τοῦ] δηλοῦντος τοῦ σ(ημείου) τὸ K
lsquoRendendo esplicito un diagramma numerico come lo troviamo qui sotto disponiamo in primo luogo il dividendo e un poco al di sotto di esso il divisore come li ha il diagramma in righe delimitate da linee [hellip] e lsaquooccorreragraversaquo nella posizione tra il dividendo e il divisore annotare lrsquouno accanto allrsquoaltro i piugrave vicini lsaquodei numerirsaquo minori che risultano affincheacute la disposizione non sia confusa quelli con cui il divisore faceva ogni volta i lsaquonumerirsaquo minori annotarli sotto il divisore scrivendo in prima posizione sulla loro riga laquorisultaraquo cosigrave Ris nella riga dei diviso-ri52 invece laquoperraquo fatto cosigrave53 P in luogo di laquoquelli per cui deve farsi la divisioneraquo nella riga dei lsaquonumerirsaquo minori laquosottrraquo in quanto questi sono sempre sottratti dai dividendi che si trovano sopra nei residuli del dividendo (occorre ben farlo anche per loro) laquoReraquo in accordo con ciograve
52 I laquodivisoriraquo sono al plurale ma siamo semplicemente di fronte a un tratto idioma-tico della lingua greca nel caso di espressioni generalizzanti crsquoegrave soltanto un divisore che occupa lrsquounica colonna di cui si compone la sua riga
53 Si intenda ἔχον οὕτως = ita se habens
1
5
10
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 143
che egrave proprio agli scarti di ciascuno ndash intendo qui lsaquociascunrsaquo residuo54 ndash in luogo di laquoresti che vanno a essere divisi ulteriormenteraquorsquo
a) Operatori di citazione e segni convenzionali I segni introdotti sono quattro la mia discussione egrave condotta dando per scontato che essi siano identici a quelli impiegati dallrsquoautore dei Prolegomena anche se si tratta di unrsquoipotesi non corroborabile neacute falsificabile
i Segno per il risultato Lrsquoabbreviazione convenzionale per γίνεται egrave identica al segno introdotto dallrsquoautore e i copisti si dividono tra i due errori possibili scrivere due abbreviazioni o risolverle entrambe Un fenomeno del tutto analogo si riscontra nel Matr 4678 il manoscritto alla base di tutta la tradizione degli Arithmetica di Diofanto al momen-to della definizione dellrsquoἀριθμός (lrsquolsquoincognitarsquo nel nostro linguaggio) ὁ δὲ μηδὲν τούτων τῶν ἰδιωμάτων κτησάμενος ἔχων δὲ ἐν ἑαυτῷ πλῆθος μονάδων ἄλογος ςο` καλεῖται ς` ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον τὸ ς` laquoil lsaquonumerorsaquo che non possiede nessuna di queste proprietagrave ma che ha in seacute una molteplicitagrave indefinita di unitagrave egrave chiamato lsquonumerorsquo e il suo segno egrave ς`raquo Qui solo il terzo dei tre ς ha una barra a sormontare per segnalarne il carattere puramente denotativo (cioegrave di segno convenzionale e non di abbreviazione si veda il punto successivo)55 il primo egrave una delle abbreviazioni piugrave diffuse per ἀριθμός (e infatti egrave dotato del compendio per la desinenza e dellrsquoaccento grave) il secondo egrave una delle piugrave comu-ni per καὶ () Giovanni Cortasmeno autore di capillari annotazioni infra lineam agli Arithmetica nel codice madrileno scioglie il primo ςο`
54 Doppia variatio che impiega al posto di λοιπόν laquorestoraquo i due termini decisamente non canonici τὸ λοίπασμα e ἡ λοιπάς (piugrave oltre leggiamo anche il participio λοιπασθέντα) Una ricerca sul TLG in rete non ha fornito occorrenze del primo si tratta dunque di uno hapax Quanto al secondo che ricorre anche nella sezione sulla divisione lsquoalla Papporsquo lo si rintraccia giagrave nei papiri documentari il termine diventeragrave perograve canonico nelle esposizioni bizantine drsquointroduzione allrsquoAlmagesto ricalcate sul modello dei Prolegomena (si veda la nota 87 infra) Questi due termini designano i resti parziali prodotti nel corso di una divisione lunga li ho tradotti rispettivamente con il neologismo laquoresiduloraquo e con il sostantivo pari-menti non canonico laquoresiduoraquo
55 Il copista interpreta erroneamente il terzo segno come unrsquoabbreviazione e qui ag-giunge un apice inverso (cioegrave un accento grave) altrove lo scioglie direttamente in forme opportune di ἀριθμός Matr 4678 f 58v La frase come la leggiamo nel manoscritto egrave cor-rotta sulla base di una parafrasi in Psello (edita in DOO II p 3710-12) Tannery emendograve ἄλογος in ἀόριστον DOO I p 64-5 et app Il Matritensis vergato da due copisti differenti (cambio di mano a tre righe dalla fine del f 62r) contiene lrsquoIntroductio arithmetica di Nicomaco e le opere diofantee oltre ad alcuni brevi opuscoli musicali la sua data egrave stata recentemente corretta dal XIII al secolo XI pm in Peacuterez Martiacuten 2006 (una riproduzione digitale del manoscritto si trova allrsquoindirizzo httpbdhbneesbnesearchbibliotecaDio-fanto20de20AlejandrC3ADa)
Fabio Acerbi144
in ἀριθμός ed aggiunge un altro segno56 sopra il terzo anteponendovi lrsquoindicazione καὶ ἔστιν αὐτοῦ σ(ημεῖον) τόδε Va da seacute che non abbiamo nessuna garanzia che il segno originariamente introdotto da Diofanto coincidesse realmente con unrsquoabbreviazione convenzionale per ἀριθμός Lrsquoevidenza del PMich III 144 (sec II in) suggerisce drsquoaltronde che il Matritensis e con esso tutta la tradizione medievale di Diofanto ripro-duca fedelmente pur accentuandone la sinuositagrave il segno originario
ii Segno per il divisore Un cerchiolino sbarrato da non confondere con il segno per ὁμοῦ che nei manoscritti matematici ha di norma due barre trasversali (cf tav 2a) Non sono riuscito a rintracciarne ulteriori occorrenze in altre opere la forma che esso assume nel Vat gr 2326 e la correzione apportata nel Par gr 2390 lasciano aperta la possibilitagrave per quanto a mio avviso remota che la forma originaria non fosse lon-tana da unrsquoabbreviazione di παρά registrata nei repertori57 Il correttore del Par gr 2390 trasforma in effetti il segno oslash nellrsquoaffine abbreviazione canonica per (forme di) ἐλάσσων laquominoreraquo58 e si incarica diligente-mente di farlo notare ricapitolando i segni nella porzione superiore del margine esterno del f 7v Nello stesso margine egli traccia anche uno lsquoscolio tabellarersquo ed egrave lrsquounico a porre il (proprio) segno dove indicato dalla descrizione (tav 6 Par gr 2390 f 7v) Oltre a ciograve adattando la tabella al margine ristretto lo scoliaste trascrive come colonne affian-cate le due righe dei resti parziali e dei massimi multipli e aggiunge le indicazioni ὁ μεριζόμενος laquodividendoraquo e ὁ μερίζων laquodivisoreraquo ma vi introduce alcune incongruenze di formato il risultato scritto in verti-cale e la linea verticale di sinistra che separa il divisore dal segno che lo dovrebbe precedere direttamente
iii Segno per i massimi multipli Corrisponde alla semplice abbre-viazione per sospensione della forma verbale ἄφελε laquosottrairaquo in questo
56 Si tratta del segno di ampio uso praticamente identico allrsquoabbreviazione canonica per οὖν
57 Si tratta di un pi a forma di gancio sbarrato da uno slash di troncamento Ce-reteli 1904 tav IX item 7 sub ΠΑΡΑ che rinvia al PVindRain 423 cf anche la forma π` nel POxy LXI 4142 edito in Jones 1999 II pp 26-34 In generale nei papiri e nei manoscritti matematici in maiuscola le preposizioni sono abbreviate facendo seguire un lsquoapostroforsquo alla loro prima lettera Α᾽ Υ᾽ ecc Per la seconda fattispecie di supporto libra-rio si veda in particolare il cosiddetto fragmentum mathematicum Bobiense scriptio inferior databile al V-VI secolo del palinsesto Milano Biblioteca Ambrosiana L 99 sup (Isidoro di Siviglia Etymologiae datazione Cavallo 1977 p 100) pp 113-114 che sono stampate in riproduzione apografa conforme in Belger 1881 (la p 114 egrave riprodotta anche nella tav 10 di Acerbi 2010)
58 Se questa era lrsquointenzione si tratta ovviamente di una forzatura il divisore puograve ben essere maggiore del dividendo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 145
caso lo slash di troncamento taglia orizzontalmente il tratto verticale del phi I copisti offrono molteplici varianti apponendo chi uno spirito dolce chi un ε chi un αί accentato a sormontare Tutti questi segni svolgono la funzione di abbreviazioni vere e proprie (e cosigrave doveva essere anche per lrsquoautore si veda il punto 1 di p 153 infra) la forma originale si ottiene a mio avviso incrociando i dati del Marc gr 313 e dei tre apografi del Vat gr 1594 αφ anche se lrsquoassenza dello spirito potrebbe essere semplicemente dovuta alla pratica del copista del codice veneziano di economizzare nei diacritici
iv Segno per i resti Un lambda completato da una barra a sormon-tare o da un apice che rinvia alle abbreviazioni per sospensione di una forma opportuna di λοιπός laquorestoraquo In realtagrave la forma che troviamo nella tabella egrave differente (tav 2b) e coincide con quella offerta quasi unanimemente dai manoscritti nella descrizione e in almeno un caso nella tabella del metodo di divisione attribuito a Pappo (tav 4) un lambda che accoglie al di sotto una legatura omicron-iota () sbarrata da uno slash di troncamento Qualcosa di simile si trova nel PVindob G 19996 (sec I) una specie di lambda maiuscolo molto aperto e dal vertice arrotondato che include un circoletto interpretato dagli editori come segno per περίεστιν o per λοιπόν59 Lo stesso segno si rintraccia ad esempio in un medesimo scolio tabellare di prima mano ad Alma-gestum nel Vat gr 1594 f 93v e nel Marc gr 313 f 135r ma stavolta la forma del lambda egrave molto ben definita
Fin qui i segni Ma il gioco egrave piugrave complesso La descrizione si muo-ve pericolosamente sulla linea di confine non sempre ben definita tra segno convenzionale e abbreviazione il primo ndash e il repertorio grafico matematico-astronomico ne egrave particolarmente fornito60 ndash puograve anche
59 Ho consultato lrsquoedizione Gerstinger ndash Vogel 1932 pp 46 e 48 la porzione rilevante del papiro egrave riprodotta nella tav 11 di Fowler 1999 Si veda ancora ivi pp 253-257 per la trascrizione di questo segmento di testo (con correzioni rispetto alla princeps) e per una messa a punto recente inclusa la proposta di datazione che ho riportato qui sopra Il verso del papiro che contiene una tavola aritmetica del tutto scorrelata dalla tematica del recto egrave edito come PRain Unterricht 151
60 La pratica di ridurre lo spazio occupato da un testo tecnico per mezzo di abbreviazioni e segni convenzionali era molto diffusa nei manoscritti in maiuscola contrariamente a quanto avviene per altri generi letterari vedremo tra breve cosa accade negli Arithmetica di Diofanto ma si leggano in proposito anche le considerazioni di Hei-berg nei prolegomena alla propria edizione dellrsquoAlmagesto in particolare riguardo al ricorso massiccio ad espedienti brachigrafici nel modello del Vat gr 180 POO II pp lxxxiv-xciii civ-cv cxxvii cxxxviii-cxxxix Agli elenchi dettagliati forniti da Heiberg possiamo aggiungere il piccolo prontuario stampato in Hultsch 1876-1878 III 2 pp 126-132 e basato sul testo e sugli scolii alla Collectio di Pappo nel Vat gr 218 (sec X in) Si vedano infine le osservazioni del copista del Par gr 2360 f 120v trascritte da Heiberg in AOO III pp x-xi sulle laquonotazioni tipiche a scopo di tagliar corto nello scrivereraquo impiegate nel pro-
Fabio Acerbi146
derivare dalla seconda (un caso egrave appunto il segno per ἐλάσσων che probabilmente trae origine da una legatura epsilon-lambda) ma poi il rapporto referente-relato si fissa convenzionalmente Quelli definiti nel testo che abbiamo letto sono appunto segni convenzionali non ci sarebbe bisogno di spiegarne forma e funzione se fossero intesi come abbreviazioni assumono nella tabella una funzione denotativa non esplicativa o discorsiva (come accade invece nella tav 1a) Ma come vengono descritti questi segni
I referenti delle descrizioni sono i segni sono introdotti da οὕτως (item i-ii) o in alternativa da un τό con il ruolo di lsquooperatore di citazionersquo (item iii-iv) che corrisponde esattamente alle nostre virgolette In entram-bi i casi gli enti sono menzionati e svolgono una funzione metalinguistica sono collocati materialmente nel testo ma egrave come se si trovassero fuori e la loro descrizione li additasse ndash in effetti i segni convenzionali scritti nel testo sono a loro volta i relata di quelli che si trovano nella tabella
I relata dei segni scritti nel testo sono di due tipi singoli vocaboli (item i-ii) o descrizioni della funzione dei segni per mezzo di clausole sintaticamente complesse (item ii e iv) I singoli vocaboli sono γίνεται e παρά e sono entrambi preceduti dal τό lsquocitazionalersquo in quanto relata di segni convenzionali le forme abbreviate con cui sono tracciati nei manoscritti vanno forzatamente sciolte Bisogna ammettere che la per-spicacia e le risorse grafiche dei copisti ndash di cui tutto si puograve dire fuor che commettano qui degli errori ndash sono messe a dura prova con lrsquointrodurre segni identici ad abbreviazioni o con lrsquoattivare un gioco metalinguistico particolarmente serrato in un contesto meno lsquonaturalersquo di come potreb-be esserlo ad esempio quello di un trattato grammaticale Lrsquoitem iii che presenta direttamente un segno identico ad unrsquoabbreviazione non egrave sorretto da una descrizione ma da una giustificazione in διὰ τό Lrsquoartico-lo τό vi assume una funzione metalinguistica anche se non lsquocitazionalersquo poicheacute al tempo stesso genera un infinito sostantivato e lo singolarizza per questo ho scritto laquosono sottrattiraquo in corsivo nella mia traduzione
prio modello archimedeo (nota 32 supra) egli ne compila anche una breve lista Un elenco antico di laquosegni della geometriaraquo sicuramente redatto per assistere il copista si trova anche al f 3v del ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 vergato da Efrem negli anni 950-960 (tav 8 in Acerbi 2010) Possiamo farci unrsquoidea quantitativa del guadagno di spazio in rapporto ad un testo privo di abbreviazioni e con le parole separate da spazi sulla base del fragmentum mathematicum Bobiense il testo vi egrave disposto a tutta pagina su 36 righe di circa 30 segni ciascuna nelle due pagine in questione figurano 2038 segni con 15 mezze righe occupate dalle due figure Ora nel testo dellrsquoedizione stabilita in Heiberg 1927 pp 87-90 le stesse pagine contano 4455 segni spazi compresi Ne risulta che la dimensione in caratteri di un testo matematico puograve essere ridotta di piugrave della metagrave con lrsquoimpiego di compendi e segni convenzionali
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 147
Negli item ii e iv il segno si collega ad una descrizione nel secondo caso in via esclusiva le descrizioni pertanto rinforzano o sostituiscono lrsquoidentificazione con lrsquoente linguistico denotato Le clausole descrittive sono precedute da ἀντί e dallrsquoarticolo τό con funzione di lsquooperatore di citazionersquo esse sono παρ᾿ ἃ δεῖ τὸν μερισμὸν γίνεσθαι (item ii) e λοιποὶ οἱ μέλλοντες ἐπιμερίζεσθαι (item iv) Nella descrizione della divisione lsquoalla Papporsquo che leggeremo tra breve i segni negli item iii e iv rice-vono lo stesso trattamento degli altri due il loro relatum egrave un singolo vocabolo e non una clausola descrittiva rispettivamente nelle espres-sioni τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε (sul participio ritorneremo nel punto 1 infra) e τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά (la forma del segno notato con λ οι egrave descritta supra nellrsquoitem iv) La descrizione del segno oslash per il divisore merita una discussione piugrave dettagliata In origine si trovava probabilmente scritto Π(ΑΡΑ)ΕΧΟΝ successivamente letto come π(αρ[α])έχον ndash dato che lrsquoabbreviazione per il preverbo egrave identica a quella per la preposizione (che sia Π᾽ o un pi seguito dal segno per ἄρα a sormontare) ndash invece di π(αρὰ) ἔχον I copisti e i correttori si dettero a tutte le possibili contorsioni per restituire un testo dotato di senso leggere appunto una forma verbale con preverbo modificare il preverbo (ma forse il segno per ἄρα era insidiosamente simile ad uno epsilon) correggere il testo rileggiamo lrsquoapparato sub τὸ παρὰ ἔχον οὕτως τὸ παρέχον οὕτως M et π(αρ-) comp Z οὕτως τὸ περιέχον S τὸ περιέχον οὕτως C προγράφοντας οὕτως ex corr m 2 P Nella clausola descrittiva seguente la presenza liminare di παρὰ (che ho corretto in παρ᾿ ἃ nella speranza di restituire una frase che abbia un senso senza intervenire sul testo) innesca un bel corto circuito il Π(ΑΡΑ) che sicuramente figu-rava nellrsquoarchetipo egrave un sintagma complesso una preposizione unrsquoab-breviazione o un segno per unrsquoabbreviazione Se lrsquoeditore si trova in conflitto con la propria inclinazione alla critica conservativa i copisti si rifiutarono di mettere mano ad un testo che doveva stridere anche per loro essendo il compito demandato al ritocco del revisore del Par gr 2390 o alla riscrittura radicale del recensore bizantino Il problema egrave che ci troviamo di fronte ad unrsquoespressione che descrive la funzione dellrsquooggetto denotato non lrsquooggetto stesso ma che lo contiene al suo interno per soprammercato qui il Π(ΑΡΑ) egrave usato per giustificare una menzione a sua volta relatum di un segno
Evidentemente questa maniera di procedere che giagrave aveva attirato interventi da parte di copisti e correttori della recensione di base parve insostenibilmente opaca allrsquoautore della recensione bizantina61 Egli
61 Uno dei manoscritti di questa recensione propone anche una tabella di divisione
Fabio Acerbi148
modifica tutte le descrizioni diluendo lrsquoidiomatismo dellrsquoarticolo lsquocita-zionalersquo con lrsquointroduzione sistematica del verbo δηλόω e di frasi atte a chiarire quale sia il segno denotante e quale il vocabolo (o il segno) denotato Egli introduce allo scopo di rendere esplicita la funzione de-notativa dei segni introdotti il termine σημείου curiosamente in tutte le sue tre occorrenze esso compare a sua volta nella forma dellrsquoabbrevia-zione per sospensione σΗ´ Egli traccia il segno per i massimi multipli ἀφ e quello per i resti λ οι` in modo che non vi siano ambiguitagrave quanto al loro carattere di abbreviazione Si faccia infine attenzione al residuo di barra sul παρᾱ con funzione denotativa (2 occorrenze) contenuto nella descrizione del segno per il divisore sostituita dallrsquoaccento grave nel παρὰ con funzione discorsiva (la differenza egrave nettissima nei manoscritti da me consultati) Questa osservazione ci permette di passare direttamente allrsquoitem seguente
b) Le barre sui numerali e sulle lettere denotative Egrave opportuno discutere questo punto adesso esattamente percheacute di barre siffatte che pure troviamo in tutti i manoscritti i nostri testi non fanno mai menzione si tratta infatti di una pratica condivisa sin dallrsquoantichitagrave La barra identifica una stringa di lettere dellrsquoalfabeto che non svolge una funzione grammaticale o sintattica propria allrsquointerno del discorso Ciograve avviene in particolare e si tratta della fattispecie piugrave frequente se la stringa di lettere non dagrave origine a un vocabolo della lingua greca lette-re denotative e numerali certo ma anche termini provenienti da altri idiomi e contrazioni di parole greche come i nomina sacra62 tali termi-ni possono essere o no preceduti da un articolo lsquocitazionalersquo a seconda dellrsquouso che ne viene fatto allrsquointerno del discorso Ma non si tratta dellrsquounica fattispecie i papiri grammaticali ed i manoscritti piugrave antichi dei trattati dello stesso argomento segnalano gli esempi delle parti del discorso (cioegrave di lsquoverersquo parole greche) per mezzo di barre sormontanti63 La differenza insomma egrave tra menzione e uso (come parte del discorso in atto) di una stringa di caratteri tra il porre le lsquovirgolettersquo e il non porle tra funzione denotativa e non Apparentemente la convenzione si limi-
corredata dei segni opportuni e contrariamente alle indicazioni della descrizione svilup-pata lsquoin verticalersquo ma per motivi misteriosi non completa (tav 7a Laur Plut 89 sup 48 f 13r)
62 Tutto ciograve egrave spiegato con estrema chiarezza giagrave in Traube 1907 pp 45-4763 Si veda il Par gr 2548 codex vetustissimus e testimone unico delle lsquoopere minorirsquo
di Apollonio Discolo il f 106v con le barre ben visibili egrave riprodotto come tav 19 in De Gregorio 2000 (ivi pp 137-138 per la datazione) Per la testimonianza dei papiri grammaticali si veda Wouters 1979 passim essi contengono di norma elenchi di parti del discorso nessuna delle quali egrave preceduta dallrsquoarticolo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 149
tava in questo secondo caso a segnalare con la barra singoli vocaboli le menzioni di frasi o di sintagmi complessi sono di norma identificate dallrsquoarticolo lsquocitazionalersquo Drsquoaltra parte le abbreviazioni convenzionali non rientrano nella casistica percheacute la loro resa grafica che contiene elementi non alfabetici come compendi per desinenze lettere supra li-neam marche di contrazione o sospensione quali slashes o barre sotto-poste o sormontanti eventualmente solo un sottinsieme della stringa di segni alfabetici le esclude automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
Venendo al discorso matematico una barra sormonta senza ecce-zione le lettere denotative64 che sia in papiri o in manoscritti in maiu-scola65 o minuscola ma solo allrsquointerno del testo comrsquoegrave da attendersi nei diagrammi esse la perdono per il semplice motivo che non crsquoegrave alcun testo ambiente un diagramma ha unicamente una funzione denotati-va Drsquoaltra parte le lettere numerali che a volte figurano nei diagrammi della tradizione metrica66 allo scopo di indicare la lunghezza dei seg-menti mantengono la barra in un diagramma il contesto denotativo geometrico egrave prevalente e i numerali vengono percepiti come entitagrave grafiche lsquoesternersquo al discorso Va da seacute a fortiori che le lettere numerali inserite in un testo dovranno essere segnalate da barre che a loro volta non servono nelle tavole67 in quanto queste ultime sono come abbiamo visto un vero e proprio testo che perograve funge da ambiente a quello al-fabetico limitato alle titolazioni e non a caso tracciato in unrsquoopportuna lsquomaiuscola distintivarsquo allo scopo di segnalarne il carattere denotativo e non discorsivo68 Una tabella operazionale egrave invece un paratesto e quindi le barre sulle lettere numerali che rappresentano gli interi sono
64 La notazione per le lettere denotative subigrave unrsquoevoluzione (il cui risultato finale egrave descritto per sommi capi nella nota 3 supra) di cui non mette conto occuparsi qui
65 I papiri di contenuto geometrico (o astronomici ma che presentano argomenti geometrici) sono rari si vedano il PHerc 1061 (sec II aC Demetrio Lacone De geome-tria) e il PFay 9 (sec II ex Elementi I 39 e 41) Gli importanti ostraka OBerl 12002 e 12609 (sec III aC m Elementi XIII) non pongono le barre sopra le lettere denotative Per i manoscritti in maiuscola si veda ad esempio passim nel Par gr 2389 una cui riproduzione digitale egrave consultabile in rete allrsquoindirizzo httpgallicabnffrark12148btv1b8470171d o il fragmentum mathematicum Bobiense
66 Si veda ancora il ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 codex unicus dei Metrica di Erone e contenente una raccolta importante di problemi del corpus metrologico
67 Si vedano come esempio le tavole citate alle note 10 e 14 supra Discorso a parte per il segno di lsquoposto vuotorsquo si veda il punto c che segue
68 Queste regole generali vanno prese cum grano salis si dagrave naturalmente un certo dominio di variabilitagrave legato verosimilmente al grado di cultura grafica del copista nel PMich III 144 i numerali sono quasi tutti senza barra sia nel testo che nelle tabelle ope-razionali
Fabio Acerbi150
necessarie esse mancano invece sui segni convenzionali che ho descrit-to nel punto precedente e fatto rilevante sulle lettere numerali relative agli ordini sessagesimali quando esse siano identificate da uno o piugrave apici la presenza di questo segno grafico non alfabetico69 le esclude ancora una volta automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo Unrsquoultima osservazione che ci saragrave utile nel seacuteguito la descrizio-ne di una stringa di lettere lsquoagrammaticalersquo non puograve prevedere la men-zione della presenza della barra che le pertiene in quanto tale si tratta di una pratica denotativa che egrave possibile formulare soltanto ad un livello di discorso superiore sia a quello dellrsquouso che a quello della menzione70
c) Il segno di lsquoposto vuotorsquo Si noti nella tav 2b la forma ŏ per il segno di lsquoposto vuotorsquo in un ordine sessagesimale coerentemente con la propria notazione il copista del Marc gr 313 lo scioglie talvolta allrsquoin-terno del testo principale come unrsquoabbreviazione per οὐδέν laquonienteraquo Altre convenzioni di scrittura del tratto che accompagna il circoletto e che si badi bene fa parte integrante del segno di lsquoposto vuotorsquo ndash e infatti nelle tavole troviamo sempre il segno completo mentre tutti gli altri numerali sono come abbiamo visto nel punto precedente privi di barra o di apice a causa del fatto che i vari ordini sessagesimali sono univocamente determinati dalle linee di giustificazione ndash un tratto an-golare anteposto (tav 3 Lar Plut 2818 f 136v)71 o una semplice barra a sormontare (tavv 4-9) si produce in questo modo il segno 65926 che sembra essere stata la forma di base72
69 Occorre dunque supporre come testimoniano papiri e manoscritti in maiuscola che la convenzione relativa allrsquouso della barra si sia consolidata ben prima dellrsquointroduzione di segni diacritici quali accenti e spiriti
70 Si veda il punto 2 infra per maggiori dettagli sulla questione delle barre e degli apici e per le indicazioni in merito che leggiamo in Diofanto
71 Come accennato questa tavola dei sottomultipli coincide con quella descritta ed esposta nei Prolegomena Fatto molto rilevante i numerali nella prima non recano neacute barre neacute apici contrariamente a quanto accade a tutte le istanze della seconda nei manoscritti Quella del Laur Plut 2818 preserva a mio avviso la forma originaria come abbiamo visto una tavola non richiede segni aggiuntivi sulle lettere numerali
72 Si vedano come esempio ancora le tavole citate alle note 10 e 14 supra oppure per una rassegna delle forme che il segno assume nei manoscritti piugrave antichi delle Tavole facili Tihon 2011 pp 58-59 e per quelle che assume nei papiri Jones 1999 I pp 61-62 Ovviamente non possiamo leggere il segno 65926 come un omicron con una barra in quanto ο = 70 nella notazione greca e la barra egrave di rigore quando il numerale figuri allrsquointerno di un testo Occorre ammettere che si dagrave origine ad un bel corto circuito notazionale con il concepire un segno con funzione di lsquoposto vuotorsquo ma che lsquosomigliarsquo ad una lettera dellrsquoalfabeto sormontata da una barra cioegrave ad un numerale in piugrave quando il lsquoposto vuotorsquo non corrisponda ad un intero ma ad una specie sessagesimale la presenza della barra a priori indistinguibile da quella che sormonta gli interi introduce unrsquoincongruenza con la notazione a mezzo di apici vista nellrsquoitem precedente
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 151
d) Errori di copia La tabella riprodotta nella tav 2b ha una forma simmetrica ma si tratta di una forzatura il grande rettangolo in basso a destra drsquoaltronde assente nella descrizione contiene uno scolio che fa notare come lrsquoultimo resto parziale ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ͵γτνζ´´´´´ κζ´´´´´´ cioegrave 0 0 0 0 0 3357 27 siano ἔγγιστα λ´λ´ δ´δ´ ξ laquocon ottima approssimazione 60 minuti quartiraquo dove si notino gli apici semplici per indicare il pas-saggio allrsquoordinale e il raddoppiamento del sistema segno + apice per significare il plurale Lo scolio debitamente accompagnato dal segno di rimando in forma di simbolo solare egrave stato probabilmente incluso nella tabella proprio allo scopo di renderla simmetrica A sua volta un errore precedente spiega lo spazio eccessivo accordato al rettangolo contenente lo scolio il secondo massimo multiplo ŏ λβ´ ξδ´´ ριβ´´´ σιϛ´´´´ egrave trascritto anche al di sotto del risultato
Passiamo ora alla descrizione del metodo di divisione attribuito a Pappo
ἵνα οὖν ταῦτα συναχθῇ τὰ ἐκ τοῦ μερισμοῦ ὁ εἰρημένος Πάππος εὐδιατύπῳ τινὶ καὶ πρὸς τοῦτο τάξει χρησάμενος ποιεῖται τὴν τῆς συλλήψεως τοῦ ζητουμένου ἀνεύρεσιν οὕτως ἐκθέμενος γὰρ τὸν μέλλοντα μερίζεσθαι τουτέστι τὰς τξ μοίρας ἐν ἀρχῇ ἀφαιρεῖ ἀπ᾽ αὐτῶν τὸν ἐν τῇ σελίδι τυγχάνοντα ἐλάττονα τουτέστι τὸν τδ κβ´ κ´´ ὄντα τῶν ἐγγὺς ἐλασσόνων ὡς πρὸς τοὺς ἐκκειμένους διὸ καὶ γράφει αὐτὸν προγράφων αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε καὶ εὑρίσκων τὰ παρακείμενα αὐτῷ τῷ ἀπογραφέντι ἐν τῷ σελιδίῳ λεπτὰ πρῶτα ν´ συναπογράφεται παρατιθῶν αὐτοῖς τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον ἀνατείνουσαν σημαῖνον τὸ εἶδος ὅτι πρῶτα λεπτά εὑρίσκει οὖν οὕτως τὸ τῶν τξ μέρος τὸ τδ κβ´ κ´´ ὃ μεριζόμενον παρὰ τὰς τξε ιδ´ μη´´ ἡμέρας καὶ ποιοῦν τὸν ἐκ τοῦ μερισμοῦ ἀριθμὸν πρῶτα λεπτὰ ν´ καὶ τὸν λοιπὸν ἀπογραφόμενος τὸν νε λζ´ μ´´ προτάσσει αὐτοῦ τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά τάσσει δὲ καὶ ἁπλῆν τινα διατείνουσαν γραμμὴν ὡς ἀπὸ τοῦ τξ ἐπὶ τὸν ἑξῆς ἐκτεθειμένον ἐγγὺς
1
5
10
1 εὐδιατύπῳ] ZSPC εὐδιατύπωτ M 4 ἀφαιρεῖ] MZSP ἀφ ι C 5 ἐλάττονα] P comp MZSC 6 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | αφ ] αφ ε M ἀφ ZS ἀφαί P ἄφ C | ἀντὶ] om C | ἄφελε] MZSP ἄφ C 8 ἀπογραφέντι] MZSP ἐγγραφέντι C | λεπτὰ πρῶτα] P λε πρωτα SC λεπτῶν πρωτ MZ | παρατιθῶν] MZS παρατιθεὶς C et ex corr m 2 P 9 ᾱ] Z αο P α´ MS α C | ἔχον] MPC ἔχων ZS 9-10 πρῶτα λεπτά] ZP πρωτ λ´λ´ M πρωτα λε S αα λε C 11 ἡμέρας] comp codd | ἀριθμὸν] P et comp MZ καὶ C et comp S 12 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M πρωτ λεπτ(α) Z πρωτ λ εᾱ S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C | ἀπογραφόμενος] MZSP ἐγγραφόμενος C | νε λζ´] MZSP λζ νζ C 13 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | λ οι] MZSC ex λ fecit λ οι P | προσσημαῖνον] MC et προσ- comp ZS προση- P | τὸ] MZC τὰ S et fecit m 2 P 14 ἀπὸ] MZSP πρὸς C ἐλάττονα] P comp MZSC
1 εὐδιατύπῳ] εὐδιατυπώτω K 6-7 αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ] τὸ ἀφ K 8 παρατιθῶν mdash 10 λεπτά] τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ σημαίνουσαν τὸ εἶδος αὐτῶν ὅτι ᾱ λεπτά εἰσιν K | τὸ (sec)] τὰ K 12 πρῶτα] πρώτων K | τε λ ] λ οι` K | προσσημαῖνον mdash
Fabio Acerbi152
ἐλάττονα τὸν τδ κβ´ κ´´ ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις καὶ ταύτην ἐπιδεικνύουσαν τὴν τάξιν τῆς προόδου τῆς ἐκθέσεως ἧστινος κλωμένης γραμμῆς πρὸς τῷ ἐγγὺς ἐλάσσονι ἡ ἀντανάκλασις ἐπὶ τὸν λοιπὸν γέγραπται φερομένη ὡς εἴρηται διὰ τὸ εὔτακτον τῆς προκοπῆς οὕτως τε ποιήσας ἑξῆς τὸ αφ ποιῶν ὃ προσσημαίνει ὡς εἴρηται τὸ ὅτι δεῖ ἀφελεῖν ὁμοίως ἀπὸ τοῦ λοιποῦ καὶ δὴ τὸν ἐγγὺς πάλιν ἐλάσσονα ὡς πρὸς τὴν ἐν τῷ σελιδίῳ ἔκθεσιν εὑρισκόμενον λαμβάνων ἑξῆς προγράφει αὐτὸν ὄντα νδ μζ´ ιγ´´ ιβ´´´ καὶ εὑρίσκει αὐτοῖς παρακείμενα ἐν τῷ σελιδίῳ πρῶτα λεπτὰ θ´ ἅτινα καὶ αὐτὰ προσαπογράφεται σὺν τῇ παρασημειώσει τῶν πρώτων γράφων τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον τὴν ἀνατείνουσαν καὶ ὡς εἴρηται τὴν γραμμὴν πάλιν διὰ τὴν τάξιν κλωμένην κατὰ δευτέραν κλάσιν προσέλκει γινομένου τοῦ μέρους αὐτῆς τούτου παραλλήλου τῷ ἐξ ἀρχῆς
16 ante κλωμένης add ἐπὶ C 18 τε] MZP om SC | αφ ] M ἀφ ZSC ἀφαί P 19 προσσημαίνει] MS προση- ZC et ex corr P | ὅτι] ZP comp MSC 20 δὴ] MZSC διὰ fecit m 2 P 21 πρὸς] MSP et supra lineam C ex ἀπὸ fecit m 2 Z | ιγ´´] MZSP νγ´´ C 22 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M ᾱᾱ λεπτὰ Z άάα λε S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C 23 προσαπο- γράφεται] απο suprascr in comp M 24 ᾱ] ZP α´ MS α C 25 κλάσιν] MP τάξιν ZSC | τοῦ] ZSPC τούτου M 26 τούτου] τοῦ bis ZSPC sed prius erasit m 2 P τοῦ M
mdash 18 προκοπῆς] om K | τε ποιήσας] ποιήσας καὶ K | αφ ] ἀφ K 19 τὸ] om K 21 προ-γράφει] γράφει K 22 σελιδίῳ] α´ σελιδίῳ K | ἅτινα] ἃ K 23 προσαπογράφεται] ἀπογράφεται K | τῶν πρώτων mdash 26 ἐξ ἀρχῆς] om K
lsquoAllo scopo di raccogliere ciograve che risulta dalla divisione il detto Pappo utilizzando anche in questo caso una certa disposizione ben strutturata determina nel modo seguente il lsaquonumerorsaquo cercato preso nel suo insieme collocando73 in testa il lsaquonumerorsaquo che sta per essere diviso cioegrave i 360 gradi iniziali sottrae loro tra i piugrave prossimi dei lsaquonumerirsaquo minori rispetto a quelli esposti quello che si trova essere minore nella colonna (cioegrave 304 22 20) Questo egrave il motivo per cui lo trascrive scrivendogli davanti lrsquoabbreviazio-ne laquosottrraquo per laquosottrairaquo e trovando che 50 minuti primi sono collocati accanto a quello stesso lsaquonumerorsaquo che egrave stato trascritto nella colonna li trascrive al tempo stesso collocando accanto74 ad essi la lettera A con un lsaquotrattorsaquo75 sopra che significa la specie minuti primi Trova dunque in que-sto modo la parte di 360 che egrave 304 22 20 la quale divisa per 365 giorni 14 48 fa il numero lsaquoche risultarsaquo dalla divisione 50 minuti primi Trascrivendo
73 La descrizione egrave strutturata come una procedura Acerbi 201274 Il purismo del correttore del Par gr 2390 di Clostomalle nel Marc gr 314 e
dellrsquoautore della recensione bizantina impone loro di modificare la terminazione ma forme tematiche e contratte di τιθεῖν sono correnti nel greco tardivo
75 Il testo greco ha solo il participio con γραμμήν sottinteso Per il significato del participio si veda il punto 2
15
20
25
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 153
poi il resto 55 37 40 gli pone altresigrave76 a prefisso laquoReraquo che significa laquorestiraquo e dispone anche una certa linea semplice77 che va da 360 al piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori che egrave esposto di seacuteguito 304 22 20 come nello lsaquoschemarsaquo esposto linea che mostra lrsquoordine del percorso dellrsquoesposizione Questa linea spezzata lagrave dove si trova il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori egrave tracciata inflessa allrsquoindietro lsaquoersaquo punta verso il resto come egrave stato detto in vista di una progressione ordinata E cosigrave facendo prendendo di seacuteguito il laquosottrraquo che significa come egrave stato detto laquoche occorre similmente sottrarre dal re-storaquo e ovviamente prendendo di nuovo il lsaquonumerorsaquo che egrave trovato essere il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori in relazione alla disposizione nella colonna ndash 54 47 13 12 ndash lo scrive di seacuteguito e trova che 9 minuti primi sono posti loro accanto nella colonna trascrive78 anche questi con la segnaletica dei primi scrivendo la lettera A con un lsaquotrattorsaquo sopra e come egrave stato detto prolunga di nuovo la linea spezzata in vista di una buona disposizione tramite una seconda inflessione essendo questa sua parte parallela a quella inizialersquo
La descrizione continua con una serie di laquoe cosigrave viaraquo e non fa ulte-riore riferimento alla tabella
1) La forma verbale ἐξεσμένον Egrave il neutro del participio perfetto medio-passivo di ξέω lett laquopialloraquo laquolevigoraquo Si danno tre possibilitagrave si tratta di un termine canonico per quanto non altrove attestato per designare unrsquoabbreviazione oppure lrsquoautore anonimo improvvisa sul piano metaforico come se unrsquoabbreviazione non fosse altro che la paro-la completa lsquoaccorciata a colpi di piallarsquo in maniera opportuna oppure il testo egrave corrotto e srsquoimpone una correzione ad esempio τὸ ἑξῆς μένον laquociograve che sta di seacuteguitoraquo Questrsquoultima strada mi pare chiusa dal senso delle frase lrsquoabbreviazione non lsquosta di seacuteguitorsquo a niente ma anzi precede la perifrasi τὸ ἑξῆς μένον se impiegata semplicemente per rimandare al segno αφ immediatamente seguente costituirebbe un intollerabile solecismo Se accettiamo la prima di queste letture considerando quin-di lrsquoabbreviazione αφ in posizione predicativa abbiamo a che fare con
76 Rendo in questo modo il τε isolato77 La linea egrave laquosempliceraquo in quanto egrave una retta la precisazione intende evidenziare per
anticipazione il carattere lsquonon semplicersquo che essa assumeragrave alla prima inflessione quando diventeragrave una spezzata linee siffatte erano in effetti concepite dallrsquoanonimo e prima di lui da tutta la tradizione matematica greca come una singola linea spezzata nei punti drsquoinfles-sione I due segmenti paralleli menzionati al termine del passo sono orizzontali
78 Il verbo egrave al medio in variatio rispetto ai due che precedono e che seguono egrave il matematico che lsquosirsquo trascrive le cifre
Fabio Acerbi154
uno hapax semantico nella grecitagrave superstite come egrave facile verificare con una ricerca sul TLG in rete La recensione bizantina risolve il pro-blema sopprimendo semplicemente τὸ ἐξεσμένον
2) La notazione per le specie numeriche Nella terminologia matema-tica greca gli ordini sessagesimali sono εἴδη laquospecieraquo numerici essi corri- spondono agli ordini di grandezza nel nostro sistema decimale e indica-no in analogia con il caso geometrico la lsquoformarsquo che assume un numero quadrato cubo ecc Centinaia e migliaia sono quindi degli εἴδη rispet-tivamente quadrati (100 egrave il quadrato di 10) e cubi (1000 egrave il cubo di 10) sono specie numeriche ma non numeri particolari e drsquoaltronde 300 non egrave un quadrato ma 3 item dellrsquoεἶδος lsquoquadratorsquo 100 3 egrave il numerale di molteplicitagrave della specie quadrata lsquocentinaiarsquo i due 0 che seguono il 3 segnalano esattamente questo fatto che la notazione greca per gli interi non posizionale fa scomparire al livello denotativo Ciograve non vale soltan-to per i numeri interi ma anche per le loro parti i minuti secondi appar-tengono alla specie lsquoquadratorsquo in quanto 13600 egrave il quadrato di 160
La concezione appare interamente dispiegata nellrsquointroduzione degli Arithmetica diofantei79 che si rivela giova farlo rimarcare un te-stimone fondamentale per la ricostruzione della notazione matematica antica Alle specie usate in questrsquoopera vengono assegnati una denomi-nazione ed un segno convenzionale costituito dallrsquoiniziale (di ognuno dei componenti) della denominazione al quadrato o δύναμις il segno ΔΥ al κύβος il segno ΚΥ alla lsquoquarta potenzarsquo o δυναμοδύναμις il segno ΔΥΔ ecc La descrizione di tali segni egrave del tipo καὶ ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον Κ ἐπίσημον ἔχον Υ ΚΥ κύβος laquoe il suo segno egrave un Κ che ha come indice un Υ ΚΥ cuboraquo dove in accordo con quanto abbiamo visto nel punto b supra e pur nel comprensibile imbarazzo del copista della prima parte del Matritensis (o di un suo passato collega) a districarsi in questo formidabile ginepraio notazionale80 le due lettere Κ e Υ ricevono una barra mentre ΚΥ non la richiede a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον il quale ancora una volta esclude automaticamente il segno dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
79 In particolare a DOO I pp 214-62180 Nel Matr 4678 riscontriamo i seguenti fenomeni nelle poche righe a cavallo dei ff
58r-v 1) accento acuto posto su tutti i segni come se fossero abbreviazioni 2) ripetizione sistematica segnodenominazione come in ΚΥ κύβος appena letto dovuta sicuramente allrsquointrusione di glosse interlineari esplicative dei segni ndash e successivo pentimento (δύναμις e κύβος sono in effetti cancellati dalla prima mano il primo con un tratto il secondo con dei punti supra lineam poi il copista si stanca di correggere) 3) nella descrizione del segno per la δυναμοδύναμις menzione di un δέλτα δύο che saragrave molto probabilmente stato ΔΔ subito dopo nella descrizione del κυβόκυβος si legge un incongruo δύο KK
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 155
Diofanto introduce poi dei segni anche per le specie delle parti dellrsquounitagrave (le nostre frazioni) che egli chiama ὁμώνυμα μορία laquoparti omonimeraquo di cui quelle sessagesimali sono casi particolari81 Egli spie-ga appunto che le loro denominazioni sono ottenute da quelle delle specie degli interi per sinonimia passando ad un lsquoordinalersquo82 formato semplicemente aggiungendo il suffisso -στον δυναμοστόν κυβοστόν δυναμοδυναμοστόν ecc (sott μόριον) I loro segni convenzionali sono invece ottenuti da quelli per le specie degli interi aggiungendo una γραμμὴν διαστέλλουσαν τὸ εἶδος laquolinea che distingue la specieraquo83 Una linea sui segni delle specie delle parti egrave richiesta si badi bene per distinguerli dai segni di quelle degli interi come giagrave osservato questi ultimi sono giagrave lsquoagrammaticalirsquo a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον a fortiori lo saranno anche i primi Si tratta della traduzione semio-tica del passaggio dal cardinale allrsquoordinale che a livello grammaticale egrave effettuato con il suffisso -στον Che forma ha questa linea Barra o apice (Egrave cervellotico pensare a forme piugrave complesse) La domanda non ammette una risposta immediata in quanto delle specie diofantee nessuno piugrave si occupa nellrsquoantichitagrave84 Se egrave vero che la prima risposta darebbe origine ad un conflitto tra due convenzioni denotative diffe-renti la barra lsquocitazionalersquo e la barra che distingue la specie lrsquoevidenza grafica del Matritensis lascia lievemente sgomenti (ricordiamoci che giagrave i segni di base sono indebitamente dotati di un accento dal copista) Le poche occorrenze del segno per le specie delle parti85 vedono lrsquoaggiunta di uno slash di sospensione di un doppio apice inverso ndash in tutta evi-
81 Questo fatto era giagrave chiaro nellrsquoantichitagrave Teone in Alm I 10 in iA p 45310-1682 Il parallelo con i cardinali e gli ordinali relativi agli interi egrave reso esplicito da Dio-
fanto ὥσπερ δὲ τῶν ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια παρομοίως καλεῖται τοῖς ἀριθμοῖς τοῦ μὲν τρία τὸ τρίτον τοῦ δὲ τέσσαρα τὸ τέταρτον οὕτως καὶ τῶν νῦν ἐπονομασθέντων ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια κληθήσεται παρομοίως τοῖς ἀριθμοῖς laquocome le parti omonime dei numeri sono chia-mate per assonanza con i numeri di lsquotrersquo lsquolsaquounrsaquo terzorsquo di lsquoquattrorsquo lsquolsaquounrsaquo quartorsquo cosigrave le parti omonime dei numeri appena nominati saranno chiamate per assonanza con i numeriraquo (DOO I p 69-13 si noti lrsquoarticolo lsquocitazionalersquo al singolare in τοῦ τρία e τοῦ τέσσαρα) Il parallelo prosegue anche al livello dei segni che rappresentano queste specie come vedremo tra un attimo
83 Diofanto Arithmetica prefazione in DOO I p 620-21 un passaggio maltrattato in questa edizione occorre espungere il participio ἔχον senza introdurre segni ulteriori oppure eliminare un precedente ἐπί come fa un correttore del Matritensis f 58v
84 Unica parzialissima eccezione lrsquoaccenno di Teone menzionato nella nota 81 supra85 Al f 59r e per di piugrave nel margine per sanare un lungo saut du mecircme au mecircme La
collocazione in margine egrave il motivo per cui troviamo una notazione abbreviata nel resto del trattato il primo copista scioglie tutti i segni prendendoli per abbreviazioni mentre il secondo elimina sistematicamente il tratto aggiuntivo delle specie delle parti dellrsquounitagrave Drsquoaltronde egli scrive ad esempio ΔΥ invece di ΔΥ ed egrave quindi indotto a porre la barra al di sopra della stringa di lettere risultante (passim ma si veda ad esempio il f 72r)
Fabio Acerbi156
denza il compendio per la desinenza -ον accentata il copista interpreta il segno come unrsquoabbreviazione ndash e di una barra a sormontare lo Υ Potremmo forse interpretarlo come il segno di contrazione del grafema -στ- lrsquounico tassello mancante in unrsquoabbreviazione come ad esempio (δυναμοδυναμο)(στ)(ὸν) ma uno scolio di prima mano al f 58v rela-tivo alle specie degli interi inficia questrsquoipotesi esse sono dotate di slash di sospensione accento acuto in un caso del compendio canonico per la terminazione -ον hellip ma tutti gli Υ a esponente sono a loro volta sormontati da una barra
Meno legata al singolo manoscritto ma nondimeno non uniforme si presenta la pratica di notazione dei segni che rappresentano gli enti numerici sessagesimali86 da una parte sta lrsquoevidenza del testo dei Pro-legomena e delle sue tabelle apici ndash drsquoaltronde come abbiamo visto la notazione universalmente impiegata per i numerali ordinali e per le fra-zioni unitarie ndash dallrsquoaltra sta lrsquoevidenza del testo dellrsquoAlmagesto in tutti i manoscritti piugrave antichi e lo stesso si dica del commentario teonino a questrsquoopera o del suo lsquoGrande commentariorsquo alle Tavole facili e dei testi astronomici su papiro barre87 Sembra insomma che la nostra docu-
86 Sia le molteplicitagrave che le specie ahimeacute entrambe rappresentate da lettere dellrsquoalfabeto Come osservato allrsquoinizio della sezione 3 ci sono in effetti due tipi di lettere numerali in gioco se facciamo astrazione da apici o barre lsquo4 minuti secondirsquo si trova scritto δ β la prima lettera numerale denota la molteplicitagrave degli item di una certa specie la se-conda la specie nei Prolegomena entrambe sono accompagnate da un doppio apice il che rende inutile la presenza delle seconde Si noti che la descrizione della tabella non fa parola della notazione da usare per le lettere numerali che denotano la molteplicitagrave barre o apici e quanti apici hellip In questo caso fa interamente fede la tabella cioegrave la pratica grafica condivisa instauratasi non egrave chiaro quando
87 I manoscritti piugrave antichi dellrsquoAlmagesto sono menzionati nella nota 10 supra quelli dei due commentarii teonini sono il Laur Plut 2818 e il celeberrimo Vat gr 190 (sec IX in Euclide Elementi Data Teone lsquoGrande commentariorsquo) per la notazione dei pa-piri astronomici si veda Jones 1999 II passim La notazione non sembra lsquoinquinatarsquo dalla pratica dei copisti bizantini e pare dipendere soltanto dalla data di composizione Tro-viamo ad esempio barre sopra tutti i numerali di molteplicitagrave (interi o sessagesimali) nel frammento di un commentario alle Tavole facili contenente un calcolo relativo al 24 aprile 213 (Par gr 2841 sec XIII ex-XIV in oltre al frammento ai ff 32r l 11-34v l 23 contiene Arato Phaenomena ed Efestione Apotelesmatica edizione in Jones 1990) Nel commentario alle Tavole facili composto ca 610-617 ed attribuito a Stefano di Alessandria la situazione egrave la seguente (Jean Lempire per litteras per lrsquoedizione si veda Lempire 2014 ho controllato il Vat gr 304 ff 135r-171v sec XIV am contiene in aggiunta Teone in Almagestum I-II lsquoPiccolo commentariorsquo alle Tavole facili Diofanto Arithmetica e De polygo-nis numeris varia astronomica tabulae) barre sopra gli interi sporadicamente rimpiazzate da apici apici sopra le parti sessagesimali in numero uguale alla denominazione doppio () apice per le frazioni unitarie Sono impiegate barre sopra gli interi e apici sopra le parti sessagesimali nei manoscritti principali di tutti i trattati di introduzione allrsquoAlmagesto o comunque di argomento logistico redatti in epoca bizantina Giorgio Pachimere (1242-ca 1310) Quadrivium (autografo nel manoscritto Roma Biblioteca Angelica gr 38 [RGK III nr 115] si veda Tannery ndash Steacutephanou 1940 per lrsquoedizione) Teodoro Metochita (1270-
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 157
mentazione si faccia testimone di un cambio notazionale avvenuto nel periodo intercorrente fra Teone (sec IV pm) e la scuola alessandrina di Ammonio e dei suoi allievi (sec VI in) e probabilmente innescato da questrsquoultimo ambiente lrsquoaspetto paradossale egrave che nello stesso codice si rintraccino due notazioni differenti per gli enti numerici sessagesimali e lrsquouna (apici) sia adottata sistematicamente e coerentemente in uno scritto (i Prolegomena) che si presenta esattamente come unrsquointroduzione tecnica alla pratica numerico-algoritmica del trattato (lrsquoAlmagesto) in cui egrave adottata lrsquoaltra (barre che ritroviamo senza eccezioni anche negli scolii)
Torniamo ai Prolegomena la descrizione del segno da porre a fianco di ogni singolo quoziente parziale e denotante la sua specie numerica (minuti primi minuti secondi ecc) solleva tre problemi
Primo problema Ci vuole una barra o un apice su τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquola lettera A [hellip] che significa la specieraquo quando lo scriviamo nella tabella Tutta la nostra discussione precedente fa pro-pendere per lrsquoapice e si ricordi anche la forma verbale ἀνατείνουσαν che suggerisce qualcosa che si lsquoestende verso lrsquoaltorsquo (la mia traduzione egrave volutamente neutra) se fosse apposta una barra la cosa dovrebbe passare
1231332) Compendium astronomicum (copia lsquoautorizzatarsquo coeva nei Vat gr 182 e 181 da parte del copista che integrograve le parti mancanti del Par gr 2389 [ff 207-210 255-270 374-375] Bianconi 2005a pp 425-427 Peacuterez Martiacuten 2008 p 436 e n 177) Teodoro Meliteniota (morto lrsquo831393) Tribiblos astronomica (autografo nel Vat gr 792 si vedano Leurquin 1991 per unrsquoanalisi del manoscritto Leurquin 1990 per lrsquoedizione) una com-pilazione anonima (per cui ho consultato il Par gr 2396 ff 87r-92v limitatamente a questi fogli manu Costantino Trivoli [RGK II nr 318 ma ovviamente questo codice non vi egrave segnalato] terzo quarto del XV secolo il resto del codice annotato da Niceforo Gregora egrave di etagrave planudea e parzialmente [ff 33v-76v] un autografo di Planude stesso contiene Teone in Almagestum I II IV Mondrain 2002 il codice va completato ndash limitatamente a stralci dei libri VIII-X XII-XIII del commentario teonino la cui parte intermedia si egrave persa ndash con 26 carte [ff 123-147] inserite nel Vat gr 1087 anchrsquoesso contenente anno-tazioni di Gregora Rome 1927 per la figura del copista dei ff 77r-86r del Par gr 2396 e dei ff appena nominati del Vat gr 1087 un anonimo collaboratore di Gregora si veda in ultimo Bianconi 2006a pp 147-151) si veda anche il calcolo effettuato da Niceforo Gre-gora (12921295-13581361) dellrsquoeclisse di sole del 16 luglio 1330 (attestata unicamente ai ff 1r-8v della miscellanea astronomica Marc gr 325 databile ca 1324-1329 in parte vergata e ovunque fittamente annotata da Gregora stesso edizione del testo in Mogenet et al 1983 annotazioni di Gregora elencate in Bianconi 2005a p 413) Unrsquoeccezione apparente il lsquoPiccolo commentariorsquo di Teone alle Tavole facili le parti sessagesimali sono segnalate da apici (ad esempio nel Vat gr 175 vergato da Giovanni Catrario e completato nel 1321-1322 sulla figura di Catrario si vedano in ultimo Bianconi 2005b pp 141-156 e 2006b) lrsquoopera egrave antica ma la sua tradizione non rimonta oltre la fine del XIII secolo a parte un frammento nel Leiden BPG 78 ff 156r-161v (minuscola del IX-X secolo) e in effetti in questo manoscritto tutti i numerali di molteplicitagrave sono sormontati da barre Unrsquoeccezione effettiva egrave il De hypotesibus planetarum nel Vat gr 1594 barre sugli interi e apici sulle parti sessagesimali
Fabio Acerbi158
sotto silenzio e la presenza dellrsquoapice la rende inutile88 Si tratta della stessa convenzione diofantea e coincide ancora con la notazione per i numerali ordinali e per le frazioni unitarie che egrave corrente nei mano- scritti matematici greci per questo motivo non percheacute la descrizione sia particolarmente perspicua nessuno dei copisti della recensione an-tica ha incertezze apici Ma questi apici si rintracciano soltanto sulle indicazioni di specie non contemplate dalla descrizione che sono ante-poste ai resti parziali a fianco dei quozienti parziali i segni di specie sono invece trasformati in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordi-nali corrispondenti del tipo πρωτ tavv 5 e 7b-8 Il recensore bizantino taglia invece la testa al toro elimina dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali elimina la seconda menzione della laquolet-tera Araquo contestualmente allrsquoazzeramento dellrsquoespediente della linea a zig-zag (si veda il punto seguente) modifica la descrizione che contiene la prima menzione in quella dellrsquoapice associato direttamente ai nume-rali di molteplicitagrave riciclando addirittura lrsquoalpha per adibirlo a desi-gnare un numero cardinale (come sorprendersi) τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ laquoponendo al di sopra di essi [scil dei 50 minuti primi] 1 solo lsaquoaccentorsaquo acutoraquo La scelta del recensore egrave assennata che rechi una barra o un apice in una tabella un alpha denota un numero non un numero drsquoordine
Secondo problema da tenere ben distinto dal precedente Cosa ci vuole sul segno α per la lettera alpha menzionata nella frase τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquolettera A [hellip] che significa la specieraquo89 Unrsquooc-chiata allrsquoapparato critico rivela una bella incertezza nei manoscritti Z scrive sempre ᾱ e in un caso lo fa anche P MS optano sempre per α´ C per α P scrive nellrsquoaltro caso αο Per quanto solo la barra sia congrua con il senso della frase in quanto la lettera alpha egrave qui menzionata (si tratta di un oggetto che compare nella tabella) e non cambia niente se essa egrave accompagnata dal suo nome di genere στοιχεῖον ad un livello grafico lrsquoincertezza fra il segno ᾱ che denota laquola lettera αraquo e il segno α´ (o lrsquoabbreviazione αο) per una forma di πρῶτος egrave per piugrave versi giustificata
88 Detto in altri termini la barra egrave uno strumento grafico non matematico e quindi la sua presenza non va segnalata mentre un apice lo egrave e la sua presenza lo deve
89 Notare che in questa frase il primo α non vuole la barra (egrave menzionato allrsquointerno di una frase che impiega convenzioni moderne) il secondo sigrave (idem ma con convenzioni antiche) ndash e nella traduzione la scelta di denotarlo con A (senza virgolette) e non con lsquoArsquo (con virgolette) egrave del tutto arbitraria ndash si noti inoltre che le necessarie precisazioni laquosenzacon virgoletteraquo mostrano che le lingue moderne palesano difficoltagrave analoghe a quelle del greco antico per quanto riguarda i livelli denotativi in ambito metadiscorsivo per non usare le due parentetiche avrei dovuto scrivere rispettivamente lsquoArsquo e lsquolsquoArsquorsquo (doppie virgolette semplici)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 159
ᾱ coincide con il numerale 1 α egrave la prima lettera dellrsquoalfabeto ed inoltre α´ egrave esattamente quello che va scritto nella tabella Potremmo dirci che il sostantivo στοιχεῖον chiude la questione la sua presenza congiunta ad un ipotetico α´ renderebbe la descrizione ridondante o inappropriata90 Ma a parte il fatto che α egrave proprio τὸ πρῶτον στοιχεῖον il segno α´ cat-tura in fondo il cuore della descrizione di uno στοιχεῖον ἔχον lsaquoγραμμὴνrsaquo ἀνατείνουσαν
Terzo problema Lrsquoautore dei Prolegomena che si arresta allrsquoesem-pio dei minuti primi non dice quanti apici occorre mettere sulle lettere numerali che identificano gli ordini superiori al primo se uno soltanto come nel caso diofanteo e delle frazioni unitarie o in numero uguale alla loro denominazione (cioegrave pari al numero denotato dal numerale stesso su cui vanno posti) come effettivamente avviene nei mano-scritti dei Prolegomena La tabella egrave quindi sottodeterminata dalla sua descrizione anzi in un certo senso prende il sopravvento su di essa la pratica di marcare i numerali di molteplicitagrave con gli apici che compe-tono allrsquoordine cui appartengono viene trasferita ai segni per gli ordini stessi per supplire ad una descrizione carente di questi ultimi E la tabella egrave sottodeterminata dalla descrizione in quanto egrave la descrizione di una tabella reale ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις laquocome nello lsaquoschemarsaquo espostoraquo leggiamo a un certo punto del testo
3) La linea a zig-zag Non possiamo che applaudire a questo geniale espediente grafico lo troviamo messo in opera solo nel Marc gr 313 Per quanto lrsquoautore non faccia parola di ciograve nel corso della sua descrizione la linea spezzata egrave intesa dover lsquosaltarersquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue Il copista del codice marciano effettua correttamente due salti nella prima delle sue tabelle (tav 4) ma inserisce un lsquodentersquo in piugrave in quella che considera corretta (tav 5) La linea a zig-zag egrave incompatibile con la presenza di linee di giustificazione nella tabella che in effetti mancano nel Marc gr 313 ciograve induce gli errori di allineamento dei primi 5 quozienti parziali di cui egrave vittima il copista Probabilmente per questo motivo in nessuno degli apografi del Vat gr 1594 la linea a zig-zag figura nella tabella inquadrata come si conviene da una (doppia) cornice esterna e le cui colonne sono appunto separate da linee verticali (tav 7b Vat gr 184 f 17v e tav 8 Par gr 2390 f 9v cui egrave sostanzialmente identica la tabella del Marc gr 314 che si trova
90 Trascuro lrsquoabbreviazione αο = πρῶτος percheacute la desinenza non egrave quella richiesta neacute nella frase (egrave richiesto πρῶτον) neacute nella tabella (πρῶτα)
Fabio Acerbi160
al f 248r ndash ma la mancanza di linee orizzontali causa un gigantesco pa-sticcio nel codice vaticano) Alla recensione bizantina che dipende per il suo testo di base dal Vat gr 1594 e quindi non trova la linea a zig-zag nella tabella non resta che sopprimere la sua descrizione ndash ma proprio per questo motivo e finalmente diventa possibile tracciare un apparato completo di linee di giustificazione (tav 9 Laur Plut 89 sup 48 f 14v) Dato che la descrizione di Teone di questo procedimento di divi-sione non fa cenno allrsquoesistenza della linea a zig-zag viene da chiedersi se essa non costituisca un espediente escogitato dallrsquoautore dei Prolegomena per vivacizzare la procedura originale di Pappo
4) Discrepanze tra descrizione e tabella Il gioco delle minime va-rianti mostra che la divisione era stata eseguita (e trasmessa) corret-tamente tutti i valori numerici sono esatti La tabella nel Marc gr 313 presenta perograve alcune discrepanze con la propria descrizione Essa omette (ma non nella versione lsquoscorrettarsquo lrsquoomissione non si riscontra neanche nel Par gr 2390) il segno per laquorestoraquo di fronte ai resti par-ziali ma aggiunge lrsquoindicazione della loro specie Essa trasforma invece come abbiamo visto le indicazioni di specie che seguono i quozienti parziali in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordinali corri-spondenti La descrizione prevede di chiudere la tabella con il risultato καὶ συνάγων ἅπαντα τὰ ἐκ τῶν μερισθέντων μερῶν λεπτὰ σημειοῦται ὑπὸ πάντας οὕτως γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoe raccogliendo tutti i minuti che provengono dalle parti divise lsaquoPapporsaquo nota sotto tutto cosigrave Ris 0 59 8 17 13 12 31raquo ma sotto la tabella tutta la tradizione ci consegna qualcosa di piugrave articolato ὁ ζητούμενος καθ᾽ ὃν μερίζεται ὁ τξε ιδ´ μη´´ π(αρὰ) τὸν τξ γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoil lsaquonumerorsaquo cercato secondo cui 365 14 48 egrave diviso per 360 risulta 0 59 8 17 13 12 31raquo frase che del resto contiene due errori lrsquoinversione del dividendo e del divisore e la confusione tra segno convenzionale (iuxta descrizione) e abbreviazione (come nella frase) nel caso di γι Oltre ad eliminare la linea a zig-zag91 la recensione bizantina sopprime dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali e modifica come abbiamo visto al punto 2 le loro descrizioni in quelle di apici associati diretta-mente ai numerali di molteplicitagrave
91 Le due righe che nella recensione di base contengono solo i resti parziali minori di 160 del divisore ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue sono in parte completate con lrsquoindicazione abbreviata ἀνάλ(υσις) laquoanalisiraquo il termine greco per questa procedura di riduzione In un sussulto di ipercorrettismo matematico tali resti parziali ridotti non sono preceduti dal segno per laquorestoraquo come nel Par gr 2390 ma da quello per laquorisultatoraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 161
Gli esempi che abbiamo discusso mostrano come i problemi di notazione pesino e non poco sullrsquoespressione discorsiva di un algorit-mo matematico lrsquoente di riferimento per lsquoformularersquo il procedimento di divisione fu considerata la tabella cioegrave un oggetto la cui costitu-zione egrave legata piugrave ad una pratica grafica che a considerazioni logico- algoritmiche non la sua descrizione che in effetti finisce per determi-nare la tabella in maniera non univoca Di questa sottodeterminazione si fa testimone la traiettoria che abbiamo cercato di seguire nelle mani di copisti e revisori il procedimento di divisione si modifica a volte in aspetti secondari a volte in punti piugrave sostanziali ndash fino a rendere neces-saria una radicale revisione della sua descrizione per renderla conforme alla tabella ndash in ogni caso mai per ragioni squisitamente matematiche92
Abstract
The article presents and discusses in detail two passages from the anonymous Prolegomena to the Almagest a VIth century primer to the elementary procedures of calculation needed in Ptolemyrsquos Almagest In the two passages we may follow the complex interplay between mathematical notation the auctor who employed and described it the tachygrapher who transcribed it in vivo copyists who reproduced it correctors who modified it Along this path misgivings and errors arise in the transmission of abbreviations and paratextual units such as diagrams tables operational schemes
Fabio AcerbiCNRS UMR8560 Centre Alexandre Koyreacute
fabacerbigmailcom
92 Sono grato a Daniele Bianconi Lucio del Corso Jean Lempire per alcune preziose indicazioni
AOO = Archimedis opera omnia cum commentariis Eutocii ed J L Heiberg I-III Lipsiae 1910-1915
DOO = Diophanti Alexandrini opera omnia cum Graecis commentariis ed P Tannery I-II Lipsiae 1893-1895
GC = Le laquoGrand Commentaireraquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Mogenet ndash A Tihon I-III Cittagrave del Vaticano 1985-1999
iA = Commentaires de Pappus et de Theacuteon drsquoAlexandrie sur lrsquoAlmageste ed A Rome I-III con paginazione continua Cittagrave del Vaticano 1931-1943
HOO = Heronis Alexandrini opera quae supersunt omnia ed G Schmidt ndash L Nix ndash W Schmidt ndash H Schoene ndash J L Heiberg I-V Lipsiae 1899-1914
PC = Le ldquoPetit Commentairerdquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed A Tihon Cittagrave del Vaticano 1978
POO = Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia ed J L Heiberg I-II in 3 parti Lipsiae 1898-1907
RGK = Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600 I Handschriften aus Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln II Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs und Nachtraumlge zu den Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln III Handschriften aus Bibliotheken Roms mit dem Vatikan A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg unter Mitarbeit von D Harlfinger und P Eleuteri B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln Wien 1981-1997 (Oumlsterreichische Akademie der Wissenschaften Veroumlffentlichungen der Kommission fuumlr Byzantinistik III1-3 A-C)
Sigla
Acerbi 2010 = F Acerbi Il silenzio delle sirene La matematica greca antica Roma 2010
Acerbi 2012 = F Acerbi I codici stilistici della matematica greca dimostrazioni procedure algoritmi laquoQUCCraquo 1012 (2012) pp 167-214
Acerbi et al 2010 = F Acerbi ndash N Vinel ndash B Vitrac Les Proleacutegomegravenes agrave lrsquoAlmageste Une eacutedition agrave partir des manuscrits les plus anciens Introduction geacuteneacuterale ndash Parties I-III laquoSCIAMVSraquo 11 (2010) pp 53-210
Agati 1992 = M L Agati La minuscola laquoBouleteacuteeraquo Cittagrave del Vaticano 1992
Belger 1881 = C Belger Ein neues Fragmentum mathematicum Bobiense laquoHermesraquo 16 (1881) pp 261-284
Bianconi 2005a = D Bianconi La biblioteca di Cora tra Massimo Planude e Niceforo Gregora Una questione di mani laquoSampTraquo 3 (2005) pp 391-438
Bianconi 2005b = D Bianconi Tessalonica nellrsquoetagrave dei Paleologi Le pratiche intellettuali nel riflesso della cultura scritta Paris 2005
Bianconi 2006a = D Bianconi Le pietre e il ponte ovvero identificazioni di mani e storia della cultura laquoBizantinisticaraquo 8 (2006) pp 135-181
Bianconi 2006b = D Bianconi Qualcosa di nuovo su Giovanni Catrario laquoMEGraquo 6 (2006) pp 69-91
Cavallo 1977 = G Cavallo Funzione e strutture della maiuscola greca tra i secoli VIII-XI in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Colloque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 95-137
Cereteli 1904 = G F Cereteli De compendiis scripturae codicum Graecorum praecipue Petropolitanorum et Mosquensium anni nota instructorum Sankt-Petersburg 1904
De Gregorio 2000 = G De Gregorio Materiali vecchi e nuovi per uno studio della minu-scola greca fra VII e IX secolo in G Prato (a cura di) I manoscritti greci tra riflessione e dibattito Atti del V Colloquio Internazionale di Paleografia Greca Cremona 4-10 ottobre 1998 Firenze 2000 pp 83-151
Follieri 1977 = E Follieri La minuscola libraria dei secoli IX e X in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Col-loque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 139-165
Fonkič 2005 = B Fonkič Venecianskaia rukopisrsquo laquoAlrsquomagestaraquo Ptolemeja (Marc gr 313690) o datirovke i proischoždenii kodeksa laquoVDIraquo s III 254 (2005) pp 162-167
Fowler 1999 = D H Fowler The Mathematics of Platorsquos Academy A New Reconstruction Second Edition Oxford 1999
Bibliografia
Fabio Acerbi164
Gerstinger ndash Vogel 1932 = H Gerstinger ndash K Vogel Eine stereometrische Aufgaben-sammlung im Papyrus Graecus [sic] Vindobonensis 19996 laquoMitteilungen aus der Papy-russammlung der Nationalbibliothek in Wienraquo Neue Serie Folge 1 Griechische literarische Papyri 1 Wien 1932 pp 11-76
Heiberg 1927 = Mathematici Graeci Minores ed J L Heiberg Kjoslashbenhavn 1927
Hultsch 1876-1878 = Pappi Alexandrini Collectionis quae supersunt ed F Hultsch I-III Berlin 1876-1878
Janz 2003 = T Janz The Scribes and the Date of the Vat gr 1291 in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae X Cittagrave del Vaticano 2003 pp 159-180
Jones 1990 = Ptolemyrsquos First Commentator ed A Jones Philadelphia 1990
Jones 1999 = Astronomical Papyri from Oxyrhynchus ed A Jones I-II Philadelphia 1999
Jones 2005 = A Jones Ptolemyrsquos Canobic Inscription and Heliodorusrsquo Observation Reports laquoSCIAMVSraquo 6 (2005) pp 53-97
Lempire 2014 = Steacutephanos drsquoAlexandrie Le commentaire aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Lempire Louvain 2014
Leurquin 1990 = Theacuteodore Meacuteliteacuteniote Tribiblos astronomique Livre I ed R Leurquin Amsterdam 1990
Leurquin 1991 = R Leurquin Un manuscrit autographe de la Tribiblos Astronomique de Theacuteodore Meacuteliteacuteniote le Vaticanus graecus 792 laquoScriptoriumraquo 45 (1991) pp 145-162
Maas 1927 = P Maas Griechische Palaeographie in A Gercke ndash E Norden (hrsg von) Einleitung in die Altertumswissenschaft I9 Leipzig 1927 pp 69-80
Martinelli Tempesta 2010 = S Martinelli Tempesta Il codice Milano Biblioteca Am-brosiana B 75 sup (gr 104) e lrsquoevoluzione della scrittura di Giovanni Scutariota in A B Garciacutea ndash I Peacuterez Martiacuten (ed by) The Legacy of Bernard de Montfaucon Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting Proceedings of the Seventh Inter-national Colloquium of Greek Palaeography Madrid-Salamanca 15-20 September 2008 Turnhout 2010 pp 171-186
Mazzucchi 1994 = C M Mazzucchi Leggere i classici durante la catastrofe (Costantino-poli maggio-agosto 1203) le note marginali al Diodoro Siculo Vaticano gr 130 Parte prima stratigrafia laquoAevumraquo 68 (1994) pp 164-218
Mioni 1976 = E Mioni Bessarione scriba e alcuni suoi collaboratori in Miscellanea marcia-na di studi bessarionei Padova 1976 pp 263-323
Mioni 1985 = Codices graeci manuscripti Bibliothecae Divi Marci Venetiarum II Thesaurus Antiquus Codices 300-625 recensuit E Mioni Roma 1985
Mogenet 1962 = J Mogenet Une scholie ineacutedite du Vat gr 1594 sur les rapports entre lrsquoastronomie arabe et Byzance laquoOsirisraquo 14 (1962) pp 198-221
Mogenet et al 1983 = Niceacutephore Greacutegoras Calcul de lrsquoeacuteclipse de soleil du 16 juillet 1330 ed J Mogenet ndash A Tihon ndash R Royez ndash A Berg Amsterdam 1983
Mondrain 2002 = B Mondrain Maxime Planude Niceacutephore Greacutegoras et Ptoleacutemeacutee laquoPa-laeoslavicaraquo 10 (2002) pp 312-322
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 165
Mondrain 2004 = B Mondrain Lrsquoancien empereur Jean VI Cantacuzegravene et ses copistes in A Rigo (a cura di) Gregorio Palamas e oltre Studi e documenti sulle controversie teologiche del XIV secolo bizantino Firenze 2004 pp 249-296
Mondrain 2007 = B Mondrain Les eacutecritures dans les manuscrits byzantins du XIV e siegravecle Quelques probleacutematiques laquoRSBNraquo n s 44 (2007) pp 157-196
Peacuterez Martiacuten 2006 = I Peacuterez Martiacuten Maxime Planude et le Diophantus Matritensis (Madrid Biblioteca Nacional ms 4678) un paradigme de la reacutecupeacuteration des textes anciens dans la ldquorenaissance paleacuteologuerdquo laquoByzantionraquo 76 (2006) pp 433-462
Peacuterez Martiacuten 2008 = I Peacuterez Martiacuten El lsquoestilo Hodegosrsquo y su proyeccioacuten en las escrituras constantinopolitanas laquoSampTraquo 6 (2008) pp 389-458
Perria 1991 = L Perria Scrittura e ornamentazione nei codici della laquocollezione filosoficaraquo laquoRSBNraquo n s 28 (1991) pp 45-111
Rollo 2012 = A Rollo LrsquoArchimede di Giorgio Valla in V Fera ndash D Gionta ndash A Rollo (a cura di) Archimede e le sue fortune Atti del Convegno di Siracusa-Messina 24-26 giugno 2008 Messina 2012 pp 99-147
Rome 1927 = A Rome Membra disjecta laquoRBenraquo 39 (1927) pp 187-188
Rome 1938 = A Rome Un manuscrit de la bibliothegraveque de Boniface VIII agrave la Meacutediceacuteenne de Florence laquoACraquo 7 (1938) pp 261-268
Ronconi 2013 = F Ronconi La collection philosophique un fantocircme historique laquoScripto-riumraquo 67 (2013) pp 119-140
Tannery ndash Steacutephanou 1940 = Quadrivium de Georges Pachymegravere ed P Tannery ndash E Steacutephanou Cittagrave del Vaticano 1940
Tihon 2011 = Πτολεμαίου Πρόχειροι Κανόνες Les Tables faciles de Ptoleacutemeacutee vol Ia Tables A1-A2 ed A Tihon Leuven 2011
Traube 1907 = L Traube Nomina Sacra Versuch einer Geschichte der christlichen Kuumlrzung Muumlnchen 1907
Vogel 1936 = K Vogel Beitraumlge zur griechischen Logistik laquoSBAWraquo Mathematisch-natur-wissenschaftliche Abteilung Jahrgang 1936 pp 357-472
Wouters 1979 = A Wouters The Grammatical Papyri from Graeco-Roman Egypt Contri-butions to the Study of the lsquoArs Grammaticarsquo in Antiquity Brussel 1979
F ACERBI Tav 1
b Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 65r
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 284 f 160r
F ACERBITav 2
b Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 13r
a Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 19v
F ACERBI Tav 3
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 136v
F ACERBITav 4
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17r
F ACERBI Tav 5
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17v
F ACERBITav 6
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 7v
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
Fabio Acerbi136
προκείσθω δὶς τὸ μῆκος αὐτῆς ὀφεῖλον τὴν τάξιν τοῦ κατὰ τοὺς πολλαπλασιασμοὺς κανόνος ἀποδοῦναι καὶ ἐκκείσθω ἐπὶ σελιδίων διαγεγραμμένων οὕτω καὶ δὴ αὐτῆς ἐφ᾽ ἑαυτὴν πολ-λαπλασιασθείσης γεγονέτωσαν τὰ ἐν τοῖς οἰκείοις σελιδίοις εἴδη ταῦτα δὴ συναγόμενα καθ᾽ ἣν ὑπεδείξαμεν τάξιν ποιήσει τὰς ὑπογεγραμμένας μοίρας ἢ καὶ λεπτά τινα εἴσι ͵δυϙθ νθ´ ιδ´´ ι´´´ κε´´´´ ὡς λείπειν τοῦ ἐπιμερισθῆναι ŏ ŏ με´´ μθ´´´ λε´´´´
che sia prescritto che la sua lunghezza debba figurare due volte nella disposizione della tavola delle moltiplicazioni e che lsaquoquestrsquoultimarsaquo sia disposta su colonne delimitate da linee cosigrave mdash E pertanto una volta moltiplicato lsaquoil latorsaquo per se stesso che le specie trovino posto nelle colonne appropriate quelle che vengono cosigrave raccolte secondo la disposizione che abbiamo indicato produrranno dunque i gradi o anche i minuti qui sotto trascritti 4499 59 14 10 25 in modo che dalle divisioni successive resti39 0 0 45 49 35
La tabella associata (tav 2a Marc gr 313 f 19v) contiene una sola svista grossolana reca 51 invece di 55 in ognuno dei due fattori posti affiancati sopra di essa Al di sotto preceduto dal segno convenzionale per ὁμοῦ egrave collocato il risultato incongruamente sfalsato di un paio di colonne e con la lettera numerale ͵δ priva di barra sormontante in-naturalmente disconnessa da υϙθ I riporti sono indicati dai numerali ι ρκγ´ η´´ ν´´´ posti al fondo delle prime quattro colonne Il calcolo egrave corretto in ogni sua parte
Il clou in questo piccolo spaccato delle interazioni testo-paratesto matematico risiede nella descrizione contenuta nei Prolegomena della disposizione tabellare di due procedimenti di divisione il primo ano-nimo e quindi da supporre tradizionale il secondo piugrave efficiente ed attribuito al matematico del IV secolo Pappo
Il primo metodo di divisione egrave sostanzialmente analogo a quello che usiamo attualmente Dividendo e divisore questrsquoultimo preceduto da un segno su cui ritorneremo nella prossima sezione sono posti uno sotto lrsquoaltro intervallati da una riga inizialmente vuota Primo passo viene reperito il massimo multiplo del divisore che sia minore del di-videndo esso viene trascritto sotto il dividendo nella prima lsquocasellarsquo della riga vuota recante in testa un segno per laquosottrairaquo il fattore mol-tiplicativo (o quoziente parziale) viene trascritto in una lsquocasellarsquo pre-ceduta da un segno per laquorisultaraquo sotto il divisore Secondo passo il massimo multiplo viene sottratto dal dividendo il resto cosigrave ottenuto egrave trascritto preceduto da un segno per laquorestoraquo in una casella posta
39 Lrsquoautore concettualizza il procedimento di estrazione di radice quadrata come una forma di divisione
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 137
accanto al dividendo40 I due passi precedenti sono quindi ripetuti con la sola differenza che il resto appena ottenuto prende il posto del divi-dendo il quoziente parziale scala di un ordine sessagesimale ad ogni passo41 E cosigrave via aggiungendo ogni volta due caselle La debolezza di questo metodo come di quello che utilizziamo attualmente risiede nel fatto che il reperimento dei quozienti parziali (ovverosia dei massimi multipli) viene effettuato per tentativi non riuscire a farlo al primo colpo appesantisce notevolmente i calcoli successivi e costringe ad un lavoro di riordino e addizione dei quozienti parziali stessi La tabella risultante dove appunto osserviamo questo fenomeno in parallelo con identiche inaccuratezze nella descrizione ha la forma riprodotta unico tra i manoscritti della recensione antica nel Marc gr 313 f 13r (tav 2b invito il lettore a non rivolgersi alle tavole se non dopo aver termi-nato questa sezione sarebbe anzi auspicabile che tentasse di ricostruire questa tabella e le due successive a partire dalla mia descrizione)42
Il secondo metodo di divisione attribuito a Pappo egrave congegnato in modo da rendere non aleatoria la ricerca dei quozienti parziali Come altrove nei Prolegomena la descrizione della procedura di calcolo si riag-gancia esplicitamente a una frase di Tolomeo laquouna volta dimostrato che il periodo di una singola rivoluzione lsaquodel solersaquo egrave di 365 giorni 14 48 se di-vidiamo per essi i 360 gradi di un singolo cerchio avremo il moto medio giornaliero del sole circa 0 gradi 59 8 17 13 12 31raquo43 Questrsquoaffermazione si trova nel terzo libro dellrsquoAlmagesto si tratta della prima occasione in cui viene effettuata una divisione in cui il divisore egrave maggiore del dividendo e i commentatori del trattato tolemaico non si fecero sfuggire lrsquooccasione di mostrare come eseguirla Ora il terzo libro del commentario di Pappo non ci egrave pervenuto Ci resta dunque come testo parallelo a quello dei Prolegomena la descrizione rigidamente formulare in Teone sicuramente un calco di quella pappiana Teone qui come nelle altre applicazioni del metodo (Laur Plut 2818 ff 136v [tav 3] e 190r) descrive brevemente ed espone esplicitamente la stessa tavola dei sottomultipli del divisore che
40 Esempio nella divisione di 378 per 17 il massimo multiplo egrave 374 il quoziente parziale egrave 22 il resto 4 e in effetti 378 = 374 + 4 = 17times22 + 4 Si noti che il segno per laquorestoraquo non egrave apposto in testa di riga ma davanti a ogni resto parziale e in effetti il dividendo che si trova in prima posizione in questa riga non egrave un resto
41 Analogamente nellrsquoalgoritmo moderno poniamo la virgola o scaliamo la cifra di un posto
42 Nei Prolegomena la descrizione della tabella associata al metodo anonimo egrave pre-ceduta da una breve sinossi dellrsquooperazione in stile procedurale (cioegrave senza riferimenti alla tabella) e seguita dalla sua esecuzione accurata ma con pochi riferimenti alla tabella se non quello ai due segni da apporre ai resti parziali e ai massimi multipli
43 Alm III 1 in POO I 1 p 2091-4
Fabio Acerbi138
troviamo nei Prolegomena ma non offre alcuna descrizione della disposi-zione tabellare della divisione stessa neacute vi fa riferimento
A questa procedura sono in effetti associate una tavola e una tabel-la costruite come segue (tavv 4 e 5 Marc gr 313 ff 17r e 17v il co-pista era ndash giustamente ndash insoddisfatto della prima versione) La tavola le cui righe e colonne sono delimitate da linee contiene sottomultipli44 del divisore 365 14 48 9 righe che riportano i valori da 160 a 960 piugrave altre 6 con i valori per decine da 1060 a 6060 la prima colonna elenca le 15 parti sessagesimali omettendo come drsquoabitudine la laquodenomina-zioneraquo dellrsquoordine (i numerali elencati sono quindi α β γ δ ε ϛ ζ η θ ι κ λ μ ν ξ) la seconda i sottomultipli corrispondenti organizzati su quattro colonne per tener conto dei tre ordini sessagesimali (il primo sottomultiplo egrave quindi ϛ ε´ ιδ´´ μη´´´ cioegrave 160 di τξε ιδ´ μη´´) La tabella priva di linee delimitanti espone la vera divisione Nella prima colonna troviamo i resti parziali ognuno preceduto dallrsquoindicazione del proprio ordine sessagesimale e da un segno per laquorestoraquo Nella seconda preceduti da un segno per laquosottrairaquo i sottraendi ognuno coincide ovviamente con uno dei sottomultipli nella tavola La terza colonna contiene se-guiti dallrsquoindicazione del proprio ordine sessagesimale i quozienti par-ziali ottenuti trascrivendo dalla prima riga della tavola il numerale corrispondente al sottraendo affiancato ed assegnando come ordine sessagesimale il successivo a quello posto in testa di riga Il risultato preceduto da un segno per laquorisultaraquo e posto al di sotto della tabella si ottiene sommando i quozienti parziali il procedimento non permette in generale di determinare lrsquointero quoziente parziale relativo ad un ordine sessagesimale fissato se non dopo due passi Una linea spezzata unisce i resti parziali successivi e i relativi sottraendi per evidenziare la laquoprogressione della proceduraraquo la spezzata lsquosaltarsquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore (le cui righe sono per il resto vuote) e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue di conseguenza anche il quoziente parziale relativo a questo resto appartiene allrsquoordine sessagesimale successivo
A questo punto possiamo rivolgerci alle tavv 4-5 e verificare se le immagini che ci siamo formati sulla base della mia descrizione corri-spondono a quelle che troviamo nel Marc gr 313 Non si tratta di un giochetto sterile egrave al contrario il cuore di un intrico di problemi Un primo ordine di problemi deriva dal fatto che nei Prolegomena lrsquoalgo-
44 Sottomultipli e non multipli in quanto il divisore egrave maggiore del dividendo Drsquoaltronde nel sistema sessagesimale come in quello decimale un sottomultiplo si ottiene dal multiplo corrispondente semplicemente scalando tutte le cifre di un posto (ad esempio 1360 di 365 14 48 si ottiene in questa maniera da 13 volte 365 14 48)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 139
ritmo della divisione lsquoalla Papporsquo non egrave mai eseguito (cioegrave formulato verbalmente) in maniera indipendente dalla descrizione della tabella Comrsquoegrave dunque possibile descrivere una tabella operazionale che non ha uno statuto testuale indipendente sulla base di un algoritmo in corso di esecuzione E drsquoaltro canto come non rilevare unrsquoanomalia in un algoritmo eseguito nella sua forma primaria sotto forma di descrizione di una tabella Ci potremmo chiedere se viene descritto lrsquoalgoritmo o la tabella La tensione fra i due enti grafici egrave acuita dal fatto che nei nostri testi tutto ciograve (esposizione o descrizione di un algoritmo o della tabella associata) avviene sempre e solo sulla base di un esempio numerico para-digmatico Per questo motivo la tabella in quanto struttura (cioegrave privata dei dati numerici accidentali) non puograve fare a meno della descrizione45 Dal canto suo Teone come forse Pappo ancor prima descrive ed espone la tavola dei (sotto)multipli ma non la tabella di divisione lrsquoalgoritmo relativo a questrsquoultima egrave espresso come per controbilanciare in maniera eccezionalmente trasparente e formulare Se ciograve comporta un guada-gno a livello verbale-argomentativo sorge un problema operativo grave come e dove sistemare i resti e i quozienti parziali ndash cioegrave tutti i numeri in output dellrsquoalgoritmo differenti dai (sotto)multipli ndash che la tabella si incarica di disporre in modo lsquonaturalersquo Teone prescrive soltanto di confrontare i resti con la seconda colonna della tavola dei sottomultipli e di trascrivere via via il quoziente ottenuto dopo ogni passo Insomma come eseguire materialmente una divisione Non certo adattando ad un nuovo caso specifico la formulazione dellrsquoalgoritmo che Teone propone
Un secondo ordine di problemi e una trappola micidiale per il co-pista egrave interno alla dialettica lsquotabellarsquolsquosua descrizionersquo ed egrave in assenza di simbolismo quello dei riferimenti linguistici da adottarsi nella seconda agli enti grafici che figurano nella prima Occorre ricercare la massima generalitagrave fornita da una descrizione definita di un ente numerico (ad esempio impiegando il termine laquorestoraquo o la perifrasi laquomassimo sotto-multiplo minoranteraquo) o basta assumere direttamente il suo valore speci-fico come esempio paradigmatico E in che modo risolvere il conflitto tra uso e menzione se come nel nostro caso la tabella contiene segni convenzionali ed occorre fornirne una descrizione Si rende ad esempio necessario introdurre un lsquooperatore di citazionersquo noi useremmo le virgo-lette la lingua greca premette lrsquoarticolo neutro Drsquoaccordo ma nel caso
45 Questa caratteristica non egrave connaturata alla matematica degli algoritmi la risorsa dello lsquostile proceduralersquo serve esattamente ad aggirare questo problema al di lagrave di un certo livello di dettaglio perograve essa condurrebbe ad un appesantimento insostenibile della for-mulazione dovuto alla pluralitagrave dei riferimenti agli oggetti matematici in gioco sulla que-stione dei diversi stili della matematica greca si veda Acerbi 2012
Fabio Acerbi140
greco qual egrave il suo range E come distinguerlo nei casi ambigui da un semplice articolo che precede un sostantivo quando questrsquoultimo lo ri-chieda Nel corso del processo di copia del testo della descrizione infine possono generarsi tensioni tra enti grafici interpretabili vuoi come segno convenzionale vuoi come abbreviazione Ambiguitagrave relative a questi punti opacizzano la descrizione Un problema analogo si porrebbe a priori nella dialettica tra uso delle lettere denotative per designare enti geometrici e loro menzione nella costruzione di un diagramma ma esso egrave risolto con lrsquoazzeramento della seconda funzione le lettere denota-tive sono sempre usate allrsquointerno del testo (sono cioegrave il referente degli oggetti geometrici di cui tratta il discorso matematico) mai menzionate (come accadrebbe se fossero il referente di oggetti grafici posti nel dia-gramma) Insomma il codice adottato per la costituzione dei diagrammi geometrici egrave condiviso (cioegrave canonizzato) semplice e perspicuo mentre quello per le tabelle operazionali non lo egrave da qui le sviste dei copisti e le trascuratezze di correttori ed editori
Infine chi vuole apprendere da questi testi come eseguire una divi-sione a cosa deve prestar fede se ad esempio a causa di errori di copia la descrizione finisce per non coincidere con la tabella operazionale visto che sono entrambe due maniere valide di eseguire lo stesso algoritmo Dopo tutto lo scopo di tutta questa macchina grafico-argomentativa egrave di insegnare a eseguire divisioni in formato tabellare Questo problema si fa particolarmente acuto se la tabella non egrave trasparente nel metodo di Pappo lo egrave quasi completamente in quello anonimo no E gli errori che riscontreremo nella (doppia) tabella ai ff 17r-v del Marc gr 313 a chi sono attribuibili Allrsquoautore al trascrittore o al copista medievale
Questo groviglio di problemi riceve alcune risposte sorprendenti dalla tradizione manoscritta come andiamo finalmente a vedere
4 Analisi delle testimonianze
I codici che ho adibito per lrsquoedizione sono i seguenti M = Marc gr 31346 C = Marc gr 314 (Tolomeo Tetrabiblos et opera minora cum commentariis Vezio Valente Anthologiae)47 Z = Vat gr 2326 (fattizio
46 Riferibile al sec IX ex-X in accolgo la datazione suggeritami per litteras il 522005 da Nigel G Wilson si veda anche Agati 1992 pp 141-142 La presenza non sistematica degli accenti che fa anticipare a Wilson la datazione di laquosaec X medraquo fornita in Mioni 1985 p 24 indusse Boris Fonkič (2005 non vidi) ad assegnare il codice allrsquoinizio del IX secolo
47 Il manoscritto riferibile alla seconda o terza decade della prima metagrave del XIV secolo fu vergato da Michele Clostomalle olim lsquoMetochitesschreiberrsquo Bianconi 2005a pp 428-430 Il titolo dei Prolegomena in questa trascrizione identico in grafia ma non in formulazione a
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 141
e mutilo Tolomeo Almagestum) S = Vat gr 184 (varia astronomica scholia miscellanea ad Almagestum Tolomeo Almagestum) P = Par gr 2390 (varia astronomica) gli ultimi tre riferibili allo scorcio del XIII secolo48 e apografi sicuri del Vat gr 159449 attualmente mutilo di due fascicoli che ci privano dei due terzi finali dei Prolegomena M e il Vat gr 1594 ammettono un modello comune il resto della tradizione (25 trascrizioni in tutto) dipende dagli apografi appena citati del Vat gr 1594 Le varianti della recensione bizantina che leggiamo tra lrsquoaltro nei Vat gr 198 Marc gr 310 (Tolomeo Almagestum cum commentariis Pappi Theonis et Cabasilae) e con ulteriori modifiche Laur Plut 89 sup 48 (varia astronomica Tolomeo Almagestum Barlaam Logistica) sono identificate dal siglum K e si trovano punteggiatura originale in-clusa nel secondo apparato50 Lrsquoanalisi delle testimonianze51 costituite ovviamente anche dalle tabelle associate saragrave condotta nella forma di una sequenza di osservazioni indicizzate da numerali o lettere oltre che di alcune note a piersquo di pagina
Iniziamo dalla descrizione del metodo di divisione anonimo
quello che leggiamo nel Vat gr 1594 (questrsquoultimo coincide con quello adottato nella recen-sione bizantina) fu apposto da Niceforo Gregora e successivamente corretto da Bessarione
48 Sto studiando il primo e il terzo codice in collaborazione rispettivamente con Daniele Bianconi e Inmaculada Peacuterez Martiacuten
49 Su questo codice risalente alla seconda metagrave del IX secolo e sulla sua collocazione nella lsquocollezione filosoficarsquo per prima proposta in Follieri 1977 pp 145-146 si vedano almeno Perria 1991 pp 82-88 Ronconi 2013 Che il titolo dei Prolegomena nel Vat gr 1594 sia stato apposto da Niceforo Gregora egrave stato riconosciuto per la prima volta in Mazzucchi 1994 p 211 n 196 si veda Bianconi 2005a p 418 per altri interventi di Gregora nello stesso manoscritto
50 Il Vat gr 198 egrave stato vergato dal copista Malachia nel corso del terzo quarto del XIV secolo Mondrain 2004 pp 278-290 e 292 Allo stesso copista (denominato non a caso prima dellrsquoidentificazione anonymus Aristotelicus) dobbiamo un buon numero di trascrizioni aristoteliche con i relativi commentari in margine Gli dobbiamo anche il Par gr 2342 secondo tomo di un quadrivium quasi completo di cui il Vat gr 198 egrave il primo nellrsquoordine aritmetica armonica astronomia (Almagesto e commentari relativi) nel codice vaticano geometria ed ancora astronomia (corpus astronomico minore) in quello parigino le opere trascritte sono sempre accompagnate in margine dai relativi commentari Il copista del Marc gr 310 egrave Isacco Argiro (ca 1300-1375) Mondrain 2007 p 166 Allo stesso Argiro dobbiamo il codice laurenziano (Daniele Bianconi per litteras) Poicheacute la recensione modificata che leggiamo nel Laur Plut 89 sup 48 egrave senza alcun dubbio basata su quella nel Marc gr 310 e non viceversa ci troviamo di fronte ad un copista che trascrive due volte lo stesso testo in due versioni leggermente differenti la conclusione naturale egrave che la seconda recensione egrave dovuta ad Argiro stesso la questione andragrave studiata in dettaglio
51 Nei manoscritti citati i Prolegomena si trovano ai fogli seguenti Vat gr 1594 ff 1r-8v (mutilo mancano due fascicoli su tre) Marc gr 313 ff 1r-28r (incompleto man-cano due fogli allrsquoinizio e il f 6 attualmente rimpiazzato da uno bianco) Marc gr 314 ff 235r-255r Vat gr 2326 ff 19r-40v e 43r-v (incompleto e con i fascicoli in disordine) Vat gr 184 ff 10r-23v Par gr 2390 ff 1r-13v Vat gr 198 ff 127r-136v Marc gr 310 ff 1r-13r Laur Plut 89 sup 48 ff 7r-19r
Fabio Acerbi142
ἐκθέμενοι οὖν διάγραμμα τῶν ἀριθμῶν ὡς ὑπόκειται προτάσσομεν τὸν μεριζόμενον καὶ μικρὸν ὑπ᾽ αὐτὸν τὸν μερίζοντα ὡς ἔχει τὸ διάγραμμα ἐν στίχοις διοριζομένοις ὑπὸ γραμμῶν [hellip] καὶ τὰ μὲν γινόμενα ἐγγὺς ἐλάττονα ἐν τῇ μεταξὺ θέσει τοῦ μεριζομένου καὶ τοῦ μερίζοντος ἐν στίχοις παρασημειοῦσθαι πρὸς τὸ ἀσύγχυτον εἶναι τὴν τάξιν τὰ δὲ μεθ᾿ ὧν ὁ μερίζων ἐποίει τοὺς ἀεὶ ἐλάσσονας ὑπὸ τὸν μερίζοντα σημειοῦσθαι προγράφοντας ἐπὶ τοῦ στίχου αὐτῶν τὸ γίνεται οὕτως γι ἐν δὲ τῷ στίχῳ τῶν μεριζόντων τὸ παρὰ ἔχον οὕτως oslash ἀντὶ τοῦ παρ᾿ ἃ δεῖ τὸν μερισμὸν γίνεσθαι ἐν δὲ τῷ στίχῳ τῶν ἐλασσόνων τὸ αφ διὰ τὸ τούτους ἀεὶ ἀφαιρεῖσθαι ἀπὸ τῶν ἐπάνω τῶν μεριζομένων ἐν δὲ τοῖς τοῦ μεριζομένου λοιπάσμασι τοῖς καὶ ἐπιοφείλουσι τὸ λ κατὰ τὸ ἴδιον τῶν διαστάσεων ἑκάστης ndash λέγω δὴ λοιπάδος ndash ἀντὶ τοῦ λοιποὶ οἱ μέλλοντες ἐπιμερίζεσθαι
2 post τὸν suprascr τὸν ἐλάττονα m 2 S 5 πρὸς] MP et ex corr Z κατὰ S om C | ἀσύγχυτον] MSPC -χητον Z 6 ἀεὶ] MZPC ὡσεὶ S 7 γίνεται οὕτως γι ] γι τ οὕτως γι τ M γί οὕτως γί Z γι οὕτως γί SC τὸ γινόμενον οὕτως γίνεται P 8 τὸ παρὰ ἔχον οὕτως] scripsi τὸ παρέχον οὕτως M et π(αρ-) comp Z οὕτως τὸ περιέχον S προγράφοντας οὕτως ex corr m 2 P τὸ περιέχον οὕτως C | oslash] MZSC (sed ο fecit | Z) ἐλάττων comp ex corr m 2 P | παρ᾿ ἃ] scripsi παρα M π(αρα) comp ZSC ex παρα fe-cit παρὰ et τοῦτον suprascr m 2 P 9 γίνεσθαι] comp C | αφ ] αφ ε M ἀφ ZSC ἀφαί P | ἀεὶ] om M 11 ἐπιοφείλουσι] MZSC ex ἐπιο- fecit ἐπο- m 2 P | λ] MZPC λ´ S 12 λοιποὶ] PC λοιποῦ MZS
3 στίχοις] στίχῳ K 5 πρὸς] διὰ K 7 ἐπὶ mdash γι ] τὸ γίνεται διὰ τοιούτου σ(ημείου) γί K 8 τὸ παρὰ ἔχον mdash παρ᾿ ἃ] τὸ παρᾱ διὰ σ(ημείου) τοιούτου καὶ τοῦτο oslash δηλοῦντος τοῦ παρᾱ ὅτι παρὰ τὸν τοιοῦτον (ἀριθμὸν) K 9 αφ διὰ τὸ τούτους] ἀφ δηλοῖ δὲ τοῦτο ἀφαίρεσ(ιν) ὅτι τούτους ἀεὶ δεῖ K 11 ἐπιοφείλουσι] ἐπιμερίζεσθαι ὀφείλουσι K | λ] λ οι` K 12 ἀντὶ τοῦ] δηλοῦντος τοῦ σ(ημείου) τὸ K
lsquoRendendo esplicito un diagramma numerico come lo troviamo qui sotto disponiamo in primo luogo il dividendo e un poco al di sotto di esso il divisore come li ha il diagramma in righe delimitate da linee [hellip] e lsaquooccorreragraversaquo nella posizione tra il dividendo e il divisore annotare lrsquouno accanto allrsquoaltro i piugrave vicini lsaquodei numerirsaquo minori che risultano affincheacute la disposizione non sia confusa quelli con cui il divisore faceva ogni volta i lsaquonumerirsaquo minori annotarli sotto il divisore scrivendo in prima posizione sulla loro riga laquorisultaraquo cosigrave Ris nella riga dei diviso-ri52 invece laquoperraquo fatto cosigrave53 P in luogo di laquoquelli per cui deve farsi la divisioneraquo nella riga dei lsaquonumerirsaquo minori laquosottrraquo in quanto questi sono sempre sottratti dai dividendi che si trovano sopra nei residuli del dividendo (occorre ben farlo anche per loro) laquoReraquo in accordo con ciograve
52 I laquodivisoriraquo sono al plurale ma siamo semplicemente di fronte a un tratto idioma-tico della lingua greca nel caso di espressioni generalizzanti crsquoegrave soltanto un divisore che occupa lrsquounica colonna di cui si compone la sua riga
53 Si intenda ἔχον οὕτως = ita se habens
1
5
10
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 143
che egrave proprio agli scarti di ciascuno ndash intendo qui lsaquociascunrsaquo residuo54 ndash in luogo di laquoresti che vanno a essere divisi ulteriormenteraquorsquo
a) Operatori di citazione e segni convenzionali I segni introdotti sono quattro la mia discussione egrave condotta dando per scontato che essi siano identici a quelli impiegati dallrsquoautore dei Prolegomena anche se si tratta di unrsquoipotesi non corroborabile neacute falsificabile
i Segno per il risultato Lrsquoabbreviazione convenzionale per γίνεται egrave identica al segno introdotto dallrsquoautore e i copisti si dividono tra i due errori possibili scrivere due abbreviazioni o risolverle entrambe Un fenomeno del tutto analogo si riscontra nel Matr 4678 il manoscritto alla base di tutta la tradizione degli Arithmetica di Diofanto al momen-to della definizione dellrsquoἀριθμός (lrsquolsquoincognitarsquo nel nostro linguaggio) ὁ δὲ μηδὲν τούτων τῶν ἰδιωμάτων κτησάμενος ἔχων δὲ ἐν ἑαυτῷ πλῆθος μονάδων ἄλογος ςο` καλεῖται ς` ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον τὸ ς` laquoil lsaquonumerorsaquo che non possiede nessuna di queste proprietagrave ma che ha in seacute una molteplicitagrave indefinita di unitagrave egrave chiamato lsquonumerorsquo e il suo segno egrave ς`raquo Qui solo il terzo dei tre ς ha una barra a sormontare per segnalarne il carattere puramente denotativo (cioegrave di segno convenzionale e non di abbreviazione si veda il punto successivo)55 il primo egrave una delle abbreviazioni piugrave diffuse per ἀριθμός (e infatti egrave dotato del compendio per la desinenza e dellrsquoaccento grave) il secondo egrave una delle piugrave comu-ni per καὶ () Giovanni Cortasmeno autore di capillari annotazioni infra lineam agli Arithmetica nel codice madrileno scioglie il primo ςο`
54 Doppia variatio che impiega al posto di λοιπόν laquorestoraquo i due termini decisamente non canonici τὸ λοίπασμα e ἡ λοιπάς (piugrave oltre leggiamo anche il participio λοιπασθέντα) Una ricerca sul TLG in rete non ha fornito occorrenze del primo si tratta dunque di uno hapax Quanto al secondo che ricorre anche nella sezione sulla divisione lsquoalla Papporsquo lo si rintraccia giagrave nei papiri documentari il termine diventeragrave perograve canonico nelle esposizioni bizantine drsquointroduzione allrsquoAlmagesto ricalcate sul modello dei Prolegomena (si veda la nota 87 infra) Questi due termini designano i resti parziali prodotti nel corso di una divisione lunga li ho tradotti rispettivamente con il neologismo laquoresiduloraquo e con il sostantivo pari-menti non canonico laquoresiduoraquo
55 Il copista interpreta erroneamente il terzo segno come unrsquoabbreviazione e qui ag-giunge un apice inverso (cioegrave un accento grave) altrove lo scioglie direttamente in forme opportune di ἀριθμός Matr 4678 f 58v La frase come la leggiamo nel manoscritto egrave cor-rotta sulla base di una parafrasi in Psello (edita in DOO II p 3710-12) Tannery emendograve ἄλογος in ἀόριστον DOO I p 64-5 et app Il Matritensis vergato da due copisti differenti (cambio di mano a tre righe dalla fine del f 62r) contiene lrsquoIntroductio arithmetica di Nicomaco e le opere diofantee oltre ad alcuni brevi opuscoli musicali la sua data egrave stata recentemente corretta dal XIII al secolo XI pm in Peacuterez Martiacuten 2006 (una riproduzione digitale del manoscritto si trova allrsquoindirizzo httpbdhbneesbnesearchbibliotecaDio-fanto20de20AlejandrC3ADa)
Fabio Acerbi144
in ἀριθμός ed aggiunge un altro segno56 sopra il terzo anteponendovi lrsquoindicazione καὶ ἔστιν αὐτοῦ σ(ημεῖον) τόδε Va da seacute che non abbiamo nessuna garanzia che il segno originariamente introdotto da Diofanto coincidesse realmente con unrsquoabbreviazione convenzionale per ἀριθμός Lrsquoevidenza del PMich III 144 (sec II in) suggerisce drsquoaltronde che il Matritensis e con esso tutta la tradizione medievale di Diofanto ripro-duca fedelmente pur accentuandone la sinuositagrave il segno originario
ii Segno per il divisore Un cerchiolino sbarrato da non confondere con il segno per ὁμοῦ che nei manoscritti matematici ha di norma due barre trasversali (cf tav 2a) Non sono riuscito a rintracciarne ulteriori occorrenze in altre opere la forma che esso assume nel Vat gr 2326 e la correzione apportata nel Par gr 2390 lasciano aperta la possibilitagrave per quanto a mio avviso remota che la forma originaria non fosse lon-tana da unrsquoabbreviazione di παρά registrata nei repertori57 Il correttore del Par gr 2390 trasforma in effetti il segno oslash nellrsquoaffine abbreviazione canonica per (forme di) ἐλάσσων laquominoreraquo58 e si incarica diligente-mente di farlo notare ricapitolando i segni nella porzione superiore del margine esterno del f 7v Nello stesso margine egli traccia anche uno lsquoscolio tabellarersquo ed egrave lrsquounico a porre il (proprio) segno dove indicato dalla descrizione (tav 6 Par gr 2390 f 7v) Oltre a ciograve adattando la tabella al margine ristretto lo scoliaste trascrive come colonne affian-cate le due righe dei resti parziali e dei massimi multipli e aggiunge le indicazioni ὁ μεριζόμενος laquodividendoraquo e ὁ μερίζων laquodivisoreraquo ma vi introduce alcune incongruenze di formato il risultato scritto in verti-cale e la linea verticale di sinistra che separa il divisore dal segno che lo dovrebbe precedere direttamente
iii Segno per i massimi multipli Corrisponde alla semplice abbre-viazione per sospensione della forma verbale ἄφελε laquosottrairaquo in questo
56 Si tratta del segno di ampio uso praticamente identico allrsquoabbreviazione canonica per οὖν
57 Si tratta di un pi a forma di gancio sbarrato da uno slash di troncamento Ce-reteli 1904 tav IX item 7 sub ΠΑΡΑ che rinvia al PVindRain 423 cf anche la forma π` nel POxy LXI 4142 edito in Jones 1999 II pp 26-34 In generale nei papiri e nei manoscritti matematici in maiuscola le preposizioni sono abbreviate facendo seguire un lsquoapostroforsquo alla loro prima lettera Α᾽ Υ᾽ ecc Per la seconda fattispecie di supporto libra-rio si veda in particolare il cosiddetto fragmentum mathematicum Bobiense scriptio inferior databile al V-VI secolo del palinsesto Milano Biblioteca Ambrosiana L 99 sup (Isidoro di Siviglia Etymologiae datazione Cavallo 1977 p 100) pp 113-114 che sono stampate in riproduzione apografa conforme in Belger 1881 (la p 114 egrave riprodotta anche nella tav 10 di Acerbi 2010)
58 Se questa era lrsquointenzione si tratta ovviamente di una forzatura il divisore puograve ben essere maggiore del dividendo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 145
caso lo slash di troncamento taglia orizzontalmente il tratto verticale del phi I copisti offrono molteplici varianti apponendo chi uno spirito dolce chi un ε chi un αί accentato a sormontare Tutti questi segni svolgono la funzione di abbreviazioni vere e proprie (e cosigrave doveva essere anche per lrsquoautore si veda il punto 1 di p 153 infra) la forma originale si ottiene a mio avviso incrociando i dati del Marc gr 313 e dei tre apografi del Vat gr 1594 αφ anche se lrsquoassenza dello spirito potrebbe essere semplicemente dovuta alla pratica del copista del codice veneziano di economizzare nei diacritici
iv Segno per i resti Un lambda completato da una barra a sormon-tare o da un apice che rinvia alle abbreviazioni per sospensione di una forma opportuna di λοιπός laquorestoraquo In realtagrave la forma che troviamo nella tabella egrave differente (tav 2b) e coincide con quella offerta quasi unanimemente dai manoscritti nella descrizione e in almeno un caso nella tabella del metodo di divisione attribuito a Pappo (tav 4) un lambda che accoglie al di sotto una legatura omicron-iota () sbarrata da uno slash di troncamento Qualcosa di simile si trova nel PVindob G 19996 (sec I) una specie di lambda maiuscolo molto aperto e dal vertice arrotondato che include un circoletto interpretato dagli editori come segno per περίεστιν o per λοιπόν59 Lo stesso segno si rintraccia ad esempio in un medesimo scolio tabellare di prima mano ad Alma-gestum nel Vat gr 1594 f 93v e nel Marc gr 313 f 135r ma stavolta la forma del lambda egrave molto ben definita
Fin qui i segni Ma il gioco egrave piugrave complesso La descrizione si muo-ve pericolosamente sulla linea di confine non sempre ben definita tra segno convenzionale e abbreviazione il primo ndash e il repertorio grafico matematico-astronomico ne egrave particolarmente fornito60 ndash puograve anche
59 Ho consultato lrsquoedizione Gerstinger ndash Vogel 1932 pp 46 e 48 la porzione rilevante del papiro egrave riprodotta nella tav 11 di Fowler 1999 Si veda ancora ivi pp 253-257 per la trascrizione di questo segmento di testo (con correzioni rispetto alla princeps) e per una messa a punto recente inclusa la proposta di datazione che ho riportato qui sopra Il verso del papiro che contiene una tavola aritmetica del tutto scorrelata dalla tematica del recto egrave edito come PRain Unterricht 151
60 La pratica di ridurre lo spazio occupato da un testo tecnico per mezzo di abbreviazioni e segni convenzionali era molto diffusa nei manoscritti in maiuscola contrariamente a quanto avviene per altri generi letterari vedremo tra breve cosa accade negli Arithmetica di Diofanto ma si leggano in proposito anche le considerazioni di Hei-berg nei prolegomena alla propria edizione dellrsquoAlmagesto in particolare riguardo al ricorso massiccio ad espedienti brachigrafici nel modello del Vat gr 180 POO II pp lxxxiv-xciii civ-cv cxxvii cxxxviii-cxxxix Agli elenchi dettagliati forniti da Heiberg possiamo aggiungere il piccolo prontuario stampato in Hultsch 1876-1878 III 2 pp 126-132 e basato sul testo e sugli scolii alla Collectio di Pappo nel Vat gr 218 (sec X in) Si vedano infine le osservazioni del copista del Par gr 2360 f 120v trascritte da Heiberg in AOO III pp x-xi sulle laquonotazioni tipiche a scopo di tagliar corto nello scrivereraquo impiegate nel pro-
Fabio Acerbi146
derivare dalla seconda (un caso egrave appunto il segno per ἐλάσσων che probabilmente trae origine da una legatura epsilon-lambda) ma poi il rapporto referente-relato si fissa convenzionalmente Quelli definiti nel testo che abbiamo letto sono appunto segni convenzionali non ci sarebbe bisogno di spiegarne forma e funzione se fossero intesi come abbreviazioni assumono nella tabella una funzione denotativa non esplicativa o discorsiva (come accade invece nella tav 1a) Ma come vengono descritti questi segni
I referenti delle descrizioni sono i segni sono introdotti da οὕτως (item i-ii) o in alternativa da un τό con il ruolo di lsquooperatore di citazionersquo (item iii-iv) che corrisponde esattamente alle nostre virgolette In entram-bi i casi gli enti sono menzionati e svolgono una funzione metalinguistica sono collocati materialmente nel testo ma egrave come se si trovassero fuori e la loro descrizione li additasse ndash in effetti i segni convenzionali scritti nel testo sono a loro volta i relata di quelli che si trovano nella tabella
I relata dei segni scritti nel testo sono di due tipi singoli vocaboli (item i-ii) o descrizioni della funzione dei segni per mezzo di clausole sintaticamente complesse (item ii e iv) I singoli vocaboli sono γίνεται e παρά e sono entrambi preceduti dal τό lsquocitazionalersquo in quanto relata di segni convenzionali le forme abbreviate con cui sono tracciati nei manoscritti vanno forzatamente sciolte Bisogna ammettere che la per-spicacia e le risorse grafiche dei copisti ndash di cui tutto si puograve dire fuor che commettano qui degli errori ndash sono messe a dura prova con lrsquointrodurre segni identici ad abbreviazioni o con lrsquoattivare un gioco metalinguistico particolarmente serrato in un contesto meno lsquonaturalersquo di come potreb-be esserlo ad esempio quello di un trattato grammaticale Lrsquoitem iii che presenta direttamente un segno identico ad unrsquoabbreviazione non egrave sorretto da una descrizione ma da una giustificazione in διὰ τό Lrsquoartico-lo τό vi assume una funzione metalinguistica anche se non lsquocitazionalersquo poicheacute al tempo stesso genera un infinito sostantivato e lo singolarizza per questo ho scritto laquosono sottrattiraquo in corsivo nella mia traduzione
prio modello archimedeo (nota 32 supra) egli ne compila anche una breve lista Un elenco antico di laquosegni della geometriaraquo sicuramente redatto per assistere il copista si trova anche al f 3v del ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 vergato da Efrem negli anni 950-960 (tav 8 in Acerbi 2010) Possiamo farci unrsquoidea quantitativa del guadagno di spazio in rapporto ad un testo privo di abbreviazioni e con le parole separate da spazi sulla base del fragmentum mathematicum Bobiense il testo vi egrave disposto a tutta pagina su 36 righe di circa 30 segni ciascuna nelle due pagine in questione figurano 2038 segni con 15 mezze righe occupate dalle due figure Ora nel testo dellrsquoedizione stabilita in Heiberg 1927 pp 87-90 le stesse pagine contano 4455 segni spazi compresi Ne risulta che la dimensione in caratteri di un testo matematico puograve essere ridotta di piugrave della metagrave con lrsquoimpiego di compendi e segni convenzionali
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 147
Negli item ii e iv il segno si collega ad una descrizione nel secondo caso in via esclusiva le descrizioni pertanto rinforzano o sostituiscono lrsquoidentificazione con lrsquoente linguistico denotato Le clausole descrittive sono precedute da ἀντί e dallrsquoarticolo τό con funzione di lsquooperatore di citazionersquo esse sono παρ᾿ ἃ δεῖ τὸν μερισμὸν γίνεσθαι (item ii) e λοιποὶ οἱ μέλλοντες ἐπιμερίζεσθαι (item iv) Nella descrizione della divisione lsquoalla Papporsquo che leggeremo tra breve i segni negli item iii e iv rice-vono lo stesso trattamento degli altri due il loro relatum egrave un singolo vocabolo e non una clausola descrittiva rispettivamente nelle espres-sioni τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε (sul participio ritorneremo nel punto 1 infra) e τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά (la forma del segno notato con λ οι egrave descritta supra nellrsquoitem iv) La descrizione del segno oslash per il divisore merita una discussione piugrave dettagliata In origine si trovava probabilmente scritto Π(ΑΡΑ)ΕΧΟΝ successivamente letto come π(αρ[α])έχον ndash dato che lrsquoabbreviazione per il preverbo egrave identica a quella per la preposizione (che sia Π᾽ o un pi seguito dal segno per ἄρα a sormontare) ndash invece di π(αρὰ) ἔχον I copisti e i correttori si dettero a tutte le possibili contorsioni per restituire un testo dotato di senso leggere appunto una forma verbale con preverbo modificare il preverbo (ma forse il segno per ἄρα era insidiosamente simile ad uno epsilon) correggere il testo rileggiamo lrsquoapparato sub τὸ παρὰ ἔχον οὕτως τὸ παρέχον οὕτως M et π(αρ-) comp Z οὕτως τὸ περιέχον S τὸ περιέχον οὕτως C προγράφοντας οὕτως ex corr m 2 P Nella clausola descrittiva seguente la presenza liminare di παρὰ (che ho corretto in παρ᾿ ἃ nella speranza di restituire una frase che abbia un senso senza intervenire sul testo) innesca un bel corto circuito il Π(ΑΡΑ) che sicuramente figu-rava nellrsquoarchetipo egrave un sintagma complesso una preposizione unrsquoab-breviazione o un segno per unrsquoabbreviazione Se lrsquoeditore si trova in conflitto con la propria inclinazione alla critica conservativa i copisti si rifiutarono di mettere mano ad un testo che doveva stridere anche per loro essendo il compito demandato al ritocco del revisore del Par gr 2390 o alla riscrittura radicale del recensore bizantino Il problema egrave che ci troviamo di fronte ad unrsquoespressione che descrive la funzione dellrsquooggetto denotato non lrsquooggetto stesso ma che lo contiene al suo interno per soprammercato qui il Π(ΑΡΑ) egrave usato per giustificare una menzione a sua volta relatum di un segno
Evidentemente questa maniera di procedere che giagrave aveva attirato interventi da parte di copisti e correttori della recensione di base parve insostenibilmente opaca allrsquoautore della recensione bizantina61 Egli
61 Uno dei manoscritti di questa recensione propone anche una tabella di divisione
Fabio Acerbi148
modifica tutte le descrizioni diluendo lrsquoidiomatismo dellrsquoarticolo lsquocita-zionalersquo con lrsquointroduzione sistematica del verbo δηλόω e di frasi atte a chiarire quale sia il segno denotante e quale il vocabolo (o il segno) denotato Egli introduce allo scopo di rendere esplicita la funzione de-notativa dei segni introdotti il termine σημείου curiosamente in tutte le sue tre occorrenze esso compare a sua volta nella forma dellrsquoabbrevia-zione per sospensione σΗ´ Egli traccia il segno per i massimi multipli ἀφ e quello per i resti λ οι` in modo che non vi siano ambiguitagrave quanto al loro carattere di abbreviazione Si faccia infine attenzione al residuo di barra sul παρᾱ con funzione denotativa (2 occorrenze) contenuto nella descrizione del segno per il divisore sostituita dallrsquoaccento grave nel παρὰ con funzione discorsiva (la differenza egrave nettissima nei manoscritti da me consultati) Questa osservazione ci permette di passare direttamente allrsquoitem seguente
b) Le barre sui numerali e sulle lettere denotative Egrave opportuno discutere questo punto adesso esattamente percheacute di barre siffatte che pure troviamo in tutti i manoscritti i nostri testi non fanno mai menzione si tratta infatti di una pratica condivisa sin dallrsquoantichitagrave La barra identifica una stringa di lettere dellrsquoalfabeto che non svolge una funzione grammaticale o sintattica propria allrsquointerno del discorso Ciograve avviene in particolare e si tratta della fattispecie piugrave frequente se la stringa di lettere non dagrave origine a un vocabolo della lingua greca lette-re denotative e numerali certo ma anche termini provenienti da altri idiomi e contrazioni di parole greche come i nomina sacra62 tali termi-ni possono essere o no preceduti da un articolo lsquocitazionalersquo a seconda dellrsquouso che ne viene fatto allrsquointerno del discorso Ma non si tratta dellrsquounica fattispecie i papiri grammaticali ed i manoscritti piugrave antichi dei trattati dello stesso argomento segnalano gli esempi delle parti del discorso (cioegrave di lsquoverersquo parole greche) per mezzo di barre sormontanti63 La differenza insomma egrave tra menzione e uso (come parte del discorso in atto) di una stringa di caratteri tra il porre le lsquovirgolettersquo e il non porle tra funzione denotativa e non Apparentemente la convenzione si limi-
corredata dei segni opportuni e contrariamente alle indicazioni della descrizione svilup-pata lsquoin verticalersquo ma per motivi misteriosi non completa (tav 7a Laur Plut 89 sup 48 f 13r)
62 Tutto ciograve egrave spiegato con estrema chiarezza giagrave in Traube 1907 pp 45-4763 Si veda il Par gr 2548 codex vetustissimus e testimone unico delle lsquoopere minorirsquo
di Apollonio Discolo il f 106v con le barre ben visibili egrave riprodotto come tav 19 in De Gregorio 2000 (ivi pp 137-138 per la datazione) Per la testimonianza dei papiri grammaticali si veda Wouters 1979 passim essi contengono di norma elenchi di parti del discorso nessuna delle quali egrave preceduta dallrsquoarticolo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 149
tava in questo secondo caso a segnalare con la barra singoli vocaboli le menzioni di frasi o di sintagmi complessi sono di norma identificate dallrsquoarticolo lsquocitazionalersquo Drsquoaltra parte le abbreviazioni convenzionali non rientrano nella casistica percheacute la loro resa grafica che contiene elementi non alfabetici come compendi per desinenze lettere supra li-neam marche di contrazione o sospensione quali slashes o barre sotto-poste o sormontanti eventualmente solo un sottinsieme della stringa di segni alfabetici le esclude automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
Venendo al discorso matematico una barra sormonta senza ecce-zione le lettere denotative64 che sia in papiri o in manoscritti in maiu-scola65 o minuscola ma solo allrsquointerno del testo comrsquoegrave da attendersi nei diagrammi esse la perdono per il semplice motivo che non crsquoegrave alcun testo ambiente un diagramma ha unicamente una funzione denotati-va Drsquoaltra parte le lettere numerali che a volte figurano nei diagrammi della tradizione metrica66 allo scopo di indicare la lunghezza dei seg-menti mantengono la barra in un diagramma il contesto denotativo geometrico egrave prevalente e i numerali vengono percepiti come entitagrave grafiche lsquoesternersquo al discorso Va da seacute a fortiori che le lettere numerali inserite in un testo dovranno essere segnalate da barre che a loro volta non servono nelle tavole67 in quanto queste ultime sono come abbiamo visto un vero e proprio testo che perograve funge da ambiente a quello al-fabetico limitato alle titolazioni e non a caso tracciato in unrsquoopportuna lsquomaiuscola distintivarsquo allo scopo di segnalarne il carattere denotativo e non discorsivo68 Una tabella operazionale egrave invece un paratesto e quindi le barre sulle lettere numerali che rappresentano gli interi sono
64 La notazione per le lettere denotative subigrave unrsquoevoluzione (il cui risultato finale egrave descritto per sommi capi nella nota 3 supra) di cui non mette conto occuparsi qui
65 I papiri di contenuto geometrico (o astronomici ma che presentano argomenti geometrici) sono rari si vedano il PHerc 1061 (sec II aC Demetrio Lacone De geome-tria) e il PFay 9 (sec II ex Elementi I 39 e 41) Gli importanti ostraka OBerl 12002 e 12609 (sec III aC m Elementi XIII) non pongono le barre sopra le lettere denotative Per i manoscritti in maiuscola si veda ad esempio passim nel Par gr 2389 una cui riproduzione digitale egrave consultabile in rete allrsquoindirizzo httpgallicabnffrark12148btv1b8470171d o il fragmentum mathematicum Bobiense
66 Si veda ancora il ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 codex unicus dei Metrica di Erone e contenente una raccolta importante di problemi del corpus metrologico
67 Si vedano come esempio le tavole citate alle note 10 e 14 supra Discorso a parte per il segno di lsquoposto vuotorsquo si veda il punto c che segue
68 Queste regole generali vanno prese cum grano salis si dagrave naturalmente un certo dominio di variabilitagrave legato verosimilmente al grado di cultura grafica del copista nel PMich III 144 i numerali sono quasi tutti senza barra sia nel testo che nelle tabelle ope-razionali
Fabio Acerbi150
necessarie esse mancano invece sui segni convenzionali che ho descrit-to nel punto precedente e fatto rilevante sulle lettere numerali relative agli ordini sessagesimali quando esse siano identificate da uno o piugrave apici la presenza di questo segno grafico non alfabetico69 le esclude ancora una volta automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo Unrsquoultima osservazione che ci saragrave utile nel seacuteguito la descrizio-ne di una stringa di lettere lsquoagrammaticalersquo non puograve prevedere la men-zione della presenza della barra che le pertiene in quanto tale si tratta di una pratica denotativa che egrave possibile formulare soltanto ad un livello di discorso superiore sia a quello dellrsquouso che a quello della menzione70
c) Il segno di lsquoposto vuotorsquo Si noti nella tav 2b la forma ŏ per il segno di lsquoposto vuotorsquo in un ordine sessagesimale coerentemente con la propria notazione il copista del Marc gr 313 lo scioglie talvolta allrsquoin-terno del testo principale come unrsquoabbreviazione per οὐδέν laquonienteraquo Altre convenzioni di scrittura del tratto che accompagna il circoletto e che si badi bene fa parte integrante del segno di lsquoposto vuotorsquo ndash e infatti nelle tavole troviamo sempre il segno completo mentre tutti gli altri numerali sono come abbiamo visto nel punto precedente privi di barra o di apice a causa del fatto che i vari ordini sessagesimali sono univocamente determinati dalle linee di giustificazione ndash un tratto an-golare anteposto (tav 3 Lar Plut 2818 f 136v)71 o una semplice barra a sormontare (tavv 4-9) si produce in questo modo il segno 65926 che sembra essere stata la forma di base72
69 Occorre dunque supporre come testimoniano papiri e manoscritti in maiuscola che la convenzione relativa allrsquouso della barra si sia consolidata ben prima dellrsquointroduzione di segni diacritici quali accenti e spiriti
70 Si veda il punto 2 infra per maggiori dettagli sulla questione delle barre e degli apici e per le indicazioni in merito che leggiamo in Diofanto
71 Come accennato questa tavola dei sottomultipli coincide con quella descritta ed esposta nei Prolegomena Fatto molto rilevante i numerali nella prima non recano neacute barre neacute apici contrariamente a quanto accade a tutte le istanze della seconda nei manoscritti Quella del Laur Plut 2818 preserva a mio avviso la forma originaria come abbiamo visto una tavola non richiede segni aggiuntivi sulle lettere numerali
72 Si vedano come esempio ancora le tavole citate alle note 10 e 14 supra oppure per una rassegna delle forme che il segno assume nei manoscritti piugrave antichi delle Tavole facili Tihon 2011 pp 58-59 e per quelle che assume nei papiri Jones 1999 I pp 61-62 Ovviamente non possiamo leggere il segno 65926 come un omicron con una barra in quanto ο = 70 nella notazione greca e la barra egrave di rigore quando il numerale figuri allrsquointerno di un testo Occorre ammettere che si dagrave origine ad un bel corto circuito notazionale con il concepire un segno con funzione di lsquoposto vuotorsquo ma che lsquosomigliarsquo ad una lettera dellrsquoalfabeto sormontata da una barra cioegrave ad un numerale in piugrave quando il lsquoposto vuotorsquo non corrisponda ad un intero ma ad una specie sessagesimale la presenza della barra a priori indistinguibile da quella che sormonta gli interi introduce unrsquoincongruenza con la notazione a mezzo di apici vista nellrsquoitem precedente
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 151
d) Errori di copia La tabella riprodotta nella tav 2b ha una forma simmetrica ma si tratta di una forzatura il grande rettangolo in basso a destra drsquoaltronde assente nella descrizione contiene uno scolio che fa notare come lrsquoultimo resto parziale ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ͵γτνζ´´´´´ κζ´´´´´´ cioegrave 0 0 0 0 0 3357 27 siano ἔγγιστα λ´λ´ δ´δ´ ξ laquocon ottima approssimazione 60 minuti quartiraquo dove si notino gli apici semplici per indicare il pas-saggio allrsquoordinale e il raddoppiamento del sistema segno + apice per significare il plurale Lo scolio debitamente accompagnato dal segno di rimando in forma di simbolo solare egrave stato probabilmente incluso nella tabella proprio allo scopo di renderla simmetrica A sua volta un errore precedente spiega lo spazio eccessivo accordato al rettangolo contenente lo scolio il secondo massimo multiplo ŏ λβ´ ξδ´´ ριβ´´´ σιϛ´´´´ egrave trascritto anche al di sotto del risultato
Passiamo ora alla descrizione del metodo di divisione attribuito a Pappo
ἵνα οὖν ταῦτα συναχθῇ τὰ ἐκ τοῦ μερισμοῦ ὁ εἰρημένος Πάππος εὐδιατύπῳ τινὶ καὶ πρὸς τοῦτο τάξει χρησάμενος ποιεῖται τὴν τῆς συλλήψεως τοῦ ζητουμένου ἀνεύρεσιν οὕτως ἐκθέμενος γὰρ τὸν μέλλοντα μερίζεσθαι τουτέστι τὰς τξ μοίρας ἐν ἀρχῇ ἀφαιρεῖ ἀπ᾽ αὐτῶν τὸν ἐν τῇ σελίδι τυγχάνοντα ἐλάττονα τουτέστι τὸν τδ κβ´ κ´´ ὄντα τῶν ἐγγὺς ἐλασσόνων ὡς πρὸς τοὺς ἐκκειμένους διὸ καὶ γράφει αὐτὸν προγράφων αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε καὶ εὑρίσκων τὰ παρακείμενα αὐτῷ τῷ ἀπογραφέντι ἐν τῷ σελιδίῳ λεπτὰ πρῶτα ν´ συναπογράφεται παρατιθῶν αὐτοῖς τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον ἀνατείνουσαν σημαῖνον τὸ εἶδος ὅτι πρῶτα λεπτά εὑρίσκει οὖν οὕτως τὸ τῶν τξ μέρος τὸ τδ κβ´ κ´´ ὃ μεριζόμενον παρὰ τὰς τξε ιδ´ μη´´ ἡμέρας καὶ ποιοῦν τὸν ἐκ τοῦ μερισμοῦ ἀριθμὸν πρῶτα λεπτὰ ν´ καὶ τὸν λοιπὸν ἀπογραφόμενος τὸν νε λζ´ μ´´ προτάσσει αὐτοῦ τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά τάσσει δὲ καὶ ἁπλῆν τινα διατείνουσαν γραμμὴν ὡς ἀπὸ τοῦ τξ ἐπὶ τὸν ἑξῆς ἐκτεθειμένον ἐγγὺς
1
5
10
1 εὐδιατύπῳ] ZSPC εὐδιατύπωτ M 4 ἀφαιρεῖ] MZSP ἀφ ι C 5 ἐλάττονα] P comp MZSC 6 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | αφ ] αφ ε M ἀφ ZS ἀφαί P ἄφ C | ἀντὶ] om C | ἄφελε] MZSP ἄφ C 8 ἀπογραφέντι] MZSP ἐγγραφέντι C | λεπτὰ πρῶτα] P λε πρωτα SC λεπτῶν πρωτ MZ | παρατιθῶν] MZS παρατιθεὶς C et ex corr m 2 P 9 ᾱ] Z αο P α´ MS α C | ἔχον] MPC ἔχων ZS 9-10 πρῶτα λεπτά] ZP πρωτ λ´λ´ M πρωτα λε S αα λε C 11 ἡμέρας] comp codd | ἀριθμὸν] P et comp MZ καὶ C et comp S 12 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M πρωτ λεπτ(α) Z πρωτ λ εᾱ S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C | ἀπογραφόμενος] MZSP ἐγγραφόμενος C | νε λζ´] MZSP λζ νζ C 13 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | λ οι] MZSC ex λ fecit λ οι P | προσσημαῖνον] MC et προσ- comp ZS προση- P | τὸ] MZC τὰ S et fecit m 2 P 14 ἀπὸ] MZSP πρὸς C ἐλάττονα] P comp MZSC
1 εὐδιατύπῳ] εὐδιατυπώτω K 6-7 αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ] τὸ ἀφ K 8 παρατιθῶν mdash 10 λεπτά] τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ σημαίνουσαν τὸ εἶδος αὐτῶν ὅτι ᾱ λεπτά εἰσιν K | τὸ (sec)] τὰ K 12 πρῶτα] πρώτων K | τε λ ] λ οι` K | προσσημαῖνον mdash
Fabio Acerbi152
ἐλάττονα τὸν τδ κβ´ κ´´ ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις καὶ ταύτην ἐπιδεικνύουσαν τὴν τάξιν τῆς προόδου τῆς ἐκθέσεως ἧστινος κλωμένης γραμμῆς πρὸς τῷ ἐγγὺς ἐλάσσονι ἡ ἀντανάκλασις ἐπὶ τὸν λοιπὸν γέγραπται φερομένη ὡς εἴρηται διὰ τὸ εὔτακτον τῆς προκοπῆς οὕτως τε ποιήσας ἑξῆς τὸ αφ ποιῶν ὃ προσσημαίνει ὡς εἴρηται τὸ ὅτι δεῖ ἀφελεῖν ὁμοίως ἀπὸ τοῦ λοιποῦ καὶ δὴ τὸν ἐγγὺς πάλιν ἐλάσσονα ὡς πρὸς τὴν ἐν τῷ σελιδίῳ ἔκθεσιν εὑρισκόμενον λαμβάνων ἑξῆς προγράφει αὐτὸν ὄντα νδ μζ´ ιγ´´ ιβ´´´ καὶ εὑρίσκει αὐτοῖς παρακείμενα ἐν τῷ σελιδίῳ πρῶτα λεπτὰ θ´ ἅτινα καὶ αὐτὰ προσαπογράφεται σὺν τῇ παρασημειώσει τῶν πρώτων γράφων τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον τὴν ἀνατείνουσαν καὶ ὡς εἴρηται τὴν γραμμὴν πάλιν διὰ τὴν τάξιν κλωμένην κατὰ δευτέραν κλάσιν προσέλκει γινομένου τοῦ μέρους αὐτῆς τούτου παραλλήλου τῷ ἐξ ἀρχῆς
16 ante κλωμένης add ἐπὶ C 18 τε] MZP om SC | αφ ] M ἀφ ZSC ἀφαί P 19 προσσημαίνει] MS προση- ZC et ex corr P | ὅτι] ZP comp MSC 20 δὴ] MZSC διὰ fecit m 2 P 21 πρὸς] MSP et supra lineam C ex ἀπὸ fecit m 2 Z | ιγ´´] MZSP νγ´´ C 22 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M ᾱᾱ λεπτὰ Z άάα λε S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C 23 προσαπο- γράφεται] απο suprascr in comp M 24 ᾱ] ZP α´ MS α C 25 κλάσιν] MP τάξιν ZSC | τοῦ] ZSPC τούτου M 26 τούτου] τοῦ bis ZSPC sed prius erasit m 2 P τοῦ M
mdash 18 προκοπῆς] om K | τε ποιήσας] ποιήσας καὶ K | αφ ] ἀφ K 19 τὸ] om K 21 προ-γράφει] γράφει K 22 σελιδίῳ] α´ σελιδίῳ K | ἅτινα] ἃ K 23 προσαπογράφεται] ἀπογράφεται K | τῶν πρώτων mdash 26 ἐξ ἀρχῆς] om K
lsquoAllo scopo di raccogliere ciograve che risulta dalla divisione il detto Pappo utilizzando anche in questo caso una certa disposizione ben strutturata determina nel modo seguente il lsaquonumerorsaquo cercato preso nel suo insieme collocando73 in testa il lsaquonumerorsaquo che sta per essere diviso cioegrave i 360 gradi iniziali sottrae loro tra i piugrave prossimi dei lsaquonumerirsaquo minori rispetto a quelli esposti quello che si trova essere minore nella colonna (cioegrave 304 22 20) Questo egrave il motivo per cui lo trascrive scrivendogli davanti lrsquoabbreviazio-ne laquosottrraquo per laquosottrairaquo e trovando che 50 minuti primi sono collocati accanto a quello stesso lsaquonumerorsaquo che egrave stato trascritto nella colonna li trascrive al tempo stesso collocando accanto74 ad essi la lettera A con un lsaquotrattorsaquo75 sopra che significa la specie minuti primi Trova dunque in que-sto modo la parte di 360 che egrave 304 22 20 la quale divisa per 365 giorni 14 48 fa il numero lsaquoche risultarsaquo dalla divisione 50 minuti primi Trascrivendo
73 La descrizione egrave strutturata come una procedura Acerbi 201274 Il purismo del correttore del Par gr 2390 di Clostomalle nel Marc gr 314 e
dellrsquoautore della recensione bizantina impone loro di modificare la terminazione ma forme tematiche e contratte di τιθεῖν sono correnti nel greco tardivo
75 Il testo greco ha solo il participio con γραμμήν sottinteso Per il significato del participio si veda il punto 2
15
20
25
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 153
poi il resto 55 37 40 gli pone altresigrave76 a prefisso laquoReraquo che significa laquorestiraquo e dispone anche una certa linea semplice77 che va da 360 al piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori che egrave esposto di seacuteguito 304 22 20 come nello lsaquoschemarsaquo esposto linea che mostra lrsquoordine del percorso dellrsquoesposizione Questa linea spezzata lagrave dove si trova il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori egrave tracciata inflessa allrsquoindietro lsaquoersaquo punta verso il resto come egrave stato detto in vista di una progressione ordinata E cosigrave facendo prendendo di seacuteguito il laquosottrraquo che significa come egrave stato detto laquoche occorre similmente sottrarre dal re-storaquo e ovviamente prendendo di nuovo il lsaquonumerorsaquo che egrave trovato essere il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori in relazione alla disposizione nella colonna ndash 54 47 13 12 ndash lo scrive di seacuteguito e trova che 9 minuti primi sono posti loro accanto nella colonna trascrive78 anche questi con la segnaletica dei primi scrivendo la lettera A con un lsaquotrattorsaquo sopra e come egrave stato detto prolunga di nuovo la linea spezzata in vista di una buona disposizione tramite una seconda inflessione essendo questa sua parte parallela a quella inizialersquo
La descrizione continua con una serie di laquoe cosigrave viaraquo e non fa ulte-riore riferimento alla tabella
1) La forma verbale ἐξεσμένον Egrave il neutro del participio perfetto medio-passivo di ξέω lett laquopialloraquo laquolevigoraquo Si danno tre possibilitagrave si tratta di un termine canonico per quanto non altrove attestato per designare unrsquoabbreviazione oppure lrsquoautore anonimo improvvisa sul piano metaforico come se unrsquoabbreviazione non fosse altro che la paro-la completa lsquoaccorciata a colpi di piallarsquo in maniera opportuna oppure il testo egrave corrotto e srsquoimpone una correzione ad esempio τὸ ἑξῆς μένον laquociograve che sta di seacuteguitoraquo Questrsquoultima strada mi pare chiusa dal senso delle frase lrsquoabbreviazione non lsquosta di seacuteguitorsquo a niente ma anzi precede la perifrasi τὸ ἑξῆς μένον se impiegata semplicemente per rimandare al segno αφ immediatamente seguente costituirebbe un intollerabile solecismo Se accettiamo la prima di queste letture considerando quin-di lrsquoabbreviazione αφ in posizione predicativa abbiamo a che fare con
76 Rendo in questo modo il τε isolato77 La linea egrave laquosempliceraquo in quanto egrave una retta la precisazione intende evidenziare per
anticipazione il carattere lsquonon semplicersquo che essa assumeragrave alla prima inflessione quando diventeragrave una spezzata linee siffatte erano in effetti concepite dallrsquoanonimo e prima di lui da tutta la tradizione matematica greca come una singola linea spezzata nei punti drsquoinfles-sione I due segmenti paralleli menzionati al termine del passo sono orizzontali
78 Il verbo egrave al medio in variatio rispetto ai due che precedono e che seguono egrave il matematico che lsquosirsquo trascrive le cifre
Fabio Acerbi154
uno hapax semantico nella grecitagrave superstite come egrave facile verificare con una ricerca sul TLG in rete La recensione bizantina risolve il pro-blema sopprimendo semplicemente τὸ ἐξεσμένον
2) La notazione per le specie numeriche Nella terminologia matema-tica greca gli ordini sessagesimali sono εἴδη laquospecieraquo numerici essi corri- spondono agli ordini di grandezza nel nostro sistema decimale e indica-no in analogia con il caso geometrico la lsquoformarsquo che assume un numero quadrato cubo ecc Centinaia e migliaia sono quindi degli εἴδη rispet-tivamente quadrati (100 egrave il quadrato di 10) e cubi (1000 egrave il cubo di 10) sono specie numeriche ma non numeri particolari e drsquoaltronde 300 non egrave un quadrato ma 3 item dellrsquoεἶδος lsquoquadratorsquo 100 3 egrave il numerale di molteplicitagrave della specie quadrata lsquocentinaiarsquo i due 0 che seguono il 3 segnalano esattamente questo fatto che la notazione greca per gli interi non posizionale fa scomparire al livello denotativo Ciograve non vale soltan-to per i numeri interi ma anche per le loro parti i minuti secondi appar-tengono alla specie lsquoquadratorsquo in quanto 13600 egrave il quadrato di 160
La concezione appare interamente dispiegata nellrsquointroduzione degli Arithmetica diofantei79 che si rivela giova farlo rimarcare un te-stimone fondamentale per la ricostruzione della notazione matematica antica Alle specie usate in questrsquoopera vengono assegnati una denomi-nazione ed un segno convenzionale costituito dallrsquoiniziale (di ognuno dei componenti) della denominazione al quadrato o δύναμις il segno ΔΥ al κύβος il segno ΚΥ alla lsquoquarta potenzarsquo o δυναμοδύναμις il segno ΔΥΔ ecc La descrizione di tali segni egrave del tipo καὶ ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον Κ ἐπίσημον ἔχον Υ ΚΥ κύβος laquoe il suo segno egrave un Κ che ha come indice un Υ ΚΥ cuboraquo dove in accordo con quanto abbiamo visto nel punto b supra e pur nel comprensibile imbarazzo del copista della prima parte del Matritensis (o di un suo passato collega) a districarsi in questo formidabile ginepraio notazionale80 le due lettere Κ e Υ ricevono una barra mentre ΚΥ non la richiede a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον il quale ancora una volta esclude automaticamente il segno dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
79 In particolare a DOO I pp 214-62180 Nel Matr 4678 riscontriamo i seguenti fenomeni nelle poche righe a cavallo dei ff
58r-v 1) accento acuto posto su tutti i segni come se fossero abbreviazioni 2) ripetizione sistematica segnodenominazione come in ΚΥ κύβος appena letto dovuta sicuramente allrsquointrusione di glosse interlineari esplicative dei segni ndash e successivo pentimento (δύναμις e κύβος sono in effetti cancellati dalla prima mano il primo con un tratto il secondo con dei punti supra lineam poi il copista si stanca di correggere) 3) nella descrizione del segno per la δυναμοδύναμις menzione di un δέλτα δύο che saragrave molto probabilmente stato ΔΔ subito dopo nella descrizione del κυβόκυβος si legge un incongruo δύο KK
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 155
Diofanto introduce poi dei segni anche per le specie delle parti dellrsquounitagrave (le nostre frazioni) che egli chiama ὁμώνυμα μορία laquoparti omonimeraquo di cui quelle sessagesimali sono casi particolari81 Egli spie-ga appunto che le loro denominazioni sono ottenute da quelle delle specie degli interi per sinonimia passando ad un lsquoordinalersquo82 formato semplicemente aggiungendo il suffisso -στον δυναμοστόν κυβοστόν δυναμοδυναμοστόν ecc (sott μόριον) I loro segni convenzionali sono invece ottenuti da quelli per le specie degli interi aggiungendo una γραμμὴν διαστέλλουσαν τὸ εἶδος laquolinea che distingue la specieraquo83 Una linea sui segni delle specie delle parti egrave richiesta si badi bene per distinguerli dai segni di quelle degli interi come giagrave osservato questi ultimi sono giagrave lsquoagrammaticalirsquo a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον a fortiori lo saranno anche i primi Si tratta della traduzione semio-tica del passaggio dal cardinale allrsquoordinale che a livello grammaticale egrave effettuato con il suffisso -στον Che forma ha questa linea Barra o apice (Egrave cervellotico pensare a forme piugrave complesse) La domanda non ammette una risposta immediata in quanto delle specie diofantee nessuno piugrave si occupa nellrsquoantichitagrave84 Se egrave vero che la prima risposta darebbe origine ad un conflitto tra due convenzioni denotative diffe-renti la barra lsquocitazionalersquo e la barra che distingue la specie lrsquoevidenza grafica del Matritensis lascia lievemente sgomenti (ricordiamoci che giagrave i segni di base sono indebitamente dotati di un accento dal copista) Le poche occorrenze del segno per le specie delle parti85 vedono lrsquoaggiunta di uno slash di sospensione di un doppio apice inverso ndash in tutta evi-
81 Questo fatto era giagrave chiaro nellrsquoantichitagrave Teone in Alm I 10 in iA p 45310-1682 Il parallelo con i cardinali e gli ordinali relativi agli interi egrave reso esplicito da Dio-
fanto ὥσπερ δὲ τῶν ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια παρομοίως καλεῖται τοῖς ἀριθμοῖς τοῦ μὲν τρία τὸ τρίτον τοῦ δὲ τέσσαρα τὸ τέταρτον οὕτως καὶ τῶν νῦν ἐπονομασθέντων ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια κληθήσεται παρομοίως τοῖς ἀριθμοῖς laquocome le parti omonime dei numeri sono chia-mate per assonanza con i numeri di lsquotrersquo lsquolsaquounrsaquo terzorsquo di lsquoquattrorsquo lsquolsaquounrsaquo quartorsquo cosigrave le parti omonime dei numeri appena nominati saranno chiamate per assonanza con i numeriraquo (DOO I p 69-13 si noti lrsquoarticolo lsquocitazionalersquo al singolare in τοῦ τρία e τοῦ τέσσαρα) Il parallelo prosegue anche al livello dei segni che rappresentano queste specie come vedremo tra un attimo
83 Diofanto Arithmetica prefazione in DOO I p 620-21 un passaggio maltrattato in questa edizione occorre espungere il participio ἔχον senza introdurre segni ulteriori oppure eliminare un precedente ἐπί come fa un correttore del Matritensis f 58v
84 Unica parzialissima eccezione lrsquoaccenno di Teone menzionato nella nota 81 supra85 Al f 59r e per di piugrave nel margine per sanare un lungo saut du mecircme au mecircme La
collocazione in margine egrave il motivo per cui troviamo una notazione abbreviata nel resto del trattato il primo copista scioglie tutti i segni prendendoli per abbreviazioni mentre il secondo elimina sistematicamente il tratto aggiuntivo delle specie delle parti dellrsquounitagrave Drsquoaltronde egli scrive ad esempio ΔΥ invece di ΔΥ ed egrave quindi indotto a porre la barra al di sopra della stringa di lettere risultante (passim ma si veda ad esempio il f 72r)
Fabio Acerbi156
denza il compendio per la desinenza -ον accentata il copista interpreta il segno come unrsquoabbreviazione ndash e di una barra a sormontare lo Υ Potremmo forse interpretarlo come il segno di contrazione del grafema -στ- lrsquounico tassello mancante in unrsquoabbreviazione come ad esempio (δυναμοδυναμο)(στ)(ὸν) ma uno scolio di prima mano al f 58v rela-tivo alle specie degli interi inficia questrsquoipotesi esse sono dotate di slash di sospensione accento acuto in un caso del compendio canonico per la terminazione -ον hellip ma tutti gli Υ a esponente sono a loro volta sormontati da una barra
Meno legata al singolo manoscritto ma nondimeno non uniforme si presenta la pratica di notazione dei segni che rappresentano gli enti numerici sessagesimali86 da una parte sta lrsquoevidenza del testo dei Pro-legomena e delle sue tabelle apici ndash drsquoaltronde come abbiamo visto la notazione universalmente impiegata per i numerali ordinali e per le fra-zioni unitarie ndash dallrsquoaltra sta lrsquoevidenza del testo dellrsquoAlmagesto in tutti i manoscritti piugrave antichi e lo stesso si dica del commentario teonino a questrsquoopera o del suo lsquoGrande commentariorsquo alle Tavole facili e dei testi astronomici su papiro barre87 Sembra insomma che la nostra docu-
86 Sia le molteplicitagrave che le specie ahimeacute entrambe rappresentate da lettere dellrsquoalfabeto Come osservato allrsquoinizio della sezione 3 ci sono in effetti due tipi di lettere numerali in gioco se facciamo astrazione da apici o barre lsquo4 minuti secondirsquo si trova scritto δ β la prima lettera numerale denota la molteplicitagrave degli item di una certa specie la se-conda la specie nei Prolegomena entrambe sono accompagnate da un doppio apice il che rende inutile la presenza delle seconde Si noti che la descrizione della tabella non fa parola della notazione da usare per le lettere numerali che denotano la molteplicitagrave barre o apici e quanti apici hellip In questo caso fa interamente fede la tabella cioegrave la pratica grafica condivisa instauratasi non egrave chiaro quando
87 I manoscritti piugrave antichi dellrsquoAlmagesto sono menzionati nella nota 10 supra quelli dei due commentarii teonini sono il Laur Plut 2818 e il celeberrimo Vat gr 190 (sec IX in Euclide Elementi Data Teone lsquoGrande commentariorsquo) per la notazione dei pa-piri astronomici si veda Jones 1999 II passim La notazione non sembra lsquoinquinatarsquo dalla pratica dei copisti bizantini e pare dipendere soltanto dalla data di composizione Tro-viamo ad esempio barre sopra tutti i numerali di molteplicitagrave (interi o sessagesimali) nel frammento di un commentario alle Tavole facili contenente un calcolo relativo al 24 aprile 213 (Par gr 2841 sec XIII ex-XIV in oltre al frammento ai ff 32r l 11-34v l 23 contiene Arato Phaenomena ed Efestione Apotelesmatica edizione in Jones 1990) Nel commentario alle Tavole facili composto ca 610-617 ed attribuito a Stefano di Alessandria la situazione egrave la seguente (Jean Lempire per litteras per lrsquoedizione si veda Lempire 2014 ho controllato il Vat gr 304 ff 135r-171v sec XIV am contiene in aggiunta Teone in Almagestum I-II lsquoPiccolo commentariorsquo alle Tavole facili Diofanto Arithmetica e De polygo-nis numeris varia astronomica tabulae) barre sopra gli interi sporadicamente rimpiazzate da apici apici sopra le parti sessagesimali in numero uguale alla denominazione doppio () apice per le frazioni unitarie Sono impiegate barre sopra gli interi e apici sopra le parti sessagesimali nei manoscritti principali di tutti i trattati di introduzione allrsquoAlmagesto o comunque di argomento logistico redatti in epoca bizantina Giorgio Pachimere (1242-ca 1310) Quadrivium (autografo nel manoscritto Roma Biblioteca Angelica gr 38 [RGK III nr 115] si veda Tannery ndash Steacutephanou 1940 per lrsquoedizione) Teodoro Metochita (1270-
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 157
mentazione si faccia testimone di un cambio notazionale avvenuto nel periodo intercorrente fra Teone (sec IV pm) e la scuola alessandrina di Ammonio e dei suoi allievi (sec VI in) e probabilmente innescato da questrsquoultimo ambiente lrsquoaspetto paradossale egrave che nello stesso codice si rintraccino due notazioni differenti per gli enti numerici sessagesimali e lrsquouna (apici) sia adottata sistematicamente e coerentemente in uno scritto (i Prolegomena) che si presenta esattamente come unrsquointroduzione tecnica alla pratica numerico-algoritmica del trattato (lrsquoAlmagesto) in cui egrave adottata lrsquoaltra (barre che ritroviamo senza eccezioni anche negli scolii)
Torniamo ai Prolegomena la descrizione del segno da porre a fianco di ogni singolo quoziente parziale e denotante la sua specie numerica (minuti primi minuti secondi ecc) solleva tre problemi
Primo problema Ci vuole una barra o un apice su τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquola lettera A [hellip] che significa la specieraquo quando lo scriviamo nella tabella Tutta la nostra discussione precedente fa pro-pendere per lrsquoapice e si ricordi anche la forma verbale ἀνατείνουσαν che suggerisce qualcosa che si lsquoestende verso lrsquoaltorsquo (la mia traduzione egrave volutamente neutra) se fosse apposta una barra la cosa dovrebbe passare
1231332) Compendium astronomicum (copia lsquoautorizzatarsquo coeva nei Vat gr 182 e 181 da parte del copista che integrograve le parti mancanti del Par gr 2389 [ff 207-210 255-270 374-375] Bianconi 2005a pp 425-427 Peacuterez Martiacuten 2008 p 436 e n 177) Teodoro Meliteniota (morto lrsquo831393) Tribiblos astronomica (autografo nel Vat gr 792 si vedano Leurquin 1991 per unrsquoanalisi del manoscritto Leurquin 1990 per lrsquoedizione) una com-pilazione anonima (per cui ho consultato il Par gr 2396 ff 87r-92v limitatamente a questi fogli manu Costantino Trivoli [RGK II nr 318 ma ovviamente questo codice non vi egrave segnalato] terzo quarto del XV secolo il resto del codice annotato da Niceforo Gregora egrave di etagrave planudea e parzialmente [ff 33v-76v] un autografo di Planude stesso contiene Teone in Almagestum I II IV Mondrain 2002 il codice va completato ndash limitatamente a stralci dei libri VIII-X XII-XIII del commentario teonino la cui parte intermedia si egrave persa ndash con 26 carte [ff 123-147] inserite nel Vat gr 1087 anchrsquoesso contenente anno-tazioni di Gregora Rome 1927 per la figura del copista dei ff 77r-86r del Par gr 2396 e dei ff appena nominati del Vat gr 1087 un anonimo collaboratore di Gregora si veda in ultimo Bianconi 2006a pp 147-151) si veda anche il calcolo effettuato da Niceforo Gre-gora (12921295-13581361) dellrsquoeclisse di sole del 16 luglio 1330 (attestata unicamente ai ff 1r-8v della miscellanea astronomica Marc gr 325 databile ca 1324-1329 in parte vergata e ovunque fittamente annotata da Gregora stesso edizione del testo in Mogenet et al 1983 annotazioni di Gregora elencate in Bianconi 2005a p 413) Unrsquoeccezione apparente il lsquoPiccolo commentariorsquo di Teone alle Tavole facili le parti sessagesimali sono segnalate da apici (ad esempio nel Vat gr 175 vergato da Giovanni Catrario e completato nel 1321-1322 sulla figura di Catrario si vedano in ultimo Bianconi 2005b pp 141-156 e 2006b) lrsquoopera egrave antica ma la sua tradizione non rimonta oltre la fine del XIII secolo a parte un frammento nel Leiden BPG 78 ff 156r-161v (minuscola del IX-X secolo) e in effetti in questo manoscritto tutti i numerali di molteplicitagrave sono sormontati da barre Unrsquoeccezione effettiva egrave il De hypotesibus planetarum nel Vat gr 1594 barre sugli interi e apici sulle parti sessagesimali
Fabio Acerbi158
sotto silenzio e la presenza dellrsquoapice la rende inutile88 Si tratta della stessa convenzione diofantea e coincide ancora con la notazione per i numerali ordinali e per le frazioni unitarie che egrave corrente nei mano- scritti matematici greci per questo motivo non percheacute la descrizione sia particolarmente perspicua nessuno dei copisti della recensione an-tica ha incertezze apici Ma questi apici si rintracciano soltanto sulle indicazioni di specie non contemplate dalla descrizione che sono ante-poste ai resti parziali a fianco dei quozienti parziali i segni di specie sono invece trasformati in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordi-nali corrispondenti del tipo πρωτ tavv 5 e 7b-8 Il recensore bizantino taglia invece la testa al toro elimina dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali elimina la seconda menzione della laquolet-tera Araquo contestualmente allrsquoazzeramento dellrsquoespediente della linea a zig-zag (si veda il punto seguente) modifica la descrizione che contiene la prima menzione in quella dellrsquoapice associato direttamente ai nume-rali di molteplicitagrave riciclando addirittura lrsquoalpha per adibirlo a desi-gnare un numero cardinale (come sorprendersi) τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ laquoponendo al di sopra di essi [scil dei 50 minuti primi] 1 solo lsaquoaccentorsaquo acutoraquo La scelta del recensore egrave assennata che rechi una barra o un apice in una tabella un alpha denota un numero non un numero drsquoordine
Secondo problema da tenere ben distinto dal precedente Cosa ci vuole sul segno α per la lettera alpha menzionata nella frase τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquolettera A [hellip] che significa la specieraquo89 Unrsquooc-chiata allrsquoapparato critico rivela una bella incertezza nei manoscritti Z scrive sempre ᾱ e in un caso lo fa anche P MS optano sempre per α´ C per α P scrive nellrsquoaltro caso αο Per quanto solo la barra sia congrua con il senso della frase in quanto la lettera alpha egrave qui menzionata (si tratta di un oggetto che compare nella tabella) e non cambia niente se essa egrave accompagnata dal suo nome di genere στοιχεῖον ad un livello grafico lrsquoincertezza fra il segno ᾱ che denota laquola lettera αraquo e il segno α´ (o lrsquoabbreviazione αο) per una forma di πρῶτος egrave per piugrave versi giustificata
88 Detto in altri termini la barra egrave uno strumento grafico non matematico e quindi la sua presenza non va segnalata mentre un apice lo egrave e la sua presenza lo deve
89 Notare che in questa frase il primo α non vuole la barra (egrave menzionato allrsquointerno di una frase che impiega convenzioni moderne) il secondo sigrave (idem ma con convenzioni antiche) ndash e nella traduzione la scelta di denotarlo con A (senza virgolette) e non con lsquoArsquo (con virgolette) egrave del tutto arbitraria ndash si noti inoltre che le necessarie precisazioni laquosenzacon virgoletteraquo mostrano che le lingue moderne palesano difficoltagrave analoghe a quelle del greco antico per quanto riguarda i livelli denotativi in ambito metadiscorsivo per non usare le due parentetiche avrei dovuto scrivere rispettivamente lsquoArsquo e lsquolsquoArsquorsquo (doppie virgolette semplici)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 159
ᾱ coincide con il numerale 1 α egrave la prima lettera dellrsquoalfabeto ed inoltre α´ egrave esattamente quello che va scritto nella tabella Potremmo dirci che il sostantivo στοιχεῖον chiude la questione la sua presenza congiunta ad un ipotetico α´ renderebbe la descrizione ridondante o inappropriata90 Ma a parte il fatto che α egrave proprio τὸ πρῶτον στοιχεῖον il segno α´ cat-tura in fondo il cuore della descrizione di uno στοιχεῖον ἔχον lsaquoγραμμὴνrsaquo ἀνατείνουσαν
Terzo problema Lrsquoautore dei Prolegomena che si arresta allrsquoesem-pio dei minuti primi non dice quanti apici occorre mettere sulle lettere numerali che identificano gli ordini superiori al primo se uno soltanto come nel caso diofanteo e delle frazioni unitarie o in numero uguale alla loro denominazione (cioegrave pari al numero denotato dal numerale stesso su cui vanno posti) come effettivamente avviene nei mano-scritti dei Prolegomena La tabella egrave quindi sottodeterminata dalla sua descrizione anzi in un certo senso prende il sopravvento su di essa la pratica di marcare i numerali di molteplicitagrave con gli apici che compe-tono allrsquoordine cui appartengono viene trasferita ai segni per gli ordini stessi per supplire ad una descrizione carente di questi ultimi E la tabella egrave sottodeterminata dalla descrizione in quanto egrave la descrizione di una tabella reale ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις laquocome nello lsaquoschemarsaquo espostoraquo leggiamo a un certo punto del testo
3) La linea a zig-zag Non possiamo che applaudire a questo geniale espediente grafico lo troviamo messo in opera solo nel Marc gr 313 Per quanto lrsquoautore non faccia parola di ciograve nel corso della sua descrizione la linea spezzata egrave intesa dover lsquosaltarersquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue Il copista del codice marciano effettua correttamente due salti nella prima delle sue tabelle (tav 4) ma inserisce un lsquodentersquo in piugrave in quella che considera corretta (tav 5) La linea a zig-zag egrave incompatibile con la presenza di linee di giustificazione nella tabella che in effetti mancano nel Marc gr 313 ciograve induce gli errori di allineamento dei primi 5 quozienti parziali di cui egrave vittima il copista Probabilmente per questo motivo in nessuno degli apografi del Vat gr 1594 la linea a zig-zag figura nella tabella inquadrata come si conviene da una (doppia) cornice esterna e le cui colonne sono appunto separate da linee verticali (tav 7b Vat gr 184 f 17v e tav 8 Par gr 2390 f 9v cui egrave sostanzialmente identica la tabella del Marc gr 314 che si trova
90 Trascuro lrsquoabbreviazione αο = πρῶτος percheacute la desinenza non egrave quella richiesta neacute nella frase (egrave richiesto πρῶτον) neacute nella tabella (πρῶτα)
Fabio Acerbi160
al f 248r ndash ma la mancanza di linee orizzontali causa un gigantesco pa-sticcio nel codice vaticano) Alla recensione bizantina che dipende per il suo testo di base dal Vat gr 1594 e quindi non trova la linea a zig-zag nella tabella non resta che sopprimere la sua descrizione ndash ma proprio per questo motivo e finalmente diventa possibile tracciare un apparato completo di linee di giustificazione (tav 9 Laur Plut 89 sup 48 f 14v) Dato che la descrizione di Teone di questo procedimento di divi-sione non fa cenno allrsquoesistenza della linea a zig-zag viene da chiedersi se essa non costituisca un espediente escogitato dallrsquoautore dei Prolegomena per vivacizzare la procedura originale di Pappo
4) Discrepanze tra descrizione e tabella Il gioco delle minime va-rianti mostra che la divisione era stata eseguita (e trasmessa) corret-tamente tutti i valori numerici sono esatti La tabella nel Marc gr 313 presenta perograve alcune discrepanze con la propria descrizione Essa omette (ma non nella versione lsquoscorrettarsquo lrsquoomissione non si riscontra neanche nel Par gr 2390) il segno per laquorestoraquo di fronte ai resti par-ziali ma aggiunge lrsquoindicazione della loro specie Essa trasforma invece come abbiamo visto le indicazioni di specie che seguono i quozienti parziali in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordinali corri-spondenti La descrizione prevede di chiudere la tabella con il risultato καὶ συνάγων ἅπαντα τὰ ἐκ τῶν μερισθέντων μερῶν λεπτὰ σημειοῦται ὑπὸ πάντας οὕτως γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoe raccogliendo tutti i minuti che provengono dalle parti divise lsaquoPapporsaquo nota sotto tutto cosigrave Ris 0 59 8 17 13 12 31raquo ma sotto la tabella tutta la tradizione ci consegna qualcosa di piugrave articolato ὁ ζητούμενος καθ᾽ ὃν μερίζεται ὁ τξε ιδ´ μη´´ π(αρὰ) τὸν τξ γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoil lsaquonumerorsaquo cercato secondo cui 365 14 48 egrave diviso per 360 risulta 0 59 8 17 13 12 31raquo frase che del resto contiene due errori lrsquoinversione del dividendo e del divisore e la confusione tra segno convenzionale (iuxta descrizione) e abbreviazione (come nella frase) nel caso di γι Oltre ad eliminare la linea a zig-zag91 la recensione bizantina sopprime dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali e modifica come abbiamo visto al punto 2 le loro descrizioni in quelle di apici associati diretta-mente ai numerali di molteplicitagrave
91 Le due righe che nella recensione di base contengono solo i resti parziali minori di 160 del divisore ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue sono in parte completate con lrsquoindicazione abbreviata ἀνάλ(υσις) laquoanalisiraquo il termine greco per questa procedura di riduzione In un sussulto di ipercorrettismo matematico tali resti parziali ridotti non sono preceduti dal segno per laquorestoraquo come nel Par gr 2390 ma da quello per laquorisultatoraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 161
Gli esempi che abbiamo discusso mostrano come i problemi di notazione pesino e non poco sullrsquoespressione discorsiva di un algorit-mo matematico lrsquoente di riferimento per lsquoformularersquo il procedimento di divisione fu considerata la tabella cioegrave un oggetto la cui costitu-zione egrave legata piugrave ad una pratica grafica che a considerazioni logico- algoritmiche non la sua descrizione che in effetti finisce per determi-nare la tabella in maniera non univoca Di questa sottodeterminazione si fa testimone la traiettoria che abbiamo cercato di seguire nelle mani di copisti e revisori il procedimento di divisione si modifica a volte in aspetti secondari a volte in punti piugrave sostanziali ndash fino a rendere neces-saria una radicale revisione della sua descrizione per renderla conforme alla tabella ndash in ogni caso mai per ragioni squisitamente matematiche92
Abstract
The article presents and discusses in detail two passages from the anonymous Prolegomena to the Almagest a VIth century primer to the elementary procedures of calculation needed in Ptolemyrsquos Almagest In the two passages we may follow the complex interplay between mathematical notation the auctor who employed and described it the tachygrapher who transcribed it in vivo copyists who reproduced it correctors who modified it Along this path misgivings and errors arise in the transmission of abbreviations and paratextual units such as diagrams tables operational schemes
Fabio AcerbiCNRS UMR8560 Centre Alexandre Koyreacute
fabacerbigmailcom
92 Sono grato a Daniele Bianconi Lucio del Corso Jean Lempire per alcune preziose indicazioni
AOO = Archimedis opera omnia cum commentariis Eutocii ed J L Heiberg I-III Lipsiae 1910-1915
DOO = Diophanti Alexandrini opera omnia cum Graecis commentariis ed P Tannery I-II Lipsiae 1893-1895
GC = Le laquoGrand Commentaireraquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Mogenet ndash A Tihon I-III Cittagrave del Vaticano 1985-1999
iA = Commentaires de Pappus et de Theacuteon drsquoAlexandrie sur lrsquoAlmageste ed A Rome I-III con paginazione continua Cittagrave del Vaticano 1931-1943
HOO = Heronis Alexandrini opera quae supersunt omnia ed G Schmidt ndash L Nix ndash W Schmidt ndash H Schoene ndash J L Heiberg I-V Lipsiae 1899-1914
PC = Le ldquoPetit Commentairerdquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed A Tihon Cittagrave del Vaticano 1978
POO = Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia ed J L Heiberg I-II in 3 parti Lipsiae 1898-1907
RGK = Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600 I Handschriften aus Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln II Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs und Nachtraumlge zu den Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln III Handschriften aus Bibliotheken Roms mit dem Vatikan A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg unter Mitarbeit von D Harlfinger und P Eleuteri B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln Wien 1981-1997 (Oumlsterreichische Akademie der Wissenschaften Veroumlffentlichungen der Kommission fuumlr Byzantinistik III1-3 A-C)
Sigla
Acerbi 2010 = F Acerbi Il silenzio delle sirene La matematica greca antica Roma 2010
Acerbi 2012 = F Acerbi I codici stilistici della matematica greca dimostrazioni procedure algoritmi laquoQUCCraquo 1012 (2012) pp 167-214
Acerbi et al 2010 = F Acerbi ndash N Vinel ndash B Vitrac Les Proleacutegomegravenes agrave lrsquoAlmageste Une eacutedition agrave partir des manuscrits les plus anciens Introduction geacuteneacuterale ndash Parties I-III laquoSCIAMVSraquo 11 (2010) pp 53-210
Agati 1992 = M L Agati La minuscola laquoBouleteacuteeraquo Cittagrave del Vaticano 1992
Belger 1881 = C Belger Ein neues Fragmentum mathematicum Bobiense laquoHermesraquo 16 (1881) pp 261-284
Bianconi 2005a = D Bianconi La biblioteca di Cora tra Massimo Planude e Niceforo Gregora Una questione di mani laquoSampTraquo 3 (2005) pp 391-438
Bianconi 2005b = D Bianconi Tessalonica nellrsquoetagrave dei Paleologi Le pratiche intellettuali nel riflesso della cultura scritta Paris 2005
Bianconi 2006a = D Bianconi Le pietre e il ponte ovvero identificazioni di mani e storia della cultura laquoBizantinisticaraquo 8 (2006) pp 135-181
Bianconi 2006b = D Bianconi Qualcosa di nuovo su Giovanni Catrario laquoMEGraquo 6 (2006) pp 69-91
Cavallo 1977 = G Cavallo Funzione e strutture della maiuscola greca tra i secoli VIII-XI in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Colloque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 95-137
Cereteli 1904 = G F Cereteli De compendiis scripturae codicum Graecorum praecipue Petropolitanorum et Mosquensium anni nota instructorum Sankt-Petersburg 1904
De Gregorio 2000 = G De Gregorio Materiali vecchi e nuovi per uno studio della minu-scola greca fra VII e IX secolo in G Prato (a cura di) I manoscritti greci tra riflessione e dibattito Atti del V Colloquio Internazionale di Paleografia Greca Cremona 4-10 ottobre 1998 Firenze 2000 pp 83-151
Follieri 1977 = E Follieri La minuscola libraria dei secoli IX e X in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Col-loque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 139-165
Fonkič 2005 = B Fonkič Venecianskaia rukopisrsquo laquoAlrsquomagestaraquo Ptolemeja (Marc gr 313690) o datirovke i proischoždenii kodeksa laquoVDIraquo s III 254 (2005) pp 162-167
Fowler 1999 = D H Fowler The Mathematics of Platorsquos Academy A New Reconstruction Second Edition Oxford 1999
Bibliografia
Fabio Acerbi164
Gerstinger ndash Vogel 1932 = H Gerstinger ndash K Vogel Eine stereometrische Aufgaben-sammlung im Papyrus Graecus [sic] Vindobonensis 19996 laquoMitteilungen aus der Papy-russammlung der Nationalbibliothek in Wienraquo Neue Serie Folge 1 Griechische literarische Papyri 1 Wien 1932 pp 11-76
Heiberg 1927 = Mathematici Graeci Minores ed J L Heiberg Kjoslashbenhavn 1927
Hultsch 1876-1878 = Pappi Alexandrini Collectionis quae supersunt ed F Hultsch I-III Berlin 1876-1878
Janz 2003 = T Janz The Scribes and the Date of the Vat gr 1291 in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae X Cittagrave del Vaticano 2003 pp 159-180
Jones 1990 = Ptolemyrsquos First Commentator ed A Jones Philadelphia 1990
Jones 1999 = Astronomical Papyri from Oxyrhynchus ed A Jones I-II Philadelphia 1999
Jones 2005 = A Jones Ptolemyrsquos Canobic Inscription and Heliodorusrsquo Observation Reports laquoSCIAMVSraquo 6 (2005) pp 53-97
Lempire 2014 = Steacutephanos drsquoAlexandrie Le commentaire aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Lempire Louvain 2014
Leurquin 1990 = Theacuteodore Meacuteliteacuteniote Tribiblos astronomique Livre I ed R Leurquin Amsterdam 1990
Leurquin 1991 = R Leurquin Un manuscrit autographe de la Tribiblos Astronomique de Theacuteodore Meacuteliteacuteniote le Vaticanus graecus 792 laquoScriptoriumraquo 45 (1991) pp 145-162
Maas 1927 = P Maas Griechische Palaeographie in A Gercke ndash E Norden (hrsg von) Einleitung in die Altertumswissenschaft I9 Leipzig 1927 pp 69-80
Martinelli Tempesta 2010 = S Martinelli Tempesta Il codice Milano Biblioteca Am-brosiana B 75 sup (gr 104) e lrsquoevoluzione della scrittura di Giovanni Scutariota in A B Garciacutea ndash I Peacuterez Martiacuten (ed by) The Legacy of Bernard de Montfaucon Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting Proceedings of the Seventh Inter-national Colloquium of Greek Palaeography Madrid-Salamanca 15-20 September 2008 Turnhout 2010 pp 171-186
Mazzucchi 1994 = C M Mazzucchi Leggere i classici durante la catastrofe (Costantino-poli maggio-agosto 1203) le note marginali al Diodoro Siculo Vaticano gr 130 Parte prima stratigrafia laquoAevumraquo 68 (1994) pp 164-218
Mioni 1976 = E Mioni Bessarione scriba e alcuni suoi collaboratori in Miscellanea marcia-na di studi bessarionei Padova 1976 pp 263-323
Mioni 1985 = Codices graeci manuscripti Bibliothecae Divi Marci Venetiarum II Thesaurus Antiquus Codices 300-625 recensuit E Mioni Roma 1985
Mogenet 1962 = J Mogenet Une scholie ineacutedite du Vat gr 1594 sur les rapports entre lrsquoastronomie arabe et Byzance laquoOsirisraquo 14 (1962) pp 198-221
Mogenet et al 1983 = Niceacutephore Greacutegoras Calcul de lrsquoeacuteclipse de soleil du 16 juillet 1330 ed J Mogenet ndash A Tihon ndash R Royez ndash A Berg Amsterdam 1983
Mondrain 2002 = B Mondrain Maxime Planude Niceacutephore Greacutegoras et Ptoleacutemeacutee laquoPa-laeoslavicaraquo 10 (2002) pp 312-322
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 165
Mondrain 2004 = B Mondrain Lrsquoancien empereur Jean VI Cantacuzegravene et ses copistes in A Rigo (a cura di) Gregorio Palamas e oltre Studi e documenti sulle controversie teologiche del XIV secolo bizantino Firenze 2004 pp 249-296
Mondrain 2007 = B Mondrain Les eacutecritures dans les manuscrits byzantins du XIV e siegravecle Quelques probleacutematiques laquoRSBNraquo n s 44 (2007) pp 157-196
Peacuterez Martiacuten 2006 = I Peacuterez Martiacuten Maxime Planude et le Diophantus Matritensis (Madrid Biblioteca Nacional ms 4678) un paradigme de la reacutecupeacuteration des textes anciens dans la ldquorenaissance paleacuteologuerdquo laquoByzantionraquo 76 (2006) pp 433-462
Peacuterez Martiacuten 2008 = I Peacuterez Martiacuten El lsquoestilo Hodegosrsquo y su proyeccioacuten en las escrituras constantinopolitanas laquoSampTraquo 6 (2008) pp 389-458
Perria 1991 = L Perria Scrittura e ornamentazione nei codici della laquocollezione filosoficaraquo laquoRSBNraquo n s 28 (1991) pp 45-111
Rollo 2012 = A Rollo LrsquoArchimede di Giorgio Valla in V Fera ndash D Gionta ndash A Rollo (a cura di) Archimede e le sue fortune Atti del Convegno di Siracusa-Messina 24-26 giugno 2008 Messina 2012 pp 99-147
Rome 1927 = A Rome Membra disjecta laquoRBenraquo 39 (1927) pp 187-188
Rome 1938 = A Rome Un manuscrit de la bibliothegraveque de Boniface VIII agrave la Meacutediceacuteenne de Florence laquoACraquo 7 (1938) pp 261-268
Ronconi 2013 = F Ronconi La collection philosophique un fantocircme historique laquoScripto-riumraquo 67 (2013) pp 119-140
Tannery ndash Steacutephanou 1940 = Quadrivium de Georges Pachymegravere ed P Tannery ndash E Steacutephanou Cittagrave del Vaticano 1940
Tihon 2011 = Πτολεμαίου Πρόχειροι Κανόνες Les Tables faciles de Ptoleacutemeacutee vol Ia Tables A1-A2 ed A Tihon Leuven 2011
Traube 1907 = L Traube Nomina Sacra Versuch einer Geschichte der christlichen Kuumlrzung Muumlnchen 1907
Vogel 1936 = K Vogel Beitraumlge zur griechischen Logistik laquoSBAWraquo Mathematisch-natur-wissenschaftliche Abteilung Jahrgang 1936 pp 357-472
Wouters 1979 = A Wouters The Grammatical Papyri from Graeco-Roman Egypt Contri-butions to the Study of the lsquoArs Grammaticarsquo in Antiquity Brussel 1979
F ACERBI Tav 1
b Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 65r
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 284 f 160r
F ACERBITav 2
b Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 13r
a Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 19v
F ACERBI Tav 3
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 136v
F ACERBITav 4
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17r
F ACERBI Tav 5
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17v
F ACERBITav 6
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 7v
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 137
accanto al dividendo40 I due passi precedenti sono quindi ripetuti con la sola differenza che il resto appena ottenuto prende il posto del divi-dendo il quoziente parziale scala di un ordine sessagesimale ad ogni passo41 E cosigrave via aggiungendo ogni volta due caselle La debolezza di questo metodo come di quello che utilizziamo attualmente risiede nel fatto che il reperimento dei quozienti parziali (ovverosia dei massimi multipli) viene effettuato per tentativi non riuscire a farlo al primo colpo appesantisce notevolmente i calcoli successivi e costringe ad un lavoro di riordino e addizione dei quozienti parziali stessi La tabella risultante dove appunto osserviamo questo fenomeno in parallelo con identiche inaccuratezze nella descrizione ha la forma riprodotta unico tra i manoscritti della recensione antica nel Marc gr 313 f 13r (tav 2b invito il lettore a non rivolgersi alle tavole se non dopo aver termi-nato questa sezione sarebbe anzi auspicabile che tentasse di ricostruire questa tabella e le due successive a partire dalla mia descrizione)42
Il secondo metodo di divisione attribuito a Pappo egrave congegnato in modo da rendere non aleatoria la ricerca dei quozienti parziali Come altrove nei Prolegomena la descrizione della procedura di calcolo si riag-gancia esplicitamente a una frase di Tolomeo laquouna volta dimostrato che il periodo di una singola rivoluzione lsaquodel solersaquo egrave di 365 giorni 14 48 se di-vidiamo per essi i 360 gradi di un singolo cerchio avremo il moto medio giornaliero del sole circa 0 gradi 59 8 17 13 12 31raquo43 Questrsquoaffermazione si trova nel terzo libro dellrsquoAlmagesto si tratta della prima occasione in cui viene effettuata una divisione in cui il divisore egrave maggiore del dividendo e i commentatori del trattato tolemaico non si fecero sfuggire lrsquooccasione di mostrare come eseguirla Ora il terzo libro del commentario di Pappo non ci egrave pervenuto Ci resta dunque come testo parallelo a quello dei Prolegomena la descrizione rigidamente formulare in Teone sicuramente un calco di quella pappiana Teone qui come nelle altre applicazioni del metodo (Laur Plut 2818 ff 136v [tav 3] e 190r) descrive brevemente ed espone esplicitamente la stessa tavola dei sottomultipli del divisore che
40 Esempio nella divisione di 378 per 17 il massimo multiplo egrave 374 il quoziente parziale egrave 22 il resto 4 e in effetti 378 = 374 + 4 = 17times22 + 4 Si noti che il segno per laquorestoraquo non egrave apposto in testa di riga ma davanti a ogni resto parziale e in effetti il dividendo che si trova in prima posizione in questa riga non egrave un resto
41 Analogamente nellrsquoalgoritmo moderno poniamo la virgola o scaliamo la cifra di un posto
42 Nei Prolegomena la descrizione della tabella associata al metodo anonimo egrave pre-ceduta da una breve sinossi dellrsquooperazione in stile procedurale (cioegrave senza riferimenti alla tabella) e seguita dalla sua esecuzione accurata ma con pochi riferimenti alla tabella se non quello ai due segni da apporre ai resti parziali e ai massimi multipli
43 Alm III 1 in POO I 1 p 2091-4
Fabio Acerbi138
troviamo nei Prolegomena ma non offre alcuna descrizione della disposi-zione tabellare della divisione stessa neacute vi fa riferimento
A questa procedura sono in effetti associate una tavola e una tabel-la costruite come segue (tavv 4 e 5 Marc gr 313 ff 17r e 17v il co-pista era ndash giustamente ndash insoddisfatto della prima versione) La tavola le cui righe e colonne sono delimitate da linee contiene sottomultipli44 del divisore 365 14 48 9 righe che riportano i valori da 160 a 960 piugrave altre 6 con i valori per decine da 1060 a 6060 la prima colonna elenca le 15 parti sessagesimali omettendo come drsquoabitudine la laquodenomina-zioneraquo dellrsquoordine (i numerali elencati sono quindi α β γ δ ε ϛ ζ η θ ι κ λ μ ν ξ) la seconda i sottomultipli corrispondenti organizzati su quattro colonne per tener conto dei tre ordini sessagesimali (il primo sottomultiplo egrave quindi ϛ ε´ ιδ´´ μη´´´ cioegrave 160 di τξε ιδ´ μη´´) La tabella priva di linee delimitanti espone la vera divisione Nella prima colonna troviamo i resti parziali ognuno preceduto dallrsquoindicazione del proprio ordine sessagesimale e da un segno per laquorestoraquo Nella seconda preceduti da un segno per laquosottrairaquo i sottraendi ognuno coincide ovviamente con uno dei sottomultipli nella tavola La terza colonna contiene se-guiti dallrsquoindicazione del proprio ordine sessagesimale i quozienti par-ziali ottenuti trascrivendo dalla prima riga della tavola il numerale corrispondente al sottraendo affiancato ed assegnando come ordine sessagesimale il successivo a quello posto in testa di riga Il risultato preceduto da un segno per laquorisultaraquo e posto al di sotto della tabella si ottiene sommando i quozienti parziali il procedimento non permette in generale di determinare lrsquointero quoziente parziale relativo ad un ordine sessagesimale fissato se non dopo due passi Una linea spezzata unisce i resti parziali successivi e i relativi sottraendi per evidenziare la laquoprogressione della proceduraraquo la spezzata lsquosaltarsquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore (le cui righe sono per il resto vuote) e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue di conseguenza anche il quoziente parziale relativo a questo resto appartiene allrsquoordine sessagesimale successivo
A questo punto possiamo rivolgerci alle tavv 4-5 e verificare se le immagini che ci siamo formati sulla base della mia descrizione corri-spondono a quelle che troviamo nel Marc gr 313 Non si tratta di un giochetto sterile egrave al contrario il cuore di un intrico di problemi Un primo ordine di problemi deriva dal fatto che nei Prolegomena lrsquoalgo-
44 Sottomultipli e non multipli in quanto il divisore egrave maggiore del dividendo Drsquoaltronde nel sistema sessagesimale come in quello decimale un sottomultiplo si ottiene dal multiplo corrispondente semplicemente scalando tutte le cifre di un posto (ad esempio 1360 di 365 14 48 si ottiene in questa maniera da 13 volte 365 14 48)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 139
ritmo della divisione lsquoalla Papporsquo non egrave mai eseguito (cioegrave formulato verbalmente) in maniera indipendente dalla descrizione della tabella Comrsquoegrave dunque possibile descrivere una tabella operazionale che non ha uno statuto testuale indipendente sulla base di un algoritmo in corso di esecuzione E drsquoaltro canto come non rilevare unrsquoanomalia in un algoritmo eseguito nella sua forma primaria sotto forma di descrizione di una tabella Ci potremmo chiedere se viene descritto lrsquoalgoritmo o la tabella La tensione fra i due enti grafici egrave acuita dal fatto che nei nostri testi tutto ciograve (esposizione o descrizione di un algoritmo o della tabella associata) avviene sempre e solo sulla base di un esempio numerico para-digmatico Per questo motivo la tabella in quanto struttura (cioegrave privata dei dati numerici accidentali) non puograve fare a meno della descrizione45 Dal canto suo Teone come forse Pappo ancor prima descrive ed espone la tavola dei (sotto)multipli ma non la tabella di divisione lrsquoalgoritmo relativo a questrsquoultima egrave espresso come per controbilanciare in maniera eccezionalmente trasparente e formulare Se ciograve comporta un guada-gno a livello verbale-argomentativo sorge un problema operativo grave come e dove sistemare i resti e i quozienti parziali ndash cioegrave tutti i numeri in output dellrsquoalgoritmo differenti dai (sotto)multipli ndash che la tabella si incarica di disporre in modo lsquonaturalersquo Teone prescrive soltanto di confrontare i resti con la seconda colonna della tavola dei sottomultipli e di trascrivere via via il quoziente ottenuto dopo ogni passo Insomma come eseguire materialmente una divisione Non certo adattando ad un nuovo caso specifico la formulazione dellrsquoalgoritmo che Teone propone
Un secondo ordine di problemi e una trappola micidiale per il co-pista egrave interno alla dialettica lsquotabellarsquolsquosua descrizionersquo ed egrave in assenza di simbolismo quello dei riferimenti linguistici da adottarsi nella seconda agli enti grafici che figurano nella prima Occorre ricercare la massima generalitagrave fornita da una descrizione definita di un ente numerico (ad esempio impiegando il termine laquorestoraquo o la perifrasi laquomassimo sotto-multiplo minoranteraquo) o basta assumere direttamente il suo valore speci-fico come esempio paradigmatico E in che modo risolvere il conflitto tra uso e menzione se come nel nostro caso la tabella contiene segni convenzionali ed occorre fornirne una descrizione Si rende ad esempio necessario introdurre un lsquooperatore di citazionersquo noi useremmo le virgo-lette la lingua greca premette lrsquoarticolo neutro Drsquoaccordo ma nel caso
45 Questa caratteristica non egrave connaturata alla matematica degli algoritmi la risorsa dello lsquostile proceduralersquo serve esattamente ad aggirare questo problema al di lagrave di un certo livello di dettaglio perograve essa condurrebbe ad un appesantimento insostenibile della for-mulazione dovuto alla pluralitagrave dei riferimenti agli oggetti matematici in gioco sulla que-stione dei diversi stili della matematica greca si veda Acerbi 2012
Fabio Acerbi140
greco qual egrave il suo range E come distinguerlo nei casi ambigui da un semplice articolo che precede un sostantivo quando questrsquoultimo lo ri-chieda Nel corso del processo di copia del testo della descrizione infine possono generarsi tensioni tra enti grafici interpretabili vuoi come segno convenzionale vuoi come abbreviazione Ambiguitagrave relative a questi punti opacizzano la descrizione Un problema analogo si porrebbe a priori nella dialettica tra uso delle lettere denotative per designare enti geometrici e loro menzione nella costruzione di un diagramma ma esso egrave risolto con lrsquoazzeramento della seconda funzione le lettere denota-tive sono sempre usate allrsquointerno del testo (sono cioegrave il referente degli oggetti geometrici di cui tratta il discorso matematico) mai menzionate (come accadrebbe se fossero il referente di oggetti grafici posti nel dia-gramma) Insomma il codice adottato per la costituzione dei diagrammi geometrici egrave condiviso (cioegrave canonizzato) semplice e perspicuo mentre quello per le tabelle operazionali non lo egrave da qui le sviste dei copisti e le trascuratezze di correttori ed editori
Infine chi vuole apprendere da questi testi come eseguire una divi-sione a cosa deve prestar fede se ad esempio a causa di errori di copia la descrizione finisce per non coincidere con la tabella operazionale visto che sono entrambe due maniere valide di eseguire lo stesso algoritmo Dopo tutto lo scopo di tutta questa macchina grafico-argomentativa egrave di insegnare a eseguire divisioni in formato tabellare Questo problema si fa particolarmente acuto se la tabella non egrave trasparente nel metodo di Pappo lo egrave quasi completamente in quello anonimo no E gli errori che riscontreremo nella (doppia) tabella ai ff 17r-v del Marc gr 313 a chi sono attribuibili Allrsquoautore al trascrittore o al copista medievale
Questo groviglio di problemi riceve alcune risposte sorprendenti dalla tradizione manoscritta come andiamo finalmente a vedere
4 Analisi delle testimonianze
I codici che ho adibito per lrsquoedizione sono i seguenti M = Marc gr 31346 C = Marc gr 314 (Tolomeo Tetrabiblos et opera minora cum commentariis Vezio Valente Anthologiae)47 Z = Vat gr 2326 (fattizio
46 Riferibile al sec IX ex-X in accolgo la datazione suggeritami per litteras il 522005 da Nigel G Wilson si veda anche Agati 1992 pp 141-142 La presenza non sistematica degli accenti che fa anticipare a Wilson la datazione di laquosaec X medraquo fornita in Mioni 1985 p 24 indusse Boris Fonkič (2005 non vidi) ad assegnare il codice allrsquoinizio del IX secolo
47 Il manoscritto riferibile alla seconda o terza decade della prima metagrave del XIV secolo fu vergato da Michele Clostomalle olim lsquoMetochitesschreiberrsquo Bianconi 2005a pp 428-430 Il titolo dei Prolegomena in questa trascrizione identico in grafia ma non in formulazione a
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 141
e mutilo Tolomeo Almagestum) S = Vat gr 184 (varia astronomica scholia miscellanea ad Almagestum Tolomeo Almagestum) P = Par gr 2390 (varia astronomica) gli ultimi tre riferibili allo scorcio del XIII secolo48 e apografi sicuri del Vat gr 159449 attualmente mutilo di due fascicoli che ci privano dei due terzi finali dei Prolegomena M e il Vat gr 1594 ammettono un modello comune il resto della tradizione (25 trascrizioni in tutto) dipende dagli apografi appena citati del Vat gr 1594 Le varianti della recensione bizantina che leggiamo tra lrsquoaltro nei Vat gr 198 Marc gr 310 (Tolomeo Almagestum cum commentariis Pappi Theonis et Cabasilae) e con ulteriori modifiche Laur Plut 89 sup 48 (varia astronomica Tolomeo Almagestum Barlaam Logistica) sono identificate dal siglum K e si trovano punteggiatura originale in-clusa nel secondo apparato50 Lrsquoanalisi delle testimonianze51 costituite ovviamente anche dalle tabelle associate saragrave condotta nella forma di una sequenza di osservazioni indicizzate da numerali o lettere oltre che di alcune note a piersquo di pagina
Iniziamo dalla descrizione del metodo di divisione anonimo
quello che leggiamo nel Vat gr 1594 (questrsquoultimo coincide con quello adottato nella recen-sione bizantina) fu apposto da Niceforo Gregora e successivamente corretto da Bessarione
48 Sto studiando il primo e il terzo codice in collaborazione rispettivamente con Daniele Bianconi e Inmaculada Peacuterez Martiacuten
49 Su questo codice risalente alla seconda metagrave del IX secolo e sulla sua collocazione nella lsquocollezione filosoficarsquo per prima proposta in Follieri 1977 pp 145-146 si vedano almeno Perria 1991 pp 82-88 Ronconi 2013 Che il titolo dei Prolegomena nel Vat gr 1594 sia stato apposto da Niceforo Gregora egrave stato riconosciuto per la prima volta in Mazzucchi 1994 p 211 n 196 si veda Bianconi 2005a p 418 per altri interventi di Gregora nello stesso manoscritto
50 Il Vat gr 198 egrave stato vergato dal copista Malachia nel corso del terzo quarto del XIV secolo Mondrain 2004 pp 278-290 e 292 Allo stesso copista (denominato non a caso prima dellrsquoidentificazione anonymus Aristotelicus) dobbiamo un buon numero di trascrizioni aristoteliche con i relativi commentari in margine Gli dobbiamo anche il Par gr 2342 secondo tomo di un quadrivium quasi completo di cui il Vat gr 198 egrave il primo nellrsquoordine aritmetica armonica astronomia (Almagesto e commentari relativi) nel codice vaticano geometria ed ancora astronomia (corpus astronomico minore) in quello parigino le opere trascritte sono sempre accompagnate in margine dai relativi commentari Il copista del Marc gr 310 egrave Isacco Argiro (ca 1300-1375) Mondrain 2007 p 166 Allo stesso Argiro dobbiamo il codice laurenziano (Daniele Bianconi per litteras) Poicheacute la recensione modificata che leggiamo nel Laur Plut 89 sup 48 egrave senza alcun dubbio basata su quella nel Marc gr 310 e non viceversa ci troviamo di fronte ad un copista che trascrive due volte lo stesso testo in due versioni leggermente differenti la conclusione naturale egrave che la seconda recensione egrave dovuta ad Argiro stesso la questione andragrave studiata in dettaglio
51 Nei manoscritti citati i Prolegomena si trovano ai fogli seguenti Vat gr 1594 ff 1r-8v (mutilo mancano due fascicoli su tre) Marc gr 313 ff 1r-28r (incompleto man-cano due fogli allrsquoinizio e il f 6 attualmente rimpiazzato da uno bianco) Marc gr 314 ff 235r-255r Vat gr 2326 ff 19r-40v e 43r-v (incompleto e con i fascicoli in disordine) Vat gr 184 ff 10r-23v Par gr 2390 ff 1r-13v Vat gr 198 ff 127r-136v Marc gr 310 ff 1r-13r Laur Plut 89 sup 48 ff 7r-19r
Fabio Acerbi142
ἐκθέμενοι οὖν διάγραμμα τῶν ἀριθμῶν ὡς ὑπόκειται προτάσσομεν τὸν μεριζόμενον καὶ μικρὸν ὑπ᾽ αὐτὸν τὸν μερίζοντα ὡς ἔχει τὸ διάγραμμα ἐν στίχοις διοριζομένοις ὑπὸ γραμμῶν [hellip] καὶ τὰ μὲν γινόμενα ἐγγὺς ἐλάττονα ἐν τῇ μεταξὺ θέσει τοῦ μεριζομένου καὶ τοῦ μερίζοντος ἐν στίχοις παρασημειοῦσθαι πρὸς τὸ ἀσύγχυτον εἶναι τὴν τάξιν τὰ δὲ μεθ᾿ ὧν ὁ μερίζων ἐποίει τοὺς ἀεὶ ἐλάσσονας ὑπὸ τὸν μερίζοντα σημειοῦσθαι προγράφοντας ἐπὶ τοῦ στίχου αὐτῶν τὸ γίνεται οὕτως γι ἐν δὲ τῷ στίχῳ τῶν μεριζόντων τὸ παρὰ ἔχον οὕτως oslash ἀντὶ τοῦ παρ᾿ ἃ δεῖ τὸν μερισμὸν γίνεσθαι ἐν δὲ τῷ στίχῳ τῶν ἐλασσόνων τὸ αφ διὰ τὸ τούτους ἀεὶ ἀφαιρεῖσθαι ἀπὸ τῶν ἐπάνω τῶν μεριζομένων ἐν δὲ τοῖς τοῦ μεριζομένου λοιπάσμασι τοῖς καὶ ἐπιοφείλουσι τὸ λ κατὰ τὸ ἴδιον τῶν διαστάσεων ἑκάστης ndash λέγω δὴ λοιπάδος ndash ἀντὶ τοῦ λοιποὶ οἱ μέλλοντες ἐπιμερίζεσθαι
2 post τὸν suprascr τὸν ἐλάττονα m 2 S 5 πρὸς] MP et ex corr Z κατὰ S om C | ἀσύγχυτον] MSPC -χητον Z 6 ἀεὶ] MZPC ὡσεὶ S 7 γίνεται οὕτως γι ] γι τ οὕτως γι τ M γί οὕτως γί Z γι οὕτως γί SC τὸ γινόμενον οὕτως γίνεται P 8 τὸ παρὰ ἔχον οὕτως] scripsi τὸ παρέχον οὕτως M et π(αρ-) comp Z οὕτως τὸ περιέχον S προγράφοντας οὕτως ex corr m 2 P τὸ περιέχον οὕτως C | oslash] MZSC (sed ο fecit | Z) ἐλάττων comp ex corr m 2 P | παρ᾿ ἃ] scripsi παρα M π(αρα) comp ZSC ex παρα fe-cit παρὰ et τοῦτον suprascr m 2 P 9 γίνεσθαι] comp C | αφ ] αφ ε M ἀφ ZSC ἀφαί P | ἀεὶ] om M 11 ἐπιοφείλουσι] MZSC ex ἐπιο- fecit ἐπο- m 2 P | λ] MZPC λ´ S 12 λοιποὶ] PC λοιποῦ MZS
3 στίχοις] στίχῳ K 5 πρὸς] διὰ K 7 ἐπὶ mdash γι ] τὸ γίνεται διὰ τοιούτου σ(ημείου) γί K 8 τὸ παρὰ ἔχον mdash παρ᾿ ἃ] τὸ παρᾱ διὰ σ(ημείου) τοιούτου καὶ τοῦτο oslash δηλοῦντος τοῦ παρᾱ ὅτι παρὰ τὸν τοιοῦτον (ἀριθμὸν) K 9 αφ διὰ τὸ τούτους] ἀφ δηλοῖ δὲ τοῦτο ἀφαίρεσ(ιν) ὅτι τούτους ἀεὶ δεῖ K 11 ἐπιοφείλουσι] ἐπιμερίζεσθαι ὀφείλουσι K | λ] λ οι` K 12 ἀντὶ τοῦ] δηλοῦντος τοῦ σ(ημείου) τὸ K
lsquoRendendo esplicito un diagramma numerico come lo troviamo qui sotto disponiamo in primo luogo il dividendo e un poco al di sotto di esso il divisore come li ha il diagramma in righe delimitate da linee [hellip] e lsaquooccorreragraversaquo nella posizione tra il dividendo e il divisore annotare lrsquouno accanto allrsquoaltro i piugrave vicini lsaquodei numerirsaquo minori che risultano affincheacute la disposizione non sia confusa quelli con cui il divisore faceva ogni volta i lsaquonumerirsaquo minori annotarli sotto il divisore scrivendo in prima posizione sulla loro riga laquorisultaraquo cosigrave Ris nella riga dei diviso-ri52 invece laquoperraquo fatto cosigrave53 P in luogo di laquoquelli per cui deve farsi la divisioneraquo nella riga dei lsaquonumerirsaquo minori laquosottrraquo in quanto questi sono sempre sottratti dai dividendi che si trovano sopra nei residuli del dividendo (occorre ben farlo anche per loro) laquoReraquo in accordo con ciograve
52 I laquodivisoriraquo sono al plurale ma siamo semplicemente di fronte a un tratto idioma-tico della lingua greca nel caso di espressioni generalizzanti crsquoegrave soltanto un divisore che occupa lrsquounica colonna di cui si compone la sua riga
53 Si intenda ἔχον οὕτως = ita se habens
1
5
10
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 143
che egrave proprio agli scarti di ciascuno ndash intendo qui lsaquociascunrsaquo residuo54 ndash in luogo di laquoresti che vanno a essere divisi ulteriormenteraquorsquo
a) Operatori di citazione e segni convenzionali I segni introdotti sono quattro la mia discussione egrave condotta dando per scontato che essi siano identici a quelli impiegati dallrsquoautore dei Prolegomena anche se si tratta di unrsquoipotesi non corroborabile neacute falsificabile
i Segno per il risultato Lrsquoabbreviazione convenzionale per γίνεται egrave identica al segno introdotto dallrsquoautore e i copisti si dividono tra i due errori possibili scrivere due abbreviazioni o risolverle entrambe Un fenomeno del tutto analogo si riscontra nel Matr 4678 il manoscritto alla base di tutta la tradizione degli Arithmetica di Diofanto al momen-to della definizione dellrsquoἀριθμός (lrsquolsquoincognitarsquo nel nostro linguaggio) ὁ δὲ μηδὲν τούτων τῶν ἰδιωμάτων κτησάμενος ἔχων δὲ ἐν ἑαυτῷ πλῆθος μονάδων ἄλογος ςο` καλεῖται ς` ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον τὸ ς` laquoil lsaquonumerorsaquo che non possiede nessuna di queste proprietagrave ma che ha in seacute una molteplicitagrave indefinita di unitagrave egrave chiamato lsquonumerorsquo e il suo segno egrave ς`raquo Qui solo il terzo dei tre ς ha una barra a sormontare per segnalarne il carattere puramente denotativo (cioegrave di segno convenzionale e non di abbreviazione si veda il punto successivo)55 il primo egrave una delle abbreviazioni piugrave diffuse per ἀριθμός (e infatti egrave dotato del compendio per la desinenza e dellrsquoaccento grave) il secondo egrave una delle piugrave comu-ni per καὶ () Giovanni Cortasmeno autore di capillari annotazioni infra lineam agli Arithmetica nel codice madrileno scioglie il primo ςο`
54 Doppia variatio che impiega al posto di λοιπόν laquorestoraquo i due termini decisamente non canonici τὸ λοίπασμα e ἡ λοιπάς (piugrave oltre leggiamo anche il participio λοιπασθέντα) Una ricerca sul TLG in rete non ha fornito occorrenze del primo si tratta dunque di uno hapax Quanto al secondo che ricorre anche nella sezione sulla divisione lsquoalla Papporsquo lo si rintraccia giagrave nei papiri documentari il termine diventeragrave perograve canonico nelle esposizioni bizantine drsquointroduzione allrsquoAlmagesto ricalcate sul modello dei Prolegomena (si veda la nota 87 infra) Questi due termini designano i resti parziali prodotti nel corso di una divisione lunga li ho tradotti rispettivamente con il neologismo laquoresiduloraquo e con il sostantivo pari-menti non canonico laquoresiduoraquo
55 Il copista interpreta erroneamente il terzo segno come unrsquoabbreviazione e qui ag-giunge un apice inverso (cioegrave un accento grave) altrove lo scioglie direttamente in forme opportune di ἀριθμός Matr 4678 f 58v La frase come la leggiamo nel manoscritto egrave cor-rotta sulla base di una parafrasi in Psello (edita in DOO II p 3710-12) Tannery emendograve ἄλογος in ἀόριστον DOO I p 64-5 et app Il Matritensis vergato da due copisti differenti (cambio di mano a tre righe dalla fine del f 62r) contiene lrsquoIntroductio arithmetica di Nicomaco e le opere diofantee oltre ad alcuni brevi opuscoli musicali la sua data egrave stata recentemente corretta dal XIII al secolo XI pm in Peacuterez Martiacuten 2006 (una riproduzione digitale del manoscritto si trova allrsquoindirizzo httpbdhbneesbnesearchbibliotecaDio-fanto20de20AlejandrC3ADa)
Fabio Acerbi144
in ἀριθμός ed aggiunge un altro segno56 sopra il terzo anteponendovi lrsquoindicazione καὶ ἔστιν αὐτοῦ σ(ημεῖον) τόδε Va da seacute che non abbiamo nessuna garanzia che il segno originariamente introdotto da Diofanto coincidesse realmente con unrsquoabbreviazione convenzionale per ἀριθμός Lrsquoevidenza del PMich III 144 (sec II in) suggerisce drsquoaltronde che il Matritensis e con esso tutta la tradizione medievale di Diofanto ripro-duca fedelmente pur accentuandone la sinuositagrave il segno originario
ii Segno per il divisore Un cerchiolino sbarrato da non confondere con il segno per ὁμοῦ che nei manoscritti matematici ha di norma due barre trasversali (cf tav 2a) Non sono riuscito a rintracciarne ulteriori occorrenze in altre opere la forma che esso assume nel Vat gr 2326 e la correzione apportata nel Par gr 2390 lasciano aperta la possibilitagrave per quanto a mio avviso remota che la forma originaria non fosse lon-tana da unrsquoabbreviazione di παρά registrata nei repertori57 Il correttore del Par gr 2390 trasforma in effetti il segno oslash nellrsquoaffine abbreviazione canonica per (forme di) ἐλάσσων laquominoreraquo58 e si incarica diligente-mente di farlo notare ricapitolando i segni nella porzione superiore del margine esterno del f 7v Nello stesso margine egli traccia anche uno lsquoscolio tabellarersquo ed egrave lrsquounico a porre il (proprio) segno dove indicato dalla descrizione (tav 6 Par gr 2390 f 7v) Oltre a ciograve adattando la tabella al margine ristretto lo scoliaste trascrive come colonne affian-cate le due righe dei resti parziali e dei massimi multipli e aggiunge le indicazioni ὁ μεριζόμενος laquodividendoraquo e ὁ μερίζων laquodivisoreraquo ma vi introduce alcune incongruenze di formato il risultato scritto in verti-cale e la linea verticale di sinistra che separa il divisore dal segno che lo dovrebbe precedere direttamente
iii Segno per i massimi multipli Corrisponde alla semplice abbre-viazione per sospensione della forma verbale ἄφελε laquosottrairaquo in questo
56 Si tratta del segno di ampio uso praticamente identico allrsquoabbreviazione canonica per οὖν
57 Si tratta di un pi a forma di gancio sbarrato da uno slash di troncamento Ce-reteli 1904 tav IX item 7 sub ΠΑΡΑ che rinvia al PVindRain 423 cf anche la forma π` nel POxy LXI 4142 edito in Jones 1999 II pp 26-34 In generale nei papiri e nei manoscritti matematici in maiuscola le preposizioni sono abbreviate facendo seguire un lsquoapostroforsquo alla loro prima lettera Α᾽ Υ᾽ ecc Per la seconda fattispecie di supporto libra-rio si veda in particolare il cosiddetto fragmentum mathematicum Bobiense scriptio inferior databile al V-VI secolo del palinsesto Milano Biblioteca Ambrosiana L 99 sup (Isidoro di Siviglia Etymologiae datazione Cavallo 1977 p 100) pp 113-114 che sono stampate in riproduzione apografa conforme in Belger 1881 (la p 114 egrave riprodotta anche nella tav 10 di Acerbi 2010)
58 Se questa era lrsquointenzione si tratta ovviamente di una forzatura il divisore puograve ben essere maggiore del dividendo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 145
caso lo slash di troncamento taglia orizzontalmente il tratto verticale del phi I copisti offrono molteplici varianti apponendo chi uno spirito dolce chi un ε chi un αί accentato a sormontare Tutti questi segni svolgono la funzione di abbreviazioni vere e proprie (e cosigrave doveva essere anche per lrsquoautore si veda il punto 1 di p 153 infra) la forma originale si ottiene a mio avviso incrociando i dati del Marc gr 313 e dei tre apografi del Vat gr 1594 αφ anche se lrsquoassenza dello spirito potrebbe essere semplicemente dovuta alla pratica del copista del codice veneziano di economizzare nei diacritici
iv Segno per i resti Un lambda completato da una barra a sormon-tare o da un apice che rinvia alle abbreviazioni per sospensione di una forma opportuna di λοιπός laquorestoraquo In realtagrave la forma che troviamo nella tabella egrave differente (tav 2b) e coincide con quella offerta quasi unanimemente dai manoscritti nella descrizione e in almeno un caso nella tabella del metodo di divisione attribuito a Pappo (tav 4) un lambda che accoglie al di sotto una legatura omicron-iota () sbarrata da uno slash di troncamento Qualcosa di simile si trova nel PVindob G 19996 (sec I) una specie di lambda maiuscolo molto aperto e dal vertice arrotondato che include un circoletto interpretato dagli editori come segno per περίεστιν o per λοιπόν59 Lo stesso segno si rintraccia ad esempio in un medesimo scolio tabellare di prima mano ad Alma-gestum nel Vat gr 1594 f 93v e nel Marc gr 313 f 135r ma stavolta la forma del lambda egrave molto ben definita
Fin qui i segni Ma il gioco egrave piugrave complesso La descrizione si muo-ve pericolosamente sulla linea di confine non sempre ben definita tra segno convenzionale e abbreviazione il primo ndash e il repertorio grafico matematico-astronomico ne egrave particolarmente fornito60 ndash puograve anche
59 Ho consultato lrsquoedizione Gerstinger ndash Vogel 1932 pp 46 e 48 la porzione rilevante del papiro egrave riprodotta nella tav 11 di Fowler 1999 Si veda ancora ivi pp 253-257 per la trascrizione di questo segmento di testo (con correzioni rispetto alla princeps) e per una messa a punto recente inclusa la proposta di datazione che ho riportato qui sopra Il verso del papiro che contiene una tavola aritmetica del tutto scorrelata dalla tematica del recto egrave edito come PRain Unterricht 151
60 La pratica di ridurre lo spazio occupato da un testo tecnico per mezzo di abbreviazioni e segni convenzionali era molto diffusa nei manoscritti in maiuscola contrariamente a quanto avviene per altri generi letterari vedremo tra breve cosa accade negli Arithmetica di Diofanto ma si leggano in proposito anche le considerazioni di Hei-berg nei prolegomena alla propria edizione dellrsquoAlmagesto in particolare riguardo al ricorso massiccio ad espedienti brachigrafici nel modello del Vat gr 180 POO II pp lxxxiv-xciii civ-cv cxxvii cxxxviii-cxxxix Agli elenchi dettagliati forniti da Heiberg possiamo aggiungere il piccolo prontuario stampato in Hultsch 1876-1878 III 2 pp 126-132 e basato sul testo e sugli scolii alla Collectio di Pappo nel Vat gr 218 (sec X in) Si vedano infine le osservazioni del copista del Par gr 2360 f 120v trascritte da Heiberg in AOO III pp x-xi sulle laquonotazioni tipiche a scopo di tagliar corto nello scrivereraquo impiegate nel pro-
Fabio Acerbi146
derivare dalla seconda (un caso egrave appunto il segno per ἐλάσσων che probabilmente trae origine da una legatura epsilon-lambda) ma poi il rapporto referente-relato si fissa convenzionalmente Quelli definiti nel testo che abbiamo letto sono appunto segni convenzionali non ci sarebbe bisogno di spiegarne forma e funzione se fossero intesi come abbreviazioni assumono nella tabella una funzione denotativa non esplicativa o discorsiva (come accade invece nella tav 1a) Ma come vengono descritti questi segni
I referenti delle descrizioni sono i segni sono introdotti da οὕτως (item i-ii) o in alternativa da un τό con il ruolo di lsquooperatore di citazionersquo (item iii-iv) che corrisponde esattamente alle nostre virgolette In entram-bi i casi gli enti sono menzionati e svolgono una funzione metalinguistica sono collocati materialmente nel testo ma egrave come se si trovassero fuori e la loro descrizione li additasse ndash in effetti i segni convenzionali scritti nel testo sono a loro volta i relata di quelli che si trovano nella tabella
I relata dei segni scritti nel testo sono di due tipi singoli vocaboli (item i-ii) o descrizioni della funzione dei segni per mezzo di clausole sintaticamente complesse (item ii e iv) I singoli vocaboli sono γίνεται e παρά e sono entrambi preceduti dal τό lsquocitazionalersquo in quanto relata di segni convenzionali le forme abbreviate con cui sono tracciati nei manoscritti vanno forzatamente sciolte Bisogna ammettere che la per-spicacia e le risorse grafiche dei copisti ndash di cui tutto si puograve dire fuor che commettano qui degli errori ndash sono messe a dura prova con lrsquointrodurre segni identici ad abbreviazioni o con lrsquoattivare un gioco metalinguistico particolarmente serrato in un contesto meno lsquonaturalersquo di come potreb-be esserlo ad esempio quello di un trattato grammaticale Lrsquoitem iii che presenta direttamente un segno identico ad unrsquoabbreviazione non egrave sorretto da una descrizione ma da una giustificazione in διὰ τό Lrsquoartico-lo τό vi assume una funzione metalinguistica anche se non lsquocitazionalersquo poicheacute al tempo stesso genera un infinito sostantivato e lo singolarizza per questo ho scritto laquosono sottrattiraquo in corsivo nella mia traduzione
prio modello archimedeo (nota 32 supra) egli ne compila anche una breve lista Un elenco antico di laquosegni della geometriaraquo sicuramente redatto per assistere il copista si trova anche al f 3v del ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 vergato da Efrem negli anni 950-960 (tav 8 in Acerbi 2010) Possiamo farci unrsquoidea quantitativa del guadagno di spazio in rapporto ad un testo privo di abbreviazioni e con le parole separate da spazi sulla base del fragmentum mathematicum Bobiense il testo vi egrave disposto a tutta pagina su 36 righe di circa 30 segni ciascuna nelle due pagine in questione figurano 2038 segni con 15 mezze righe occupate dalle due figure Ora nel testo dellrsquoedizione stabilita in Heiberg 1927 pp 87-90 le stesse pagine contano 4455 segni spazi compresi Ne risulta che la dimensione in caratteri di un testo matematico puograve essere ridotta di piugrave della metagrave con lrsquoimpiego di compendi e segni convenzionali
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 147
Negli item ii e iv il segno si collega ad una descrizione nel secondo caso in via esclusiva le descrizioni pertanto rinforzano o sostituiscono lrsquoidentificazione con lrsquoente linguistico denotato Le clausole descrittive sono precedute da ἀντί e dallrsquoarticolo τό con funzione di lsquooperatore di citazionersquo esse sono παρ᾿ ἃ δεῖ τὸν μερισμὸν γίνεσθαι (item ii) e λοιποὶ οἱ μέλλοντες ἐπιμερίζεσθαι (item iv) Nella descrizione della divisione lsquoalla Papporsquo che leggeremo tra breve i segni negli item iii e iv rice-vono lo stesso trattamento degli altri due il loro relatum egrave un singolo vocabolo e non una clausola descrittiva rispettivamente nelle espres-sioni τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε (sul participio ritorneremo nel punto 1 infra) e τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά (la forma del segno notato con λ οι egrave descritta supra nellrsquoitem iv) La descrizione del segno oslash per il divisore merita una discussione piugrave dettagliata In origine si trovava probabilmente scritto Π(ΑΡΑ)ΕΧΟΝ successivamente letto come π(αρ[α])έχον ndash dato che lrsquoabbreviazione per il preverbo egrave identica a quella per la preposizione (che sia Π᾽ o un pi seguito dal segno per ἄρα a sormontare) ndash invece di π(αρὰ) ἔχον I copisti e i correttori si dettero a tutte le possibili contorsioni per restituire un testo dotato di senso leggere appunto una forma verbale con preverbo modificare il preverbo (ma forse il segno per ἄρα era insidiosamente simile ad uno epsilon) correggere il testo rileggiamo lrsquoapparato sub τὸ παρὰ ἔχον οὕτως τὸ παρέχον οὕτως M et π(αρ-) comp Z οὕτως τὸ περιέχον S τὸ περιέχον οὕτως C προγράφοντας οὕτως ex corr m 2 P Nella clausola descrittiva seguente la presenza liminare di παρὰ (che ho corretto in παρ᾿ ἃ nella speranza di restituire una frase che abbia un senso senza intervenire sul testo) innesca un bel corto circuito il Π(ΑΡΑ) che sicuramente figu-rava nellrsquoarchetipo egrave un sintagma complesso una preposizione unrsquoab-breviazione o un segno per unrsquoabbreviazione Se lrsquoeditore si trova in conflitto con la propria inclinazione alla critica conservativa i copisti si rifiutarono di mettere mano ad un testo che doveva stridere anche per loro essendo il compito demandato al ritocco del revisore del Par gr 2390 o alla riscrittura radicale del recensore bizantino Il problema egrave che ci troviamo di fronte ad unrsquoespressione che descrive la funzione dellrsquooggetto denotato non lrsquooggetto stesso ma che lo contiene al suo interno per soprammercato qui il Π(ΑΡΑ) egrave usato per giustificare una menzione a sua volta relatum di un segno
Evidentemente questa maniera di procedere che giagrave aveva attirato interventi da parte di copisti e correttori della recensione di base parve insostenibilmente opaca allrsquoautore della recensione bizantina61 Egli
61 Uno dei manoscritti di questa recensione propone anche una tabella di divisione
Fabio Acerbi148
modifica tutte le descrizioni diluendo lrsquoidiomatismo dellrsquoarticolo lsquocita-zionalersquo con lrsquointroduzione sistematica del verbo δηλόω e di frasi atte a chiarire quale sia il segno denotante e quale il vocabolo (o il segno) denotato Egli introduce allo scopo di rendere esplicita la funzione de-notativa dei segni introdotti il termine σημείου curiosamente in tutte le sue tre occorrenze esso compare a sua volta nella forma dellrsquoabbrevia-zione per sospensione σΗ´ Egli traccia il segno per i massimi multipli ἀφ e quello per i resti λ οι` in modo che non vi siano ambiguitagrave quanto al loro carattere di abbreviazione Si faccia infine attenzione al residuo di barra sul παρᾱ con funzione denotativa (2 occorrenze) contenuto nella descrizione del segno per il divisore sostituita dallrsquoaccento grave nel παρὰ con funzione discorsiva (la differenza egrave nettissima nei manoscritti da me consultati) Questa osservazione ci permette di passare direttamente allrsquoitem seguente
b) Le barre sui numerali e sulle lettere denotative Egrave opportuno discutere questo punto adesso esattamente percheacute di barre siffatte che pure troviamo in tutti i manoscritti i nostri testi non fanno mai menzione si tratta infatti di una pratica condivisa sin dallrsquoantichitagrave La barra identifica una stringa di lettere dellrsquoalfabeto che non svolge una funzione grammaticale o sintattica propria allrsquointerno del discorso Ciograve avviene in particolare e si tratta della fattispecie piugrave frequente se la stringa di lettere non dagrave origine a un vocabolo della lingua greca lette-re denotative e numerali certo ma anche termini provenienti da altri idiomi e contrazioni di parole greche come i nomina sacra62 tali termi-ni possono essere o no preceduti da un articolo lsquocitazionalersquo a seconda dellrsquouso che ne viene fatto allrsquointerno del discorso Ma non si tratta dellrsquounica fattispecie i papiri grammaticali ed i manoscritti piugrave antichi dei trattati dello stesso argomento segnalano gli esempi delle parti del discorso (cioegrave di lsquoverersquo parole greche) per mezzo di barre sormontanti63 La differenza insomma egrave tra menzione e uso (come parte del discorso in atto) di una stringa di caratteri tra il porre le lsquovirgolettersquo e il non porle tra funzione denotativa e non Apparentemente la convenzione si limi-
corredata dei segni opportuni e contrariamente alle indicazioni della descrizione svilup-pata lsquoin verticalersquo ma per motivi misteriosi non completa (tav 7a Laur Plut 89 sup 48 f 13r)
62 Tutto ciograve egrave spiegato con estrema chiarezza giagrave in Traube 1907 pp 45-4763 Si veda il Par gr 2548 codex vetustissimus e testimone unico delle lsquoopere minorirsquo
di Apollonio Discolo il f 106v con le barre ben visibili egrave riprodotto come tav 19 in De Gregorio 2000 (ivi pp 137-138 per la datazione) Per la testimonianza dei papiri grammaticali si veda Wouters 1979 passim essi contengono di norma elenchi di parti del discorso nessuna delle quali egrave preceduta dallrsquoarticolo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 149
tava in questo secondo caso a segnalare con la barra singoli vocaboli le menzioni di frasi o di sintagmi complessi sono di norma identificate dallrsquoarticolo lsquocitazionalersquo Drsquoaltra parte le abbreviazioni convenzionali non rientrano nella casistica percheacute la loro resa grafica che contiene elementi non alfabetici come compendi per desinenze lettere supra li-neam marche di contrazione o sospensione quali slashes o barre sotto-poste o sormontanti eventualmente solo un sottinsieme della stringa di segni alfabetici le esclude automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
Venendo al discorso matematico una barra sormonta senza ecce-zione le lettere denotative64 che sia in papiri o in manoscritti in maiu-scola65 o minuscola ma solo allrsquointerno del testo comrsquoegrave da attendersi nei diagrammi esse la perdono per il semplice motivo che non crsquoegrave alcun testo ambiente un diagramma ha unicamente una funzione denotati-va Drsquoaltra parte le lettere numerali che a volte figurano nei diagrammi della tradizione metrica66 allo scopo di indicare la lunghezza dei seg-menti mantengono la barra in un diagramma il contesto denotativo geometrico egrave prevalente e i numerali vengono percepiti come entitagrave grafiche lsquoesternersquo al discorso Va da seacute a fortiori che le lettere numerali inserite in un testo dovranno essere segnalate da barre che a loro volta non servono nelle tavole67 in quanto queste ultime sono come abbiamo visto un vero e proprio testo che perograve funge da ambiente a quello al-fabetico limitato alle titolazioni e non a caso tracciato in unrsquoopportuna lsquomaiuscola distintivarsquo allo scopo di segnalarne il carattere denotativo e non discorsivo68 Una tabella operazionale egrave invece un paratesto e quindi le barre sulle lettere numerali che rappresentano gli interi sono
64 La notazione per le lettere denotative subigrave unrsquoevoluzione (il cui risultato finale egrave descritto per sommi capi nella nota 3 supra) di cui non mette conto occuparsi qui
65 I papiri di contenuto geometrico (o astronomici ma che presentano argomenti geometrici) sono rari si vedano il PHerc 1061 (sec II aC Demetrio Lacone De geome-tria) e il PFay 9 (sec II ex Elementi I 39 e 41) Gli importanti ostraka OBerl 12002 e 12609 (sec III aC m Elementi XIII) non pongono le barre sopra le lettere denotative Per i manoscritti in maiuscola si veda ad esempio passim nel Par gr 2389 una cui riproduzione digitale egrave consultabile in rete allrsquoindirizzo httpgallicabnffrark12148btv1b8470171d o il fragmentum mathematicum Bobiense
66 Si veda ancora il ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 codex unicus dei Metrica di Erone e contenente una raccolta importante di problemi del corpus metrologico
67 Si vedano come esempio le tavole citate alle note 10 e 14 supra Discorso a parte per il segno di lsquoposto vuotorsquo si veda il punto c che segue
68 Queste regole generali vanno prese cum grano salis si dagrave naturalmente un certo dominio di variabilitagrave legato verosimilmente al grado di cultura grafica del copista nel PMich III 144 i numerali sono quasi tutti senza barra sia nel testo che nelle tabelle ope-razionali
Fabio Acerbi150
necessarie esse mancano invece sui segni convenzionali che ho descrit-to nel punto precedente e fatto rilevante sulle lettere numerali relative agli ordini sessagesimali quando esse siano identificate da uno o piugrave apici la presenza di questo segno grafico non alfabetico69 le esclude ancora una volta automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo Unrsquoultima osservazione che ci saragrave utile nel seacuteguito la descrizio-ne di una stringa di lettere lsquoagrammaticalersquo non puograve prevedere la men-zione della presenza della barra che le pertiene in quanto tale si tratta di una pratica denotativa che egrave possibile formulare soltanto ad un livello di discorso superiore sia a quello dellrsquouso che a quello della menzione70
c) Il segno di lsquoposto vuotorsquo Si noti nella tav 2b la forma ŏ per il segno di lsquoposto vuotorsquo in un ordine sessagesimale coerentemente con la propria notazione il copista del Marc gr 313 lo scioglie talvolta allrsquoin-terno del testo principale come unrsquoabbreviazione per οὐδέν laquonienteraquo Altre convenzioni di scrittura del tratto che accompagna il circoletto e che si badi bene fa parte integrante del segno di lsquoposto vuotorsquo ndash e infatti nelle tavole troviamo sempre il segno completo mentre tutti gli altri numerali sono come abbiamo visto nel punto precedente privi di barra o di apice a causa del fatto che i vari ordini sessagesimali sono univocamente determinati dalle linee di giustificazione ndash un tratto an-golare anteposto (tav 3 Lar Plut 2818 f 136v)71 o una semplice barra a sormontare (tavv 4-9) si produce in questo modo il segno 65926 che sembra essere stata la forma di base72
69 Occorre dunque supporre come testimoniano papiri e manoscritti in maiuscola che la convenzione relativa allrsquouso della barra si sia consolidata ben prima dellrsquointroduzione di segni diacritici quali accenti e spiriti
70 Si veda il punto 2 infra per maggiori dettagli sulla questione delle barre e degli apici e per le indicazioni in merito che leggiamo in Diofanto
71 Come accennato questa tavola dei sottomultipli coincide con quella descritta ed esposta nei Prolegomena Fatto molto rilevante i numerali nella prima non recano neacute barre neacute apici contrariamente a quanto accade a tutte le istanze della seconda nei manoscritti Quella del Laur Plut 2818 preserva a mio avviso la forma originaria come abbiamo visto una tavola non richiede segni aggiuntivi sulle lettere numerali
72 Si vedano come esempio ancora le tavole citate alle note 10 e 14 supra oppure per una rassegna delle forme che il segno assume nei manoscritti piugrave antichi delle Tavole facili Tihon 2011 pp 58-59 e per quelle che assume nei papiri Jones 1999 I pp 61-62 Ovviamente non possiamo leggere il segno 65926 come un omicron con una barra in quanto ο = 70 nella notazione greca e la barra egrave di rigore quando il numerale figuri allrsquointerno di un testo Occorre ammettere che si dagrave origine ad un bel corto circuito notazionale con il concepire un segno con funzione di lsquoposto vuotorsquo ma che lsquosomigliarsquo ad una lettera dellrsquoalfabeto sormontata da una barra cioegrave ad un numerale in piugrave quando il lsquoposto vuotorsquo non corrisponda ad un intero ma ad una specie sessagesimale la presenza della barra a priori indistinguibile da quella che sormonta gli interi introduce unrsquoincongruenza con la notazione a mezzo di apici vista nellrsquoitem precedente
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 151
d) Errori di copia La tabella riprodotta nella tav 2b ha una forma simmetrica ma si tratta di una forzatura il grande rettangolo in basso a destra drsquoaltronde assente nella descrizione contiene uno scolio che fa notare come lrsquoultimo resto parziale ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ͵γτνζ´´´´´ κζ´´´´´´ cioegrave 0 0 0 0 0 3357 27 siano ἔγγιστα λ´λ´ δ´δ´ ξ laquocon ottima approssimazione 60 minuti quartiraquo dove si notino gli apici semplici per indicare il pas-saggio allrsquoordinale e il raddoppiamento del sistema segno + apice per significare il plurale Lo scolio debitamente accompagnato dal segno di rimando in forma di simbolo solare egrave stato probabilmente incluso nella tabella proprio allo scopo di renderla simmetrica A sua volta un errore precedente spiega lo spazio eccessivo accordato al rettangolo contenente lo scolio il secondo massimo multiplo ŏ λβ´ ξδ´´ ριβ´´´ σιϛ´´´´ egrave trascritto anche al di sotto del risultato
Passiamo ora alla descrizione del metodo di divisione attribuito a Pappo
ἵνα οὖν ταῦτα συναχθῇ τὰ ἐκ τοῦ μερισμοῦ ὁ εἰρημένος Πάππος εὐδιατύπῳ τινὶ καὶ πρὸς τοῦτο τάξει χρησάμενος ποιεῖται τὴν τῆς συλλήψεως τοῦ ζητουμένου ἀνεύρεσιν οὕτως ἐκθέμενος γὰρ τὸν μέλλοντα μερίζεσθαι τουτέστι τὰς τξ μοίρας ἐν ἀρχῇ ἀφαιρεῖ ἀπ᾽ αὐτῶν τὸν ἐν τῇ σελίδι τυγχάνοντα ἐλάττονα τουτέστι τὸν τδ κβ´ κ´´ ὄντα τῶν ἐγγὺς ἐλασσόνων ὡς πρὸς τοὺς ἐκκειμένους διὸ καὶ γράφει αὐτὸν προγράφων αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε καὶ εὑρίσκων τὰ παρακείμενα αὐτῷ τῷ ἀπογραφέντι ἐν τῷ σελιδίῳ λεπτὰ πρῶτα ν´ συναπογράφεται παρατιθῶν αὐτοῖς τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον ἀνατείνουσαν σημαῖνον τὸ εἶδος ὅτι πρῶτα λεπτά εὑρίσκει οὖν οὕτως τὸ τῶν τξ μέρος τὸ τδ κβ´ κ´´ ὃ μεριζόμενον παρὰ τὰς τξε ιδ´ μη´´ ἡμέρας καὶ ποιοῦν τὸν ἐκ τοῦ μερισμοῦ ἀριθμὸν πρῶτα λεπτὰ ν´ καὶ τὸν λοιπὸν ἀπογραφόμενος τὸν νε λζ´ μ´´ προτάσσει αὐτοῦ τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά τάσσει δὲ καὶ ἁπλῆν τινα διατείνουσαν γραμμὴν ὡς ἀπὸ τοῦ τξ ἐπὶ τὸν ἑξῆς ἐκτεθειμένον ἐγγὺς
1
5
10
1 εὐδιατύπῳ] ZSPC εὐδιατύπωτ M 4 ἀφαιρεῖ] MZSP ἀφ ι C 5 ἐλάττονα] P comp MZSC 6 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | αφ ] αφ ε M ἀφ ZS ἀφαί P ἄφ C | ἀντὶ] om C | ἄφελε] MZSP ἄφ C 8 ἀπογραφέντι] MZSP ἐγγραφέντι C | λεπτὰ πρῶτα] P λε πρωτα SC λεπτῶν πρωτ MZ | παρατιθῶν] MZS παρατιθεὶς C et ex corr m 2 P 9 ᾱ] Z αο P α´ MS α C | ἔχον] MPC ἔχων ZS 9-10 πρῶτα λεπτά] ZP πρωτ λ´λ´ M πρωτα λε S αα λε C 11 ἡμέρας] comp codd | ἀριθμὸν] P et comp MZ καὶ C et comp S 12 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M πρωτ λεπτ(α) Z πρωτ λ εᾱ S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C | ἀπογραφόμενος] MZSP ἐγγραφόμενος C | νε λζ´] MZSP λζ νζ C 13 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | λ οι] MZSC ex λ fecit λ οι P | προσσημαῖνον] MC et προσ- comp ZS προση- P | τὸ] MZC τὰ S et fecit m 2 P 14 ἀπὸ] MZSP πρὸς C ἐλάττονα] P comp MZSC
1 εὐδιατύπῳ] εὐδιατυπώτω K 6-7 αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ] τὸ ἀφ K 8 παρατιθῶν mdash 10 λεπτά] τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ σημαίνουσαν τὸ εἶδος αὐτῶν ὅτι ᾱ λεπτά εἰσιν K | τὸ (sec)] τὰ K 12 πρῶτα] πρώτων K | τε λ ] λ οι` K | προσσημαῖνον mdash
Fabio Acerbi152
ἐλάττονα τὸν τδ κβ´ κ´´ ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις καὶ ταύτην ἐπιδεικνύουσαν τὴν τάξιν τῆς προόδου τῆς ἐκθέσεως ἧστινος κλωμένης γραμμῆς πρὸς τῷ ἐγγὺς ἐλάσσονι ἡ ἀντανάκλασις ἐπὶ τὸν λοιπὸν γέγραπται φερομένη ὡς εἴρηται διὰ τὸ εὔτακτον τῆς προκοπῆς οὕτως τε ποιήσας ἑξῆς τὸ αφ ποιῶν ὃ προσσημαίνει ὡς εἴρηται τὸ ὅτι δεῖ ἀφελεῖν ὁμοίως ἀπὸ τοῦ λοιποῦ καὶ δὴ τὸν ἐγγὺς πάλιν ἐλάσσονα ὡς πρὸς τὴν ἐν τῷ σελιδίῳ ἔκθεσιν εὑρισκόμενον λαμβάνων ἑξῆς προγράφει αὐτὸν ὄντα νδ μζ´ ιγ´´ ιβ´´´ καὶ εὑρίσκει αὐτοῖς παρακείμενα ἐν τῷ σελιδίῳ πρῶτα λεπτὰ θ´ ἅτινα καὶ αὐτὰ προσαπογράφεται σὺν τῇ παρασημειώσει τῶν πρώτων γράφων τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον τὴν ἀνατείνουσαν καὶ ὡς εἴρηται τὴν γραμμὴν πάλιν διὰ τὴν τάξιν κλωμένην κατὰ δευτέραν κλάσιν προσέλκει γινομένου τοῦ μέρους αὐτῆς τούτου παραλλήλου τῷ ἐξ ἀρχῆς
16 ante κλωμένης add ἐπὶ C 18 τε] MZP om SC | αφ ] M ἀφ ZSC ἀφαί P 19 προσσημαίνει] MS προση- ZC et ex corr P | ὅτι] ZP comp MSC 20 δὴ] MZSC διὰ fecit m 2 P 21 πρὸς] MSP et supra lineam C ex ἀπὸ fecit m 2 Z | ιγ´´] MZSP νγ´´ C 22 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M ᾱᾱ λεπτὰ Z άάα λε S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C 23 προσαπο- γράφεται] απο suprascr in comp M 24 ᾱ] ZP α´ MS α C 25 κλάσιν] MP τάξιν ZSC | τοῦ] ZSPC τούτου M 26 τούτου] τοῦ bis ZSPC sed prius erasit m 2 P τοῦ M
mdash 18 προκοπῆς] om K | τε ποιήσας] ποιήσας καὶ K | αφ ] ἀφ K 19 τὸ] om K 21 προ-γράφει] γράφει K 22 σελιδίῳ] α´ σελιδίῳ K | ἅτινα] ἃ K 23 προσαπογράφεται] ἀπογράφεται K | τῶν πρώτων mdash 26 ἐξ ἀρχῆς] om K
lsquoAllo scopo di raccogliere ciograve che risulta dalla divisione il detto Pappo utilizzando anche in questo caso una certa disposizione ben strutturata determina nel modo seguente il lsaquonumerorsaquo cercato preso nel suo insieme collocando73 in testa il lsaquonumerorsaquo che sta per essere diviso cioegrave i 360 gradi iniziali sottrae loro tra i piugrave prossimi dei lsaquonumerirsaquo minori rispetto a quelli esposti quello che si trova essere minore nella colonna (cioegrave 304 22 20) Questo egrave il motivo per cui lo trascrive scrivendogli davanti lrsquoabbreviazio-ne laquosottrraquo per laquosottrairaquo e trovando che 50 minuti primi sono collocati accanto a quello stesso lsaquonumerorsaquo che egrave stato trascritto nella colonna li trascrive al tempo stesso collocando accanto74 ad essi la lettera A con un lsaquotrattorsaquo75 sopra che significa la specie minuti primi Trova dunque in que-sto modo la parte di 360 che egrave 304 22 20 la quale divisa per 365 giorni 14 48 fa il numero lsaquoche risultarsaquo dalla divisione 50 minuti primi Trascrivendo
73 La descrizione egrave strutturata come una procedura Acerbi 201274 Il purismo del correttore del Par gr 2390 di Clostomalle nel Marc gr 314 e
dellrsquoautore della recensione bizantina impone loro di modificare la terminazione ma forme tematiche e contratte di τιθεῖν sono correnti nel greco tardivo
75 Il testo greco ha solo il participio con γραμμήν sottinteso Per il significato del participio si veda il punto 2
15
20
25
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 153
poi il resto 55 37 40 gli pone altresigrave76 a prefisso laquoReraquo che significa laquorestiraquo e dispone anche una certa linea semplice77 che va da 360 al piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori che egrave esposto di seacuteguito 304 22 20 come nello lsaquoschemarsaquo esposto linea che mostra lrsquoordine del percorso dellrsquoesposizione Questa linea spezzata lagrave dove si trova il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori egrave tracciata inflessa allrsquoindietro lsaquoersaquo punta verso il resto come egrave stato detto in vista di una progressione ordinata E cosigrave facendo prendendo di seacuteguito il laquosottrraquo che significa come egrave stato detto laquoche occorre similmente sottrarre dal re-storaquo e ovviamente prendendo di nuovo il lsaquonumerorsaquo che egrave trovato essere il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori in relazione alla disposizione nella colonna ndash 54 47 13 12 ndash lo scrive di seacuteguito e trova che 9 minuti primi sono posti loro accanto nella colonna trascrive78 anche questi con la segnaletica dei primi scrivendo la lettera A con un lsaquotrattorsaquo sopra e come egrave stato detto prolunga di nuovo la linea spezzata in vista di una buona disposizione tramite una seconda inflessione essendo questa sua parte parallela a quella inizialersquo
La descrizione continua con una serie di laquoe cosigrave viaraquo e non fa ulte-riore riferimento alla tabella
1) La forma verbale ἐξεσμένον Egrave il neutro del participio perfetto medio-passivo di ξέω lett laquopialloraquo laquolevigoraquo Si danno tre possibilitagrave si tratta di un termine canonico per quanto non altrove attestato per designare unrsquoabbreviazione oppure lrsquoautore anonimo improvvisa sul piano metaforico come se unrsquoabbreviazione non fosse altro che la paro-la completa lsquoaccorciata a colpi di piallarsquo in maniera opportuna oppure il testo egrave corrotto e srsquoimpone una correzione ad esempio τὸ ἑξῆς μένον laquociograve che sta di seacuteguitoraquo Questrsquoultima strada mi pare chiusa dal senso delle frase lrsquoabbreviazione non lsquosta di seacuteguitorsquo a niente ma anzi precede la perifrasi τὸ ἑξῆς μένον se impiegata semplicemente per rimandare al segno αφ immediatamente seguente costituirebbe un intollerabile solecismo Se accettiamo la prima di queste letture considerando quin-di lrsquoabbreviazione αφ in posizione predicativa abbiamo a che fare con
76 Rendo in questo modo il τε isolato77 La linea egrave laquosempliceraquo in quanto egrave una retta la precisazione intende evidenziare per
anticipazione il carattere lsquonon semplicersquo che essa assumeragrave alla prima inflessione quando diventeragrave una spezzata linee siffatte erano in effetti concepite dallrsquoanonimo e prima di lui da tutta la tradizione matematica greca come una singola linea spezzata nei punti drsquoinfles-sione I due segmenti paralleli menzionati al termine del passo sono orizzontali
78 Il verbo egrave al medio in variatio rispetto ai due che precedono e che seguono egrave il matematico che lsquosirsquo trascrive le cifre
Fabio Acerbi154
uno hapax semantico nella grecitagrave superstite come egrave facile verificare con una ricerca sul TLG in rete La recensione bizantina risolve il pro-blema sopprimendo semplicemente τὸ ἐξεσμένον
2) La notazione per le specie numeriche Nella terminologia matema-tica greca gli ordini sessagesimali sono εἴδη laquospecieraquo numerici essi corri- spondono agli ordini di grandezza nel nostro sistema decimale e indica-no in analogia con il caso geometrico la lsquoformarsquo che assume un numero quadrato cubo ecc Centinaia e migliaia sono quindi degli εἴδη rispet-tivamente quadrati (100 egrave il quadrato di 10) e cubi (1000 egrave il cubo di 10) sono specie numeriche ma non numeri particolari e drsquoaltronde 300 non egrave un quadrato ma 3 item dellrsquoεἶδος lsquoquadratorsquo 100 3 egrave il numerale di molteplicitagrave della specie quadrata lsquocentinaiarsquo i due 0 che seguono il 3 segnalano esattamente questo fatto che la notazione greca per gli interi non posizionale fa scomparire al livello denotativo Ciograve non vale soltan-to per i numeri interi ma anche per le loro parti i minuti secondi appar-tengono alla specie lsquoquadratorsquo in quanto 13600 egrave il quadrato di 160
La concezione appare interamente dispiegata nellrsquointroduzione degli Arithmetica diofantei79 che si rivela giova farlo rimarcare un te-stimone fondamentale per la ricostruzione della notazione matematica antica Alle specie usate in questrsquoopera vengono assegnati una denomi-nazione ed un segno convenzionale costituito dallrsquoiniziale (di ognuno dei componenti) della denominazione al quadrato o δύναμις il segno ΔΥ al κύβος il segno ΚΥ alla lsquoquarta potenzarsquo o δυναμοδύναμις il segno ΔΥΔ ecc La descrizione di tali segni egrave del tipo καὶ ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον Κ ἐπίσημον ἔχον Υ ΚΥ κύβος laquoe il suo segno egrave un Κ che ha come indice un Υ ΚΥ cuboraquo dove in accordo con quanto abbiamo visto nel punto b supra e pur nel comprensibile imbarazzo del copista della prima parte del Matritensis (o di un suo passato collega) a districarsi in questo formidabile ginepraio notazionale80 le due lettere Κ e Υ ricevono una barra mentre ΚΥ non la richiede a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον il quale ancora una volta esclude automaticamente il segno dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
79 In particolare a DOO I pp 214-62180 Nel Matr 4678 riscontriamo i seguenti fenomeni nelle poche righe a cavallo dei ff
58r-v 1) accento acuto posto su tutti i segni come se fossero abbreviazioni 2) ripetizione sistematica segnodenominazione come in ΚΥ κύβος appena letto dovuta sicuramente allrsquointrusione di glosse interlineari esplicative dei segni ndash e successivo pentimento (δύναμις e κύβος sono in effetti cancellati dalla prima mano il primo con un tratto il secondo con dei punti supra lineam poi il copista si stanca di correggere) 3) nella descrizione del segno per la δυναμοδύναμις menzione di un δέλτα δύο che saragrave molto probabilmente stato ΔΔ subito dopo nella descrizione del κυβόκυβος si legge un incongruo δύο KK
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 155
Diofanto introduce poi dei segni anche per le specie delle parti dellrsquounitagrave (le nostre frazioni) che egli chiama ὁμώνυμα μορία laquoparti omonimeraquo di cui quelle sessagesimali sono casi particolari81 Egli spie-ga appunto che le loro denominazioni sono ottenute da quelle delle specie degli interi per sinonimia passando ad un lsquoordinalersquo82 formato semplicemente aggiungendo il suffisso -στον δυναμοστόν κυβοστόν δυναμοδυναμοστόν ecc (sott μόριον) I loro segni convenzionali sono invece ottenuti da quelli per le specie degli interi aggiungendo una γραμμὴν διαστέλλουσαν τὸ εἶδος laquolinea che distingue la specieraquo83 Una linea sui segni delle specie delle parti egrave richiesta si badi bene per distinguerli dai segni di quelle degli interi come giagrave osservato questi ultimi sono giagrave lsquoagrammaticalirsquo a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον a fortiori lo saranno anche i primi Si tratta della traduzione semio-tica del passaggio dal cardinale allrsquoordinale che a livello grammaticale egrave effettuato con il suffisso -στον Che forma ha questa linea Barra o apice (Egrave cervellotico pensare a forme piugrave complesse) La domanda non ammette una risposta immediata in quanto delle specie diofantee nessuno piugrave si occupa nellrsquoantichitagrave84 Se egrave vero che la prima risposta darebbe origine ad un conflitto tra due convenzioni denotative diffe-renti la barra lsquocitazionalersquo e la barra che distingue la specie lrsquoevidenza grafica del Matritensis lascia lievemente sgomenti (ricordiamoci che giagrave i segni di base sono indebitamente dotati di un accento dal copista) Le poche occorrenze del segno per le specie delle parti85 vedono lrsquoaggiunta di uno slash di sospensione di un doppio apice inverso ndash in tutta evi-
81 Questo fatto era giagrave chiaro nellrsquoantichitagrave Teone in Alm I 10 in iA p 45310-1682 Il parallelo con i cardinali e gli ordinali relativi agli interi egrave reso esplicito da Dio-
fanto ὥσπερ δὲ τῶν ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια παρομοίως καλεῖται τοῖς ἀριθμοῖς τοῦ μὲν τρία τὸ τρίτον τοῦ δὲ τέσσαρα τὸ τέταρτον οὕτως καὶ τῶν νῦν ἐπονομασθέντων ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια κληθήσεται παρομοίως τοῖς ἀριθμοῖς laquocome le parti omonime dei numeri sono chia-mate per assonanza con i numeri di lsquotrersquo lsquolsaquounrsaquo terzorsquo di lsquoquattrorsquo lsquolsaquounrsaquo quartorsquo cosigrave le parti omonime dei numeri appena nominati saranno chiamate per assonanza con i numeriraquo (DOO I p 69-13 si noti lrsquoarticolo lsquocitazionalersquo al singolare in τοῦ τρία e τοῦ τέσσαρα) Il parallelo prosegue anche al livello dei segni che rappresentano queste specie come vedremo tra un attimo
83 Diofanto Arithmetica prefazione in DOO I p 620-21 un passaggio maltrattato in questa edizione occorre espungere il participio ἔχον senza introdurre segni ulteriori oppure eliminare un precedente ἐπί come fa un correttore del Matritensis f 58v
84 Unica parzialissima eccezione lrsquoaccenno di Teone menzionato nella nota 81 supra85 Al f 59r e per di piugrave nel margine per sanare un lungo saut du mecircme au mecircme La
collocazione in margine egrave il motivo per cui troviamo una notazione abbreviata nel resto del trattato il primo copista scioglie tutti i segni prendendoli per abbreviazioni mentre il secondo elimina sistematicamente il tratto aggiuntivo delle specie delle parti dellrsquounitagrave Drsquoaltronde egli scrive ad esempio ΔΥ invece di ΔΥ ed egrave quindi indotto a porre la barra al di sopra della stringa di lettere risultante (passim ma si veda ad esempio il f 72r)
Fabio Acerbi156
denza il compendio per la desinenza -ον accentata il copista interpreta il segno come unrsquoabbreviazione ndash e di una barra a sormontare lo Υ Potremmo forse interpretarlo come il segno di contrazione del grafema -στ- lrsquounico tassello mancante in unrsquoabbreviazione come ad esempio (δυναμοδυναμο)(στ)(ὸν) ma uno scolio di prima mano al f 58v rela-tivo alle specie degli interi inficia questrsquoipotesi esse sono dotate di slash di sospensione accento acuto in un caso del compendio canonico per la terminazione -ον hellip ma tutti gli Υ a esponente sono a loro volta sormontati da una barra
Meno legata al singolo manoscritto ma nondimeno non uniforme si presenta la pratica di notazione dei segni che rappresentano gli enti numerici sessagesimali86 da una parte sta lrsquoevidenza del testo dei Pro-legomena e delle sue tabelle apici ndash drsquoaltronde come abbiamo visto la notazione universalmente impiegata per i numerali ordinali e per le fra-zioni unitarie ndash dallrsquoaltra sta lrsquoevidenza del testo dellrsquoAlmagesto in tutti i manoscritti piugrave antichi e lo stesso si dica del commentario teonino a questrsquoopera o del suo lsquoGrande commentariorsquo alle Tavole facili e dei testi astronomici su papiro barre87 Sembra insomma che la nostra docu-
86 Sia le molteplicitagrave che le specie ahimeacute entrambe rappresentate da lettere dellrsquoalfabeto Come osservato allrsquoinizio della sezione 3 ci sono in effetti due tipi di lettere numerali in gioco se facciamo astrazione da apici o barre lsquo4 minuti secondirsquo si trova scritto δ β la prima lettera numerale denota la molteplicitagrave degli item di una certa specie la se-conda la specie nei Prolegomena entrambe sono accompagnate da un doppio apice il che rende inutile la presenza delle seconde Si noti che la descrizione della tabella non fa parola della notazione da usare per le lettere numerali che denotano la molteplicitagrave barre o apici e quanti apici hellip In questo caso fa interamente fede la tabella cioegrave la pratica grafica condivisa instauratasi non egrave chiaro quando
87 I manoscritti piugrave antichi dellrsquoAlmagesto sono menzionati nella nota 10 supra quelli dei due commentarii teonini sono il Laur Plut 2818 e il celeberrimo Vat gr 190 (sec IX in Euclide Elementi Data Teone lsquoGrande commentariorsquo) per la notazione dei pa-piri astronomici si veda Jones 1999 II passim La notazione non sembra lsquoinquinatarsquo dalla pratica dei copisti bizantini e pare dipendere soltanto dalla data di composizione Tro-viamo ad esempio barre sopra tutti i numerali di molteplicitagrave (interi o sessagesimali) nel frammento di un commentario alle Tavole facili contenente un calcolo relativo al 24 aprile 213 (Par gr 2841 sec XIII ex-XIV in oltre al frammento ai ff 32r l 11-34v l 23 contiene Arato Phaenomena ed Efestione Apotelesmatica edizione in Jones 1990) Nel commentario alle Tavole facili composto ca 610-617 ed attribuito a Stefano di Alessandria la situazione egrave la seguente (Jean Lempire per litteras per lrsquoedizione si veda Lempire 2014 ho controllato il Vat gr 304 ff 135r-171v sec XIV am contiene in aggiunta Teone in Almagestum I-II lsquoPiccolo commentariorsquo alle Tavole facili Diofanto Arithmetica e De polygo-nis numeris varia astronomica tabulae) barre sopra gli interi sporadicamente rimpiazzate da apici apici sopra le parti sessagesimali in numero uguale alla denominazione doppio () apice per le frazioni unitarie Sono impiegate barre sopra gli interi e apici sopra le parti sessagesimali nei manoscritti principali di tutti i trattati di introduzione allrsquoAlmagesto o comunque di argomento logistico redatti in epoca bizantina Giorgio Pachimere (1242-ca 1310) Quadrivium (autografo nel manoscritto Roma Biblioteca Angelica gr 38 [RGK III nr 115] si veda Tannery ndash Steacutephanou 1940 per lrsquoedizione) Teodoro Metochita (1270-
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 157
mentazione si faccia testimone di un cambio notazionale avvenuto nel periodo intercorrente fra Teone (sec IV pm) e la scuola alessandrina di Ammonio e dei suoi allievi (sec VI in) e probabilmente innescato da questrsquoultimo ambiente lrsquoaspetto paradossale egrave che nello stesso codice si rintraccino due notazioni differenti per gli enti numerici sessagesimali e lrsquouna (apici) sia adottata sistematicamente e coerentemente in uno scritto (i Prolegomena) che si presenta esattamente come unrsquointroduzione tecnica alla pratica numerico-algoritmica del trattato (lrsquoAlmagesto) in cui egrave adottata lrsquoaltra (barre che ritroviamo senza eccezioni anche negli scolii)
Torniamo ai Prolegomena la descrizione del segno da porre a fianco di ogni singolo quoziente parziale e denotante la sua specie numerica (minuti primi minuti secondi ecc) solleva tre problemi
Primo problema Ci vuole una barra o un apice su τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquola lettera A [hellip] che significa la specieraquo quando lo scriviamo nella tabella Tutta la nostra discussione precedente fa pro-pendere per lrsquoapice e si ricordi anche la forma verbale ἀνατείνουσαν che suggerisce qualcosa che si lsquoestende verso lrsquoaltorsquo (la mia traduzione egrave volutamente neutra) se fosse apposta una barra la cosa dovrebbe passare
1231332) Compendium astronomicum (copia lsquoautorizzatarsquo coeva nei Vat gr 182 e 181 da parte del copista che integrograve le parti mancanti del Par gr 2389 [ff 207-210 255-270 374-375] Bianconi 2005a pp 425-427 Peacuterez Martiacuten 2008 p 436 e n 177) Teodoro Meliteniota (morto lrsquo831393) Tribiblos astronomica (autografo nel Vat gr 792 si vedano Leurquin 1991 per unrsquoanalisi del manoscritto Leurquin 1990 per lrsquoedizione) una com-pilazione anonima (per cui ho consultato il Par gr 2396 ff 87r-92v limitatamente a questi fogli manu Costantino Trivoli [RGK II nr 318 ma ovviamente questo codice non vi egrave segnalato] terzo quarto del XV secolo il resto del codice annotato da Niceforo Gregora egrave di etagrave planudea e parzialmente [ff 33v-76v] un autografo di Planude stesso contiene Teone in Almagestum I II IV Mondrain 2002 il codice va completato ndash limitatamente a stralci dei libri VIII-X XII-XIII del commentario teonino la cui parte intermedia si egrave persa ndash con 26 carte [ff 123-147] inserite nel Vat gr 1087 anchrsquoesso contenente anno-tazioni di Gregora Rome 1927 per la figura del copista dei ff 77r-86r del Par gr 2396 e dei ff appena nominati del Vat gr 1087 un anonimo collaboratore di Gregora si veda in ultimo Bianconi 2006a pp 147-151) si veda anche il calcolo effettuato da Niceforo Gre-gora (12921295-13581361) dellrsquoeclisse di sole del 16 luglio 1330 (attestata unicamente ai ff 1r-8v della miscellanea astronomica Marc gr 325 databile ca 1324-1329 in parte vergata e ovunque fittamente annotata da Gregora stesso edizione del testo in Mogenet et al 1983 annotazioni di Gregora elencate in Bianconi 2005a p 413) Unrsquoeccezione apparente il lsquoPiccolo commentariorsquo di Teone alle Tavole facili le parti sessagesimali sono segnalate da apici (ad esempio nel Vat gr 175 vergato da Giovanni Catrario e completato nel 1321-1322 sulla figura di Catrario si vedano in ultimo Bianconi 2005b pp 141-156 e 2006b) lrsquoopera egrave antica ma la sua tradizione non rimonta oltre la fine del XIII secolo a parte un frammento nel Leiden BPG 78 ff 156r-161v (minuscola del IX-X secolo) e in effetti in questo manoscritto tutti i numerali di molteplicitagrave sono sormontati da barre Unrsquoeccezione effettiva egrave il De hypotesibus planetarum nel Vat gr 1594 barre sugli interi e apici sulle parti sessagesimali
Fabio Acerbi158
sotto silenzio e la presenza dellrsquoapice la rende inutile88 Si tratta della stessa convenzione diofantea e coincide ancora con la notazione per i numerali ordinali e per le frazioni unitarie che egrave corrente nei mano- scritti matematici greci per questo motivo non percheacute la descrizione sia particolarmente perspicua nessuno dei copisti della recensione an-tica ha incertezze apici Ma questi apici si rintracciano soltanto sulle indicazioni di specie non contemplate dalla descrizione che sono ante-poste ai resti parziali a fianco dei quozienti parziali i segni di specie sono invece trasformati in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordi-nali corrispondenti del tipo πρωτ tavv 5 e 7b-8 Il recensore bizantino taglia invece la testa al toro elimina dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali elimina la seconda menzione della laquolet-tera Araquo contestualmente allrsquoazzeramento dellrsquoespediente della linea a zig-zag (si veda il punto seguente) modifica la descrizione che contiene la prima menzione in quella dellrsquoapice associato direttamente ai nume-rali di molteplicitagrave riciclando addirittura lrsquoalpha per adibirlo a desi-gnare un numero cardinale (come sorprendersi) τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ laquoponendo al di sopra di essi [scil dei 50 minuti primi] 1 solo lsaquoaccentorsaquo acutoraquo La scelta del recensore egrave assennata che rechi una barra o un apice in una tabella un alpha denota un numero non un numero drsquoordine
Secondo problema da tenere ben distinto dal precedente Cosa ci vuole sul segno α per la lettera alpha menzionata nella frase τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquolettera A [hellip] che significa la specieraquo89 Unrsquooc-chiata allrsquoapparato critico rivela una bella incertezza nei manoscritti Z scrive sempre ᾱ e in un caso lo fa anche P MS optano sempre per α´ C per α P scrive nellrsquoaltro caso αο Per quanto solo la barra sia congrua con il senso della frase in quanto la lettera alpha egrave qui menzionata (si tratta di un oggetto che compare nella tabella) e non cambia niente se essa egrave accompagnata dal suo nome di genere στοιχεῖον ad un livello grafico lrsquoincertezza fra il segno ᾱ che denota laquola lettera αraquo e il segno α´ (o lrsquoabbreviazione αο) per una forma di πρῶτος egrave per piugrave versi giustificata
88 Detto in altri termini la barra egrave uno strumento grafico non matematico e quindi la sua presenza non va segnalata mentre un apice lo egrave e la sua presenza lo deve
89 Notare che in questa frase il primo α non vuole la barra (egrave menzionato allrsquointerno di una frase che impiega convenzioni moderne) il secondo sigrave (idem ma con convenzioni antiche) ndash e nella traduzione la scelta di denotarlo con A (senza virgolette) e non con lsquoArsquo (con virgolette) egrave del tutto arbitraria ndash si noti inoltre che le necessarie precisazioni laquosenzacon virgoletteraquo mostrano che le lingue moderne palesano difficoltagrave analoghe a quelle del greco antico per quanto riguarda i livelli denotativi in ambito metadiscorsivo per non usare le due parentetiche avrei dovuto scrivere rispettivamente lsquoArsquo e lsquolsquoArsquorsquo (doppie virgolette semplici)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 159
ᾱ coincide con il numerale 1 α egrave la prima lettera dellrsquoalfabeto ed inoltre α´ egrave esattamente quello che va scritto nella tabella Potremmo dirci che il sostantivo στοιχεῖον chiude la questione la sua presenza congiunta ad un ipotetico α´ renderebbe la descrizione ridondante o inappropriata90 Ma a parte il fatto che α egrave proprio τὸ πρῶτον στοιχεῖον il segno α´ cat-tura in fondo il cuore della descrizione di uno στοιχεῖον ἔχον lsaquoγραμμὴνrsaquo ἀνατείνουσαν
Terzo problema Lrsquoautore dei Prolegomena che si arresta allrsquoesem-pio dei minuti primi non dice quanti apici occorre mettere sulle lettere numerali che identificano gli ordini superiori al primo se uno soltanto come nel caso diofanteo e delle frazioni unitarie o in numero uguale alla loro denominazione (cioegrave pari al numero denotato dal numerale stesso su cui vanno posti) come effettivamente avviene nei mano-scritti dei Prolegomena La tabella egrave quindi sottodeterminata dalla sua descrizione anzi in un certo senso prende il sopravvento su di essa la pratica di marcare i numerali di molteplicitagrave con gli apici che compe-tono allrsquoordine cui appartengono viene trasferita ai segni per gli ordini stessi per supplire ad una descrizione carente di questi ultimi E la tabella egrave sottodeterminata dalla descrizione in quanto egrave la descrizione di una tabella reale ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις laquocome nello lsaquoschemarsaquo espostoraquo leggiamo a un certo punto del testo
3) La linea a zig-zag Non possiamo che applaudire a questo geniale espediente grafico lo troviamo messo in opera solo nel Marc gr 313 Per quanto lrsquoautore non faccia parola di ciograve nel corso della sua descrizione la linea spezzata egrave intesa dover lsquosaltarersquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue Il copista del codice marciano effettua correttamente due salti nella prima delle sue tabelle (tav 4) ma inserisce un lsquodentersquo in piugrave in quella che considera corretta (tav 5) La linea a zig-zag egrave incompatibile con la presenza di linee di giustificazione nella tabella che in effetti mancano nel Marc gr 313 ciograve induce gli errori di allineamento dei primi 5 quozienti parziali di cui egrave vittima il copista Probabilmente per questo motivo in nessuno degli apografi del Vat gr 1594 la linea a zig-zag figura nella tabella inquadrata come si conviene da una (doppia) cornice esterna e le cui colonne sono appunto separate da linee verticali (tav 7b Vat gr 184 f 17v e tav 8 Par gr 2390 f 9v cui egrave sostanzialmente identica la tabella del Marc gr 314 che si trova
90 Trascuro lrsquoabbreviazione αο = πρῶτος percheacute la desinenza non egrave quella richiesta neacute nella frase (egrave richiesto πρῶτον) neacute nella tabella (πρῶτα)
Fabio Acerbi160
al f 248r ndash ma la mancanza di linee orizzontali causa un gigantesco pa-sticcio nel codice vaticano) Alla recensione bizantina che dipende per il suo testo di base dal Vat gr 1594 e quindi non trova la linea a zig-zag nella tabella non resta che sopprimere la sua descrizione ndash ma proprio per questo motivo e finalmente diventa possibile tracciare un apparato completo di linee di giustificazione (tav 9 Laur Plut 89 sup 48 f 14v) Dato che la descrizione di Teone di questo procedimento di divi-sione non fa cenno allrsquoesistenza della linea a zig-zag viene da chiedersi se essa non costituisca un espediente escogitato dallrsquoautore dei Prolegomena per vivacizzare la procedura originale di Pappo
4) Discrepanze tra descrizione e tabella Il gioco delle minime va-rianti mostra che la divisione era stata eseguita (e trasmessa) corret-tamente tutti i valori numerici sono esatti La tabella nel Marc gr 313 presenta perograve alcune discrepanze con la propria descrizione Essa omette (ma non nella versione lsquoscorrettarsquo lrsquoomissione non si riscontra neanche nel Par gr 2390) il segno per laquorestoraquo di fronte ai resti par-ziali ma aggiunge lrsquoindicazione della loro specie Essa trasforma invece come abbiamo visto le indicazioni di specie che seguono i quozienti parziali in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordinali corri-spondenti La descrizione prevede di chiudere la tabella con il risultato καὶ συνάγων ἅπαντα τὰ ἐκ τῶν μερισθέντων μερῶν λεπτὰ σημειοῦται ὑπὸ πάντας οὕτως γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoe raccogliendo tutti i minuti che provengono dalle parti divise lsaquoPapporsaquo nota sotto tutto cosigrave Ris 0 59 8 17 13 12 31raquo ma sotto la tabella tutta la tradizione ci consegna qualcosa di piugrave articolato ὁ ζητούμενος καθ᾽ ὃν μερίζεται ὁ τξε ιδ´ μη´´ π(αρὰ) τὸν τξ γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoil lsaquonumerorsaquo cercato secondo cui 365 14 48 egrave diviso per 360 risulta 0 59 8 17 13 12 31raquo frase che del resto contiene due errori lrsquoinversione del dividendo e del divisore e la confusione tra segno convenzionale (iuxta descrizione) e abbreviazione (come nella frase) nel caso di γι Oltre ad eliminare la linea a zig-zag91 la recensione bizantina sopprime dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali e modifica come abbiamo visto al punto 2 le loro descrizioni in quelle di apici associati diretta-mente ai numerali di molteplicitagrave
91 Le due righe che nella recensione di base contengono solo i resti parziali minori di 160 del divisore ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue sono in parte completate con lrsquoindicazione abbreviata ἀνάλ(υσις) laquoanalisiraquo il termine greco per questa procedura di riduzione In un sussulto di ipercorrettismo matematico tali resti parziali ridotti non sono preceduti dal segno per laquorestoraquo come nel Par gr 2390 ma da quello per laquorisultatoraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 161
Gli esempi che abbiamo discusso mostrano come i problemi di notazione pesino e non poco sullrsquoespressione discorsiva di un algorit-mo matematico lrsquoente di riferimento per lsquoformularersquo il procedimento di divisione fu considerata la tabella cioegrave un oggetto la cui costitu-zione egrave legata piugrave ad una pratica grafica che a considerazioni logico- algoritmiche non la sua descrizione che in effetti finisce per determi-nare la tabella in maniera non univoca Di questa sottodeterminazione si fa testimone la traiettoria che abbiamo cercato di seguire nelle mani di copisti e revisori il procedimento di divisione si modifica a volte in aspetti secondari a volte in punti piugrave sostanziali ndash fino a rendere neces-saria una radicale revisione della sua descrizione per renderla conforme alla tabella ndash in ogni caso mai per ragioni squisitamente matematiche92
Abstract
The article presents and discusses in detail two passages from the anonymous Prolegomena to the Almagest a VIth century primer to the elementary procedures of calculation needed in Ptolemyrsquos Almagest In the two passages we may follow the complex interplay between mathematical notation the auctor who employed and described it the tachygrapher who transcribed it in vivo copyists who reproduced it correctors who modified it Along this path misgivings and errors arise in the transmission of abbreviations and paratextual units such as diagrams tables operational schemes
Fabio AcerbiCNRS UMR8560 Centre Alexandre Koyreacute
fabacerbigmailcom
92 Sono grato a Daniele Bianconi Lucio del Corso Jean Lempire per alcune preziose indicazioni
AOO = Archimedis opera omnia cum commentariis Eutocii ed J L Heiberg I-III Lipsiae 1910-1915
DOO = Diophanti Alexandrini opera omnia cum Graecis commentariis ed P Tannery I-II Lipsiae 1893-1895
GC = Le laquoGrand Commentaireraquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Mogenet ndash A Tihon I-III Cittagrave del Vaticano 1985-1999
iA = Commentaires de Pappus et de Theacuteon drsquoAlexandrie sur lrsquoAlmageste ed A Rome I-III con paginazione continua Cittagrave del Vaticano 1931-1943
HOO = Heronis Alexandrini opera quae supersunt omnia ed G Schmidt ndash L Nix ndash W Schmidt ndash H Schoene ndash J L Heiberg I-V Lipsiae 1899-1914
PC = Le ldquoPetit Commentairerdquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed A Tihon Cittagrave del Vaticano 1978
POO = Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia ed J L Heiberg I-II in 3 parti Lipsiae 1898-1907
RGK = Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600 I Handschriften aus Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln II Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs und Nachtraumlge zu den Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln III Handschriften aus Bibliotheken Roms mit dem Vatikan A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg unter Mitarbeit von D Harlfinger und P Eleuteri B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln Wien 1981-1997 (Oumlsterreichische Akademie der Wissenschaften Veroumlffentlichungen der Kommission fuumlr Byzantinistik III1-3 A-C)
Sigla
Acerbi 2010 = F Acerbi Il silenzio delle sirene La matematica greca antica Roma 2010
Acerbi 2012 = F Acerbi I codici stilistici della matematica greca dimostrazioni procedure algoritmi laquoQUCCraquo 1012 (2012) pp 167-214
Acerbi et al 2010 = F Acerbi ndash N Vinel ndash B Vitrac Les Proleacutegomegravenes agrave lrsquoAlmageste Une eacutedition agrave partir des manuscrits les plus anciens Introduction geacuteneacuterale ndash Parties I-III laquoSCIAMVSraquo 11 (2010) pp 53-210
Agati 1992 = M L Agati La minuscola laquoBouleteacuteeraquo Cittagrave del Vaticano 1992
Belger 1881 = C Belger Ein neues Fragmentum mathematicum Bobiense laquoHermesraquo 16 (1881) pp 261-284
Bianconi 2005a = D Bianconi La biblioteca di Cora tra Massimo Planude e Niceforo Gregora Una questione di mani laquoSampTraquo 3 (2005) pp 391-438
Bianconi 2005b = D Bianconi Tessalonica nellrsquoetagrave dei Paleologi Le pratiche intellettuali nel riflesso della cultura scritta Paris 2005
Bianconi 2006a = D Bianconi Le pietre e il ponte ovvero identificazioni di mani e storia della cultura laquoBizantinisticaraquo 8 (2006) pp 135-181
Bianconi 2006b = D Bianconi Qualcosa di nuovo su Giovanni Catrario laquoMEGraquo 6 (2006) pp 69-91
Cavallo 1977 = G Cavallo Funzione e strutture della maiuscola greca tra i secoli VIII-XI in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Colloque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 95-137
Cereteli 1904 = G F Cereteli De compendiis scripturae codicum Graecorum praecipue Petropolitanorum et Mosquensium anni nota instructorum Sankt-Petersburg 1904
De Gregorio 2000 = G De Gregorio Materiali vecchi e nuovi per uno studio della minu-scola greca fra VII e IX secolo in G Prato (a cura di) I manoscritti greci tra riflessione e dibattito Atti del V Colloquio Internazionale di Paleografia Greca Cremona 4-10 ottobre 1998 Firenze 2000 pp 83-151
Follieri 1977 = E Follieri La minuscola libraria dei secoli IX e X in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Col-loque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 139-165
Fonkič 2005 = B Fonkič Venecianskaia rukopisrsquo laquoAlrsquomagestaraquo Ptolemeja (Marc gr 313690) o datirovke i proischoždenii kodeksa laquoVDIraquo s III 254 (2005) pp 162-167
Fowler 1999 = D H Fowler The Mathematics of Platorsquos Academy A New Reconstruction Second Edition Oxford 1999
Bibliografia
Fabio Acerbi164
Gerstinger ndash Vogel 1932 = H Gerstinger ndash K Vogel Eine stereometrische Aufgaben-sammlung im Papyrus Graecus [sic] Vindobonensis 19996 laquoMitteilungen aus der Papy-russammlung der Nationalbibliothek in Wienraquo Neue Serie Folge 1 Griechische literarische Papyri 1 Wien 1932 pp 11-76
Heiberg 1927 = Mathematici Graeci Minores ed J L Heiberg Kjoslashbenhavn 1927
Hultsch 1876-1878 = Pappi Alexandrini Collectionis quae supersunt ed F Hultsch I-III Berlin 1876-1878
Janz 2003 = T Janz The Scribes and the Date of the Vat gr 1291 in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae X Cittagrave del Vaticano 2003 pp 159-180
Jones 1990 = Ptolemyrsquos First Commentator ed A Jones Philadelphia 1990
Jones 1999 = Astronomical Papyri from Oxyrhynchus ed A Jones I-II Philadelphia 1999
Jones 2005 = A Jones Ptolemyrsquos Canobic Inscription and Heliodorusrsquo Observation Reports laquoSCIAMVSraquo 6 (2005) pp 53-97
Lempire 2014 = Steacutephanos drsquoAlexandrie Le commentaire aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Lempire Louvain 2014
Leurquin 1990 = Theacuteodore Meacuteliteacuteniote Tribiblos astronomique Livre I ed R Leurquin Amsterdam 1990
Leurquin 1991 = R Leurquin Un manuscrit autographe de la Tribiblos Astronomique de Theacuteodore Meacuteliteacuteniote le Vaticanus graecus 792 laquoScriptoriumraquo 45 (1991) pp 145-162
Maas 1927 = P Maas Griechische Palaeographie in A Gercke ndash E Norden (hrsg von) Einleitung in die Altertumswissenschaft I9 Leipzig 1927 pp 69-80
Martinelli Tempesta 2010 = S Martinelli Tempesta Il codice Milano Biblioteca Am-brosiana B 75 sup (gr 104) e lrsquoevoluzione della scrittura di Giovanni Scutariota in A B Garciacutea ndash I Peacuterez Martiacuten (ed by) The Legacy of Bernard de Montfaucon Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting Proceedings of the Seventh Inter-national Colloquium of Greek Palaeography Madrid-Salamanca 15-20 September 2008 Turnhout 2010 pp 171-186
Mazzucchi 1994 = C M Mazzucchi Leggere i classici durante la catastrofe (Costantino-poli maggio-agosto 1203) le note marginali al Diodoro Siculo Vaticano gr 130 Parte prima stratigrafia laquoAevumraquo 68 (1994) pp 164-218
Mioni 1976 = E Mioni Bessarione scriba e alcuni suoi collaboratori in Miscellanea marcia-na di studi bessarionei Padova 1976 pp 263-323
Mioni 1985 = Codices graeci manuscripti Bibliothecae Divi Marci Venetiarum II Thesaurus Antiquus Codices 300-625 recensuit E Mioni Roma 1985
Mogenet 1962 = J Mogenet Une scholie ineacutedite du Vat gr 1594 sur les rapports entre lrsquoastronomie arabe et Byzance laquoOsirisraquo 14 (1962) pp 198-221
Mogenet et al 1983 = Niceacutephore Greacutegoras Calcul de lrsquoeacuteclipse de soleil du 16 juillet 1330 ed J Mogenet ndash A Tihon ndash R Royez ndash A Berg Amsterdam 1983
Mondrain 2002 = B Mondrain Maxime Planude Niceacutephore Greacutegoras et Ptoleacutemeacutee laquoPa-laeoslavicaraquo 10 (2002) pp 312-322
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 165
Mondrain 2004 = B Mondrain Lrsquoancien empereur Jean VI Cantacuzegravene et ses copistes in A Rigo (a cura di) Gregorio Palamas e oltre Studi e documenti sulle controversie teologiche del XIV secolo bizantino Firenze 2004 pp 249-296
Mondrain 2007 = B Mondrain Les eacutecritures dans les manuscrits byzantins du XIV e siegravecle Quelques probleacutematiques laquoRSBNraquo n s 44 (2007) pp 157-196
Peacuterez Martiacuten 2006 = I Peacuterez Martiacuten Maxime Planude et le Diophantus Matritensis (Madrid Biblioteca Nacional ms 4678) un paradigme de la reacutecupeacuteration des textes anciens dans la ldquorenaissance paleacuteologuerdquo laquoByzantionraquo 76 (2006) pp 433-462
Peacuterez Martiacuten 2008 = I Peacuterez Martiacuten El lsquoestilo Hodegosrsquo y su proyeccioacuten en las escrituras constantinopolitanas laquoSampTraquo 6 (2008) pp 389-458
Perria 1991 = L Perria Scrittura e ornamentazione nei codici della laquocollezione filosoficaraquo laquoRSBNraquo n s 28 (1991) pp 45-111
Rollo 2012 = A Rollo LrsquoArchimede di Giorgio Valla in V Fera ndash D Gionta ndash A Rollo (a cura di) Archimede e le sue fortune Atti del Convegno di Siracusa-Messina 24-26 giugno 2008 Messina 2012 pp 99-147
Rome 1927 = A Rome Membra disjecta laquoRBenraquo 39 (1927) pp 187-188
Rome 1938 = A Rome Un manuscrit de la bibliothegraveque de Boniface VIII agrave la Meacutediceacuteenne de Florence laquoACraquo 7 (1938) pp 261-268
Ronconi 2013 = F Ronconi La collection philosophique un fantocircme historique laquoScripto-riumraquo 67 (2013) pp 119-140
Tannery ndash Steacutephanou 1940 = Quadrivium de Georges Pachymegravere ed P Tannery ndash E Steacutephanou Cittagrave del Vaticano 1940
Tihon 2011 = Πτολεμαίου Πρόχειροι Κανόνες Les Tables faciles de Ptoleacutemeacutee vol Ia Tables A1-A2 ed A Tihon Leuven 2011
Traube 1907 = L Traube Nomina Sacra Versuch einer Geschichte der christlichen Kuumlrzung Muumlnchen 1907
Vogel 1936 = K Vogel Beitraumlge zur griechischen Logistik laquoSBAWraquo Mathematisch-natur-wissenschaftliche Abteilung Jahrgang 1936 pp 357-472
Wouters 1979 = A Wouters The Grammatical Papyri from Graeco-Roman Egypt Contri-butions to the Study of the lsquoArs Grammaticarsquo in Antiquity Brussel 1979
F ACERBI Tav 1
b Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 65r
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 284 f 160r
F ACERBITav 2
b Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 13r
a Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 19v
F ACERBI Tav 3
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 136v
F ACERBITav 4
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17r
F ACERBI Tav 5
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17v
F ACERBITav 6
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 7v
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
Fabio Acerbi138
troviamo nei Prolegomena ma non offre alcuna descrizione della disposi-zione tabellare della divisione stessa neacute vi fa riferimento
A questa procedura sono in effetti associate una tavola e una tabel-la costruite come segue (tavv 4 e 5 Marc gr 313 ff 17r e 17v il co-pista era ndash giustamente ndash insoddisfatto della prima versione) La tavola le cui righe e colonne sono delimitate da linee contiene sottomultipli44 del divisore 365 14 48 9 righe che riportano i valori da 160 a 960 piugrave altre 6 con i valori per decine da 1060 a 6060 la prima colonna elenca le 15 parti sessagesimali omettendo come drsquoabitudine la laquodenomina-zioneraquo dellrsquoordine (i numerali elencati sono quindi α β γ δ ε ϛ ζ η θ ι κ λ μ ν ξ) la seconda i sottomultipli corrispondenti organizzati su quattro colonne per tener conto dei tre ordini sessagesimali (il primo sottomultiplo egrave quindi ϛ ε´ ιδ´´ μη´´´ cioegrave 160 di τξε ιδ´ μη´´) La tabella priva di linee delimitanti espone la vera divisione Nella prima colonna troviamo i resti parziali ognuno preceduto dallrsquoindicazione del proprio ordine sessagesimale e da un segno per laquorestoraquo Nella seconda preceduti da un segno per laquosottrairaquo i sottraendi ognuno coincide ovviamente con uno dei sottomultipli nella tavola La terza colonna contiene se-guiti dallrsquoindicazione del proprio ordine sessagesimale i quozienti par-ziali ottenuti trascrivendo dalla prima riga della tavola il numerale corrispondente al sottraendo affiancato ed assegnando come ordine sessagesimale il successivo a quello posto in testa di riga Il risultato preceduto da un segno per laquorisultaraquo e posto al di sotto della tabella si ottiene sommando i quozienti parziali il procedimento non permette in generale di determinare lrsquointero quoziente parziale relativo ad un ordine sessagesimale fissato se non dopo due passi Una linea spezzata unisce i resti parziali successivi e i relativi sottraendi per evidenziare la laquoprogressione della proceduraraquo la spezzata lsquosaltarsquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore (le cui righe sono per il resto vuote) e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue di conseguenza anche il quoziente parziale relativo a questo resto appartiene allrsquoordine sessagesimale successivo
A questo punto possiamo rivolgerci alle tavv 4-5 e verificare se le immagini che ci siamo formati sulla base della mia descrizione corri-spondono a quelle che troviamo nel Marc gr 313 Non si tratta di un giochetto sterile egrave al contrario il cuore di un intrico di problemi Un primo ordine di problemi deriva dal fatto che nei Prolegomena lrsquoalgo-
44 Sottomultipli e non multipli in quanto il divisore egrave maggiore del dividendo Drsquoaltronde nel sistema sessagesimale come in quello decimale un sottomultiplo si ottiene dal multiplo corrispondente semplicemente scalando tutte le cifre di un posto (ad esempio 1360 di 365 14 48 si ottiene in questa maniera da 13 volte 365 14 48)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 139
ritmo della divisione lsquoalla Papporsquo non egrave mai eseguito (cioegrave formulato verbalmente) in maniera indipendente dalla descrizione della tabella Comrsquoegrave dunque possibile descrivere una tabella operazionale che non ha uno statuto testuale indipendente sulla base di un algoritmo in corso di esecuzione E drsquoaltro canto come non rilevare unrsquoanomalia in un algoritmo eseguito nella sua forma primaria sotto forma di descrizione di una tabella Ci potremmo chiedere se viene descritto lrsquoalgoritmo o la tabella La tensione fra i due enti grafici egrave acuita dal fatto che nei nostri testi tutto ciograve (esposizione o descrizione di un algoritmo o della tabella associata) avviene sempre e solo sulla base di un esempio numerico para-digmatico Per questo motivo la tabella in quanto struttura (cioegrave privata dei dati numerici accidentali) non puograve fare a meno della descrizione45 Dal canto suo Teone come forse Pappo ancor prima descrive ed espone la tavola dei (sotto)multipli ma non la tabella di divisione lrsquoalgoritmo relativo a questrsquoultima egrave espresso come per controbilanciare in maniera eccezionalmente trasparente e formulare Se ciograve comporta un guada-gno a livello verbale-argomentativo sorge un problema operativo grave come e dove sistemare i resti e i quozienti parziali ndash cioegrave tutti i numeri in output dellrsquoalgoritmo differenti dai (sotto)multipli ndash che la tabella si incarica di disporre in modo lsquonaturalersquo Teone prescrive soltanto di confrontare i resti con la seconda colonna della tavola dei sottomultipli e di trascrivere via via il quoziente ottenuto dopo ogni passo Insomma come eseguire materialmente una divisione Non certo adattando ad un nuovo caso specifico la formulazione dellrsquoalgoritmo che Teone propone
Un secondo ordine di problemi e una trappola micidiale per il co-pista egrave interno alla dialettica lsquotabellarsquolsquosua descrizionersquo ed egrave in assenza di simbolismo quello dei riferimenti linguistici da adottarsi nella seconda agli enti grafici che figurano nella prima Occorre ricercare la massima generalitagrave fornita da una descrizione definita di un ente numerico (ad esempio impiegando il termine laquorestoraquo o la perifrasi laquomassimo sotto-multiplo minoranteraquo) o basta assumere direttamente il suo valore speci-fico come esempio paradigmatico E in che modo risolvere il conflitto tra uso e menzione se come nel nostro caso la tabella contiene segni convenzionali ed occorre fornirne una descrizione Si rende ad esempio necessario introdurre un lsquooperatore di citazionersquo noi useremmo le virgo-lette la lingua greca premette lrsquoarticolo neutro Drsquoaccordo ma nel caso
45 Questa caratteristica non egrave connaturata alla matematica degli algoritmi la risorsa dello lsquostile proceduralersquo serve esattamente ad aggirare questo problema al di lagrave di un certo livello di dettaglio perograve essa condurrebbe ad un appesantimento insostenibile della for-mulazione dovuto alla pluralitagrave dei riferimenti agli oggetti matematici in gioco sulla que-stione dei diversi stili della matematica greca si veda Acerbi 2012
Fabio Acerbi140
greco qual egrave il suo range E come distinguerlo nei casi ambigui da un semplice articolo che precede un sostantivo quando questrsquoultimo lo ri-chieda Nel corso del processo di copia del testo della descrizione infine possono generarsi tensioni tra enti grafici interpretabili vuoi come segno convenzionale vuoi come abbreviazione Ambiguitagrave relative a questi punti opacizzano la descrizione Un problema analogo si porrebbe a priori nella dialettica tra uso delle lettere denotative per designare enti geometrici e loro menzione nella costruzione di un diagramma ma esso egrave risolto con lrsquoazzeramento della seconda funzione le lettere denota-tive sono sempre usate allrsquointerno del testo (sono cioegrave il referente degli oggetti geometrici di cui tratta il discorso matematico) mai menzionate (come accadrebbe se fossero il referente di oggetti grafici posti nel dia-gramma) Insomma il codice adottato per la costituzione dei diagrammi geometrici egrave condiviso (cioegrave canonizzato) semplice e perspicuo mentre quello per le tabelle operazionali non lo egrave da qui le sviste dei copisti e le trascuratezze di correttori ed editori
Infine chi vuole apprendere da questi testi come eseguire una divi-sione a cosa deve prestar fede se ad esempio a causa di errori di copia la descrizione finisce per non coincidere con la tabella operazionale visto che sono entrambe due maniere valide di eseguire lo stesso algoritmo Dopo tutto lo scopo di tutta questa macchina grafico-argomentativa egrave di insegnare a eseguire divisioni in formato tabellare Questo problema si fa particolarmente acuto se la tabella non egrave trasparente nel metodo di Pappo lo egrave quasi completamente in quello anonimo no E gli errori che riscontreremo nella (doppia) tabella ai ff 17r-v del Marc gr 313 a chi sono attribuibili Allrsquoautore al trascrittore o al copista medievale
Questo groviglio di problemi riceve alcune risposte sorprendenti dalla tradizione manoscritta come andiamo finalmente a vedere
4 Analisi delle testimonianze
I codici che ho adibito per lrsquoedizione sono i seguenti M = Marc gr 31346 C = Marc gr 314 (Tolomeo Tetrabiblos et opera minora cum commentariis Vezio Valente Anthologiae)47 Z = Vat gr 2326 (fattizio
46 Riferibile al sec IX ex-X in accolgo la datazione suggeritami per litteras il 522005 da Nigel G Wilson si veda anche Agati 1992 pp 141-142 La presenza non sistematica degli accenti che fa anticipare a Wilson la datazione di laquosaec X medraquo fornita in Mioni 1985 p 24 indusse Boris Fonkič (2005 non vidi) ad assegnare il codice allrsquoinizio del IX secolo
47 Il manoscritto riferibile alla seconda o terza decade della prima metagrave del XIV secolo fu vergato da Michele Clostomalle olim lsquoMetochitesschreiberrsquo Bianconi 2005a pp 428-430 Il titolo dei Prolegomena in questa trascrizione identico in grafia ma non in formulazione a
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 141
e mutilo Tolomeo Almagestum) S = Vat gr 184 (varia astronomica scholia miscellanea ad Almagestum Tolomeo Almagestum) P = Par gr 2390 (varia astronomica) gli ultimi tre riferibili allo scorcio del XIII secolo48 e apografi sicuri del Vat gr 159449 attualmente mutilo di due fascicoli che ci privano dei due terzi finali dei Prolegomena M e il Vat gr 1594 ammettono un modello comune il resto della tradizione (25 trascrizioni in tutto) dipende dagli apografi appena citati del Vat gr 1594 Le varianti della recensione bizantina che leggiamo tra lrsquoaltro nei Vat gr 198 Marc gr 310 (Tolomeo Almagestum cum commentariis Pappi Theonis et Cabasilae) e con ulteriori modifiche Laur Plut 89 sup 48 (varia astronomica Tolomeo Almagestum Barlaam Logistica) sono identificate dal siglum K e si trovano punteggiatura originale in-clusa nel secondo apparato50 Lrsquoanalisi delle testimonianze51 costituite ovviamente anche dalle tabelle associate saragrave condotta nella forma di una sequenza di osservazioni indicizzate da numerali o lettere oltre che di alcune note a piersquo di pagina
Iniziamo dalla descrizione del metodo di divisione anonimo
quello che leggiamo nel Vat gr 1594 (questrsquoultimo coincide con quello adottato nella recen-sione bizantina) fu apposto da Niceforo Gregora e successivamente corretto da Bessarione
48 Sto studiando il primo e il terzo codice in collaborazione rispettivamente con Daniele Bianconi e Inmaculada Peacuterez Martiacuten
49 Su questo codice risalente alla seconda metagrave del IX secolo e sulla sua collocazione nella lsquocollezione filosoficarsquo per prima proposta in Follieri 1977 pp 145-146 si vedano almeno Perria 1991 pp 82-88 Ronconi 2013 Che il titolo dei Prolegomena nel Vat gr 1594 sia stato apposto da Niceforo Gregora egrave stato riconosciuto per la prima volta in Mazzucchi 1994 p 211 n 196 si veda Bianconi 2005a p 418 per altri interventi di Gregora nello stesso manoscritto
50 Il Vat gr 198 egrave stato vergato dal copista Malachia nel corso del terzo quarto del XIV secolo Mondrain 2004 pp 278-290 e 292 Allo stesso copista (denominato non a caso prima dellrsquoidentificazione anonymus Aristotelicus) dobbiamo un buon numero di trascrizioni aristoteliche con i relativi commentari in margine Gli dobbiamo anche il Par gr 2342 secondo tomo di un quadrivium quasi completo di cui il Vat gr 198 egrave il primo nellrsquoordine aritmetica armonica astronomia (Almagesto e commentari relativi) nel codice vaticano geometria ed ancora astronomia (corpus astronomico minore) in quello parigino le opere trascritte sono sempre accompagnate in margine dai relativi commentari Il copista del Marc gr 310 egrave Isacco Argiro (ca 1300-1375) Mondrain 2007 p 166 Allo stesso Argiro dobbiamo il codice laurenziano (Daniele Bianconi per litteras) Poicheacute la recensione modificata che leggiamo nel Laur Plut 89 sup 48 egrave senza alcun dubbio basata su quella nel Marc gr 310 e non viceversa ci troviamo di fronte ad un copista che trascrive due volte lo stesso testo in due versioni leggermente differenti la conclusione naturale egrave che la seconda recensione egrave dovuta ad Argiro stesso la questione andragrave studiata in dettaglio
51 Nei manoscritti citati i Prolegomena si trovano ai fogli seguenti Vat gr 1594 ff 1r-8v (mutilo mancano due fascicoli su tre) Marc gr 313 ff 1r-28r (incompleto man-cano due fogli allrsquoinizio e il f 6 attualmente rimpiazzato da uno bianco) Marc gr 314 ff 235r-255r Vat gr 2326 ff 19r-40v e 43r-v (incompleto e con i fascicoli in disordine) Vat gr 184 ff 10r-23v Par gr 2390 ff 1r-13v Vat gr 198 ff 127r-136v Marc gr 310 ff 1r-13r Laur Plut 89 sup 48 ff 7r-19r
Fabio Acerbi142
ἐκθέμενοι οὖν διάγραμμα τῶν ἀριθμῶν ὡς ὑπόκειται προτάσσομεν τὸν μεριζόμενον καὶ μικρὸν ὑπ᾽ αὐτὸν τὸν μερίζοντα ὡς ἔχει τὸ διάγραμμα ἐν στίχοις διοριζομένοις ὑπὸ γραμμῶν [hellip] καὶ τὰ μὲν γινόμενα ἐγγὺς ἐλάττονα ἐν τῇ μεταξὺ θέσει τοῦ μεριζομένου καὶ τοῦ μερίζοντος ἐν στίχοις παρασημειοῦσθαι πρὸς τὸ ἀσύγχυτον εἶναι τὴν τάξιν τὰ δὲ μεθ᾿ ὧν ὁ μερίζων ἐποίει τοὺς ἀεὶ ἐλάσσονας ὑπὸ τὸν μερίζοντα σημειοῦσθαι προγράφοντας ἐπὶ τοῦ στίχου αὐτῶν τὸ γίνεται οὕτως γι ἐν δὲ τῷ στίχῳ τῶν μεριζόντων τὸ παρὰ ἔχον οὕτως oslash ἀντὶ τοῦ παρ᾿ ἃ δεῖ τὸν μερισμὸν γίνεσθαι ἐν δὲ τῷ στίχῳ τῶν ἐλασσόνων τὸ αφ διὰ τὸ τούτους ἀεὶ ἀφαιρεῖσθαι ἀπὸ τῶν ἐπάνω τῶν μεριζομένων ἐν δὲ τοῖς τοῦ μεριζομένου λοιπάσμασι τοῖς καὶ ἐπιοφείλουσι τὸ λ κατὰ τὸ ἴδιον τῶν διαστάσεων ἑκάστης ndash λέγω δὴ λοιπάδος ndash ἀντὶ τοῦ λοιποὶ οἱ μέλλοντες ἐπιμερίζεσθαι
2 post τὸν suprascr τὸν ἐλάττονα m 2 S 5 πρὸς] MP et ex corr Z κατὰ S om C | ἀσύγχυτον] MSPC -χητον Z 6 ἀεὶ] MZPC ὡσεὶ S 7 γίνεται οὕτως γι ] γι τ οὕτως γι τ M γί οὕτως γί Z γι οὕτως γί SC τὸ γινόμενον οὕτως γίνεται P 8 τὸ παρὰ ἔχον οὕτως] scripsi τὸ παρέχον οὕτως M et π(αρ-) comp Z οὕτως τὸ περιέχον S προγράφοντας οὕτως ex corr m 2 P τὸ περιέχον οὕτως C | oslash] MZSC (sed ο fecit | Z) ἐλάττων comp ex corr m 2 P | παρ᾿ ἃ] scripsi παρα M π(αρα) comp ZSC ex παρα fe-cit παρὰ et τοῦτον suprascr m 2 P 9 γίνεσθαι] comp C | αφ ] αφ ε M ἀφ ZSC ἀφαί P | ἀεὶ] om M 11 ἐπιοφείλουσι] MZSC ex ἐπιο- fecit ἐπο- m 2 P | λ] MZPC λ´ S 12 λοιποὶ] PC λοιποῦ MZS
3 στίχοις] στίχῳ K 5 πρὸς] διὰ K 7 ἐπὶ mdash γι ] τὸ γίνεται διὰ τοιούτου σ(ημείου) γί K 8 τὸ παρὰ ἔχον mdash παρ᾿ ἃ] τὸ παρᾱ διὰ σ(ημείου) τοιούτου καὶ τοῦτο oslash δηλοῦντος τοῦ παρᾱ ὅτι παρὰ τὸν τοιοῦτον (ἀριθμὸν) K 9 αφ διὰ τὸ τούτους] ἀφ δηλοῖ δὲ τοῦτο ἀφαίρεσ(ιν) ὅτι τούτους ἀεὶ δεῖ K 11 ἐπιοφείλουσι] ἐπιμερίζεσθαι ὀφείλουσι K | λ] λ οι` K 12 ἀντὶ τοῦ] δηλοῦντος τοῦ σ(ημείου) τὸ K
lsquoRendendo esplicito un diagramma numerico come lo troviamo qui sotto disponiamo in primo luogo il dividendo e un poco al di sotto di esso il divisore come li ha il diagramma in righe delimitate da linee [hellip] e lsaquooccorreragraversaquo nella posizione tra il dividendo e il divisore annotare lrsquouno accanto allrsquoaltro i piugrave vicini lsaquodei numerirsaquo minori che risultano affincheacute la disposizione non sia confusa quelli con cui il divisore faceva ogni volta i lsaquonumerirsaquo minori annotarli sotto il divisore scrivendo in prima posizione sulla loro riga laquorisultaraquo cosigrave Ris nella riga dei diviso-ri52 invece laquoperraquo fatto cosigrave53 P in luogo di laquoquelli per cui deve farsi la divisioneraquo nella riga dei lsaquonumerirsaquo minori laquosottrraquo in quanto questi sono sempre sottratti dai dividendi che si trovano sopra nei residuli del dividendo (occorre ben farlo anche per loro) laquoReraquo in accordo con ciograve
52 I laquodivisoriraquo sono al plurale ma siamo semplicemente di fronte a un tratto idioma-tico della lingua greca nel caso di espressioni generalizzanti crsquoegrave soltanto un divisore che occupa lrsquounica colonna di cui si compone la sua riga
53 Si intenda ἔχον οὕτως = ita se habens
1
5
10
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 143
che egrave proprio agli scarti di ciascuno ndash intendo qui lsaquociascunrsaquo residuo54 ndash in luogo di laquoresti che vanno a essere divisi ulteriormenteraquorsquo
a) Operatori di citazione e segni convenzionali I segni introdotti sono quattro la mia discussione egrave condotta dando per scontato che essi siano identici a quelli impiegati dallrsquoautore dei Prolegomena anche se si tratta di unrsquoipotesi non corroborabile neacute falsificabile
i Segno per il risultato Lrsquoabbreviazione convenzionale per γίνεται egrave identica al segno introdotto dallrsquoautore e i copisti si dividono tra i due errori possibili scrivere due abbreviazioni o risolverle entrambe Un fenomeno del tutto analogo si riscontra nel Matr 4678 il manoscritto alla base di tutta la tradizione degli Arithmetica di Diofanto al momen-to della definizione dellrsquoἀριθμός (lrsquolsquoincognitarsquo nel nostro linguaggio) ὁ δὲ μηδὲν τούτων τῶν ἰδιωμάτων κτησάμενος ἔχων δὲ ἐν ἑαυτῷ πλῆθος μονάδων ἄλογος ςο` καλεῖται ς` ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον τὸ ς` laquoil lsaquonumerorsaquo che non possiede nessuna di queste proprietagrave ma che ha in seacute una molteplicitagrave indefinita di unitagrave egrave chiamato lsquonumerorsquo e il suo segno egrave ς`raquo Qui solo il terzo dei tre ς ha una barra a sormontare per segnalarne il carattere puramente denotativo (cioegrave di segno convenzionale e non di abbreviazione si veda il punto successivo)55 il primo egrave una delle abbreviazioni piugrave diffuse per ἀριθμός (e infatti egrave dotato del compendio per la desinenza e dellrsquoaccento grave) il secondo egrave una delle piugrave comu-ni per καὶ () Giovanni Cortasmeno autore di capillari annotazioni infra lineam agli Arithmetica nel codice madrileno scioglie il primo ςο`
54 Doppia variatio che impiega al posto di λοιπόν laquorestoraquo i due termini decisamente non canonici τὸ λοίπασμα e ἡ λοιπάς (piugrave oltre leggiamo anche il participio λοιπασθέντα) Una ricerca sul TLG in rete non ha fornito occorrenze del primo si tratta dunque di uno hapax Quanto al secondo che ricorre anche nella sezione sulla divisione lsquoalla Papporsquo lo si rintraccia giagrave nei papiri documentari il termine diventeragrave perograve canonico nelle esposizioni bizantine drsquointroduzione allrsquoAlmagesto ricalcate sul modello dei Prolegomena (si veda la nota 87 infra) Questi due termini designano i resti parziali prodotti nel corso di una divisione lunga li ho tradotti rispettivamente con il neologismo laquoresiduloraquo e con il sostantivo pari-menti non canonico laquoresiduoraquo
55 Il copista interpreta erroneamente il terzo segno come unrsquoabbreviazione e qui ag-giunge un apice inverso (cioegrave un accento grave) altrove lo scioglie direttamente in forme opportune di ἀριθμός Matr 4678 f 58v La frase come la leggiamo nel manoscritto egrave cor-rotta sulla base di una parafrasi in Psello (edita in DOO II p 3710-12) Tannery emendograve ἄλογος in ἀόριστον DOO I p 64-5 et app Il Matritensis vergato da due copisti differenti (cambio di mano a tre righe dalla fine del f 62r) contiene lrsquoIntroductio arithmetica di Nicomaco e le opere diofantee oltre ad alcuni brevi opuscoli musicali la sua data egrave stata recentemente corretta dal XIII al secolo XI pm in Peacuterez Martiacuten 2006 (una riproduzione digitale del manoscritto si trova allrsquoindirizzo httpbdhbneesbnesearchbibliotecaDio-fanto20de20AlejandrC3ADa)
Fabio Acerbi144
in ἀριθμός ed aggiunge un altro segno56 sopra il terzo anteponendovi lrsquoindicazione καὶ ἔστιν αὐτοῦ σ(ημεῖον) τόδε Va da seacute che non abbiamo nessuna garanzia che il segno originariamente introdotto da Diofanto coincidesse realmente con unrsquoabbreviazione convenzionale per ἀριθμός Lrsquoevidenza del PMich III 144 (sec II in) suggerisce drsquoaltronde che il Matritensis e con esso tutta la tradizione medievale di Diofanto ripro-duca fedelmente pur accentuandone la sinuositagrave il segno originario
ii Segno per il divisore Un cerchiolino sbarrato da non confondere con il segno per ὁμοῦ che nei manoscritti matematici ha di norma due barre trasversali (cf tav 2a) Non sono riuscito a rintracciarne ulteriori occorrenze in altre opere la forma che esso assume nel Vat gr 2326 e la correzione apportata nel Par gr 2390 lasciano aperta la possibilitagrave per quanto a mio avviso remota che la forma originaria non fosse lon-tana da unrsquoabbreviazione di παρά registrata nei repertori57 Il correttore del Par gr 2390 trasforma in effetti il segno oslash nellrsquoaffine abbreviazione canonica per (forme di) ἐλάσσων laquominoreraquo58 e si incarica diligente-mente di farlo notare ricapitolando i segni nella porzione superiore del margine esterno del f 7v Nello stesso margine egli traccia anche uno lsquoscolio tabellarersquo ed egrave lrsquounico a porre il (proprio) segno dove indicato dalla descrizione (tav 6 Par gr 2390 f 7v) Oltre a ciograve adattando la tabella al margine ristretto lo scoliaste trascrive come colonne affian-cate le due righe dei resti parziali e dei massimi multipli e aggiunge le indicazioni ὁ μεριζόμενος laquodividendoraquo e ὁ μερίζων laquodivisoreraquo ma vi introduce alcune incongruenze di formato il risultato scritto in verti-cale e la linea verticale di sinistra che separa il divisore dal segno che lo dovrebbe precedere direttamente
iii Segno per i massimi multipli Corrisponde alla semplice abbre-viazione per sospensione della forma verbale ἄφελε laquosottrairaquo in questo
56 Si tratta del segno di ampio uso praticamente identico allrsquoabbreviazione canonica per οὖν
57 Si tratta di un pi a forma di gancio sbarrato da uno slash di troncamento Ce-reteli 1904 tav IX item 7 sub ΠΑΡΑ che rinvia al PVindRain 423 cf anche la forma π` nel POxy LXI 4142 edito in Jones 1999 II pp 26-34 In generale nei papiri e nei manoscritti matematici in maiuscola le preposizioni sono abbreviate facendo seguire un lsquoapostroforsquo alla loro prima lettera Α᾽ Υ᾽ ecc Per la seconda fattispecie di supporto libra-rio si veda in particolare il cosiddetto fragmentum mathematicum Bobiense scriptio inferior databile al V-VI secolo del palinsesto Milano Biblioteca Ambrosiana L 99 sup (Isidoro di Siviglia Etymologiae datazione Cavallo 1977 p 100) pp 113-114 che sono stampate in riproduzione apografa conforme in Belger 1881 (la p 114 egrave riprodotta anche nella tav 10 di Acerbi 2010)
58 Se questa era lrsquointenzione si tratta ovviamente di una forzatura il divisore puograve ben essere maggiore del dividendo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 145
caso lo slash di troncamento taglia orizzontalmente il tratto verticale del phi I copisti offrono molteplici varianti apponendo chi uno spirito dolce chi un ε chi un αί accentato a sormontare Tutti questi segni svolgono la funzione di abbreviazioni vere e proprie (e cosigrave doveva essere anche per lrsquoautore si veda il punto 1 di p 153 infra) la forma originale si ottiene a mio avviso incrociando i dati del Marc gr 313 e dei tre apografi del Vat gr 1594 αφ anche se lrsquoassenza dello spirito potrebbe essere semplicemente dovuta alla pratica del copista del codice veneziano di economizzare nei diacritici
iv Segno per i resti Un lambda completato da una barra a sormon-tare o da un apice che rinvia alle abbreviazioni per sospensione di una forma opportuna di λοιπός laquorestoraquo In realtagrave la forma che troviamo nella tabella egrave differente (tav 2b) e coincide con quella offerta quasi unanimemente dai manoscritti nella descrizione e in almeno un caso nella tabella del metodo di divisione attribuito a Pappo (tav 4) un lambda che accoglie al di sotto una legatura omicron-iota () sbarrata da uno slash di troncamento Qualcosa di simile si trova nel PVindob G 19996 (sec I) una specie di lambda maiuscolo molto aperto e dal vertice arrotondato che include un circoletto interpretato dagli editori come segno per περίεστιν o per λοιπόν59 Lo stesso segno si rintraccia ad esempio in un medesimo scolio tabellare di prima mano ad Alma-gestum nel Vat gr 1594 f 93v e nel Marc gr 313 f 135r ma stavolta la forma del lambda egrave molto ben definita
Fin qui i segni Ma il gioco egrave piugrave complesso La descrizione si muo-ve pericolosamente sulla linea di confine non sempre ben definita tra segno convenzionale e abbreviazione il primo ndash e il repertorio grafico matematico-astronomico ne egrave particolarmente fornito60 ndash puograve anche
59 Ho consultato lrsquoedizione Gerstinger ndash Vogel 1932 pp 46 e 48 la porzione rilevante del papiro egrave riprodotta nella tav 11 di Fowler 1999 Si veda ancora ivi pp 253-257 per la trascrizione di questo segmento di testo (con correzioni rispetto alla princeps) e per una messa a punto recente inclusa la proposta di datazione che ho riportato qui sopra Il verso del papiro che contiene una tavola aritmetica del tutto scorrelata dalla tematica del recto egrave edito come PRain Unterricht 151
60 La pratica di ridurre lo spazio occupato da un testo tecnico per mezzo di abbreviazioni e segni convenzionali era molto diffusa nei manoscritti in maiuscola contrariamente a quanto avviene per altri generi letterari vedremo tra breve cosa accade negli Arithmetica di Diofanto ma si leggano in proposito anche le considerazioni di Hei-berg nei prolegomena alla propria edizione dellrsquoAlmagesto in particolare riguardo al ricorso massiccio ad espedienti brachigrafici nel modello del Vat gr 180 POO II pp lxxxiv-xciii civ-cv cxxvii cxxxviii-cxxxix Agli elenchi dettagliati forniti da Heiberg possiamo aggiungere il piccolo prontuario stampato in Hultsch 1876-1878 III 2 pp 126-132 e basato sul testo e sugli scolii alla Collectio di Pappo nel Vat gr 218 (sec X in) Si vedano infine le osservazioni del copista del Par gr 2360 f 120v trascritte da Heiberg in AOO III pp x-xi sulle laquonotazioni tipiche a scopo di tagliar corto nello scrivereraquo impiegate nel pro-
Fabio Acerbi146
derivare dalla seconda (un caso egrave appunto il segno per ἐλάσσων che probabilmente trae origine da una legatura epsilon-lambda) ma poi il rapporto referente-relato si fissa convenzionalmente Quelli definiti nel testo che abbiamo letto sono appunto segni convenzionali non ci sarebbe bisogno di spiegarne forma e funzione se fossero intesi come abbreviazioni assumono nella tabella una funzione denotativa non esplicativa o discorsiva (come accade invece nella tav 1a) Ma come vengono descritti questi segni
I referenti delle descrizioni sono i segni sono introdotti da οὕτως (item i-ii) o in alternativa da un τό con il ruolo di lsquooperatore di citazionersquo (item iii-iv) che corrisponde esattamente alle nostre virgolette In entram-bi i casi gli enti sono menzionati e svolgono una funzione metalinguistica sono collocati materialmente nel testo ma egrave come se si trovassero fuori e la loro descrizione li additasse ndash in effetti i segni convenzionali scritti nel testo sono a loro volta i relata di quelli che si trovano nella tabella
I relata dei segni scritti nel testo sono di due tipi singoli vocaboli (item i-ii) o descrizioni della funzione dei segni per mezzo di clausole sintaticamente complesse (item ii e iv) I singoli vocaboli sono γίνεται e παρά e sono entrambi preceduti dal τό lsquocitazionalersquo in quanto relata di segni convenzionali le forme abbreviate con cui sono tracciati nei manoscritti vanno forzatamente sciolte Bisogna ammettere che la per-spicacia e le risorse grafiche dei copisti ndash di cui tutto si puograve dire fuor che commettano qui degli errori ndash sono messe a dura prova con lrsquointrodurre segni identici ad abbreviazioni o con lrsquoattivare un gioco metalinguistico particolarmente serrato in un contesto meno lsquonaturalersquo di come potreb-be esserlo ad esempio quello di un trattato grammaticale Lrsquoitem iii che presenta direttamente un segno identico ad unrsquoabbreviazione non egrave sorretto da una descrizione ma da una giustificazione in διὰ τό Lrsquoartico-lo τό vi assume una funzione metalinguistica anche se non lsquocitazionalersquo poicheacute al tempo stesso genera un infinito sostantivato e lo singolarizza per questo ho scritto laquosono sottrattiraquo in corsivo nella mia traduzione
prio modello archimedeo (nota 32 supra) egli ne compila anche una breve lista Un elenco antico di laquosegni della geometriaraquo sicuramente redatto per assistere il copista si trova anche al f 3v del ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 vergato da Efrem negli anni 950-960 (tav 8 in Acerbi 2010) Possiamo farci unrsquoidea quantitativa del guadagno di spazio in rapporto ad un testo privo di abbreviazioni e con le parole separate da spazi sulla base del fragmentum mathematicum Bobiense il testo vi egrave disposto a tutta pagina su 36 righe di circa 30 segni ciascuna nelle due pagine in questione figurano 2038 segni con 15 mezze righe occupate dalle due figure Ora nel testo dellrsquoedizione stabilita in Heiberg 1927 pp 87-90 le stesse pagine contano 4455 segni spazi compresi Ne risulta che la dimensione in caratteri di un testo matematico puograve essere ridotta di piugrave della metagrave con lrsquoimpiego di compendi e segni convenzionali
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 147
Negli item ii e iv il segno si collega ad una descrizione nel secondo caso in via esclusiva le descrizioni pertanto rinforzano o sostituiscono lrsquoidentificazione con lrsquoente linguistico denotato Le clausole descrittive sono precedute da ἀντί e dallrsquoarticolo τό con funzione di lsquooperatore di citazionersquo esse sono παρ᾿ ἃ δεῖ τὸν μερισμὸν γίνεσθαι (item ii) e λοιποὶ οἱ μέλλοντες ἐπιμερίζεσθαι (item iv) Nella descrizione della divisione lsquoalla Papporsquo che leggeremo tra breve i segni negli item iii e iv rice-vono lo stesso trattamento degli altri due il loro relatum egrave un singolo vocabolo e non una clausola descrittiva rispettivamente nelle espres-sioni τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε (sul participio ritorneremo nel punto 1 infra) e τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά (la forma del segno notato con λ οι egrave descritta supra nellrsquoitem iv) La descrizione del segno oslash per il divisore merita una discussione piugrave dettagliata In origine si trovava probabilmente scritto Π(ΑΡΑ)ΕΧΟΝ successivamente letto come π(αρ[α])έχον ndash dato che lrsquoabbreviazione per il preverbo egrave identica a quella per la preposizione (che sia Π᾽ o un pi seguito dal segno per ἄρα a sormontare) ndash invece di π(αρὰ) ἔχον I copisti e i correttori si dettero a tutte le possibili contorsioni per restituire un testo dotato di senso leggere appunto una forma verbale con preverbo modificare il preverbo (ma forse il segno per ἄρα era insidiosamente simile ad uno epsilon) correggere il testo rileggiamo lrsquoapparato sub τὸ παρὰ ἔχον οὕτως τὸ παρέχον οὕτως M et π(αρ-) comp Z οὕτως τὸ περιέχον S τὸ περιέχον οὕτως C προγράφοντας οὕτως ex corr m 2 P Nella clausola descrittiva seguente la presenza liminare di παρὰ (che ho corretto in παρ᾿ ἃ nella speranza di restituire una frase che abbia un senso senza intervenire sul testo) innesca un bel corto circuito il Π(ΑΡΑ) che sicuramente figu-rava nellrsquoarchetipo egrave un sintagma complesso una preposizione unrsquoab-breviazione o un segno per unrsquoabbreviazione Se lrsquoeditore si trova in conflitto con la propria inclinazione alla critica conservativa i copisti si rifiutarono di mettere mano ad un testo che doveva stridere anche per loro essendo il compito demandato al ritocco del revisore del Par gr 2390 o alla riscrittura radicale del recensore bizantino Il problema egrave che ci troviamo di fronte ad unrsquoespressione che descrive la funzione dellrsquooggetto denotato non lrsquooggetto stesso ma che lo contiene al suo interno per soprammercato qui il Π(ΑΡΑ) egrave usato per giustificare una menzione a sua volta relatum di un segno
Evidentemente questa maniera di procedere che giagrave aveva attirato interventi da parte di copisti e correttori della recensione di base parve insostenibilmente opaca allrsquoautore della recensione bizantina61 Egli
61 Uno dei manoscritti di questa recensione propone anche una tabella di divisione
Fabio Acerbi148
modifica tutte le descrizioni diluendo lrsquoidiomatismo dellrsquoarticolo lsquocita-zionalersquo con lrsquointroduzione sistematica del verbo δηλόω e di frasi atte a chiarire quale sia il segno denotante e quale il vocabolo (o il segno) denotato Egli introduce allo scopo di rendere esplicita la funzione de-notativa dei segni introdotti il termine σημείου curiosamente in tutte le sue tre occorrenze esso compare a sua volta nella forma dellrsquoabbrevia-zione per sospensione σΗ´ Egli traccia il segno per i massimi multipli ἀφ e quello per i resti λ οι` in modo che non vi siano ambiguitagrave quanto al loro carattere di abbreviazione Si faccia infine attenzione al residuo di barra sul παρᾱ con funzione denotativa (2 occorrenze) contenuto nella descrizione del segno per il divisore sostituita dallrsquoaccento grave nel παρὰ con funzione discorsiva (la differenza egrave nettissima nei manoscritti da me consultati) Questa osservazione ci permette di passare direttamente allrsquoitem seguente
b) Le barre sui numerali e sulle lettere denotative Egrave opportuno discutere questo punto adesso esattamente percheacute di barre siffatte che pure troviamo in tutti i manoscritti i nostri testi non fanno mai menzione si tratta infatti di una pratica condivisa sin dallrsquoantichitagrave La barra identifica una stringa di lettere dellrsquoalfabeto che non svolge una funzione grammaticale o sintattica propria allrsquointerno del discorso Ciograve avviene in particolare e si tratta della fattispecie piugrave frequente se la stringa di lettere non dagrave origine a un vocabolo della lingua greca lette-re denotative e numerali certo ma anche termini provenienti da altri idiomi e contrazioni di parole greche come i nomina sacra62 tali termi-ni possono essere o no preceduti da un articolo lsquocitazionalersquo a seconda dellrsquouso che ne viene fatto allrsquointerno del discorso Ma non si tratta dellrsquounica fattispecie i papiri grammaticali ed i manoscritti piugrave antichi dei trattati dello stesso argomento segnalano gli esempi delle parti del discorso (cioegrave di lsquoverersquo parole greche) per mezzo di barre sormontanti63 La differenza insomma egrave tra menzione e uso (come parte del discorso in atto) di una stringa di caratteri tra il porre le lsquovirgolettersquo e il non porle tra funzione denotativa e non Apparentemente la convenzione si limi-
corredata dei segni opportuni e contrariamente alle indicazioni della descrizione svilup-pata lsquoin verticalersquo ma per motivi misteriosi non completa (tav 7a Laur Plut 89 sup 48 f 13r)
62 Tutto ciograve egrave spiegato con estrema chiarezza giagrave in Traube 1907 pp 45-4763 Si veda il Par gr 2548 codex vetustissimus e testimone unico delle lsquoopere minorirsquo
di Apollonio Discolo il f 106v con le barre ben visibili egrave riprodotto come tav 19 in De Gregorio 2000 (ivi pp 137-138 per la datazione) Per la testimonianza dei papiri grammaticali si veda Wouters 1979 passim essi contengono di norma elenchi di parti del discorso nessuna delle quali egrave preceduta dallrsquoarticolo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 149
tava in questo secondo caso a segnalare con la barra singoli vocaboli le menzioni di frasi o di sintagmi complessi sono di norma identificate dallrsquoarticolo lsquocitazionalersquo Drsquoaltra parte le abbreviazioni convenzionali non rientrano nella casistica percheacute la loro resa grafica che contiene elementi non alfabetici come compendi per desinenze lettere supra li-neam marche di contrazione o sospensione quali slashes o barre sotto-poste o sormontanti eventualmente solo un sottinsieme della stringa di segni alfabetici le esclude automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
Venendo al discorso matematico una barra sormonta senza ecce-zione le lettere denotative64 che sia in papiri o in manoscritti in maiu-scola65 o minuscola ma solo allrsquointerno del testo comrsquoegrave da attendersi nei diagrammi esse la perdono per il semplice motivo che non crsquoegrave alcun testo ambiente un diagramma ha unicamente una funzione denotati-va Drsquoaltra parte le lettere numerali che a volte figurano nei diagrammi della tradizione metrica66 allo scopo di indicare la lunghezza dei seg-menti mantengono la barra in un diagramma il contesto denotativo geometrico egrave prevalente e i numerali vengono percepiti come entitagrave grafiche lsquoesternersquo al discorso Va da seacute a fortiori che le lettere numerali inserite in un testo dovranno essere segnalate da barre che a loro volta non servono nelle tavole67 in quanto queste ultime sono come abbiamo visto un vero e proprio testo che perograve funge da ambiente a quello al-fabetico limitato alle titolazioni e non a caso tracciato in unrsquoopportuna lsquomaiuscola distintivarsquo allo scopo di segnalarne il carattere denotativo e non discorsivo68 Una tabella operazionale egrave invece un paratesto e quindi le barre sulle lettere numerali che rappresentano gli interi sono
64 La notazione per le lettere denotative subigrave unrsquoevoluzione (il cui risultato finale egrave descritto per sommi capi nella nota 3 supra) di cui non mette conto occuparsi qui
65 I papiri di contenuto geometrico (o astronomici ma che presentano argomenti geometrici) sono rari si vedano il PHerc 1061 (sec II aC Demetrio Lacone De geome-tria) e il PFay 9 (sec II ex Elementi I 39 e 41) Gli importanti ostraka OBerl 12002 e 12609 (sec III aC m Elementi XIII) non pongono le barre sopra le lettere denotative Per i manoscritti in maiuscola si veda ad esempio passim nel Par gr 2389 una cui riproduzione digitale egrave consultabile in rete allrsquoindirizzo httpgallicabnffrark12148btv1b8470171d o il fragmentum mathematicum Bobiense
66 Si veda ancora il ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 codex unicus dei Metrica di Erone e contenente una raccolta importante di problemi del corpus metrologico
67 Si vedano come esempio le tavole citate alle note 10 e 14 supra Discorso a parte per il segno di lsquoposto vuotorsquo si veda il punto c che segue
68 Queste regole generali vanno prese cum grano salis si dagrave naturalmente un certo dominio di variabilitagrave legato verosimilmente al grado di cultura grafica del copista nel PMich III 144 i numerali sono quasi tutti senza barra sia nel testo che nelle tabelle ope-razionali
Fabio Acerbi150
necessarie esse mancano invece sui segni convenzionali che ho descrit-to nel punto precedente e fatto rilevante sulle lettere numerali relative agli ordini sessagesimali quando esse siano identificate da uno o piugrave apici la presenza di questo segno grafico non alfabetico69 le esclude ancora una volta automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo Unrsquoultima osservazione che ci saragrave utile nel seacuteguito la descrizio-ne di una stringa di lettere lsquoagrammaticalersquo non puograve prevedere la men-zione della presenza della barra che le pertiene in quanto tale si tratta di una pratica denotativa che egrave possibile formulare soltanto ad un livello di discorso superiore sia a quello dellrsquouso che a quello della menzione70
c) Il segno di lsquoposto vuotorsquo Si noti nella tav 2b la forma ŏ per il segno di lsquoposto vuotorsquo in un ordine sessagesimale coerentemente con la propria notazione il copista del Marc gr 313 lo scioglie talvolta allrsquoin-terno del testo principale come unrsquoabbreviazione per οὐδέν laquonienteraquo Altre convenzioni di scrittura del tratto che accompagna il circoletto e che si badi bene fa parte integrante del segno di lsquoposto vuotorsquo ndash e infatti nelle tavole troviamo sempre il segno completo mentre tutti gli altri numerali sono come abbiamo visto nel punto precedente privi di barra o di apice a causa del fatto che i vari ordini sessagesimali sono univocamente determinati dalle linee di giustificazione ndash un tratto an-golare anteposto (tav 3 Lar Plut 2818 f 136v)71 o una semplice barra a sormontare (tavv 4-9) si produce in questo modo il segno 65926 che sembra essere stata la forma di base72
69 Occorre dunque supporre come testimoniano papiri e manoscritti in maiuscola che la convenzione relativa allrsquouso della barra si sia consolidata ben prima dellrsquointroduzione di segni diacritici quali accenti e spiriti
70 Si veda il punto 2 infra per maggiori dettagli sulla questione delle barre e degli apici e per le indicazioni in merito che leggiamo in Diofanto
71 Come accennato questa tavola dei sottomultipli coincide con quella descritta ed esposta nei Prolegomena Fatto molto rilevante i numerali nella prima non recano neacute barre neacute apici contrariamente a quanto accade a tutte le istanze della seconda nei manoscritti Quella del Laur Plut 2818 preserva a mio avviso la forma originaria come abbiamo visto una tavola non richiede segni aggiuntivi sulle lettere numerali
72 Si vedano come esempio ancora le tavole citate alle note 10 e 14 supra oppure per una rassegna delle forme che il segno assume nei manoscritti piugrave antichi delle Tavole facili Tihon 2011 pp 58-59 e per quelle che assume nei papiri Jones 1999 I pp 61-62 Ovviamente non possiamo leggere il segno 65926 come un omicron con una barra in quanto ο = 70 nella notazione greca e la barra egrave di rigore quando il numerale figuri allrsquointerno di un testo Occorre ammettere che si dagrave origine ad un bel corto circuito notazionale con il concepire un segno con funzione di lsquoposto vuotorsquo ma che lsquosomigliarsquo ad una lettera dellrsquoalfabeto sormontata da una barra cioegrave ad un numerale in piugrave quando il lsquoposto vuotorsquo non corrisponda ad un intero ma ad una specie sessagesimale la presenza della barra a priori indistinguibile da quella che sormonta gli interi introduce unrsquoincongruenza con la notazione a mezzo di apici vista nellrsquoitem precedente
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 151
d) Errori di copia La tabella riprodotta nella tav 2b ha una forma simmetrica ma si tratta di una forzatura il grande rettangolo in basso a destra drsquoaltronde assente nella descrizione contiene uno scolio che fa notare come lrsquoultimo resto parziale ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ͵γτνζ´´´´´ κζ´´´´´´ cioegrave 0 0 0 0 0 3357 27 siano ἔγγιστα λ´λ´ δ´δ´ ξ laquocon ottima approssimazione 60 minuti quartiraquo dove si notino gli apici semplici per indicare il pas-saggio allrsquoordinale e il raddoppiamento del sistema segno + apice per significare il plurale Lo scolio debitamente accompagnato dal segno di rimando in forma di simbolo solare egrave stato probabilmente incluso nella tabella proprio allo scopo di renderla simmetrica A sua volta un errore precedente spiega lo spazio eccessivo accordato al rettangolo contenente lo scolio il secondo massimo multiplo ŏ λβ´ ξδ´´ ριβ´´´ σιϛ´´´´ egrave trascritto anche al di sotto del risultato
Passiamo ora alla descrizione del metodo di divisione attribuito a Pappo
ἵνα οὖν ταῦτα συναχθῇ τὰ ἐκ τοῦ μερισμοῦ ὁ εἰρημένος Πάππος εὐδιατύπῳ τινὶ καὶ πρὸς τοῦτο τάξει χρησάμενος ποιεῖται τὴν τῆς συλλήψεως τοῦ ζητουμένου ἀνεύρεσιν οὕτως ἐκθέμενος γὰρ τὸν μέλλοντα μερίζεσθαι τουτέστι τὰς τξ μοίρας ἐν ἀρχῇ ἀφαιρεῖ ἀπ᾽ αὐτῶν τὸν ἐν τῇ σελίδι τυγχάνοντα ἐλάττονα τουτέστι τὸν τδ κβ´ κ´´ ὄντα τῶν ἐγγὺς ἐλασσόνων ὡς πρὸς τοὺς ἐκκειμένους διὸ καὶ γράφει αὐτὸν προγράφων αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε καὶ εὑρίσκων τὰ παρακείμενα αὐτῷ τῷ ἀπογραφέντι ἐν τῷ σελιδίῳ λεπτὰ πρῶτα ν´ συναπογράφεται παρατιθῶν αὐτοῖς τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον ἀνατείνουσαν σημαῖνον τὸ εἶδος ὅτι πρῶτα λεπτά εὑρίσκει οὖν οὕτως τὸ τῶν τξ μέρος τὸ τδ κβ´ κ´´ ὃ μεριζόμενον παρὰ τὰς τξε ιδ´ μη´´ ἡμέρας καὶ ποιοῦν τὸν ἐκ τοῦ μερισμοῦ ἀριθμὸν πρῶτα λεπτὰ ν´ καὶ τὸν λοιπὸν ἀπογραφόμενος τὸν νε λζ´ μ´´ προτάσσει αὐτοῦ τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά τάσσει δὲ καὶ ἁπλῆν τινα διατείνουσαν γραμμὴν ὡς ἀπὸ τοῦ τξ ἐπὶ τὸν ἑξῆς ἐκτεθειμένον ἐγγὺς
1
5
10
1 εὐδιατύπῳ] ZSPC εὐδιατύπωτ M 4 ἀφαιρεῖ] MZSP ἀφ ι C 5 ἐλάττονα] P comp MZSC 6 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | αφ ] αφ ε M ἀφ ZS ἀφαί P ἄφ C | ἀντὶ] om C | ἄφελε] MZSP ἄφ C 8 ἀπογραφέντι] MZSP ἐγγραφέντι C | λεπτὰ πρῶτα] P λε πρωτα SC λεπτῶν πρωτ MZ | παρατιθῶν] MZS παρατιθεὶς C et ex corr m 2 P 9 ᾱ] Z αο P α´ MS α C | ἔχον] MPC ἔχων ZS 9-10 πρῶτα λεπτά] ZP πρωτ λ´λ´ M πρωτα λε S αα λε C 11 ἡμέρας] comp codd | ἀριθμὸν] P et comp MZ καὶ C et comp S 12 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M πρωτ λεπτ(α) Z πρωτ λ εᾱ S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C | ἀπογραφόμενος] MZSP ἐγγραφόμενος C | νε λζ´] MZSP λζ νζ C 13 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | λ οι] MZSC ex λ fecit λ οι P | προσσημαῖνον] MC et προσ- comp ZS προση- P | τὸ] MZC τὰ S et fecit m 2 P 14 ἀπὸ] MZSP πρὸς C ἐλάττονα] P comp MZSC
1 εὐδιατύπῳ] εὐδιατυπώτω K 6-7 αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ] τὸ ἀφ K 8 παρατιθῶν mdash 10 λεπτά] τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ σημαίνουσαν τὸ εἶδος αὐτῶν ὅτι ᾱ λεπτά εἰσιν K | τὸ (sec)] τὰ K 12 πρῶτα] πρώτων K | τε λ ] λ οι` K | προσσημαῖνον mdash
Fabio Acerbi152
ἐλάττονα τὸν τδ κβ´ κ´´ ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις καὶ ταύτην ἐπιδεικνύουσαν τὴν τάξιν τῆς προόδου τῆς ἐκθέσεως ἧστινος κλωμένης γραμμῆς πρὸς τῷ ἐγγὺς ἐλάσσονι ἡ ἀντανάκλασις ἐπὶ τὸν λοιπὸν γέγραπται φερομένη ὡς εἴρηται διὰ τὸ εὔτακτον τῆς προκοπῆς οὕτως τε ποιήσας ἑξῆς τὸ αφ ποιῶν ὃ προσσημαίνει ὡς εἴρηται τὸ ὅτι δεῖ ἀφελεῖν ὁμοίως ἀπὸ τοῦ λοιποῦ καὶ δὴ τὸν ἐγγὺς πάλιν ἐλάσσονα ὡς πρὸς τὴν ἐν τῷ σελιδίῳ ἔκθεσιν εὑρισκόμενον λαμβάνων ἑξῆς προγράφει αὐτὸν ὄντα νδ μζ´ ιγ´´ ιβ´´´ καὶ εὑρίσκει αὐτοῖς παρακείμενα ἐν τῷ σελιδίῳ πρῶτα λεπτὰ θ´ ἅτινα καὶ αὐτὰ προσαπογράφεται σὺν τῇ παρασημειώσει τῶν πρώτων γράφων τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον τὴν ἀνατείνουσαν καὶ ὡς εἴρηται τὴν γραμμὴν πάλιν διὰ τὴν τάξιν κλωμένην κατὰ δευτέραν κλάσιν προσέλκει γινομένου τοῦ μέρους αὐτῆς τούτου παραλλήλου τῷ ἐξ ἀρχῆς
16 ante κλωμένης add ἐπὶ C 18 τε] MZP om SC | αφ ] M ἀφ ZSC ἀφαί P 19 προσσημαίνει] MS προση- ZC et ex corr P | ὅτι] ZP comp MSC 20 δὴ] MZSC διὰ fecit m 2 P 21 πρὸς] MSP et supra lineam C ex ἀπὸ fecit m 2 Z | ιγ´´] MZSP νγ´´ C 22 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M ᾱᾱ λεπτὰ Z άάα λε S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C 23 προσαπο- γράφεται] απο suprascr in comp M 24 ᾱ] ZP α´ MS α C 25 κλάσιν] MP τάξιν ZSC | τοῦ] ZSPC τούτου M 26 τούτου] τοῦ bis ZSPC sed prius erasit m 2 P τοῦ M
mdash 18 προκοπῆς] om K | τε ποιήσας] ποιήσας καὶ K | αφ ] ἀφ K 19 τὸ] om K 21 προ-γράφει] γράφει K 22 σελιδίῳ] α´ σελιδίῳ K | ἅτινα] ἃ K 23 προσαπογράφεται] ἀπογράφεται K | τῶν πρώτων mdash 26 ἐξ ἀρχῆς] om K
lsquoAllo scopo di raccogliere ciograve che risulta dalla divisione il detto Pappo utilizzando anche in questo caso una certa disposizione ben strutturata determina nel modo seguente il lsaquonumerorsaquo cercato preso nel suo insieme collocando73 in testa il lsaquonumerorsaquo che sta per essere diviso cioegrave i 360 gradi iniziali sottrae loro tra i piugrave prossimi dei lsaquonumerirsaquo minori rispetto a quelli esposti quello che si trova essere minore nella colonna (cioegrave 304 22 20) Questo egrave il motivo per cui lo trascrive scrivendogli davanti lrsquoabbreviazio-ne laquosottrraquo per laquosottrairaquo e trovando che 50 minuti primi sono collocati accanto a quello stesso lsaquonumerorsaquo che egrave stato trascritto nella colonna li trascrive al tempo stesso collocando accanto74 ad essi la lettera A con un lsaquotrattorsaquo75 sopra che significa la specie minuti primi Trova dunque in que-sto modo la parte di 360 che egrave 304 22 20 la quale divisa per 365 giorni 14 48 fa il numero lsaquoche risultarsaquo dalla divisione 50 minuti primi Trascrivendo
73 La descrizione egrave strutturata come una procedura Acerbi 201274 Il purismo del correttore del Par gr 2390 di Clostomalle nel Marc gr 314 e
dellrsquoautore della recensione bizantina impone loro di modificare la terminazione ma forme tematiche e contratte di τιθεῖν sono correnti nel greco tardivo
75 Il testo greco ha solo il participio con γραμμήν sottinteso Per il significato del participio si veda il punto 2
15
20
25
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 153
poi il resto 55 37 40 gli pone altresigrave76 a prefisso laquoReraquo che significa laquorestiraquo e dispone anche una certa linea semplice77 che va da 360 al piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori che egrave esposto di seacuteguito 304 22 20 come nello lsaquoschemarsaquo esposto linea che mostra lrsquoordine del percorso dellrsquoesposizione Questa linea spezzata lagrave dove si trova il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori egrave tracciata inflessa allrsquoindietro lsaquoersaquo punta verso il resto come egrave stato detto in vista di una progressione ordinata E cosigrave facendo prendendo di seacuteguito il laquosottrraquo che significa come egrave stato detto laquoche occorre similmente sottrarre dal re-storaquo e ovviamente prendendo di nuovo il lsaquonumerorsaquo che egrave trovato essere il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori in relazione alla disposizione nella colonna ndash 54 47 13 12 ndash lo scrive di seacuteguito e trova che 9 minuti primi sono posti loro accanto nella colonna trascrive78 anche questi con la segnaletica dei primi scrivendo la lettera A con un lsaquotrattorsaquo sopra e come egrave stato detto prolunga di nuovo la linea spezzata in vista di una buona disposizione tramite una seconda inflessione essendo questa sua parte parallela a quella inizialersquo
La descrizione continua con una serie di laquoe cosigrave viaraquo e non fa ulte-riore riferimento alla tabella
1) La forma verbale ἐξεσμένον Egrave il neutro del participio perfetto medio-passivo di ξέω lett laquopialloraquo laquolevigoraquo Si danno tre possibilitagrave si tratta di un termine canonico per quanto non altrove attestato per designare unrsquoabbreviazione oppure lrsquoautore anonimo improvvisa sul piano metaforico come se unrsquoabbreviazione non fosse altro che la paro-la completa lsquoaccorciata a colpi di piallarsquo in maniera opportuna oppure il testo egrave corrotto e srsquoimpone una correzione ad esempio τὸ ἑξῆς μένον laquociograve che sta di seacuteguitoraquo Questrsquoultima strada mi pare chiusa dal senso delle frase lrsquoabbreviazione non lsquosta di seacuteguitorsquo a niente ma anzi precede la perifrasi τὸ ἑξῆς μένον se impiegata semplicemente per rimandare al segno αφ immediatamente seguente costituirebbe un intollerabile solecismo Se accettiamo la prima di queste letture considerando quin-di lrsquoabbreviazione αφ in posizione predicativa abbiamo a che fare con
76 Rendo in questo modo il τε isolato77 La linea egrave laquosempliceraquo in quanto egrave una retta la precisazione intende evidenziare per
anticipazione il carattere lsquonon semplicersquo che essa assumeragrave alla prima inflessione quando diventeragrave una spezzata linee siffatte erano in effetti concepite dallrsquoanonimo e prima di lui da tutta la tradizione matematica greca come una singola linea spezzata nei punti drsquoinfles-sione I due segmenti paralleli menzionati al termine del passo sono orizzontali
78 Il verbo egrave al medio in variatio rispetto ai due che precedono e che seguono egrave il matematico che lsquosirsquo trascrive le cifre
Fabio Acerbi154
uno hapax semantico nella grecitagrave superstite come egrave facile verificare con una ricerca sul TLG in rete La recensione bizantina risolve il pro-blema sopprimendo semplicemente τὸ ἐξεσμένον
2) La notazione per le specie numeriche Nella terminologia matema-tica greca gli ordini sessagesimali sono εἴδη laquospecieraquo numerici essi corri- spondono agli ordini di grandezza nel nostro sistema decimale e indica-no in analogia con il caso geometrico la lsquoformarsquo che assume un numero quadrato cubo ecc Centinaia e migliaia sono quindi degli εἴδη rispet-tivamente quadrati (100 egrave il quadrato di 10) e cubi (1000 egrave il cubo di 10) sono specie numeriche ma non numeri particolari e drsquoaltronde 300 non egrave un quadrato ma 3 item dellrsquoεἶδος lsquoquadratorsquo 100 3 egrave il numerale di molteplicitagrave della specie quadrata lsquocentinaiarsquo i due 0 che seguono il 3 segnalano esattamente questo fatto che la notazione greca per gli interi non posizionale fa scomparire al livello denotativo Ciograve non vale soltan-to per i numeri interi ma anche per le loro parti i minuti secondi appar-tengono alla specie lsquoquadratorsquo in quanto 13600 egrave il quadrato di 160
La concezione appare interamente dispiegata nellrsquointroduzione degli Arithmetica diofantei79 che si rivela giova farlo rimarcare un te-stimone fondamentale per la ricostruzione della notazione matematica antica Alle specie usate in questrsquoopera vengono assegnati una denomi-nazione ed un segno convenzionale costituito dallrsquoiniziale (di ognuno dei componenti) della denominazione al quadrato o δύναμις il segno ΔΥ al κύβος il segno ΚΥ alla lsquoquarta potenzarsquo o δυναμοδύναμις il segno ΔΥΔ ecc La descrizione di tali segni egrave del tipo καὶ ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον Κ ἐπίσημον ἔχον Υ ΚΥ κύβος laquoe il suo segno egrave un Κ che ha come indice un Υ ΚΥ cuboraquo dove in accordo con quanto abbiamo visto nel punto b supra e pur nel comprensibile imbarazzo del copista della prima parte del Matritensis (o di un suo passato collega) a districarsi in questo formidabile ginepraio notazionale80 le due lettere Κ e Υ ricevono una barra mentre ΚΥ non la richiede a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον il quale ancora una volta esclude automaticamente il segno dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
79 In particolare a DOO I pp 214-62180 Nel Matr 4678 riscontriamo i seguenti fenomeni nelle poche righe a cavallo dei ff
58r-v 1) accento acuto posto su tutti i segni come se fossero abbreviazioni 2) ripetizione sistematica segnodenominazione come in ΚΥ κύβος appena letto dovuta sicuramente allrsquointrusione di glosse interlineari esplicative dei segni ndash e successivo pentimento (δύναμις e κύβος sono in effetti cancellati dalla prima mano il primo con un tratto il secondo con dei punti supra lineam poi il copista si stanca di correggere) 3) nella descrizione del segno per la δυναμοδύναμις menzione di un δέλτα δύο che saragrave molto probabilmente stato ΔΔ subito dopo nella descrizione del κυβόκυβος si legge un incongruo δύο KK
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 155
Diofanto introduce poi dei segni anche per le specie delle parti dellrsquounitagrave (le nostre frazioni) che egli chiama ὁμώνυμα μορία laquoparti omonimeraquo di cui quelle sessagesimali sono casi particolari81 Egli spie-ga appunto che le loro denominazioni sono ottenute da quelle delle specie degli interi per sinonimia passando ad un lsquoordinalersquo82 formato semplicemente aggiungendo il suffisso -στον δυναμοστόν κυβοστόν δυναμοδυναμοστόν ecc (sott μόριον) I loro segni convenzionali sono invece ottenuti da quelli per le specie degli interi aggiungendo una γραμμὴν διαστέλλουσαν τὸ εἶδος laquolinea che distingue la specieraquo83 Una linea sui segni delle specie delle parti egrave richiesta si badi bene per distinguerli dai segni di quelle degli interi come giagrave osservato questi ultimi sono giagrave lsquoagrammaticalirsquo a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον a fortiori lo saranno anche i primi Si tratta della traduzione semio-tica del passaggio dal cardinale allrsquoordinale che a livello grammaticale egrave effettuato con il suffisso -στον Che forma ha questa linea Barra o apice (Egrave cervellotico pensare a forme piugrave complesse) La domanda non ammette una risposta immediata in quanto delle specie diofantee nessuno piugrave si occupa nellrsquoantichitagrave84 Se egrave vero che la prima risposta darebbe origine ad un conflitto tra due convenzioni denotative diffe-renti la barra lsquocitazionalersquo e la barra che distingue la specie lrsquoevidenza grafica del Matritensis lascia lievemente sgomenti (ricordiamoci che giagrave i segni di base sono indebitamente dotati di un accento dal copista) Le poche occorrenze del segno per le specie delle parti85 vedono lrsquoaggiunta di uno slash di sospensione di un doppio apice inverso ndash in tutta evi-
81 Questo fatto era giagrave chiaro nellrsquoantichitagrave Teone in Alm I 10 in iA p 45310-1682 Il parallelo con i cardinali e gli ordinali relativi agli interi egrave reso esplicito da Dio-
fanto ὥσπερ δὲ τῶν ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια παρομοίως καλεῖται τοῖς ἀριθμοῖς τοῦ μὲν τρία τὸ τρίτον τοῦ δὲ τέσσαρα τὸ τέταρτον οὕτως καὶ τῶν νῦν ἐπονομασθέντων ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια κληθήσεται παρομοίως τοῖς ἀριθμοῖς laquocome le parti omonime dei numeri sono chia-mate per assonanza con i numeri di lsquotrersquo lsquolsaquounrsaquo terzorsquo di lsquoquattrorsquo lsquolsaquounrsaquo quartorsquo cosigrave le parti omonime dei numeri appena nominati saranno chiamate per assonanza con i numeriraquo (DOO I p 69-13 si noti lrsquoarticolo lsquocitazionalersquo al singolare in τοῦ τρία e τοῦ τέσσαρα) Il parallelo prosegue anche al livello dei segni che rappresentano queste specie come vedremo tra un attimo
83 Diofanto Arithmetica prefazione in DOO I p 620-21 un passaggio maltrattato in questa edizione occorre espungere il participio ἔχον senza introdurre segni ulteriori oppure eliminare un precedente ἐπί come fa un correttore del Matritensis f 58v
84 Unica parzialissima eccezione lrsquoaccenno di Teone menzionato nella nota 81 supra85 Al f 59r e per di piugrave nel margine per sanare un lungo saut du mecircme au mecircme La
collocazione in margine egrave il motivo per cui troviamo una notazione abbreviata nel resto del trattato il primo copista scioglie tutti i segni prendendoli per abbreviazioni mentre il secondo elimina sistematicamente il tratto aggiuntivo delle specie delle parti dellrsquounitagrave Drsquoaltronde egli scrive ad esempio ΔΥ invece di ΔΥ ed egrave quindi indotto a porre la barra al di sopra della stringa di lettere risultante (passim ma si veda ad esempio il f 72r)
Fabio Acerbi156
denza il compendio per la desinenza -ον accentata il copista interpreta il segno come unrsquoabbreviazione ndash e di una barra a sormontare lo Υ Potremmo forse interpretarlo come il segno di contrazione del grafema -στ- lrsquounico tassello mancante in unrsquoabbreviazione come ad esempio (δυναμοδυναμο)(στ)(ὸν) ma uno scolio di prima mano al f 58v rela-tivo alle specie degli interi inficia questrsquoipotesi esse sono dotate di slash di sospensione accento acuto in un caso del compendio canonico per la terminazione -ον hellip ma tutti gli Υ a esponente sono a loro volta sormontati da una barra
Meno legata al singolo manoscritto ma nondimeno non uniforme si presenta la pratica di notazione dei segni che rappresentano gli enti numerici sessagesimali86 da una parte sta lrsquoevidenza del testo dei Pro-legomena e delle sue tabelle apici ndash drsquoaltronde come abbiamo visto la notazione universalmente impiegata per i numerali ordinali e per le fra-zioni unitarie ndash dallrsquoaltra sta lrsquoevidenza del testo dellrsquoAlmagesto in tutti i manoscritti piugrave antichi e lo stesso si dica del commentario teonino a questrsquoopera o del suo lsquoGrande commentariorsquo alle Tavole facili e dei testi astronomici su papiro barre87 Sembra insomma che la nostra docu-
86 Sia le molteplicitagrave che le specie ahimeacute entrambe rappresentate da lettere dellrsquoalfabeto Come osservato allrsquoinizio della sezione 3 ci sono in effetti due tipi di lettere numerali in gioco se facciamo astrazione da apici o barre lsquo4 minuti secondirsquo si trova scritto δ β la prima lettera numerale denota la molteplicitagrave degli item di una certa specie la se-conda la specie nei Prolegomena entrambe sono accompagnate da un doppio apice il che rende inutile la presenza delle seconde Si noti che la descrizione della tabella non fa parola della notazione da usare per le lettere numerali che denotano la molteplicitagrave barre o apici e quanti apici hellip In questo caso fa interamente fede la tabella cioegrave la pratica grafica condivisa instauratasi non egrave chiaro quando
87 I manoscritti piugrave antichi dellrsquoAlmagesto sono menzionati nella nota 10 supra quelli dei due commentarii teonini sono il Laur Plut 2818 e il celeberrimo Vat gr 190 (sec IX in Euclide Elementi Data Teone lsquoGrande commentariorsquo) per la notazione dei pa-piri astronomici si veda Jones 1999 II passim La notazione non sembra lsquoinquinatarsquo dalla pratica dei copisti bizantini e pare dipendere soltanto dalla data di composizione Tro-viamo ad esempio barre sopra tutti i numerali di molteplicitagrave (interi o sessagesimali) nel frammento di un commentario alle Tavole facili contenente un calcolo relativo al 24 aprile 213 (Par gr 2841 sec XIII ex-XIV in oltre al frammento ai ff 32r l 11-34v l 23 contiene Arato Phaenomena ed Efestione Apotelesmatica edizione in Jones 1990) Nel commentario alle Tavole facili composto ca 610-617 ed attribuito a Stefano di Alessandria la situazione egrave la seguente (Jean Lempire per litteras per lrsquoedizione si veda Lempire 2014 ho controllato il Vat gr 304 ff 135r-171v sec XIV am contiene in aggiunta Teone in Almagestum I-II lsquoPiccolo commentariorsquo alle Tavole facili Diofanto Arithmetica e De polygo-nis numeris varia astronomica tabulae) barre sopra gli interi sporadicamente rimpiazzate da apici apici sopra le parti sessagesimali in numero uguale alla denominazione doppio () apice per le frazioni unitarie Sono impiegate barre sopra gli interi e apici sopra le parti sessagesimali nei manoscritti principali di tutti i trattati di introduzione allrsquoAlmagesto o comunque di argomento logistico redatti in epoca bizantina Giorgio Pachimere (1242-ca 1310) Quadrivium (autografo nel manoscritto Roma Biblioteca Angelica gr 38 [RGK III nr 115] si veda Tannery ndash Steacutephanou 1940 per lrsquoedizione) Teodoro Metochita (1270-
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 157
mentazione si faccia testimone di un cambio notazionale avvenuto nel periodo intercorrente fra Teone (sec IV pm) e la scuola alessandrina di Ammonio e dei suoi allievi (sec VI in) e probabilmente innescato da questrsquoultimo ambiente lrsquoaspetto paradossale egrave che nello stesso codice si rintraccino due notazioni differenti per gli enti numerici sessagesimali e lrsquouna (apici) sia adottata sistematicamente e coerentemente in uno scritto (i Prolegomena) che si presenta esattamente come unrsquointroduzione tecnica alla pratica numerico-algoritmica del trattato (lrsquoAlmagesto) in cui egrave adottata lrsquoaltra (barre che ritroviamo senza eccezioni anche negli scolii)
Torniamo ai Prolegomena la descrizione del segno da porre a fianco di ogni singolo quoziente parziale e denotante la sua specie numerica (minuti primi minuti secondi ecc) solleva tre problemi
Primo problema Ci vuole una barra o un apice su τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquola lettera A [hellip] che significa la specieraquo quando lo scriviamo nella tabella Tutta la nostra discussione precedente fa pro-pendere per lrsquoapice e si ricordi anche la forma verbale ἀνατείνουσαν che suggerisce qualcosa che si lsquoestende verso lrsquoaltorsquo (la mia traduzione egrave volutamente neutra) se fosse apposta una barra la cosa dovrebbe passare
1231332) Compendium astronomicum (copia lsquoautorizzatarsquo coeva nei Vat gr 182 e 181 da parte del copista che integrograve le parti mancanti del Par gr 2389 [ff 207-210 255-270 374-375] Bianconi 2005a pp 425-427 Peacuterez Martiacuten 2008 p 436 e n 177) Teodoro Meliteniota (morto lrsquo831393) Tribiblos astronomica (autografo nel Vat gr 792 si vedano Leurquin 1991 per unrsquoanalisi del manoscritto Leurquin 1990 per lrsquoedizione) una com-pilazione anonima (per cui ho consultato il Par gr 2396 ff 87r-92v limitatamente a questi fogli manu Costantino Trivoli [RGK II nr 318 ma ovviamente questo codice non vi egrave segnalato] terzo quarto del XV secolo il resto del codice annotato da Niceforo Gregora egrave di etagrave planudea e parzialmente [ff 33v-76v] un autografo di Planude stesso contiene Teone in Almagestum I II IV Mondrain 2002 il codice va completato ndash limitatamente a stralci dei libri VIII-X XII-XIII del commentario teonino la cui parte intermedia si egrave persa ndash con 26 carte [ff 123-147] inserite nel Vat gr 1087 anchrsquoesso contenente anno-tazioni di Gregora Rome 1927 per la figura del copista dei ff 77r-86r del Par gr 2396 e dei ff appena nominati del Vat gr 1087 un anonimo collaboratore di Gregora si veda in ultimo Bianconi 2006a pp 147-151) si veda anche il calcolo effettuato da Niceforo Gre-gora (12921295-13581361) dellrsquoeclisse di sole del 16 luglio 1330 (attestata unicamente ai ff 1r-8v della miscellanea astronomica Marc gr 325 databile ca 1324-1329 in parte vergata e ovunque fittamente annotata da Gregora stesso edizione del testo in Mogenet et al 1983 annotazioni di Gregora elencate in Bianconi 2005a p 413) Unrsquoeccezione apparente il lsquoPiccolo commentariorsquo di Teone alle Tavole facili le parti sessagesimali sono segnalate da apici (ad esempio nel Vat gr 175 vergato da Giovanni Catrario e completato nel 1321-1322 sulla figura di Catrario si vedano in ultimo Bianconi 2005b pp 141-156 e 2006b) lrsquoopera egrave antica ma la sua tradizione non rimonta oltre la fine del XIII secolo a parte un frammento nel Leiden BPG 78 ff 156r-161v (minuscola del IX-X secolo) e in effetti in questo manoscritto tutti i numerali di molteplicitagrave sono sormontati da barre Unrsquoeccezione effettiva egrave il De hypotesibus planetarum nel Vat gr 1594 barre sugli interi e apici sulle parti sessagesimali
Fabio Acerbi158
sotto silenzio e la presenza dellrsquoapice la rende inutile88 Si tratta della stessa convenzione diofantea e coincide ancora con la notazione per i numerali ordinali e per le frazioni unitarie che egrave corrente nei mano- scritti matematici greci per questo motivo non percheacute la descrizione sia particolarmente perspicua nessuno dei copisti della recensione an-tica ha incertezze apici Ma questi apici si rintracciano soltanto sulle indicazioni di specie non contemplate dalla descrizione che sono ante-poste ai resti parziali a fianco dei quozienti parziali i segni di specie sono invece trasformati in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordi-nali corrispondenti del tipo πρωτ tavv 5 e 7b-8 Il recensore bizantino taglia invece la testa al toro elimina dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali elimina la seconda menzione della laquolet-tera Araquo contestualmente allrsquoazzeramento dellrsquoespediente della linea a zig-zag (si veda il punto seguente) modifica la descrizione che contiene la prima menzione in quella dellrsquoapice associato direttamente ai nume-rali di molteplicitagrave riciclando addirittura lrsquoalpha per adibirlo a desi-gnare un numero cardinale (come sorprendersi) τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ laquoponendo al di sopra di essi [scil dei 50 minuti primi] 1 solo lsaquoaccentorsaquo acutoraquo La scelta del recensore egrave assennata che rechi una barra o un apice in una tabella un alpha denota un numero non un numero drsquoordine
Secondo problema da tenere ben distinto dal precedente Cosa ci vuole sul segno α per la lettera alpha menzionata nella frase τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquolettera A [hellip] che significa la specieraquo89 Unrsquooc-chiata allrsquoapparato critico rivela una bella incertezza nei manoscritti Z scrive sempre ᾱ e in un caso lo fa anche P MS optano sempre per α´ C per α P scrive nellrsquoaltro caso αο Per quanto solo la barra sia congrua con il senso della frase in quanto la lettera alpha egrave qui menzionata (si tratta di un oggetto che compare nella tabella) e non cambia niente se essa egrave accompagnata dal suo nome di genere στοιχεῖον ad un livello grafico lrsquoincertezza fra il segno ᾱ che denota laquola lettera αraquo e il segno α´ (o lrsquoabbreviazione αο) per una forma di πρῶτος egrave per piugrave versi giustificata
88 Detto in altri termini la barra egrave uno strumento grafico non matematico e quindi la sua presenza non va segnalata mentre un apice lo egrave e la sua presenza lo deve
89 Notare che in questa frase il primo α non vuole la barra (egrave menzionato allrsquointerno di una frase che impiega convenzioni moderne) il secondo sigrave (idem ma con convenzioni antiche) ndash e nella traduzione la scelta di denotarlo con A (senza virgolette) e non con lsquoArsquo (con virgolette) egrave del tutto arbitraria ndash si noti inoltre che le necessarie precisazioni laquosenzacon virgoletteraquo mostrano che le lingue moderne palesano difficoltagrave analoghe a quelle del greco antico per quanto riguarda i livelli denotativi in ambito metadiscorsivo per non usare le due parentetiche avrei dovuto scrivere rispettivamente lsquoArsquo e lsquolsquoArsquorsquo (doppie virgolette semplici)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 159
ᾱ coincide con il numerale 1 α egrave la prima lettera dellrsquoalfabeto ed inoltre α´ egrave esattamente quello che va scritto nella tabella Potremmo dirci che il sostantivo στοιχεῖον chiude la questione la sua presenza congiunta ad un ipotetico α´ renderebbe la descrizione ridondante o inappropriata90 Ma a parte il fatto che α egrave proprio τὸ πρῶτον στοιχεῖον il segno α´ cat-tura in fondo il cuore della descrizione di uno στοιχεῖον ἔχον lsaquoγραμμὴνrsaquo ἀνατείνουσαν
Terzo problema Lrsquoautore dei Prolegomena che si arresta allrsquoesem-pio dei minuti primi non dice quanti apici occorre mettere sulle lettere numerali che identificano gli ordini superiori al primo se uno soltanto come nel caso diofanteo e delle frazioni unitarie o in numero uguale alla loro denominazione (cioegrave pari al numero denotato dal numerale stesso su cui vanno posti) come effettivamente avviene nei mano-scritti dei Prolegomena La tabella egrave quindi sottodeterminata dalla sua descrizione anzi in un certo senso prende il sopravvento su di essa la pratica di marcare i numerali di molteplicitagrave con gli apici che compe-tono allrsquoordine cui appartengono viene trasferita ai segni per gli ordini stessi per supplire ad una descrizione carente di questi ultimi E la tabella egrave sottodeterminata dalla descrizione in quanto egrave la descrizione di una tabella reale ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις laquocome nello lsaquoschemarsaquo espostoraquo leggiamo a un certo punto del testo
3) La linea a zig-zag Non possiamo che applaudire a questo geniale espediente grafico lo troviamo messo in opera solo nel Marc gr 313 Per quanto lrsquoautore non faccia parola di ciograve nel corso della sua descrizione la linea spezzata egrave intesa dover lsquosaltarersquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue Il copista del codice marciano effettua correttamente due salti nella prima delle sue tabelle (tav 4) ma inserisce un lsquodentersquo in piugrave in quella che considera corretta (tav 5) La linea a zig-zag egrave incompatibile con la presenza di linee di giustificazione nella tabella che in effetti mancano nel Marc gr 313 ciograve induce gli errori di allineamento dei primi 5 quozienti parziali di cui egrave vittima il copista Probabilmente per questo motivo in nessuno degli apografi del Vat gr 1594 la linea a zig-zag figura nella tabella inquadrata come si conviene da una (doppia) cornice esterna e le cui colonne sono appunto separate da linee verticali (tav 7b Vat gr 184 f 17v e tav 8 Par gr 2390 f 9v cui egrave sostanzialmente identica la tabella del Marc gr 314 che si trova
90 Trascuro lrsquoabbreviazione αο = πρῶτος percheacute la desinenza non egrave quella richiesta neacute nella frase (egrave richiesto πρῶτον) neacute nella tabella (πρῶτα)
Fabio Acerbi160
al f 248r ndash ma la mancanza di linee orizzontali causa un gigantesco pa-sticcio nel codice vaticano) Alla recensione bizantina che dipende per il suo testo di base dal Vat gr 1594 e quindi non trova la linea a zig-zag nella tabella non resta che sopprimere la sua descrizione ndash ma proprio per questo motivo e finalmente diventa possibile tracciare un apparato completo di linee di giustificazione (tav 9 Laur Plut 89 sup 48 f 14v) Dato che la descrizione di Teone di questo procedimento di divi-sione non fa cenno allrsquoesistenza della linea a zig-zag viene da chiedersi se essa non costituisca un espediente escogitato dallrsquoautore dei Prolegomena per vivacizzare la procedura originale di Pappo
4) Discrepanze tra descrizione e tabella Il gioco delle minime va-rianti mostra che la divisione era stata eseguita (e trasmessa) corret-tamente tutti i valori numerici sono esatti La tabella nel Marc gr 313 presenta perograve alcune discrepanze con la propria descrizione Essa omette (ma non nella versione lsquoscorrettarsquo lrsquoomissione non si riscontra neanche nel Par gr 2390) il segno per laquorestoraquo di fronte ai resti par-ziali ma aggiunge lrsquoindicazione della loro specie Essa trasforma invece come abbiamo visto le indicazioni di specie che seguono i quozienti parziali in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordinali corri-spondenti La descrizione prevede di chiudere la tabella con il risultato καὶ συνάγων ἅπαντα τὰ ἐκ τῶν μερισθέντων μερῶν λεπτὰ σημειοῦται ὑπὸ πάντας οὕτως γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoe raccogliendo tutti i minuti che provengono dalle parti divise lsaquoPapporsaquo nota sotto tutto cosigrave Ris 0 59 8 17 13 12 31raquo ma sotto la tabella tutta la tradizione ci consegna qualcosa di piugrave articolato ὁ ζητούμενος καθ᾽ ὃν μερίζεται ὁ τξε ιδ´ μη´´ π(αρὰ) τὸν τξ γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoil lsaquonumerorsaquo cercato secondo cui 365 14 48 egrave diviso per 360 risulta 0 59 8 17 13 12 31raquo frase che del resto contiene due errori lrsquoinversione del dividendo e del divisore e la confusione tra segno convenzionale (iuxta descrizione) e abbreviazione (come nella frase) nel caso di γι Oltre ad eliminare la linea a zig-zag91 la recensione bizantina sopprime dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali e modifica come abbiamo visto al punto 2 le loro descrizioni in quelle di apici associati diretta-mente ai numerali di molteplicitagrave
91 Le due righe che nella recensione di base contengono solo i resti parziali minori di 160 del divisore ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue sono in parte completate con lrsquoindicazione abbreviata ἀνάλ(υσις) laquoanalisiraquo il termine greco per questa procedura di riduzione In un sussulto di ipercorrettismo matematico tali resti parziali ridotti non sono preceduti dal segno per laquorestoraquo come nel Par gr 2390 ma da quello per laquorisultatoraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 161
Gli esempi che abbiamo discusso mostrano come i problemi di notazione pesino e non poco sullrsquoespressione discorsiva di un algorit-mo matematico lrsquoente di riferimento per lsquoformularersquo il procedimento di divisione fu considerata la tabella cioegrave un oggetto la cui costitu-zione egrave legata piugrave ad una pratica grafica che a considerazioni logico- algoritmiche non la sua descrizione che in effetti finisce per determi-nare la tabella in maniera non univoca Di questa sottodeterminazione si fa testimone la traiettoria che abbiamo cercato di seguire nelle mani di copisti e revisori il procedimento di divisione si modifica a volte in aspetti secondari a volte in punti piugrave sostanziali ndash fino a rendere neces-saria una radicale revisione della sua descrizione per renderla conforme alla tabella ndash in ogni caso mai per ragioni squisitamente matematiche92
Abstract
The article presents and discusses in detail two passages from the anonymous Prolegomena to the Almagest a VIth century primer to the elementary procedures of calculation needed in Ptolemyrsquos Almagest In the two passages we may follow the complex interplay between mathematical notation the auctor who employed and described it the tachygrapher who transcribed it in vivo copyists who reproduced it correctors who modified it Along this path misgivings and errors arise in the transmission of abbreviations and paratextual units such as diagrams tables operational schemes
Fabio AcerbiCNRS UMR8560 Centre Alexandre Koyreacute
fabacerbigmailcom
92 Sono grato a Daniele Bianconi Lucio del Corso Jean Lempire per alcune preziose indicazioni
AOO = Archimedis opera omnia cum commentariis Eutocii ed J L Heiberg I-III Lipsiae 1910-1915
DOO = Diophanti Alexandrini opera omnia cum Graecis commentariis ed P Tannery I-II Lipsiae 1893-1895
GC = Le laquoGrand Commentaireraquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Mogenet ndash A Tihon I-III Cittagrave del Vaticano 1985-1999
iA = Commentaires de Pappus et de Theacuteon drsquoAlexandrie sur lrsquoAlmageste ed A Rome I-III con paginazione continua Cittagrave del Vaticano 1931-1943
HOO = Heronis Alexandrini opera quae supersunt omnia ed G Schmidt ndash L Nix ndash W Schmidt ndash H Schoene ndash J L Heiberg I-V Lipsiae 1899-1914
PC = Le ldquoPetit Commentairerdquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed A Tihon Cittagrave del Vaticano 1978
POO = Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia ed J L Heiberg I-II in 3 parti Lipsiae 1898-1907
RGK = Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600 I Handschriften aus Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln II Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs und Nachtraumlge zu den Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln III Handschriften aus Bibliotheken Roms mit dem Vatikan A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg unter Mitarbeit von D Harlfinger und P Eleuteri B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln Wien 1981-1997 (Oumlsterreichische Akademie der Wissenschaften Veroumlffentlichungen der Kommission fuumlr Byzantinistik III1-3 A-C)
Sigla
Acerbi 2010 = F Acerbi Il silenzio delle sirene La matematica greca antica Roma 2010
Acerbi 2012 = F Acerbi I codici stilistici della matematica greca dimostrazioni procedure algoritmi laquoQUCCraquo 1012 (2012) pp 167-214
Acerbi et al 2010 = F Acerbi ndash N Vinel ndash B Vitrac Les Proleacutegomegravenes agrave lrsquoAlmageste Une eacutedition agrave partir des manuscrits les plus anciens Introduction geacuteneacuterale ndash Parties I-III laquoSCIAMVSraquo 11 (2010) pp 53-210
Agati 1992 = M L Agati La minuscola laquoBouleteacuteeraquo Cittagrave del Vaticano 1992
Belger 1881 = C Belger Ein neues Fragmentum mathematicum Bobiense laquoHermesraquo 16 (1881) pp 261-284
Bianconi 2005a = D Bianconi La biblioteca di Cora tra Massimo Planude e Niceforo Gregora Una questione di mani laquoSampTraquo 3 (2005) pp 391-438
Bianconi 2005b = D Bianconi Tessalonica nellrsquoetagrave dei Paleologi Le pratiche intellettuali nel riflesso della cultura scritta Paris 2005
Bianconi 2006a = D Bianconi Le pietre e il ponte ovvero identificazioni di mani e storia della cultura laquoBizantinisticaraquo 8 (2006) pp 135-181
Bianconi 2006b = D Bianconi Qualcosa di nuovo su Giovanni Catrario laquoMEGraquo 6 (2006) pp 69-91
Cavallo 1977 = G Cavallo Funzione e strutture della maiuscola greca tra i secoli VIII-XI in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Colloque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 95-137
Cereteli 1904 = G F Cereteli De compendiis scripturae codicum Graecorum praecipue Petropolitanorum et Mosquensium anni nota instructorum Sankt-Petersburg 1904
De Gregorio 2000 = G De Gregorio Materiali vecchi e nuovi per uno studio della minu-scola greca fra VII e IX secolo in G Prato (a cura di) I manoscritti greci tra riflessione e dibattito Atti del V Colloquio Internazionale di Paleografia Greca Cremona 4-10 ottobre 1998 Firenze 2000 pp 83-151
Follieri 1977 = E Follieri La minuscola libraria dei secoli IX e X in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Col-loque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 139-165
Fonkič 2005 = B Fonkič Venecianskaia rukopisrsquo laquoAlrsquomagestaraquo Ptolemeja (Marc gr 313690) o datirovke i proischoždenii kodeksa laquoVDIraquo s III 254 (2005) pp 162-167
Fowler 1999 = D H Fowler The Mathematics of Platorsquos Academy A New Reconstruction Second Edition Oxford 1999
Bibliografia
Fabio Acerbi164
Gerstinger ndash Vogel 1932 = H Gerstinger ndash K Vogel Eine stereometrische Aufgaben-sammlung im Papyrus Graecus [sic] Vindobonensis 19996 laquoMitteilungen aus der Papy-russammlung der Nationalbibliothek in Wienraquo Neue Serie Folge 1 Griechische literarische Papyri 1 Wien 1932 pp 11-76
Heiberg 1927 = Mathematici Graeci Minores ed J L Heiberg Kjoslashbenhavn 1927
Hultsch 1876-1878 = Pappi Alexandrini Collectionis quae supersunt ed F Hultsch I-III Berlin 1876-1878
Janz 2003 = T Janz The Scribes and the Date of the Vat gr 1291 in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae X Cittagrave del Vaticano 2003 pp 159-180
Jones 1990 = Ptolemyrsquos First Commentator ed A Jones Philadelphia 1990
Jones 1999 = Astronomical Papyri from Oxyrhynchus ed A Jones I-II Philadelphia 1999
Jones 2005 = A Jones Ptolemyrsquos Canobic Inscription and Heliodorusrsquo Observation Reports laquoSCIAMVSraquo 6 (2005) pp 53-97
Lempire 2014 = Steacutephanos drsquoAlexandrie Le commentaire aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Lempire Louvain 2014
Leurquin 1990 = Theacuteodore Meacuteliteacuteniote Tribiblos astronomique Livre I ed R Leurquin Amsterdam 1990
Leurquin 1991 = R Leurquin Un manuscrit autographe de la Tribiblos Astronomique de Theacuteodore Meacuteliteacuteniote le Vaticanus graecus 792 laquoScriptoriumraquo 45 (1991) pp 145-162
Maas 1927 = P Maas Griechische Palaeographie in A Gercke ndash E Norden (hrsg von) Einleitung in die Altertumswissenschaft I9 Leipzig 1927 pp 69-80
Martinelli Tempesta 2010 = S Martinelli Tempesta Il codice Milano Biblioteca Am-brosiana B 75 sup (gr 104) e lrsquoevoluzione della scrittura di Giovanni Scutariota in A B Garciacutea ndash I Peacuterez Martiacuten (ed by) The Legacy of Bernard de Montfaucon Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting Proceedings of the Seventh Inter-national Colloquium of Greek Palaeography Madrid-Salamanca 15-20 September 2008 Turnhout 2010 pp 171-186
Mazzucchi 1994 = C M Mazzucchi Leggere i classici durante la catastrofe (Costantino-poli maggio-agosto 1203) le note marginali al Diodoro Siculo Vaticano gr 130 Parte prima stratigrafia laquoAevumraquo 68 (1994) pp 164-218
Mioni 1976 = E Mioni Bessarione scriba e alcuni suoi collaboratori in Miscellanea marcia-na di studi bessarionei Padova 1976 pp 263-323
Mioni 1985 = Codices graeci manuscripti Bibliothecae Divi Marci Venetiarum II Thesaurus Antiquus Codices 300-625 recensuit E Mioni Roma 1985
Mogenet 1962 = J Mogenet Une scholie ineacutedite du Vat gr 1594 sur les rapports entre lrsquoastronomie arabe et Byzance laquoOsirisraquo 14 (1962) pp 198-221
Mogenet et al 1983 = Niceacutephore Greacutegoras Calcul de lrsquoeacuteclipse de soleil du 16 juillet 1330 ed J Mogenet ndash A Tihon ndash R Royez ndash A Berg Amsterdam 1983
Mondrain 2002 = B Mondrain Maxime Planude Niceacutephore Greacutegoras et Ptoleacutemeacutee laquoPa-laeoslavicaraquo 10 (2002) pp 312-322
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 165
Mondrain 2004 = B Mondrain Lrsquoancien empereur Jean VI Cantacuzegravene et ses copistes in A Rigo (a cura di) Gregorio Palamas e oltre Studi e documenti sulle controversie teologiche del XIV secolo bizantino Firenze 2004 pp 249-296
Mondrain 2007 = B Mondrain Les eacutecritures dans les manuscrits byzantins du XIV e siegravecle Quelques probleacutematiques laquoRSBNraquo n s 44 (2007) pp 157-196
Peacuterez Martiacuten 2006 = I Peacuterez Martiacuten Maxime Planude et le Diophantus Matritensis (Madrid Biblioteca Nacional ms 4678) un paradigme de la reacutecupeacuteration des textes anciens dans la ldquorenaissance paleacuteologuerdquo laquoByzantionraquo 76 (2006) pp 433-462
Peacuterez Martiacuten 2008 = I Peacuterez Martiacuten El lsquoestilo Hodegosrsquo y su proyeccioacuten en las escrituras constantinopolitanas laquoSampTraquo 6 (2008) pp 389-458
Perria 1991 = L Perria Scrittura e ornamentazione nei codici della laquocollezione filosoficaraquo laquoRSBNraquo n s 28 (1991) pp 45-111
Rollo 2012 = A Rollo LrsquoArchimede di Giorgio Valla in V Fera ndash D Gionta ndash A Rollo (a cura di) Archimede e le sue fortune Atti del Convegno di Siracusa-Messina 24-26 giugno 2008 Messina 2012 pp 99-147
Rome 1927 = A Rome Membra disjecta laquoRBenraquo 39 (1927) pp 187-188
Rome 1938 = A Rome Un manuscrit de la bibliothegraveque de Boniface VIII agrave la Meacutediceacuteenne de Florence laquoACraquo 7 (1938) pp 261-268
Ronconi 2013 = F Ronconi La collection philosophique un fantocircme historique laquoScripto-riumraquo 67 (2013) pp 119-140
Tannery ndash Steacutephanou 1940 = Quadrivium de Georges Pachymegravere ed P Tannery ndash E Steacutephanou Cittagrave del Vaticano 1940
Tihon 2011 = Πτολεμαίου Πρόχειροι Κανόνες Les Tables faciles de Ptoleacutemeacutee vol Ia Tables A1-A2 ed A Tihon Leuven 2011
Traube 1907 = L Traube Nomina Sacra Versuch einer Geschichte der christlichen Kuumlrzung Muumlnchen 1907
Vogel 1936 = K Vogel Beitraumlge zur griechischen Logistik laquoSBAWraquo Mathematisch-natur-wissenschaftliche Abteilung Jahrgang 1936 pp 357-472
Wouters 1979 = A Wouters The Grammatical Papyri from Graeco-Roman Egypt Contri-butions to the Study of the lsquoArs Grammaticarsquo in Antiquity Brussel 1979
F ACERBI Tav 1
b Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 65r
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 284 f 160r
F ACERBITav 2
b Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 13r
a Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 19v
F ACERBI Tav 3
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 136v
F ACERBITav 4
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17r
F ACERBI Tav 5
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17v
F ACERBITav 6
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 7v
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 139
ritmo della divisione lsquoalla Papporsquo non egrave mai eseguito (cioegrave formulato verbalmente) in maniera indipendente dalla descrizione della tabella Comrsquoegrave dunque possibile descrivere una tabella operazionale che non ha uno statuto testuale indipendente sulla base di un algoritmo in corso di esecuzione E drsquoaltro canto come non rilevare unrsquoanomalia in un algoritmo eseguito nella sua forma primaria sotto forma di descrizione di una tabella Ci potremmo chiedere se viene descritto lrsquoalgoritmo o la tabella La tensione fra i due enti grafici egrave acuita dal fatto che nei nostri testi tutto ciograve (esposizione o descrizione di un algoritmo o della tabella associata) avviene sempre e solo sulla base di un esempio numerico para-digmatico Per questo motivo la tabella in quanto struttura (cioegrave privata dei dati numerici accidentali) non puograve fare a meno della descrizione45 Dal canto suo Teone come forse Pappo ancor prima descrive ed espone la tavola dei (sotto)multipli ma non la tabella di divisione lrsquoalgoritmo relativo a questrsquoultima egrave espresso come per controbilanciare in maniera eccezionalmente trasparente e formulare Se ciograve comporta un guada-gno a livello verbale-argomentativo sorge un problema operativo grave come e dove sistemare i resti e i quozienti parziali ndash cioegrave tutti i numeri in output dellrsquoalgoritmo differenti dai (sotto)multipli ndash che la tabella si incarica di disporre in modo lsquonaturalersquo Teone prescrive soltanto di confrontare i resti con la seconda colonna della tavola dei sottomultipli e di trascrivere via via il quoziente ottenuto dopo ogni passo Insomma come eseguire materialmente una divisione Non certo adattando ad un nuovo caso specifico la formulazione dellrsquoalgoritmo che Teone propone
Un secondo ordine di problemi e una trappola micidiale per il co-pista egrave interno alla dialettica lsquotabellarsquolsquosua descrizionersquo ed egrave in assenza di simbolismo quello dei riferimenti linguistici da adottarsi nella seconda agli enti grafici che figurano nella prima Occorre ricercare la massima generalitagrave fornita da una descrizione definita di un ente numerico (ad esempio impiegando il termine laquorestoraquo o la perifrasi laquomassimo sotto-multiplo minoranteraquo) o basta assumere direttamente il suo valore speci-fico come esempio paradigmatico E in che modo risolvere il conflitto tra uso e menzione se come nel nostro caso la tabella contiene segni convenzionali ed occorre fornirne una descrizione Si rende ad esempio necessario introdurre un lsquooperatore di citazionersquo noi useremmo le virgo-lette la lingua greca premette lrsquoarticolo neutro Drsquoaccordo ma nel caso
45 Questa caratteristica non egrave connaturata alla matematica degli algoritmi la risorsa dello lsquostile proceduralersquo serve esattamente ad aggirare questo problema al di lagrave di un certo livello di dettaglio perograve essa condurrebbe ad un appesantimento insostenibile della for-mulazione dovuto alla pluralitagrave dei riferimenti agli oggetti matematici in gioco sulla que-stione dei diversi stili della matematica greca si veda Acerbi 2012
Fabio Acerbi140
greco qual egrave il suo range E come distinguerlo nei casi ambigui da un semplice articolo che precede un sostantivo quando questrsquoultimo lo ri-chieda Nel corso del processo di copia del testo della descrizione infine possono generarsi tensioni tra enti grafici interpretabili vuoi come segno convenzionale vuoi come abbreviazione Ambiguitagrave relative a questi punti opacizzano la descrizione Un problema analogo si porrebbe a priori nella dialettica tra uso delle lettere denotative per designare enti geometrici e loro menzione nella costruzione di un diagramma ma esso egrave risolto con lrsquoazzeramento della seconda funzione le lettere denota-tive sono sempre usate allrsquointerno del testo (sono cioegrave il referente degli oggetti geometrici di cui tratta il discorso matematico) mai menzionate (come accadrebbe se fossero il referente di oggetti grafici posti nel dia-gramma) Insomma il codice adottato per la costituzione dei diagrammi geometrici egrave condiviso (cioegrave canonizzato) semplice e perspicuo mentre quello per le tabelle operazionali non lo egrave da qui le sviste dei copisti e le trascuratezze di correttori ed editori
Infine chi vuole apprendere da questi testi come eseguire una divi-sione a cosa deve prestar fede se ad esempio a causa di errori di copia la descrizione finisce per non coincidere con la tabella operazionale visto che sono entrambe due maniere valide di eseguire lo stesso algoritmo Dopo tutto lo scopo di tutta questa macchina grafico-argomentativa egrave di insegnare a eseguire divisioni in formato tabellare Questo problema si fa particolarmente acuto se la tabella non egrave trasparente nel metodo di Pappo lo egrave quasi completamente in quello anonimo no E gli errori che riscontreremo nella (doppia) tabella ai ff 17r-v del Marc gr 313 a chi sono attribuibili Allrsquoautore al trascrittore o al copista medievale
Questo groviglio di problemi riceve alcune risposte sorprendenti dalla tradizione manoscritta come andiamo finalmente a vedere
4 Analisi delle testimonianze
I codici che ho adibito per lrsquoedizione sono i seguenti M = Marc gr 31346 C = Marc gr 314 (Tolomeo Tetrabiblos et opera minora cum commentariis Vezio Valente Anthologiae)47 Z = Vat gr 2326 (fattizio
46 Riferibile al sec IX ex-X in accolgo la datazione suggeritami per litteras il 522005 da Nigel G Wilson si veda anche Agati 1992 pp 141-142 La presenza non sistematica degli accenti che fa anticipare a Wilson la datazione di laquosaec X medraquo fornita in Mioni 1985 p 24 indusse Boris Fonkič (2005 non vidi) ad assegnare il codice allrsquoinizio del IX secolo
47 Il manoscritto riferibile alla seconda o terza decade della prima metagrave del XIV secolo fu vergato da Michele Clostomalle olim lsquoMetochitesschreiberrsquo Bianconi 2005a pp 428-430 Il titolo dei Prolegomena in questa trascrizione identico in grafia ma non in formulazione a
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 141
e mutilo Tolomeo Almagestum) S = Vat gr 184 (varia astronomica scholia miscellanea ad Almagestum Tolomeo Almagestum) P = Par gr 2390 (varia astronomica) gli ultimi tre riferibili allo scorcio del XIII secolo48 e apografi sicuri del Vat gr 159449 attualmente mutilo di due fascicoli che ci privano dei due terzi finali dei Prolegomena M e il Vat gr 1594 ammettono un modello comune il resto della tradizione (25 trascrizioni in tutto) dipende dagli apografi appena citati del Vat gr 1594 Le varianti della recensione bizantina che leggiamo tra lrsquoaltro nei Vat gr 198 Marc gr 310 (Tolomeo Almagestum cum commentariis Pappi Theonis et Cabasilae) e con ulteriori modifiche Laur Plut 89 sup 48 (varia astronomica Tolomeo Almagestum Barlaam Logistica) sono identificate dal siglum K e si trovano punteggiatura originale in-clusa nel secondo apparato50 Lrsquoanalisi delle testimonianze51 costituite ovviamente anche dalle tabelle associate saragrave condotta nella forma di una sequenza di osservazioni indicizzate da numerali o lettere oltre che di alcune note a piersquo di pagina
Iniziamo dalla descrizione del metodo di divisione anonimo
quello che leggiamo nel Vat gr 1594 (questrsquoultimo coincide con quello adottato nella recen-sione bizantina) fu apposto da Niceforo Gregora e successivamente corretto da Bessarione
48 Sto studiando il primo e il terzo codice in collaborazione rispettivamente con Daniele Bianconi e Inmaculada Peacuterez Martiacuten
49 Su questo codice risalente alla seconda metagrave del IX secolo e sulla sua collocazione nella lsquocollezione filosoficarsquo per prima proposta in Follieri 1977 pp 145-146 si vedano almeno Perria 1991 pp 82-88 Ronconi 2013 Che il titolo dei Prolegomena nel Vat gr 1594 sia stato apposto da Niceforo Gregora egrave stato riconosciuto per la prima volta in Mazzucchi 1994 p 211 n 196 si veda Bianconi 2005a p 418 per altri interventi di Gregora nello stesso manoscritto
50 Il Vat gr 198 egrave stato vergato dal copista Malachia nel corso del terzo quarto del XIV secolo Mondrain 2004 pp 278-290 e 292 Allo stesso copista (denominato non a caso prima dellrsquoidentificazione anonymus Aristotelicus) dobbiamo un buon numero di trascrizioni aristoteliche con i relativi commentari in margine Gli dobbiamo anche il Par gr 2342 secondo tomo di un quadrivium quasi completo di cui il Vat gr 198 egrave il primo nellrsquoordine aritmetica armonica astronomia (Almagesto e commentari relativi) nel codice vaticano geometria ed ancora astronomia (corpus astronomico minore) in quello parigino le opere trascritte sono sempre accompagnate in margine dai relativi commentari Il copista del Marc gr 310 egrave Isacco Argiro (ca 1300-1375) Mondrain 2007 p 166 Allo stesso Argiro dobbiamo il codice laurenziano (Daniele Bianconi per litteras) Poicheacute la recensione modificata che leggiamo nel Laur Plut 89 sup 48 egrave senza alcun dubbio basata su quella nel Marc gr 310 e non viceversa ci troviamo di fronte ad un copista che trascrive due volte lo stesso testo in due versioni leggermente differenti la conclusione naturale egrave che la seconda recensione egrave dovuta ad Argiro stesso la questione andragrave studiata in dettaglio
51 Nei manoscritti citati i Prolegomena si trovano ai fogli seguenti Vat gr 1594 ff 1r-8v (mutilo mancano due fascicoli su tre) Marc gr 313 ff 1r-28r (incompleto man-cano due fogli allrsquoinizio e il f 6 attualmente rimpiazzato da uno bianco) Marc gr 314 ff 235r-255r Vat gr 2326 ff 19r-40v e 43r-v (incompleto e con i fascicoli in disordine) Vat gr 184 ff 10r-23v Par gr 2390 ff 1r-13v Vat gr 198 ff 127r-136v Marc gr 310 ff 1r-13r Laur Plut 89 sup 48 ff 7r-19r
Fabio Acerbi142
ἐκθέμενοι οὖν διάγραμμα τῶν ἀριθμῶν ὡς ὑπόκειται προτάσσομεν τὸν μεριζόμενον καὶ μικρὸν ὑπ᾽ αὐτὸν τὸν μερίζοντα ὡς ἔχει τὸ διάγραμμα ἐν στίχοις διοριζομένοις ὑπὸ γραμμῶν [hellip] καὶ τὰ μὲν γινόμενα ἐγγὺς ἐλάττονα ἐν τῇ μεταξὺ θέσει τοῦ μεριζομένου καὶ τοῦ μερίζοντος ἐν στίχοις παρασημειοῦσθαι πρὸς τὸ ἀσύγχυτον εἶναι τὴν τάξιν τὰ δὲ μεθ᾿ ὧν ὁ μερίζων ἐποίει τοὺς ἀεὶ ἐλάσσονας ὑπὸ τὸν μερίζοντα σημειοῦσθαι προγράφοντας ἐπὶ τοῦ στίχου αὐτῶν τὸ γίνεται οὕτως γι ἐν δὲ τῷ στίχῳ τῶν μεριζόντων τὸ παρὰ ἔχον οὕτως oslash ἀντὶ τοῦ παρ᾿ ἃ δεῖ τὸν μερισμὸν γίνεσθαι ἐν δὲ τῷ στίχῳ τῶν ἐλασσόνων τὸ αφ διὰ τὸ τούτους ἀεὶ ἀφαιρεῖσθαι ἀπὸ τῶν ἐπάνω τῶν μεριζομένων ἐν δὲ τοῖς τοῦ μεριζομένου λοιπάσμασι τοῖς καὶ ἐπιοφείλουσι τὸ λ κατὰ τὸ ἴδιον τῶν διαστάσεων ἑκάστης ndash λέγω δὴ λοιπάδος ndash ἀντὶ τοῦ λοιποὶ οἱ μέλλοντες ἐπιμερίζεσθαι
2 post τὸν suprascr τὸν ἐλάττονα m 2 S 5 πρὸς] MP et ex corr Z κατὰ S om C | ἀσύγχυτον] MSPC -χητον Z 6 ἀεὶ] MZPC ὡσεὶ S 7 γίνεται οὕτως γι ] γι τ οὕτως γι τ M γί οὕτως γί Z γι οὕτως γί SC τὸ γινόμενον οὕτως γίνεται P 8 τὸ παρὰ ἔχον οὕτως] scripsi τὸ παρέχον οὕτως M et π(αρ-) comp Z οὕτως τὸ περιέχον S προγράφοντας οὕτως ex corr m 2 P τὸ περιέχον οὕτως C | oslash] MZSC (sed ο fecit | Z) ἐλάττων comp ex corr m 2 P | παρ᾿ ἃ] scripsi παρα M π(αρα) comp ZSC ex παρα fe-cit παρὰ et τοῦτον suprascr m 2 P 9 γίνεσθαι] comp C | αφ ] αφ ε M ἀφ ZSC ἀφαί P | ἀεὶ] om M 11 ἐπιοφείλουσι] MZSC ex ἐπιο- fecit ἐπο- m 2 P | λ] MZPC λ´ S 12 λοιποὶ] PC λοιποῦ MZS
3 στίχοις] στίχῳ K 5 πρὸς] διὰ K 7 ἐπὶ mdash γι ] τὸ γίνεται διὰ τοιούτου σ(ημείου) γί K 8 τὸ παρὰ ἔχον mdash παρ᾿ ἃ] τὸ παρᾱ διὰ σ(ημείου) τοιούτου καὶ τοῦτο oslash δηλοῦντος τοῦ παρᾱ ὅτι παρὰ τὸν τοιοῦτον (ἀριθμὸν) K 9 αφ διὰ τὸ τούτους] ἀφ δηλοῖ δὲ τοῦτο ἀφαίρεσ(ιν) ὅτι τούτους ἀεὶ δεῖ K 11 ἐπιοφείλουσι] ἐπιμερίζεσθαι ὀφείλουσι K | λ] λ οι` K 12 ἀντὶ τοῦ] δηλοῦντος τοῦ σ(ημείου) τὸ K
lsquoRendendo esplicito un diagramma numerico come lo troviamo qui sotto disponiamo in primo luogo il dividendo e un poco al di sotto di esso il divisore come li ha il diagramma in righe delimitate da linee [hellip] e lsaquooccorreragraversaquo nella posizione tra il dividendo e il divisore annotare lrsquouno accanto allrsquoaltro i piugrave vicini lsaquodei numerirsaquo minori che risultano affincheacute la disposizione non sia confusa quelli con cui il divisore faceva ogni volta i lsaquonumerirsaquo minori annotarli sotto il divisore scrivendo in prima posizione sulla loro riga laquorisultaraquo cosigrave Ris nella riga dei diviso-ri52 invece laquoperraquo fatto cosigrave53 P in luogo di laquoquelli per cui deve farsi la divisioneraquo nella riga dei lsaquonumerirsaquo minori laquosottrraquo in quanto questi sono sempre sottratti dai dividendi che si trovano sopra nei residuli del dividendo (occorre ben farlo anche per loro) laquoReraquo in accordo con ciograve
52 I laquodivisoriraquo sono al plurale ma siamo semplicemente di fronte a un tratto idioma-tico della lingua greca nel caso di espressioni generalizzanti crsquoegrave soltanto un divisore che occupa lrsquounica colonna di cui si compone la sua riga
53 Si intenda ἔχον οὕτως = ita se habens
1
5
10
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 143
che egrave proprio agli scarti di ciascuno ndash intendo qui lsaquociascunrsaquo residuo54 ndash in luogo di laquoresti che vanno a essere divisi ulteriormenteraquorsquo
a) Operatori di citazione e segni convenzionali I segni introdotti sono quattro la mia discussione egrave condotta dando per scontato che essi siano identici a quelli impiegati dallrsquoautore dei Prolegomena anche se si tratta di unrsquoipotesi non corroborabile neacute falsificabile
i Segno per il risultato Lrsquoabbreviazione convenzionale per γίνεται egrave identica al segno introdotto dallrsquoautore e i copisti si dividono tra i due errori possibili scrivere due abbreviazioni o risolverle entrambe Un fenomeno del tutto analogo si riscontra nel Matr 4678 il manoscritto alla base di tutta la tradizione degli Arithmetica di Diofanto al momen-to della definizione dellrsquoἀριθμός (lrsquolsquoincognitarsquo nel nostro linguaggio) ὁ δὲ μηδὲν τούτων τῶν ἰδιωμάτων κτησάμενος ἔχων δὲ ἐν ἑαυτῷ πλῆθος μονάδων ἄλογος ςο` καλεῖται ς` ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον τὸ ς` laquoil lsaquonumerorsaquo che non possiede nessuna di queste proprietagrave ma che ha in seacute una molteplicitagrave indefinita di unitagrave egrave chiamato lsquonumerorsquo e il suo segno egrave ς`raquo Qui solo il terzo dei tre ς ha una barra a sormontare per segnalarne il carattere puramente denotativo (cioegrave di segno convenzionale e non di abbreviazione si veda il punto successivo)55 il primo egrave una delle abbreviazioni piugrave diffuse per ἀριθμός (e infatti egrave dotato del compendio per la desinenza e dellrsquoaccento grave) il secondo egrave una delle piugrave comu-ni per καὶ () Giovanni Cortasmeno autore di capillari annotazioni infra lineam agli Arithmetica nel codice madrileno scioglie il primo ςο`
54 Doppia variatio che impiega al posto di λοιπόν laquorestoraquo i due termini decisamente non canonici τὸ λοίπασμα e ἡ λοιπάς (piugrave oltre leggiamo anche il participio λοιπασθέντα) Una ricerca sul TLG in rete non ha fornito occorrenze del primo si tratta dunque di uno hapax Quanto al secondo che ricorre anche nella sezione sulla divisione lsquoalla Papporsquo lo si rintraccia giagrave nei papiri documentari il termine diventeragrave perograve canonico nelle esposizioni bizantine drsquointroduzione allrsquoAlmagesto ricalcate sul modello dei Prolegomena (si veda la nota 87 infra) Questi due termini designano i resti parziali prodotti nel corso di una divisione lunga li ho tradotti rispettivamente con il neologismo laquoresiduloraquo e con il sostantivo pari-menti non canonico laquoresiduoraquo
55 Il copista interpreta erroneamente il terzo segno come unrsquoabbreviazione e qui ag-giunge un apice inverso (cioegrave un accento grave) altrove lo scioglie direttamente in forme opportune di ἀριθμός Matr 4678 f 58v La frase come la leggiamo nel manoscritto egrave cor-rotta sulla base di una parafrasi in Psello (edita in DOO II p 3710-12) Tannery emendograve ἄλογος in ἀόριστον DOO I p 64-5 et app Il Matritensis vergato da due copisti differenti (cambio di mano a tre righe dalla fine del f 62r) contiene lrsquoIntroductio arithmetica di Nicomaco e le opere diofantee oltre ad alcuni brevi opuscoli musicali la sua data egrave stata recentemente corretta dal XIII al secolo XI pm in Peacuterez Martiacuten 2006 (una riproduzione digitale del manoscritto si trova allrsquoindirizzo httpbdhbneesbnesearchbibliotecaDio-fanto20de20AlejandrC3ADa)
Fabio Acerbi144
in ἀριθμός ed aggiunge un altro segno56 sopra il terzo anteponendovi lrsquoindicazione καὶ ἔστιν αὐτοῦ σ(ημεῖον) τόδε Va da seacute che non abbiamo nessuna garanzia che il segno originariamente introdotto da Diofanto coincidesse realmente con unrsquoabbreviazione convenzionale per ἀριθμός Lrsquoevidenza del PMich III 144 (sec II in) suggerisce drsquoaltronde che il Matritensis e con esso tutta la tradizione medievale di Diofanto ripro-duca fedelmente pur accentuandone la sinuositagrave il segno originario
ii Segno per il divisore Un cerchiolino sbarrato da non confondere con il segno per ὁμοῦ che nei manoscritti matematici ha di norma due barre trasversali (cf tav 2a) Non sono riuscito a rintracciarne ulteriori occorrenze in altre opere la forma che esso assume nel Vat gr 2326 e la correzione apportata nel Par gr 2390 lasciano aperta la possibilitagrave per quanto a mio avviso remota che la forma originaria non fosse lon-tana da unrsquoabbreviazione di παρά registrata nei repertori57 Il correttore del Par gr 2390 trasforma in effetti il segno oslash nellrsquoaffine abbreviazione canonica per (forme di) ἐλάσσων laquominoreraquo58 e si incarica diligente-mente di farlo notare ricapitolando i segni nella porzione superiore del margine esterno del f 7v Nello stesso margine egli traccia anche uno lsquoscolio tabellarersquo ed egrave lrsquounico a porre il (proprio) segno dove indicato dalla descrizione (tav 6 Par gr 2390 f 7v) Oltre a ciograve adattando la tabella al margine ristretto lo scoliaste trascrive come colonne affian-cate le due righe dei resti parziali e dei massimi multipli e aggiunge le indicazioni ὁ μεριζόμενος laquodividendoraquo e ὁ μερίζων laquodivisoreraquo ma vi introduce alcune incongruenze di formato il risultato scritto in verti-cale e la linea verticale di sinistra che separa il divisore dal segno che lo dovrebbe precedere direttamente
iii Segno per i massimi multipli Corrisponde alla semplice abbre-viazione per sospensione della forma verbale ἄφελε laquosottrairaquo in questo
56 Si tratta del segno di ampio uso praticamente identico allrsquoabbreviazione canonica per οὖν
57 Si tratta di un pi a forma di gancio sbarrato da uno slash di troncamento Ce-reteli 1904 tav IX item 7 sub ΠΑΡΑ che rinvia al PVindRain 423 cf anche la forma π` nel POxy LXI 4142 edito in Jones 1999 II pp 26-34 In generale nei papiri e nei manoscritti matematici in maiuscola le preposizioni sono abbreviate facendo seguire un lsquoapostroforsquo alla loro prima lettera Α᾽ Υ᾽ ecc Per la seconda fattispecie di supporto libra-rio si veda in particolare il cosiddetto fragmentum mathematicum Bobiense scriptio inferior databile al V-VI secolo del palinsesto Milano Biblioteca Ambrosiana L 99 sup (Isidoro di Siviglia Etymologiae datazione Cavallo 1977 p 100) pp 113-114 che sono stampate in riproduzione apografa conforme in Belger 1881 (la p 114 egrave riprodotta anche nella tav 10 di Acerbi 2010)
58 Se questa era lrsquointenzione si tratta ovviamente di una forzatura il divisore puograve ben essere maggiore del dividendo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 145
caso lo slash di troncamento taglia orizzontalmente il tratto verticale del phi I copisti offrono molteplici varianti apponendo chi uno spirito dolce chi un ε chi un αί accentato a sormontare Tutti questi segni svolgono la funzione di abbreviazioni vere e proprie (e cosigrave doveva essere anche per lrsquoautore si veda il punto 1 di p 153 infra) la forma originale si ottiene a mio avviso incrociando i dati del Marc gr 313 e dei tre apografi del Vat gr 1594 αφ anche se lrsquoassenza dello spirito potrebbe essere semplicemente dovuta alla pratica del copista del codice veneziano di economizzare nei diacritici
iv Segno per i resti Un lambda completato da una barra a sormon-tare o da un apice che rinvia alle abbreviazioni per sospensione di una forma opportuna di λοιπός laquorestoraquo In realtagrave la forma che troviamo nella tabella egrave differente (tav 2b) e coincide con quella offerta quasi unanimemente dai manoscritti nella descrizione e in almeno un caso nella tabella del metodo di divisione attribuito a Pappo (tav 4) un lambda che accoglie al di sotto una legatura omicron-iota () sbarrata da uno slash di troncamento Qualcosa di simile si trova nel PVindob G 19996 (sec I) una specie di lambda maiuscolo molto aperto e dal vertice arrotondato che include un circoletto interpretato dagli editori come segno per περίεστιν o per λοιπόν59 Lo stesso segno si rintraccia ad esempio in un medesimo scolio tabellare di prima mano ad Alma-gestum nel Vat gr 1594 f 93v e nel Marc gr 313 f 135r ma stavolta la forma del lambda egrave molto ben definita
Fin qui i segni Ma il gioco egrave piugrave complesso La descrizione si muo-ve pericolosamente sulla linea di confine non sempre ben definita tra segno convenzionale e abbreviazione il primo ndash e il repertorio grafico matematico-astronomico ne egrave particolarmente fornito60 ndash puograve anche
59 Ho consultato lrsquoedizione Gerstinger ndash Vogel 1932 pp 46 e 48 la porzione rilevante del papiro egrave riprodotta nella tav 11 di Fowler 1999 Si veda ancora ivi pp 253-257 per la trascrizione di questo segmento di testo (con correzioni rispetto alla princeps) e per una messa a punto recente inclusa la proposta di datazione che ho riportato qui sopra Il verso del papiro che contiene una tavola aritmetica del tutto scorrelata dalla tematica del recto egrave edito come PRain Unterricht 151
60 La pratica di ridurre lo spazio occupato da un testo tecnico per mezzo di abbreviazioni e segni convenzionali era molto diffusa nei manoscritti in maiuscola contrariamente a quanto avviene per altri generi letterari vedremo tra breve cosa accade negli Arithmetica di Diofanto ma si leggano in proposito anche le considerazioni di Hei-berg nei prolegomena alla propria edizione dellrsquoAlmagesto in particolare riguardo al ricorso massiccio ad espedienti brachigrafici nel modello del Vat gr 180 POO II pp lxxxiv-xciii civ-cv cxxvii cxxxviii-cxxxix Agli elenchi dettagliati forniti da Heiberg possiamo aggiungere il piccolo prontuario stampato in Hultsch 1876-1878 III 2 pp 126-132 e basato sul testo e sugli scolii alla Collectio di Pappo nel Vat gr 218 (sec X in) Si vedano infine le osservazioni del copista del Par gr 2360 f 120v trascritte da Heiberg in AOO III pp x-xi sulle laquonotazioni tipiche a scopo di tagliar corto nello scrivereraquo impiegate nel pro-
Fabio Acerbi146
derivare dalla seconda (un caso egrave appunto il segno per ἐλάσσων che probabilmente trae origine da una legatura epsilon-lambda) ma poi il rapporto referente-relato si fissa convenzionalmente Quelli definiti nel testo che abbiamo letto sono appunto segni convenzionali non ci sarebbe bisogno di spiegarne forma e funzione se fossero intesi come abbreviazioni assumono nella tabella una funzione denotativa non esplicativa o discorsiva (come accade invece nella tav 1a) Ma come vengono descritti questi segni
I referenti delle descrizioni sono i segni sono introdotti da οὕτως (item i-ii) o in alternativa da un τό con il ruolo di lsquooperatore di citazionersquo (item iii-iv) che corrisponde esattamente alle nostre virgolette In entram-bi i casi gli enti sono menzionati e svolgono una funzione metalinguistica sono collocati materialmente nel testo ma egrave come se si trovassero fuori e la loro descrizione li additasse ndash in effetti i segni convenzionali scritti nel testo sono a loro volta i relata di quelli che si trovano nella tabella
I relata dei segni scritti nel testo sono di due tipi singoli vocaboli (item i-ii) o descrizioni della funzione dei segni per mezzo di clausole sintaticamente complesse (item ii e iv) I singoli vocaboli sono γίνεται e παρά e sono entrambi preceduti dal τό lsquocitazionalersquo in quanto relata di segni convenzionali le forme abbreviate con cui sono tracciati nei manoscritti vanno forzatamente sciolte Bisogna ammettere che la per-spicacia e le risorse grafiche dei copisti ndash di cui tutto si puograve dire fuor che commettano qui degli errori ndash sono messe a dura prova con lrsquointrodurre segni identici ad abbreviazioni o con lrsquoattivare un gioco metalinguistico particolarmente serrato in un contesto meno lsquonaturalersquo di come potreb-be esserlo ad esempio quello di un trattato grammaticale Lrsquoitem iii che presenta direttamente un segno identico ad unrsquoabbreviazione non egrave sorretto da una descrizione ma da una giustificazione in διὰ τό Lrsquoartico-lo τό vi assume una funzione metalinguistica anche se non lsquocitazionalersquo poicheacute al tempo stesso genera un infinito sostantivato e lo singolarizza per questo ho scritto laquosono sottrattiraquo in corsivo nella mia traduzione
prio modello archimedeo (nota 32 supra) egli ne compila anche una breve lista Un elenco antico di laquosegni della geometriaraquo sicuramente redatto per assistere il copista si trova anche al f 3v del ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 vergato da Efrem negli anni 950-960 (tav 8 in Acerbi 2010) Possiamo farci unrsquoidea quantitativa del guadagno di spazio in rapporto ad un testo privo di abbreviazioni e con le parole separate da spazi sulla base del fragmentum mathematicum Bobiense il testo vi egrave disposto a tutta pagina su 36 righe di circa 30 segni ciascuna nelle due pagine in questione figurano 2038 segni con 15 mezze righe occupate dalle due figure Ora nel testo dellrsquoedizione stabilita in Heiberg 1927 pp 87-90 le stesse pagine contano 4455 segni spazi compresi Ne risulta che la dimensione in caratteri di un testo matematico puograve essere ridotta di piugrave della metagrave con lrsquoimpiego di compendi e segni convenzionali
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 147
Negli item ii e iv il segno si collega ad una descrizione nel secondo caso in via esclusiva le descrizioni pertanto rinforzano o sostituiscono lrsquoidentificazione con lrsquoente linguistico denotato Le clausole descrittive sono precedute da ἀντί e dallrsquoarticolo τό con funzione di lsquooperatore di citazionersquo esse sono παρ᾿ ἃ δεῖ τὸν μερισμὸν γίνεσθαι (item ii) e λοιποὶ οἱ μέλλοντες ἐπιμερίζεσθαι (item iv) Nella descrizione della divisione lsquoalla Papporsquo che leggeremo tra breve i segni negli item iii e iv rice-vono lo stesso trattamento degli altri due il loro relatum egrave un singolo vocabolo e non una clausola descrittiva rispettivamente nelle espres-sioni τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε (sul participio ritorneremo nel punto 1 infra) e τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά (la forma del segno notato con λ οι egrave descritta supra nellrsquoitem iv) La descrizione del segno oslash per il divisore merita una discussione piugrave dettagliata In origine si trovava probabilmente scritto Π(ΑΡΑ)ΕΧΟΝ successivamente letto come π(αρ[α])έχον ndash dato che lrsquoabbreviazione per il preverbo egrave identica a quella per la preposizione (che sia Π᾽ o un pi seguito dal segno per ἄρα a sormontare) ndash invece di π(αρὰ) ἔχον I copisti e i correttori si dettero a tutte le possibili contorsioni per restituire un testo dotato di senso leggere appunto una forma verbale con preverbo modificare il preverbo (ma forse il segno per ἄρα era insidiosamente simile ad uno epsilon) correggere il testo rileggiamo lrsquoapparato sub τὸ παρὰ ἔχον οὕτως τὸ παρέχον οὕτως M et π(αρ-) comp Z οὕτως τὸ περιέχον S τὸ περιέχον οὕτως C προγράφοντας οὕτως ex corr m 2 P Nella clausola descrittiva seguente la presenza liminare di παρὰ (che ho corretto in παρ᾿ ἃ nella speranza di restituire una frase che abbia un senso senza intervenire sul testo) innesca un bel corto circuito il Π(ΑΡΑ) che sicuramente figu-rava nellrsquoarchetipo egrave un sintagma complesso una preposizione unrsquoab-breviazione o un segno per unrsquoabbreviazione Se lrsquoeditore si trova in conflitto con la propria inclinazione alla critica conservativa i copisti si rifiutarono di mettere mano ad un testo che doveva stridere anche per loro essendo il compito demandato al ritocco del revisore del Par gr 2390 o alla riscrittura radicale del recensore bizantino Il problema egrave che ci troviamo di fronte ad unrsquoespressione che descrive la funzione dellrsquooggetto denotato non lrsquooggetto stesso ma che lo contiene al suo interno per soprammercato qui il Π(ΑΡΑ) egrave usato per giustificare una menzione a sua volta relatum di un segno
Evidentemente questa maniera di procedere che giagrave aveva attirato interventi da parte di copisti e correttori della recensione di base parve insostenibilmente opaca allrsquoautore della recensione bizantina61 Egli
61 Uno dei manoscritti di questa recensione propone anche una tabella di divisione
Fabio Acerbi148
modifica tutte le descrizioni diluendo lrsquoidiomatismo dellrsquoarticolo lsquocita-zionalersquo con lrsquointroduzione sistematica del verbo δηλόω e di frasi atte a chiarire quale sia il segno denotante e quale il vocabolo (o il segno) denotato Egli introduce allo scopo di rendere esplicita la funzione de-notativa dei segni introdotti il termine σημείου curiosamente in tutte le sue tre occorrenze esso compare a sua volta nella forma dellrsquoabbrevia-zione per sospensione σΗ´ Egli traccia il segno per i massimi multipli ἀφ e quello per i resti λ οι` in modo che non vi siano ambiguitagrave quanto al loro carattere di abbreviazione Si faccia infine attenzione al residuo di barra sul παρᾱ con funzione denotativa (2 occorrenze) contenuto nella descrizione del segno per il divisore sostituita dallrsquoaccento grave nel παρὰ con funzione discorsiva (la differenza egrave nettissima nei manoscritti da me consultati) Questa osservazione ci permette di passare direttamente allrsquoitem seguente
b) Le barre sui numerali e sulle lettere denotative Egrave opportuno discutere questo punto adesso esattamente percheacute di barre siffatte che pure troviamo in tutti i manoscritti i nostri testi non fanno mai menzione si tratta infatti di una pratica condivisa sin dallrsquoantichitagrave La barra identifica una stringa di lettere dellrsquoalfabeto che non svolge una funzione grammaticale o sintattica propria allrsquointerno del discorso Ciograve avviene in particolare e si tratta della fattispecie piugrave frequente se la stringa di lettere non dagrave origine a un vocabolo della lingua greca lette-re denotative e numerali certo ma anche termini provenienti da altri idiomi e contrazioni di parole greche come i nomina sacra62 tali termi-ni possono essere o no preceduti da un articolo lsquocitazionalersquo a seconda dellrsquouso che ne viene fatto allrsquointerno del discorso Ma non si tratta dellrsquounica fattispecie i papiri grammaticali ed i manoscritti piugrave antichi dei trattati dello stesso argomento segnalano gli esempi delle parti del discorso (cioegrave di lsquoverersquo parole greche) per mezzo di barre sormontanti63 La differenza insomma egrave tra menzione e uso (come parte del discorso in atto) di una stringa di caratteri tra il porre le lsquovirgolettersquo e il non porle tra funzione denotativa e non Apparentemente la convenzione si limi-
corredata dei segni opportuni e contrariamente alle indicazioni della descrizione svilup-pata lsquoin verticalersquo ma per motivi misteriosi non completa (tav 7a Laur Plut 89 sup 48 f 13r)
62 Tutto ciograve egrave spiegato con estrema chiarezza giagrave in Traube 1907 pp 45-4763 Si veda il Par gr 2548 codex vetustissimus e testimone unico delle lsquoopere minorirsquo
di Apollonio Discolo il f 106v con le barre ben visibili egrave riprodotto come tav 19 in De Gregorio 2000 (ivi pp 137-138 per la datazione) Per la testimonianza dei papiri grammaticali si veda Wouters 1979 passim essi contengono di norma elenchi di parti del discorso nessuna delle quali egrave preceduta dallrsquoarticolo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 149
tava in questo secondo caso a segnalare con la barra singoli vocaboli le menzioni di frasi o di sintagmi complessi sono di norma identificate dallrsquoarticolo lsquocitazionalersquo Drsquoaltra parte le abbreviazioni convenzionali non rientrano nella casistica percheacute la loro resa grafica che contiene elementi non alfabetici come compendi per desinenze lettere supra li-neam marche di contrazione o sospensione quali slashes o barre sotto-poste o sormontanti eventualmente solo un sottinsieme della stringa di segni alfabetici le esclude automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
Venendo al discorso matematico una barra sormonta senza ecce-zione le lettere denotative64 che sia in papiri o in manoscritti in maiu-scola65 o minuscola ma solo allrsquointerno del testo comrsquoegrave da attendersi nei diagrammi esse la perdono per il semplice motivo che non crsquoegrave alcun testo ambiente un diagramma ha unicamente una funzione denotati-va Drsquoaltra parte le lettere numerali che a volte figurano nei diagrammi della tradizione metrica66 allo scopo di indicare la lunghezza dei seg-menti mantengono la barra in un diagramma il contesto denotativo geometrico egrave prevalente e i numerali vengono percepiti come entitagrave grafiche lsquoesternersquo al discorso Va da seacute a fortiori che le lettere numerali inserite in un testo dovranno essere segnalate da barre che a loro volta non servono nelle tavole67 in quanto queste ultime sono come abbiamo visto un vero e proprio testo che perograve funge da ambiente a quello al-fabetico limitato alle titolazioni e non a caso tracciato in unrsquoopportuna lsquomaiuscola distintivarsquo allo scopo di segnalarne il carattere denotativo e non discorsivo68 Una tabella operazionale egrave invece un paratesto e quindi le barre sulle lettere numerali che rappresentano gli interi sono
64 La notazione per le lettere denotative subigrave unrsquoevoluzione (il cui risultato finale egrave descritto per sommi capi nella nota 3 supra) di cui non mette conto occuparsi qui
65 I papiri di contenuto geometrico (o astronomici ma che presentano argomenti geometrici) sono rari si vedano il PHerc 1061 (sec II aC Demetrio Lacone De geome-tria) e il PFay 9 (sec II ex Elementi I 39 e 41) Gli importanti ostraka OBerl 12002 e 12609 (sec III aC m Elementi XIII) non pongono le barre sopra le lettere denotative Per i manoscritti in maiuscola si veda ad esempio passim nel Par gr 2389 una cui riproduzione digitale egrave consultabile in rete allrsquoindirizzo httpgallicabnffrark12148btv1b8470171d o il fragmentum mathematicum Bobiense
66 Si veda ancora il ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 codex unicus dei Metrica di Erone e contenente una raccolta importante di problemi del corpus metrologico
67 Si vedano come esempio le tavole citate alle note 10 e 14 supra Discorso a parte per il segno di lsquoposto vuotorsquo si veda il punto c che segue
68 Queste regole generali vanno prese cum grano salis si dagrave naturalmente un certo dominio di variabilitagrave legato verosimilmente al grado di cultura grafica del copista nel PMich III 144 i numerali sono quasi tutti senza barra sia nel testo che nelle tabelle ope-razionali
Fabio Acerbi150
necessarie esse mancano invece sui segni convenzionali che ho descrit-to nel punto precedente e fatto rilevante sulle lettere numerali relative agli ordini sessagesimali quando esse siano identificate da uno o piugrave apici la presenza di questo segno grafico non alfabetico69 le esclude ancora una volta automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo Unrsquoultima osservazione che ci saragrave utile nel seacuteguito la descrizio-ne di una stringa di lettere lsquoagrammaticalersquo non puograve prevedere la men-zione della presenza della barra che le pertiene in quanto tale si tratta di una pratica denotativa che egrave possibile formulare soltanto ad un livello di discorso superiore sia a quello dellrsquouso che a quello della menzione70
c) Il segno di lsquoposto vuotorsquo Si noti nella tav 2b la forma ŏ per il segno di lsquoposto vuotorsquo in un ordine sessagesimale coerentemente con la propria notazione il copista del Marc gr 313 lo scioglie talvolta allrsquoin-terno del testo principale come unrsquoabbreviazione per οὐδέν laquonienteraquo Altre convenzioni di scrittura del tratto che accompagna il circoletto e che si badi bene fa parte integrante del segno di lsquoposto vuotorsquo ndash e infatti nelle tavole troviamo sempre il segno completo mentre tutti gli altri numerali sono come abbiamo visto nel punto precedente privi di barra o di apice a causa del fatto che i vari ordini sessagesimali sono univocamente determinati dalle linee di giustificazione ndash un tratto an-golare anteposto (tav 3 Lar Plut 2818 f 136v)71 o una semplice barra a sormontare (tavv 4-9) si produce in questo modo il segno 65926 che sembra essere stata la forma di base72
69 Occorre dunque supporre come testimoniano papiri e manoscritti in maiuscola che la convenzione relativa allrsquouso della barra si sia consolidata ben prima dellrsquointroduzione di segni diacritici quali accenti e spiriti
70 Si veda il punto 2 infra per maggiori dettagli sulla questione delle barre e degli apici e per le indicazioni in merito che leggiamo in Diofanto
71 Come accennato questa tavola dei sottomultipli coincide con quella descritta ed esposta nei Prolegomena Fatto molto rilevante i numerali nella prima non recano neacute barre neacute apici contrariamente a quanto accade a tutte le istanze della seconda nei manoscritti Quella del Laur Plut 2818 preserva a mio avviso la forma originaria come abbiamo visto una tavola non richiede segni aggiuntivi sulle lettere numerali
72 Si vedano come esempio ancora le tavole citate alle note 10 e 14 supra oppure per una rassegna delle forme che il segno assume nei manoscritti piugrave antichi delle Tavole facili Tihon 2011 pp 58-59 e per quelle che assume nei papiri Jones 1999 I pp 61-62 Ovviamente non possiamo leggere il segno 65926 come un omicron con una barra in quanto ο = 70 nella notazione greca e la barra egrave di rigore quando il numerale figuri allrsquointerno di un testo Occorre ammettere che si dagrave origine ad un bel corto circuito notazionale con il concepire un segno con funzione di lsquoposto vuotorsquo ma che lsquosomigliarsquo ad una lettera dellrsquoalfabeto sormontata da una barra cioegrave ad un numerale in piugrave quando il lsquoposto vuotorsquo non corrisponda ad un intero ma ad una specie sessagesimale la presenza della barra a priori indistinguibile da quella che sormonta gli interi introduce unrsquoincongruenza con la notazione a mezzo di apici vista nellrsquoitem precedente
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 151
d) Errori di copia La tabella riprodotta nella tav 2b ha una forma simmetrica ma si tratta di una forzatura il grande rettangolo in basso a destra drsquoaltronde assente nella descrizione contiene uno scolio che fa notare come lrsquoultimo resto parziale ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ͵γτνζ´´´´´ κζ´´´´´´ cioegrave 0 0 0 0 0 3357 27 siano ἔγγιστα λ´λ´ δ´δ´ ξ laquocon ottima approssimazione 60 minuti quartiraquo dove si notino gli apici semplici per indicare il pas-saggio allrsquoordinale e il raddoppiamento del sistema segno + apice per significare il plurale Lo scolio debitamente accompagnato dal segno di rimando in forma di simbolo solare egrave stato probabilmente incluso nella tabella proprio allo scopo di renderla simmetrica A sua volta un errore precedente spiega lo spazio eccessivo accordato al rettangolo contenente lo scolio il secondo massimo multiplo ŏ λβ´ ξδ´´ ριβ´´´ σιϛ´´´´ egrave trascritto anche al di sotto del risultato
Passiamo ora alla descrizione del metodo di divisione attribuito a Pappo
ἵνα οὖν ταῦτα συναχθῇ τὰ ἐκ τοῦ μερισμοῦ ὁ εἰρημένος Πάππος εὐδιατύπῳ τινὶ καὶ πρὸς τοῦτο τάξει χρησάμενος ποιεῖται τὴν τῆς συλλήψεως τοῦ ζητουμένου ἀνεύρεσιν οὕτως ἐκθέμενος γὰρ τὸν μέλλοντα μερίζεσθαι τουτέστι τὰς τξ μοίρας ἐν ἀρχῇ ἀφαιρεῖ ἀπ᾽ αὐτῶν τὸν ἐν τῇ σελίδι τυγχάνοντα ἐλάττονα τουτέστι τὸν τδ κβ´ κ´´ ὄντα τῶν ἐγγὺς ἐλασσόνων ὡς πρὸς τοὺς ἐκκειμένους διὸ καὶ γράφει αὐτὸν προγράφων αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε καὶ εὑρίσκων τὰ παρακείμενα αὐτῷ τῷ ἀπογραφέντι ἐν τῷ σελιδίῳ λεπτὰ πρῶτα ν´ συναπογράφεται παρατιθῶν αὐτοῖς τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον ἀνατείνουσαν σημαῖνον τὸ εἶδος ὅτι πρῶτα λεπτά εὑρίσκει οὖν οὕτως τὸ τῶν τξ μέρος τὸ τδ κβ´ κ´´ ὃ μεριζόμενον παρὰ τὰς τξε ιδ´ μη´´ ἡμέρας καὶ ποιοῦν τὸν ἐκ τοῦ μερισμοῦ ἀριθμὸν πρῶτα λεπτὰ ν´ καὶ τὸν λοιπὸν ἀπογραφόμενος τὸν νε λζ´ μ´´ προτάσσει αὐτοῦ τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά τάσσει δὲ καὶ ἁπλῆν τινα διατείνουσαν γραμμὴν ὡς ἀπὸ τοῦ τξ ἐπὶ τὸν ἑξῆς ἐκτεθειμένον ἐγγὺς
1
5
10
1 εὐδιατύπῳ] ZSPC εὐδιατύπωτ M 4 ἀφαιρεῖ] MZSP ἀφ ι C 5 ἐλάττονα] P comp MZSC 6 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | αφ ] αφ ε M ἀφ ZS ἀφαί P ἄφ C | ἀντὶ] om C | ἄφελε] MZSP ἄφ C 8 ἀπογραφέντι] MZSP ἐγγραφέντι C | λεπτὰ πρῶτα] P λε πρωτα SC λεπτῶν πρωτ MZ | παρατιθῶν] MZS παρατιθεὶς C et ex corr m 2 P 9 ᾱ] Z αο P α´ MS α C | ἔχον] MPC ἔχων ZS 9-10 πρῶτα λεπτά] ZP πρωτ λ´λ´ M πρωτα λε S αα λε C 11 ἡμέρας] comp codd | ἀριθμὸν] P et comp MZ καὶ C et comp S 12 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M πρωτ λεπτ(α) Z πρωτ λ εᾱ S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C | ἀπογραφόμενος] MZSP ἐγγραφόμενος C | νε λζ´] MZSP λζ νζ C 13 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | λ οι] MZSC ex λ fecit λ οι P | προσσημαῖνον] MC et προσ- comp ZS προση- P | τὸ] MZC τὰ S et fecit m 2 P 14 ἀπὸ] MZSP πρὸς C ἐλάττονα] P comp MZSC
1 εὐδιατύπῳ] εὐδιατυπώτω K 6-7 αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ] τὸ ἀφ K 8 παρατιθῶν mdash 10 λεπτά] τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ σημαίνουσαν τὸ εἶδος αὐτῶν ὅτι ᾱ λεπτά εἰσιν K | τὸ (sec)] τὰ K 12 πρῶτα] πρώτων K | τε λ ] λ οι` K | προσσημαῖνον mdash
Fabio Acerbi152
ἐλάττονα τὸν τδ κβ´ κ´´ ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις καὶ ταύτην ἐπιδεικνύουσαν τὴν τάξιν τῆς προόδου τῆς ἐκθέσεως ἧστινος κλωμένης γραμμῆς πρὸς τῷ ἐγγὺς ἐλάσσονι ἡ ἀντανάκλασις ἐπὶ τὸν λοιπὸν γέγραπται φερομένη ὡς εἴρηται διὰ τὸ εὔτακτον τῆς προκοπῆς οὕτως τε ποιήσας ἑξῆς τὸ αφ ποιῶν ὃ προσσημαίνει ὡς εἴρηται τὸ ὅτι δεῖ ἀφελεῖν ὁμοίως ἀπὸ τοῦ λοιποῦ καὶ δὴ τὸν ἐγγὺς πάλιν ἐλάσσονα ὡς πρὸς τὴν ἐν τῷ σελιδίῳ ἔκθεσιν εὑρισκόμενον λαμβάνων ἑξῆς προγράφει αὐτὸν ὄντα νδ μζ´ ιγ´´ ιβ´´´ καὶ εὑρίσκει αὐτοῖς παρακείμενα ἐν τῷ σελιδίῳ πρῶτα λεπτὰ θ´ ἅτινα καὶ αὐτὰ προσαπογράφεται σὺν τῇ παρασημειώσει τῶν πρώτων γράφων τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον τὴν ἀνατείνουσαν καὶ ὡς εἴρηται τὴν γραμμὴν πάλιν διὰ τὴν τάξιν κλωμένην κατὰ δευτέραν κλάσιν προσέλκει γινομένου τοῦ μέρους αὐτῆς τούτου παραλλήλου τῷ ἐξ ἀρχῆς
16 ante κλωμένης add ἐπὶ C 18 τε] MZP om SC | αφ ] M ἀφ ZSC ἀφαί P 19 προσσημαίνει] MS προση- ZC et ex corr P | ὅτι] ZP comp MSC 20 δὴ] MZSC διὰ fecit m 2 P 21 πρὸς] MSP et supra lineam C ex ἀπὸ fecit m 2 Z | ιγ´´] MZSP νγ´´ C 22 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M ᾱᾱ λεπτὰ Z άάα λε S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C 23 προσαπο- γράφεται] απο suprascr in comp M 24 ᾱ] ZP α´ MS α C 25 κλάσιν] MP τάξιν ZSC | τοῦ] ZSPC τούτου M 26 τούτου] τοῦ bis ZSPC sed prius erasit m 2 P τοῦ M
mdash 18 προκοπῆς] om K | τε ποιήσας] ποιήσας καὶ K | αφ ] ἀφ K 19 τὸ] om K 21 προ-γράφει] γράφει K 22 σελιδίῳ] α´ σελιδίῳ K | ἅτινα] ἃ K 23 προσαπογράφεται] ἀπογράφεται K | τῶν πρώτων mdash 26 ἐξ ἀρχῆς] om K
lsquoAllo scopo di raccogliere ciograve che risulta dalla divisione il detto Pappo utilizzando anche in questo caso una certa disposizione ben strutturata determina nel modo seguente il lsaquonumerorsaquo cercato preso nel suo insieme collocando73 in testa il lsaquonumerorsaquo che sta per essere diviso cioegrave i 360 gradi iniziali sottrae loro tra i piugrave prossimi dei lsaquonumerirsaquo minori rispetto a quelli esposti quello che si trova essere minore nella colonna (cioegrave 304 22 20) Questo egrave il motivo per cui lo trascrive scrivendogli davanti lrsquoabbreviazio-ne laquosottrraquo per laquosottrairaquo e trovando che 50 minuti primi sono collocati accanto a quello stesso lsaquonumerorsaquo che egrave stato trascritto nella colonna li trascrive al tempo stesso collocando accanto74 ad essi la lettera A con un lsaquotrattorsaquo75 sopra che significa la specie minuti primi Trova dunque in que-sto modo la parte di 360 che egrave 304 22 20 la quale divisa per 365 giorni 14 48 fa il numero lsaquoche risultarsaquo dalla divisione 50 minuti primi Trascrivendo
73 La descrizione egrave strutturata come una procedura Acerbi 201274 Il purismo del correttore del Par gr 2390 di Clostomalle nel Marc gr 314 e
dellrsquoautore della recensione bizantina impone loro di modificare la terminazione ma forme tematiche e contratte di τιθεῖν sono correnti nel greco tardivo
75 Il testo greco ha solo il participio con γραμμήν sottinteso Per il significato del participio si veda il punto 2
15
20
25
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 153
poi il resto 55 37 40 gli pone altresigrave76 a prefisso laquoReraquo che significa laquorestiraquo e dispone anche una certa linea semplice77 che va da 360 al piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori che egrave esposto di seacuteguito 304 22 20 come nello lsaquoschemarsaquo esposto linea che mostra lrsquoordine del percorso dellrsquoesposizione Questa linea spezzata lagrave dove si trova il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori egrave tracciata inflessa allrsquoindietro lsaquoersaquo punta verso il resto come egrave stato detto in vista di una progressione ordinata E cosigrave facendo prendendo di seacuteguito il laquosottrraquo che significa come egrave stato detto laquoche occorre similmente sottrarre dal re-storaquo e ovviamente prendendo di nuovo il lsaquonumerorsaquo che egrave trovato essere il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori in relazione alla disposizione nella colonna ndash 54 47 13 12 ndash lo scrive di seacuteguito e trova che 9 minuti primi sono posti loro accanto nella colonna trascrive78 anche questi con la segnaletica dei primi scrivendo la lettera A con un lsaquotrattorsaquo sopra e come egrave stato detto prolunga di nuovo la linea spezzata in vista di una buona disposizione tramite una seconda inflessione essendo questa sua parte parallela a quella inizialersquo
La descrizione continua con una serie di laquoe cosigrave viaraquo e non fa ulte-riore riferimento alla tabella
1) La forma verbale ἐξεσμένον Egrave il neutro del participio perfetto medio-passivo di ξέω lett laquopialloraquo laquolevigoraquo Si danno tre possibilitagrave si tratta di un termine canonico per quanto non altrove attestato per designare unrsquoabbreviazione oppure lrsquoautore anonimo improvvisa sul piano metaforico come se unrsquoabbreviazione non fosse altro che la paro-la completa lsquoaccorciata a colpi di piallarsquo in maniera opportuna oppure il testo egrave corrotto e srsquoimpone una correzione ad esempio τὸ ἑξῆς μένον laquociograve che sta di seacuteguitoraquo Questrsquoultima strada mi pare chiusa dal senso delle frase lrsquoabbreviazione non lsquosta di seacuteguitorsquo a niente ma anzi precede la perifrasi τὸ ἑξῆς μένον se impiegata semplicemente per rimandare al segno αφ immediatamente seguente costituirebbe un intollerabile solecismo Se accettiamo la prima di queste letture considerando quin-di lrsquoabbreviazione αφ in posizione predicativa abbiamo a che fare con
76 Rendo in questo modo il τε isolato77 La linea egrave laquosempliceraquo in quanto egrave una retta la precisazione intende evidenziare per
anticipazione il carattere lsquonon semplicersquo che essa assumeragrave alla prima inflessione quando diventeragrave una spezzata linee siffatte erano in effetti concepite dallrsquoanonimo e prima di lui da tutta la tradizione matematica greca come una singola linea spezzata nei punti drsquoinfles-sione I due segmenti paralleli menzionati al termine del passo sono orizzontali
78 Il verbo egrave al medio in variatio rispetto ai due che precedono e che seguono egrave il matematico che lsquosirsquo trascrive le cifre
Fabio Acerbi154
uno hapax semantico nella grecitagrave superstite come egrave facile verificare con una ricerca sul TLG in rete La recensione bizantina risolve il pro-blema sopprimendo semplicemente τὸ ἐξεσμένον
2) La notazione per le specie numeriche Nella terminologia matema-tica greca gli ordini sessagesimali sono εἴδη laquospecieraquo numerici essi corri- spondono agli ordini di grandezza nel nostro sistema decimale e indica-no in analogia con il caso geometrico la lsquoformarsquo che assume un numero quadrato cubo ecc Centinaia e migliaia sono quindi degli εἴδη rispet-tivamente quadrati (100 egrave il quadrato di 10) e cubi (1000 egrave il cubo di 10) sono specie numeriche ma non numeri particolari e drsquoaltronde 300 non egrave un quadrato ma 3 item dellrsquoεἶδος lsquoquadratorsquo 100 3 egrave il numerale di molteplicitagrave della specie quadrata lsquocentinaiarsquo i due 0 che seguono il 3 segnalano esattamente questo fatto che la notazione greca per gli interi non posizionale fa scomparire al livello denotativo Ciograve non vale soltan-to per i numeri interi ma anche per le loro parti i minuti secondi appar-tengono alla specie lsquoquadratorsquo in quanto 13600 egrave il quadrato di 160
La concezione appare interamente dispiegata nellrsquointroduzione degli Arithmetica diofantei79 che si rivela giova farlo rimarcare un te-stimone fondamentale per la ricostruzione della notazione matematica antica Alle specie usate in questrsquoopera vengono assegnati una denomi-nazione ed un segno convenzionale costituito dallrsquoiniziale (di ognuno dei componenti) della denominazione al quadrato o δύναμις il segno ΔΥ al κύβος il segno ΚΥ alla lsquoquarta potenzarsquo o δυναμοδύναμις il segno ΔΥΔ ecc La descrizione di tali segni egrave del tipo καὶ ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον Κ ἐπίσημον ἔχον Υ ΚΥ κύβος laquoe il suo segno egrave un Κ che ha come indice un Υ ΚΥ cuboraquo dove in accordo con quanto abbiamo visto nel punto b supra e pur nel comprensibile imbarazzo del copista della prima parte del Matritensis (o di un suo passato collega) a districarsi in questo formidabile ginepraio notazionale80 le due lettere Κ e Υ ricevono una barra mentre ΚΥ non la richiede a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον il quale ancora una volta esclude automaticamente il segno dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
79 In particolare a DOO I pp 214-62180 Nel Matr 4678 riscontriamo i seguenti fenomeni nelle poche righe a cavallo dei ff
58r-v 1) accento acuto posto su tutti i segni come se fossero abbreviazioni 2) ripetizione sistematica segnodenominazione come in ΚΥ κύβος appena letto dovuta sicuramente allrsquointrusione di glosse interlineari esplicative dei segni ndash e successivo pentimento (δύναμις e κύβος sono in effetti cancellati dalla prima mano il primo con un tratto il secondo con dei punti supra lineam poi il copista si stanca di correggere) 3) nella descrizione del segno per la δυναμοδύναμις menzione di un δέλτα δύο che saragrave molto probabilmente stato ΔΔ subito dopo nella descrizione del κυβόκυβος si legge un incongruo δύο KK
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 155
Diofanto introduce poi dei segni anche per le specie delle parti dellrsquounitagrave (le nostre frazioni) che egli chiama ὁμώνυμα μορία laquoparti omonimeraquo di cui quelle sessagesimali sono casi particolari81 Egli spie-ga appunto che le loro denominazioni sono ottenute da quelle delle specie degli interi per sinonimia passando ad un lsquoordinalersquo82 formato semplicemente aggiungendo il suffisso -στον δυναμοστόν κυβοστόν δυναμοδυναμοστόν ecc (sott μόριον) I loro segni convenzionali sono invece ottenuti da quelli per le specie degli interi aggiungendo una γραμμὴν διαστέλλουσαν τὸ εἶδος laquolinea che distingue la specieraquo83 Una linea sui segni delle specie delle parti egrave richiesta si badi bene per distinguerli dai segni di quelle degli interi come giagrave osservato questi ultimi sono giagrave lsquoagrammaticalirsquo a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον a fortiori lo saranno anche i primi Si tratta della traduzione semio-tica del passaggio dal cardinale allrsquoordinale che a livello grammaticale egrave effettuato con il suffisso -στον Che forma ha questa linea Barra o apice (Egrave cervellotico pensare a forme piugrave complesse) La domanda non ammette una risposta immediata in quanto delle specie diofantee nessuno piugrave si occupa nellrsquoantichitagrave84 Se egrave vero che la prima risposta darebbe origine ad un conflitto tra due convenzioni denotative diffe-renti la barra lsquocitazionalersquo e la barra che distingue la specie lrsquoevidenza grafica del Matritensis lascia lievemente sgomenti (ricordiamoci che giagrave i segni di base sono indebitamente dotati di un accento dal copista) Le poche occorrenze del segno per le specie delle parti85 vedono lrsquoaggiunta di uno slash di sospensione di un doppio apice inverso ndash in tutta evi-
81 Questo fatto era giagrave chiaro nellrsquoantichitagrave Teone in Alm I 10 in iA p 45310-1682 Il parallelo con i cardinali e gli ordinali relativi agli interi egrave reso esplicito da Dio-
fanto ὥσπερ δὲ τῶν ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια παρομοίως καλεῖται τοῖς ἀριθμοῖς τοῦ μὲν τρία τὸ τρίτον τοῦ δὲ τέσσαρα τὸ τέταρτον οὕτως καὶ τῶν νῦν ἐπονομασθέντων ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια κληθήσεται παρομοίως τοῖς ἀριθμοῖς laquocome le parti omonime dei numeri sono chia-mate per assonanza con i numeri di lsquotrersquo lsquolsaquounrsaquo terzorsquo di lsquoquattrorsquo lsquolsaquounrsaquo quartorsquo cosigrave le parti omonime dei numeri appena nominati saranno chiamate per assonanza con i numeriraquo (DOO I p 69-13 si noti lrsquoarticolo lsquocitazionalersquo al singolare in τοῦ τρία e τοῦ τέσσαρα) Il parallelo prosegue anche al livello dei segni che rappresentano queste specie come vedremo tra un attimo
83 Diofanto Arithmetica prefazione in DOO I p 620-21 un passaggio maltrattato in questa edizione occorre espungere il participio ἔχον senza introdurre segni ulteriori oppure eliminare un precedente ἐπί come fa un correttore del Matritensis f 58v
84 Unica parzialissima eccezione lrsquoaccenno di Teone menzionato nella nota 81 supra85 Al f 59r e per di piugrave nel margine per sanare un lungo saut du mecircme au mecircme La
collocazione in margine egrave il motivo per cui troviamo una notazione abbreviata nel resto del trattato il primo copista scioglie tutti i segni prendendoli per abbreviazioni mentre il secondo elimina sistematicamente il tratto aggiuntivo delle specie delle parti dellrsquounitagrave Drsquoaltronde egli scrive ad esempio ΔΥ invece di ΔΥ ed egrave quindi indotto a porre la barra al di sopra della stringa di lettere risultante (passim ma si veda ad esempio il f 72r)
Fabio Acerbi156
denza il compendio per la desinenza -ον accentata il copista interpreta il segno come unrsquoabbreviazione ndash e di una barra a sormontare lo Υ Potremmo forse interpretarlo come il segno di contrazione del grafema -στ- lrsquounico tassello mancante in unrsquoabbreviazione come ad esempio (δυναμοδυναμο)(στ)(ὸν) ma uno scolio di prima mano al f 58v rela-tivo alle specie degli interi inficia questrsquoipotesi esse sono dotate di slash di sospensione accento acuto in un caso del compendio canonico per la terminazione -ον hellip ma tutti gli Υ a esponente sono a loro volta sormontati da una barra
Meno legata al singolo manoscritto ma nondimeno non uniforme si presenta la pratica di notazione dei segni che rappresentano gli enti numerici sessagesimali86 da una parte sta lrsquoevidenza del testo dei Pro-legomena e delle sue tabelle apici ndash drsquoaltronde come abbiamo visto la notazione universalmente impiegata per i numerali ordinali e per le fra-zioni unitarie ndash dallrsquoaltra sta lrsquoevidenza del testo dellrsquoAlmagesto in tutti i manoscritti piugrave antichi e lo stesso si dica del commentario teonino a questrsquoopera o del suo lsquoGrande commentariorsquo alle Tavole facili e dei testi astronomici su papiro barre87 Sembra insomma che la nostra docu-
86 Sia le molteplicitagrave che le specie ahimeacute entrambe rappresentate da lettere dellrsquoalfabeto Come osservato allrsquoinizio della sezione 3 ci sono in effetti due tipi di lettere numerali in gioco se facciamo astrazione da apici o barre lsquo4 minuti secondirsquo si trova scritto δ β la prima lettera numerale denota la molteplicitagrave degli item di una certa specie la se-conda la specie nei Prolegomena entrambe sono accompagnate da un doppio apice il che rende inutile la presenza delle seconde Si noti che la descrizione della tabella non fa parola della notazione da usare per le lettere numerali che denotano la molteplicitagrave barre o apici e quanti apici hellip In questo caso fa interamente fede la tabella cioegrave la pratica grafica condivisa instauratasi non egrave chiaro quando
87 I manoscritti piugrave antichi dellrsquoAlmagesto sono menzionati nella nota 10 supra quelli dei due commentarii teonini sono il Laur Plut 2818 e il celeberrimo Vat gr 190 (sec IX in Euclide Elementi Data Teone lsquoGrande commentariorsquo) per la notazione dei pa-piri astronomici si veda Jones 1999 II passim La notazione non sembra lsquoinquinatarsquo dalla pratica dei copisti bizantini e pare dipendere soltanto dalla data di composizione Tro-viamo ad esempio barre sopra tutti i numerali di molteplicitagrave (interi o sessagesimali) nel frammento di un commentario alle Tavole facili contenente un calcolo relativo al 24 aprile 213 (Par gr 2841 sec XIII ex-XIV in oltre al frammento ai ff 32r l 11-34v l 23 contiene Arato Phaenomena ed Efestione Apotelesmatica edizione in Jones 1990) Nel commentario alle Tavole facili composto ca 610-617 ed attribuito a Stefano di Alessandria la situazione egrave la seguente (Jean Lempire per litteras per lrsquoedizione si veda Lempire 2014 ho controllato il Vat gr 304 ff 135r-171v sec XIV am contiene in aggiunta Teone in Almagestum I-II lsquoPiccolo commentariorsquo alle Tavole facili Diofanto Arithmetica e De polygo-nis numeris varia astronomica tabulae) barre sopra gli interi sporadicamente rimpiazzate da apici apici sopra le parti sessagesimali in numero uguale alla denominazione doppio () apice per le frazioni unitarie Sono impiegate barre sopra gli interi e apici sopra le parti sessagesimali nei manoscritti principali di tutti i trattati di introduzione allrsquoAlmagesto o comunque di argomento logistico redatti in epoca bizantina Giorgio Pachimere (1242-ca 1310) Quadrivium (autografo nel manoscritto Roma Biblioteca Angelica gr 38 [RGK III nr 115] si veda Tannery ndash Steacutephanou 1940 per lrsquoedizione) Teodoro Metochita (1270-
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 157
mentazione si faccia testimone di un cambio notazionale avvenuto nel periodo intercorrente fra Teone (sec IV pm) e la scuola alessandrina di Ammonio e dei suoi allievi (sec VI in) e probabilmente innescato da questrsquoultimo ambiente lrsquoaspetto paradossale egrave che nello stesso codice si rintraccino due notazioni differenti per gli enti numerici sessagesimali e lrsquouna (apici) sia adottata sistematicamente e coerentemente in uno scritto (i Prolegomena) che si presenta esattamente come unrsquointroduzione tecnica alla pratica numerico-algoritmica del trattato (lrsquoAlmagesto) in cui egrave adottata lrsquoaltra (barre che ritroviamo senza eccezioni anche negli scolii)
Torniamo ai Prolegomena la descrizione del segno da porre a fianco di ogni singolo quoziente parziale e denotante la sua specie numerica (minuti primi minuti secondi ecc) solleva tre problemi
Primo problema Ci vuole una barra o un apice su τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquola lettera A [hellip] che significa la specieraquo quando lo scriviamo nella tabella Tutta la nostra discussione precedente fa pro-pendere per lrsquoapice e si ricordi anche la forma verbale ἀνατείνουσαν che suggerisce qualcosa che si lsquoestende verso lrsquoaltorsquo (la mia traduzione egrave volutamente neutra) se fosse apposta una barra la cosa dovrebbe passare
1231332) Compendium astronomicum (copia lsquoautorizzatarsquo coeva nei Vat gr 182 e 181 da parte del copista che integrograve le parti mancanti del Par gr 2389 [ff 207-210 255-270 374-375] Bianconi 2005a pp 425-427 Peacuterez Martiacuten 2008 p 436 e n 177) Teodoro Meliteniota (morto lrsquo831393) Tribiblos astronomica (autografo nel Vat gr 792 si vedano Leurquin 1991 per unrsquoanalisi del manoscritto Leurquin 1990 per lrsquoedizione) una com-pilazione anonima (per cui ho consultato il Par gr 2396 ff 87r-92v limitatamente a questi fogli manu Costantino Trivoli [RGK II nr 318 ma ovviamente questo codice non vi egrave segnalato] terzo quarto del XV secolo il resto del codice annotato da Niceforo Gregora egrave di etagrave planudea e parzialmente [ff 33v-76v] un autografo di Planude stesso contiene Teone in Almagestum I II IV Mondrain 2002 il codice va completato ndash limitatamente a stralci dei libri VIII-X XII-XIII del commentario teonino la cui parte intermedia si egrave persa ndash con 26 carte [ff 123-147] inserite nel Vat gr 1087 anchrsquoesso contenente anno-tazioni di Gregora Rome 1927 per la figura del copista dei ff 77r-86r del Par gr 2396 e dei ff appena nominati del Vat gr 1087 un anonimo collaboratore di Gregora si veda in ultimo Bianconi 2006a pp 147-151) si veda anche il calcolo effettuato da Niceforo Gre-gora (12921295-13581361) dellrsquoeclisse di sole del 16 luglio 1330 (attestata unicamente ai ff 1r-8v della miscellanea astronomica Marc gr 325 databile ca 1324-1329 in parte vergata e ovunque fittamente annotata da Gregora stesso edizione del testo in Mogenet et al 1983 annotazioni di Gregora elencate in Bianconi 2005a p 413) Unrsquoeccezione apparente il lsquoPiccolo commentariorsquo di Teone alle Tavole facili le parti sessagesimali sono segnalate da apici (ad esempio nel Vat gr 175 vergato da Giovanni Catrario e completato nel 1321-1322 sulla figura di Catrario si vedano in ultimo Bianconi 2005b pp 141-156 e 2006b) lrsquoopera egrave antica ma la sua tradizione non rimonta oltre la fine del XIII secolo a parte un frammento nel Leiden BPG 78 ff 156r-161v (minuscola del IX-X secolo) e in effetti in questo manoscritto tutti i numerali di molteplicitagrave sono sormontati da barre Unrsquoeccezione effettiva egrave il De hypotesibus planetarum nel Vat gr 1594 barre sugli interi e apici sulle parti sessagesimali
Fabio Acerbi158
sotto silenzio e la presenza dellrsquoapice la rende inutile88 Si tratta della stessa convenzione diofantea e coincide ancora con la notazione per i numerali ordinali e per le frazioni unitarie che egrave corrente nei mano- scritti matematici greci per questo motivo non percheacute la descrizione sia particolarmente perspicua nessuno dei copisti della recensione an-tica ha incertezze apici Ma questi apici si rintracciano soltanto sulle indicazioni di specie non contemplate dalla descrizione che sono ante-poste ai resti parziali a fianco dei quozienti parziali i segni di specie sono invece trasformati in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordi-nali corrispondenti del tipo πρωτ tavv 5 e 7b-8 Il recensore bizantino taglia invece la testa al toro elimina dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali elimina la seconda menzione della laquolet-tera Araquo contestualmente allrsquoazzeramento dellrsquoespediente della linea a zig-zag (si veda il punto seguente) modifica la descrizione che contiene la prima menzione in quella dellrsquoapice associato direttamente ai nume-rali di molteplicitagrave riciclando addirittura lrsquoalpha per adibirlo a desi-gnare un numero cardinale (come sorprendersi) τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ laquoponendo al di sopra di essi [scil dei 50 minuti primi] 1 solo lsaquoaccentorsaquo acutoraquo La scelta del recensore egrave assennata che rechi una barra o un apice in una tabella un alpha denota un numero non un numero drsquoordine
Secondo problema da tenere ben distinto dal precedente Cosa ci vuole sul segno α per la lettera alpha menzionata nella frase τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquolettera A [hellip] che significa la specieraquo89 Unrsquooc-chiata allrsquoapparato critico rivela una bella incertezza nei manoscritti Z scrive sempre ᾱ e in un caso lo fa anche P MS optano sempre per α´ C per α P scrive nellrsquoaltro caso αο Per quanto solo la barra sia congrua con il senso della frase in quanto la lettera alpha egrave qui menzionata (si tratta di un oggetto che compare nella tabella) e non cambia niente se essa egrave accompagnata dal suo nome di genere στοιχεῖον ad un livello grafico lrsquoincertezza fra il segno ᾱ che denota laquola lettera αraquo e il segno α´ (o lrsquoabbreviazione αο) per una forma di πρῶτος egrave per piugrave versi giustificata
88 Detto in altri termini la barra egrave uno strumento grafico non matematico e quindi la sua presenza non va segnalata mentre un apice lo egrave e la sua presenza lo deve
89 Notare che in questa frase il primo α non vuole la barra (egrave menzionato allrsquointerno di una frase che impiega convenzioni moderne) il secondo sigrave (idem ma con convenzioni antiche) ndash e nella traduzione la scelta di denotarlo con A (senza virgolette) e non con lsquoArsquo (con virgolette) egrave del tutto arbitraria ndash si noti inoltre che le necessarie precisazioni laquosenzacon virgoletteraquo mostrano che le lingue moderne palesano difficoltagrave analoghe a quelle del greco antico per quanto riguarda i livelli denotativi in ambito metadiscorsivo per non usare le due parentetiche avrei dovuto scrivere rispettivamente lsquoArsquo e lsquolsquoArsquorsquo (doppie virgolette semplici)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 159
ᾱ coincide con il numerale 1 α egrave la prima lettera dellrsquoalfabeto ed inoltre α´ egrave esattamente quello che va scritto nella tabella Potremmo dirci che il sostantivo στοιχεῖον chiude la questione la sua presenza congiunta ad un ipotetico α´ renderebbe la descrizione ridondante o inappropriata90 Ma a parte il fatto che α egrave proprio τὸ πρῶτον στοιχεῖον il segno α´ cat-tura in fondo il cuore della descrizione di uno στοιχεῖον ἔχον lsaquoγραμμὴνrsaquo ἀνατείνουσαν
Terzo problema Lrsquoautore dei Prolegomena che si arresta allrsquoesem-pio dei minuti primi non dice quanti apici occorre mettere sulle lettere numerali che identificano gli ordini superiori al primo se uno soltanto come nel caso diofanteo e delle frazioni unitarie o in numero uguale alla loro denominazione (cioegrave pari al numero denotato dal numerale stesso su cui vanno posti) come effettivamente avviene nei mano-scritti dei Prolegomena La tabella egrave quindi sottodeterminata dalla sua descrizione anzi in un certo senso prende il sopravvento su di essa la pratica di marcare i numerali di molteplicitagrave con gli apici che compe-tono allrsquoordine cui appartengono viene trasferita ai segni per gli ordini stessi per supplire ad una descrizione carente di questi ultimi E la tabella egrave sottodeterminata dalla descrizione in quanto egrave la descrizione di una tabella reale ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις laquocome nello lsaquoschemarsaquo espostoraquo leggiamo a un certo punto del testo
3) La linea a zig-zag Non possiamo che applaudire a questo geniale espediente grafico lo troviamo messo in opera solo nel Marc gr 313 Per quanto lrsquoautore non faccia parola di ciograve nel corso della sua descrizione la linea spezzata egrave intesa dover lsquosaltarersquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue Il copista del codice marciano effettua correttamente due salti nella prima delle sue tabelle (tav 4) ma inserisce un lsquodentersquo in piugrave in quella che considera corretta (tav 5) La linea a zig-zag egrave incompatibile con la presenza di linee di giustificazione nella tabella che in effetti mancano nel Marc gr 313 ciograve induce gli errori di allineamento dei primi 5 quozienti parziali di cui egrave vittima il copista Probabilmente per questo motivo in nessuno degli apografi del Vat gr 1594 la linea a zig-zag figura nella tabella inquadrata come si conviene da una (doppia) cornice esterna e le cui colonne sono appunto separate da linee verticali (tav 7b Vat gr 184 f 17v e tav 8 Par gr 2390 f 9v cui egrave sostanzialmente identica la tabella del Marc gr 314 che si trova
90 Trascuro lrsquoabbreviazione αο = πρῶτος percheacute la desinenza non egrave quella richiesta neacute nella frase (egrave richiesto πρῶτον) neacute nella tabella (πρῶτα)
Fabio Acerbi160
al f 248r ndash ma la mancanza di linee orizzontali causa un gigantesco pa-sticcio nel codice vaticano) Alla recensione bizantina che dipende per il suo testo di base dal Vat gr 1594 e quindi non trova la linea a zig-zag nella tabella non resta che sopprimere la sua descrizione ndash ma proprio per questo motivo e finalmente diventa possibile tracciare un apparato completo di linee di giustificazione (tav 9 Laur Plut 89 sup 48 f 14v) Dato che la descrizione di Teone di questo procedimento di divi-sione non fa cenno allrsquoesistenza della linea a zig-zag viene da chiedersi se essa non costituisca un espediente escogitato dallrsquoautore dei Prolegomena per vivacizzare la procedura originale di Pappo
4) Discrepanze tra descrizione e tabella Il gioco delle minime va-rianti mostra che la divisione era stata eseguita (e trasmessa) corret-tamente tutti i valori numerici sono esatti La tabella nel Marc gr 313 presenta perograve alcune discrepanze con la propria descrizione Essa omette (ma non nella versione lsquoscorrettarsquo lrsquoomissione non si riscontra neanche nel Par gr 2390) il segno per laquorestoraquo di fronte ai resti par-ziali ma aggiunge lrsquoindicazione della loro specie Essa trasforma invece come abbiamo visto le indicazioni di specie che seguono i quozienti parziali in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordinali corri-spondenti La descrizione prevede di chiudere la tabella con il risultato καὶ συνάγων ἅπαντα τὰ ἐκ τῶν μερισθέντων μερῶν λεπτὰ σημειοῦται ὑπὸ πάντας οὕτως γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoe raccogliendo tutti i minuti che provengono dalle parti divise lsaquoPapporsaquo nota sotto tutto cosigrave Ris 0 59 8 17 13 12 31raquo ma sotto la tabella tutta la tradizione ci consegna qualcosa di piugrave articolato ὁ ζητούμενος καθ᾽ ὃν μερίζεται ὁ τξε ιδ´ μη´´ π(αρὰ) τὸν τξ γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoil lsaquonumerorsaquo cercato secondo cui 365 14 48 egrave diviso per 360 risulta 0 59 8 17 13 12 31raquo frase che del resto contiene due errori lrsquoinversione del dividendo e del divisore e la confusione tra segno convenzionale (iuxta descrizione) e abbreviazione (come nella frase) nel caso di γι Oltre ad eliminare la linea a zig-zag91 la recensione bizantina sopprime dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali e modifica come abbiamo visto al punto 2 le loro descrizioni in quelle di apici associati diretta-mente ai numerali di molteplicitagrave
91 Le due righe che nella recensione di base contengono solo i resti parziali minori di 160 del divisore ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue sono in parte completate con lrsquoindicazione abbreviata ἀνάλ(υσις) laquoanalisiraquo il termine greco per questa procedura di riduzione In un sussulto di ipercorrettismo matematico tali resti parziali ridotti non sono preceduti dal segno per laquorestoraquo come nel Par gr 2390 ma da quello per laquorisultatoraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 161
Gli esempi che abbiamo discusso mostrano come i problemi di notazione pesino e non poco sullrsquoespressione discorsiva di un algorit-mo matematico lrsquoente di riferimento per lsquoformularersquo il procedimento di divisione fu considerata la tabella cioegrave un oggetto la cui costitu-zione egrave legata piugrave ad una pratica grafica che a considerazioni logico- algoritmiche non la sua descrizione che in effetti finisce per determi-nare la tabella in maniera non univoca Di questa sottodeterminazione si fa testimone la traiettoria che abbiamo cercato di seguire nelle mani di copisti e revisori il procedimento di divisione si modifica a volte in aspetti secondari a volte in punti piugrave sostanziali ndash fino a rendere neces-saria una radicale revisione della sua descrizione per renderla conforme alla tabella ndash in ogni caso mai per ragioni squisitamente matematiche92
Abstract
The article presents and discusses in detail two passages from the anonymous Prolegomena to the Almagest a VIth century primer to the elementary procedures of calculation needed in Ptolemyrsquos Almagest In the two passages we may follow the complex interplay between mathematical notation the auctor who employed and described it the tachygrapher who transcribed it in vivo copyists who reproduced it correctors who modified it Along this path misgivings and errors arise in the transmission of abbreviations and paratextual units such as diagrams tables operational schemes
Fabio AcerbiCNRS UMR8560 Centre Alexandre Koyreacute
fabacerbigmailcom
92 Sono grato a Daniele Bianconi Lucio del Corso Jean Lempire per alcune preziose indicazioni
AOO = Archimedis opera omnia cum commentariis Eutocii ed J L Heiberg I-III Lipsiae 1910-1915
DOO = Diophanti Alexandrini opera omnia cum Graecis commentariis ed P Tannery I-II Lipsiae 1893-1895
GC = Le laquoGrand Commentaireraquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Mogenet ndash A Tihon I-III Cittagrave del Vaticano 1985-1999
iA = Commentaires de Pappus et de Theacuteon drsquoAlexandrie sur lrsquoAlmageste ed A Rome I-III con paginazione continua Cittagrave del Vaticano 1931-1943
HOO = Heronis Alexandrini opera quae supersunt omnia ed G Schmidt ndash L Nix ndash W Schmidt ndash H Schoene ndash J L Heiberg I-V Lipsiae 1899-1914
PC = Le ldquoPetit Commentairerdquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed A Tihon Cittagrave del Vaticano 1978
POO = Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia ed J L Heiberg I-II in 3 parti Lipsiae 1898-1907
RGK = Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600 I Handschriften aus Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln II Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs und Nachtraumlge zu den Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln III Handschriften aus Bibliotheken Roms mit dem Vatikan A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg unter Mitarbeit von D Harlfinger und P Eleuteri B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln Wien 1981-1997 (Oumlsterreichische Akademie der Wissenschaften Veroumlffentlichungen der Kommission fuumlr Byzantinistik III1-3 A-C)
Sigla
Acerbi 2010 = F Acerbi Il silenzio delle sirene La matematica greca antica Roma 2010
Acerbi 2012 = F Acerbi I codici stilistici della matematica greca dimostrazioni procedure algoritmi laquoQUCCraquo 1012 (2012) pp 167-214
Acerbi et al 2010 = F Acerbi ndash N Vinel ndash B Vitrac Les Proleacutegomegravenes agrave lrsquoAlmageste Une eacutedition agrave partir des manuscrits les plus anciens Introduction geacuteneacuterale ndash Parties I-III laquoSCIAMVSraquo 11 (2010) pp 53-210
Agati 1992 = M L Agati La minuscola laquoBouleteacuteeraquo Cittagrave del Vaticano 1992
Belger 1881 = C Belger Ein neues Fragmentum mathematicum Bobiense laquoHermesraquo 16 (1881) pp 261-284
Bianconi 2005a = D Bianconi La biblioteca di Cora tra Massimo Planude e Niceforo Gregora Una questione di mani laquoSampTraquo 3 (2005) pp 391-438
Bianconi 2005b = D Bianconi Tessalonica nellrsquoetagrave dei Paleologi Le pratiche intellettuali nel riflesso della cultura scritta Paris 2005
Bianconi 2006a = D Bianconi Le pietre e il ponte ovvero identificazioni di mani e storia della cultura laquoBizantinisticaraquo 8 (2006) pp 135-181
Bianconi 2006b = D Bianconi Qualcosa di nuovo su Giovanni Catrario laquoMEGraquo 6 (2006) pp 69-91
Cavallo 1977 = G Cavallo Funzione e strutture della maiuscola greca tra i secoli VIII-XI in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Colloque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 95-137
Cereteli 1904 = G F Cereteli De compendiis scripturae codicum Graecorum praecipue Petropolitanorum et Mosquensium anni nota instructorum Sankt-Petersburg 1904
De Gregorio 2000 = G De Gregorio Materiali vecchi e nuovi per uno studio della minu-scola greca fra VII e IX secolo in G Prato (a cura di) I manoscritti greci tra riflessione e dibattito Atti del V Colloquio Internazionale di Paleografia Greca Cremona 4-10 ottobre 1998 Firenze 2000 pp 83-151
Follieri 1977 = E Follieri La minuscola libraria dei secoli IX e X in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Col-loque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 139-165
Fonkič 2005 = B Fonkič Venecianskaia rukopisrsquo laquoAlrsquomagestaraquo Ptolemeja (Marc gr 313690) o datirovke i proischoždenii kodeksa laquoVDIraquo s III 254 (2005) pp 162-167
Fowler 1999 = D H Fowler The Mathematics of Platorsquos Academy A New Reconstruction Second Edition Oxford 1999
Bibliografia
Fabio Acerbi164
Gerstinger ndash Vogel 1932 = H Gerstinger ndash K Vogel Eine stereometrische Aufgaben-sammlung im Papyrus Graecus [sic] Vindobonensis 19996 laquoMitteilungen aus der Papy-russammlung der Nationalbibliothek in Wienraquo Neue Serie Folge 1 Griechische literarische Papyri 1 Wien 1932 pp 11-76
Heiberg 1927 = Mathematici Graeci Minores ed J L Heiberg Kjoslashbenhavn 1927
Hultsch 1876-1878 = Pappi Alexandrini Collectionis quae supersunt ed F Hultsch I-III Berlin 1876-1878
Janz 2003 = T Janz The Scribes and the Date of the Vat gr 1291 in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae X Cittagrave del Vaticano 2003 pp 159-180
Jones 1990 = Ptolemyrsquos First Commentator ed A Jones Philadelphia 1990
Jones 1999 = Astronomical Papyri from Oxyrhynchus ed A Jones I-II Philadelphia 1999
Jones 2005 = A Jones Ptolemyrsquos Canobic Inscription and Heliodorusrsquo Observation Reports laquoSCIAMVSraquo 6 (2005) pp 53-97
Lempire 2014 = Steacutephanos drsquoAlexandrie Le commentaire aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Lempire Louvain 2014
Leurquin 1990 = Theacuteodore Meacuteliteacuteniote Tribiblos astronomique Livre I ed R Leurquin Amsterdam 1990
Leurquin 1991 = R Leurquin Un manuscrit autographe de la Tribiblos Astronomique de Theacuteodore Meacuteliteacuteniote le Vaticanus graecus 792 laquoScriptoriumraquo 45 (1991) pp 145-162
Maas 1927 = P Maas Griechische Palaeographie in A Gercke ndash E Norden (hrsg von) Einleitung in die Altertumswissenschaft I9 Leipzig 1927 pp 69-80
Martinelli Tempesta 2010 = S Martinelli Tempesta Il codice Milano Biblioteca Am-brosiana B 75 sup (gr 104) e lrsquoevoluzione della scrittura di Giovanni Scutariota in A B Garciacutea ndash I Peacuterez Martiacuten (ed by) The Legacy of Bernard de Montfaucon Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting Proceedings of the Seventh Inter-national Colloquium of Greek Palaeography Madrid-Salamanca 15-20 September 2008 Turnhout 2010 pp 171-186
Mazzucchi 1994 = C M Mazzucchi Leggere i classici durante la catastrofe (Costantino-poli maggio-agosto 1203) le note marginali al Diodoro Siculo Vaticano gr 130 Parte prima stratigrafia laquoAevumraquo 68 (1994) pp 164-218
Mioni 1976 = E Mioni Bessarione scriba e alcuni suoi collaboratori in Miscellanea marcia-na di studi bessarionei Padova 1976 pp 263-323
Mioni 1985 = Codices graeci manuscripti Bibliothecae Divi Marci Venetiarum II Thesaurus Antiquus Codices 300-625 recensuit E Mioni Roma 1985
Mogenet 1962 = J Mogenet Une scholie ineacutedite du Vat gr 1594 sur les rapports entre lrsquoastronomie arabe et Byzance laquoOsirisraquo 14 (1962) pp 198-221
Mogenet et al 1983 = Niceacutephore Greacutegoras Calcul de lrsquoeacuteclipse de soleil du 16 juillet 1330 ed J Mogenet ndash A Tihon ndash R Royez ndash A Berg Amsterdam 1983
Mondrain 2002 = B Mondrain Maxime Planude Niceacutephore Greacutegoras et Ptoleacutemeacutee laquoPa-laeoslavicaraquo 10 (2002) pp 312-322
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 165
Mondrain 2004 = B Mondrain Lrsquoancien empereur Jean VI Cantacuzegravene et ses copistes in A Rigo (a cura di) Gregorio Palamas e oltre Studi e documenti sulle controversie teologiche del XIV secolo bizantino Firenze 2004 pp 249-296
Mondrain 2007 = B Mondrain Les eacutecritures dans les manuscrits byzantins du XIV e siegravecle Quelques probleacutematiques laquoRSBNraquo n s 44 (2007) pp 157-196
Peacuterez Martiacuten 2006 = I Peacuterez Martiacuten Maxime Planude et le Diophantus Matritensis (Madrid Biblioteca Nacional ms 4678) un paradigme de la reacutecupeacuteration des textes anciens dans la ldquorenaissance paleacuteologuerdquo laquoByzantionraquo 76 (2006) pp 433-462
Peacuterez Martiacuten 2008 = I Peacuterez Martiacuten El lsquoestilo Hodegosrsquo y su proyeccioacuten en las escrituras constantinopolitanas laquoSampTraquo 6 (2008) pp 389-458
Perria 1991 = L Perria Scrittura e ornamentazione nei codici della laquocollezione filosoficaraquo laquoRSBNraquo n s 28 (1991) pp 45-111
Rollo 2012 = A Rollo LrsquoArchimede di Giorgio Valla in V Fera ndash D Gionta ndash A Rollo (a cura di) Archimede e le sue fortune Atti del Convegno di Siracusa-Messina 24-26 giugno 2008 Messina 2012 pp 99-147
Rome 1927 = A Rome Membra disjecta laquoRBenraquo 39 (1927) pp 187-188
Rome 1938 = A Rome Un manuscrit de la bibliothegraveque de Boniface VIII agrave la Meacutediceacuteenne de Florence laquoACraquo 7 (1938) pp 261-268
Ronconi 2013 = F Ronconi La collection philosophique un fantocircme historique laquoScripto-riumraquo 67 (2013) pp 119-140
Tannery ndash Steacutephanou 1940 = Quadrivium de Georges Pachymegravere ed P Tannery ndash E Steacutephanou Cittagrave del Vaticano 1940
Tihon 2011 = Πτολεμαίου Πρόχειροι Κανόνες Les Tables faciles de Ptoleacutemeacutee vol Ia Tables A1-A2 ed A Tihon Leuven 2011
Traube 1907 = L Traube Nomina Sacra Versuch einer Geschichte der christlichen Kuumlrzung Muumlnchen 1907
Vogel 1936 = K Vogel Beitraumlge zur griechischen Logistik laquoSBAWraquo Mathematisch-natur-wissenschaftliche Abteilung Jahrgang 1936 pp 357-472
Wouters 1979 = A Wouters The Grammatical Papyri from Graeco-Roman Egypt Contri-butions to the Study of the lsquoArs Grammaticarsquo in Antiquity Brussel 1979
F ACERBI Tav 1
b Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 65r
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 284 f 160r
F ACERBITav 2
b Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 13r
a Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 19v
F ACERBI Tav 3
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 136v
F ACERBITav 4
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17r
F ACERBI Tav 5
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17v
F ACERBITav 6
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 7v
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
Fabio Acerbi140
greco qual egrave il suo range E come distinguerlo nei casi ambigui da un semplice articolo che precede un sostantivo quando questrsquoultimo lo ri-chieda Nel corso del processo di copia del testo della descrizione infine possono generarsi tensioni tra enti grafici interpretabili vuoi come segno convenzionale vuoi come abbreviazione Ambiguitagrave relative a questi punti opacizzano la descrizione Un problema analogo si porrebbe a priori nella dialettica tra uso delle lettere denotative per designare enti geometrici e loro menzione nella costruzione di un diagramma ma esso egrave risolto con lrsquoazzeramento della seconda funzione le lettere denota-tive sono sempre usate allrsquointerno del testo (sono cioegrave il referente degli oggetti geometrici di cui tratta il discorso matematico) mai menzionate (come accadrebbe se fossero il referente di oggetti grafici posti nel dia-gramma) Insomma il codice adottato per la costituzione dei diagrammi geometrici egrave condiviso (cioegrave canonizzato) semplice e perspicuo mentre quello per le tabelle operazionali non lo egrave da qui le sviste dei copisti e le trascuratezze di correttori ed editori
Infine chi vuole apprendere da questi testi come eseguire una divi-sione a cosa deve prestar fede se ad esempio a causa di errori di copia la descrizione finisce per non coincidere con la tabella operazionale visto che sono entrambe due maniere valide di eseguire lo stesso algoritmo Dopo tutto lo scopo di tutta questa macchina grafico-argomentativa egrave di insegnare a eseguire divisioni in formato tabellare Questo problema si fa particolarmente acuto se la tabella non egrave trasparente nel metodo di Pappo lo egrave quasi completamente in quello anonimo no E gli errori che riscontreremo nella (doppia) tabella ai ff 17r-v del Marc gr 313 a chi sono attribuibili Allrsquoautore al trascrittore o al copista medievale
Questo groviglio di problemi riceve alcune risposte sorprendenti dalla tradizione manoscritta come andiamo finalmente a vedere
4 Analisi delle testimonianze
I codici che ho adibito per lrsquoedizione sono i seguenti M = Marc gr 31346 C = Marc gr 314 (Tolomeo Tetrabiblos et opera minora cum commentariis Vezio Valente Anthologiae)47 Z = Vat gr 2326 (fattizio
46 Riferibile al sec IX ex-X in accolgo la datazione suggeritami per litteras il 522005 da Nigel G Wilson si veda anche Agati 1992 pp 141-142 La presenza non sistematica degli accenti che fa anticipare a Wilson la datazione di laquosaec X medraquo fornita in Mioni 1985 p 24 indusse Boris Fonkič (2005 non vidi) ad assegnare il codice allrsquoinizio del IX secolo
47 Il manoscritto riferibile alla seconda o terza decade della prima metagrave del XIV secolo fu vergato da Michele Clostomalle olim lsquoMetochitesschreiberrsquo Bianconi 2005a pp 428-430 Il titolo dei Prolegomena in questa trascrizione identico in grafia ma non in formulazione a
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 141
e mutilo Tolomeo Almagestum) S = Vat gr 184 (varia astronomica scholia miscellanea ad Almagestum Tolomeo Almagestum) P = Par gr 2390 (varia astronomica) gli ultimi tre riferibili allo scorcio del XIII secolo48 e apografi sicuri del Vat gr 159449 attualmente mutilo di due fascicoli che ci privano dei due terzi finali dei Prolegomena M e il Vat gr 1594 ammettono un modello comune il resto della tradizione (25 trascrizioni in tutto) dipende dagli apografi appena citati del Vat gr 1594 Le varianti della recensione bizantina che leggiamo tra lrsquoaltro nei Vat gr 198 Marc gr 310 (Tolomeo Almagestum cum commentariis Pappi Theonis et Cabasilae) e con ulteriori modifiche Laur Plut 89 sup 48 (varia astronomica Tolomeo Almagestum Barlaam Logistica) sono identificate dal siglum K e si trovano punteggiatura originale in-clusa nel secondo apparato50 Lrsquoanalisi delle testimonianze51 costituite ovviamente anche dalle tabelle associate saragrave condotta nella forma di una sequenza di osservazioni indicizzate da numerali o lettere oltre che di alcune note a piersquo di pagina
Iniziamo dalla descrizione del metodo di divisione anonimo
quello che leggiamo nel Vat gr 1594 (questrsquoultimo coincide con quello adottato nella recen-sione bizantina) fu apposto da Niceforo Gregora e successivamente corretto da Bessarione
48 Sto studiando il primo e il terzo codice in collaborazione rispettivamente con Daniele Bianconi e Inmaculada Peacuterez Martiacuten
49 Su questo codice risalente alla seconda metagrave del IX secolo e sulla sua collocazione nella lsquocollezione filosoficarsquo per prima proposta in Follieri 1977 pp 145-146 si vedano almeno Perria 1991 pp 82-88 Ronconi 2013 Che il titolo dei Prolegomena nel Vat gr 1594 sia stato apposto da Niceforo Gregora egrave stato riconosciuto per la prima volta in Mazzucchi 1994 p 211 n 196 si veda Bianconi 2005a p 418 per altri interventi di Gregora nello stesso manoscritto
50 Il Vat gr 198 egrave stato vergato dal copista Malachia nel corso del terzo quarto del XIV secolo Mondrain 2004 pp 278-290 e 292 Allo stesso copista (denominato non a caso prima dellrsquoidentificazione anonymus Aristotelicus) dobbiamo un buon numero di trascrizioni aristoteliche con i relativi commentari in margine Gli dobbiamo anche il Par gr 2342 secondo tomo di un quadrivium quasi completo di cui il Vat gr 198 egrave il primo nellrsquoordine aritmetica armonica astronomia (Almagesto e commentari relativi) nel codice vaticano geometria ed ancora astronomia (corpus astronomico minore) in quello parigino le opere trascritte sono sempre accompagnate in margine dai relativi commentari Il copista del Marc gr 310 egrave Isacco Argiro (ca 1300-1375) Mondrain 2007 p 166 Allo stesso Argiro dobbiamo il codice laurenziano (Daniele Bianconi per litteras) Poicheacute la recensione modificata che leggiamo nel Laur Plut 89 sup 48 egrave senza alcun dubbio basata su quella nel Marc gr 310 e non viceversa ci troviamo di fronte ad un copista che trascrive due volte lo stesso testo in due versioni leggermente differenti la conclusione naturale egrave che la seconda recensione egrave dovuta ad Argiro stesso la questione andragrave studiata in dettaglio
51 Nei manoscritti citati i Prolegomena si trovano ai fogli seguenti Vat gr 1594 ff 1r-8v (mutilo mancano due fascicoli su tre) Marc gr 313 ff 1r-28r (incompleto man-cano due fogli allrsquoinizio e il f 6 attualmente rimpiazzato da uno bianco) Marc gr 314 ff 235r-255r Vat gr 2326 ff 19r-40v e 43r-v (incompleto e con i fascicoli in disordine) Vat gr 184 ff 10r-23v Par gr 2390 ff 1r-13v Vat gr 198 ff 127r-136v Marc gr 310 ff 1r-13r Laur Plut 89 sup 48 ff 7r-19r
Fabio Acerbi142
ἐκθέμενοι οὖν διάγραμμα τῶν ἀριθμῶν ὡς ὑπόκειται προτάσσομεν τὸν μεριζόμενον καὶ μικρὸν ὑπ᾽ αὐτὸν τὸν μερίζοντα ὡς ἔχει τὸ διάγραμμα ἐν στίχοις διοριζομένοις ὑπὸ γραμμῶν [hellip] καὶ τὰ μὲν γινόμενα ἐγγὺς ἐλάττονα ἐν τῇ μεταξὺ θέσει τοῦ μεριζομένου καὶ τοῦ μερίζοντος ἐν στίχοις παρασημειοῦσθαι πρὸς τὸ ἀσύγχυτον εἶναι τὴν τάξιν τὰ δὲ μεθ᾿ ὧν ὁ μερίζων ἐποίει τοὺς ἀεὶ ἐλάσσονας ὑπὸ τὸν μερίζοντα σημειοῦσθαι προγράφοντας ἐπὶ τοῦ στίχου αὐτῶν τὸ γίνεται οὕτως γι ἐν δὲ τῷ στίχῳ τῶν μεριζόντων τὸ παρὰ ἔχον οὕτως oslash ἀντὶ τοῦ παρ᾿ ἃ δεῖ τὸν μερισμὸν γίνεσθαι ἐν δὲ τῷ στίχῳ τῶν ἐλασσόνων τὸ αφ διὰ τὸ τούτους ἀεὶ ἀφαιρεῖσθαι ἀπὸ τῶν ἐπάνω τῶν μεριζομένων ἐν δὲ τοῖς τοῦ μεριζομένου λοιπάσμασι τοῖς καὶ ἐπιοφείλουσι τὸ λ κατὰ τὸ ἴδιον τῶν διαστάσεων ἑκάστης ndash λέγω δὴ λοιπάδος ndash ἀντὶ τοῦ λοιποὶ οἱ μέλλοντες ἐπιμερίζεσθαι
2 post τὸν suprascr τὸν ἐλάττονα m 2 S 5 πρὸς] MP et ex corr Z κατὰ S om C | ἀσύγχυτον] MSPC -χητον Z 6 ἀεὶ] MZPC ὡσεὶ S 7 γίνεται οὕτως γι ] γι τ οὕτως γι τ M γί οὕτως γί Z γι οὕτως γί SC τὸ γινόμενον οὕτως γίνεται P 8 τὸ παρὰ ἔχον οὕτως] scripsi τὸ παρέχον οὕτως M et π(αρ-) comp Z οὕτως τὸ περιέχον S προγράφοντας οὕτως ex corr m 2 P τὸ περιέχον οὕτως C | oslash] MZSC (sed ο fecit | Z) ἐλάττων comp ex corr m 2 P | παρ᾿ ἃ] scripsi παρα M π(αρα) comp ZSC ex παρα fe-cit παρὰ et τοῦτον suprascr m 2 P 9 γίνεσθαι] comp C | αφ ] αφ ε M ἀφ ZSC ἀφαί P | ἀεὶ] om M 11 ἐπιοφείλουσι] MZSC ex ἐπιο- fecit ἐπο- m 2 P | λ] MZPC λ´ S 12 λοιποὶ] PC λοιποῦ MZS
3 στίχοις] στίχῳ K 5 πρὸς] διὰ K 7 ἐπὶ mdash γι ] τὸ γίνεται διὰ τοιούτου σ(ημείου) γί K 8 τὸ παρὰ ἔχον mdash παρ᾿ ἃ] τὸ παρᾱ διὰ σ(ημείου) τοιούτου καὶ τοῦτο oslash δηλοῦντος τοῦ παρᾱ ὅτι παρὰ τὸν τοιοῦτον (ἀριθμὸν) K 9 αφ διὰ τὸ τούτους] ἀφ δηλοῖ δὲ τοῦτο ἀφαίρεσ(ιν) ὅτι τούτους ἀεὶ δεῖ K 11 ἐπιοφείλουσι] ἐπιμερίζεσθαι ὀφείλουσι K | λ] λ οι` K 12 ἀντὶ τοῦ] δηλοῦντος τοῦ σ(ημείου) τὸ K
lsquoRendendo esplicito un diagramma numerico come lo troviamo qui sotto disponiamo in primo luogo il dividendo e un poco al di sotto di esso il divisore come li ha il diagramma in righe delimitate da linee [hellip] e lsaquooccorreragraversaquo nella posizione tra il dividendo e il divisore annotare lrsquouno accanto allrsquoaltro i piugrave vicini lsaquodei numerirsaquo minori che risultano affincheacute la disposizione non sia confusa quelli con cui il divisore faceva ogni volta i lsaquonumerirsaquo minori annotarli sotto il divisore scrivendo in prima posizione sulla loro riga laquorisultaraquo cosigrave Ris nella riga dei diviso-ri52 invece laquoperraquo fatto cosigrave53 P in luogo di laquoquelli per cui deve farsi la divisioneraquo nella riga dei lsaquonumerirsaquo minori laquosottrraquo in quanto questi sono sempre sottratti dai dividendi che si trovano sopra nei residuli del dividendo (occorre ben farlo anche per loro) laquoReraquo in accordo con ciograve
52 I laquodivisoriraquo sono al plurale ma siamo semplicemente di fronte a un tratto idioma-tico della lingua greca nel caso di espressioni generalizzanti crsquoegrave soltanto un divisore che occupa lrsquounica colonna di cui si compone la sua riga
53 Si intenda ἔχον οὕτως = ita se habens
1
5
10
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 143
che egrave proprio agli scarti di ciascuno ndash intendo qui lsaquociascunrsaquo residuo54 ndash in luogo di laquoresti che vanno a essere divisi ulteriormenteraquorsquo
a) Operatori di citazione e segni convenzionali I segni introdotti sono quattro la mia discussione egrave condotta dando per scontato che essi siano identici a quelli impiegati dallrsquoautore dei Prolegomena anche se si tratta di unrsquoipotesi non corroborabile neacute falsificabile
i Segno per il risultato Lrsquoabbreviazione convenzionale per γίνεται egrave identica al segno introdotto dallrsquoautore e i copisti si dividono tra i due errori possibili scrivere due abbreviazioni o risolverle entrambe Un fenomeno del tutto analogo si riscontra nel Matr 4678 il manoscritto alla base di tutta la tradizione degli Arithmetica di Diofanto al momen-to della definizione dellrsquoἀριθμός (lrsquolsquoincognitarsquo nel nostro linguaggio) ὁ δὲ μηδὲν τούτων τῶν ἰδιωμάτων κτησάμενος ἔχων δὲ ἐν ἑαυτῷ πλῆθος μονάδων ἄλογος ςο` καλεῖται ς` ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον τὸ ς` laquoil lsaquonumerorsaquo che non possiede nessuna di queste proprietagrave ma che ha in seacute una molteplicitagrave indefinita di unitagrave egrave chiamato lsquonumerorsquo e il suo segno egrave ς`raquo Qui solo il terzo dei tre ς ha una barra a sormontare per segnalarne il carattere puramente denotativo (cioegrave di segno convenzionale e non di abbreviazione si veda il punto successivo)55 il primo egrave una delle abbreviazioni piugrave diffuse per ἀριθμός (e infatti egrave dotato del compendio per la desinenza e dellrsquoaccento grave) il secondo egrave una delle piugrave comu-ni per καὶ () Giovanni Cortasmeno autore di capillari annotazioni infra lineam agli Arithmetica nel codice madrileno scioglie il primo ςο`
54 Doppia variatio che impiega al posto di λοιπόν laquorestoraquo i due termini decisamente non canonici τὸ λοίπασμα e ἡ λοιπάς (piugrave oltre leggiamo anche il participio λοιπασθέντα) Una ricerca sul TLG in rete non ha fornito occorrenze del primo si tratta dunque di uno hapax Quanto al secondo che ricorre anche nella sezione sulla divisione lsquoalla Papporsquo lo si rintraccia giagrave nei papiri documentari il termine diventeragrave perograve canonico nelle esposizioni bizantine drsquointroduzione allrsquoAlmagesto ricalcate sul modello dei Prolegomena (si veda la nota 87 infra) Questi due termini designano i resti parziali prodotti nel corso di una divisione lunga li ho tradotti rispettivamente con il neologismo laquoresiduloraquo e con il sostantivo pari-menti non canonico laquoresiduoraquo
55 Il copista interpreta erroneamente il terzo segno come unrsquoabbreviazione e qui ag-giunge un apice inverso (cioegrave un accento grave) altrove lo scioglie direttamente in forme opportune di ἀριθμός Matr 4678 f 58v La frase come la leggiamo nel manoscritto egrave cor-rotta sulla base di una parafrasi in Psello (edita in DOO II p 3710-12) Tannery emendograve ἄλογος in ἀόριστον DOO I p 64-5 et app Il Matritensis vergato da due copisti differenti (cambio di mano a tre righe dalla fine del f 62r) contiene lrsquoIntroductio arithmetica di Nicomaco e le opere diofantee oltre ad alcuni brevi opuscoli musicali la sua data egrave stata recentemente corretta dal XIII al secolo XI pm in Peacuterez Martiacuten 2006 (una riproduzione digitale del manoscritto si trova allrsquoindirizzo httpbdhbneesbnesearchbibliotecaDio-fanto20de20AlejandrC3ADa)
Fabio Acerbi144
in ἀριθμός ed aggiunge un altro segno56 sopra il terzo anteponendovi lrsquoindicazione καὶ ἔστιν αὐτοῦ σ(ημεῖον) τόδε Va da seacute che non abbiamo nessuna garanzia che il segno originariamente introdotto da Diofanto coincidesse realmente con unrsquoabbreviazione convenzionale per ἀριθμός Lrsquoevidenza del PMich III 144 (sec II in) suggerisce drsquoaltronde che il Matritensis e con esso tutta la tradizione medievale di Diofanto ripro-duca fedelmente pur accentuandone la sinuositagrave il segno originario
ii Segno per il divisore Un cerchiolino sbarrato da non confondere con il segno per ὁμοῦ che nei manoscritti matematici ha di norma due barre trasversali (cf tav 2a) Non sono riuscito a rintracciarne ulteriori occorrenze in altre opere la forma che esso assume nel Vat gr 2326 e la correzione apportata nel Par gr 2390 lasciano aperta la possibilitagrave per quanto a mio avviso remota che la forma originaria non fosse lon-tana da unrsquoabbreviazione di παρά registrata nei repertori57 Il correttore del Par gr 2390 trasforma in effetti il segno oslash nellrsquoaffine abbreviazione canonica per (forme di) ἐλάσσων laquominoreraquo58 e si incarica diligente-mente di farlo notare ricapitolando i segni nella porzione superiore del margine esterno del f 7v Nello stesso margine egli traccia anche uno lsquoscolio tabellarersquo ed egrave lrsquounico a porre il (proprio) segno dove indicato dalla descrizione (tav 6 Par gr 2390 f 7v) Oltre a ciograve adattando la tabella al margine ristretto lo scoliaste trascrive come colonne affian-cate le due righe dei resti parziali e dei massimi multipli e aggiunge le indicazioni ὁ μεριζόμενος laquodividendoraquo e ὁ μερίζων laquodivisoreraquo ma vi introduce alcune incongruenze di formato il risultato scritto in verti-cale e la linea verticale di sinistra che separa il divisore dal segno che lo dovrebbe precedere direttamente
iii Segno per i massimi multipli Corrisponde alla semplice abbre-viazione per sospensione della forma verbale ἄφελε laquosottrairaquo in questo
56 Si tratta del segno di ampio uso praticamente identico allrsquoabbreviazione canonica per οὖν
57 Si tratta di un pi a forma di gancio sbarrato da uno slash di troncamento Ce-reteli 1904 tav IX item 7 sub ΠΑΡΑ che rinvia al PVindRain 423 cf anche la forma π` nel POxy LXI 4142 edito in Jones 1999 II pp 26-34 In generale nei papiri e nei manoscritti matematici in maiuscola le preposizioni sono abbreviate facendo seguire un lsquoapostroforsquo alla loro prima lettera Α᾽ Υ᾽ ecc Per la seconda fattispecie di supporto libra-rio si veda in particolare il cosiddetto fragmentum mathematicum Bobiense scriptio inferior databile al V-VI secolo del palinsesto Milano Biblioteca Ambrosiana L 99 sup (Isidoro di Siviglia Etymologiae datazione Cavallo 1977 p 100) pp 113-114 che sono stampate in riproduzione apografa conforme in Belger 1881 (la p 114 egrave riprodotta anche nella tav 10 di Acerbi 2010)
58 Se questa era lrsquointenzione si tratta ovviamente di una forzatura il divisore puograve ben essere maggiore del dividendo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 145
caso lo slash di troncamento taglia orizzontalmente il tratto verticale del phi I copisti offrono molteplici varianti apponendo chi uno spirito dolce chi un ε chi un αί accentato a sormontare Tutti questi segni svolgono la funzione di abbreviazioni vere e proprie (e cosigrave doveva essere anche per lrsquoautore si veda il punto 1 di p 153 infra) la forma originale si ottiene a mio avviso incrociando i dati del Marc gr 313 e dei tre apografi del Vat gr 1594 αφ anche se lrsquoassenza dello spirito potrebbe essere semplicemente dovuta alla pratica del copista del codice veneziano di economizzare nei diacritici
iv Segno per i resti Un lambda completato da una barra a sormon-tare o da un apice che rinvia alle abbreviazioni per sospensione di una forma opportuna di λοιπός laquorestoraquo In realtagrave la forma che troviamo nella tabella egrave differente (tav 2b) e coincide con quella offerta quasi unanimemente dai manoscritti nella descrizione e in almeno un caso nella tabella del metodo di divisione attribuito a Pappo (tav 4) un lambda che accoglie al di sotto una legatura omicron-iota () sbarrata da uno slash di troncamento Qualcosa di simile si trova nel PVindob G 19996 (sec I) una specie di lambda maiuscolo molto aperto e dal vertice arrotondato che include un circoletto interpretato dagli editori come segno per περίεστιν o per λοιπόν59 Lo stesso segno si rintraccia ad esempio in un medesimo scolio tabellare di prima mano ad Alma-gestum nel Vat gr 1594 f 93v e nel Marc gr 313 f 135r ma stavolta la forma del lambda egrave molto ben definita
Fin qui i segni Ma il gioco egrave piugrave complesso La descrizione si muo-ve pericolosamente sulla linea di confine non sempre ben definita tra segno convenzionale e abbreviazione il primo ndash e il repertorio grafico matematico-astronomico ne egrave particolarmente fornito60 ndash puograve anche
59 Ho consultato lrsquoedizione Gerstinger ndash Vogel 1932 pp 46 e 48 la porzione rilevante del papiro egrave riprodotta nella tav 11 di Fowler 1999 Si veda ancora ivi pp 253-257 per la trascrizione di questo segmento di testo (con correzioni rispetto alla princeps) e per una messa a punto recente inclusa la proposta di datazione che ho riportato qui sopra Il verso del papiro che contiene una tavola aritmetica del tutto scorrelata dalla tematica del recto egrave edito come PRain Unterricht 151
60 La pratica di ridurre lo spazio occupato da un testo tecnico per mezzo di abbreviazioni e segni convenzionali era molto diffusa nei manoscritti in maiuscola contrariamente a quanto avviene per altri generi letterari vedremo tra breve cosa accade negli Arithmetica di Diofanto ma si leggano in proposito anche le considerazioni di Hei-berg nei prolegomena alla propria edizione dellrsquoAlmagesto in particolare riguardo al ricorso massiccio ad espedienti brachigrafici nel modello del Vat gr 180 POO II pp lxxxiv-xciii civ-cv cxxvii cxxxviii-cxxxix Agli elenchi dettagliati forniti da Heiberg possiamo aggiungere il piccolo prontuario stampato in Hultsch 1876-1878 III 2 pp 126-132 e basato sul testo e sugli scolii alla Collectio di Pappo nel Vat gr 218 (sec X in) Si vedano infine le osservazioni del copista del Par gr 2360 f 120v trascritte da Heiberg in AOO III pp x-xi sulle laquonotazioni tipiche a scopo di tagliar corto nello scrivereraquo impiegate nel pro-
Fabio Acerbi146
derivare dalla seconda (un caso egrave appunto il segno per ἐλάσσων che probabilmente trae origine da una legatura epsilon-lambda) ma poi il rapporto referente-relato si fissa convenzionalmente Quelli definiti nel testo che abbiamo letto sono appunto segni convenzionali non ci sarebbe bisogno di spiegarne forma e funzione se fossero intesi come abbreviazioni assumono nella tabella una funzione denotativa non esplicativa o discorsiva (come accade invece nella tav 1a) Ma come vengono descritti questi segni
I referenti delle descrizioni sono i segni sono introdotti da οὕτως (item i-ii) o in alternativa da un τό con il ruolo di lsquooperatore di citazionersquo (item iii-iv) che corrisponde esattamente alle nostre virgolette In entram-bi i casi gli enti sono menzionati e svolgono una funzione metalinguistica sono collocati materialmente nel testo ma egrave come se si trovassero fuori e la loro descrizione li additasse ndash in effetti i segni convenzionali scritti nel testo sono a loro volta i relata di quelli che si trovano nella tabella
I relata dei segni scritti nel testo sono di due tipi singoli vocaboli (item i-ii) o descrizioni della funzione dei segni per mezzo di clausole sintaticamente complesse (item ii e iv) I singoli vocaboli sono γίνεται e παρά e sono entrambi preceduti dal τό lsquocitazionalersquo in quanto relata di segni convenzionali le forme abbreviate con cui sono tracciati nei manoscritti vanno forzatamente sciolte Bisogna ammettere che la per-spicacia e le risorse grafiche dei copisti ndash di cui tutto si puograve dire fuor che commettano qui degli errori ndash sono messe a dura prova con lrsquointrodurre segni identici ad abbreviazioni o con lrsquoattivare un gioco metalinguistico particolarmente serrato in un contesto meno lsquonaturalersquo di come potreb-be esserlo ad esempio quello di un trattato grammaticale Lrsquoitem iii che presenta direttamente un segno identico ad unrsquoabbreviazione non egrave sorretto da una descrizione ma da una giustificazione in διὰ τό Lrsquoartico-lo τό vi assume una funzione metalinguistica anche se non lsquocitazionalersquo poicheacute al tempo stesso genera un infinito sostantivato e lo singolarizza per questo ho scritto laquosono sottrattiraquo in corsivo nella mia traduzione
prio modello archimedeo (nota 32 supra) egli ne compila anche una breve lista Un elenco antico di laquosegni della geometriaraquo sicuramente redatto per assistere il copista si trova anche al f 3v del ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 vergato da Efrem negli anni 950-960 (tav 8 in Acerbi 2010) Possiamo farci unrsquoidea quantitativa del guadagno di spazio in rapporto ad un testo privo di abbreviazioni e con le parole separate da spazi sulla base del fragmentum mathematicum Bobiense il testo vi egrave disposto a tutta pagina su 36 righe di circa 30 segni ciascuna nelle due pagine in questione figurano 2038 segni con 15 mezze righe occupate dalle due figure Ora nel testo dellrsquoedizione stabilita in Heiberg 1927 pp 87-90 le stesse pagine contano 4455 segni spazi compresi Ne risulta che la dimensione in caratteri di un testo matematico puograve essere ridotta di piugrave della metagrave con lrsquoimpiego di compendi e segni convenzionali
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 147
Negli item ii e iv il segno si collega ad una descrizione nel secondo caso in via esclusiva le descrizioni pertanto rinforzano o sostituiscono lrsquoidentificazione con lrsquoente linguistico denotato Le clausole descrittive sono precedute da ἀντί e dallrsquoarticolo τό con funzione di lsquooperatore di citazionersquo esse sono παρ᾿ ἃ δεῖ τὸν μερισμὸν γίνεσθαι (item ii) e λοιποὶ οἱ μέλλοντες ἐπιμερίζεσθαι (item iv) Nella descrizione della divisione lsquoalla Papporsquo che leggeremo tra breve i segni negli item iii e iv rice-vono lo stesso trattamento degli altri due il loro relatum egrave un singolo vocabolo e non una clausola descrittiva rispettivamente nelle espres-sioni τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε (sul participio ritorneremo nel punto 1 infra) e τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά (la forma del segno notato con λ οι egrave descritta supra nellrsquoitem iv) La descrizione del segno oslash per il divisore merita una discussione piugrave dettagliata In origine si trovava probabilmente scritto Π(ΑΡΑ)ΕΧΟΝ successivamente letto come π(αρ[α])έχον ndash dato che lrsquoabbreviazione per il preverbo egrave identica a quella per la preposizione (che sia Π᾽ o un pi seguito dal segno per ἄρα a sormontare) ndash invece di π(αρὰ) ἔχον I copisti e i correttori si dettero a tutte le possibili contorsioni per restituire un testo dotato di senso leggere appunto una forma verbale con preverbo modificare il preverbo (ma forse il segno per ἄρα era insidiosamente simile ad uno epsilon) correggere il testo rileggiamo lrsquoapparato sub τὸ παρὰ ἔχον οὕτως τὸ παρέχον οὕτως M et π(αρ-) comp Z οὕτως τὸ περιέχον S τὸ περιέχον οὕτως C προγράφοντας οὕτως ex corr m 2 P Nella clausola descrittiva seguente la presenza liminare di παρὰ (che ho corretto in παρ᾿ ἃ nella speranza di restituire una frase che abbia un senso senza intervenire sul testo) innesca un bel corto circuito il Π(ΑΡΑ) che sicuramente figu-rava nellrsquoarchetipo egrave un sintagma complesso una preposizione unrsquoab-breviazione o un segno per unrsquoabbreviazione Se lrsquoeditore si trova in conflitto con la propria inclinazione alla critica conservativa i copisti si rifiutarono di mettere mano ad un testo che doveva stridere anche per loro essendo il compito demandato al ritocco del revisore del Par gr 2390 o alla riscrittura radicale del recensore bizantino Il problema egrave che ci troviamo di fronte ad unrsquoespressione che descrive la funzione dellrsquooggetto denotato non lrsquooggetto stesso ma che lo contiene al suo interno per soprammercato qui il Π(ΑΡΑ) egrave usato per giustificare una menzione a sua volta relatum di un segno
Evidentemente questa maniera di procedere che giagrave aveva attirato interventi da parte di copisti e correttori della recensione di base parve insostenibilmente opaca allrsquoautore della recensione bizantina61 Egli
61 Uno dei manoscritti di questa recensione propone anche una tabella di divisione
Fabio Acerbi148
modifica tutte le descrizioni diluendo lrsquoidiomatismo dellrsquoarticolo lsquocita-zionalersquo con lrsquointroduzione sistematica del verbo δηλόω e di frasi atte a chiarire quale sia il segno denotante e quale il vocabolo (o il segno) denotato Egli introduce allo scopo di rendere esplicita la funzione de-notativa dei segni introdotti il termine σημείου curiosamente in tutte le sue tre occorrenze esso compare a sua volta nella forma dellrsquoabbrevia-zione per sospensione σΗ´ Egli traccia il segno per i massimi multipli ἀφ e quello per i resti λ οι` in modo che non vi siano ambiguitagrave quanto al loro carattere di abbreviazione Si faccia infine attenzione al residuo di barra sul παρᾱ con funzione denotativa (2 occorrenze) contenuto nella descrizione del segno per il divisore sostituita dallrsquoaccento grave nel παρὰ con funzione discorsiva (la differenza egrave nettissima nei manoscritti da me consultati) Questa osservazione ci permette di passare direttamente allrsquoitem seguente
b) Le barre sui numerali e sulle lettere denotative Egrave opportuno discutere questo punto adesso esattamente percheacute di barre siffatte che pure troviamo in tutti i manoscritti i nostri testi non fanno mai menzione si tratta infatti di una pratica condivisa sin dallrsquoantichitagrave La barra identifica una stringa di lettere dellrsquoalfabeto che non svolge una funzione grammaticale o sintattica propria allrsquointerno del discorso Ciograve avviene in particolare e si tratta della fattispecie piugrave frequente se la stringa di lettere non dagrave origine a un vocabolo della lingua greca lette-re denotative e numerali certo ma anche termini provenienti da altri idiomi e contrazioni di parole greche come i nomina sacra62 tali termi-ni possono essere o no preceduti da un articolo lsquocitazionalersquo a seconda dellrsquouso che ne viene fatto allrsquointerno del discorso Ma non si tratta dellrsquounica fattispecie i papiri grammaticali ed i manoscritti piugrave antichi dei trattati dello stesso argomento segnalano gli esempi delle parti del discorso (cioegrave di lsquoverersquo parole greche) per mezzo di barre sormontanti63 La differenza insomma egrave tra menzione e uso (come parte del discorso in atto) di una stringa di caratteri tra il porre le lsquovirgolettersquo e il non porle tra funzione denotativa e non Apparentemente la convenzione si limi-
corredata dei segni opportuni e contrariamente alle indicazioni della descrizione svilup-pata lsquoin verticalersquo ma per motivi misteriosi non completa (tav 7a Laur Plut 89 sup 48 f 13r)
62 Tutto ciograve egrave spiegato con estrema chiarezza giagrave in Traube 1907 pp 45-4763 Si veda il Par gr 2548 codex vetustissimus e testimone unico delle lsquoopere minorirsquo
di Apollonio Discolo il f 106v con le barre ben visibili egrave riprodotto come tav 19 in De Gregorio 2000 (ivi pp 137-138 per la datazione) Per la testimonianza dei papiri grammaticali si veda Wouters 1979 passim essi contengono di norma elenchi di parti del discorso nessuna delle quali egrave preceduta dallrsquoarticolo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 149
tava in questo secondo caso a segnalare con la barra singoli vocaboli le menzioni di frasi o di sintagmi complessi sono di norma identificate dallrsquoarticolo lsquocitazionalersquo Drsquoaltra parte le abbreviazioni convenzionali non rientrano nella casistica percheacute la loro resa grafica che contiene elementi non alfabetici come compendi per desinenze lettere supra li-neam marche di contrazione o sospensione quali slashes o barre sotto-poste o sormontanti eventualmente solo un sottinsieme della stringa di segni alfabetici le esclude automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
Venendo al discorso matematico una barra sormonta senza ecce-zione le lettere denotative64 che sia in papiri o in manoscritti in maiu-scola65 o minuscola ma solo allrsquointerno del testo comrsquoegrave da attendersi nei diagrammi esse la perdono per il semplice motivo che non crsquoegrave alcun testo ambiente un diagramma ha unicamente una funzione denotati-va Drsquoaltra parte le lettere numerali che a volte figurano nei diagrammi della tradizione metrica66 allo scopo di indicare la lunghezza dei seg-menti mantengono la barra in un diagramma il contesto denotativo geometrico egrave prevalente e i numerali vengono percepiti come entitagrave grafiche lsquoesternersquo al discorso Va da seacute a fortiori che le lettere numerali inserite in un testo dovranno essere segnalate da barre che a loro volta non servono nelle tavole67 in quanto queste ultime sono come abbiamo visto un vero e proprio testo che perograve funge da ambiente a quello al-fabetico limitato alle titolazioni e non a caso tracciato in unrsquoopportuna lsquomaiuscola distintivarsquo allo scopo di segnalarne il carattere denotativo e non discorsivo68 Una tabella operazionale egrave invece un paratesto e quindi le barre sulle lettere numerali che rappresentano gli interi sono
64 La notazione per le lettere denotative subigrave unrsquoevoluzione (il cui risultato finale egrave descritto per sommi capi nella nota 3 supra) di cui non mette conto occuparsi qui
65 I papiri di contenuto geometrico (o astronomici ma che presentano argomenti geometrici) sono rari si vedano il PHerc 1061 (sec II aC Demetrio Lacone De geome-tria) e il PFay 9 (sec II ex Elementi I 39 e 41) Gli importanti ostraka OBerl 12002 e 12609 (sec III aC m Elementi XIII) non pongono le barre sopra le lettere denotative Per i manoscritti in maiuscola si veda ad esempio passim nel Par gr 2389 una cui riproduzione digitale egrave consultabile in rete allrsquoindirizzo httpgallicabnffrark12148btv1b8470171d o il fragmentum mathematicum Bobiense
66 Si veda ancora il ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 codex unicus dei Metrica di Erone e contenente una raccolta importante di problemi del corpus metrologico
67 Si vedano come esempio le tavole citate alle note 10 e 14 supra Discorso a parte per il segno di lsquoposto vuotorsquo si veda il punto c che segue
68 Queste regole generali vanno prese cum grano salis si dagrave naturalmente un certo dominio di variabilitagrave legato verosimilmente al grado di cultura grafica del copista nel PMich III 144 i numerali sono quasi tutti senza barra sia nel testo che nelle tabelle ope-razionali
Fabio Acerbi150
necessarie esse mancano invece sui segni convenzionali che ho descrit-to nel punto precedente e fatto rilevante sulle lettere numerali relative agli ordini sessagesimali quando esse siano identificate da uno o piugrave apici la presenza di questo segno grafico non alfabetico69 le esclude ancora una volta automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo Unrsquoultima osservazione che ci saragrave utile nel seacuteguito la descrizio-ne di una stringa di lettere lsquoagrammaticalersquo non puograve prevedere la men-zione della presenza della barra che le pertiene in quanto tale si tratta di una pratica denotativa che egrave possibile formulare soltanto ad un livello di discorso superiore sia a quello dellrsquouso che a quello della menzione70
c) Il segno di lsquoposto vuotorsquo Si noti nella tav 2b la forma ŏ per il segno di lsquoposto vuotorsquo in un ordine sessagesimale coerentemente con la propria notazione il copista del Marc gr 313 lo scioglie talvolta allrsquoin-terno del testo principale come unrsquoabbreviazione per οὐδέν laquonienteraquo Altre convenzioni di scrittura del tratto che accompagna il circoletto e che si badi bene fa parte integrante del segno di lsquoposto vuotorsquo ndash e infatti nelle tavole troviamo sempre il segno completo mentre tutti gli altri numerali sono come abbiamo visto nel punto precedente privi di barra o di apice a causa del fatto che i vari ordini sessagesimali sono univocamente determinati dalle linee di giustificazione ndash un tratto an-golare anteposto (tav 3 Lar Plut 2818 f 136v)71 o una semplice barra a sormontare (tavv 4-9) si produce in questo modo il segno 65926 che sembra essere stata la forma di base72
69 Occorre dunque supporre come testimoniano papiri e manoscritti in maiuscola che la convenzione relativa allrsquouso della barra si sia consolidata ben prima dellrsquointroduzione di segni diacritici quali accenti e spiriti
70 Si veda il punto 2 infra per maggiori dettagli sulla questione delle barre e degli apici e per le indicazioni in merito che leggiamo in Diofanto
71 Come accennato questa tavola dei sottomultipli coincide con quella descritta ed esposta nei Prolegomena Fatto molto rilevante i numerali nella prima non recano neacute barre neacute apici contrariamente a quanto accade a tutte le istanze della seconda nei manoscritti Quella del Laur Plut 2818 preserva a mio avviso la forma originaria come abbiamo visto una tavola non richiede segni aggiuntivi sulle lettere numerali
72 Si vedano come esempio ancora le tavole citate alle note 10 e 14 supra oppure per una rassegna delle forme che il segno assume nei manoscritti piugrave antichi delle Tavole facili Tihon 2011 pp 58-59 e per quelle che assume nei papiri Jones 1999 I pp 61-62 Ovviamente non possiamo leggere il segno 65926 come un omicron con una barra in quanto ο = 70 nella notazione greca e la barra egrave di rigore quando il numerale figuri allrsquointerno di un testo Occorre ammettere che si dagrave origine ad un bel corto circuito notazionale con il concepire un segno con funzione di lsquoposto vuotorsquo ma che lsquosomigliarsquo ad una lettera dellrsquoalfabeto sormontata da una barra cioegrave ad un numerale in piugrave quando il lsquoposto vuotorsquo non corrisponda ad un intero ma ad una specie sessagesimale la presenza della barra a priori indistinguibile da quella che sormonta gli interi introduce unrsquoincongruenza con la notazione a mezzo di apici vista nellrsquoitem precedente
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 151
d) Errori di copia La tabella riprodotta nella tav 2b ha una forma simmetrica ma si tratta di una forzatura il grande rettangolo in basso a destra drsquoaltronde assente nella descrizione contiene uno scolio che fa notare come lrsquoultimo resto parziale ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ͵γτνζ´´´´´ κζ´´´´´´ cioegrave 0 0 0 0 0 3357 27 siano ἔγγιστα λ´λ´ δ´δ´ ξ laquocon ottima approssimazione 60 minuti quartiraquo dove si notino gli apici semplici per indicare il pas-saggio allrsquoordinale e il raddoppiamento del sistema segno + apice per significare il plurale Lo scolio debitamente accompagnato dal segno di rimando in forma di simbolo solare egrave stato probabilmente incluso nella tabella proprio allo scopo di renderla simmetrica A sua volta un errore precedente spiega lo spazio eccessivo accordato al rettangolo contenente lo scolio il secondo massimo multiplo ŏ λβ´ ξδ´´ ριβ´´´ σιϛ´´´´ egrave trascritto anche al di sotto del risultato
Passiamo ora alla descrizione del metodo di divisione attribuito a Pappo
ἵνα οὖν ταῦτα συναχθῇ τὰ ἐκ τοῦ μερισμοῦ ὁ εἰρημένος Πάππος εὐδιατύπῳ τινὶ καὶ πρὸς τοῦτο τάξει χρησάμενος ποιεῖται τὴν τῆς συλλήψεως τοῦ ζητουμένου ἀνεύρεσιν οὕτως ἐκθέμενος γὰρ τὸν μέλλοντα μερίζεσθαι τουτέστι τὰς τξ μοίρας ἐν ἀρχῇ ἀφαιρεῖ ἀπ᾽ αὐτῶν τὸν ἐν τῇ σελίδι τυγχάνοντα ἐλάττονα τουτέστι τὸν τδ κβ´ κ´´ ὄντα τῶν ἐγγὺς ἐλασσόνων ὡς πρὸς τοὺς ἐκκειμένους διὸ καὶ γράφει αὐτὸν προγράφων αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε καὶ εὑρίσκων τὰ παρακείμενα αὐτῷ τῷ ἀπογραφέντι ἐν τῷ σελιδίῳ λεπτὰ πρῶτα ν´ συναπογράφεται παρατιθῶν αὐτοῖς τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον ἀνατείνουσαν σημαῖνον τὸ εἶδος ὅτι πρῶτα λεπτά εὑρίσκει οὖν οὕτως τὸ τῶν τξ μέρος τὸ τδ κβ´ κ´´ ὃ μεριζόμενον παρὰ τὰς τξε ιδ´ μη´´ ἡμέρας καὶ ποιοῦν τὸν ἐκ τοῦ μερισμοῦ ἀριθμὸν πρῶτα λεπτὰ ν´ καὶ τὸν λοιπὸν ἀπογραφόμενος τὸν νε λζ´ μ´´ προτάσσει αὐτοῦ τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά τάσσει δὲ καὶ ἁπλῆν τινα διατείνουσαν γραμμὴν ὡς ἀπὸ τοῦ τξ ἐπὶ τὸν ἑξῆς ἐκτεθειμένον ἐγγὺς
1
5
10
1 εὐδιατύπῳ] ZSPC εὐδιατύπωτ M 4 ἀφαιρεῖ] MZSP ἀφ ι C 5 ἐλάττονα] P comp MZSC 6 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | αφ ] αφ ε M ἀφ ZS ἀφαί P ἄφ C | ἀντὶ] om C | ἄφελε] MZSP ἄφ C 8 ἀπογραφέντι] MZSP ἐγγραφέντι C | λεπτὰ πρῶτα] P λε πρωτα SC λεπτῶν πρωτ MZ | παρατιθῶν] MZS παρατιθεὶς C et ex corr m 2 P 9 ᾱ] Z αο P α´ MS α C | ἔχον] MPC ἔχων ZS 9-10 πρῶτα λεπτά] ZP πρωτ λ´λ´ M πρωτα λε S αα λε C 11 ἡμέρας] comp codd | ἀριθμὸν] P et comp MZ καὶ C et comp S 12 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M πρωτ λεπτ(α) Z πρωτ λ εᾱ S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C | ἀπογραφόμενος] MZSP ἐγγραφόμενος C | νε λζ´] MZSP λζ νζ C 13 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | λ οι] MZSC ex λ fecit λ οι P | προσσημαῖνον] MC et προσ- comp ZS προση- P | τὸ] MZC τὰ S et fecit m 2 P 14 ἀπὸ] MZSP πρὸς C ἐλάττονα] P comp MZSC
1 εὐδιατύπῳ] εὐδιατυπώτω K 6-7 αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ] τὸ ἀφ K 8 παρατιθῶν mdash 10 λεπτά] τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ σημαίνουσαν τὸ εἶδος αὐτῶν ὅτι ᾱ λεπτά εἰσιν K | τὸ (sec)] τὰ K 12 πρῶτα] πρώτων K | τε λ ] λ οι` K | προσσημαῖνον mdash
Fabio Acerbi152
ἐλάττονα τὸν τδ κβ´ κ´´ ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις καὶ ταύτην ἐπιδεικνύουσαν τὴν τάξιν τῆς προόδου τῆς ἐκθέσεως ἧστινος κλωμένης γραμμῆς πρὸς τῷ ἐγγὺς ἐλάσσονι ἡ ἀντανάκλασις ἐπὶ τὸν λοιπὸν γέγραπται φερομένη ὡς εἴρηται διὰ τὸ εὔτακτον τῆς προκοπῆς οὕτως τε ποιήσας ἑξῆς τὸ αφ ποιῶν ὃ προσσημαίνει ὡς εἴρηται τὸ ὅτι δεῖ ἀφελεῖν ὁμοίως ἀπὸ τοῦ λοιποῦ καὶ δὴ τὸν ἐγγὺς πάλιν ἐλάσσονα ὡς πρὸς τὴν ἐν τῷ σελιδίῳ ἔκθεσιν εὑρισκόμενον λαμβάνων ἑξῆς προγράφει αὐτὸν ὄντα νδ μζ´ ιγ´´ ιβ´´´ καὶ εὑρίσκει αὐτοῖς παρακείμενα ἐν τῷ σελιδίῳ πρῶτα λεπτὰ θ´ ἅτινα καὶ αὐτὰ προσαπογράφεται σὺν τῇ παρασημειώσει τῶν πρώτων γράφων τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον τὴν ἀνατείνουσαν καὶ ὡς εἴρηται τὴν γραμμὴν πάλιν διὰ τὴν τάξιν κλωμένην κατὰ δευτέραν κλάσιν προσέλκει γινομένου τοῦ μέρους αὐτῆς τούτου παραλλήλου τῷ ἐξ ἀρχῆς
16 ante κλωμένης add ἐπὶ C 18 τε] MZP om SC | αφ ] M ἀφ ZSC ἀφαί P 19 προσσημαίνει] MS προση- ZC et ex corr P | ὅτι] ZP comp MSC 20 δὴ] MZSC διὰ fecit m 2 P 21 πρὸς] MSP et supra lineam C ex ἀπὸ fecit m 2 Z | ιγ´´] MZSP νγ´´ C 22 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M ᾱᾱ λεπτὰ Z άάα λε S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C 23 προσαπο- γράφεται] απο suprascr in comp M 24 ᾱ] ZP α´ MS α C 25 κλάσιν] MP τάξιν ZSC | τοῦ] ZSPC τούτου M 26 τούτου] τοῦ bis ZSPC sed prius erasit m 2 P τοῦ M
mdash 18 προκοπῆς] om K | τε ποιήσας] ποιήσας καὶ K | αφ ] ἀφ K 19 τὸ] om K 21 προ-γράφει] γράφει K 22 σελιδίῳ] α´ σελιδίῳ K | ἅτινα] ἃ K 23 προσαπογράφεται] ἀπογράφεται K | τῶν πρώτων mdash 26 ἐξ ἀρχῆς] om K
lsquoAllo scopo di raccogliere ciograve che risulta dalla divisione il detto Pappo utilizzando anche in questo caso una certa disposizione ben strutturata determina nel modo seguente il lsaquonumerorsaquo cercato preso nel suo insieme collocando73 in testa il lsaquonumerorsaquo che sta per essere diviso cioegrave i 360 gradi iniziali sottrae loro tra i piugrave prossimi dei lsaquonumerirsaquo minori rispetto a quelli esposti quello che si trova essere minore nella colonna (cioegrave 304 22 20) Questo egrave il motivo per cui lo trascrive scrivendogli davanti lrsquoabbreviazio-ne laquosottrraquo per laquosottrairaquo e trovando che 50 minuti primi sono collocati accanto a quello stesso lsaquonumerorsaquo che egrave stato trascritto nella colonna li trascrive al tempo stesso collocando accanto74 ad essi la lettera A con un lsaquotrattorsaquo75 sopra che significa la specie minuti primi Trova dunque in que-sto modo la parte di 360 che egrave 304 22 20 la quale divisa per 365 giorni 14 48 fa il numero lsaquoche risultarsaquo dalla divisione 50 minuti primi Trascrivendo
73 La descrizione egrave strutturata come una procedura Acerbi 201274 Il purismo del correttore del Par gr 2390 di Clostomalle nel Marc gr 314 e
dellrsquoautore della recensione bizantina impone loro di modificare la terminazione ma forme tematiche e contratte di τιθεῖν sono correnti nel greco tardivo
75 Il testo greco ha solo il participio con γραμμήν sottinteso Per il significato del participio si veda il punto 2
15
20
25
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 153
poi il resto 55 37 40 gli pone altresigrave76 a prefisso laquoReraquo che significa laquorestiraquo e dispone anche una certa linea semplice77 che va da 360 al piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori che egrave esposto di seacuteguito 304 22 20 come nello lsaquoschemarsaquo esposto linea che mostra lrsquoordine del percorso dellrsquoesposizione Questa linea spezzata lagrave dove si trova il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori egrave tracciata inflessa allrsquoindietro lsaquoersaquo punta verso il resto come egrave stato detto in vista di una progressione ordinata E cosigrave facendo prendendo di seacuteguito il laquosottrraquo che significa come egrave stato detto laquoche occorre similmente sottrarre dal re-storaquo e ovviamente prendendo di nuovo il lsaquonumerorsaquo che egrave trovato essere il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori in relazione alla disposizione nella colonna ndash 54 47 13 12 ndash lo scrive di seacuteguito e trova che 9 minuti primi sono posti loro accanto nella colonna trascrive78 anche questi con la segnaletica dei primi scrivendo la lettera A con un lsaquotrattorsaquo sopra e come egrave stato detto prolunga di nuovo la linea spezzata in vista di una buona disposizione tramite una seconda inflessione essendo questa sua parte parallela a quella inizialersquo
La descrizione continua con una serie di laquoe cosigrave viaraquo e non fa ulte-riore riferimento alla tabella
1) La forma verbale ἐξεσμένον Egrave il neutro del participio perfetto medio-passivo di ξέω lett laquopialloraquo laquolevigoraquo Si danno tre possibilitagrave si tratta di un termine canonico per quanto non altrove attestato per designare unrsquoabbreviazione oppure lrsquoautore anonimo improvvisa sul piano metaforico come se unrsquoabbreviazione non fosse altro che la paro-la completa lsquoaccorciata a colpi di piallarsquo in maniera opportuna oppure il testo egrave corrotto e srsquoimpone una correzione ad esempio τὸ ἑξῆς μένον laquociograve che sta di seacuteguitoraquo Questrsquoultima strada mi pare chiusa dal senso delle frase lrsquoabbreviazione non lsquosta di seacuteguitorsquo a niente ma anzi precede la perifrasi τὸ ἑξῆς μένον se impiegata semplicemente per rimandare al segno αφ immediatamente seguente costituirebbe un intollerabile solecismo Se accettiamo la prima di queste letture considerando quin-di lrsquoabbreviazione αφ in posizione predicativa abbiamo a che fare con
76 Rendo in questo modo il τε isolato77 La linea egrave laquosempliceraquo in quanto egrave una retta la precisazione intende evidenziare per
anticipazione il carattere lsquonon semplicersquo che essa assumeragrave alla prima inflessione quando diventeragrave una spezzata linee siffatte erano in effetti concepite dallrsquoanonimo e prima di lui da tutta la tradizione matematica greca come una singola linea spezzata nei punti drsquoinfles-sione I due segmenti paralleli menzionati al termine del passo sono orizzontali
78 Il verbo egrave al medio in variatio rispetto ai due che precedono e che seguono egrave il matematico che lsquosirsquo trascrive le cifre
Fabio Acerbi154
uno hapax semantico nella grecitagrave superstite come egrave facile verificare con una ricerca sul TLG in rete La recensione bizantina risolve il pro-blema sopprimendo semplicemente τὸ ἐξεσμένον
2) La notazione per le specie numeriche Nella terminologia matema-tica greca gli ordini sessagesimali sono εἴδη laquospecieraquo numerici essi corri- spondono agli ordini di grandezza nel nostro sistema decimale e indica-no in analogia con il caso geometrico la lsquoformarsquo che assume un numero quadrato cubo ecc Centinaia e migliaia sono quindi degli εἴδη rispet-tivamente quadrati (100 egrave il quadrato di 10) e cubi (1000 egrave il cubo di 10) sono specie numeriche ma non numeri particolari e drsquoaltronde 300 non egrave un quadrato ma 3 item dellrsquoεἶδος lsquoquadratorsquo 100 3 egrave il numerale di molteplicitagrave della specie quadrata lsquocentinaiarsquo i due 0 che seguono il 3 segnalano esattamente questo fatto che la notazione greca per gli interi non posizionale fa scomparire al livello denotativo Ciograve non vale soltan-to per i numeri interi ma anche per le loro parti i minuti secondi appar-tengono alla specie lsquoquadratorsquo in quanto 13600 egrave il quadrato di 160
La concezione appare interamente dispiegata nellrsquointroduzione degli Arithmetica diofantei79 che si rivela giova farlo rimarcare un te-stimone fondamentale per la ricostruzione della notazione matematica antica Alle specie usate in questrsquoopera vengono assegnati una denomi-nazione ed un segno convenzionale costituito dallrsquoiniziale (di ognuno dei componenti) della denominazione al quadrato o δύναμις il segno ΔΥ al κύβος il segno ΚΥ alla lsquoquarta potenzarsquo o δυναμοδύναμις il segno ΔΥΔ ecc La descrizione di tali segni egrave del tipo καὶ ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον Κ ἐπίσημον ἔχον Υ ΚΥ κύβος laquoe il suo segno egrave un Κ che ha come indice un Υ ΚΥ cuboraquo dove in accordo con quanto abbiamo visto nel punto b supra e pur nel comprensibile imbarazzo del copista della prima parte del Matritensis (o di un suo passato collega) a districarsi in questo formidabile ginepraio notazionale80 le due lettere Κ e Υ ricevono una barra mentre ΚΥ non la richiede a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον il quale ancora una volta esclude automaticamente il segno dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
79 In particolare a DOO I pp 214-62180 Nel Matr 4678 riscontriamo i seguenti fenomeni nelle poche righe a cavallo dei ff
58r-v 1) accento acuto posto su tutti i segni come se fossero abbreviazioni 2) ripetizione sistematica segnodenominazione come in ΚΥ κύβος appena letto dovuta sicuramente allrsquointrusione di glosse interlineari esplicative dei segni ndash e successivo pentimento (δύναμις e κύβος sono in effetti cancellati dalla prima mano il primo con un tratto il secondo con dei punti supra lineam poi il copista si stanca di correggere) 3) nella descrizione del segno per la δυναμοδύναμις menzione di un δέλτα δύο che saragrave molto probabilmente stato ΔΔ subito dopo nella descrizione del κυβόκυβος si legge un incongruo δύο KK
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 155
Diofanto introduce poi dei segni anche per le specie delle parti dellrsquounitagrave (le nostre frazioni) che egli chiama ὁμώνυμα μορία laquoparti omonimeraquo di cui quelle sessagesimali sono casi particolari81 Egli spie-ga appunto che le loro denominazioni sono ottenute da quelle delle specie degli interi per sinonimia passando ad un lsquoordinalersquo82 formato semplicemente aggiungendo il suffisso -στον δυναμοστόν κυβοστόν δυναμοδυναμοστόν ecc (sott μόριον) I loro segni convenzionali sono invece ottenuti da quelli per le specie degli interi aggiungendo una γραμμὴν διαστέλλουσαν τὸ εἶδος laquolinea che distingue la specieraquo83 Una linea sui segni delle specie delle parti egrave richiesta si badi bene per distinguerli dai segni di quelle degli interi come giagrave osservato questi ultimi sono giagrave lsquoagrammaticalirsquo a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον a fortiori lo saranno anche i primi Si tratta della traduzione semio-tica del passaggio dal cardinale allrsquoordinale che a livello grammaticale egrave effettuato con il suffisso -στον Che forma ha questa linea Barra o apice (Egrave cervellotico pensare a forme piugrave complesse) La domanda non ammette una risposta immediata in quanto delle specie diofantee nessuno piugrave si occupa nellrsquoantichitagrave84 Se egrave vero che la prima risposta darebbe origine ad un conflitto tra due convenzioni denotative diffe-renti la barra lsquocitazionalersquo e la barra che distingue la specie lrsquoevidenza grafica del Matritensis lascia lievemente sgomenti (ricordiamoci che giagrave i segni di base sono indebitamente dotati di un accento dal copista) Le poche occorrenze del segno per le specie delle parti85 vedono lrsquoaggiunta di uno slash di sospensione di un doppio apice inverso ndash in tutta evi-
81 Questo fatto era giagrave chiaro nellrsquoantichitagrave Teone in Alm I 10 in iA p 45310-1682 Il parallelo con i cardinali e gli ordinali relativi agli interi egrave reso esplicito da Dio-
fanto ὥσπερ δὲ τῶν ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια παρομοίως καλεῖται τοῖς ἀριθμοῖς τοῦ μὲν τρία τὸ τρίτον τοῦ δὲ τέσσαρα τὸ τέταρτον οὕτως καὶ τῶν νῦν ἐπονομασθέντων ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια κληθήσεται παρομοίως τοῖς ἀριθμοῖς laquocome le parti omonime dei numeri sono chia-mate per assonanza con i numeri di lsquotrersquo lsquolsaquounrsaquo terzorsquo di lsquoquattrorsquo lsquolsaquounrsaquo quartorsquo cosigrave le parti omonime dei numeri appena nominati saranno chiamate per assonanza con i numeriraquo (DOO I p 69-13 si noti lrsquoarticolo lsquocitazionalersquo al singolare in τοῦ τρία e τοῦ τέσσαρα) Il parallelo prosegue anche al livello dei segni che rappresentano queste specie come vedremo tra un attimo
83 Diofanto Arithmetica prefazione in DOO I p 620-21 un passaggio maltrattato in questa edizione occorre espungere il participio ἔχον senza introdurre segni ulteriori oppure eliminare un precedente ἐπί come fa un correttore del Matritensis f 58v
84 Unica parzialissima eccezione lrsquoaccenno di Teone menzionato nella nota 81 supra85 Al f 59r e per di piugrave nel margine per sanare un lungo saut du mecircme au mecircme La
collocazione in margine egrave il motivo per cui troviamo una notazione abbreviata nel resto del trattato il primo copista scioglie tutti i segni prendendoli per abbreviazioni mentre il secondo elimina sistematicamente il tratto aggiuntivo delle specie delle parti dellrsquounitagrave Drsquoaltronde egli scrive ad esempio ΔΥ invece di ΔΥ ed egrave quindi indotto a porre la barra al di sopra della stringa di lettere risultante (passim ma si veda ad esempio il f 72r)
Fabio Acerbi156
denza il compendio per la desinenza -ον accentata il copista interpreta il segno come unrsquoabbreviazione ndash e di una barra a sormontare lo Υ Potremmo forse interpretarlo come il segno di contrazione del grafema -στ- lrsquounico tassello mancante in unrsquoabbreviazione come ad esempio (δυναμοδυναμο)(στ)(ὸν) ma uno scolio di prima mano al f 58v rela-tivo alle specie degli interi inficia questrsquoipotesi esse sono dotate di slash di sospensione accento acuto in un caso del compendio canonico per la terminazione -ον hellip ma tutti gli Υ a esponente sono a loro volta sormontati da una barra
Meno legata al singolo manoscritto ma nondimeno non uniforme si presenta la pratica di notazione dei segni che rappresentano gli enti numerici sessagesimali86 da una parte sta lrsquoevidenza del testo dei Pro-legomena e delle sue tabelle apici ndash drsquoaltronde come abbiamo visto la notazione universalmente impiegata per i numerali ordinali e per le fra-zioni unitarie ndash dallrsquoaltra sta lrsquoevidenza del testo dellrsquoAlmagesto in tutti i manoscritti piugrave antichi e lo stesso si dica del commentario teonino a questrsquoopera o del suo lsquoGrande commentariorsquo alle Tavole facili e dei testi astronomici su papiro barre87 Sembra insomma che la nostra docu-
86 Sia le molteplicitagrave che le specie ahimeacute entrambe rappresentate da lettere dellrsquoalfabeto Come osservato allrsquoinizio della sezione 3 ci sono in effetti due tipi di lettere numerali in gioco se facciamo astrazione da apici o barre lsquo4 minuti secondirsquo si trova scritto δ β la prima lettera numerale denota la molteplicitagrave degli item di una certa specie la se-conda la specie nei Prolegomena entrambe sono accompagnate da un doppio apice il che rende inutile la presenza delle seconde Si noti che la descrizione della tabella non fa parola della notazione da usare per le lettere numerali che denotano la molteplicitagrave barre o apici e quanti apici hellip In questo caso fa interamente fede la tabella cioegrave la pratica grafica condivisa instauratasi non egrave chiaro quando
87 I manoscritti piugrave antichi dellrsquoAlmagesto sono menzionati nella nota 10 supra quelli dei due commentarii teonini sono il Laur Plut 2818 e il celeberrimo Vat gr 190 (sec IX in Euclide Elementi Data Teone lsquoGrande commentariorsquo) per la notazione dei pa-piri astronomici si veda Jones 1999 II passim La notazione non sembra lsquoinquinatarsquo dalla pratica dei copisti bizantini e pare dipendere soltanto dalla data di composizione Tro-viamo ad esempio barre sopra tutti i numerali di molteplicitagrave (interi o sessagesimali) nel frammento di un commentario alle Tavole facili contenente un calcolo relativo al 24 aprile 213 (Par gr 2841 sec XIII ex-XIV in oltre al frammento ai ff 32r l 11-34v l 23 contiene Arato Phaenomena ed Efestione Apotelesmatica edizione in Jones 1990) Nel commentario alle Tavole facili composto ca 610-617 ed attribuito a Stefano di Alessandria la situazione egrave la seguente (Jean Lempire per litteras per lrsquoedizione si veda Lempire 2014 ho controllato il Vat gr 304 ff 135r-171v sec XIV am contiene in aggiunta Teone in Almagestum I-II lsquoPiccolo commentariorsquo alle Tavole facili Diofanto Arithmetica e De polygo-nis numeris varia astronomica tabulae) barre sopra gli interi sporadicamente rimpiazzate da apici apici sopra le parti sessagesimali in numero uguale alla denominazione doppio () apice per le frazioni unitarie Sono impiegate barre sopra gli interi e apici sopra le parti sessagesimali nei manoscritti principali di tutti i trattati di introduzione allrsquoAlmagesto o comunque di argomento logistico redatti in epoca bizantina Giorgio Pachimere (1242-ca 1310) Quadrivium (autografo nel manoscritto Roma Biblioteca Angelica gr 38 [RGK III nr 115] si veda Tannery ndash Steacutephanou 1940 per lrsquoedizione) Teodoro Metochita (1270-
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 157
mentazione si faccia testimone di un cambio notazionale avvenuto nel periodo intercorrente fra Teone (sec IV pm) e la scuola alessandrina di Ammonio e dei suoi allievi (sec VI in) e probabilmente innescato da questrsquoultimo ambiente lrsquoaspetto paradossale egrave che nello stesso codice si rintraccino due notazioni differenti per gli enti numerici sessagesimali e lrsquouna (apici) sia adottata sistematicamente e coerentemente in uno scritto (i Prolegomena) che si presenta esattamente come unrsquointroduzione tecnica alla pratica numerico-algoritmica del trattato (lrsquoAlmagesto) in cui egrave adottata lrsquoaltra (barre che ritroviamo senza eccezioni anche negli scolii)
Torniamo ai Prolegomena la descrizione del segno da porre a fianco di ogni singolo quoziente parziale e denotante la sua specie numerica (minuti primi minuti secondi ecc) solleva tre problemi
Primo problema Ci vuole una barra o un apice su τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquola lettera A [hellip] che significa la specieraquo quando lo scriviamo nella tabella Tutta la nostra discussione precedente fa pro-pendere per lrsquoapice e si ricordi anche la forma verbale ἀνατείνουσαν che suggerisce qualcosa che si lsquoestende verso lrsquoaltorsquo (la mia traduzione egrave volutamente neutra) se fosse apposta una barra la cosa dovrebbe passare
1231332) Compendium astronomicum (copia lsquoautorizzatarsquo coeva nei Vat gr 182 e 181 da parte del copista che integrograve le parti mancanti del Par gr 2389 [ff 207-210 255-270 374-375] Bianconi 2005a pp 425-427 Peacuterez Martiacuten 2008 p 436 e n 177) Teodoro Meliteniota (morto lrsquo831393) Tribiblos astronomica (autografo nel Vat gr 792 si vedano Leurquin 1991 per unrsquoanalisi del manoscritto Leurquin 1990 per lrsquoedizione) una com-pilazione anonima (per cui ho consultato il Par gr 2396 ff 87r-92v limitatamente a questi fogli manu Costantino Trivoli [RGK II nr 318 ma ovviamente questo codice non vi egrave segnalato] terzo quarto del XV secolo il resto del codice annotato da Niceforo Gregora egrave di etagrave planudea e parzialmente [ff 33v-76v] un autografo di Planude stesso contiene Teone in Almagestum I II IV Mondrain 2002 il codice va completato ndash limitatamente a stralci dei libri VIII-X XII-XIII del commentario teonino la cui parte intermedia si egrave persa ndash con 26 carte [ff 123-147] inserite nel Vat gr 1087 anchrsquoesso contenente anno-tazioni di Gregora Rome 1927 per la figura del copista dei ff 77r-86r del Par gr 2396 e dei ff appena nominati del Vat gr 1087 un anonimo collaboratore di Gregora si veda in ultimo Bianconi 2006a pp 147-151) si veda anche il calcolo effettuato da Niceforo Gre-gora (12921295-13581361) dellrsquoeclisse di sole del 16 luglio 1330 (attestata unicamente ai ff 1r-8v della miscellanea astronomica Marc gr 325 databile ca 1324-1329 in parte vergata e ovunque fittamente annotata da Gregora stesso edizione del testo in Mogenet et al 1983 annotazioni di Gregora elencate in Bianconi 2005a p 413) Unrsquoeccezione apparente il lsquoPiccolo commentariorsquo di Teone alle Tavole facili le parti sessagesimali sono segnalate da apici (ad esempio nel Vat gr 175 vergato da Giovanni Catrario e completato nel 1321-1322 sulla figura di Catrario si vedano in ultimo Bianconi 2005b pp 141-156 e 2006b) lrsquoopera egrave antica ma la sua tradizione non rimonta oltre la fine del XIII secolo a parte un frammento nel Leiden BPG 78 ff 156r-161v (minuscola del IX-X secolo) e in effetti in questo manoscritto tutti i numerali di molteplicitagrave sono sormontati da barre Unrsquoeccezione effettiva egrave il De hypotesibus planetarum nel Vat gr 1594 barre sugli interi e apici sulle parti sessagesimali
Fabio Acerbi158
sotto silenzio e la presenza dellrsquoapice la rende inutile88 Si tratta della stessa convenzione diofantea e coincide ancora con la notazione per i numerali ordinali e per le frazioni unitarie che egrave corrente nei mano- scritti matematici greci per questo motivo non percheacute la descrizione sia particolarmente perspicua nessuno dei copisti della recensione an-tica ha incertezze apici Ma questi apici si rintracciano soltanto sulle indicazioni di specie non contemplate dalla descrizione che sono ante-poste ai resti parziali a fianco dei quozienti parziali i segni di specie sono invece trasformati in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordi-nali corrispondenti del tipo πρωτ tavv 5 e 7b-8 Il recensore bizantino taglia invece la testa al toro elimina dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali elimina la seconda menzione della laquolet-tera Araquo contestualmente allrsquoazzeramento dellrsquoespediente della linea a zig-zag (si veda il punto seguente) modifica la descrizione che contiene la prima menzione in quella dellrsquoapice associato direttamente ai nume-rali di molteplicitagrave riciclando addirittura lrsquoalpha per adibirlo a desi-gnare un numero cardinale (come sorprendersi) τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ laquoponendo al di sopra di essi [scil dei 50 minuti primi] 1 solo lsaquoaccentorsaquo acutoraquo La scelta del recensore egrave assennata che rechi una barra o un apice in una tabella un alpha denota un numero non un numero drsquoordine
Secondo problema da tenere ben distinto dal precedente Cosa ci vuole sul segno α per la lettera alpha menzionata nella frase τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquolettera A [hellip] che significa la specieraquo89 Unrsquooc-chiata allrsquoapparato critico rivela una bella incertezza nei manoscritti Z scrive sempre ᾱ e in un caso lo fa anche P MS optano sempre per α´ C per α P scrive nellrsquoaltro caso αο Per quanto solo la barra sia congrua con il senso della frase in quanto la lettera alpha egrave qui menzionata (si tratta di un oggetto che compare nella tabella) e non cambia niente se essa egrave accompagnata dal suo nome di genere στοιχεῖον ad un livello grafico lrsquoincertezza fra il segno ᾱ che denota laquola lettera αraquo e il segno α´ (o lrsquoabbreviazione αο) per una forma di πρῶτος egrave per piugrave versi giustificata
88 Detto in altri termini la barra egrave uno strumento grafico non matematico e quindi la sua presenza non va segnalata mentre un apice lo egrave e la sua presenza lo deve
89 Notare che in questa frase il primo α non vuole la barra (egrave menzionato allrsquointerno di una frase che impiega convenzioni moderne) il secondo sigrave (idem ma con convenzioni antiche) ndash e nella traduzione la scelta di denotarlo con A (senza virgolette) e non con lsquoArsquo (con virgolette) egrave del tutto arbitraria ndash si noti inoltre che le necessarie precisazioni laquosenzacon virgoletteraquo mostrano che le lingue moderne palesano difficoltagrave analoghe a quelle del greco antico per quanto riguarda i livelli denotativi in ambito metadiscorsivo per non usare le due parentetiche avrei dovuto scrivere rispettivamente lsquoArsquo e lsquolsquoArsquorsquo (doppie virgolette semplici)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 159
ᾱ coincide con il numerale 1 α egrave la prima lettera dellrsquoalfabeto ed inoltre α´ egrave esattamente quello che va scritto nella tabella Potremmo dirci che il sostantivo στοιχεῖον chiude la questione la sua presenza congiunta ad un ipotetico α´ renderebbe la descrizione ridondante o inappropriata90 Ma a parte il fatto che α egrave proprio τὸ πρῶτον στοιχεῖον il segno α´ cat-tura in fondo il cuore della descrizione di uno στοιχεῖον ἔχον lsaquoγραμμὴνrsaquo ἀνατείνουσαν
Terzo problema Lrsquoautore dei Prolegomena che si arresta allrsquoesem-pio dei minuti primi non dice quanti apici occorre mettere sulle lettere numerali che identificano gli ordini superiori al primo se uno soltanto come nel caso diofanteo e delle frazioni unitarie o in numero uguale alla loro denominazione (cioegrave pari al numero denotato dal numerale stesso su cui vanno posti) come effettivamente avviene nei mano-scritti dei Prolegomena La tabella egrave quindi sottodeterminata dalla sua descrizione anzi in un certo senso prende il sopravvento su di essa la pratica di marcare i numerali di molteplicitagrave con gli apici che compe-tono allrsquoordine cui appartengono viene trasferita ai segni per gli ordini stessi per supplire ad una descrizione carente di questi ultimi E la tabella egrave sottodeterminata dalla descrizione in quanto egrave la descrizione di una tabella reale ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις laquocome nello lsaquoschemarsaquo espostoraquo leggiamo a un certo punto del testo
3) La linea a zig-zag Non possiamo che applaudire a questo geniale espediente grafico lo troviamo messo in opera solo nel Marc gr 313 Per quanto lrsquoautore non faccia parola di ciograve nel corso della sua descrizione la linea spezzata egrave intesa dover lsquosaltarersquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue Il copista del codice marciano effettua correttamente due salti nella prima delle sue tabelle (tav 4) ma inserisce un lsquodentersquo in piugrave in quella che considera corretta (tav 5) La linea a zig-zag egrave incompatibile con la presenza di linee di giustificazione nella tabella che in effetti mancano nel Marc gr 313 ciograve induce gli errori di allineamento dei primi 5 quozienti parziali di cui egrave vittima il copista Probabilmente per questo motivo in nessuno degli apografi del Vat gr 1594 la linea a zig-zag figura nella tabella inquadrata come si conviene da una (doppia) cornice esterna e le cui colonne sono appunto separate da linee verticali (tav 7b Vat gr 184 f 17v e tav 8 Par gr 2390 f 9v cui egrave sostanzialmente identica la tabella del Marc gr 314 che si trova
90 Trascuro lrsquoabbreviazione αο = πρῶτος percheacute la desinenza non egrave quella richiesta neacute nella frase (egrave richiesto πρῶτον) neacute nella tabella (πρῶτα)
Fabio Acerbi160
al f 248r ndash ma la mancanza di linee orizzontali causa un gigantesco pa-sticcio nel codice vaticano) Alla recensione bizantina che dipende per il suo testo di base dal Vat gr 1594 e quindi non trova la linea a zig-zag nella tabella non resta che sopprimere la sua descrizione ndash ma proprio per questo motivo e finalmente diventa possibile tracciare un apparato completo di linee di giustificazione (tav 9 Laur Plut 89 sup 48 f 14v) Dato che la descrizione di Teone di questo procedimento di divi-sione non fa cenno allrsquoesistenza della linea a zig-zag viene da chiedersi se essa non costituisca un espediente escogitato dallrsquoautore dei Prolegomena per vivacizzare la procedura originale di Pappo
4) Discrepanze tra descrizione e tabella Il gioco delle minime va-rianti mostra che la divisione era stata eseguita (e trasmessa) corret-tamente tutti i valori numerici sono esatti La tabella nel Marc gr 313 presenta perograve alcune discrepanze con la propria descrizione Essa omette (ma non nella versione lsquoscorrettarsquo lrsquoomissione non si riscontra neanche nel Par gr 2390) il segno per laquorestoraquo di fronte ai resti par-ziali ma aggiunge lrsquoindicazione della loro specie Essa trasforma invece come abbiamo visto le indicazioni di specie che seguono i quozienti parziali in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordinali corri-spondenti La descrizione prevede di chiudere la tabella con il risultato καὶ συνάγων ἅπαντα τὰ ἐκ τῶν μερισθέντων μερῶν λεπτὰ σημειοῦται ὑπὸ πάντας οὕτως γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoe raccogliendo tutti i minuti che provengono dalle parti divise lsaquoPapporsaquo nota sotto tutto cosigrave Ris 0 59 8 17 13 12 31raquo ma sotto la tabella tutta la tradizione ci consegna qualcosa di piugrave articolato ὁ ζητούμενος καθ᾽ ὃν μερίζεται ὁ τξε ιδ´ μη´´ π(αρὰ) τὸν τξ γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoil lsaquonumerorsaquo cercato secondo cui 365 14 48 egrave diviso per 360 risulta 0 59 8 17 13 12 31raquo frase che del resto contiene due errori lrsquoinversione del dividendo e del divisore e la confusione tra segno convenzionale (iuxta descrizione) e abbreviazione (come nella frase) nel caso di γι Oltre ad eliminare la linea a zig-zag91 la recensione bizantina sopprime dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali e modifica come abbiamo visto al punto 2 le loro descrizioni in quelle di apici associati diretta-mente ai numerali di molteplicitagrave
91 Le due righe che nella recensione di base contengono solo i resti parziali minori di 160 del divisore ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue sono in parte completate con lrsquoindicazione abbreviata ἀνάλ(υσις) laquoanalisiraquo il termine greco per questa procedura di riduzione In un sussulto di ipercorrettismo matematico tali resti parziali ridotti non sono preceduti dal segno per laquorestoraquo come nel Par gr 2390 ma da quello per laquorisultatoraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 161
Gli esempi che abbiamo discusso mostrano come i problemi di notazione pesino e non poco sullrsquoespressione discorsiva di un algorit-mo matematico lrsquoente di riferimento per lsquoformularersquo il procedimento di divisione fu considerata la tabella cioegrave un oggetto la cui costitu-zione egrave legata piugrave ad una pratica grafica che a considerazioni logico- algoritmiche non la sua descrizione che in effetti finisce per determi-nare la tabella in maniera non univoca Di questa sottodeterminazione si fa testimone la traiettoria che abbiamo cercato di seguire nelle mani di copisti e revisori il procedimento di divisione si modifica a volte in aspetti secondari a volte in punti piugrave sostanziali ndash fino a rendere neces-saria una radicale revisione della sua descrizione per renderla conforme alla tabella ndash in ogni caso mai per ragioni squisitamente matematiche92
Abstract
The article presents and discusses in detail two passages from the anonymous Prolegomena to the Almagest a VIth century primer to the elementary procedures of calculation needed in Ptolemyrsquos Almagest In the two passages we may follow the complex interplay between mathematical notation the auctor who employed and described it the tachygrapher who transcribed it in vivo copyists who reproduced it correctors who modified it Along this path misgivings and errors arise in the transmission of abbreviations and paratextual units such as diagrams tables operational schemes
Fabio AcerbiCNRS UMR8560 Centre Alexandre Koyreacute
fabacerbigmailcom
92 Sono grato a Daniele Bianconi Lucio del Corso Jean Lempire per alcune preziose indicazioni
AOO = Archimedis opera omnia cum commentariis Eutocii ed J L Heiberg I-III Lipsiae 1910-1915
DOO = Diophanti Alexandrini opera omnia cum Graecis commentariis ed P Tannery I-II Lipsiae 1893-1895
GC = Le laquoGrand Commentaireraquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Mogenet ndash A Tihon I-III Cittagrave del Vaticano 1985-1999
iA = Commentaires de Pappus et de Theacuteon drsquoAlexandrie sur lrsquoAlmageste ed A Rome I-III con paginazione continua Cittagrave del Vaticano 1931-1943
HOO = Heronis Alexandrini opera quae supersunt omnia ed G Schmidt ndash L Nix ndash W Schmidt ndash H Schoene ndash J L Heiberg I-V Lipsiae 1899-1914
PC = Le ldquoPetit Commentairerdquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed A Tihon Cittagrave del Vaticano 1978
POO = Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia ed J L Heiberg I-II in 3 parti Lipsiae 1898-1907
RGK = Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600 I Handschriften aus Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln II Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs und Nachtraumlge zu den Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln III Handschriften aus Bibliotheken Roms mit dem Vatikan A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg unter Mitarbeit von D Harlfinger und P Eleuteri B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln Wien 1981-1997 (Oumlsterreichische Akademie der Wissenschaften Veroumlffentlichungen der Kommission fuumlr Byzantinistik III1-3 A-C)
Sigla
Acerbi 2010 = F Acerbi Il silenzio delle sirene La matematica greca antica Roma 2010
Acerbi 2012 = F Acerbi I codici stilistici della matematica greca dimostrazioni procedure algoritmi laquoQUCCraquo 1012 (2012) pp 167-214
Acerbi et al 2010 = F Acerbi ndash N Vinel ndash B Vitrac Les Proleacutegomegravenes agrave lrsquoAlmageste Une eacutedition agrave partir des manuscrits les plus anciens Introduction geacuteneacuterale ndash Parties I-III laquoSCIAMVSraquo 11 (2010) pp 53-210
Agati 1992 = M L Agati La minuscola laquoBouleteacuteeraquo Cittagrave del Vaticano 1992
Belger 1881 = C Belger Ein neues Fragmentum mathematicum Bobiense laquoHermesraquo 16 (1881) pp 261-284
Bianconi 2005a = D Bianconi La biblioteca di Cora tra Massimo Planude e Niceforo Gregora Una questione di mani laquoSampTraquo 3 (2005) pp 391-438
Bianconi 2005b = D Bianconi Tessalonica nellrsquoetagrave dei Paleologi Le pratiche intellettuali nel riflesso della cultura scritta Paris 2005
Bianconi 2006a = D Bianconi Le pietre e il ponte ovvero identificazioni di mani e storia della cultura laquoBizantinisticaraquo 8 (2006) pp 135-181
Bianconi 2006b = D Bianconi Qualcosa di nuovo su Giovanni Catrario laquoMEGraquo 6 (2006) pp 69-91
Cavallo 1977 = G Cavallo Funzione e strutture della maiuscola greca tra i secoli VIII-XI in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Colloque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 95-137
Cereteli 1904 = G F Cereteli De compendiis scripturae codicum Graecorum praecipue Petropolitanorum et Mosquensium anni nota instructorum Sankt-Petersburg 1904
De Gregorio 2000 = G De Gregorio Materiali vecchi e nuovi per uno studio della minu-scola greca fra VII e IX secolo in G Prato (a cura di) I manoscritti greci tra riflessione e dibattito Atti del V Colloquio Internazionale di Paleografia Greca Cremona 4-10 ottobre 1998 Firenze 2000 pp 83-151
Follieri 1977 = E Follieri La minuscola libraria dei secoli IX e X in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Col-loque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 139-165
Fonkič 2005 = B Fonkič Venecianskaia rukopisrsquo laquoAlrsquomagestaraquo Ptolemeja (Marc gr 313690) o datirovke i proischoždenii kodeksa laquoVDIraquo s III 254 (2005) pp 162-167
Fowler 1999 = D H Fowler The Mathematics of Platorsquos Academy A New Reconstruction Second Edition Oxford 1999
Bibliografia
Fabio Acerbi164
Gerstinger ndash Vogel 1932 = H Gerstinger ndash K Vogel Eine stereometrische Aufgaben-sammlung im Papyrus Graecus [sic] Vindobonensis 19996 laquoMitteilungen aus der Papy-russammlung der Nationalbibliothek in Wienraquo Neue Serie Folge 1 Griechische literarische Papyri 1 Wien 1932 pp 11-76
Heiberg 1927 = Mathematici Graeci Minores ed J L Heiberg Kjoslashbenhavn 1927
Hultsch 1876-1878 = Pappi Alexandrini Collectionis quae supersunt ed F Hultsch I-III Berlin 1876-1878
Janz 2003 = T Janz The Scribes and the Date of the Vat gr 1291 in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae X Cittagrave del Vaticano 2003 pp 159-180
Jones 1990 = Ptolemyrsquos First Commentator ed A Jones Philadelphia 1990
Jones 1999 = Astronomical Papyri from Oxyrhynchus ed A Jones I-II Philadelphia 1999
Jones 2005 = A Jones Ptolemyrsquos Canobic Inscription and Heliodorusrsquo Observation Reports laquoSCIAMVSraquo 6 (2005) pp 53-97
Lempire 2014 = Steacutephanos drsquoAlexandrie Le commentaire aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Lempire Louvain 2014
Leurquin 1990 = Theacuteodore Meacuteliteacuteniote Tribiblos astronomique Livre I ed R Leurquin Amsterdam 1990
Leurquin 1991 = R Leurquin Un manuscrit autographe de la Tribiblos Astronomique de Theacuteodore Meacuteliteacuteniote le Vaticanus graecus 792 laquoScriptoriumraquo 45 (1991) pp 145-162
Maas 1927 = P Maas Griechische Palaeographie in A Gercke ndash E Norden (hrsg von) Einleitung in die Altertumswissenschaft I9 Leipzig 1927 pp 69-80
Martinelli Tempesta 2010 = S Martinelli Tempesta Il codice Milano Biblioteca Am-brosiana B 75 sup (gr 104) e lrsquoevoluzione della scrittura di Giovanni Scutariota in A B Garciacutea ndash I Peacuterez Martiacuten (ed by) The Legacy of Bernard de Montfaucon Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting Proceedings of the Seventh Inter-national Colloquium of Greek Palaeography Madrid-Salamanca 15-20 September 2008 Turnhout 2010 pp 171-186
Mazzucchi 1994 = C M Mazzucchi Leggere i classici durante la catastrofe (Costantino-poli maggio-agosto 1203) le note marginali al Diodoro Siculo Vaticano gr 130 Parte prima stratigrafia laquoAevumraquo 68 (1994) pp 164-218
Mioni 1976 = E Mioni Bessarione scriba e alcuni suoi collaboratori in Miscellanea marcia-na di studi bessarionei Padova 1976 pp 263-323
Mioni 1985 = Codices graeci manuscripti Bibliothecae Divi Marci Venetiarum II Thesaurus Antiquus Codices 300-625 recensuit E Mioni Roma 1985
Mogenet 1962 = J Mogenet Une scholie ineacutedite du Vat gr 1594 sur les rapports entre lrsquoastronomie arabe et Byzance laquoOsirisraquo 14 (1962) pp 198-221
Mogenet et al 1983 = Niceacutephore Greacutegoras Calcul de lrsquoeacuteclipse de soleil du 16 juillet 1330 ed J Mogenet ndash A Tihon ndash R Royez ndash A Berg Amsterdam 1983
Mondrain 2002 = B Mondrain Maxime Planude Niceacutephore Greacutegoras et Ptoleacutemeacutee laquoPa-laeoslavicaraquo 10 (2002) pp 312-322
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 165
Mondrain 2004 = B Mondrain Lrsquoancien empereur Jean VI Cantacuzegravene et ses copistes in A Rigo (a cura di) Gregorio Palamas e oltre Studi e documenti sulle controversie teologiche del XIV secolo bizantino Firenze 2004 pp 249-296
Mondrain 2007 = B Mondrain Les eacutecritures dans les manuscrits byzantins du XIV e siegravecle Quelques probleacutematiques laquoRSBNraquo n s 44 (2007) pp 157-196
Peacuterez Martiacuten 2006 = I Peacuterez Martiacuten Maxime Planude et le Diophantus Matritensis (Madrid Biblioteca Nacional ms 4678) un paradigme de la reacutecupeacuteration des textes anciens dans la ldquorenaissance paleacuteologuerdquo laquoByzantionraquo 76 (2006) pp 433-462
Peacuterez Martiacuten 2008 = I Peacuterez Martiacuten El lsquoestilo Hodegosrsquo y su proyeccioacuten en las escrituras constantinopolitanas laquoSampTraquo 6 (2008) pp 389-458
Perria 1991 = L Perria Scrittura e ornamentazione nei codici della laquocollezione filosoficaraquo laquoRSBNraquo n s 28 (1991) pp 45-111
Rollo 2012 = A Rollo LrsquoArchimede di Giorgio Valla in V Fera ndash D Gionta ndash A Rollo (a cura di) Archimede e le sue fortune Atti del Convegno di Siracusa-Messina 24-26 giugno 2008 Messina 2012 pp 99-147
Rome 1927 = A Rome Membra disjecta laquoRBenraquo 39 (1927) pp 187-188
Rome 1938 = A Rome Un manuscrit de la bibliothegraveque de Boniface VIII agrave la Meacutediceacuteenne de Florence laquoACraquo 7 (1938) pp 261-268
Ronconi 2013 = F Ronconi La collection philosophique un fantocircme historique laquoScripto-riumraquo 67 (2013) pp 119-140
Tannery ndash Steacutephanou 1940 = Quadrivium de Georges Pachymegravere ed P Tannery ndash E Steacutephanou Cittagrave del Vaticano 1940
Tihon 2011 = Πτολεμαίου Πρόχειροι Κανόνες Les Tables faciles de Ptoleacutemeacutee vol Ia Tables A1-A2 ed A Tihon Leuven 2011
Traube 1907 = L Traube Nomina Sacra Versuch einer Geschichte der christlichen Kuumlrzung Muumlnchen 1907
Vogel 1936 = K Vogel Beitraumlge zur griechischen Logistik laquoSBAWraquo Mathematisch-natur-wissenschaftliche Abteilung Jahrgang 1936 pp 357-472
Wouters 1979 = A Wouters The Grammatical Papyri from Graeco-Roman Egypt Contri-butions to the Study of the lsquoArs Grammaticarsquo in Antiquity Brussel 1979
F ACERBI Tav 1
b Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 65r
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 284 f 160r
F ACERBITav 2
b Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 13r
a Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 19v
F ACERBI Tav 3
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 136v
F ACERBITav 4
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17r
F ACERBI Tav 5
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17v
F ACERBITav 6
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 7v
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 141
e mutilo Tolomeo Almagestum) S = Vat gr 184 (varia astronomica scholia miscellanea ad Almagestum Tolomeo Almagestum) P = Par gr 2390 (varia astronomica) gli ultimi tre riferibili allo scorcio del XIII secolo48 e apografi sicuri del Vat gr 159449 attualmente mutilo di due fascicoli che ci privano dei due terzi finali dei Prolegomena M e il Vat gr 1594 ammettono un modello comune il resto della tradizione (25 trascrizioni in tutto) dipende dagli apografi appena citati del Vat gr 1594 Le varianti della recensione bizantina che leggiamo tra lrsquoaltro nei Vat gr 198 Marc gr 310 (Tolomeo Almagestum cum commentariis Pappi Theonis et Cabasilae) e con ulteriori modifiche Laur Plut 89 sup 48 (varia astronomica Tolomeo Almagestum Barlaam Logistica) sono identificate dal siglum K e si trovano punteggiatura originale in-clusa nel secondo apparato50 Lrsquoanalisi delle testimonianze51 costituite ovviamente anche dalle tabelle associate saragrave condotta nella forma di una sequenza di osservazioni indicizzate da numerali o lettere oltre che di alcune note a piersquo di pagina
Iniziamo dalla descrizione del metodo di divisione anonimo
quello che leggiamo nel Vat gr 1594 (questrsquoultimo coincide con quello adottato nella recen-sione bizantina) fu apposto da Niceforo Gregora e successivamente corretto da Bessarione
48 Sto studiando il primo e il terzo codice in collaborazione rispettivamente con Daniele Bianconi e Inmaculada Peacuterez Martiacuten
49 Su questo codice risalente alla seconda metagrave del IX secolo e sulla sua collocazione nella lsquocollezione filosoficarsquo per prima proposta in Follieri 1977 pp 145-146 si vedano almeno Perria 1991 pp 82-88 Ronconi 2013 Che il titolo dei Prolegomena nel Vat gr 1594 sia stato apposto da Niceforo Gregora egrave stato riconosciuto per la prima volta in Mazzucchi 1994 p 211 n 196 si veda Bianconi 2005a p 418 per altri interventi di Gregora nello stesso manoscritto
50 Il Vat gr 198 egrave stato vergato dal copista Malachia nel corso del terzo quarto del XIV secolo Mondrain 2004 pp 278-290 e 292 Allo stesso copista (denominato non a caso prima dellrsquoidentificazione anonymus Aristotelicus) dobbiamo un buon numero di trascrizioni aristoteliche con i relativi commentari in margine Gli dobbiamo anche il Par gr 2342 secondo tomo di un quadrivium quasi completo di cui il Vat gr 198 egrave il primo nellrsquoordine aritmetica armonica astronomia (Almagesto e commentari relativi) nel codice vaticano geometria ed ancora astronomia (corpus astronomico minore) in quello parigino le opere trascritte sono sempre accompagnate in margine dai relativi commentari Il copista del Marc gr 310 egrave Isacco Argiro (ca 1300-1375) Mondrain 2007 p 166 Allo stesso Argiro dobbiamo il codice laurenziano (Daniele Bianconi per litteras) Poicheacute la recensione modificata che leggiamo nel Laur Plut 89 sup 48 egrave senza alcun dubbio basata su quella nel Marc gr 310 e non viceversa ci troviamo di fronte ad un copista che trascrive due volte lo stesso testo in due versioni leggermente differenti la conclusione naturale egrave che la seconda recensione egrave dovuta ad Argiro stesso la questione andragrave studiata in dettaglio
51 Nei manoscritti citati i Prolegomena si trovano ai fogli seguenti Vat gr 1594 ff 1r-8v (mutilo mancano due fascicoli su tre) Marc gr 313 ff 1r-28r (incompleto man-cano due fogli allrsquoinizio e il f 6 attualmente rimpiazzato da uno bianco) Marc gr 314 ff 235r-255r Vat gr 2326 ff 19r-40v e 43r-v (incompleto e con i fascicoli in disordine) Vat gr 184 ff 10r-23v Par gr 2390 ff 1r-13v Vat gr 198 ff 127r-136v Marc gr 310 ff 1r-13r Laur Plut 89 sup 48 ff 7r-19r
Fabio Acerbi142
ἐκθέμενοι οὖν διάγραμμα τῶν ἀριθμῶν ὡς ὑπόκειται προτάσσομεν τὸν μεριζόμενον καὶ μικρὸν ὑπ᾽ αὐτὸν τὸν μερίζοντα ὡς ἔχει τὸ διάγραμμα ἐν στίχοις διοριζομένοις ὑπὸ γραμμῶν [hellip] καὶ τὰ μὲν γινόμενα ἐγγὺς ἐλάττονα ἐν τῇ μεταξὺ θέσει τοῦ μεριζομένου καὶ τοῦ μερίζοντος ἐν στίχοις παρασημειοῦσθαι πρὸς τὸ ἀσύγχυτον εἶναι τὴν τάξιν τὰ δὲ μεθ᾿ ὧν ὁ μερίζων ἐποίει τοὺς ἀεὶ ἐλάσσονας ὑπὸ τὸν μερίζοντα σημειοῦσθαι προγράφοντας ἐπὶ τοῦ στίχου αὐτῶν τὸ γίνεται οὕτως γι ἐν δὲ τῷ στίχῳ τῶν μεριζόντων τὸ παρὰ ἔχον οὕτως oslash ἀντὶ τοῦ παρ᾿ ἃ δεῖ τὸν μερισμὸν γίνεσθαι ἐν δὲ τῷ στίχῳ τῶν ἐλασσόνων τὸ αφ διὰ τὸ τούτους ἀεὶ ἀφαιρεῖσθαι ἀπὸ τῶν ἐπάνω τῶν μεριζομένων ἐν δὲ τοῖς τοῦ μεριζομένου λοιπάσμασι τοῖς καὶ ἐπιοφείλουσι τὸ λ κατὰ τὸ ἴδιον τῶν διαστάσεων ἑκάστης ndash λέγω δὴ λοιπάδος ndash ἀντὶ τοῦ λοιποὶ οἱ μέλλοντες ἐπιμερίζεσθαι
2 post τὸν suprascr τὸν ἐλάττονα m 2 S 5 πρὸς] MP et ex corr Z κατὰ S om C | ἀσύγχυτον] MSPC -χητον Z 6 ἀεὶ] MZPC ὡσεὶ S 7 γίνεται οὕτως γι ] γι τ οὕτως γι τ M γί οὕτως γί Z γι οὕτως γί SC τὸ γινόμενον οὕτως γίνεται P 8 τὸ παρὰ ἔχον οὕτως] scripsi τὸ παρέχον οὕτως M et π(αρ-) comp Z οὕτως τὸ περιέχον S προγράφοντας οὕτως ex corr m 2 P τὸ περιέχον οὕτως C | oslash] MZSC (sed ο fecit | Z) ἐλάττων comp ex corr m 2 P | παρ᾿ ἃ] scripsi παρα M π(αρα) comp ZSC ex παρα fe-cit παρὰ et τοῦτον suprascr m 2 P 9 γίνεσθαι] comp C | αφ ] αφ ε M ἀφ ZSC ἀφαί P | ἀεὶ] om M 11 ἐπιοφείλουσι] MZSC ex ἐπιο- fecit ἐπο- m 2 P | λ] MZPC λ´ S 12 λοιποὶ] PC λοιποῦ MZS
3 στίχοις] στίχῳ K 5 πρὸς] διὰ K 7 ἐπὶ mdash γι ] τὸ γίνεται διὰ τοιούτου σ(ημείου) γί K 8 τὸ παρὰ ἔχον mdash παρ᾿ ἃ] τὸ παρᾱ διὰ σ(ημείου) τοιούτου καὶ τοῦτο oslash δηλοῦντος τοῦ παρᾱ ὅτι παρὰ τὸν τοιοῦτον (ἀριθμὸν) K 9 αφ διὰ τὸ τούτους] ἀφ δηλοῖ δὲ τοῦτο ἀφαίρεσ(ιν) ὅτι τούτους ἀεὶ δεῖ K 11 ἐπιοφείλουσι] ἐπιμερίζεσθαι ὀφείλουσι K | λ] λ οι` K 12 ἀντὶ τοῦ] δηλοῦντος τοῦ σ(ημείου) τὸ K
lsquoRendendo esplicito un diagramma numerico come lo troviamo qui sotto disponiamo in primo luogo il dividendo e un poco al di sotto di esso il divisore come li ha il diagramma in righe delimitate da linee [hellip] e lsaquooccorreragraversaquo nella posizione tra il dividendo e il divisore annotare lrsquouno accanto allrsquoaltro i piugrave vicini lsaquodei numerirsaquo minori che risultano affincheacute la disposizione non sia confusa quelli con cui il divisore faceva ogni volta i lsaquonumerirsaquo minori annotarli sotto il divisore scrivendo in prima posizione sulla loro riga laquorisultaraquo cosigrave Ris nella riga dei diviso-ri52 invece laquoperraquo fatto cosigrave53 P in luogo di laquoquelli per cui deve farsi la divisioneraquo nella riga dei lsaquonumerirsaquo minori laquosottrraquo in quanto questi sono sempre sottratti dai dividendi che si trovano sopra nei residuli del dividendo (occorre ben farlo anche per loro) laquoReraquo in accordo con ciograve
52 I laquodivisoriraquo sono al plurale ma siamo semplicemente di fronte a un tratto idioma-tico della lingua greca nel caso di espressioni generalizzanti crsquoegrave soltanto un divisore che occupa lrsquounica colonna di cui si compone la sua riga
53 Si intenda ἔχον οὕτως = ita se habens
1
5
10
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 143
che egrave proprio agli scarti di ciascuno ndash intendo qui lsaquociascunrsaquo residuo54 ndash in luogo di laquoresti che vanno a essere divisi ulteriormenteraquorsquo
a) Operatori di citazione e segni convenzionali I segni introdotti sono quattro la mia discussione egrave condotta dando per scontato che essi siano identici a quelli impiegati dallrsquoautore dei Prolegomena anche se si tratta di unrsquoipotesi non corroborabile neacute falsificabile
i Segno per il risultato Lrsquoabbreviazione convenzionale per γίνεται egrave identica al segno introdotto dallrsquoautore e i copisti si dividono tra i due errori possibili scrivere due abbreviazioni o risolverle entrambe Un fenomeno del tutto analogo si riscontra nel Matr 4678 il manoscritto alla base di tutta la tradizione degli Arithmetica di Diofanto al momen-to della definizione dellrsquoἀριθμός (lrsquolsquoincognitarsquo nel nostro linguaggio) ὁ δὲ μηδὲν τούτων τῶν ἰδιωμάτων κτησάμενος ἔχων δὲ ἐν ἑαυτῷ πλῆθος μονάδων ἄλογος ςο` καλεῖται ς` ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον τὸ ς` laquoil lsaquonumerorsaquo che non possiede nessuna di queste proprietagrave ma che ha in seacute una molteplicitagrave indefinita di unitagrave egrave chiamato lsquonumerorsquo e il suo segno egrave ς`raquo Qui solo il terzo dei tre ς ha una barra a sormontare per segnalarne il carattere puramente denotativo (cioegrave di segno convenzionale e non di abbreviazione si veda il punto successivo)55 il primo egrave una delle abbreviazioni piugrave diffuse per ἀριθμός (e infatti egrave dotato del compendio per la desinenza e dellrsquoaccento grave) il secondo egrave una delle piugrave comu-ni per καὶ () Giovanni Cortasmeno autore di capillari annotazioni infra lineam agli Arithmetica nel codice madrileno scioglie il primo ςο`
54 Doppia variatio che impiega al posto di λοιπόν laquorestoraquo i due termini decisamente non canonici τὸ λοίπασμα e ἡ λοιπάς (piugrave oltre leggiamo anche il participio λοιπασθέντα) Una ricerca sul TLG in rete non ha fornito occorrenze del primo si tratta dunque di uno hapax Quanto al secondo che ricorre anche nella sezione sulla divisione lsquoalla Papporsquo lo si rintraccia giagrave nei papiri documentari il termine diventeragrave perograve canonico nelle esposizioni bizantine drsquointroduzione allrsquoAlmagesto ricalcate sul modello dei Prolegomena (si veda la nota 87 infra) Questi due termini designano i resti parziali prodotti nel corso di una divisione lunga li ho tradotti rispettivamente con il neologismo laquoresiduloraquo e con il sostantivo pari-menti non canonico laquoresiduoraquo
55 Il copista interpreta erroneamente il terzo segno come unrsquoabbreviazione e qui ag-giunge un apice inverso (cioegrave un accento grave) altrove lo scioglie direttamente in forme opportune di ἀριθμός Matr 4678 f 58v La frase come la leggiamo nel manoscritto egrave cor-rotta sulla base di una parafrasi in Psello (edita in DOO II p 3710-12) Tannery emendograve ἄλογος in ἀόριστον DOO I p 64-5 et app Il Matritensis vergato da due copisti differenti (cambio di mano a tre righe dalla fine del f 62r) contiene lrsquoIntroductio arithmetica di Nicomaco e le opere diofantee oltre ad alcuni brevi opuscoli musicali la sua data egrave stata recentemente corretta dal XIII al secolo XI pm in Peacuterez Martiacuten 2006 (una riproduzione digitale del manoscritto si trova allrsquoindirizzo httpbdhbneesbnesearchbibliotecaDio-fanto20de20AlejandrC3ADa)
Fabio Acerbi144
in ἀριθμός ed aggiunge un altro segno56 sopra il terzo anteponendovi lrsquoindicazione καὶ ἔστιν αὐτοῦ σ(ημεῖον) τόδε Va da seacute che non abbiamo nessuna garanzia che il segno originariamente introdotto da Diofanto coincidesse realmente con unrsquoabbreviazione convenzionale per ἀριθμός Lrsquoevidenza del PMich III 144 (sec II in) suggerisce drsquoaltronde che il Matritensis e con esso tutta la tradizione medievale di Diofanto ripro-duca fedelmente pur accentuandone la sinuositagrave il segno originario
ii Segno per il divisore Un cerchiolino sbarrato da non confondere con il segno per ὁμοῦ che nei manoscritti matematici ha di norma due barre trasversali (cf tav 2a) Non sono riuscito a rintracciarne ulteriori occorrenze in altre opere la forma che esso assume nel Vat gr 2326 e la correzione apportata nel Par gr 2390 lasciano aperta la possibilitagrave per quanto a mio avviso remota che la forma originaria non fosse lon-tana da unrsquoabbreviazione di παρά registrata nei repertori57 Il correttore del Par gr 2390 trasforma in effetti il segno oslash nellrsquoaffine abbreviazione canonica per (forme di) ἐλάσσων laquominoreraquo58 e si incarica diligente-mente di farlo notare ricapitolando i segni nella porzione superiore del margine esterno del f 7v Nello stesso margine egli traccia anche uno lsquoscolio tabellarersquo ed egrave lrsquounico a porre il (proprio) segno dove indicato dalla descrizione (tav 6 Par gr 2390 f 7v) Oltre a ciograve adattando la tabella al margine ristretto lo scoliaste trascrive come colonne affian-cate le due righe dei resti parziali e dei massimi multipli e aggiunge le indicazioni ὁ μεριζόμενος laquodividendoraquo e ὁ μερίζων laquodivisoreraquo ma vi introduce alcune incongruenze di formato il risultato scritto in verti-cale e la linea verticale di sinistra che separa il divisore dal segno che lo dovrebbe precedere direttamente
iii Segno per i massimi multipli Corrisponde alla semplice abbre-viazione per sospensione della forma verbale ἄφελε laquosottrairaquo in questo
56 Si tratta del segno di ampio uso praticamente identico allrsquoabbreviazione canonica per οὖν
57 Si tratta di un pi a forma di gancio sbarrato da uno slash di troncamento Ce-reteli 1904 tav IX item 7 sub ΠΑΡΑ che rinvia al PVindRain 423 cf anche la forma π` nel POxy LXI 4142 edito in Jones 1999 II pp 26-34 In generale nei papiri e nei manoscritti matematici in maiuscola le preposizioni sono abbreviate facendo seguire un lsquoapostroforsquo alla loro prima lettera Α᾽ Υ᾽ ecc Per la seconda fattispecie di supporto libra-rio si veda in particolare il cosiddetto fragmentum mathematicum Bobiense scriptio inferior databile al V-VI secolo del palinsesto Milano Biblioteca Ambrosiana L 99 sup (Isidoro di Siviglia Etymologiae datazione Cavallo 1977 p 100) pp 113-114 che sono stampate in riproduzione apografa conforme in Belger 1881 (la p 114 egrave riprodotta anche nella tav 10 di Acerbi 2010)
58 Se questa era lrsquointenzione si tratta ovviamente di una forzatura il divisore puograve ben essere maggiore del dividendo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 145
caso lo slash di troncamento taglia orizzontalmente il tratto verticale del phi I copisti offrono molteplici varianti apponendo chi uno spirito dolce chi un ε chi un αί accentato a sormontare Tutti questi segni svolgono la funzione di abbreviazioni vere e proprie (e cosigrave doveva essere anche per lrsquoautore si veda il punto 1 di p 153 infra) la forma originale si ottiene a mio avviso incrociando i dati del Marc gr 313 e dei tre apografi del Vat gr 1594 αφ anche se lrsquoassenza dello spirito potrebbe essere semplicemente dovuta alla pratica del copista del codice veneziano di economizzare nei diacritici
iv Segno per i resti Un lambda completato da una barra a sormon-tare o da un apice che rinvia alle abbreviazioni per sospensione di una forma opportuna di λοιπός laquorestoraquo In realtagrave la forma che troviamo nella tabella egrave differente (tav 2b) e coincide con quella offerta quasi unanimemente dai manoscritti nella descrizione e in almeno un caso nella tabella del metodo di divisione attribuito a Pappo (tav 4) un lambda che accoglie al di sotto una legatura omicron-iota () sbarrata da uno slash di troncamento Qualcosa di simile si trova nel PVindob G 19996 (sec I) una specie di lambda maiuscolo molto aperto e dal vertice arrotondato che include un circoletto interpretato dagli editori come segno per περίεστιν o per λοιπόν59 Lo stesso segno si rintraccia ad esempio in un medesimo scolio tabellare di prima mano ad Alma-gestum nel Vat gr 1594 f 93v e nel Marc gr 313 f 135r ma stavolta la forma del lambda egrave molto ben definita
Fin qui i segni Ma il gioco egrave piugrave complesso La descrizione si muo-ve pericolosamente sulla linea di confine non sempre ben definita tra segno convenzionale e abbreviazione il primo ndash e il repertorio grafico matematico-astronomico ne egrave particolarmente fornito60 ndash puograve anche
59 Ho consultato lrsquoedizione Gerstinger ndash Vogel 1932 pp 46 e 48 la porzione rilevante del papiro egrave riprodotta nella tav 11 di Fowler 1999 Si veda ancora ivi pp 253-257 per la trascrizione di questo segmento di testo (con correzioni rispetto alla princeps) e per una messa a punto recente inclusa la proposta di datazione che ho riportato qui sopra Il verso del papiro che contiene una tavola aritmetica del tutto scorrelata dalla tematica del recto egrave edito come PRain Unterricht 151
60 La pratica di ridurre lo spazio occupato da un testo tecnico per mezzo di abbreviazioni e segni convenzionali era molto diffusa nei manoscritti in maiuscola contrariamente a quanto avviene per altri generi letterari vedremo tra breve cosa accade negli Arithmetica di Diofanto ma si leggano in proposito anche le considerazioni di Hei-berg nei prolegomena alla propria edizione dellrsquoAlmagesto in particolare riguardo al ricorso massiccio ad espedienti brachigrafici nel modello del Vat gr 180 POO II pp lxxxiv-xciii civ-cv cxxvii cxxxviii-cxxxix Agli elenchi dettagliati forniti da Heiberg possiamo aggiungere il piccolo prontuario stampato in Hultsch 1876-1878 III 2 pp 126-132 e basato sul testo e sugli scolii alla Collectio di Pappo nel Vat gr 218 (sec X in) Si vedano infine le osservazioni del copista del Par gr 2360 f 120v trascritte da Heiberg in AOO III pp x-xi sulle laquonotazioni tipiche a scopo di tagliar corto nello scrivereraquo impiegate nel pro-
Fabio Acerbi146
derivare dalla seconda (un caso egrave appunto il segno per ἐλάσσων che probabilmente trae origine da una legatura epsilon-lambda) ma poi il rapporto referente-relato si fissa convenzionalmente Quelli definiti nel testo che abbiamo letto sono appunto segni convenzionali non ci sarebbe bisogno di spiegarne forma e funzione se fossero intesi come abbreviazioni assumono nella tabella una funzione denotativa non esplicativa o discorsiva (come accade invece nella tav 1a) Ma come vengono descritti questi segni
I referenti delle descrizioni sono i segni sono introdotti da οὕτως (item i-ii) o in alternativa da un τό con il ruolo di lsquooperatore di citazionersquo (item iii-iv) che corrisponde esattamente alle nostre virgolette In entram-bi i casi gli enti sono menzionati e svolgono una funzione metalinguistica sono collocati materialmente nel testo ma egrave come se si trovassero fuori e la loro descrizione li additasse ndash in effetti i segni convenzionali scritti nel testo sono a loro volta i relata di quelli che si trovano nella tabella
I relata dei segni scritti nel testo sono di due tipi singoli vocaboli (item i-ii) o descrizioni della funzione dei segni per mezzo di clausole sintaticamente complesse (item ii e iv) I singoli vocaboli sono γίνεται e παρά e sono entrambi preceduti dal τό lsquocitazionalersquo in quanto relata di segni convenzionali le forme abbreviate con cui sono tracciati nei manoscritti vanno forzatamente sciolte Bisogna ammettere che la per-spicacia e le risorse grafiche dei copisti ndash di cui tutto si puograve dire fuor che commettano qui degli errori ndash sono messe a dura prova con lrsquointrodurre segni identici ad abbreviazioni o con lrsquoattivare un gioco metalinguistico particolarmente serrato in un contesto meno lsquonaturalersquo di come potreb-be esserlo ad esempio quello di un trattato grammaticale Lrsquoitem iii che presenta direttamente un segno identico ad unrsquoabbreviazione non egrave sorretto da una descrizione ma da una giustificazione in διὰ τό Lrsquoartico-lo τό vi assume una funzione metalinguistica anche se non lsquocitazionalersquo poicheacute al tempo stesso genera un infinito sostantivato e lo singolarizza per questo ho scritto laquosono sottrattiraquo in corsivo nella mia traduzione
prio modello archimedeo (nota 32 supra) egli ne compila anche una breve lista Un elenco antico di laquosegni della geometriaraquo sicuramente redatto per assistere il copista si trova anche al f 3v del ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 vergato da Efrem negli anni 950-960 (tav 8 in Acerbi 2010) Possiamo farci unrsquoidea quantitativa del guadagno di spazio in rapporto ad un testo privo di abbreviazioni e con le parole separate da spazi sulla base del fragmentum mathematicum Bobiense il testo vi egrave disposto a tutta pagina su 36 righe di circa 30 segni ciascuna nelle due pagine in questione figurano 2038 segni con 15 mezze righe occupate dalle due figure Ora nel testo dellrsquoedizione stabilita in Heiberg 1927 pp 87-90 le stesse pagine contano 4455 segni spazi compresi Ne risulta che la dimensione in caratteri di un testo matematico puograve essere ridotta di piugrave della metagrave con lrsquoimpiego di compendi e segni convenzionali
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 147
Negli item ii e iv il segno si collega ad una descrizione nel secondo caso in via esclusiva le descrizioni pertanto rinforzano o sostituiscono lrsquoidentificazione con lrsquoente linguistico denotato Le clausole descrittive sono precedute da ἀντί e dallrsquoarticolo τό con funzione di lsquooperatore di citazionersquo esse sono παρ᾿ ἃ δεῖ τὸν μερισμὸν γίνεσθαι (item ii) e λοιποὶ οἱ μέλλοντες ἐπιμερίζεσθαι (item iv) Nella descrizione della divisione lsquoalla Papporsquo che leggeremo tra breve i segni negli item iii e iv rice-vono lo stesso trattamento degli altri due il loro relatum egrave un singolo vocabolo e non una clausola descrittiva rispettivamente nelle espres-sioni τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε (sul participio ritorneremo nel punto 1 infra) e τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά (la forma del segno notato con λ οι egrave descritta supra nellrsquoitem iv) La descrizione del segno oslash per il divisore merita una discussione piugrave dettagliata In origine si trovava probabilmente scritto Π(ΑΡΑ)ΕΧΟΝ successivamente letto come π(αρ[α])έχον ndash dato che lrsquoabbreviazione per il preverbo egrave identica a quella per la preposizione (che sia Π᾽ o un pi seguito dal segno per ἄρα a sormontare) ndash invece di π(αρὰ) ἔχον I copisti e i correttori si dettero a tutte le possibili contorsioni per restituire un testo dotato di senso leggere appunto una forma verbale con preverbo modificare il preverbo (ma forse il segno per ἄρα era insidiosamente simile ad uno epsilon) correggere il testo rileggiamo lrsquoapparato sub τὸ παρὰ ἔχον οὕτως τὸ παρέχον οὕτως M et π(αρ-) comp Z οὕτως τὸ περιέχον S τὸ περιέχον οὕτως C προγράφοντας οὕτως ex corr m 2 P Nella clausola descrittiva seguente la presenza liminare di παρὰ (che ho corretto in παρ᾿ ἃ nella speranza di restituire una frase che abbia un senso senza intervenire sul testo) innesca un bel corto circuito il Π(ΑΡΑ) che sicuramente figu-rava nellrsquoarchetipo egrave un sintagma complesso una preposizione unrsquoab-breviazione o un segno per unrsquoabbreviazione Se lrsquoeditore si trova in conflitto con la propria inclinazione alla critica conservativa i copisti si rifiutarono di mettere mano ad un testo che doveva stridere anche per loro essendo il compito demandato al ritocco del revisore del Par gr 2390 o alla riscrittura radicale del recensore bizantino Il problema egrave che ci troviamo di fronte ad unrsquoespressione che descrive la funzione dellrsquooggetto denotato non lrsquooggetto stesso ma che lo contiene al suo interno per soprammercato qui il Π(ΑΡΑ) egrave usato per giustificare una menzione a sua volta relatum di un segno
Evidentemente questa maniera di procedere che giagrave aveva attirato interventi da parte di copisti e correttori della recensione di base parve insostenibilmente opaca allrsquoautore della recensione bizantina61 Egli
61 Uno dei manoscritti di questa recensione propone anche una tabella di divisione
Fabio Acerbi148
modifica tutte le descrizioni diluendo lrsquoidiomatismo dellrsquoarticolo lsquocita-zionalersquo con lrsquointroduzione sistematica del verbo δηλόω e di frasi atte a chiarire quale sia il segno denotante e quale il vocabolo (o il segno) denotato Egli introduce allo scopo di rendere esplicita la funzione de-notativa dei segni introdotti il termine σημείου curiosamente in tutte le sue tre occorrenze esso compare a sua volta nella forma dellrsquoabbrevia-zione per sospensione σΗ´ Egli traccia il segno per i massimi multipli ἀφ e quello per i resti λ οι` in modo che non vi siano ambiguitagrave quanto al loro carattere di abbreviazione Si faccia infine attenzione al residuo di barra sul παρᾱ con funzione denotativa (2 occorrenze) contenuto nella descrizione del segno per il divisore sostituita dallrsquoaccento grave nel παρὰ con funzione discorsiva (la differenza egrave nettissima nei manoscritti da me consultati) Questa osservazione ci permette di passare direttamente allrsquoitem seguente
b) Le barre sui numerali e sulle lettere denotative Egrave opportuno discutere questo punto adesso esattamente percheacute di barre siffatte che pure troviamo in tutti i manoscritti i nostri testi non fanno mai menzione si tratta infatti di una pratica condivisa sin dallrsquoantichitagrave La barra identifica una stringa di lettere dellrsquoalfabeto che non svolge una funzione grammaticale o sintattica propria allrsquointerno del discorso Ciograve avviene in particolare e si tratta della fattispecie piugrave frequente se la stringa di lettere non dagrave origine a un vocabolo della lingua greca lette-re denotative e numerali certo ma anche termini provenienti da altri idiomi e contrazioni di parole greche come i nomina sacra62 tali termi-ni possono essere o no preceduti da un articolo lsquocitazionalersquo a seconda dellrsquouso che ne viene fatto allrsquointerno del discorso Ma non si tratta dellrsquounica fattispecie i papiri grammaticali ed i manoscritti piugrave antichi dei trattati dello stesso argomento segnalano gli esempi delle parti del discorso (cioegrave di lsquoverersquo parole greche) per mezzo di barre sormontanti63 La differenza insomma egrave tra menzione e uso (come parte del discorso in atto) di una stringa di caratteri tra il porre le lsquovirgolettersquo e il non porle tra funzione denotativa e non Apparentemente la convenzione si limi-
corredata dei segni opportuni e contrariamente alle indicazioni della descrizione svilup-pata lsquoin verticalersquo ma per motivi misteriosi non completa (tav 7a Laur Plut 89 sup 48 f 13r)
62 Tutto ciograve egrave spiegato con estrema chiarezza giagrave in Traube 1907 pp 45-4763 Si veda il Par gr 2548 codex vetustissimus e testimone unico delle lsquoopere minorirsquo
di Apollonio Discolo il f 106v con le barre ben visibili egrave riprodotto come tav 19 in De Gregorio 2000 (ivi pp 137-138 per la datazione) Per la testimonianza dei papiri grammaticali si veda Wouters 1979 passim essi contengono di norma elenchi di parti del discorso nessuna delle quali egrave preceduta dallrsquoarticolo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 149
tava in questo secondo caso a segnalare con la barra singoli vocaboli le menzioni di frasi o di sintagmi complessi sono di norma identificate dallrsquoarticolo lsquocitazionalersquo Drsquoaltra parte le abbreviazioni convenzionali non rientrano nella casistica percheacute la loro resa grafica che contiene elementi non alfabetici come compendi per desinenze lettere supra li-neam marche di contrazione o sospensione quali slashes o barre sotto-poste o sormontanti eventualmente solo un sottinsieme della stringa di segni alfabetici le esclude automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
Venendo al discorso matematico una barra sormonta senza ecce-zione le lettere denotative64 che sia in papiri o in manoscritti in maiu-scola65 o minuscola ma solo allrsquointerno del testo comrsquoegrave da attendersi nei diagrammi esse la perdono per il semplice motivo che non crsquoegrave alcun testo ambiente un diagramma ha unicamente una funzione denotati-va Drsquoaltra parte le lettere numerali che a volte figurano nei diagrammi della tradizione metrica66 allo scopo di indicare la lunghezza dei seg-menti mantengono la barra in un diagramma il contesto denotativo geometrico egrave prevalente e i numerali vengono percepiti come entitagrave grafiche lsquoesternersquo al discorso Va da seacute a fortiori che le lettere numerali inserite in un testo dovranno essere segnalate da barre che a loro volta non servono nelle tavole67 in quanto queste ultime sono come abbiamo visto un vero e proprio testo che perograve funge da ambiente a quello al-fabetico limitato alle titolazioni e non a caso tracciato in unrsquoopportuna lsquomaiuscola distintivarsquo allo scopo di segnalarne il carattere denotativo e non discorsivo68 Una tabella operazionale egrave invece un paratesto e quindi le barre sulle lettere numerali che rappresentano gli interi sono
64 La notazione per le lettere denotative subigrave unrsquoevoluzione (il cui risultato finale egrave descritto per sommi capi nella nota 3 supra) di cui non mette conto occuparsi qui
65 I papiri di contenuto geometrico (o astronomici ma che presentano argomenti geometrici) sono rari si vedano il PHerc 1061 (sec II aC Demetrio Lacone De geome-tria) e il PFay 9 (sec II ex Elementi I 39 e 41) Gli importanti ostraka OBerl 12002 e 12609 (sec III aC m Elementi XIII) non pongono le barre sopra le lettere denotative Per i manoscritti in maiuscola si veda ad esempio passim nel Par gr 2389 una cui riproduzione digitale egrave consultabile in rete allrsquoindirizzo httpgallicabnffrark12148btv1b8470171d o il fragmentum mathematicum Bobiense
66 Si veda ancora il ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 codex unicus dei Metrica di Erone e contenente una raccolta importante di problemi del corpus metrologico
67 Si vedano come esempio le tavole citate alle note 10 e 14 supra Discorso a parte per il segno di lsquoposto vuotorsquo si veda il punto c che segue
68 Queste regole generali vanno prese cum grano salis si dagrave naturalmente un certo dominio di variabilitagrave legato verosimilmente al grado di cultura grafica del copista nel PMich III 144 i numerali sono quasi tutti senza barra sia nel testo che nelle tabelle ope-razionali
Fabio Acerbi150
necessarie esse mancano invece sui segni convenzionali che ho descrit-to nel punto precedente e fatto rilevante sulle lettere numerali relative agli ordini sessagesimali quando esse siano identificate da uno o piugrave apici la presenza di questo segno grafico non alfabetico69 le esclude ancora una volta automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo Unrsquoultima osservazione che ci saragrave utile nel seacuteguito la descrizio-ne di una stringa di lettere lsquoagrammaticalersquo non puograve prevedere la men-zione della presenza della barra che le pertiene in quanto tale si tratta di una pratica denotativa che egrave possibile formulare soltanto ad un livello di discorso superiore sia a quello dellrsquouso che a quello della menzione70
c) Il segno di lsquoposto vuotorsquo Si noti nella tav 2b la forma ŏ per il segno di lsquoposto vuotorsquo in un ordine sessagesimale coerentemente con la propria notazione il copista del Marc gr 313 lo scioglie talvolta allrsquoin-terno del testo principale come unrsquoabbreviazione per οὐδέν laquonienteraquo Altre convenzioni di scrittura del tratto che accompagna il circoletto e che si badi bene fa parte integrante del segno di lsquoposto vuotorsquo ndash e infatti nelle tavole troviamo sempre il segno completo mentre tutti gli altri numerali sono come abbiamo visto nel punto precedente privi di barra o di apice a causa del fatto che i vari ordini sessagesimali sono univocamente determinati dalle linee di giustificazione ndash un tratto an-golare anteposto (tav 3 Lar Plut 2818 f 136v)71 o una semplice barra a sormontare (tavv 4-9) si produce in questo modo il segno 65926 che sembra essere stata la forma di base72
69 Occorre dunque supporre come testimoniano papiri e manoscritti in maiuscola che la convenzione relativa allrsquouso della barra si sia consolidata ben prima dellrsquointroduzione di segni diacritici quali accenti e spiriti
70 Si veda il punto 2 infra per maggiori dettagli sulla questione delle barre e degli apici e per le indicazioni in merito che leggiamo in Diofanto
71 Come accennato questa tavola dei sottomultipli coincide con quella descritta ed esposta nei Prolegomena Fatto molto rilevante i numerali nella prima non recano neacute barre neacute apici contrariamente a quanto accade a tutte le istanze della seconda nei manoscritti Quella del Laur Plut 2818 preserva a mio avviso la forma originaria come abbiamo visto una tavola non richiede segni aggiuntivi sulle lettere numerali
72 Si vedano come esempio ancora le tavole citate alle note 10 e 14 supra oppure per una rassegna delle forme che il segno assume nei manoscritti piugrave antichi delle Tavole facili Tihon 2011 pp 58-59 e per quelle che assume nei papiri Jones 1999 I pp 61-62 Ovviamente non possiamo leggere il segno 65926 come un omicron con una barra in quanto ο = 70 nella notazione greca e la barra egrave di rigore quando il numerale figuri allrsquointerno di un testo Occorre ammettere che si dagrave origine ad un bel corto circuito notazionale con il concepire un segno con funzione di lsquoposto vuotorsquo ma che lsquosomigliarsquo ad una lettera dellrsquoalfabeto sormontata da una barra cioegrave ad un numerale in piugrave quando il lsquoposto vuotorsquo non corrisponda ad un intero ma ad una specie sessagesimale la presenza della barra a priori indistinguibile da quella che sormonta gli interi introduce unrsquoincongruenza con la notazione a mezzo di apici vista nellrsquoitem precedente
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 151
d) Errori di copia La tabella riprodotta nella tav 2b ha una forma simmetrica ma si tratta di una forzatura il grande rettangolo in basso a destra drsquoaltronde assente nella descrizione contiene uno scolio che fa notare come lrsquoultimo resto parziale ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ͵γτνζ´´´´´ κζ´´´´´´ cioegrave 0 0 0 0 0 3357 27 siano ἔγγιστα λ´λ´ δ´δ´ ξ laquocon ottima approssimazione 60 minuti quartiraquo dove si notino gli apici semplici per indicare il pas-saggio allrsquoordinale e il raddoppiamento del sistema segno + apice per significare il plurale Lo scolio debitamente accompagnato dal segno di rimando in forma di simbolo solare egrave stato probabilmente incluso nella tabella proprio allo scopo di renderla simmetrica A sua volta un errore precedente spiega lo spazio eccessivo accordato al rettangolo contenente lo scolio il secondo massimo multiplo ŏ λβ´ ξδ´´ ριβ´´´ σιϛ´´´´ egrave trascritto anche al di sotto del risultato
Passiamo ora alla descrizione del metodo di divisione attribuito a Pappo
ἵνα οὖν ταῦτα συναχθῇ τὰ ἐκ τοῦ μερισμοῦ ὁ εἰρημένος Πάππος εὐδιατύπῳ τινὶ καὶ πρὸς τοῦτο τάξει χρησάμενος ποιεῖται τὴν τῆς συλλήψεως τοῦ ζητουμένου ἀνεύρεσιν οὕτως ἐκθέμενος γὰρ τὸν μέλλοντα μερίζεσθαι τουτέστι τὰς τξ μοίρας ἐν ἀρχῇ ἀφαιρεῖ ἀπ᾽ αὐτῶν τὸν ἐν τῇ σελίδι τυγχάνοντα ἐλάττονα τουτέστι τὸν τδ κβ´ κ´´ ὄντα τῶν ἐγγὺς ἐλασσόνων ὡς πρὸς τοὺς ἐκκειμένους διὸ καὶ γράφει αὐτὸν προγράφων αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε καὶ εὑρίσκων τὰ παρακείμενα αὐτῷ τῷ ἀπογραφέντι ἐν τῷ σελιδίῳ λεπτὰ πρῶτα ν´ συναπογράφεται παρατιθῶν αὐτοῖς τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον ἀνατείνουσαν σημαῖνον τὸ εἶδος ὅτι πρῶτα λεπτά εὑρίσκει οὖν οὕτως τὸ τῶν τξ μέρος τὸ τδ κβ´ κ´´ ὃ μεριζόμενον παρὰ τὰς τξε ιδ´ μη´´ ἡμέρας καὶ ποιοῦν τὸν ἐκ τοῦ μερισμοῦ ἀριθμὸν πρῶτα λεπτὰ ν´ καὶ τὸν λοιπὸν ἀπογραφόμενος τὸν νε λζ´ μ´´ προτάσσει αὐτοῦ τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά τάσσει δὲ καὶ ἁπλῆν τινα διατείνουσαν γραμμὴν ὡς ἀπὸ τοῦ τξ ἐπὶ τὸν ἑξῆς ἐκτεθειμένον ἐγγὺς
1
5
10
1 εὐδιατύπῳ] ZSPC εὐδιατύπωτ M 4 ἀφαιρεῖ] MZSP ἀφ ι C 5 ἐλάττονα] P comp MZSC 6 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | αφ ] αφ ε M ἀφ ZS ἀφαί P ἄφ C | ἀντὶ] om C | ἄφελε] MZSP ἄφ C 8 ἀπογραφέντι] MZSP ἐγγραφέντι C | λεπτὰ πρῶτα] P λε πρωτα SC λεπτῶν πρωτ MZ | παρατιθῶν] MZS παρατιθεὶς C et ex corr m 2 P 9 ᾱ] Z αο P α´ MS α C | ἔχον] MPC ἔχων ZS 9-10 πρῶτα λεπτά] ZP πρωτ λ´λ´ M πρωτα λε S αα λε C 11 ἡμέρας] comp codd | ἀριθμὸν] P et comp MZ καὶ C et comp S 12 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M πρωτ λεπτ(α) Z πρωτ λ εᾱ S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C | ἀπογραφόμενος] MZSP ἐγγραφόμενος C | νε λζ´] MZSP λζ νζ C 13 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | λ οι] MZSC ex λ fecit λ οι P | προσσημαῖνον] MC et προσ- comp ZS προση- P | τὸ] MZC τὰ S et fecit m 2 P 14 ἀπὸ] MZSP πρὸς C ἐλάττονα] P comp MZSC
1 εὐδιατύπῳ] εὐδιατυπώτω K 6-7 αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ] τὸ ἀφ K 8 παρατιθῶν mdash 10 λεπτά] τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ σημαίνουσαν τὸ εἶδος αὐτῶν ὅτι ᾱ λεπτά εἰσιν K | τὸ (sec)] τὰ K 12 πρῶτα] πρώτων K | τε λ ] λ οι` K | προσσημαῖνον mdash
Fabio Acerbi152
ἐλάττονα τὸν τδ κβ´ κ´´ ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις καὶ ταύτην ἐπιδεικνύουσαν τὴν τάξιν τῆς προόδου τῆς ἐκθέσεως ἧστινος κλωμένης γραμμῆς πρὸς τῷ ἐγγὺς ἐλάσσονι ἡ ἀντανάκλασις ἐπὶ τὸν λοιπὸν γέγραπται φερομένη ὡς εἴρηται διὰ τὸ εὔτακτον τῆς προκοπῆς οὕτως τε ποιήσας ἑξῆς τὸ αφ ποιῶν ὃ προσσημαίνει ὡς εἴρηται τὸ ὅτι δεῖ ἀφελεῖν ὁμοίως ἀπὸ τοῦ λοιποῦ καὶ δὴ τὸν ἐγγὺς πάλιν ἐλάσσονα ὡς πρὸς τὴν ἐν τῷ σελιδίῳ ἔκθεσιν εὑρισκόμενον λαμβάνων ἑξῆς προγράφει αὐτὸν ὄντα νδ μζ´ ιγ´´ ιβ´´´ καὶ εὑρίσκει αὐτοῖς παρακείμενα ἐν τῷ σελιδίῳ πρῶτα λεπτὰ θ´ ἅτινα καὶ αὐτὰ προσαπογράφεται σὺν τῇ παρασημειώσει τῶν πρώτων γράφων τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον τὴν ἀνατείνουσαν καὶ ὡς εἴρηται τὴν γραμμὴν πάλιν διὰ τὴν τάξιν κλωμένην κατὰ δευτέραν κλάσιν προσέλκει γινομένου τοῦ μέρους αὐτῆς τούτου παραλλήλου τῷ ἐξ ἀρχῆς
16 ante κλωμένης add ἐπὶ C 18 τε] MZP om SC | αφ ] M ἀφ ZSC ἀφαί P 19 προσσημαίνει] MS προση- ZC et ex corr P | ὅτι] ZP comp MSC 20 δὴ] MZSC διὰ fecit m 2 P 21 πρὸς] MSP et supra lineam C ex ἀπὸ fecit m 2 Z | ιγ´´] MZSP νγ´´ C 22 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M ᾱᾱ λεπτὰ Z άάα λε S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C 23 προσαπο- γράφεται] απο suprascr in comp M 24 ᾱ] ZP α´ MS α C 25 κλάσιν] MP τάξιν ZSC | τοῦ] ZSPC τούτου M 26 τούτου] τοῦ bis ZSPC sed prius erasit m 2 P τοῦ M
mdash 18 προκοπῆς] om K | τε ποιήσας] ποιήσας καὶ K | αφ ] ἀφ K 19 τὸ] om K 21 προ-γράφει] γράφει K 22 σελιδίῳ] α´ σελιδίῳ K | ἅτινα] ἃ K 23 προσαπογράφεται] ἀπογράφεται K | τῶν πρώτων mdash 26 ἐξ ἀρχῆς] om K
lsquoAllo scopo di raccogliere ciograve che risulta dalla divisione il detto Pappo utilizzando anche in questo caso una certa disposizione ben strutturata determina nel modo seguente il lsaquonumerorsaquo cercato preso nel suo insieme collocando73 in testa il lsaquonumerorsaquo che sta per essere diviso cioegrave i 360 gradi iniziali sottrae loro tra i piugrave prossimi dei lsaquonumerirsaquo minori rispetto a quelli esposti quello che si trova essere minore nella colonna (cioegrave 304 22 20) Questo egrave il motivo per cui lo trascrive scrivendogli davanti lrsquoabbreviazio-ne laquosottrraquo per laquosottrairaquo e trovando che 50 minuti primi sono collocati accanto a quello stesso lsaquonumerorsaquo che egrave stato trascritto nella colonna li trascrive al tempo stesso collocando accanto74 ad essi la lettera A con un lsaquotrattorsaquo75 sopra che significa la specie minuti primi Trova dunque in que-sto modo la parte di 360 che egrave 304 22 20 la quale divisa per 365 giorni 14 48 fa il numero lsaquoche risultarsaquo dalla divisione 50 minuti primi Trascrivendo
73 La descrizione egrave strutturata come una procedura Acerbi 201274 Il purismo del correttore del Par gr 2390 di Clostomalle nel Marc gr 314 e
dellrsquoautore della recensione bizantina impone loro di modificare la terminazione ma forme tematiche e contratte di τιθεῖν sono correnti nel greco tardivo
75 Il testo greco ha solo il participio con γραμμήν sottinteso Per il significato del participio si veda il punto 2
15
20
25
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 153
poi il resto 55 37 40 gli pone altresigrave76 a prefisso laquoReraquo che significa laquorestiraquo e dispone anche una certa linea semplice77 che va da 360 al piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori che egrave esposto di seacuteguito 304 22 20 come nello lsaquoschemarsaquo esposto linea che mostra lrsquoordine del percorso dellrsquoesposizione Questa linea spezzata lagrave dove si trova il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori egrave tracciata inflessa allrsquoindietro lsaquoersaquo punta verso il resto come egrave stato detto in vista di una progressione ordinata E cosigrave facendo prendendo di seacuteguito il laquosottrraquo che significa come egrave stato detto laquoche occorre similmente sottrarre dal re-storaquo e ovviamente prendendo di nuovo il lsaquonumerorsaquo che egrave trovato essere il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori in relazione alla disposizione nella colonna ndash 54 47 13 12 ndash lo scrive di seacuteguito e trova che 9 minuti primi sono posti loro accanto nella colonna trascrive78 anche questi con la segnaletica dei primi scrivendo la lettera A con un lsaquotrattorsaquo sopra e come egrave stato detto prolunga di nuovo la linea spezzata in vista di una buona disposizione tramite una seconda inflessione essendo questa sua parte parallela a quella inizialersquo
La descrizione continua con una serie di laquoe cosigrave viaraquo e non fa ulte-riore riferimento alla tabella
1) La forma verbale ἐξεσμένον Egrave il neutro del participio perfetto medio-passivo di ξέω lett laquopialloraquo laquolevigoraquo Si danno tre possibilitagrave si tratta di un termine canonico per quanto non altrove attestato per designare unrsquoabbreviazione oppure lrsquoautore anonimo improvvisa sul piano metaforico come se unrsquoabbreviazione non fosse altro che la paro-la completa lsquoaccorciata a colpi di piallarsquo in maniera opportuna oppure il testo egrave corrotto e srsquoimpone una correzione ad esempio τὸ ἑξῆς μένον laquociograve che sta di seacuteguitoraquo Questrsquoultima strada mi pare chiusa dal senso delle frase lrsquoabbreviazione non lsquosta di seacuteguitorsquo a niente ma anzi precede la perifrasi τὸ ἑξῆς μένον se impiegata semplicemente per rimandare al segno αφ immediatamente seguente costituirebbe un intollerabile solecismo Se accettiamo la prima di queste letture considerando quin-di lrsquoabbreviazione αφ in posizione predicativa abbiamo a che fare con
76 Rendo in questo modo il τε isolato77 La linea egrave laquosempliceraquo in quanto egrave una retta la precisazione intende evidenziare per
anticipazione il carattere lsquonon semplicersquo che essa assumeragrave alla prima inflessione quando diventeragrave una spezzata linee siffatte erano in effetti concepite dallrsquoanonimo e prima di lui da tutta la tradizione matematica greca come una singola linea spezzata nei punti drsquoinfles-sione I due segmenti paralleli menzionati al termine del passo sono orizzontali
78 Il verbo egrave al medio in variatio rispetto ai due che precedono e che seguono egrave il matematico che lsquosirsquo trascrive le cifre
Fabio Acerbi154
uno hapax semantico nella grecitagrave superstite come egrave facile verificare con una ricerca sul TLG in rete La recensione bizantina risolve il pro-blema sopprimendo semplicemente τὸ ἐξεσμένον
2) La notazione per le specie numeriche Nella terminologia matema-tica greca gli ordini sessagesimali sono εἴδη laquospecieraquo numerici essi corri- spondono agli ordini di grandezza nel nostro sistema decimale e indica-no in analogia con il caso geometrico la lsquoformarsquo che assume un numero quadrato cubo ecc Centinaia e migliaia sono quindi degli εἴδη rispet-tivamente quadrati (100 egrave il quadrato di 10) e cubi (1000 egrave il cubo di 10) sono specie numeriche ma non numeri particolari e drsquoaltronde 300 non egrave un quadrato ma 3 item dellrsquoεἶδος lsquoquadratorsquo 100 3 egrave il numerale di molteplicitagrave della specie quadrata lsquocentinaiarsquo i due 0 che seguono il 3 segnalano esattamente questo fatto che la notazione greca per gli interi non posizionale fa scomparire al livello denotativo Ciograve non vale soltan-to per i numeri interi ma anche per le loro parti i minuti secondi appar-tengono alla specie lsquoquadratorsquo in quanto 13600 egrave il quadrato di 160
La concezione appare interamente dispiegata nellrsquointroduzione degli Arithmetica diofantei79 che si rivela giova farlo rimarcare un te-stimone fondamentale per la ricostruzione della notazione matematica antica Alle specie usate in questrsquoopera vengono assegnati una denomi-nazione ed un segno convenzionale costituito dallrsquoiniziale (di ognuno dei componenti) della denominazione al quadrato o δύναμις il segno ΔΥ al κύβος il segno ΚΥ alla lsquoquarta potenzarsquo o δυναμοδύναμις il segno ΔΥΔ ecc La descrizione di tali segni egrave del tipo καὶ ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον Κ ἐπίσημον ἔχον Υ ΚΥ κύβος laquoe il suo segno egrave un Κ che ha come indice un Υ ΚΥ cuboraquo dove in accordo con quanto abbiamo visto nel punto b supra e pur nel comprensibile imbarazzo del copista della prima parte del Matritensis (o di un suo passato collega) a districarsi in questo formidabile ginepraio notazionale80 le due lettere Κ e Υ ricevono una barra mentre ΚΥ non la richiede a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον il quale ancora una volta esclude automaticamente il segno dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
79 In particolare a DOO I pp 214-62180 Nel Matr 4678 riscontriamo i seguenti fenomeni nelle poche righe a cavallo dei ff
58r-v 1) accento acuto posto su tutti i segni come se fossero abbreviazioni 2) ripetizione sistematica segnodenominazione come in ΚΥ κύβος appena letto dovuta sicuramente allrsquointrusione di glosse interlineari esplicative dei segni ndash e successivo pentimento (δύναμις e κύβος sono in effetti cancellati dalla prima mano il primo con un tratto il secondo con dei punti supra lineam poi il copista si stanca di correggere) 3) nella descrizione del segno per la δυναμοδύναμις menzione di un δέλτα δύο che saragrave molto probabilmente stato ΔΔ subito dopo nella descrizione del κυβόκυβος si legge un incongruo δύο KK
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 155
Diofanto introduce poi dei segni anche per le specie delle parti dellrsquounitagrave (le nostre frazioni) che egli chiama ὁμώνυμα μορία laquoparti omonimeraquo di cui quelle sessagesimali sono casi particolari81 Egli spie-ga appunto che le loro denominazioni sono ottenute da quelle delle specie degli interi per sinonimia passando ad un lsquoordinalersquo82 formato semplicemente aggiungendo il suffisso -στον δυναμοστόν κυβοστόν δυναμοδυναμοστόν ecc (sott μόριον) I loro segni convenzionali sono invece ottenuti da quelli per le specie degli interi aggiungendo una γραμμὴν διαστέλλουσαν τὸ εἶδος laquolinea che distingue la specieraquo83 Una linea sui segni delle specie delle parti egrave richiesta si badi bene per distinguerli dai segni di quelle degli interi come giagrave osservato questi ultimi sono giagrave lsquoagrammaticalirsquo a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον a fortiori lo saranno anche i primi Si tratta della traduzione semio-tica del passaggio dal cardinale allrsquoordinale che a livello grammaticale egrave effettuato con il suffisso -στον Che forma ha questa linea Barra o apice (Egrave cervellotico pensare a forme piugrave complesse) La domanda non ammette una risposta immediata in quanto delle specie diofantee nessuno piugrave si occupa nellrsquoantichitagrave84 Se egrave vero che la prima risposta darebbe origine ad un conflitto tra due convenzioni denotative diffe-renti la barra lsquocitazionalersquo e la barra che distingue la specie lrsquoevidenza grafica del Matritensis lascia lievemente sgomenti (ricordiamoci che giagrave i segni di base sono indebitamente dotati di un accento dal copista) Le poche occorrenze del segno per le specie delle parti85 vedono lrsquoaggiunta di uno slash di sospensione di un doppio apice inverso ndash in tutta evi-
81 Questo fatto era giagrave chiaro nellrsquoantichitagrave Teone in Alm I 10 in iA p 45310-1682 Il parallelo con i cardinali e gli ordinali relativi agli interi egrave reso esplicito da Dio-
fanto ὥσπερ δὲ τῶν ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια παρομοίως καλεῖται τοῖς ἀριθμοῖς τοῦ μὲν τρία τὸ τρίτον τοῦ δὲ τέσσαρα τὸ τέταρτον οὕτως καὶ τῶν νῦν ἐπονομασθέντων ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια κληθήσεται παρομοίως τοῖς ἀριθμοῖς laquocome le parti omonime dei numeri sono chia-mate per assonanza con i numeri di lsquotrersquo lsquolsaquounrsaquo terzorsquo di lsquoquattrorsquo lsquolsaquounrsaquo quartorsquo cosigrave le parti omonime dei numeri appena nominati saranno chiamate per assonanza con i numeriraquo (DOO I p 69-13 si noti lrsquoarticolo lsquocitazionalersquo al singolare in τοῦ τρία e τοῦ τέσσαρα) Il parallelo prosegue anche al livello dei segni che rappresentano queste specie come vedremo tra un attimo
83 Diofanto Arithmetica prefazione in DOO I p 620-21 un passaggio maltrattato in questa edizione occorre espungere il participio ἔχον senza introdurre segni ulteriori oppure eliminare un precedente ἐπί come fa un correttore del Matritensis f 58v
84 Unica parzialissima eccezione lrsquoaccenno di Teone menzionato nella nota 81 supra85 Al f 59r e per di piugrave nel margine per sanare un lungo saut du mecircme au mecircme La
collocazione in margine egrave il motivo per cui troviamo una notazione abbreviata nel resto del trattato il primo copista scioglie tutti i segni prendendoli per abbreviazioni mentre il secondo elimina sistematicamente il tratto aggiuntivo delle specie delle parti dellrsquounitagrave Drsquoaltronde egli scrive ad esempio ΔΥ invece di ΔΥ ed egrave quindi indotto a porre la barra al di sopra della stringa di lettere risultante (passim ma si veda ad esempio il f 72r)
Fabio Acerbi156
denza il compendio per la desinenza -ον accentata il copista interpreta il segno come unrsquoabbreviazione ndash e di una barra a sormontare lo Υ Potremmo forse interpretarlo come il segno di contrazione del grafema -στ- lrsquounico tassello mancante in unrsquoabbreviazione come ad esempio (δυναμοδυναμο)(στ)(ὸν) ma uno scolio di prima mano al f 58v rela-tivo alle specie degli interi inficia questrsquoipotesi esse sono dotate di slash di sospensione accento acuto in un caso del compendio canonico per la terminazione -ον hellip ma tutti gli Υ a esponente sono a loro volta sormontati da una barra
Meno legata al singolo manoscritto ma nondimeno non uniforme si presenta la pratica di notazione dei segni che rappresentano gli enti numerici sessagesimali86 da una parte sta lrsquoevidenza del testo dei Pro-legomena e delle sue tabelle apici ndash drsquoaltronde come abbiamo visto la notazione universalmente impiegata per i numerali ordinali e per le fra-zioni unitarie ndash dallrsquoaltra sta lrsquoevidenza del testo dellrsquoAlmagesto in tutti i manoscritti piugrave antichi e lo stesso si dica del commentario teonino a questrsquoopera o del suo lsquoGrande commentariorsquo alle Tavole facili e dei testi astronomici su papiro barre87 Sembra insomma che la nostra docu-
86 Sia le molteplicitagrave che le specie ahimeacute entrambe rappresentate da lettere dellrsquoalfabeto Come osservato allrsquoinizio della sezione 3 ci sono in effetti due tipi di lettere numerali in gioco se facciamo astrazione da apici o barre lsquo4 minuti secondirsquo si trova scritto δ β la prima lettera numerale denota la molteplicitagrave degli item di una certa specie la se-conda la specie nei Prolegomena entrambe sono accompagnate da un doppio apice il che rende inutile la presenza delle seconde Si noti che la descrizione della tabella non fa parola della notazione da usare per le lettere numerali che denotano la molteplicitagrave barre o apici e quanti apici hellip In questo caso fa interamente fede la tabella cioegrave la pratica grafica condivisa instauratasi non egrave chiaro quando
87 I manoscritti piugrave antichi dellrsquoAlmagesto sono menzionati nella nota 10 supra quelli dei due commentarii teonini sono il Laur Plut 2818 e il celeberrimo Vat gr 190 (sec IX in Euclide Elementi Data Teone lsquoGrande commentariorsquo) per la notazione dei pa-piri astronomici si veda Jones 1999 II passim La notazione non sembra lsquoinquinatarsquo dalla pratica dei copisti bizantini e pare dipendere soltanto dalla data di composizione Tro-viamo ad esempio barre sopra tutti i numerali di molteplicitagrave (interi o sessagesimali) nel frammento di un commentario alle Tavole facili contenente un calcolo relativo al 24 aprile 213 (Par gr 2841 sec XIII ex-XIV in oltre al frammento ai ff 32r l 11-34v l 23 contiene Arato Phaenomena ed Efestione Apotelesmatica edizione in Jones 1990) Nel commentario alle Tavole facili composto ca 610-617 ed attribuito a Stefano di Alessandria la situazione egrave la seguente (Jean Lempire per litteras per lrsquoedizione si veda Lempire 2014 ho controllato il Vat gr 304 ff 135r-171v sec XIV am contiene in aggiunta Teone in Almagestum I-II lsquoPiccolo commentariorsquo alle Tavole facili Diofanto Arithmetica e De polygo-nis numeris varia astronomica tabulae) barre sopra gli interi sporadicamente rimpiazzate da apici apici sopra le parti sessagesimali in numero uguale alla denominazione doppio () apice per le frazioni unitarie Sono impiegate barre sopra gli interi e apici sopra le parti sessagesimali nei manoscritti principali di tutti i trattati di introduzione allrsquoAlmagesto o comunque di argomento logistico redatti in epoca bizantina Giorgio Pachimere (1242-ca 1310) Quadrivium (autografo nel manoscritto Roma Biblioteca Angelica gr 38 [RGK III nr 115] si veda Tannery ndash Steacutephanou 1940 per lrsquoedizione) Teodoro Metochita (1270-
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 157
mentazione si faccia testimone di un cambio notazionale avvenuto nel periodo intercorrente fra Teone (sec IV pm) e la scuola alessandrina di Ammonio e dei suoi allievi (sec VI in) e probabilmente innescato da questrsquoultimo ambiente lrsquoaspetto paradossale egrave che nello stesso codice si rintraccino due notazioni differenti per gli enti numerici sessagesimali e lrsquouna (apici) sia adottata sistematicamente e coerentemente in uno scritto (i Prolegomena) che si presenta esattamente come unrsquointroduzione tecnica alla pratica numerico-algoritmica del trattato (lrsquoAlmagesto) in cui egrave adottata lrsquoaltra (barre che ritroviamo senza eccezioni anche negli scolii)
Torniamo ai Prolegomena la descrizione del segno da porre a fianco di ogni singolo quoziente parziale e denotante la sua specie numerica (minuti primi minuti secondi ecc) solleva tre problemi
Primo problema Ci vuole una barra o un apice su τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquola lettera A [hellip] che significa la specieraquo quando lo scriviamo nella tabella Tutta la nostra discussione precedente fa pro-pendere per lrsquoapice e si ricordi anche la forma verbale ἀνατείνουσαν che suggerisce qualcosa che si lsquoestende verso lrsquoaltorsquo (la mia traduzione egrave volutamente neutra) se fosse apposta una barra la cosa dovrebbe passare
1231332) Compendium astronomicum (copia lsquoautorizzatarsquo coeva nei Vat gr 182 e 181 da parte del copista che integrograve le parti mancanti del Par gr 2389 [ff 207-210 255-270 374-375] Bianconi 2005a pp 425-427 Peacuterez Martiacuten 2008 p 436 e n 177) Teodoro Meliteniota (morto lrsquo831393) Tribiblos astronomica (autografo nel Vat gr 792 si vedano Leurquin 1991 per unrsquoanalisi del manoscritto Leurquin 1990 per lrsquoedizione) una com-pilazione anonima (per cui ho consultato il Par gr 2396 ff 87r-92v limitatamente a questi fogli manu Costantino Trivoli [RGK II nr 318 ma ovviamente questo codice non vi egrave segnalato] terzo quarto del XV secolo il resto del codice annotato da Niceforo Gregora egrave di etagrave planudea e parzialmente [ff 33v-76v] un autografo di Planude stesso contiene Teone in Almagestum I II IV Mondrain 2002 il codice va completato ndash limitatamente a stralci dei libri VIII-X XII-XIII del commentario teonino la cui parte intermedia si egrave persa ndash con 26 carte [ff 123-147] inserite nel Vat gr 1087 anchrsquoesso contenente anno-tazioni di Gregora Rome 1927 per la figura del copista dei ff 77r-86r del Par gr 2396 e dei ff appena nominati del Vat gr 1087 un anonimo collaboratore di Gregora si veda in ultimo Bianconi 2006a pp 147-151) si veda anche il calcolo effettuato da Niceforo Gre-gora (12921295-13581361) dellrsquoeclisse di sole del 16 luglio 1330 (attestata unicamente ai ff 1r-8v della miscellanea astronomica Marc gr 325 databile ca 1324-1329 in parte vergata e ovunque fittamente annotata da Gregora stesso edizione del testo in Mogenet et al 1983 annotazioni di Gregora elencate in Bianconi 2005a p 413) Unrsquoeccezione apparente il lsquoPiccolo commentariorsquo di Teone alle Tavole facili le parti sessagesimali sono segnalate da apici (ad esempio nel Vat gr 175 vergato da Giovanni Catrario e completato nel 1321-1322 sulla figura di Catrario si vedano in ultimo Bianconi 2005b pp 141-156 e 2006b) lrsquoopera egrave antica ma la sua tradizione non rimonta oltre la fine del XIII secolo a parte un frammento nel Leiden BPG 78 ff 156r-161v (minuscola del IX-X secolo) e in effetti in questo manoscritto tutti i numerali di molteplicitagrave sono sormontati da barre Unrsquoeccezione effettiva egrave il De hypotesibus planetarum nel Vat gr 1594 barre sugli interi e apici sulle parti sessagesimali
Fabio Acerbi158
sotto silenzio e la presenza dellrsquoapice la rende inutile88 Si tratta della stessa convenzione diofantea e coincide ancora con la notazione per i numerali ordinali e per le frazioni unitarie che egrave corrente nei mano- scritti matematici greci per questo motivo non percheacute la descrizione sia particolarmente perspicua nessuno dei copisti della recensione an-tica ha incertezze apici Ma questi apici si rintracciano soltanto sulle indicazioni di specie non contemplate dalla descrizione che sono ante-poste ai resti parziali a fianco dei quozienti parziali i segni di specie sono invece trasformati in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordi-nali corrispondenti del tipo πρωτ tavv 5 e 7b-8 Il recensore bizantino taglia invece la testa al toro elimina dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali elimina la seconda menzione della laquolet-tera Araquo contestualmente allrsquoazzeramento dellrsquoespediente della linea a zig-zag (si veda il punto seguente) modifica la descrizione che contiene la prima menzione in quella dellrsquoapice associato direttamente ai nume-rali di molteplicitagrave riciclando addirittura lrsquoalpha per adibirlo a desi-gnare un numero cardinale (come sorprendersi) τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ laquoponendo al di sopra di essi [scil dei 50 minuti primi] 1 solo lsaquoaccentorsaquo acutoraquo La scelta del recensore egrave assennata che rechi una barra o un apice in una tabella un alpha denota un numero non un numero drsquoordine
Secondo problema da tenere ben distinto dal precedente Cosa ci vuole sul segno α per la lettera alpha menzionata nella frase τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquolettera A [hellip] che significa la specieraquo89 Unrsquooc-chiata allrsquoapparato critico rivela una bella incertezza nei manoscritti Z scrive sempre ᾱ e in un caso lo fa anche P MS optano sempre per α´ C per α P scrive nellrsquoaltro caso αο Per quanto solo la barra sia congrua con il senso della frase in quanto la lettera alpha egrave qui menzionata (si tratta di un oggetto che compare nella tabella) e non cambia niente se essa egrave accompagnata dal suo nome di genere στοιχεῖον ad un livello grafico lrsquoincertezza fra il segno ᾱ che denota laquola lettera αraquo e il segno α´ (o lrsquoabbreviazione αο) per una forma di πρῶτος egrave per piugrave versi giustificata
88 Detto in altri termini la barra egrave uno strumento grafico non matematico e quindi la sua presenza non va segnalata mentre un apice lo egrave e la sua presenza lo deve
89 Notare che in questa frase il primo α non vuole la barra (egrave menzionato allrsquointerno di una frase che impiega convenzioni moderne) il secondo sigrave (idem ma con convenzioni antiche) ndash e nella traduzione la scelta di denotarlo con A (senza virgolette) e non con lsquoArsquo (con virgolette) egrave del tutto arbitraria ndash si noti inoltre che le necessarie precisazioni laquosenzacon virgoletteraquo mostrano che le lingue moderne palesano difficoltagrave analoghe a quelle del greco antico per quanto riguarda i livelli denotativi in ambito metadiscorsivo per non usare le due parentetiche avrei dovuto scrivere rispettivamente lsquoArsquo e lsquolsquoArsquorsquo (doppie virgolette semplici)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 159
ᾱ coincide con il numerale 1 α egrave la prima lettera dellrsquoalfabeto ed inoltre α´ egrave esattamente quello che va scritto nella tabella Potremmo dirci che il sostantivo στοιχεῖον chiude la questione la sua presenza congiunta ad un ipotetico α´ renderebbe la descrizione ridondante o inappropriata90 Ma a parte il fatto che α egrave proprio τὸ πρῶτον στοιχεῖον il segno α´ cat-tura in fondo il cuore della descrizione di uno στοιχεῖον ἔχον lsaquoγραμμὴνrsaquo ἀνατείνουσαν
Terzo problema Lrsquoautore dei Prolegomena che si arresta allrsquoesem-pio dei minuti primi non dice quanti apici occorre mettere sulle lettere numerali che identificano gli ordini superiori al primo se uno soltanto come nel caso diofanteo e delle frazioni unitarie o in numero uguale alla loro denominazione (cioegrave pari al numero denotato dal numerale stesso su cui vanno posti) come effettivamente avviene nei mano-scritti dei Prolegomena La tabella egrave quindi sottodeterminata dalla sua descrizione anzi in un certo senso prende il sopravvento su di essa la pratica di marcare i numerali di molteplicitagrave con gli apici che compe-tono allrsquoordine cui appartengono viene trasferita ai segni per gli ordini stessi per supplire ad una descrizione carente di questi ultimi E la tabella egrave sottodeterminata dalla descrizione in quanto egrave la descrizione di una tabella reale ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις laquocome nello lsaquoschemarsaquo espostoraquo leggiamo a un certo punto del testo
3) La linea a zig-zag Non possiamo che applaudire a questo geniale espediente grafico lo troviamo messo in opera solo nel Marc gr 313 Per quanto lrsquoautore non faccia parola di ciograve nel corso della sua descrizione la linea spezzata egrave intesa dover lsquosaltarersquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue Il copista del codice marciano effettua correttamente due salti nella prima delle sue tabelle (tav 4) ma inserisce un lsquodentersquo in piugrave in quella che considera corretta (tav 5) La linea a zig-zag egrave incompatibile con la presenza di linee di giustificazione nella tabella che in effetti mancano nel Marc gr 313 ciograve induce gli errori di allineamento dei primi 5 quozienti parziali di cui egrave vittima il copista Probabilmente per questo motivo in nessuno degli apografi del Vat gr 1594 la linea a zig-zag figura nella tabella inquadrata come si conviene da una (doppia) cornice esterna e le cui colonne sono appunto separate da linee verticali (tav 7b Vat gr 184 f 17v e tav 8 Par gr 2390 f 9v cui egrave sostanzialmente identica la tabella del Marc gr 314 che si trova
90 Trascuro lrsquoabbreviazione αο = πρῶτος percheacute la desinenza non egrave quella richiesta neacute nella frase (egrave richiesto πρῶτον) neacute nella tabella (πρῶτα)
Fabio Acerbi160
al f 248r ndash ma la mancanza di linee orizzontali causa un gigantesco pa-sticcio nel codice vaticano) Alla recensione bizantina che dipende per il suo testo di base dal Vat gr 1594 e quindi non trova la linea a zig-zag nella tabella non resta che sopprimere la sua descrizione ndash ma proprio per questo motivo e finalmente diventa possibile tracciare un apparato completo di linee di giustificazione (tav 9 Laur Plut 89 sup 48 f 14v) Dato che la descrizione di Teone di questo procedimento di divi-sione non fa cenno allrsquoesistenza della linea a zig-zag viene da chiedersi se essa non costituisca un espediente escogitato dallrsquoautore dei Prolegomena per vivacizzare la procedura originale di Pappo
4) Discrepanze tra descrizione e tabella Il gioco delle minime va-rianti mostra che la divisione era stata eseguita (e trasmessa) corret-tamente tutti i valori numerici sono esatti La tabella nel Marc gr 313 presenta perograve alcune discrepanze con la propria descrizione Essa omette (ma non nella versione lsquoscorrettarsquo lrsquoomissione non si riscontra neanche nel Par gr 2390) il segno per laquorestoraquo di fronte ai resti par-ziali ma aggiunge lrsquoindicazione della loro specie Essa trasforma invece come abbiamo visto le indicazioni di specie che seguono i quozienti parziali in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordinali corri-spondenti La descrizione prevede di chiudere la tabella con il risultato καὶ συνάγων ἅπαντα τὰ ἐκ τῶν μερισθέντων μερῶν λεπτὰ σημειοῦται ὑπὸ πάντας οὕτως γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoe raccogliendo tutti i minuti che provengono dalle parti divise lsaquoPapporsaquo nota sotto tutto cosigrave Ris 0 59 8 17 13 12 31raquo ma sotto la tabella tutta la tradizione ci consegna qualcosa di piugrave articolato ὁ ζητούμενος καθ᾽ ὃν μερίζεται ὁ τξε ιδ´ μη´´ π(αρὰ) τὸν τξ γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoil lsaquonumerorsaquo cercato secondo cui 365 14 48 egrave diviso per 360 risulta 0 59 8 17 13 12 31raquo frase che del resto contiene due errori lrsquoinversione del dividendo e del divisore e la confusione tra segno convenzionale (iuxta descrizione) e abbreviazione (come nella frase) nel caso di γι Oltre ad eliminare la linea a zig-zag91 la recensione bizantina sopprime dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali e modifica come abbiamo visto al punto 2 le loro descrizioni in quelle di apici associati diretta-mente ai numerali di molteplicitagrave
91 Le due righe che nella recensione di base contengono solo i resti parziali minori di 160 del divisore ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue sono in parte completate con lrsquoindicazione abbreviata ἀνάλ(υσις) laquoanalisiraquo il termine greco per questa procedura di riduzione In un sussulto di ipercorrettismo matematico tali resti parziali ridotti non sono preceduti dal segno per laquorestoraquo come nel Par gr 2390 ma da quello per laquorisultatoraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 161
Gli esempi che abbiamo discusso mostrano come i problemi di notazione pesino e non poco sullrsquoespressione discorsiva di un algorit-mo matematico lrsquoente di riferimento per lsquoformularersquo il procedimento di divisione fu considerata la tabella cioegrave un oggetto la cui costitu-zione egrave legata piugrave ad una pratica grafica che a considerazioni logico- algoritmiche non la sua descrizione che in effetti finisce per determi-nare la tabella in maniera non univoca Di questa sottodeterminazione si fa testimone la traiettoria che abbiamo cercato di seguire nelle mani di copisti e revisori il procedimento di divisione si modifica a volte in aspetti secondari a volte in punti piugrave sostanziali ndash fino a rendere neces-saria una radicale revisione della sua descrizione per renderla conforme alla tabella ndash in ogni caso mai per ragioni squisitamente matematiche92
Abstract
The article presents and discusses in detail two passages from the anonymous Prolegomena to the Almagest a VIth century primer to the elementary procedures of calculation needed in Ptolemyrsquos Almagest In the two passages we may follow the complex interplay between mathematical notation the auctor who employed and described it the tachygrapher who transcribed it in vivo copyists who reproduced it correctors who modified it Along this path misgivings and errors arise in the transmission of abbreviations and paratextual units such as diagrams tables operational schemes
Fabio AcerbiCNRS UMR8560 Centre Alexandre Koyreacute
fabacerbigmailcom
92 Sono grato a Daniele Bianconi Lucio del Corso Jean Lempire per alcune preziose indicazioni
AOO = Archimedis opera omnia cum commentariis Eutocii ed J L Heiberg I-III Lipsiae 1910-1915
DOO = Diophanti Alexandrini opera omnia cum Graecis commentariis ed P Tannery I-II Lipsiae 1893-1895
GC = Le laquoGrand Commentaireraquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Mogenet ndash A Tihon I-III Cittagrave del Vaticano 1985-1999
iA = Commentaires de Pappus et de Theacuteon drsquoAlexandrie sur lrsquoAlmageste ed A Rome I-III con paginazione continua Cittagrave del Vaticano 1931-1943
HOO = Heronis Alexandrini opera quae supersunt omnia ed G Schmidt ndash L Nix ndash W Schmidt ndash H Schoene ndash J L Heiberg I-V Lipsiae 1899-1914
PC = Le ldquoPetit Commentairerdquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed A Tihon Cittagrave del Vaticano 1978
POO = Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia ed J L Heiberg I-II in 3 parti Lipsiae 1898-1907
RGK = Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600 I Handschriften aus Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln II Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs und Nachtraumlge zu den Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln III Handschriften aus Bibliotheken Roms mit dem Vatikan A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg unter Mitarbeit von D Harlfinger und P Eleuteri B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln Wien 1981-1997 (Oumlsterreichische Akademie der Wissenschaften Veroumlffentlichungen der Kommission fuumlr Byzantinistik III1-3 A-C)
Sigla
Acerbi 2010 = F Acerbi Il silenzio delle sirene La matematica greca antica Roma 2010
Acerbi 2012 = F Acerbi I codici stilistici della matematica greca dimostrazioni procedure algoritmi laquoQUCCraquo 1012 (2012) pp 167-214
Acerbi et al 2010 = F Acerbi ndash N Vinel ndash B Vitrac Les Proleacutegomegravenes agrave lrsquoAlmageste Une eacutedition agrave partir des manuscrits les plus anciens Introduction geacuteneacuterale ndash Parties I-III laquoSCIAMVSraquo 11 (2010) pp 53-210
Agati 1992 = M L Agati La minuscola laquoBouleteacuteeraquo Cittagrave del Vaticano 1992
Belger 1881 = C Belger Ein neues Fragmentum mathematicum Bobiense laquoHermesraquo 16 (1881) pp 261-284
Bianconi 2005a = D Bianconi La biblioteca di Cora tra Massimo Planude e Niceforo Gregora Una questione di mani laquoSampTraquo 3 (2005) pp 391-438
Bianconi 2005b = D Bianconi Tessalonica nellrsquoetagrave dei Paleologi Le pratiche intellettuali nel riflesso della cultura scritta Paris 2005
Bianconi 2006a = D Bianconi Le pietre e il ponte ovvero identificazioni di mani e storia della cultura laquoBizantinisticaraquo 8 (2006) pp 135-181
Bianconi 2006b = D Bianconi Qualcosa di nuovo su Giovanni Catrario laquoMEGraquo 6 (2006) pp 69-91
Cavallo 1977 = G Cavallo Funzione e strutture della maiuscola greca tra i secoli VIII-XI in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Colloque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 95-137
Cereteli 1904 = G F Cereteli De compendiis scripturae codicum Graecorum praecipue Petropolitanorum et Mosquensium anni nota instructorum Sankt-Petersburg 1904
De Gregorio 2000 = G De Gregorio Materiali vecchi e nuovi per uno studio della minu-scola greca fra VII e IX secolo in G Prato (a cura di) I manoscritti greci tra riflessione e dibattito Atti del V Colloquio Internazionale di Paleografia Greca Cremona 4-10 ottobre 1998 Firenze 2000 pp 83-151
Follieri 1977 = E Follieri La minuscola libraria dei secoli IX e X in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Col-loque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 139-165
Fonkič 2005 = B Fonkič Venecianskaia rukopisrsquo laquoAlrsquomagestaraquo Ptolemeja (Marc gr 313690) o datirovke i proischoždenii kodeksa laquoVDIraquo s III 254 (2005) pp 162-167
Fowler 1999 = D H Fowler The Mathematics of Platorsquos Academy A New Reconstruction Second Edition Oxford 1999
Bibliografia
Fabio Acerbi164
Gerstinger ndash Vogel 1932 = H Gerstinger ndash K Vogel Eine stereometrische Aufgaben-sammlung im Papyrus Graecus [sic] Vindobonensis 19996 laquoMitteilungen aus der Papy-russammlung der Nationalbibliothek in Wienraquo Neue Serie Folge 1 Griechische literarische Papyri 1 Wien 1932 pp 11-76
Heiberg 1927 = Mathematici Graeci Minores ed J L Heiberg Kjoslashbenhavn 1927
Hultsch 1876-1878 = Pappi Alexandrini Collectionis quae supersunt ed F Hultsch I-III Berlin 1876-1878
Janz 2003 = T Janz The Scribes and the Date of the Vat gr 1291 in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae X Cittagrave del Vaticano 2003 pp 159-180
Jones 1990 = Ptolemyrsquos First Commentator ed A Jones Philadelphia 1990
Jones 1999 = Astronomical Papyri from Oxyrhynchus ed A Jones I-II Philadelphia 1999
Jones 2005 = A Jones Ptolemyrsquos Canobic Inscription and Heliodorusrsquo Observation Reports laquoSCIAMVSraquo 6 (2005) pp 53-97
Lempire 2014 = Steacutephanos drsquoAlexandrie Le commentaire aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Lempire Louvain 2014
Leurquin 1990 = Theacuteodore Meacuteliteacuteniote Tribiblos astronomique Livre I ed R Leurquin Amsterdam 1990
Leurquin 1991 = R Leurquin Un manuscrit autographe de la Tribiblos Astronomique de Theacuteodore Meacuteliteacuteniote le Vaticanus graecus 792 laquoScriptoriumraquo 45 (1991) pp 145-162
Maas 1927 = P Maas Griechische Palaeographie in A Gercke ndash E Norden (hrsg von) Einleitung in die Altertumswissenschaft I9 Leipzig 1927 pp 69-80
Martinelli Tempesta 2010 = S Martinelli Tempesta Il codice Milano Biblioteca Am-brosiana B 75 sup (gr 104) e lrsquoevoluzione della scrittura di Giovanni Scutariota in A B Garciacutea ndash I Peacuterez Martiacuten (ed by) The Legacy of Bernard de Montfaucon Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting Proceedings of the Seventh Inter-national Colloquium of Greek Palaeography Madrid-Salamanca 15-20 September 2008 Turnhout 2010 pp 171-186
Mazzucchi 1994 = C M Mazzucchi Leggere i classici durante la catastrofe (Costantino-poli maggio-agosto 1203) le note marginali al Diodoro Siculo Vaticano gr 130 Parte prima stratigrafia laquoAevumraquo 68 (1994) pp 164-218
Mioni 1976 = E Mioni Bessarione scriba e alcuni suoi collaboratori in Miscellanea marcia-na di studi bessarionei Padova 1976 pp 263-323
Mioni 1985 = Codices graeci manuscripti Bibliothecae Divi Marci Venetiarum II Thesaurus Antiquus Codices 300-625 recensuit E Mioni Roma 1985
Mogenet 1962 = J Mogenet Une scholie ineacutedite du Vat gr 1594 sur les rapports entre lrsquoastronomie arabe et Byzance laquoOsirisraquo 14 (1962) pp 198-221
Mogenet et al 1983 = Niceacutephore Greacutegoras Calcul de lrsquoeacuteclipse de soleil du 16 juillet 1330 ed J Mogenet ndash A Tihon ndash R Royez ndash A Berg Amsterdam 1983
Mondrain 2002 = B Mondrain Maxime Planude Niceacutephore Greacutegoras et Ptoleacutemeacutee laquoPa-laeoslavicaraquo 10 (2002) pp 312-322
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 165
Mondrain 2004 = B Mondrain Lrsquoancien empereur Jean VI Cantacuzegravene et ses copistes in A Rigo (a cura di) Gregorio Palamas e oltre Studi e documenti sulle controversie teologiche del XIV secolo bizantino Firenze 2004 pp 249-296
Mondrain 2007 = B Mondrain Les eacutecritures dans les manuscrits byzantins du XIV e siegravecle Quelques probleacutematiques laquoRSBNraquo n s 44 (2007) pp 157-196
Peacuterez Martiacuten 2006 = I Peacuterez Martiacuten Maxime Planude et le Diophantus Matritensis (Madrid Biblioteca Nacional ms 4678) un paradigme de la reacutecupeacuteration des textes anciens dans la ldquorenaissance paleacuteologuerdquo laquoByzantionraquo 76 (2006) pp 433-462
Peacuterez Martiacuten 2008 = I Peacuterez Martiacuten El lsquoestilo Hodegosrsquo y su proyeccioacuten en las escrituras constantinopolitanas laquoSampTraquo 6 (2008) pp 389-458
Perria 1991 = L Perria Scrittura e ornamentazione nei codici della laquocollezione filosoficaraquo laquoRSBNraquo n s 28 (1991) pp 45-111
Rollo 2012 = A Rollo LrsquoArchimede di Giorgio Valla in V Fera ndash D Gionta ndash A Rollo (a cura di) Archimede e le sue fortune Atti del Convegno di Siracusa-Messina 24-26 giugno 2008 Messina 2012 pp 99-147
Rome 1927 = A Rome Membra disjecta laquoRBenraquo 39 (1927) pp 187-188
Rome 1938 = A Rome Un manuscrit de la bibliothegraveque de Boniface VIII agrave la Meacutediceacuteenne de Florence laquoACraquo 7 (1938) pp 261-268
Ronconi 2013 = F Ronconi La collection philosophique un fantocircme historique laquoScripto-riumraquo 67 (2013) pp 119-140
Tannery ndash Steacutephanou 1940 = Quadrivium de Georges Pachymegravere ed P Tannery ndash E Steacutephanou Cittagrave del Vaticano 1940
Tihon 2011 = Πτολεμαίου Πρόχειροι Κανόνες Les Tables faciles de Ptoleacutemeacutee vol Ia Tables A1-A2 ed A Tihon Leuven 2011
Traube 1907 = L Traube Nomina Sacra Versuch einer Geschichte der christlichen Kuumlrzung Muumlnchen 1907
Vogel 1936 = K Vogel Beitraumlge zur griechischen Logistik laquoSBAWraquo Mathematisch-natur-wissenschaftliche Abteilung Jahrgang 1936 pp 357-472
Wouters 1979 = A Wouters The Grammatical Papyri from Graeco-Roman Egypt Contri-butions to the Study of the lsquoArs Grammaticarsquo in Antiquity Brussel 1979
F ACERBI Tav 1
b Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 65r
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 284 f 160r
F ACERBITav 2
b Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 13r
a Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 19v
F ACERBI Tav 3
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 136v
F ACERBITav 4
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17r
F ACERBI Tav 5
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17v
F ACERBITav 6
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 7v
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
Fabio Acerbi142
ἐκθέμενοι οὖν διάγραμμα τῶν ἀριθμῶν ὡς ὑπόκειται προτάσσομεν τὸν μεριζόμενον καὶ μικρὸν ὑπ᾽ αὐτὸν τὸν μερίζοντα ὡς ἔχει τὸ διάγραμμα ἐν στίχοις διοριζομένοις ὑπὸ γραμμῶν [hellip] καὶ τὰ μὲν γινόμενα ἐγγὺς ἐλάττονα ἐν τῇ μεταξὺ θέσει τοῦ μεριζομένου καὶ τοῦ μερίζοντος ἐν στίχοις παρασημειοῦσθαι πρὸς τὸ ἀσύγχυτον εἶναι τὴν τάξιν τὰ δὲ μεθ᾿ ὧν ὁ μερίζων ἐποίει τοὺς ἀεὶ ἐλάσσονας ὑπὸ τὸν μερίζοντα σημειοῦσθαι προγράφοντας ἐπὶ τοῦ στίχου αὐτῶν τὸ γίνεται οὕτως γι ἐν δὲ τῷ στίχῳ τῶν μεριζόντων τὸ παρὰ ἔχον οὕτως oslash ἀντὶ τοῦ παρ᾿ ἃ δεῖ τὸν μερισμὸν γίνεσθαι ἐν δὲ τῷ στίχῳ τῶν ἐλασσόνων τὸ αφ διὰ τὸ τούτους ἀεὶ ἀφαιρεῖσθαι ἀπὸ τῶν ἐπάνω τῶν μεριζομένων ἐν δὲ τοῖς τοῦ μεριζομένου λοιπάσμασι τοῖς καὶ ἐπιοφείλουσι τὸ λ κατὰ τὸ ἴδιον τῶν διαστάσεων ἑκάστης ndash λέγω δὴ λοιπάδος ndash ἀντὶ τοῦ λοιποὶ οἱ μέλλοντες ἐπιμερίζεσθαι
2 post τὸν suprascr τὸν ἐλάττονα m 2 S 5 πρὸς] MP et ex corr Z κατὰ S om C | ἀσύγχυτον] MSPC -χητον Z 6 ἀεὶ] MZPC ὡσεὶ S 7 γίνεται οὕτως γι ] γι τ οὕτως γι τ M γί οὕτως γί Z γι οὕτως γί SC τὸ γινόμενον οὕτως γίνεται P 8 τὸ παρὰ ἔχον οὕτως] scripsi τὸ παρέχον οὕτως M et π(αρ-) comp Z οὕτως τὸ περιέχον S προγράφοντας οὕτως ex corr m 2 P τὸ περιέχον οὕτως C | oslash] MZSC (sed ο fecit | Z) ἐλάττων comp ex corr m 2 P | παρ᾿ ἃ] scripsi παρα M π(αρα) comp ZSC ex παρα fe-cit παρὰ et τοῦτον suprascr m 2 P 9 γίνεσθαι] comp C | αφ ] αφ ε M ἀφ ZSC ἀφαί P | ἀεὶ] om M 11 ἐπιοφείλουσι] MZSC ex ἐπιο- fecit ἐπο- m 2 P | λ] MZPC λ´ S 12 λοιποὶ] PC λοιποῦ MZS
3 στίχοις] στίχῳ K 5 πρὸς] διὰ K 7 ἐπὶ mdash γι ] τὸ γίνεται διὰ τοιούτου σ(ημείου) γί K 8 τὸ παρὰ ἔχον mdash παρ᾿ ἃ] τὸ παρᾱ διὰ σ(ημείου) τοιούτου καὶ τοῦτο oslash δηλοῦντος τοῦ παρᾱ ὅτι παρὰ τὸν τοιοῦτον (ἀριθμὸν) K 9 αφ διὰ τὸ τούτους] ἀφ δηλοῖ δὲ τοῦτο ἀφαίρεσ(ιν) ὅτι τούτους ἀεὶ δεῖ K 11 ἐπιοφείλουσι] ἐπιμερίζεσθαι ὀφείλουσι K | λ] λ οι` K 12 ἀντὶ τοῦ] δηλοῦντος τοῦ σ(ημείου) τὸ K
lsquoRendendo esplicito un diagramma numerico come lo troviamo qui sotto disponiamo in primo luogo il dividendo e un poco al di sotto di esso il divisore come li ha il diagramma in righe delimitate da linee [hellip] e lsaquooccorreragraversaquo nella posizione tra il dividendo e il divisore annotare lrsquouno accanto allrsquoaltro i piugrave vicini lsaquodei numerirsaquo minori che risultano affincheacute la disposizione non sia confusa quelli con cui il divisore faceva ogni volta i lsaquonumerirsaquo minori annotarli sotto il divisore scrivendo in prima posizione sulla loro riga laquorisultaraquo cosigrave Ris nella riga dei diviso-ri52 invece laquoperraquo fatto cosigrave53 P in luogo di laquoquelli per cui deve farsi la divisioneraquo nella riga dei lsaquonumerirsaquo minori laquosottrraquo in quanto questi sono sempre sottratti dai dividendi che si trovano sopra nei residuli del dividendo (occorre ben farlo anche per loro) laquoReraquo in accordo con ciograve
52 I laquodivisoriraquo sono al plurale ma siamo semplicemente di fronte a un tratto idioma-tico della lingua greca nel caso di espressioni generalizzanti crsquoegrave soltanto un divisore che occupa lrsquounica colonna di cui si compone la sua riga
53 Si intenda ἔχον οὕτως = ita se habens
1
5
10
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 143
che egrave proprio agli scarti di ciascuno ndash intendo qui lsaquociascunrsaquo residuo54 ndash in luogo di laquoresti che vanno a essere divisi ulteriormenteraquorsquo
a) Operatori di citazione e segni convenzionali I segni introdotti sono quattro la mia discussione egrave condotta dando per scontato che essi siano identici a quelli impiegati dallrsquoautore dei Prolegomena anche se si tratta di unrsquoipotesi non corroborabile neacute falsificabile
i Segno per il risultato Lrsquoabbreviazione convenzionale per γίνεται egrave identica al segno introdotto dallrsquoautore e i copisti si dividono tra i due errori possibili scrivere due abbreviazioni o risolverle entrambe Un fenomeno del tutto analogo si riscontra nel Matr 4678 il manoscritto alla base di tutta la tradizione degli Arithmetica di Diofanto al momen-to della definizione dellrsquoἀριθμός (lrsquolsquoincognitarsquo nel nostro linguaggio) ὁ δὲ μηδὲν τούτων τῶν ἰδιωμάτων κτησάμενος ἔχων δὲ ἐν ἑαυτῷ πλῆθος μονάδων ἄλογος ςο` καλεῖται ς` ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον τὸ ς` laquoil lsaquonumerorsaquo che non possiede nessuna di queste proprietagrave ma che ha in seacute una molteplicitagrave indefinita di unitagrave egrave chiamato lsquonumerorsquo e il suo segno egrave ς`raquo Qui solo il terzo dei tre ς ha una barra a sormontare per segnalarne il carattere puramente denotativo (cioegrave di segno convenzionale e non di abbreviazione si veda il punto successivo)55 il primo egrave una delle abbreviazioni piugrave diffuse per ἀριθμός (e infatti egrave dotato del compendio per la desinenza e dellrsquoaccento grave) il secondo egrave una delle piugrave comu-ni per καὶ () Giovanni Cortasmeno autore di capillari annotazioni infra lineam agli Arithmetica nel codice madrileno scioglie il primo ςο`
54 Doppia variatio che impiega al posto di λοιπόν laquorestoraquo i due termini decisamente non canonici τὸ λοίπασμα e ἡ λοιπάς (piugrave oltre leggiamo anche il participio λοιπασθέντα) Una ricerca sul TLG in rete non ha fornito occorrenze del primo si tratta dunque di uno hapax Quanto al secondo che ricorre anche nella sezione sulla divisione lsquoalla Papporsquo lo si rintraccia giagrave nei papiri documentari il termine diventeragrave perograve canonico nelle esposizioni bizantine drsquointroduzione allrsquoAlmagesto ricalcate sul modello dei Prolegomena (si veda la nota 87 infra) Questi due termini designano i resti parziali prodotti nel corso di una divisione lunga li ho tradotti rispettivamente con il neologismo laquoresiduloraquo e con il sostantivo pari-menti non canonico laquoresiduoraquo
55 Il copista interpreta erroneamente il terzo segno come unrsquoabbreviazione e qui ag-giunge un apice inverso (cioegrave un accento grave) altrove lo scioglie direttamente in forme opportune di ἀριθμός Matr 4678 f 58v La frase come la leggiamo nel manoscritto egrave cor-rotta sulla base di una parafrasi in Psello (edita in DOO II p 3710-12) Tannery emendograve ἄλογος in ἀόριστον DOO I p 64-5 et app Il Matritensis vergato da due copisti differenti (cambio di mano a tre righe dalla fine del f 62r) contiene lrsquoIntroductio arithmetica di Nicomaco e le opere diofantee oltre ad alcuni brevi opuscoli musicali la sua data egrave stata recentemente corretta dal XIII al secolo XI pm in Peacuterez Martiacuten 2006 (una riproduzione digitale del manoscritto si trova allrsquoindirizzo httpbdhbneesbnesearchbibliotecaDio-fanto20de20AlejandrC3ADa)
Fabio Acerbi144
in ἀριθμός ed aggiunge un altro segno56 sopra il terzo anteponendovi lrsquoindicazione καὶ ἔστιν αὐτοῦ σ(ημεῖον) τόδε Va da seacute che non abbiamo nessuna garanzia che il segno originariamente introdotto da Diofanto coincidesse realmente con unrsquoabbreviazione convenzionale per ἀριθμός Lrsquoevidenza del PMich III 144 (sec II in) suggerisce drsquoaltronde che il Matritensis e con esso tutta la tradizione medievale di Diofanto ripro-duca fedelmente pur accentuandone la sinuositagrave il segno originario
ii Segno per il divisore Un cerchiolino sbarrato da non confondere con il segno per ὁμοῦ che nei manoscritti matematici ha di norma due barre trasversali (cf tav 2a) Non sono riuscito a rintracciarne ulteriori occorrenze in altre opere la forma che esso assume nel Vat gr 2326 e la correzione apportata nel Par gr 2390 lasciano aperta la possibilitagrave per quanto a mio avviso remota che la forma originaria non fosse lon-tana da unrsquoabbreviazione di παρά registrata nei repertori57 Il correttore del Par gr 2390 trasforma in effetti il segno oslash nellrsquoaffine abbreviazione canonica per (forme di) ἐλάσσων laquominoreraquo58 e si incarica diligente-mente di farlo notare ricapitolando i segni nella porzione superiore del margine esterno del f 7v Nello stesso margine egli traccia anche uno lsquoscolio tabellarersquo ed egrave lrsquounico a porre il (proprio) segno dove indicato dalla descrizione (tav 6 Par gr 2390 f 7v) Oltre a ciograve adattando la tabella al margine ristretto lo scoliaste trascrive come colonne affian-cate le due righe dei resti parziali e dei massimi multipli e aggiunge le indicazioni ὁ μεριζόμενος laquodividendoraquo e ὁ μερίζων laquodivisoreraquo ma vi introduce alcune incongruenze di formato il risultato scritto in verti-cale e la linea verticale di sinistra che separa il divisore dal segno che lo dovrebbe precedere direttamente
iii Segno per i massimi multipli Corrisponde alla semplice abbre-viazione per sospensione della forma verbale ἄφελε laquosottrairaquo in questo
56 Si tratta del segno di ampio uso praticamente identico allrsquoabbreviazione canonica per οὖν
57 Si tratta di un pi a forma di gancio sbarrato da uno slash di troncamento Ce-reteli 1904 tav IX item 7 sub ΠΑΡΑ che rinvia al PVindRain 423 cf anche la forma π` nel POxy LXI 4142 edito in Jones 1999 II pp 26-34 In generale nei papiri e nei manoscritti matematici in maiuscola le preposizioni sono abbreviate facendo seguire un lsquoapostroforsquo alla loro prima lettera Α᾽ Υ᾽ ecc Per la seconda fattispecie di supporto libra-rio si veda in particolare il cosiddetto fragmentum mathematicum Bobiense scriptio inferior databile al V-VI secolo del palinsesto Milano Biblioteca Ambrosiana L 99 sup (Isidoro di Siviglia Etymologiae datazione Cavallo 1977 p 100) pp 113-114 che sono stampate in riproduzione apografa conforme in Belger 1881 (la p 114 egrave riprodotta anche nella tav 10 di Acerbi 2010)
58 Se questa era lrsquointenzione si tratta ovviamente di una forzatura il divisore puograve ben essere maggiore del dividendo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 145
caso lo slash di troncamento taglia orizzontalmente il tratto verticale del phi I copisti offrono molteplici varianti apponendo chi uno spirito dolce chi un ε chi un αί accentato a sormontare Tutti questi segni svolgono la funzione di abbreviazioni vere e proprie (e cosigrave doveva essere anche per lrsquoautore si veda il punto 1 di p 153 infra) la forma originale si ottiene a mio avviso incrociando i dati del Marc gr 313 e dei tre apografi del Vat gr 1594 αφ anche se lrsquoassenza dello spirito potrebbe essere semplicemente dovuta alla pratica del copista del codice veneziano di economizzare nei diacritici
iv Segno per i resti Un lambda completato da una barra a sormon-tare o da un apice che rinvia alle abbreviazioni per sospensione di una forma opportuna di λοιπός laquorestoraquo In realtagrave la forma che troviamo nella tabella egrave differente (tav 2b) e coincide con quella offerta quasi unanimemente dai manoscritti nella descrizione e in almeno un caso nella tabella del metodo di divisione attribuito a Pappo (tav 4) un lambda che accoglie al di sotto una legatura omicron-iota () sbarrata da uno slash di troncamento Qualcosa di simile si trova nel PVindob G 19996 (sec I) una specie di lambda maiuscolo molto aperto e dal vertice arrotondato che include un circoletto interpretato dagli editori come segno per περίεστιν o per λοιπόν59 Lo stesso segno si rintraccia ad esempio in un medesimo scolio tabellare di prima mano ad Alma-gestum nel Vat gr 1594 f 93v e nel Marc gr 313 f 135r ma stavolta la forma del lambda egrave molto ben definita
Fin qui i segni Ma il gioco egrave piugrave complesso La descrizione si muo-ve pericolosamente sulla linea di confine non sempre ben definita tra segno convenzionale e abbreviazione il primo ndash e il repertorio grafico matematico-astronomico ne egrave particolarmente fornito60 ndash puograve anche
59 Ho consultato lrsquoedizione Gerstinger ndash Vogel 1932 pp 46 e 48 la porzione rilevante del papiro egrave riprodotta nella tav 11 di Fowler 1999 Si veda ancora ivi pp 253-257 per la trascrizione di questo segmento di testo (con correzioni rispetto alla princeps) e per una messa a punto recente inclusa la proposta di datazione che ho riportato qui sopra Il verso del papiro che contiene una tavola aritmetica del tutto scorrelata dalla tematica del recto egrave edito come PRain Unterricht 151
60 La pratica di ridurre lo spazio occupato da un testo tecnico per mezzo di abbreviazioni e segni convenzionali era molto diffusa nei manoscritti in maiuscola contrariamente a quanto avviene per altri generi letterari vedremo tra breve cosa accade negli Arithmetica di Diofanto ma si leggano in proposito anche le considerazioni di Hei-berg nei prolegomena alla propria edizione dellrsquoAlmagesto in particolare riguardo al ricorso massiccio ad espedienti brachigrafici nel modello del Vat gr 180 POO II pp lxxxiv-xciii civ-cv cxxvii cxxxviii-cxxxix Agli elenchi dettagliati forniti da Heiberg possiamo aggiungere il piccolo prontuario stampato in Hultsch 1876-1878 III 2 pp 126-132 e basato sul testo e sugli scolii alla Collectio di Pappo nel Vat gr 218 (sec X in) Si vedano infine le osservazioni del copista del Par gr 2360 f 120v trascritte da Heiberg in AOO III pp x-xi sulle laquonotazioni tipiche a scopo di tagliar corto nello scrivereraquo impiegate nel pro-
Fabio Acerbi146
derivare dalla seconda (un caso egrave appunto il segno per ἐλάσσων che probabilmente trae origine da una legatura epsilon-lambda) ma poi il rapporto referente-relato si fissa convenzionalmente Quelli definiti nel testo che abbiamo letto sono appunto segni convenzionali non ci sarebbe bisogno di spiegarne forma e funzione se fossero intesi come abbreviazioni assumono nella tabella una funzione denotativa non esplicativa o discorsiva (come accade invece nella tav 1a) Ma come vengono descritti questi segni
I referenti delle descrizioni sono i segni sono introdotti da οὕτως (item i-ii) o in alternativa da un τό con il ruolo di lsquooperatore di citazionersquo (item iii-iv) che corrisponde esattamente alle nostre virgolette In entram-bi i casi gli enti sono menzionati e svolgono una funzione metalinguistica sono collocati materialmente nel testo ma egrave come se si trovassero fuori e la loro descrizione li additasse ndash in effetti i segni convenzionali scritti nel testo sono a loro volta i relata di quelli che si trovano nella tabella
I relata dei segni scritti nel testo sono di due tipi singoli vocaboli (item i-ii) o descrizioni della funzione dei segni per mezzo di clausole sintaticamente complesse (item ii e iv) I singoli vocaboli sono γίνεται e παρά e sono entrambi preceduti dal τό lsquocitazionalersquo in quanto relata di segni convenzionali le forme abbreviate con cui sono tracciati nei manoscritti vanno forzatamente sciolte Bisogna ammettere che la per-spicacia e le risorse grafiche dei copisti ndash di cui tutto si puograve dire fuor che commettano qui degli errori ndash sono messe a dura prova con lrsquointrodurre segni identici ad abbreviazioni o con lrsquoattivare un gioco metalinguistico particolarmente serrato in un contesto meno lsquonaturalersquo di come potreb-be esserlo ad esempio quello di un trattato grammaticale Lrsquoitem iii che presenta direttamente un segno identico ad unrsquoabbreviazione non egrave sorretto da una descrizione ma da una giustificazione in διὰ τό Lrsquoartico-lo τό vi assume una funzione metalinguistica anche se non lsquocitazionalersquo poicheacute al tempo stesso genera un infinito sostantivato e lo singolarizza per questo ho scritto laquosono sottrattiraquo in corsivo nella mia traduzione
prio modello archimedeo (nota 32 supra) egli ne compila anche una breve lista Un elenco antico di laquosegni della geometriaraquo sicuramente redatto per assistere il copista si trova anche al f 3v del ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 vergato da Efrem negli anni 950-960 (tav 8 in Acerbi 2010) Possiamo farci unrsquoidea quantitativa del guadagno di spazio in rapporto ad un testo privo di abbreviazioni e con le parole separate da spazi sulla base del fragmentum mathematicum Bobiense il testo vi egrave disposto a tutta pagina su 36 righe di circa 30 segni ciascuna nelle due pagine in questione figurano 2038 segni con 15 mezze righe occupate dalle due figure Ora nel testo dellrsquoedizione stabilita in Heiberg 1927 pp 87-90 le stesse pagine contano 4455 segni spazi compresi Ne risulta che la dimensione in caratteri di un testo matematico puograve essere ridotta di piugrave della metagrave con lrsquoimpiego di compendi e segni convenzionali
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 147
Negli item ii e iv il segno si collega ad una descrizione nel secondo caso in via esclusiva le descrizioni pertanto rinforzano o sostituiscono lrsquoidentificazione con lrsquoente linguistico denotato Le clausole descrittive sono precedute da ἀντί e dallrsquoarticolo τό con funzione di lsquooperatore di citazionersquo esse sono παρ᾿ ἃ δεῖ τὸν μερισμὸν γίνεσθαι (item ii) e λοιποὶ οἱ μέλλοντες ἐπιμερίζεσθαι (item iv) Nella descrizione della divisione lsquoalla Papporsquo che leggeremo tra breve i segni negli item iii e iv rice-vono lo stesso trattamento degli altri due il loro relatum egrave un singolo vocabolo e non una clausola descrittiva rispettivamente nelle espres-sioni τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε (sul participio ritorneremo nel punto 1 infra) e τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά (la forma del segno notato con λ οι egrave descritta supra nellrsquoitem iv) La descrizione del segno oslash per il divisore merita una discussione piugrave dettagliata In origine si trovava probabilmente scritto Π(ΑΡΑ)ΕΧΟΝ successivamente letto come π(αρ[α])έχον ndash dato che lrsquoabbreviazione per il preverbo egrave identica a quella per la preposizione (che sia Π᾽ o un pi seguito dal segno per ἄρα a sormontare) ndash invece di π(αρὰ) ἔχον I copisti e i correttori si dettero a tutte le possibili contorsioni per restituire un testo dotato di senso leggere appunto una forma verbale con preverbo modificare il preverbo (ma forse il segno per ἄρα era insidiosamente simile ad uno epsilon) correggere il testo rileggiamo lrsquoapparato sub τὸ παρὰ ἔχον οὕτως τὸ παρέχον οὕτως M et π(αρ-) comp Z οὕτως τὸ περιέχον S τὸ περιέχον οὕτως C προγράφοντας οὕτως ex corr m 2 P Nella clausola descrittiva seguente la presenza liminare di παρὰ (che ho corretto in παρ᾿ ἃ nella speranza di restituire una frase che abbia un senso senza intervenire sul testo) innesca un bel corto circuito il Π(ΑΡΑ) che sicuramente figu-rava nellrsquoarchetipo egrave un sintagma complesso una preposizione unrsquoab-breviazione o un segno per unrsquoabbreviazione Se lrsquoeditore si trova in conflitto con la propria inclinazione alla critica conservativa i copisti si rifiutarono di mettere mano ad un testo che doveva stridere anche per loro essendo il compito demandato al ritocco del revisore del Par gr 2390 o alla riscrittura radicale del recensore bizantino Il problema egrave che ci troviamo di fronte ad unrsquoespressione che descrive la funzione dellrsquooggetto denotato non lrsquooggetto stesso ma che lo contiene al suo interno per soprammercato qui il Π(ΑΡΑ) egrave usato per giustificare una menzione a sua volta relatum di un segno
Evidentemente questa maniera di procedere che giagrave aveva attirato interventi da parte di copisti e correttori della recensione di base parve insostenibilmente opaca allrsquoautore della recensione bizantina61 Egli
61 Uno dei manoscritti di questa recensione propone anche una tabella di divisione
Fabio Acerbi148
modifica tutte le descrizioni diluendo lrsquoidiomatismo dellrsquoarticolo lsquocita-zionalersquo con lrsquointroduzione sistematica del verbo δηλόω e di frasi atte a chiarire quale sia il segno denotante e quale il vocabolo (o il segno) denotato Egli introduce allo scopo di rendere esplicita la funzione de-notativa dei segni introdotti il termine σημείου curiosamente in tutte le sue tre occorrenze esso compare a sua volta nella forma dellrsquoabbrevia-zione per sospensione σΗ´ Egli traccia il segno per i massimi multipli ἀφ e quello per i resti λ οι` in modo che non vi siano ambiguitagrave quanto al loro carattere di abbreviazione Si faccia infine attenzione al residuo di barra sul παρᾱ con funzione denotativa (2 occorrenze) contenuto nella descrizione del segno per il divisore sostituita dallrsquoaccento grave nel παρὰ con funzione discorsiva (la differenza egrave nettissima nei manoscritti da me consultati) Questa osservazione ci permette di passare direttamente allrsquoitem seguente
b) Le barre sui numerali e sulle lettere denotative Egrave opportuno discutere questo punto adesso esattamente percheacute di barre siffatte che pure troviamo in tutti i manoscritti i nostri testi non fanno mai menzione si tratta infatti di una pratica condivisa sin dallrsquoantichitagrave La barra identifica una stringa di lettere dellrsquoalfabeto che non svolge una funzione grammaticale o sintattica propria allrsquointerno del discorso Ciograve avviene in particolare e si tratta della fattispecie piugrave frequente se la stringa di lettere non dagrave origine a un vocabolo della lingua greca lette-re denotative e numerali certo ma anche termini provenienti da altri idiomi e contrazioni di parole greche come i nomina sacra62 tali termi-ni possono essere o no preceduti da un articolo lsquocitazionalersquo a seconda dellrsquouso che ne viene fatto allrsquointerno del discorso Ma non si tratta dellrsquounica fattispecie i papiri grammaticali ed i manoscritti piugrave antichi dei trattati dello stesso argomento segnalano gli esempi delle parti del discorso (cioegrave di lsquoverersquo parole greche) per mezzo di barre sormontanti63 La differenza insomma egrave tra menzione e uso (come parte del discorso in atto) di una stringa di caratteri tra il porre le lsquovirgolettersquo e il non porle tra funzione denotativa e non Apparentemente la convenzione si limi-
corredata dei segni opportuni e contrariamente alle indicazioni della descrizione svilup-pata lsquoin verticalersquo ma per motivi misteriosi non completa (tav 7a Laur Plut 89 sup 48 f 13r)
62 Tutto ciograve egrave spiegato con estrema chiarezza giagrave in Traube 1907 pp 45-4763 Si veda il Par gr 2548 codex vetustissimus e testimone unico delle lsquoopere minorirsquo
di Apollonio Discolo il f 106v con le barre ben visibili egrave riprodotto come tav 19 in De Gregorio 2000 (ivi pp 137-138 per la datazione) Per la testimonianza dei papiri grammaticali si veda Wouters 1979 passim essi contengono di norma elenchi di parti del discorso nessuna delle quali egrave preceduta dallrsquoarticolo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 149
tava in questo secondo caso a segnalare con la barra singoli vocaboli le menzioni di frasi o di sintagmi complessi sono di norma identificate dallrsquoarticolo lsquocitazionalersquo Drsquoaltra parte le abbreviazioni convenzionali non rientrano nella casistica percheacute la loro resa grafica che contiene elementi non alfabetici come compendi per desinenze lettere supra li-neam marche di contrazione o sospensione quali slashes o barre sotto-poste o sormontanti eventualmente solo un sottinsieme della stringa di segni alfabetici le esclude automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
Venendo al discorso matematico una barra sormonta senza ecce-zione le lettere denotative64 che sia in papiri o in manoscritti in maiu-scola65 o minuscola ma solo allrsquointerno del testo comrsquoegrave da attendersi nei diagrammi esse la perdono per il semplice motivo che non crsquoegrave alcun testo ambiente un diagramma ha unicamente una funzione denotati-va Drsquoaltra parte le lettere numerali che a volte figurano nei diagrammi della tradizione metrica66 allo scopo di indicare la lunghezza dei seg-menti mantengono la barra in un diagramma il contesto denotativo geometrico egrave prevalente e i numerali vengono percepiti come entitagrave grafiche lsquoesternersquo al discorso Va da seacute a fortiori che le lettere numerali inserite in un testo dovranno essere segnalate da barre che a loro volta non servono nelle tavole67 in quanto queste ultime sono come abbiamo visto un vero e proprio testo che perograve funge da ambiente a quello al-fabetico limitato alle titolazioni e non a caso tracciato in unrsquoopportuna lsquomaiuscola distintivarsquo allo scopo di segnalarne il carattere denotativo e non discorsivo68 Una tabella operazionale egrave invece un paratesto e quindi le barre sulle lettere numerali che rappresentano gli interi sono
64 La notazione per le lettere denotative subigrave unrsquoevoluzione (il cui risultato finale egrave descritto per sommi capi nella nota 3 supra) di cui non mette conto occuparsi qui
65 I papiri di contenuto geometrico (o astronomici ma che presentano argomenti geometrici) sono rari si vedano il PHerc 1061 (sec II aC Demetrio Lacone De geome-tria) e il PFay 9 (sec II ex Elementi I 39 e 41) Gli importanti ostraka OBerl 12002 e 12609 (sec III aC m Elementi XIII) non pongono le barre sopra le lettere denotative Per i manoscritti in maiuscola si veda ad esempio passim nel Par gr 2389 una cui riproduzione digitale egrave consultabile in rete allrsquoindirizzo httpgallicabnffrark12148btv1b8470171d o il fragmentum mathematicum Bobiense
66 Si veda ancora il ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 codex unicus dei Metrica di Erone e contenente una raccolta importante di problemi del corpus metrologico
67 Si vedano come esempio le tavole citate alle note 10 e 14 supra Discorso a parte per il segno di lsquoposto vuotorsquo si veda il punto c che segue
68 Queste regole generali vanno prese cum grano salis si dagrave naturalmente un certo dominio di variabilitagrave legato verosimilmente al grado di cultura grafica del copista nel PMich III 144 i numerali sono quasi tutti senza barra sia nel testo che nelle tabelle ope-razionali
Fabio Acerbi150
necessarie esse mancano invece sui segni convenzionali che ho descrit-to nel punto precedente e fatto rilevante sulle lettere numerali relative agli ordini sessagesimali quando esse siano identificate da uno o piugrave apici la presenza di questo segno grafico non alfabetico69 le esclude ancora una volta automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo Unrsquoultima osservazione che ci saragrave utile nel seacuteguito la descrizio-ne di una stringa di lettere lsquoagrammaticalersquo non puograve prevedere la men-zione della presenza della barra che le pertiene in quanto tale si tratta di una pratica denotativa che egrave possibile formulare soltanto ad un livello di discorso superiore sia a quello dellrsquouso che a quello della menzione70
c) Il segno di lsquoposto vuotorsquo Si noti nella tav 2b la forma ŏ per il segno di lsquoposto vuotorsquo in un ordine sessagesimale coerentemente con la propria notazione il copista del Marc gr 313 lo scioglie talvolta allrsquoin-terno del testo principale come unrsquoabbreviazione per οὐδέν laquonienteraquo Altre convenzioni di scrittura del tratto che accompagna il circoletto e che si badi bene fa parte integrante del segno di lsquoposto vuotorsquo ndash e infatti nelle tavole troviamo sempre il segno completo mentre tutti gli altri numerali sono come abbiamo visto nel punto precedente privi di barra o di apice a causa del fatto che i vari ordini sessagesimali sono univocamente determinati dalle linee di giustificazione ndash un tratto an-golare anteposto (tav 3 Lar Plut 2818 f 136v)71 o una semplice barra a sormontare (tavv 4-9) si produce in questo modo il segno 65926 che sembra essere stata la forma di base72
69 Occorre dunque supporre come testimoniano papiri e manoscritti in maiuscola che la convenzione relativa allrsquouso della barra si sia consolidata ben prima dellrsquointroduzione di segni diacritici quali accenti e spiriti
70 Si veda il punto 2 infra per maggiori dettagli sulla questione delle barre e degli apici e per le indicazioni in merito che leggiamo in Diofanto
71 Come accennato questa tavola dei sottomultipli coincide con quella descritta ed esposta nei Prolegomena Fatto molto rilevante i numerali nella prima non recano neacute barre neacute apici contrariamente a quanto accade a tutte le istanze della seconda nei manoscritti Quella del Laur Plut 2818 preserva a mio avviso la forma originaria come abbiamo visto una tavola non richiede segni aggiuntivi sulle lettere numerali
72 Si vedano come esempio ancora le tavole citate alle note 10 e 14 supra oppure per una rassegna delle forme che il segno assume nei manoscritti piugrave antichi delle Tavole facili Tihon 2011 pp 58-59 e per quelle che assume nei papiri Jones 1999 I pp 61-62 Ovviamente non possiamo leggere il segno 65926 come un omicron con una barra in quanto ο = 70 nella notazione greca e la barra egrave di rigore quando il numerale figuri allrsquointerno di un testo Occorre ammettere che si dagrave origine ad un bel corto circuito notazionale con il concepire un segno con funzione di lsquoposto vuotorsquo ma che lsquosomigliarsquo ad una lettera dellrsquoalfabeto sormontata da una barra cioegrave ad un numerale in piugrave quando il lsquoposto vuotorsquo non corrisponda ad un intero ma ad una specie sessagesimale la presenza della barra a priori indistinguibile da quella che sormonta gli interi introduce unrsquoincongruenza con la notazione a mezzo di apici vista nellrsquoitem precedente
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 151
d) Errori di copia La tabella riprodotta nella tav 2b ha una forma simmetrica ma si tratta di una forzatura il grande rettangolo in basso a destra drsquoaltronde assente nella descrizione contiene uno scolio che fa notare come lrsquoultimo resto parziale ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ͵γτνζ´´´´´ κζ´´´´´´ cioegrave 0 0 0 0 0 3357 27 siano ἔγγιστα λ´λ´ δ´δ´ ξ laquocon ottima approssimazione 60 minuti quartiraquo dove si notino gli apici semplici per indicare il pas-saggio allrsquoordinale e il raddoppiamento del sistema segno + apice per significare il plurale Lo scolio debitamente accompagnato dal segno di rimando in forma di simbolo solare egrave stato probabilmente incluso nella tabella proprio allo scopo di renderla simmetrica A sua volta un errore precedente spiega lo spazio eccessivo accordato al rettangolo contenente lo scolio il secondo massimo multiplo ŏ λβ´ ξδ´´ ριβ´´´ σιϛ´´´´ egrave trascritto anche al di sotto del risultato
Passiamo ora alla descrizione del metodo di divisione attribuito a Pappo
ἵνα οὖν ταῦτα συναχθῇ τὰ ἐκ τοῦ μερισμοῦ ὁ εἰρημένος Πάππος εὐδιατύπῳ τινὶ καὶ πρὸς τοῦτο τάξει χρησάμενος ποιεῖται τὴν τῆς συλλήψεως τοῦ ζητουμένου ἀνεύρεσιν οὕτως ἐκθέμενος γὰρ τὸν μέλλοντα μερίζεσθαι τουτέστι τὰς τξ μοίρας ἐν ἀρχῇ ἀφαιρεῖ ἀπ᾽ αὐτῶν τὸν ἐν τῇ σελίδι τυγχάνοντα ἐλάττονα τουτέστι τὸν τδ κβ´ κ´´ ὄντα τῶν ἐγγὺς ἐλασσόνων ὡς πρὸς τοὺς ἐκκειμένους διὸ καὶ γράφει αὐτὸν προγράφων αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε καὶ εὑρίσκων τὰ παρακείμενα αὐτῷ τῷ ἀπογραφέντι ἐν τῷ σελιδίῳ λεπτὰ πρῶτα ν´ συναπογράφεται παρατιθῶν αὐτοῖς τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον ἀνατείνουσαν σημαῖνον τὸ εἶδος ὅτι πρῶτα λεπτά εὑρίσκει οὖν οὕτως τὸ τῶν τξ μέρος τὸ τδ κβ´ κ´´ ὃ μεριζόμενον παρὰ τὰς τξε ιδ´ μη´´ ἡμέρας καὶ ποιοῦν τὸν ἐκ τοῦ μερισμοῦ ἀριθμὸν πρῶτα λεπτὰ ν´ καὶ τὸν λοιπὸν ἀπογραφόμενος τὸν νε λζ´ μ´´ προτάσσει αὐτοῦ τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά τάσσει δὲ καὶ ἁπλῆν τινα διατείνουσαν γραμμὴν ὡς ἀπὸ τοῦ τξ ἐπὶ τὸν ἑξῆς ἐκτεθειμένον ἐγγὺς
1
5
10
1 εὐδιατύπῳ] ZSPC εὐδιατύπωτ M 4 ἀφαιρεῖ] MZSP ἀφ ι C 5 ἐλάττονα] P comp MZSC 6 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | αφ ] αφ ε M ἀφ ZS ἀφαί P ἄφ C | ἀντὶ] om C | ἄφελε] MZSP ἄφ C 8 ἀπογραφέντι] MZSP ἐγγραφέντι C | λεπτὰ πρῶτα] P λε πρωτα SC λεπτῶν πρωτ MZ | παρατιθῶν] MZS παρατιθεὶς C et ex corr m 2 P 9 ᾱ] Z αο P α´ MS α C | ἔχον] MPC ἔχων ZS 9-10 πρῶτα λεπτά] ZP πρωτ λ´λ´ M πρωτα λε S αα λε C 11 ἡμέρας] comp codd | ἀριθμὸν] P et comp MZ καὶ C et comp S 12 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M πρωτ λεπτ(α) Z πρωτ λ εᾱ S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C | ἀπογραφόμενος] MZSP ἐγγραφόμενος C | νε λζ´] MZSP λζ νζ C 13 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | λ οι] MZSC ex λ fecit λ οι P | προσσημαῖνον] MC et προσ- comp ZS προση- P | τὸ] MZC τὰ S et fecit m 2 P 14 ἀπὸ] MZSP πρὸς C ἐλάττονα] P comp MZSC
1 εὐδιατύπῳ] εὐδιατυπώτω K 6-7 αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ] τὸ ἀφ K 8 παρατιθῶν mdash 10 λεπτά] τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ σημαίνουσαν τὸ εἶδος αὐτῶν ὅτι ᾱ λεπτά εἰσιν K | τὸ (sec)] τὰ K 12 πρῶτα] πρώτων K | τε λ ] λ οι` K | προσσημαῖνον mdash
Fabio Acerbi152
ἐλάττονα τὸν τδ κβ´ κ´´ ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις καὶ ταύτην ἐπιδεικνύουσαν τὴν τάξιν τῆς προόδου τῆς ἐκθέσεως ἧστινος κλωμένης γραμμῆς πρὸς τῷ ἐγγὺς ἐλάσσονι ἡ ἀντανάκλασις ἐπὶ τὸν λοιπὸν γέγραπται φερομένη ὡς εἴρηται διὰ τὸ εὔτακτον τῆς προκοπῆς οὕτως τε ποιήσας ἑξῆς τὸ αφ ποιῶν ὃ προσσημαίνει ὡς εἴρηται τὸ ὅτι δεῖ ἀφελεῖν ὁμοίως ἀπὸ τοῦ λοιποῦ καὶ δὴ τὸν ἐγγὺς πάλιν ἐλάσσονα ὡς πρὸς τὴν ἐν τῷ σελιδίῳ ἔκθεσιν εὑρισκόμενον λαμβάνων ἑξῆς προγράφει αὐτὸν ὄντα νδ μζ´ ιγ´´ ιβ´´´ καὶ εὑρίσκει αὐτοῖς παρακείμενα ἐν τῷ σελιδίῳ πρῶτα λεπτὰ θ´ ἅτινα καὶ αὐτὰ προσαπογράφεται σὺν τῇ παρασημειώσει τῶν πρώτων γράφων τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον τὴν ἀνατείνουσαν καὶ ὡς εἴρηται τὴν γραμμὴν πάλιν διὰ τὴν τάξιν κλωμένην κατὰ δευτέραν κλάσιν προσέλκει γινομένου τοῦ μέρους αὐτῆς τούτου παραλλήλου τῷ ἐξ ἀρχῆς
16 ante κλωμένης add ἐπὶ C 18 τε] MZP om SC | αφ ] M ἀφ ZSC ἀφαί P 19 προσσημαίνει] MS προση- ZC et ex corr P | ὅτι] ZP comp MSC 20 δὴ] MZSC διὰ fecit m 2 P 21 πρὸς] MSP et supra lineam C ex ἀπὸ fecit m 2 Z | ιγ´´] MZSP νγ´´ C 22 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M ᾱᾱ λεπτὰ Z άάα λε S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C 23 προσαπο- γράφεται] απο suprascr in comp M 24 ᾱ] ZP α´ MS α C 25 κλάσιν] MP τάξιν ZSC | τοῦ] ZSPC τούτου M 26 τούτου] τοῦ bis ZSPC sed prius erasit m 2 P τοῦ M
mdash 18 προκοπῆς] om K | τε ποιήσας] ποιήσας καὶ K | αφ ] ἀφ K 19 τὸ] om K 21 προ-γράφει] γράφει K 22 σελιδίῳ] α´ σελιδίῳ K | ἅτινα] ἃ K 23 προσαπογράφεται] ἀπογράφεται K | τῶν πρώτων mdash 26 ἐξ ἀρχῆς] om K
lsquoAllo scopo di raccogliere ciograve che risulta dalla divisione il detto Pappo utilizzando anche in questo caso una certa disposizione ben strutturata determina nel modo seguente il lsaquonumerorsaquo cercato preso nel suo insieme collocando73 in testa il lsaquonumerorsaquo che sta per essere diviso cioegrave i 360 gradi iniziali sottrae loro tra i piugrave prossimi dei lsaquonumerirsaquo minori rispetto a quelli esposti quello che si trova essere minore nella colonna (cioegrave 304 22 20) Questo egrave il motivo per cui lo trascrive scrivendogli davanti lrsquoabbreviazio-ne laquosottrraquo per laquosottrairaquo e trovando che 50 minuti primi sono collocati accanto a quello stesso lsaquonumerorsaquo che egrave stato trascritto nella colonna li trascrive al tempo stesso collocando accanto74 ad essi la lettera A con un lsaquotrattorsaquo75 sopra che significa la specie minuti primi Trova dunque in que-sto modo la parte di 360 che egrave 304 22 20 la quale divisa per 365 giorni 14 48 fa il numero lsaquoche risultarsaquo dalla divisione 50 minuti primi Trascrivendo
73 La descrizione egrave strutturata come una procedura Acerbi 201274 Il purismo del correttore del Par gr 2390 di Clostomalle nel Marc gr 314 e
dellrsquoautore della recensione bizantina impone loro di modificare la terminazione ma forme tematiche e contratte di τιθεῖν sono correnti nel greco tardivo
75 Il testo greco ha solo il participio con γραμμήν sottinteso Per il significato del participio si veda il punto 2
15
20
25
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 153
poi il resto 55 37 40 gli pone altresigrave76 a prefisso laquoReraquo che significa laquorestiraquo e dispone anche una certa linea semplice77 che va da 360 al piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori che egrave esposto di seacuteguito 304 22 20 come nello lsaquoschemarsaquo esposto linea che mostra lrsquoordine del percorso dellrsquoesposizione Questa linea spezzata lagrave dove si trova il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori egrave tracciata inflessa allrsquoindietro lsaquoersaquo punta verso il resto come egrave stato detto in vista di una progressione ordinata E cosigrave facendo prendendo di seacuteguito il laquosottrraquo che significa come egrave stato detto laquoche occorre similmente sottrarre dal re-storaquo e ovviamente prendendo di nuovo il lsaquonumerorsaquo che egrave trovato essere il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori in relazione alla disposizione nella colonna ndash 54 47 13 12 ndash lo scrive di seacuteguito e trova che 9 minuti primi sono posti loro accanto nella colonna trascrive78 anche questi con la segnaletica dei primi scrivendo la lettera A con un lsaquotrattorsaquo sopra e come egrave stato detto prolunga di nuovo la linea spezzata in vista di una buona disposizione tramite una seconda inflessione essendo questa sua parte parallela a quella inizialersquo
La descrizione continua con una serie di laquoe cosigrave viaraquo e non fa ulte-riore riferimento alla tabella
1) La forma verbale ἐξεσμένον Egrave il neutro del participio perfetto medio-passivo di ξέω lett laquopialloraquo laquolevigoraquo Si danno tre possibilitagrave si tratta di un termine canonico per quanto non altrove attestato per designare unrsquoabbreviazione oppure lrsquoautore anonimo improvvisa sul piano metaforico come se unrsquoabbreviazione non fosse altro che la paro-la completa lsquoaccorciata a colpi di piallarsquo in maniera opportuna oppure il testo egrave corrotto e srsquoimpone una correzione ad esempio τὸ ἑξῆς μένον laquociograve che sta di seacuteguitoraquo Questrsquoultima strada mi pare chiusa dal senso delle frase lrsquoabbreviazione non lsquosta di seacuteguitorsquo a niente ma anzi precede la perifrasi τὸ ἑξῆς μένον se impiegata semplicemente per rimandare al segno αφ immediatamente seguente costituirebbe un intollerabile solecismo Se accettiamo la prima di queste letture considerando quin-di lrsquoabbreviazione αφ in posizione predicativa abbiamo a che fare con
76 Rendo in questo modo il τε isolato77 La linea egrave laquosempliceraquo in quanto egrave una retta la precisazione intende evidenziare per
anticipazione il carattere lsquonon semplicersquo che essa assumeragrave alla prima inflessione quando diventeragrave una spezzata linee siffatte erano in effetti concepite dallrsquoanonimo e prima di lui da tutta la tradizione matematica greca come una singola linea spezzata nei punti drsquoinfles-sione I due segmenti paralleli menzionati al termine del passo sono orizzontali
78 Il verbo egrave al medio in variatio rispetto ai due che precedono e che seguono egrave il matematico che lsquosirsquo trascrive le cifre
Fabio Acerbi154
uno hapax semantico nella grecitagrave superstite come egrave facile verificare con una ricerca sul TLG in rete La recensione bizantina risolve il pro-blema sopprimendo semplicemente τὸ ἐξεσμένον
2) La notazione per le specie numeriche Nella terminologia matema-tica greca gli ordini sessagesimali sono εἴδη laquospecieraquo numerici essi corri- spondono agli ordini di grandezza nel nostro sistema decimale e indica-no in analogia con il caso geometrico la lsquoformarsquo che assume un numero quadrato cubo ecc Centinaia e migliaia sono quindi degli εἴδη rispet-tivamente quadrati (100 egrave il quadrato di 10) e cubi (1000 egrave il cubo di 10) sono specie numeriche ma non numeri particolari e drsquoaltronde 300 non egrave un quadrato ma 3 item dellrsquoεἶδος lsquoquadratorsquo 100 3 egrave il numerale di molteplicitagrave della specie quadrata lsquocentinaiarsquo i due 0 che seguono il 3 segnalano esattamente questo fatto che la notazione greca per gli interi non posizionale fa scomparire al livello denotativo Ciograve non vale soltan-to per i numeri interi ma anche per le loro parti i minuti secondi appar-tengono alla specie lsquoquadratorsquo in quanto 13600 egrave il quadrato di 160
La concezione appare interamente dispiegata nellrsquointroduzione degli Arithmetica diofantei79 che si rivela giova farlo rimarcare un te-stimone fondamentale per la ricostruzione della notazione matematica antica Alle specie usate in questrsquoopera vengono assegnati una denomi-nazione ed un segno convenzionale costituito dallrsquoiniziale (di ognuno dei componenti) della denominazione al quadrato o δύναμις il segno ΔΥ al κύβος il segno ΚΥ alla lsquoquarta potenzarsquo o δυναμοδύναμις il segno ΔΥΔ ecc La descrizione di tali segni egrave del tipo καὶ ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον Κ ἐπίσημον ἔχον Υ ΚΥ κύβος laquoe il suo segno egrave un Κ che ha come indice un Υ ΚΥ cuboraquo dove in accordo con quanto abbiamo visto nel punto b supra e pur nel comprensibile imbarazzo del copista della prima parte del Matritensis (o di un suo passato collega) a districarsi in questo formidabile ginepraio notazionale80 le due lettere Κ e Υ ricevono una barra mentre ΚΥ non la richiede a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον il quale ancora una volta esclude automaticamente il segno dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
79 In particolare a DOO I pp 214-62180 Nel Matr 4678 riscontriamo i seguenti fenomeni nelle poche righe a cavallo dei ff
58r-v 1) accento acuto posto su tutti i segni come se fossero abbreviazioni 2) ripetizione sistematica segnodenominazione come in ΚΥ κύβος appena letto dovuta sicuramente allrsquointrusione di glosse interlineari esplicative dei segni ndash e successivo pentimento (δύναμις e κύβος sono in effetti cancellati dalla prima mano il primo con un tratto il secondo con dei punti supra lineam poi il copista si stanca di correggere) 3) nella descrizione del segno per la δυναμοδύναμις menzione di un δέλτα δύο che saragrave molto probabilmente stato ΔΔ subito dopo nella descrizione del κυβόκυβος si legge un incongruo δύο KK
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 155
Diofanto introduce poi dei segni anche per le specie delle parti dellrsquounitagrave (le nostre frazioni) che egli chiama ὁμώνυμα μορία laquoparti omonimeraquo di cui quelle sessagesimali sono casi particolari81 Egli spie-ga appunto che le loro denominazioni sono ottenute da quelle delle specie degli interi per sinonimia passando ad un lsquoordinalersquo82 formato semplicemente aggiungendo il suffisso -στον δυναμοστόν κυβοστόν δυναμοδυναμοστόν ecc (sott μόριον) I loro segni convenzionali sono invece ottenuti da quelli per le specie degli interi aggiungendo una γραμμὴν διαστέλλουσαν τὸ εἶδος laquolinea che distingue la specieraquo83 Una linea sui segni delle specie delle parti egrave richiesta si badi bene per distinguerli dai segni di quelle degli interi come giagrave osservato questi ultimi sono giagrave lsquoagrammaticalirsquo a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον a fortiori lo saranno anche i primi Si tratta della traduzione semio-tica del passaggio dal cardinale allrsquoordinale che a livello grammaticale egrave effettuato con il suffisso -στον Che forma ha questa linea Barra o apice (Egrave cervellotico pensare a forme piugrave complesse) La domanda non ammette una risposta immediata in quanto delle specie diofantee nessuno piugrave si occupa nellrsquoantichitagrave84 Se egrave vero che la prima risposta darebbe origine ad un conflitto tra due convenzioni denotative diffe-renti la barra lsquocitazionalersquo e la barra che distingue la specie lrsquoevidenza grafica del Matritensis lascia lievemente sgomenti (ricordiamoci che giagrave i segni di base sono indebitamente dotati di un accento dal copista) Le poche occorrenze del segno per le specie delle parti85 vedono lrsquoaggiunta di uno slash di sospensione di un doppio apice inverso ndash in tutta evi-
81 Questo fatto era giagrave chiaro nellrsquoantichitagrave Teone in Alm I 10 in iA p 45310-1682 Il parallelo con i cardinali e gli ordinali relativi agli interi egrave reso esplicito da Dio-
fanto ὥσπερ δὲ τῶν ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια παρομοίως καλεῖται τοῖς ἀριθμοῖς τοῦ μὲν τρία τὸ τρίτον τοῦ δὲ τέσσαρα τὸ τέταρτον οὕτως καὶ τῶν νῦν ἐπονομασθέντων ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια κληθήσεται παρομοίως τοῖς ἀριθμοῖς laquocome le parti omonime dei numeri sono chia-mate per assonanza con i numeri di lsquotrersquo lsquolsaquounrsaquo terzorsquo di lsquoquattrorsquo lsquolsaquounrsaquo quartorsquo cosigrave le parti omonime dei numeri appena nominati saranno chiamate per assonanza con i numeriraquo (DOO I p 69-13 si noti lrsquoarticolo lsquocitazionalersquo al singolare in τοῦ τρία e τοῦ τέσσαρα) Il parallelo prosegue anche al livello dei segni che rappresentano queste specie come vedremo tra un attimo
83 Diofanto Arithmetica prefazione in DOO I p 620-21 un passaggio maltrattato in questa edizione occorre espungere il participio ἔχον senza introdurre segni ulteriori oppure eliminare un precedente ἐπί come fa un correttore del Matritensis f 58v
84 Unica parzialissima eccezione lrsquoaccenno di Teone menzionato nella nota 81 supra85 Al f 59r e per di piugrave nel margine per sanare un lungo saut du mecircme au mecircme La
collocazione in margine egrave il motivo per cui troviamo una notazione abbreviata nel resto del trattato il primo copista scioglie tutti i segni prendendoli per abbreviazioni mentre il secondo elimina sistematicamente il tratto aggiuntivo delle specie delle parti dellrsquounitagrave Drsquoaltronde egli scrive ad esempio ΔΥ invece di ΔΥ ed egrave quindi indotto a porre la barra al di sopra della stringa di lettere risultante (passim ma si veda ad esempio il f 72r)
Fabio Acerbi156
denza il compendio per la desinenza -ον accentata il copista interpreta il segno come unrsquoabbreviazione ndash e di una barra a sormontare lo Υ Potremmo forse interpretarlo come il segno di contrazione del grafema -στ- lrsquounico tassello mancante in unrsquoabbreviazione come ad esempio (δυναμοδυναμο)(στ)(ὸν) ma uno scolio di prima mano al f 58v rela-tivo alle specie degli interi inficia questrsquoipotesi esse sono dotate di slash di sospensione accento acuto in un caso del compendio canonico per la terminazione -ον hellip ma tutti gli Υ a esponente sono a loro volta sormontati da una barra
Meno legata al singolo manoscritto ma nondimeno non uniforme si presenta la pratica di notazione dei segni che rappresentano gli enti numerici sessagesimali86 da una parte sta lrsquoevidenza del testo dei Pro-legomena e delle sue tabelle apici ndash drsquoaltronde come abbiamo visto la notazione universalmente impiegata per i numerali ordinali e per le fra-zioni unitarie ndash dallrsquoaltra sta lrsquoevidenza del testo dellrsquoAlmagesto in tutti i manoscritti piugrave antichi e lo stesso si dica del commentario teonino a questrsquoopera o del suo lsquoGrande commentariorsquo alle Tavole facili e dei testi astronomici su papiro barre87 Sembra insomma che la nostra docu-
86 Sia le molteplicitagrave che le specie ahimeacute entrambe rappresentate da lettere dellrsquoalfabeto Come osservato allrsquoinizio della sezione 3 ci sono in effetti due tipi di lettere numerali in gioco se facciamo astrazione da apici o barre lsquo4 minuti secondirsquo si trova scritto δ β la prima lettera numerale denota la molteplicitagrave degli item di una certa specie la se-conda la specie nei Prolegomena entrambe sono accompagnate da un doppio apice il che rende inutile la presenza delle seconde Si noti che la descrizione della tabella non fa parola della notazione da usare per le lettere numerali che denotano la molteplicitagrave barre o apici e quanti apici hellip In questo caso fa interamente fede la tabella cioegrave la pratica grafica condivisa instauratasi non egrave chiaro quando
87 I manoscritti piugrave antichi dellrsquoAlmagesto sono menzionati nella nota 10 supra quelli dei due commentarii teonini sono il Laur Plut 2818 e il celeberrimo Vat gr 190 (sec IX in Euclide Elementi Data Teone lsquoGrande commentariorsquo) per la notazione dei pa-piri astronomici si veda Jones 1999 II passim La notazione non sembra lsquoinquinatarsquo dalla pratica dei copisti bizantini e pare dipendere soltanto dalla data di composizione Tro-viamo ad esempio barre sopra tutti i numerali di molteplicitagrave (interi o sessagesimali) nel frammento di un commentario alle Tavole facili contenente un calcolo relativo al 24 aprile 213 (Par gr 2841 sec XIII ex-XIV in oltre al frammento ai ff 32r l 11-34v l 23 contiene Arato Phaenomena ed Efestione Apotelesmatica edizione in Jones 1990) Nel commentario alle Tavole facili composto ca 610-617 ed attribuito a Stefano di Alessandria la situazione egrave la seguente (Jean Lempire per litteras per lrsquoedizione si veda Lempire 2014 ho controllato il Vat gr 304 ff 135r-171v sec XIV am contiene in aggiunta Teone in Almagestum I-II lsquoPiccolo commentariorsquo alle Tavole facili Diofanto Arithmetica e De polygo-nis numeris varia astronomica tabulae) barre sopra gli interi sporadicamente rimpiazzate da apici apici sopra le parti sessagesimali in numero uguale alla denominazione doppio () apice per le frazioni unitarie Sono impiegate barre sopra gli interi e apici sopra le parti sessagesimali nei manoscritti principali di tutti i trattati di introduzione allrsquoAlmagesto o comunque di argomento logistico redatti in epoca bizantina Giorgio Pachimere (1242-ca 1310) Quadrivium (autografo nel manoscritto Roma Biblioteca Angelica gr 38 [RGK III nr 115] si veda Tannery ndash Steacutephanou 1940 per lrsquoedizione) Teodoro Metochita (1270-
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 157
mentazione si faccia testimone di un cambio notazionale avvenuto nel periodo intercorrente fra Teone (sec IV pm) e la scuola alessandrina di Ammonio e dei suoi allievi (sec VI in) e probabilmente innescato da questrsquoultimo ambiente lrsquoaspetto paradossale egrave che nello stesso codice si rintraccino due notazioni differenti per gli enti numerici sessagesimali e lrsquouna (apici) sia adottata sistematicamente e coerentemente in uno scritto (i Prolegomena) che si presenta esattamente come unrsquointroduzione tecnica alla pratica numerico-algoritmica del trattato (lrsquoAlmagesto) in cui egrave adottata lrsquoaltra (barre che ritroviamo senza eccezioni anche negli scolii)
Torniamo ai Prolegomena la descrizione del segno da porre a fianco di ogni singolo quoziente parziale e denotante la sua specie numerica (minuti primi minuti secondi ecc) solleva tre problemi
Primo problema Ci vuole una barra o un apice su τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquola lettera A [hellip] che significa la specieraquo quando lo scriviamo nella tabella Tutta la nostra discussione precedente fa pro-pendere per lrsquoapice e si ricordi anche la forma verbale ἀνατείνουσαν che suggerisce qualcosa che si lsquoestende verso lrsquoaltorsquo (la mia traduzione egrave volutamente neutra) se fosse apposta una barra la cosa dovrebbe passare
1231332) Compendium astronomicum (copia lsquoautorizzatarsquo coeva nei Vat gr 182 e 181 da parte del copista che integrograve le parti mancanti del Par gr 2389 [ff 207-210 255-270 374-375] Bianconi 2005a pp 425-427 Peacuterez Martiacuten 2008 p 436 e n 177) Teodoro Meliteniota (morto lrsquo831393) Tribiblos astronomica (autografo nel Vat gr 792 si vedano Leurquin 1991 per unrsquoanalisi del manoscritto Leurquin 1990 per lrsquoedizione) una com-pilazione anonima (per cui ho consultato il Par gr 2396 ff 87r-92v limitatamente a questi fogli manu Costantino Trivoli [RGK II nr 318 ma ovviamente questo codice non vi egrave segnalato] terzo quarto del XV secolo il resto del codice annotato da Niceforo Gregora egrave di etagrave planudea e parzialmente [ff 33v-76v] un autografo di Planude stesso contiene Teone in Almagestum I II IV Mondrain 2002 il codice va completato ndash limitatamente a stralci dei libri VIII-X XII-XIII del commentario teonino la cui parte intermedia si egrave persa ndash con 26 carte [ff 123-147] inserite nel Vat gr 1087 anchrsquoesso contenente anno-tazioni di Gregora Rome 1927 per la figura del copista dei ff 77r-86r del Par gr 2396 e dei ff appena nominati del Vat gr 1087 un anonimo collaboratore di Gregora si veda in ultimo Bianconi 2006a pp 147-151) si veda anche il calcolo effettuato da Niceforo Gre-gora (12921295-13581361) dellrsquoeclisse di sole del 16 luglio 1330 (attestata unicamente ai ff 1r-8v della miscellanea astronomica Marc gr 325 databile ca 1324-1329 in parte vergata e ovunque fittamente annotata da Gregora stesso edizione del testo in Mogenet et al 1983 annotazioni di Gregora elencate in Bianconi 2005a p 413) Unrsquoeccezione apparente il lsquoPiccolo commentariorsquo di Teone alle Tavole facili le parti sessagesimali sono segnalate da apici (ad esempio nel Vat gr 175 vergato da Giovanni Catrario e completato nel 1321-1322 sulla figura di Catrario si vedano in ultimo Bianconi 2005b pp 141-156 e 2006b) lrsquoopera egrave antica ma la sua tradizione non rimonta oltre la fine del XIII secolo a parte un frammento nel Leiden BPG 78 ff 156r-161v (minuscola del IX-X secolo) e in effetti in questo manoscritto tutti i numerali di molteplicitagrave sono sormontati da barre Unrsquoeccezione effettiva egrave il De hypotesibus planetarum nel Vat gr 1594 barre sugli interi e apici sulle parti sessagesimali
Fabio Acerbi158
sotto silenzio e la presenza dellrsquoapice la rende inutile88 Si tratta della stessa convenzione diofantea e coincide ancora con la notazione per i numerali ordinali e per le frazioni unitarie che egrave corrente nei mano- scritti matematici greci per questo motivo non percheacute la descrizione sia particolarmente perspicua nessuno dei copisti della recensione an-tica ha incertezze apici Ma questi apici si rintracciano soltanto sulle indicazioni di specie non contemplate dalla descrizione che sono ante-poste ai resti parziali a fianco dei quozienti parziali i segni di specie sono invece trasformati in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordi-nali corrispondenti del tipo πρωτ tavv 5 e 7b-8 Il recensore bizantino taglia invece la testa al toro elimina dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali elimina la seconda menzione della laquolet-tera Araquo contestualmente allrsquoazzeramento dellrsquoespediente della linea a zig-zag (si veda il punto seguente) modifica la descrizione che contiene la prima menzione in quella dellrsquoapice associato direttamente ai nume-rali di molteplicitagrave riciclando addirittura lrsquoalpha per adibirlo a desi-gnare un numero cardinale (come sorprendersi) τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ laquoponendo al di sopra di essi [scil dei 50 minuti primi] 1 solo lsaquoaccentorsaquo acutoraquo La scelta del recensore egrave assennata che rechi una barra o un apice in una tabella un alpha denota un numero non un numero drsquoordine
Secondo problema da tenere ben distinto dal precedente Cosa ci vuole sul segno α per la lettera alpha menzionata nella frase τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquolettera A [hellip] che significa la specieraquo89 Unrsquooc-chiata allrsquoapparato critico rivela una bella incertezza nei manoscritti Z scrive sempre ᾱ e in un caso lo fa anche P MS optano sempre per α´ C per α P scrive nellrsquoaltro caso αο Per quanto solo la barra sia congrua con il senso della frase in quanto la lettera alpha egrave qui menzionata (si tratta di un oggetto che compare nella tabella) e non cambia niente se essa egrave accompagnata dal suo nome di genere στοιχεῖον ad un livello grafico lrsquoincertezza fra il segno ᾱ che denota laquola lettera αraquo e il segno α´ (o lrsquoabbreviazione αο) per una forma di πρῶτος egrave per piugrave versi giustificata
88 Detto in altri termini la barra egrave uno strumento grafico non matematico e quindi la sua presenza non va segnalata mentre un apice lo egrave e la sua presenza lo deve
89 Notare che in questa frase il primo α non vuole la barra (egrave menzionato allrsquointerno di una frase che impiega convenzioni moderne) il secondo sigrave (idem ma con convenzioni antiche) ndash e nella traduzione la scelta di denotarlo con A (senza virgolette) e non con lsquoArsquo (con virgolette) egrave del tutto arbitraria ndash si noti inoltre che le necessarie precisazioni laquosenzacon virgoletteraquo mostrano che le lingue moderne palesano difficoltagrave analoghe a quelle del greco antico per quanto riguarda i livelli denotativi in ambito metadiscorsivo per non usare le due parentetiche avrei dovuto scrivere rispettivamente lsquoArsquo e lsquolsquoArsquorsquo (doppie virgolette semplici)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 159
ᾱ coincide con il numerale 1 α egrave la prima lettera dellrsquoalfabeto ed inoltre α´ egrave esattamente quello che va scritto nella tabella Potremmo dirci che il sostantivo στοιχεῖον chiude la questione la sua presenza congiunta ad un ipotetico α´ renderebbe la descrizione ridondante o inappropriata90 Ma a parte il fatto che α egrave proprio τὸ πρῶτον στοιχεῖον il segno α´ cat-tura in fondo il cuore della descrizione di uno στοιχεῖον ἔχον lsaquoγραμμὴνrsaquo ἀνατείνουσαν
Terzo problema Lrsquoautore dei Prolegomena che si arresta allrsquoesem-pio dei minuti primi non dice quanti apici occorre mettere sulle lettere numerali che identificano gli ordini superiori al primo se uno soltanto come nel caso diofanteo e delle frazioni unitarie o in numero uguale alla loro denominazione (cioegrave pari al numero denotato dal numerale stesso su cui vanno posti) come effettivamente avviene nei mano-scritti dei Prolegomena La tabella egrave quindi sottodeterminata dalla sua descrizione anzi in un certo senso prende il sopravvento su di essa la pratica di marcare i numerali di molteplicitagrave con gli apici che compe-tono allrsquoordine cui appartengono viene trasferita ai segni per gli ordini stessi per supplire ad una descrizione carente di questi ultimi E la tabella egrave sottodeterminata dalla descrizione in quanto egrave la descrizione di una tabella reale ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις laquocome nello lsaquoschemarsaquo espostoraquo leggiamo a un certo punto del testo
3) La linea a zig-zag Non possiamo che applaudire a questo geniale espediente grafico lo troviamo messo in opera solo nel Marc gr 313 Per quanto lrsquoautore non faccia parola di ciograve nel corso della sua descrizione la linea spezzata egrave intesa dover lsquosaltarersquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue Il copista del codice marciano effettua correttamente due salti nella prima delle sue tabelle (tav 4) ma inserisce un lsquodentersquo in piugrave in quella che considera corretta (tav 5) La linea a zig-zag egrave incompatibile con la presenza di linee di giustificazione nella tabella che in effetti mancano nel Marc gr 313 ciograve induce gli errori di allineamento dei primi 5 quozienti parziali di cui egrave vittima il copista Probabilmente per questo motivo in nessuno degli apografi del Vat gr 1594 la linea a zig-zag figura nella tabella inquadrata come si conviene da una (doppia) cornice esterna e le cui colonne sono appunto separate da linee verticali (tav 7b Vat gr 184 f 17v e tav 8 Par gr 2390 f 9v cui egrave sostanzialmente identica la tabella del Marc gr 314 che si trova
90 Trascuro lrsquoabbreviazione αο = πρῶτος percheacute la desinenza non egrave quella richiesta neacute nella frase (egrave richiesto πρῶτον) neacute nella tabella (πρῶτα)
Fabio Acerbi160
al f 248r ndash ma la mancanza di linee orizzontali causa un gigantesco pa-sticcio nel codice vaticano) Alla recensione bizantina che dipende per il suo testo di base dal Vat gr 1594 e quindi non trova la linea a zig-zag nella tabella non resta che sopprimere la sua descrizione ndash ma proprio per questo motivo e finalmente diventa possibile tracciare un apparato completo di linee di giustificazione (tav 9 Laur Plut 89 sup 48 f 14v) Dato che la descrizione di Teone di questo procedimento di divi-sione non fa cenno allrsquoesistenza della linea a zig-zag viene da chiedersi se essa non costituisca un espediente escogitato dallrsquoautore dei Prolegomena per vivacizzare la procedura originale di Pappo
4) Discrepanze tra descrizione e tabella Il gioco delle minime va-rianti mostra che la divisione era stata eseguita (e trasmessa) corret-tamente tutti i valori numerici sono esatti La tabella nel Marc gr 313 presenta perograve alcune discrepanze con la propria descrizione Essa omette (ma non nella versione lsquoscorrettarsquo lrsquoomissione non si riscontra neanche nel Par gr 2390) il segno per laquorestoraquo di fronte ai resti par-ziali ma aggiunge lrsquoindicazione della loro specie Essa trasforma invece come abbiamo visto le indicazioni di specie che seguono i quozienti parziali in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordinali corri-spondenti La descrizione prevede di chiudere la tabella con il risultato καὶ συνάγων ἅπαντα τὰ ἐκ τῶν μερισθέντων μερῶν λεπτὰ σημειοῦται ὑπὸ πάντας οὕτως γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoe raccogliendo tutti i minuti che provengono dalle parti divise lsaquoPapporsaquo nota sotto tutto cosigrave Ris 0 59 8 17 13 12 31raquo ma sotto la tabella tutta la tradizione ci consegna qualcosa di piugrave articolato ὁ ζητούμενος καθ᾽ ὃν μερίζεται ὁ τξε ιδ´ μη´´ π(αρὰ) τὸν τξ γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoil lsaquonumerorsaquo cercato secondo cui 365 14 48 egrave diviso per 360 risulta 0 59 8 17 13 12 31raquo frase che del resto contiene due errori lrsquoinversione del dividendo e del divisore e la confusione tra segno convenzionale (iuxta descrizione) e abbreviazione (come nella frase) nel caso di γι Oltre ad eliminare la linea a zig-zag91 la recensione bizantina sopprime dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali e modifica come abbiamo visto al punto 2 le loro descrizioni in quelle di apici associati diretta-mente ai numerali di molteplicitagrave
91 Le due righe che nella recensione di base contengono solo i resti parziali minori di 160 del divisore ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue sono in parte completate con lrsquoindicazione abbreviata ἀνάλ(υσις) laquoanalisiraquo il termine greco per questa procedura di riduzione In un sussulto di ipercorrettismo matematico tali resti parziali ridotti non sono preceduti dal segno per laquorestoraquo come nel Par gr 2390 ma da quello per laquorisultatoraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 161
Gli esempi che abbiamo discusso mostrano come i problemi di notazione pesino e non poco sullrsquoespressione discorsiva di un algorit-mo matematico lrsquoente di riferimento per lsquoformularersquo il procedimento di divisione fu considerata la tabella cioegrave un oggetto la cui costitu-zione egrave legata piugrave ad una pratica grafica che a considerazioni logico- algoritmiche non la sua descrizione che in effetti finisce per determi-nare la tabella in maniera non univoca Di questa sottodeterminazione si fa testimone la traiettoria che abbiamo cercato di seguire nelle mani di copisti e revisori il procedimento di divisione si modifica a volte in aspetti secondari a volte in punti piugrave sostanziali ndash fino a rendere neces-saria una radicale revisione della sua descrizione per renderla conforme alla tabella ndash in ogni caso mai per ragioni squisitamente matematiche92
Abstract
The article presents and discusses in detail two passages from the anonymous Prolegomena to the Almagest a VIth century primer to the elementary procedures of calculation needed in Ptolemyrsquos Almagest In the two passages we may follow the complex interplay between mathematical notation the auctor who employed and described it the tachygrapher who transcribed it in vivo copyists who reproduced it correctors who modified it Along this path misgivings and errors arise in the transmission of abbreviations and paratextual units such as diagrams tables operational schemes
Fabio AcerbiCNRS UMR8560 Centre Alexandre Koyreacute
fabacerbigmailcom
92 Sono grato a Daniele Bianconi Lucio del Corso Jean Lempire per alcune preziose indicazioni
AOO = Archimedis opera omnia cum commentariis Eutocii ed J L Heiberg I-III Lipsiae 1910-1915
DOO = Diophanti Alexandrini opera omnia cum Graecis commentariis ed P Tannery I-II Lipsiae 1893-1895
GC = Le laquoGrand Commentaireraquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Mogenet ndash A Tihon I-III Cittagrave del Vaticano 1985-1999
iA = Commentaires de Pappus et de Theacuteon drsquoAlexandrie sur lrsquoAlmageste ed A Rome I-III con paginazione continua Cittagrave del Vaticano 1931-1943
HOO = Heronis Alexandrini opera quae supersunt omnia ed G Schmidt ndash L Nix ndash W Schmidt ndash H Schoene ndash J L Heiberg I-V Lipsiae 1899-1914
PC = Le ldquoPetit Commentairerdquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed A Tihon Cittagrave del Vaticano 1978
POO = Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia ed J L Heiberg I-II in 3 parti Lipsiae 1898-1907
RGK = Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600 I Handschriften aus Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln II Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs und Nachtraumlge zu den Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln III Handschriften aus Bibliotheken Roms mit dem Vatikan A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg unter Mitarbeit von D Harlfinger und P Eleuteri B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln Wien 1981-1997 (Oumlsterreichische Akademie der Wissenschaften Veroumlffentlichungen der Kommission fuumlr Byzantinistik III1-3 A-C)
Sigla
Acerbi 2010 = F Acerbi Il silenzio delle sirene La matematica greca antica Roma 2010
Acerbi 2012 = F Acerbi I codici stilistici della matematica greca dimostrazioni procedure algoritmi laquoQUCCraquo 1012 (2012) pp 167-214
Acerbi et al 2010 = F Acerbi ndash N Vinel ndash B Vitrac Les Proleacutegomegravenes agrave lrsquoAlmageste Une eacutedition agrave partir des manuscrits les plus anciens Introduction geacuteneacuterale ndash Parties I-III laquoSCIAMVSraquo 11 (2010) pp 53-210
Agati 1992 = M L Agati La minuscola laquoBouleteacuteeraquo Cittagrave del Vaticano 1992
Belger 1881 = C Belger Ein neues Fragmentum mathematicum Bobiense laquoHermesraquo 16 (1881) pp 261-284
Bianconi 2005a = D Bianconi La biblioteca di Cora tra Massimo Planude e Niceforo Gregora Una questione di mani laquoSampTraquo 3 (2005) pp 391-438
Bianconi 2005b = D Bianconi Tessalonica nellrsquoetagrave dei Paleologi Le pratiche intellettuali nel riflesso della cultura scritta Paris 2005
Bianconi 2006a = D Bianconi Le pietre e il ponte ovvero identificazioni di mani e storia della cultura laquoBizantinisticaraquo 8 (2006) pp 135-181
Bianconi 2006b = D Bianconi Qualcosa di nuovo su Giovanni Catrario laquoMEGraquo 6 (2006) pp 69-91
Cavallo 1977 = G Cavallo Funzione e strutture della maiuscola greca tra i secoli VIII-XI in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Colloque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 95-137
Cereteli 1904 = G F Cereteli De compendiis scripturae codicum Graecorum praecipue Petropolitanorum et Mosquensium anni nota instructorum Sankt-Petersburg 1904
De Gregorio 2000 = G De Gregorio Materiali vecchi e nuovi per uno studio della minu-scola greca fra VII e IX secolo in G Prato (a cura di) I manoscritti greci tra riflessione e dibattito Atti del V Colloquio Internazionale di Paleografia Greca Cremona 4-10 ottobre 1998 Firenze 2000 pp 83-151
Follieri 1977 = E Follieri La minuscola libraria dei secoli IX e X in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Col-loque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 139-165
Fonkič 2005 = B Fonkič Venecianskaia rukopisrsquo laquoAlrsquomagestaraquo Ptolemeja (Marc gr 313690) o datirovke i proischoždenii kodeksa laquoVDIraquo s III 254 (2005) pp 162-167
Fowler 1999 = D H Fowler The Mathematics of Platorsquos Academy A New Reconstruction Second Edition Oxford 1999
Bibliografia
Fabio Acerbi164
Gerstinger ndash Vogel 1932 = H Gerstinger ndash K Vogel Eine stereometrische Aufgaben-sammlung im Papyrus Graecus [sic] Vindobonensis 19996 laquoMitteilungen aus der Papy-russammlung der Nationalbibliothek in Wienraquo Neue Serie Folge 1 Griechische literarische Papyri 1 Wien 1932 pp 11-76
Heiberg 1927 = Mathematici Graeci Minores ed J L Heiberg Kjoslashbenhavn 1927
Hultsch 1876-1878 = Pappi Alexandrini Collectionis quae supersunt ed F Hultsch I-III Berlin 1876-1878
Janz 2003 = T Janz The Scribes and the Date of the Vat gr 1291 in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae X Cittagrave del Vaticano 2003 pp 159-180
Jones 1990 = Ptolemyrsquos First Commentator ed A Jones Philadelphia 1990
Jones 1999 = Astronomical Papyri from Oxyrhynchus ed A Jones I-II Philadelphia 1999
Jones 2005 = A Jones Ptolemyrsquos Canobic Inscription and Heliodorusrsquo Observation Reports laquoSCIAMVSraquo 6 (2005) pp 53-97
Lempire 2014 = Steacutephanos drsquoAlexandrie Le commentaire aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Lempire Louvain 2014
Leurquin 1990 = Theacuteodore Meacuteliteacuteniote Tribiblos astronomique Livre I ed R Leurquin Amsterdam 1990
Leurquin 1991 = R Leurquin Un manuscrit autographe de la Tribiblos Astronomique de Theacuteodore Meacuteliteacuteniote le Vaticanus graecus 792 laquoScriptoriumraquo 45 (1991) pp 145-162
Maas 1927 = P Maas Griechische Palaeographie in A Gercke ndash E Norden (hrsg von) Einleitung in die Altertumswissenschaft I9 Leipzig 1927 pp 69-80
Martinelli Tempesta 2010 = S Martinelli Tempesta Il codice Milano Biblioteca Am-brosiana B 75 sup (gr 104) e lrsquoevoluzione della scrittura di Giovanni Scutariota in A B Garciacutea ndash I Peacuterez Martiacuten (ed by) The Legacy of Bernard de Montfaucon Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting Proceedings of the Seventh Inter-national Colloquium of Greek Palaeography Madrid-Salamanca 15-20 September 2008 Turnhout 2010 pp 171-186
Mazzucchi 1994 = C M Mazzucchi Leggere i classici durante la catastrofe (Costantino-poli maggio-agosto 1203) le note marginali al Diodoro Siculo Vaticano gr 130 Parte prima stratigrafia laquoAevumraquo 68 (1994) pp 164-218
Mioni 1976 = E Mioni Bessarione scriba e alcuni suoi collaboratori in Miscellanea marcia-na di studi bessarionei Padova 1976 pp 263-323
Mioni 1985 = Codices graeci manuscripti Bibliothecae Divi Marci Venetiarum II Thesaurus Antiquus Codices 300-625 recensuit E Mioni Roma 1985
Mogenet 1962 = J Mogenet Une scholie ineacutedite du Vat gr 1594 sur les rapports entre lrsquoastronomie arabe et Byzance laquoOsirisraquo 14 (1962) pp 198-221
Mogenet et al 1983 = Niceacutephore Greacutegoras Calcul de lrsquoeacuteclipse de soleil du 16 juillet 1330 ed J Mogenet ndash A Tihon ndash R Royez ndash A Berg Amsterdam 1983
Mondrain 2002 = B Mondrain Maxime Planude Niceacutephore Greacutegoras et Ptoleacutemeacutee laquoPa-laeoslavicaraquo 10 (2002) pp 312-322
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 165
Mondrain 2004 = B Mondrain Lrsquoancien empereur Jean VI Cantacuzegravene et ses copistes in A Rigo (a cura di) Gregorio Palamas e oltre Studi e documenti sulle controversie teologiche del XIV secolo bizantino Firenze 2004 pp 249-296
Mondrain 2007 = B Mondrain Les eacutecritures dans les manuscrits byzantins du XIV e siegravecle Quelques probleacutematiques laquoRSBNraquo n s 44 (2007) pp 157-196
Peacuterez Martiacuten 2006 = I Peacuterez Martiacuten Maxime Planude et le Diophantus Matritensis (Madrid Biblioteca Nacional ms 4678) un paradigme de la reacutecupeacuteration des textes anciens dans la ldquorenaissance paleacuteologuerdquo laquoByzantionraquo 76 (2006) pp 433-462
Peacuterez Martiacuten 2008 = I Peacuterez Martiacuten El lsquoestilo Hodegosrsquo y su proyeccioacuten en las escrituras constantinopolitanas laquoSampTraquo 6 (2008) pp 389-458
Perria 1991 = L Perria Scrittura e ornamentazione nei codici della laquocollezione filosoficaraquo laquoRSBNraquo n s 28 (1991) pp 45-111
Rollo 2012 = A Rollo LrsquoArchimede di Giorgio Valla in V Fera ndash D Gionta ndash A Rollo (a cura di) Archimede e le sue fortune Atti del Convegno di Siracusa-Messina 24-26 giugno 2008 Messina 2012 pp 99-147
Rome 1927 = A Rome Membra disjecta laquoRBenraquo 39 (1927) pp 187-188
Rome 1938 = A Rome Un manuscrit de la bibliothegraveque de Boniface VIII agrave la Meacutediceacuteenne de Florence laquoACraquo 7 (1938) pp 261-268
Ronconi 2013 = F Ronconi La collection philosophique un fantocircme historique laquoScripto-riumraquo 67 (2013) pp 119-140
Tannery ndash Steacutephanou 1940 = Quadrivium de Georges Pachymegravere ed P Tannery ndash E Steacutephanou Cittagrave del Vaticano 1940
Tihon 2011 = Πτολεμαίου Πρόχειροι Κανόνες Les Tables faciles de Ptoleacutemeacutee vol Ia Tables A1-A2 ed A Tihon Leuven 2011
Traube 1907 = L Traube Nomina Sacra Versuch einer Geschichte der christlichen Kuumlrzung Muumlnchen 1907
Vogel 1936 = K Vogel Beitraumlge zur griechischen Logistik laquoSBAWraquo Mathematisch-natur-wissenschaftliche Abteilung Jahrgang 1936 pp 357-472
Wouters 1979 = A Wouters The Grammatical Papyri from Graeco-Roman Egypt Contri-butions to the Study of the lsquoArs Grammaticarsquo in Antiquity Brussel 1979
F ACERBI Tav 1
b Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 65r
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 284 f 160r
F ACERBITav 2
b Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 13r
a Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 19v
F ACERBI Tav 3
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 136v
F ACERBITav 4
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17r
F ACERBI Tav 5
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17v
F ACERBITav 6
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 7v
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 143
che egrave proprio agli scarti di ciascuno ndash intendo qui lsaquociascunrsaquo residuo54 ndash in luogo di laquoresti che vanno a essere divisi ulteriormenteraquorsquo
a) Operatori di citazione e segni convenzionali I segni introdotti sono quattro la mia discussione egrave condotta dando per scontato che essi siano identici a quelli impiegati dallrsquoautore dei Prolegomena anche se si tratta di unrsquoipotesi non corroborabile neacute falsificabile
i Segno per il risultato Lrsquoabbreviazione convenzionale per γίνεται egrave identica al segno introdotto dallrsquoautore e i copisti si dividono tra i due errori possibili scrivere due abbreviazioni o risolverle entrambe Un fenomeno del tutto analogo si riscontra nel Matr 4678 il manoscritto alla base di tutta la tradizione degli Arithmetica di Diofanto al momen-to della definizione dellrsquoἀριθμός (lrsquolsquoincognitarsquo nel nostro linguaggio) ὁ δὲ μηδὲν τούτων τῶν ἰδιωμάτων κτησάμενος ἔχων δὲ ἐν ἑαυτῷ πλῆθος μονάδων ἄλογος ςο` καλεῖται ς` ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον τὸ ς` laquoil lsaquonumerorsaquo che non possiede nessuna di queste proprietagrave ma che ha in seacute una molteplicitagrave indefinita di unitagrave egrave chiamato lsquonumerorsquo e il suo segno egrave ς`raquo Qui solo il terzo dei tre ς ha una barra a sormontare per segnalarne il carattere puramente denotativo (cioegrave di segno convenzionale e non di abbreviazione si veda il punto successivo)55 il primo egrave una delle abbreviazioni piugrave diffuse per ἀριθμός (e infatti egrave dotato del compendio per la desinenza e dellrsquoaccento grave) il secondo egrave una delle piugrave comu-ni per καὶ () Giovanni Cortasmeno autore di capillari annotazioni infra lineam agli Arithmetica nel codice madrileno scioglie il primo ςο`
54 Doppia variatio che impiega al posto di λοιπόν laquorestoraquo i due termini decisamente non canonici τὸ λοίπασμα e ἡ λοιπάς (piugrave oltre leggiamo anche il participio λοιπασθέντα) Una ricerca sul TLG in rete non ha fornito occorrenze del primo si tratta dunque di uno hapax Quanto al secondo che ricorre anche nella sezione sulla divisione lsquoalla Papporsquo lo si rintraccia giagrave nei papiri documentari il termine diventeragrave perograve canonico nelle esposizioni bizantine drsquointroduzione allrsquoAlmagesto ricalcate sul modello dei Prolegomena (si veda la nota 87 infra) Questi due termini designano i resti parziali prodotti nel corso di una divisione lunga li ho tradotti rispettivamente con il neologismo laquoresiduloraquo e con il sostantivo pari-menti non canonico laquoresiduoraquo
55 Il copista interpreta erroneamente il terzo segno come unrsquoabbreviazione e qui ag-giunge un apice inverso (cioegrave un accento grave) altrove lo scioglie direttamente in forme opportune di ἀριθμός Matr 4678 f 58v La frase come la leggiamo nel manoscritto egrave cor-rotta sulla base di una parafrasi in Psello (edita in DOO II p 3710-12) Tannery emendograve ἄλογος in ἀόριστον DOO I p 64-5 et app Il Matritensis vergato da due copisti differenti (cambio di mano a tre righe dalla fine del f 62r) contiene lrsquoIntroductio arithmetica di Nicomaco e le opere diofantee oltre ad alcuni brevi opuscoli musicali la sua data egrave stata recentemente corretta dal XIII al secolo XI pm in Peacuterez Martiacuten 2006 (una riproduzione digitale del manoscritto si trova allrsquoindirizzo httpbdhbneesbnesearchbibliotecaDio-fanto20de20AlejandrC3ADa)
Fabio Acerbi144
in ἀριθμός ed aggiunge un altro segno56 sopra il terzo anteponendovi lrsquoindicazione καὶ ἔστιν αὐτοῦ σ(ημεῖον) τόδε Va da seacute che non abbiamo nessuna garanzia che il segno originariamente introdotto da Diofanto coincidesse realmente con unrsquoabbreviazione convenzionale per ἀριθμός Lrsquoevidenza del PMich III 144 (sec II in) suggerisce drsquoaltronde che il Matritensis e con esso tutta la tradizione medievale di Diofanto ripro-duca fedelmente pur accentuandone la sinuositagrave il segno originario
ii Segno per il divisore Un cerchiolino sbarrato da non confondere con il segno per ὁμοῦ che nei manoscritti matematici ha di norma due barre trasversali (cf tav 2a) Non sono riuscito a rintracciarne ulteriori occorrenze in altre opere la forma che esso assume nel Vat gr 2326 e la correzione apportata nel Par gr 2390 lasciano aperta la possibilitagrave per quanto a mio avviso remota che la forma originaria non fosse lon-tana da unrsquoabbreviazione di παρά registrata nei repertori57 Il correttore del Par gr 2390 trasforma in effetti il segno oslash nellrsquoaffine abbreviazione canonica per (forme di) ἐλάσσων laquominoreraquo58 e si incarica diligente-mente di farlo notare ricapitolando i segni nella porzione superiore del margine esterno del f 7v Nello stesso margine egli traccia anche uno lsquoscolio tabellarersquo ed egrave lrsquounico a porre il (proprio) segno dove indicato dalla descrizione (tav 6 Par gr 2390 f 7v) Oltre a ciograve adattando la tabella al margine ristretto lo scoliaste trascrive come colonne affian-cate le due righe dei resti parziali e dei massimi multipli e aggiunge le indicazioni ὁ μεριζόμενος laquodividendoraquo e ὁ μερίζων laquodivisoreraquo ma vi introduce alcune incongruenze di formato il risultato scritto in verti-cale e la linea verticale di sinistra che separa il divisore dal segno che lo dovrebbe precedere direttamente
iii Segno per i massimi multipli Corrisponde alla semplice abbre-viazione per sospensione della forma verbale ἄφελε laquosottrairaquo in questo
56 Si tratta del segno di ampio uso praticamente identico allrsquoabbreviazione canonica per οὖν
57 Si tratta di un pi a forma di gancio sbarrato da uno slash di troncamento Ce-reteli 1904 tav IX item 7 sub ΠΑΡΑ che rinvia al PVindRain 423 cf anche la forma π` nel POxy LXI 4142 edito in Jones 1999 II pp 26-34 In generale nei papiri e nei manoscritti matematici in maiuscola le preposizioni sono abbreviate facendo seguire un lsquoapostroforsquo alla loro prima lettera Α᾽ Υ᾽ ecc Per la seconda fattispecie di supporto libra-rio si veda in particolare il cosiddetto fragmentum mathematicum Bobiense scriptio inferior databile al V-VI secolo del palinsesto Milano Biblioteca Ambrosiana L 99 sup (Isidoro di Siviglia Etymologiae datazione Cavallo 1977 p 100) pp 113-114 che sono stampate in riproduzione apografa conforme in Belger 1881 (la p 114 egrave riprodotta anche nella tav 10 di Acerbi 2010)
58 Se questa era lrsquointenzione si tratta ovviamente di una forzatura il divisore puograve ben essere maggiore del dividendo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 145
caso lo slash di troncamento taglia orizzontalmente il tratto verticale del phi I copisti offrono molteplici varianti apponendo chi uno spirito dolce chi un ε chi un αί accentato a sormontare Tutti questi segni svolgono la funzione di abbreviazioni vere e proprie (e cosigrave doveva essere anche per lrsquoautore si veda il punto 1 di p 153 infra) la forma originale si ottiene a mio avviso incrociando i dati del Marc gr 313 e dei tre apografi del Vat gr 1594 αφ anche se lrsquoassenza dello spirito potrebbe essere semplicemente dovuta alla pratica del copista del codice veneziano di economizzare nei diacritici
iv Segno per i resti Un lambda completato da una barra a sormon-tare o da un apice che rinvia alle abbreviazioni per sospensione di una forma opportuna di λοιπός laquorestoraquo In realtagrave la forma che troviamo nella tabella egrave differente (tav 2b) e coincide con quella offerta quasi unanimemente dai manoscritti nella descrizione e in almeno un caso nella tabella del metodo di divisione attribuito a Pappo (tav 4) un lambda che accoglie al di sotto una legatura omicron-iota () sbarrata da uno slash di troncamento Qualcosa di simile si trova nel PVindob G 19996 (sec I) una specie di lambda maiuscolo molto aperto e dal vertice arrotondato che include un circoletto interpretato dagli editori come segno per περίεστιν o per λοιπόν59 Lo stesso segno si rintraccia ad esempio in un medesimo scolio tabellare di prima mano ad Alma-gestum nel Vat gr 1594 f 93v e nel Marc gr 313 f 135r ma stavolta la forma del lambda egrave molto ben definita
Fin qui i segni Ma il gioco egrave piugrave complesso La descrizione si muo-ve pericolosamente sulla linea di confine non sempre ben definita tra segno convenzionale e abbreviazione il primo ndash e il repertorio grafico matematico-astronomico ne egrave particolarmente fornito60 ndash puograve anche
59 Ho consultato lrsquoedizione Gerstinger ndash Vogel 1932 pp 46 e 48 la porzione rilevante del papiro egrave riprodotta nella tav 11 di Fowler 1999 Si veda ancora ivi pp 253-257 per la trascrizione di questo segmento di testo (con correzioni rispetto alla princeps) e per una messa a punto recente inclusa la proposta di datazione che ho riportato qui sopra Il verso del papiro che contiene una tavola aritmetica del tutto scorrelata dalla tematica del recto egrave edito come PRain Unterricht 151
60 La pratica di ridurre lo spazio occupato da un testo tecnico per mezzo di abbreviazioni e segni convenzionali era molto diffusa nei manoscritti in maiuscola contrariamente a quanto avviene per altri generi letterari vedremo tra breve cosa accade negli Arithmetica di Diofanto ma si leggano in proposito anche le considerazioni di Hei-berg nei prolegomena alla propria edizione dellrsquoAlmagesto in particolare riguardo al ricorso massiccio ad espedienti brachigrafici nel modello del Vat gr 180 POO II pp lxxxiv-xciii civ-cv cxxvii cxxxviii-cxxxix Agli elenchi dettagliati forniti da Heiberg possiamo aggiungere il piccolo prontuario stampato in Hultsch 1876-1878 III 2 pp 126-132 e basato sul testo e sugli scolii alla Collectio di Pappo nel Vat gr 218 (sec X in) Si vedano infine le osservazioni del copista del Par gr 2360 f 120v trascritte da Heiberg in AOO III pp x-xi sulle laquonotazioni tipiche a scopo di tagliar corto nello scrivereraquo impiegate nel pro-
Fabio Acerbi146
derivare dalla seconda (un caso egrave appunto il segno per ἐλάσσων che probabilmente trae origine da una legatura epsilon-lambda) ma poi il rapporto referente-relato si fissa convenzionalmente Quelli definiti nel testo che abbiamo letto sono appunto segni convenzionali non ci sarebbe bisogno di spiegarne forma e funzione se fossero intesi come abbreviazioni assumono nella tabella una funzione denotativa non esplicativa o discorsiva (come accade invece nella tav 1a) Ma come vengono descritti questi segni
I referenti delle descrizioni sono i segni sono introdotti da οὕτως (item i-ii) o in alternativa da un τό con il ruolo di lsquooperatore di citazionersquo (item iii-iv) che corrisponde esattamente alle nostre virgolette In entram-bi i casi gli enti sono menzionati e svolgono una funzione metalinguistica sono collocati materialmente nel testo ma egrave come se si trovassero fuori e la loro descrizione li additasse ndash in effetti i segni convenzionali scritti nel testo sono a loro volta i relata di quelli che si trovano nella tabella
I relata dei segni scritti nel testo sono di due tipi singoli vocaboli (item i-ii) o descrizioni della funzione dei segni per mezzo di clausole sintaticamente complesse (item ii e iv) I singoli vocaboli sono γίνεται e παρά e sono entrambi preceduti dal τό lsquocitazionalersquo in quanto relata di segni convenzionali le forme abbreviate con cui sono tracciati nei manoscritti vanno forzatamente sciolte Bisogna ammettere che la per-spicacia e le risorse grafiche dei copisti ndash di cui tutto si puograve dire fuor che commettano qui degli errori ndash sono messe a dura prova con lrsquointrodurre segni identici ad abbreviazioni o con lrsquoattivare un gioco metalinguistico particolarmente serrato in un contesto meno lsquonaturalersquo di come potreb-be esserlo ad esempio quello di un trattato grammaticale Lrsquoitem iii che presenta direttamente un segno identico ad unrsquoabbreviazione non egrave sorretto da una descrizione ma da una giustificazione in διὰ τό Lrsquoartico-lo τό vi assume una funzione metalinguistica anche se non lsquocitazionalersquo poicheacute al tempo stesso genera un infinito sostantivato e lo singolarizza per questo ho scritto laquosono sottrattiraquo in corsivo nella mia traduzione
prio modello archimedeo (nota 32 supra) egli ne compila anche una breve lista Un elenco antico di laquosegni della geometriaraquo sicuramente redatto per assistere il copista si trova anche al f 3v del ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 vergato da Efrem negli anni 950-960 (tav 8 in Acerbi 2010) Possiamo farci unrsquoidea quantitativa del guadagno di spazio in rapporto ad un testo privo di abbreviazioni e con le parole separate da spazi sulla base del fragmentum mathematicum Bobiense il testo vi egrave disposto a tutta pagina su 36 righe di circa 30 segni ciascuna nelle due pagine in questione figurano 2038 segni con 15 mezze righe occupate dalle due figure Ora nel testo dellrsquoedizione stabilita in Heiberg 1927 pp 87-90 le stesse pagine contano 4455 segni spazi compresi Ne risulta che la dimensione in caratteri di un testo matematico puograve essere ridotta di piugrave della metagrave con lrsquoimpiego di compendi e segni convenzionali
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 147
Negli item ii e iv il segno si collega ad una descrizione nel secondo caso in via esclusiva le descrizioni pertanto rinforzano o sostituiscono lrsquoidentificazione con lrsquoente linguistico denotato Le clausole descrittive sono precedute da ἀντί e dallrsquoarticolo τό con funzione di lsquooperatore di citazionersquo esse sono παρ᾿ ἃ δεῖ τὸν μερισμὸν γίνεσθαι (item ii) e λοιποὶ οἱ μέλλοντες ἐπιμερίζεσθαι (item iv) Nella descrizione della divisione lsquoalla Papporsquo che leggeremo tra breve i segni negli item iii e iv rice-vono lo stesso trattamento degli altri due il loro relatum egrave un singolo vocabolo e non una clausola descrittiva rispettivamente nelle espres-sioni τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε (sul participio ritorneremo nel punto 1 infra) e τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά (la forma del segno notato con λ οι egrave descritta supra nellrsquoitem iv) La descrizione del segno oslash per il divisore merita una discussione piugrave dettagliata In origine si trovava probabilmente scritto Π(ΑΡΑ)ΕΧΟΝ successivamente letto come π(αρ[α])έχον ndash dato che lrsquoabbreviazione per il preverbo egrave identica a quella per la preposizione (che sia Π᾽ o un pi seguito dal segno per ἄρα a sormontare) ndash invece di π(αρὰ) ἔχον I copisti e i correttori si dettero a tutte le possibili contorsioni per restituire un testo dotato di senso leggere appunto una forma verbale con preverbo modificare il preverbo (ma forse il segno per ἄρα era insidiosamente simile ad uno epsilon) correggere il testo rileggiamo lrsquoapparato sub τὸ παρὰ ἔχον οὕτως τὸ παρέχον οὕτως M et π(αρ-) comp Z οὕτως τὸ περιέχον S τὸ περιέχον οὕτως C προγράφοντας οὕτως ex corr m 2 P Nella clausola descrittiva seguente la presenza liminare di παρὰ (che ho corretto in παρ᾿ ἃ nella speranza di restituire una frase che abbia un senso senza intervenire sul testo) innesca un bel corto circuito il Π(ΑΡΑ) che sicuramente figu-rava nellrsquoarchetipo egrave un sintagma complesso una preposizione unrsquoab-breviazione o un segno per unrsquoabbreviazione Se lrsquoeditore si trova in conflitto con la propria inclinazione alla critica conservativa i copisti si rifiutarono di mettere mano ad un testo che doveva stridere anche per loro essendo il compito demandato al ritocco del revisore del Par gr 2390 o alla riscrittura radicale del recensore bizantino Il problema egrave che ci troviamo di fronte ad unrsquoespressione che descrive la funzione dellrsquooggetto denotato non lrsquooggetto stesso ma che lo contiene al suo interno per soprammercato qui il Π(ΑΡΑ) egrave usato per giustificare una menzione a sua volta relatum di un segno
Evidentemente questa maniera di procedere che giagrave aveva attirato interventi da parte di copisti e correttori della recensione di base parve insostenibilmente opaca allrsquoautore della recensione bizantina61 Egli
61 Uno dei manoscritti di questa recensione propone anche una tabella di divisione
Fabio Acerbi148
modifica tutte le descrizioni diluendo lrsquoidiomatismo dellrsquoarticolo lsquocita-zionalersquo con lrsquointroduzione sistematica del verbo δηλόω e di frasi atte a chiarire quale sia il segno denotante e quale il vocabolo (o il segno) denotato Egli introduce allo scopo di rendere esplicita la funzione de-notativa dei segni introdotti il termine σημείου curiosamente in tutte le sue tre occorrenze esso compare a sua volta nella forma dellrsquoabbrevia-zione per sospensione σΗ´ Egli traccia il segno per i massimi multipli ἀφ e quello per i resti λ οι` in modo che non vi siano ambiguitagrave quanto al loro carattere di abbreviazione Si faccia infine attenzione al residuo di barra sul παρᾱ con funzione denotativa (2 occorrenze) contenuto nella descrizione del segno per il divisore sostituita dallrsquoaccento grave nel παρὰ con funzione discorsiva (la differenza egrave nettissima nei manoscritti da me consultati) Questa osservazione ci permette di passare direttamente allrsquoitem seguente
b) Le barre sui numerali e sulle lettere denotative Egrave opportuno discutere questo punto adesso esattamente percheacute di barre siffatte che pure troviamo in tutti i manoscritti i nostri testi non fanno mai menzione si tratta infatti di una pratica condivisa sin dallrsquoantichitagrave La barra identifica una stringa di lettere dellrsquoalfabeto che non svolge una funzione grammaticale o sintattica propria allrsquointerno del discorso Ciograve avviene in particolare e si tratta della fattispecie piugrave frequente se la stringa di lettere non dagrave origine a un vocabolo della lingua greca lette-re denotative e numerali certo ma anche termini provenienti da altri idiomi e contrazioni di parole greche come i nomina sacra62 tali termi-ni possono essere o no preceduti da un articolo lsquocitazionalersquo a seconda dellrsquouso che ne viene fatto allrsquointerno del discorso Ma non si tratta dellrsquounica fattispecie i papiri grammaticali ed i manoscritti piugrave antichi dei trattati dello stesso argomento segnalano gli esempi delle parti del discorso (cioegrave di lsquoverersquo parole greche) per mezzo di barre sormontanti63 La differenza insomma egrave tra menzione e uso (come parte del discorso in atto) di una stringa di caratteri tra il porre le lsquovirgolettersquo e il non porle tra funzione denotativa e non Apparentemente la convenzione si limi-
corredata dei segni opportuni e contrariamente alle indicazioni della descrizione svilup-pata lsquoin verticalersquo ma per motivi misteriosi non completa (tav 7a Laur Plut 89 sup 48 f 13r)
62 Tutto ciograve egrave spiegato con estrema chiarezza giagrave in Traube 1907 pp 45-4763 Si veda il Par gr 2548 codex vetustissimus e testimone unico delle lsquoopere minorirsquo
di Apollonio Discolo il f 106v con le barre ben visibili egrave riprodotto come tav 19 in De Gregorio 2000 (ivi pp 137-138 per la datazione) Per la testimonianza dei papiri grammaticali si veda Wouters 1979 passim essi contengono di norma elenchi di parti del discorso nessuna delle quali egrave preceduta dallrsquoarticolo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 149
tava in questo secondo caso a segnalare con la barra singoli vocaboli le menzioni di frasi o di sintagmi complessi sono di norma identificate dallrsquoarticolo lsquocitazionalersquo Drsquoaltra parte le abbreviazioni convenzionali non rientrano nella casistica percheacute la loro resa grafica che contiene elementi non alfabetici come compendi per desinenze lettere supra li-neam marche di contrazione o sospensione quali slashes o barre sotto-poste o sormontanti eventualmente solo un sottinsieme della stringa di segni alfabetici le esclude automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
Venendo al discorso matematico una barra sormonta senza ecce-zione le lettere denotative64 che sia in papiri o in manoscritti in maiu-scola65 o minuscola ma solo allrsquointerno del testo comrsquoegrave da attendersi nei diagrammi esse la perdono per il semplice motivo che non crsquoegrave alcun testo ambiente un diagramma ha unicamente una funzione denotati-va Drsquoaltra parte le lettere numerali che a volte figurano nei diagrammi della tradizione metrica66 allo scopo di indicare la lunghezza dei seg-menti mantengono la barra in un diagramma il contesto denotativo geometrico egrave prevalente e i numerali vengono percepiti come entitagrave grafiche lsquoesternersquo al discorso Va da seacute a fortiori che le lettere numerali inserite in un testo dovranno essere segnalate da barre che a loro volta non servono nelle tavole67 in quanto queste ultime sono come abbiamo visto un vero e proprio testo che perograve funge da ambiente a quello al-fabetico limitato alle titolazioni e non a caso tracciato in unrsquoopportuna lsquomaiuscola distintivarsquo allo scopo di segnalarne il carattere denotativo e non discorsivo68 Una tabella operazionale egrave invece un paratesto e quindi le barre sulle lettere numerali che rappresentano gli interi sono
64 La notazione per le lettere denotative subigrave unrsquoevoluzione (il cui risultato finale egrave descritto per sommi capi nella nota 3 supra) di cui non mette conto occuparsi qui
65 I papiri di contenuto geometrico (o astronomici ma che presentano argomenti geometrici) sono rari si vedano il PHerc 1061 (sec II aC Demetrio Lacone De geome-tria) e il PFay 9 (sec II ex Elementi I 39 e 41) Gli importanti ostraka OBerl 12002 e 12609 (sec III aC m Elementi XIII) non pongono le barre sopra le lettere denotative Per i manoscritti in maiuscola si veda ad esempio passim nel Par gr 2389 una cui riproduzione digitale egrave consultabile in rete allrsquoindirizzo httpgallicabnffrark12148btv1b8470171d o il fragmentum mathematicum Bobiense
66 Si veda ancora il ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 codex unicus dei Metrica di Erone e contenente una raccolta importante di problemi del corpus metrologico
67 Si vedano come esempio le tavole citate alle note 10 e 14 supra Discorso a parte per il segno di lsquoposto vuotorsquo si veda il punto c che segue
68 Queste regole generali vanno prese cum grano salis si dagrave naturalmente un certo dominio di variabilitagrave legato verosimilmente al grado di cultura grafica del copista nel PMich III 144 i numerali sono quasi tutti senza barra sia nel testo che nelle tabelle ope-razionali
Fabio Acerbi150
necessarie esse mancano invece sui segni convenzionali che ho descrit-to nel punto precedente e fatto rilevante sulle lettere numerali relative agli ordini sessagesimali quando esse siano identificate da uno o piugrave apici la presenza di questo segno grafico non alfabetico69 le esclude ancora una volta automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo Unrsquoultima osservazione che ci saragrave utile nel seacuteguito la descrizio-ne di una stringa di lettere lsquoagrammaticalersquo non puograve prevedere la men-zione della presenza della barra che le pertiene in quanto tale si tratta di una pratica denotativa che egrave possibile formulare soltanto ad un livello di discorso superiore sia a quello dellrsquouso che a quello della menzione70
c) Il segno di lsquoposto vuotorsquo Si noti nella tav 2b la forma ŏ per il segno di lsquoposto vuotorsquo in un ordine sessagesimale coerentemente con la propria notazione il copista del Marc gr 313 lo scioglie talvolta allrsquoin-terno del testo principale come unrsquoabbreviazione per οὐδέν laquonienteraquo Altre convenzioni di scrittura del tratto che accompagna il circoletto e che si badi bene fa parte integrante del segno di lsquoposto vuotorsquo ndash e infatti nelle tavole troviamo sempre il segno completo mentre tutti gli altri numerali sono come abbiamo visto nel punto precedente privi di barra o di apice a causa del fatto che i vari ordini sessagesimali sono univocamente determinati dalle linee di giustificazione ndash un tratto an-golare anteposto (tav 3 Lar Plut 2818 f 136v)71 o una semplice barra a sormontare (tavv 4-9) si produce in questo modo il segno 65926 che sembra essere stata la forma di base72
69 Occorre dunque supporre come testimoniano papiri e manoscritti in maiuscola che la convenzione relativa allrsquouso della barra si sia consolidata ben prima dellrsquointroduzione di segni diacritici quali accenti e spiriti
70 Si veda il punto 2 infra per maggiori dettagli sulla questione delle barre e degli apici e per le indicazioni in merito che leggiamo in Diofanto
71 Come accennato questa tavola dei sottomultipli coincide con quella descritta ed esposta nei Prolegomena Fatto molto rilevante i numerali nella prima non recano neacute barre neacute apici contrariamente a quanto accade a tutte le istanze della seconda nei manoscritti Quella del Laur Plut 2818 preserva a mio avviso la forma originaria come abbiamo visto una tavola non richiede segni aggiuntivi sulle lettere numerali
72 Si vedano come esempio ancora le tavole citate alle note 10 e 14 supra oppure per una rassegna delle forme che il segno assume nei manoscritti piugrave antichi delle Tavole facili Tihon 2011 pp 58-59 e per quelle che assume nei papiri Jones 1999 I pp 61-62 Ovviamente non possiamo leggere il segno 65926 come un omicron con una barra in quanto ο = 70 nella notazione greca e la barra egrave di rigore quando il numerale figuri allrsquointerno di un testo Occorre ammettere che si dagrave origine ad un bel corto circuito notazionale con il concepire un segno con funzione di lsquoposto vuotorsquo ma che lsquosomigliarsquo ad una lettera dellrsquoalfabeto sormontata da una barra cioegrave ad un numerale in piugrave quando il lsquoposto vuotorsquo non corrisponda ad un intero ma ad una specie sessagesimale la presenza della barra a priori indistinguibile da quella che sormonta gli interi introduce unrsquoincongruenza con la notazione a mezzo di apici vista nellrsquoitem precedente
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 151
d) Errori di copia La tabella riprodotta nella tav 2b ha una forma simmetrica ma si tratta di una forzatura il grande rettangolo in basso a destra drsquoaltronde assente nella descrizione contiene uno scolio che fa notare come lrsquoultimo resto parziale ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ͵γτνζ´´´´´ κζ´´´´´´ cioegrave 0 0 0 0 0 3357 27 siano ἔγγιστα λ´λ´ δ´δ´ ξ laquocon ottima approssimazione 60 minuti quartiraquo dove si notino gli apici semplici per indicare il pas-saggio allrsquoordinale e il raddoppiamento del sistema segno + apice per significare il plurale Lo scolio debitamente accompagnato dal segno di rimando in forma di simbolo solare egrave stato probabilmente incluso nella tabella proprio allo scopo di renderla simmetrica A sua volta un errore precedente spiega lo spazio eccessivo accordato al rettangolo contenente lo scolio il secondo massimo multiplo ŏ λβ´ ξδ´´ ριβ´´´ σιϛ´´´´ egrave trascritto anche al di sotto del risultato
Passiamo ora alla descrizione del metodo di divisione attribuito a Pappo
ἵνα οὖν ταῦτα συναχθῇ τὰ ἐκ τοῦ μερισμοῦ ὁ εἰρημένος Πάππος εὐδιατύπῳ τινὶ καὶ πρὸς τοῦτο τάξει χρησάμενος ποιεῖται τὴν τῆς συλλήψεως τοῦ ζητουμένου ἀνεύρεσιν οὕτως ἐκθέμενος γὰρ τὸν μέλλοντα μερίζεσθαι τουτέστι τὰς τξ μοίρας ἐν ἀρχῇ ἀφαιρεῖ ἀπ᾽ αὐτῶν τὸν ἐν τῇ σελίδι τυγχάνοντα ἐλάττονα τουτέστι τὸν τδ κβ´ κ´´ ὄντα τῶν ἐγγὺς ἐλασσόνων ὡς πρὸς τοὺς ἐκκειμένους διὸ καὶ γράφει αὐτὸν προγράφων αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε καὶ εὑρίσκων τὰ παρακείμενα αὐτῷ τῷ ἀπογραφέντι ἐν τῷ σελιδίῳ λεπτὰ πρῶτα ν´ συναπογράφεται παρατιθῶν αὐτοῖς τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον ἀνατείνουσαν σημαῖνον τὸ εἶδος ὅτι πρῶτα λεπτά εὑρίσκει οὖν οὕτως τὸ τῶν τξ μέρος τὸ τδ κβ´ κ´´ ὃ μεριζόμενον παρὰ τὰς τξε ιδ´ μη´´ ἡμέρας καὶ ποιοῦν τὸν ἐκ τοῦ μερισμοῦ ἀριθμὸν πρῶτα λεπτὰ ν´ καὶ τὸν λοιπὸν ἀπογραφόμενος τὸν νε λζ´ μ´´ προτάσσει αὐτοῦ τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά τάσσει δὲ καὶ ἁπλῆν τινα διατείνουσαν γραμμὴν ὡς ἀπὸ τοῦ τξ ἐπὶ τὸν ἑξῆς ἐκτεθειμένον ἐγγὺς
1
5
10
1 εὐδιατύπῳ] ZSPC εὐδιατύπωτ M 4 ἀφαιρεῖ] MZSP ἀφ ι C 5 ἐλάττονα] P comp MZSC 6 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | αφ ] αφ ε M ἀφ ZS ἀφαί P ἄφ C | ἀντὶ] om C | ἄφελε] MZSP ἄφ C 8 ἀπογραφέντι] MZSP ἐγγραφέντι C | λεπτὰ πρῶτα] P λε πρωτα SC λεπτῶν πρωτ MZ | παρατιθῶν] MZS παρατιθεὶς C et ex corr m 2 P 9 ᾱ] Z αο P α´ MS α C | ἔχον] MPC ἔχων ZS 9-10 πρῶτα λεπτά] ZP πρωτ λ´λ´ M πρωτα λε S αα λε C 11 ἡμέρας] comp codd | ἀριθμὸν] P et comp MZ καὶ C et comp S 12 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M πρωτ λεπτ(α) Z πρωτ λ εᾱ S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C | ἀπογραφόμενος] MZSP ἐγγραφόμενος C | νε λζ´] MZSP λζ νζ C 13 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | λ οι] MZSC ex λ fecit λ οι P | προσσημαῖνον] MC et προσ- comp ZS προση- P | τὸ] MZC τὰ S et fecit m 2 P 14 ἀπὸ] MZSP πρὸς C ἐλάττονα] P comp MZSC
1 εὐδιατύπῳ] εὐδιατυπώτω K 6-7 αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ] τὸ ἀφ K 8 παρατιθῶν mdash 10 λεπτά] τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ σημαίνουσαν τὸ εἶδος αὐτῶν ὅτι ᾱ λεπτά εἰσιν K | τὸ (sec)] τὰ K 12 πρῶτα] πρώτων K | τε λ ] λ οι` K | προσσημαῖνον mdash
Fabio Acerbi152
ἐλάττονα τὸν τδ κβ´ κ´´ ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις καὶ ταύτην ἐπιδεικνύουσαν τὴν τάξιν τῆς προόδου τῆς ἐκθέσεως ἧστινος κλωμένης γραμμῆς πρὸς τῷ ἐγγὺς ἐλάσσονι ἡ ἀντανάκλασις ἐπὶ τὸν λοιπὸν γέγραπται φερομένη ὡς εἴρηται διὰ τὸ εὔτακτον τῆς προκοπῆς οὕτως τε ποιήσας ἑξῆς τὸ αφ ποιῶν ὃ προσσημαίνει ὡς εἴρηται τὸ ὅτι δεῖ ἀφελεῖν ὁμοίως ἀπὸ τοῦ λοιποῦ καὶ δὴ τὸν ἐγγὺς πάλιν ἐλάσσονα ὡς πρὸς τὴν ἐν τῷ σελιδίῳ ἔκθεσιν εὑρισκόμενον λαμβάνων ἑξῆς προγράφει αὐτὸν ὄντα νδ μζ´ ιγ´´ ιβ´´´ καὶ εὑρίσκει αὐτοῖς παρακείμενα ἐν τῷ σελιδίῳ πρῶτα λεπτὰ θ´ ἅτινα καὶ αὐτὰ προσαπογράφεται σὺν τῇ παρασημειώσει τῶν πρώτων γράφων τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον τὴν ἀνατείνουσαν καὶ ὡς εἴρηται τὴν γραμμὴν πάλιν διὰ τὴν τάξιν κλωμένην κατὰ δευτέραν κλάσιν προσέλκει γινομένου τοῦ μέρους αὐτῆς τούτου παραλλήλου τῷ ἐξ ἀρχῆς
16 ante κλωμένης add ἐπὶ C 18 τε] MZP om SC | αφ ] M ἀφ ZSC ἀφαί P 19 προσσημαίνει] MS προση- ZC et ex corr P | ὅτι] ZP comp MSC 20 δὴ] MZSC διὰ fecit m 2 P 21 πρὸς] MSP et supra lineam C ex ἀπὸ fecit m 2 Z | ιγ´´] MZSP νγ´´ C 22 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M ᾱᾱ λεπτὰ Z άάα λε S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C 23 προσαπο- γράφεται] απο suprascr in comp M 24 ᾱ] ZP α´ MS α C 25 κλάσιν] MP τάξιν ZSC | τοῦ] ZSPC τούτου M 26 τούτου] τοῦ bis ZSPC sed prius erasit m 2 P τοῦ M
mdash 18 προκοπῆς] om K | τε ποιήσας] ποιήσας καὶ K | αφ ] ἀφ K 19 τὸ] om K 21 προ-γράφει] γράφει K 22 σελιδίῳ] α´ σελιδίῳ K | ἅτινα] ἃ K 23 προσαπογράφεται] ἀπογράφεται K | τῶν πρώτων mdash 26 ἐξ ἀρχῆς] om K
lsquoAllo scopo di raccogliere ciograve che risulta dalla divisione il detto Pappo utilizzando anche in questo caso una certa disposizione ben strutturata determina nel modo seguente il lsaquonumerorsaquo cercato preso nel suo insieme collocando73 in testa il lsaquonumerorsaquo che sta per essere diviso cioegrave i 360 gradi iniziali sottrae loro tra i piugrave prossimi dei lsaquonumerirsaquo minori rispetto a quelli esposti quello che si trova essere minore nella colonna (cioegrave 304 22 20) Questo egrave il motivo per cui lo trascrive scrivendogli davanti lrsquoabbreviazio-ne laquosottrraquo per laquosottrairaquo e trovando che 50 minuti primi sono collocati accanto a quello stesso lsaquonumerorsaquo che egrave stato trascritto nella colonna li trascrive al tempo stesso collocando accanto74 ad essi la lettera A con un lsaquotrattorsaquo75 sopra che significa la specie minuti primi Trova dunque in que-sto modo la parte di 360 che egrave 304 22 20 la quale divisa per 365 giorni 14 48 fa il numero lsaquoche risultarsaquo dalla divisione 50 minuti primi Trascrivendo
73 La descrizione egrave strutturata come una procedura Acerbi 201274 Il purismo del correttore del Par gr 2390 di Clostomalle nel Marc gr 314 e
dellrsquoautore della recensione bizantina impone loro di modificare la terminazione ma forme tematiche e contratte di τιθεῖν sono correnti nel greco tardivo
75 Il testo greco ha solo il participio con γραμμήν sottinteso Per il significato del participio si veda il punto 2
15
20
25
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 153
poi il resto 55 37 40 gli pone altresigrave76 a prefisso laquoReraquo che significa laquorestiraquo e dispone anche una certa linea semplice77 che va da 360 al piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori che egrave esposto di seacuteguito 304 22 20 come nello lsaquoschemarsaquo esposto linea che mostra lrsquoordine del percorso dellrsquoesposizione Questa linea spezzata lagrave dove si trova il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori egrave tracciata inflessa allrsquoindietro lsaquoersaquo punta verso il resto come egrave stato detto in vista di una progressione ordinata E cosigrave facendo prendendo di seacuteguito il laquosottrraquo che significa come egrave stato detto laquoche occorre similmente sottrarre dal re-storaquo e ovviamente prendendo di nuovo il lsaquonumerorsaquo che egrave trovato essere il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori in relazione alla disposizione nella colonna ndash 54 47 13 12 ndash lo scrive di seacuteguito e trova che 9 minuti primi sono posti loro accanto nella colonna trascrive78 anche questi con la segnaletica dei primi scrivendo la lettera A con un lsaquotrattorsaquo sopra e come egrave stato detto prolunga di nuovo la linea spezzata in vista di una buona disposizione tramite una seconda inflessione essendo questa sua parte parallela a quella inizialersquo
La descrizione continua con una serie di laquoe cosigrave viaraquo e non fa ulte-riore riferimento alla tabella
1) La forma verbale ἐξεσμένον Egrave il neutro del participio perfetto medio-passivo di ξέω lett laquopialloraquo laquolevigoraquo Si danno tre possibilitagrave si tratta di un termine canonico per quanto non altrove attestato per designare unrsquoabbreviazione oppure lrsquoautore anonimo improvvisa sul piano metaforico come se unrsquoabbreviazione non fosse altro che la paro-la completa lsquoaccorciata a colpi di piallarsquo in maniera opportuna oppure il testo egrave corrotto e srsquoimpone una correzione ad esempio τὸ ἑξῆς μένον laquociograve che sta di seacuteguitoraquo Questrsquoultima strada mi pare chiusa dal senso delle frase lrsquoabbreviazione non lsquosta di seacuteguitorsquo a niente ma anzi precede la perifrasi τὸ ἑξῆς μένον se impiegata semplicemente per rimandare al segno αφ immediatamente seguente costituirebbe un intollerabile solecismo Se accettiamo la prima di queste letture considerando quin-di lrsquoabbreviazione αφ in posizione predicativa abbiamo a che fare con
76 Rendo in questo modo il τε isolato77 La linea egrave laquosempliceraquo in quanto egrave una retta la precisazione intende evidenziare per
anticipazione il carattere lsquonon semplicersquo che essa assumeragrave alla prima inflessione quando diventeragrave una spezzata linee siffatte erano in effetti concepite dallrsquoanonimo e prima di lui da tutta la tradizione matematica greca come una singola linea spezzata nei punti drsquoinfles-sione I due segmenti paralleli menzionati al termine del passo sono orizzontali
78 Il verbo egrave al medio in variatio rispetto ai due che precedono e che seguono egrave il matematico che lsquosirsquo trascrive le cifre
Fabio Acerbi154
uno hapax semantico nella grecitagrave superstite come egrave facile verificare con una ricerca sul TLG in rete La recensione bizantina risolve il pro-blema sopprimendo semplicemente τὸ ἐξεσμένον
2) La notazione per le specie numeriche Nella terminologia matema-tica greca gli ordini sessagesimali sono εἴδη laquospecieraquo numerici essi corri- spondono agli ordini di grandezza nel nostro sistema decimale e indica-no in analogia con il caso geometrico la lsquoformarsquo che assume un numero quadrato cubo ecc Centinaia e migliaia sono quindi degli εἴδη rispet-tivamente quadrati (100 egrave il quadrato di 10) e cubi (1000 egrave il cubo di 10) sono specie numeriche ma non numeri particolari e drsquoaltronde 300 non egrave un quadrato ma 3 item dellrsquoεἶδος lsquoquadratorsquo 100 3 egrave il numerale di molteplicitagrave della specie quadrata lsquocentinaiarsquo i due 0 che seguono il 3 segnalano esattamente questo fatto che la notazione greca per gli interi non posizionale fa scomparire al livello denotativo Ciograve non vale soltan-to per i numeri interi ma anche per le loro parti i minuti secondi appar-tengono alla specie lsquoquadratorsquo in quanto 13600 egrave il quadrato di 160
La concezione appare interamente dispiegata nellrsquointroduzione degli Arithmetica diofantei79 che si rivela giova farlo rimarcare un te-stimone fondamentale per la ricostruzione della notazione matematica antica Alle specie usate in questrsquoopera vengono assegnati una denomi-nazione ed un segno convenzionale costituito dallrsquoiniziale (di ognuno dei componenti) della denominazione al quadrato o δύναμις il segno ΔΥ al κύβος il segno ΚΥ alla lsquoquarta potenzarsquo o δυναμοδύναμις il segno ΔΥΔ ecc La descrizione di tali segni egrave del tipo καὶ ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον Κ ἐπίσημον ἔχον Υ ΚΥ κύβος laquoe il suo segno egrave un Κ che ha come indice un Υ ΚΥ cuboraquo dove in accordo con quanto abbiamo visto nel punto b supra e pur nel comprensibile imbarazzo del copista della prima parte del Matritensis (o di un suo passato collega) a districarsi in questo formidabile ginepraio notazionale80 le due lettere Κ e Υ ricevono una barra mentre ΚΥ non la richiede a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον il quale ancora una volta esclude automaticamente il segno dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
79 In particolare a DOO I pp 214-62180 Nel Matr 4678 riscontriamo i seguenti fenomeni nelle poche righe a cavallo dei ff
58r-v 1) accento acuto posto su tutti i segni come se fossero abbreviazioni 2) ripetizione sistematica segnodenominazione come in ΚΥ κύβος appena letto dovuta sicuramente allrsquointrusione di glosse interlineari esplicative dei segni ndash e successivo pentimento (δύναμις e κύβος sono in effetti cancellati dalla prima mano il primo con un tratto il secondo con dei punti supra lineam poi il copista si stanca di correggere) 3) nella descrizione del segno per la δυναμοδύναμις menzione di un δέλτα δύο che saragrave molto probabilmente stato ΔΔ subito dopo nella descrizione del κυβόκυβος si legge un incongruo δύο KK
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 155
Diofanto introduce poi dei segni anche per le specie delle parti dellrsquounitagrave (le nostre frazioni) che egli chiama ὁμώνυμα μορία laquoparti omonimeraquo di cui quelle sessagesimali sono casi particolari81 Egli spie-ga appunto che le loro denominazioni sono ottenute da quelle delle specie degli interi per sinonimia passando ad un lsquoordinalersquo82 formato semplicemente aggiungendo il suffisso -στον δυναμοστόν κυβοστόν δυναμοδυναμοστόν ecc (sott μόριον) I loro segni convenzionali sono invece ottenuti da quelli per le specie degli interi aggiungendo una γραμμὴν διαστέλλουσαν τὸ εἶδος laquolinea che distingue la specieraquo83 Una linea sui segni delle specie delle parti egrave richiesta si badi bene per distinguerli dai segni di quelle degli interi come giagrave osservato questi ultimi sono giagrave lsquoagrammaticalirsquo a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον a fortiori lo saranno anche i primi Si tratta della traduzione semio-tica del passaggio dal cardinale allrsquoordinale che a livello grammaticale egrave effettuato con il suffisso -στον Che forma ha questa linea Barra o apice (Egrave cervellotico pensare a forme piugrave complesse) La domanda non ammette una risposta immediata in quanto delle specie diofantee nessuno piugrave si occupa nellrsquoantichitagrave84 Se egrave vero che la prima risposta darebbe origine ad un conflitto tra due convenzioni denotative diffe-renti la barra lsquocitazionalersquo e la barra che distingue la specie lrsquoevidenza grafica del Matritensis lascia lievemente sgomenti (ricordiamoci che giagrave i segni di base sono indebitamente dotati di un accento dal copista) Le poche occorrenze del segno per le specie delle parti85 vedono lrsquoaggiunta di uno slash di sospensione di un doppio apice inverso ndash in tutta evi-
81 Questo fatto era giagrave chiaro nellrsquoantichitagrave Teone in Alm I 10 in iA p 45310-1682 Il parallelo con i cardinali e gli ordinali relativi agli interi egrave reso esplicito da Dio-
fanto ὥσπερ δὲ τῶν ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια παρομοίως καλεῖται τοῖς ἀριθμοῖς τοῦ μὲν τρία τὸ τρίτον τοῦ δὲ τέσσαρα τὸ τέταρτον οὕτως καὶ τῶν νῦν ἐπονομασθέντων ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια κληθήσεται παρομοίως τοῖς ἀριθμοῖς laquocome le parti omonime dei numeri sono chia-mate per assonanza con i numeri di lsquotrersquo lsquolsaquounrsaquo terzorsquo di lsquoquattrorsquo lsquolsaquounrsaquo quartorsquo cosigrave le parti omonime dei numeri appena nominati saranno chiamate per assonanza con i numeriraquo (DOO I p 69-13 si noti lrsquoarticolo lsquocitazionalersquo al singolare in τοῦ τρία e τοῦ τέσσαρα) Il parallelo prosegue anche al livello dei segni che rappresentano queste specie come vedremo tra un attimo
83 Diofanto Arithmetica prefazione in DOO I p 620-21 un passaggio maltrattato in questa edizione occorre espungere il participio ἔχον senza introdurre segni ulteriori oppure eliminare un precedente ἐπί come fa un correttore del Matritensis f 58v
84 Unica parzialissima eccezione lrsquoaccenno di Teone menzionato nella nota 81 supra85 Al f 59r e per di piugrave nel margine per sanare un lungo saut du mecircme au mecircme La
collocazione in margine egrave il motivo per cui troviamo una notazione abbreviata nel resto del trattato il primo copista scioglie tutti i segni prendendoli per abbreviazioni mentre il secondo elimina sistematicamente il tratto aggiuntivo delle specie delle parti dellrsquounitagrave Drsquoaltronde egli scrive ad esempio ΔΥ invece di ΔΥ ed egrave quindi indotto a porre la barra al di sopra della stringa di lettere risultante (passim ma si veda ad esempio il f 72r)
Fabio Acerbi156
denza il compendio per la desinenza -ον accentata il copista interpreta il segno come unrsquoabbreviazione ndash e di una barra a sormontare lo Υ Potremmo forse interpretarlo come il segno di contrazione del grafema -στ- lrsquounico tassello mancante in unrsquoabbreviazione come ad esempio (δυναμοδυναμο)(στ)(ὸν) ma uno scolio di prima mano al f 58v rela-tivo alle specie degli interi inficia questrsquoipotesi esse sono dotate di slash di sospensione accento acuto in un caso del compendio canonico per la terminazione -ον hellip ma tutti gli Υ a esponente sono a loro volta sormontati da una barra
Meno legata al singolo manoscritto ma nondimeno non uniforme si presenta la pratica di notazione dei segni che rappresentano gli enti numerici sessagesimali86 da una parte sta lrsquoevidenza del testo dei Pro-legomena e delle sue tabelle apici ndash drsquoaltronde come abbiamo visto la notazione universalmente impiegata per i numerali ordinali e per le fra-zioni unitarie ndash dallrsquoaltra sta lrsquoevidenza del testo dellrsquoAlmagesto in tutti i manoscritti piugrave antichi e lo stesso si dica del commentario teonino a questrsquoopera o del suo lsquoGrande commentariorsquo alle Tavole facili e dei testi astronomici su papiro barre87 Sembra insomma che la nostra docu-
86 Sia le molteplicitagrave che le specie ahimeacute entrambe rappresentate da lettere dellrsquoalfabeto Come osservato allrsquoinizio della sezione 3 ci sono in effetti due tipi di lettere numerali in gioco se facciamo astrazione da apici o barre lsquo4 minuti secondirsquo si trova scritto δ β la prima lettera numerale denota la molteplicitagrave degli item di una certa specie la se-conda la specie nei Prolegomena entrambe sono accompagnate da un doppio apice il che rende inutile la presenza delle seconde Si noti che la descrizione della tabella non fa parola della notazione da usare per le lettere numerali che denotano la molteplicitagrave barre o apici e quanti apici hellip In questo caso fa interamente fede la tabella cioegrave la pratica grafica condivisa instauratasi non egrave chiaro quando
87 I manoscritti piugrave antichi dellrsquoAlmagesto sono menzionati nella nota 10 supra quelli dei due commentarii teonini sono il Laur Plut 2818 e il celeberrimo Vat gr 190 (sec IX in Euclide Elementi Data Teone lsquoGrande commentariorsquo) per la notazione dei pa-piri astronomici si veda Jones 1999 II passim La notazione non sembra lsquoinquinatarsquo dalla pratica dei copisti bizantini e pare dipendere soltanto dalla data di composizione Tro-viamo ad esempio barre sopra tutti i numerali di molteplicitagrave (interi o sessagesimali) nel frammento di un commentario alle Tavole facili contenente un calcolo relativo al 24 aprile 213 (Par gr 2841 sec XIII ex-XIV in oltre al frammento ai ff 32r l 11-34v l 23 contiene Arato Phaenomena ed Efestione Apotelesmatica edizione in Jones 1990) Nel commentario alle Tavole facili composto ca 610-617 ed attribuito a Stefano di Alessandria la situazione egrave la seguente (Jean Lempire per litteras per lrsquoedizione si veda Lempire 2014 ho controllato il Vat gr 304 ff 135r-171v sec XIV am contiene in aggiunta Teone in Almagestum I-II lsquoPiccolo commentariorsquo alle Tavole facili Diofanto Arithmetica e De polygo-nis numeris varia astronomica tabulae) barre sopra gli interi sporadicamente rimpiazzate da apici apici sopra le parti sessagesimali in numero uguale alla denominazione doppio () apice per le frazioni unitarie Sono impiegate barre sopra gli interi e apici sopra le parti sessagesimali nei manoscritti principali di tutti i trattati di introduzione allrsquoAlmagesto o comunque di argomento logistico redatti in epoca bizantina Giorgio Pachimere (1242-ca 1310) Quadrivium (autografo nel manoscritto Roma Biblioteca Angelica gr 38 [RGK III nr 115] si veda Tannery ndash Steacutephanou 1940 per lrsquoedizione) Teodoro Metochita (1270-
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 157
mentazione si faccia testimone di un cambio notazionale avvenuto nel periodo intercorrente fra Teone (sec IV pm) e la scuola alessandrina di Ammonio e dei suoi allievi (sec VI in) e probabilmente innescato da questrsquoultimo ambiente lrsquoaspetto paradossale egrave che nello stesso codice si rintraccino due notazioni differenti per gli enti numerici sessagesimali e lrsquouna (apici) sia adottata sistematicamente e coerentemente in uno scritto (i Prolegomena) che si presenta esattamente come unrsquointroduzione tecnica alla pratica numerico-algoritmica del trattato (lrsquoAlmagesto) in cui egrave adottata lrsquoaltra (barre che ritroviamo senza eccezioni anche negli scolii)
Torniamo ai Prolegomena la descrizione del segno da porre a fianco di ogni singolo quoziente parziale e denotante la sua specie numerica (minuti primi minuti secondi ecc) solleva tre problemi
Primo problema Ci vuole una barra o un apice su τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquola lettera A [hellip] che significa la specieraquo quando lo scriviamo nella tabella Tutta la nostra discussione precedente fa pro-pendere per lrsquoapice e si ricordi anche la forma verbale ἀνατείνουσαν che suggerisce qualcosa che si lsquoestende verso lrsquoaltorsquo (la mia traduzione egrave volutamente neutra) se fosse apposta una barra la cosa dovrebbe passare
1231332) Compendium astronomicum (copia lsquoautorizzatarsquo coeva nei Vat gr 182 e 181 da parte del copista che integrograve le parti mancanti del Par gr 2389 [ff 207-210 255-270 374-375] Bianconi 2005a pp 425-427 Peacuterez Martiacuten 2008 p 436 e n 177) Teodoro Meliteniota (morto lrsquo831393) Tribiblos astronomica (autografo nel Vat gr 792 si vedano Leurquin 1991 per unrsquoanalisi del manoscritto Leurquin 1990 per lrsquoedizione) una com-pilazione anonima (per cui ho consultato il Par gr 2396 ff 87r-92v limitatamente a questi fogli manu Costantino Trivoli [RGK II nr 318 ma ovviamente questo codice non vi egrave segnalato] terzo quarto del XV secolo il resto del codice annotato da Niceforo Gregora egrave di etagrave planudea e parzialmente [ff 33v-76v] un autografo di Planude stesso contiene Teone in Almagestum I II IV Mondrain 2002 il codice va completato ndash limitatamente a stralci dei libri VIII-X XII-XIII del commentario teonino la cui parte intermedia si egrave persa ndash con 26 carte [ff 123-147] inserite nel Vat gr 1087 anchrsquoesso contenente anno-tazioni di Gregora Rome 1927 per la figura del copista dei ff 77r-86r del Par gr 2396 e dei ff appena nominati del Vat gr 1087 un anonimo collaboratore di Gregora si veda in ultimo Bianconi 2006a pp 147-151) si veda anche il calcolo effettuato da Niceforo Gre-gora (12921295-13581361) dellrsquoeclisse di sole del 16 luglio 1330 (attestata unicamente ai ff 1r-8v della miscellanea astronomica Marc gr 325 databile ca 1324-1329 in parte vergata e ovunque fittamente annotata da Gregora stesso edizione del testo in Mogenet et al 1983 annotazioni di Gregora elencate in Bianconi 2005a p 413) Unrsquoeccezione apparente il lsquoPiccolo commentariorsquo di Teone alle Tavole facili le parti sessagesimali sono segnalate da apici (ad esempio nel Vat gr 175 vergato da Giovanni Catrario e completato nel 1321-1322 sulla figura di Catrario si vedano in ultimo Bianconi 2005b pp 141-156 e 2006b) lrsquoopera egrave antica ma la sua tradizione non rimonta oltre la fine del XIII secolo a parte un frammento nel Leiden BPG 78 ff 156r-161v (minuscola del IX-X secolo) e in effetti in questo manoscritto tutti i numerali di molteplicitagrave sono sormontati da barre Unrsquoeccezione effettiva egrave il De hypotesibus planetarum nel Vat gr 1594 barre sugli interi e apici sulle parti sessagesimali
Fabio Acerbi158
sotto silenzio e la presenza dellrsquoapice la rende inutile88 Si tratta della stessa convenzione diofantea e coincide ancora con la notazione per i numerali ordinali e per le frazioni unitarie che egrave corrente nei mano- scritti matematici greci per questo motivo non percheacute la descrizione sia particolarmente perspicua nessuno dei copisti della recensione an-tica ha incertezze apici Ma questi apici si rintracciano soltanto sulle indicazioni di specie non contemplate dalla descrizione che sono ante-poste ai resti parziali a fianco dei quozienti parziali i segni di specie sono invece trasformati in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordi-nali corrispondenti del tipo πρωτ tavv 5 e 7b-8 Il recensore bizantino taglia invece la testa al toro elimina dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali elimina la seconda menzione della laquolet-tera Araquo contestualmente allrsquoazzeramento dellrsquoespediente della linea a zig-zag (si veda il punto seguente) modifica la descrizione che contiene la prima menzione in quella dellrsquoapice associato direttamente ai nume-rali di molteplicitagrave riciclando addirittura lrsquoalpha per adibirlo a desi-gnare un numero cardinale (come sorprendersi) τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ laquoponendo al di sopra di essi [scil dei 50 minuti primi] 1 solo lsaquoaccentorsaquo acutoraquo La scelta del recensore egrave assennata che rechi una barra o un apice in una tabella un alpha denota un numero non un numero drsquoordine
Secondo problema da tenere ben distinto dal precedente Cosa ci vuole sul segno α per la lettera alpha menzionata nella frase τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquolettera A [hellip] che significa la specieraquo89 Unrsquooc-chiata allrsquoapparato critico rivela una bella incertezza nei manoscritti Z scrive sempre ᾱ e in un caso lo fa anche P MS optano sempre per α´ C per α P scrive nellrsquoaltro caso αο Per quanto solo la barra sia congrua con il senso della frase in quanto la lettera alpha egrave qui menzionata (si tratta di un oggetto che compare nella tabella) e non cambia niente se essa egrave accompagnata dal suo nome di genere στοιχεῖον ad un livello grafico lrsquoincertezza fra il segno ᾱ che denota laquola lettera αraquo e il segno α´ (o lrsquoabbreviazione αο) per una forma di πρῶτος egrave per piugrave versi giustificata
88 Detto in altri termini la barra egrave uno strumento grafico non matematico e quindi la sua presenza non va segnalata mentre un apice lo egrave e la sua presenza lo deve
89 Notare che in questa frase il primo α non vuole la barra (egrave menzionato allrsquointerno di una frase che impiega convenzioni moderne) il secondo sigrave (idem ma con convenzioni antiche) ndash e nella traduzione la scelta di denotarlo con A (senza virgolette) e non con lsquoArsquo (con virgolette) egrave del tutto arbitraria ndash si noti inoltre che le necessarie precisazioni laquosenzacon virgoletteraquo mostrano che le lingue moderne palesano difficoltagrave analoghe a quelle del greco antico per quanto riguarda i livelli denotativi in ambito metadiscorsivo per non usare le due parentetiche avrei dovuto scrivere rispettivamente lsquoArsquo e lsquolsquoArsquorsquo (doppie virgolette semplici)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 159
ᾱ coincide con il numerale 1 α egrave la prima lettera dellrsquoalfabeto ed inoltre α´ egrave esattamente quello che va scritto nella tabella Potremmo dirci che il sostantivo στοιχεῖον chiude la questione la sua presenza congiunta ad un ipotetico α´ renderebbe la descrizione ridondante o inappropriata90 Ma a parte il fatto che α egrave proprio τὸ πρῶτον στοιχεῖον il segno α´ cat-tura in fondo il cuore della descrizione di uno στοιχεῖον ἔχον lsaquoγραμμὴνrsaquo ἀνατείνουσαν
Terzo problema Lrsquoautore dei Prolegomena che si arresta allrsquoesem-pio dei minuti primi non dice quanti apici occorre mettere sulle lettere numerali che identificano gli ordini superiori al primo se uno soltanto come nel caso diofanteo e delle frazioni unitarie o in numero uguale alla loro denominazione (cioegrave pari al numero denotato dal numerale stesso su cui vanno posti) come effettivamente avviene nei mano-scritti dei Prolegomena La tabella egrave quindi sottodeterminata dalla sua descrizione anzi in un certo senso prende il sopravvento su di essa la pratica di marcare i numerali di molteplicitagrave con gli apici che compe-tono allrsquoordine cui appartengono viene trasferita ai segni per gli ordini stessi per supplire ad una descrizione carente di questi ultimi E la tabella egrave sottodeterminata dalla descrizione in quanto egrave la descrizione di una tabella reale ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις laquocome nello lsaquoschemarsaquo espostoraquo leggiamo a un certo punto del testo
3) La linea a zig-zag Non possiamo che applaudire a questo geniale espediente grafico lo troviamo messo in opera solo nel Marc gr 313 Per quanto lrsquoautore non faccia parola di ciograve nel corso della sua descrizione la linea spezzata egrave intesa dover lsquosaltarersquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue Il copista del codice marciano effettua correttamente due salti nella prima delle sue tabelle (tav 4) ma inserisce un lsquodentersquo in piugrave in quella che considera corretta (tav 5) La linea a zig-zag egrave incompatibile con la presenza di linee di giustificazione nella tabella che in effetti mancano nel Marc gr 313 ciograve induce gli errori di allineamento dei primi 5 quozienti parziali di cui egrave vittima il copista Probabilmente per questo motivo in nessuno degli apografi del Vat gr 1594 la linea a zig-zag figura nella tabella inquadrata come si conviene da una (doppia) cornice esterna e le cui colonne sono appunto separate da linee verticali (tav 7b Vat gr 184 f 17v e tav 8 Par gr 2390 f 9v cui egrave sostanzialmente identica la tabella del Marc gr 314 che si trova
90 Trascuro lrsquoabbreviazione αο = πρῶτος percheacute la desinenza non egrave quella richiesta neacute nella frase (egrave richiesto πρῶτον) neacute nella tabella (πρῶτα)
Fabio Acerbi160
al f 248r ndash ma la mancanza di linee orizzontali causa un gigantesco pa-sticcio nel codice vaticano) Alla recensione bizantina che dipende per il suo testo di base dal Vat gr 1594 e quindi non trova la linea a zig-zag nella tabella non resta che sopprimere la sua descrizione ndash ma proprio per questo motivo e finalmente diventa possibile tracciare un apparato completo di linee di giustificazione (tav 9 Laur Plut 89 sup 48 f 14v) Dato che la descrizione di Teone di questo procedimento di divi-sione non fa cenno allrsquoesistenza della linea a zig-zag viene da chiedersi se essa non costituisca un espediente escogitato dallrsquoautore dei Prolegomena per vivacizzare la procedura originale di Pappo
4) Discrepanze tra descrizione e tabella Il gioco delle minime va-rianti mostra che la divisione era stata eseguita (e trasmessa) corret-tamente tutti i valori numerici sono esatti La tabella nel Marc gr 313 presenta perograve alcune discrepanze con la propria descrizione Essa omette (ma non nella versione lsquoscorrettarsquo lrsquoomissione non si riscontra neanche nel Par gr 2390) il segno per laquorestoraquo di fronte ai resti par-ziali ma aggiunge lrsquoindicazione della loro specie Essa trasforma invece come abbiamo visto le indicazioni di specie che seguono i quozienti parziali in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordinali corri-spondenti La descrizione prevede di chiudere la tabella con il risultato καὶ συνάγων ἅπαντα τὰ ἐκ τῶν μερισθέντων μερῶν λεπτὰ σημειοῦται ὑπὸ πάντας οὕτως γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoe raccogliendo tutti i minuti che provengono dalle parti divise lsaquoPapporsaquo nota sotto tutto cosigrave Ris 0 59 8 17 13 12 31raquo ma sotto la tabella tutta la tradizione ci consegna qualcosa di piugrave articolato ὁ ζητούμενος καθ᾽ ὃν μερίζεται ὁ τξε ιδ´ μη´´ π(αρὰ) τὸν τξ γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoil lsaquonumerorsaquo cercato secondo cui 365 14 48 egrave diviso per 360 risulta 0 59 8 17 13 12 31raquo frase che del resto contiene due errori lrsquoinversione del dividendo e del divisore e la confusione tra segno convenzionale (iuxta descrizione) e abbreviazione (come nella frase) nel caso di γι Oltre ad eliminare la linea a zig-zag91 la recensione bizantina sopprime dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali e modifica come abbiamo visto al punto 2 le loro descrizioni in quelle di apici associati diretta-mente ai numerali di molteplicitagrave
91 Le due righe che nella recensione di base contengono solo i resti parziali minori di 160 del divisore ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue sono in parte completate con lrsquoindicazione abbreviata ἀνάλ(υσις) laquoanalisiraquo il termine greco per questa procedura di riduzione In un sussulto di ipercorrettismo matematico tali resti parziali ridotti non sono preceduti dal segno per laquorestoraquo come nel Par gr 2390 ma da quello per laquorisultatoraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 161
Gli esempi che abbiamo discusso mostrano come i problemi di notazione pesino e non poco sullrsquoespressione discorsiva di un algorit-mo matematico lrsquoente di riferimento per lsquoformularersquo il procedimento di divisione fu considerata la tabella cioegrave un oggetto la cui costitu-zione egrave legata piugrave ad una pratica grafica che a considerazioni logico- algoritmiche non la sua descrizione che in effetti finisce per determi-nare la tabella in maniera non univoca Di questa sottodeterminazione si fa testimone la traiettoria che abbiamo cercato di seguire nelle mani di copisti e revisori il procedimento di divisione si modifica a volte in aspetti secondari a volte in punti piugrave sostanziali ndash fino a rendere neces-saria una radicale revisione della sua descrizione per renderla conforme alla tabella ndash in ogni caso mai per ragioni squisitamente matematiche92
Abstract
The article presents and discusses in detail two passages from the anonymous Prolegomena to the Almagest a VIth century primer to the elementary procedures of calculation needed in Ptolemyrsquos Almagest In the two passages we may follow the complex interplay between mathematical notation the auctor who employed and described it the tachygrapher who transcribed it in vivo copyists who reproduced it correctors who modified it Along this path misgivings and errors arise in the transmission of abbreviations and paratextual units such as diagrams tables operational schemes
Fabio AcerbiCNRS UMR8560 Centre Alexandre Koyreacute
fabacerbigmailcom
92 Sono grato a Daniele Bianconi Lucio del Corso Jean Lempire per alcune preziose indicazioni
AOO = Archimedis opera omnia cum commentariis Eutocii ed J L Heiberg I-III Lipsiae 1910-1915
DOO = Diophanti Alexandrini opera omnia cum Graecis commentariis ed P Tannery I-II Lipsiae 1893-1895
GC = Le laquoGrand Commentaireraquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Mogenet ndash A Tihon I-III Cittagrave del Vaticano 1985-1999
iA = Commentaires de Pappus et de Theacuteon drsquoAlexandrie sur lrsquoAlmageste ed A Rome I-III con paginazione continua Cittagrave del Vaticano 1931-1943
HOO = Heronis Alexandrini opera quae supersunt omnia ed G Schmidt ndash L Nix ndash W Schmidt ndash H Schoene ndash J L Heiberg I-V Lipsiae 1899-1914
PC = Le ldquoPetit Commentairerdquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed A Tihon Cittagrave del Vaticano 1978
POO = Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia ed J L Heiberg I-II in 3 parti Lipsiae 1898-1907
RGK = Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600 I Handschriften aus Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln II Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs und Nachtraumlge zu den Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln III Handschriften aus Bibliotheken Roms mit dem Vatikan A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg unter Mitarbeit von D Harlfinger und P Eleuteri B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln Wien 1981-1997 (Oumlsterreichische Akademie der Wissenschaften Veroumlffentlichungen der Kommission fuumlr Byzantinistik III1-3 A-C)
Sigla
Acerbi 2010 = F Acerbi Il silenzio delle sirene La matematica greca antica Roma 2010
Acerbi 2012 = F Acerbi I codici stilistici della matematica greca dimostrazioni procedure algoritmi laquoQUCCraquo 1012 (2012) pp 167-214
Acerbi et al 2010 = F Acerbi ndash N Vinel ndash B Vitrac Les Proleacutegomegravenes agrave lrsquoAlmageste Une eacutedition agrave partir des manuscrits les plus anciens Introduction geacuteneacuterale ndash Parties I-III laquoSCIAMVSraquo 11 (2010) pp 53-210
Agati 1992 = M L Agati La minuscola laquoBouleteacuteeraquo Cittagrave del Vaticano 1992
Belger 1881 = C Belger Ein neues Fragmentum mathematicum Bobiense laquoHermesraquo 16 (1881) pp 261-284
Bianconi 2005a = D Bianconi La biblioteca di Cora tra Massimo Planude e Niceforo Gregora Una questione di mani laquoSampTraquo 3 (2005) pp 391-438
Bianconi 2005b = D Bianconi Tessalonica nellrsquoetagrave dei Paleologi Le pratiche intellettuali nel riflesso della cultura scritta Paris 2005
Bianconi 2006a = D Bianconi Le pietre e il ponte ovvero identificazioni di mani e storia della cultura laquoBizantinisticaraquo 8 (2006) pp 135-181
Bianconi 2006b = D Bianconi Qualcosa di nuovo su Giovanni Catrario laquoMEGraquo 6 (2006) pp 69-91
Cavallo 1977 = G Cavallo Funzione e strutture della maiuscola greca tra i secoli VIII-XI in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Colloque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 95-137
Cereteli 1904 = G F Cereteli De compendiis scripturae codicum Graecorum praecipue Petropolitanorum et Mosquensium anni nota instructorum Sankt-Petersburg 1904
De Gregorio 2000 = G De Gregorio Materiali vecchi e nuovi per uno studio della minu-scola greca fra VII e IX secolo in G Prato (a cura di) I manoscritti greci tra riflessione e dibattito Atti del V Colloquio Internazionale di Paleografia Greca Cremona 4-10 ottobre 1998 Firenze 2000 pp 83-151
Follieri 1977 = E Follieri La minuscola libraria dei secoli IX e X in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Col-loque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 139-165
Fonkič 2005 = B Fonkič Venecianskaia rukopisrsquo laquoAlrsquomagestaraquo Ptolemeja (Marc gr 313690) o datirovke i proischoždenii kodeksa laquoVDIraquo s III 254 (2005) pp 162-167
Fowler 1999 = D H Fowler The Mathematics of Platorsquos Academy A New Reconstruction Second Edition Oxford 1999
Bibliografia
Fabio Acerbi164
Gerstinger ndash Vogel 1932 = H Gerstinger ndash K Vogel Eine stereometrische Aufgaben-sammlung im Papyrus Graecus [sic] Vindobonensis 19996 laquoMitteilungen aus der Papy-russammlung der Nationalbibliothek in Wienraquo Neue Serie Folge 1 Griechische literarische Papyri 1 Wien 1932 pp 11-76
Heiberg 1927 = Mathematici Graeci Minores ed J L Heiberg Kjoslashbenhavn 1927
Hultsch 1876-1878 = Pappi Alexandrini Collectionis quae supersunt ed F Hultsch I-III Berlin 1876-1878
Janz 2003 = T Janz The Scribes and the Date of the Vat gr 1291 in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae X Cittagrave del Vaticano 2003 pp 159-180
Jones 1990 = Ptolemyrsquos First Commentator ed A Jones Philadelphia 1990
Jones 1999 = Astronomical Papyri from Oxyrhynchus ed A Jones I-II Philadelphia 1999
Jones 2005 = A Jones Ptolemyrsquos Canobic Inscription and Heliodorusrsquo Observation Reports laquoSCIAMVSraquo 6 (2005) pp 53-97
Lempire 2014 = Steacutephanos drsquoAlexandrie Le commentaire aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Lempire Louvain 2014
Leurquin 1990 = Theacuteodore Meacuteliteacuteniote Tribiblos astronomique Livre I ed R Leurquin Amsterdam 1990
Leurquin 1991 = R Leurquin Un manuscrit autographe de la Tribiblos Astronomique de Theacuteodore Meacuteliteacuteniote le Vaticanus graecus 792 laquoScriptoriumraquo 45 (1991) pp 145-162
Maas 1927 = P Maas Griechische Palaeographie in A Gercke ndash E Norden (hrsg von) Einleitung in die Altertumswissenschaft I9 Leipzig 1927 pp 69-80
Martinelli Tempesta 2010 = S Martinelli Tempesta Il codice Milano Biblioteca Am-brosiana B 75 sup (gr 104) e lrsquoevoluzione della scrittura di Giovanni Scutariota in A B Garciacutea ndash I Peacuterez Martiacuten (ed by) The Legacy of Bernard de Montfaucon Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting Proceedings of the Seventh Inter-national Colloquium of Greek Palaeography Madrid-Salamanca 15-20 September 2008 Turnhout 2010 pp 171-186
Mazzucchi 1994 = C M Mazzucchi Leggere i classici durante la catastrofe (Costantino-poli maggio-agosto 1203) le note marginali al Diodoro Siculo Vaticano gr 130 Parte prima stratigrafia laquoAevumraquo 68 (1994) pp 164-218
Mioni 1976 = E Mioni Bessarione scriba e alcuni suoi collaboratori in Miscellanea marcia-na di studi bessarionei Padova 1976 pp 263-323
Mioni 1985 = Codices graeci manuscripti Bibliothecae Divi Marci Venetiarum II Thesaurus Antiquus Codices 300-625 recensuit E Mioni Roma 1985
Mogenet 1962 = J Mogenet Une scholie ineacutedite du Vat gr 1594 sur les rapports entre lrsquoastronomie arabe et Byzance laquoOsirisraquo 14 (1962) pp 198-221
Mogenet et al 1983 = Niceacutephore Greacutegoras Calcul de lrsquoeacuteclipse de soleil du 16 juillet 1330 ed J Mogenet ndash A Tihon ndash R Royez ndash A Berg Amsterdam 1983
Mondrain 2002 = B Mondrain Maxime Planude Niceacutephore Greacutegoras et Ptoleacutemeacutee laquoPa-laeoslavicaraquo 10 (2002) pp 312-322
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 165
Mondrain 2004 = B Mondrain Lrsquoancien empereur Jean VI Cantacuzegravene et ses copistes in A Rigo (a cura di) Gregorio Palamas e oltre Studi e documenti sulle controversie teologiche del XIV secolo bizantino Firenze 2004 pp 249-296
Mondrain 2007 = B Mondrain Les eacutecritures dans les manuscrits byzantins du XIV e siegravecle Quelques probleacutematiques laquoRSBNraquo n s 44 (2007) pp 157-196
Peacuterez Martiacuten 2006 = I Peacuterez Martiacuten Maxime Planude et le Diophantus Matritensis (Madrid Biblioteca Nacional ms 4678) un paradigme de la reacutecupeacuteration des textes anciens dans la ldquorenaissance paleacuteologuerdquo laquoByzantionraquo 76 (2006) pp 433-462
Peacuterez Martiacuten 2008 = I Peacuterez Martiacuten El lsquoestilo Hodegosrsquo y su proyeccioacuten en las escrituras constantinopolitanas laquoSampTraquo 6 (2008) pp 389-458
Perria 1991 = L Perria Scrittura e ornamentazione nei codici della laquocollezione filosoficaraquo laquoRSBNraquo n s 28 (1991) pp 45-111
Rollo 2012 = A Rollo LrsquoArchimede di Giorgio Valla in V Fera ndash D Gionta ndash A Rollo (a cura di) Archimede e le sue fortune Atti del Convegno di Siracusa-Messina 24-26 giugno 2008 Messina 2012 pp 99-147
Rome 1927 = A Rome Membra disjecta laquoRBenraquo 39 (1927) pp 187-188
Rome 1938 = A Rome Un manuscrit de la bibliothegraveque de Boniface VIII agrave la Meacutediceacuteenne de Florence laquoACraquo 7 (1938) pp 261-268
Ronconi 2013 = F Ronconi La collection philosophique un fantocircme historique laquoScripto-riumraquo 67 (2013) pp 119-140
Tannery ndash Steacutephanou 1940 = Quadrivium de Georges Pachymegravere ed P Tannery ndash E Steacutephanou Cittagrave del Vaticano 1940
Tihon 2011 = Πτολεμαίου Πρόχειροι Κανόνες Les Tables faciles de Ptoleacutemeacutee vol Ia Tables A1-A2 ed A Tihon Leuven 2011
Traube 1907 = L Traube Nomina Sacra Versuch einer Geschichte der christlichen Kuumlrzung Muumlnchen 1907
Vogel 1936 = K Vogel Beitraumlge zur griechischen Logistik laquoSBAWraquo Mathematisch-natur-wissenschaftliche Abteilung Jahrgang 1936 pp 357-472
Wouters 1979 = A Wouters The Grammatical Papyri from Graeco-Roman Egypt Contri-butions to the Study of the lsquoArs Grammaticarsquo in Antiquity Brussel 1979
F ACERBI Tav 1
b Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 65r
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 284 f 160r
F ACERBITav 2
b Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 13r
a Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 19v
F ACERBI Tav 3
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 136v
F ACERBITav 4
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17r
F ACERBI Tav 5
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17v
F ACERBITav 6
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 7v
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
Fabio Acerbi144
in ἀριθμός ed aggiunge un altro segno56 sopra il terzo anteponendovi lrsquoindicazione καὶ ἔστιν αὐτοῦ σ(ημεῖον) τόδε Va da seacute che non abbiamo nessuna garanzia che il segno originariamente introdotto da Diofanto coincidesse realmente con unrsquoabbreviazione convenzionale per ἀριθμός Lrsquoevidenza del PMich III 144 (sec II in) suggerisce drsquoaltronde che il Matritensis e con esso tutta la tradizione medievale di Diofanto ripro-duca fedelmente pur accentuandone la sinuositagrave il segno originario
ii Segno per il divisore Un cerchiolino sbarrato da non confondere con il segno per ὁμοῦ che nei manoscritti matematici ha di norma due barre trasversali (cf tav 2a) Non sono riuscito a rintracciarne ulteriori occorrenze in altre opere la forma che esso assume nel Vat gr 2326 e la correzione apportata nel Par gr 2390 lasciano aperta la possibilitagrave per quanto a mio avviso remota che la forma originaria non fosse lon-tana da unrsquoabbreviazione di παρά registrata nei repertori57 Il correttore del Par gr 2390 trasforma in effetti il segno oslash nellrsquoaffine abbreviazione canonica per (forme di) ἐλάσσων laquominoreraquo58 e si incarica diligente-mente di farlo notare ricapitolando i segni nella porzione superiore del margine esterno del f 7v Nello stesso margine egli traccia anche uno lsquoscolio tabellarersquo ed egrave lrsquounico a porre il (proprio) segno dove indicato dalla descrizione (tav 6 Par gr 2390 f 7v) Oltre a ciograve adattando la tabella al margine ristretto lo scoliaste trascrive come colonne affian-cate le due righe dei resti parziali e dei massimi multipli e aggiunge le indicazioni ὁ μεριζόμενος laquodividendoraquo e ὁ μερίζων laquodivisoreraquo ma vi introduce alcune incongruenze di formato il risultato scritto in verti-cale e la linea verticale di sinistra che separa il divisore dal segno che lo dovrebbe precedere direttamente
iii Segno per i massimi multipli Corrisponde alla semplice abbre-viazione per sospensione della forma verbale ἄφελε laquosottrairaquo in questo
56 Si tratta del segno di ampio uso praticamente identico allrsquoabbreviazione canonica per οὖν
57 Si tratta di un pi a forma di gancio sbarrato da uno slash di troncamento Ce-reteli 1904 tav IX item 7 sub ΠΑΡΑ che rinvia al PVindRain 423 cf anche la forma π` nel POxy LXI 4142 edito in Jones 1999 II pp 26-34 In generale nei papiri e nei manoscritti matematici in maiuscola le preposizioni sono abbreviate facendo seguire un lsquoapostroforsquo alla loro prima lettera Α᾽ Υ᾽ ecc Per la seconda fattispecie di supporto libra-rio si veda in particolare il cosiddetto fragmentum mathematicum Bobiense scriptio inferior databile al V-VI secolo del palinsesto Milano Biblioteca Ambrosiana L 99 sup (Isidoro di Siviglia Etymologiae datazione Cavallo 1977 p 100) pp 113-114 che sono stampate in riproduzione apografa conforme in Belger 1881 (la p 114 egrave riprodotta anche nella tav 10 di Acerbi 2010)
58 Se questa era lrsquointenzione si tratta ovviamente di una forzatura il divisore puograve ben essere maggiore del dividendo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 145
caso lo slash di troncamento taglia orizzontalmente il tratto verticale del phi I copisti offrono molteplici varianti apponendo chi uno spirito dolce chi un ε chi un αί accentato a sormontare Tutti questi segni svolgono la funzione di abbreviazioni vere e proprie (e cosigrave doveva essere anche per lrsquoautore si veda il punto 1 di p 153 infra) la forma originale si ottiene a mio avviso incrociando i dati del Marc gr 313 e dei tre apografi del Vat gr 1594 αφ anche se lrsquoassenza dello spirito potrebbe essere semplicemente dovuta alla pratica del copista del codice veneziano di economizzare nei diacritici
iv Segno per i resti Un lambda completato da una barra a sormon-tare o da un apice che rinvia alle abbreviazioni per sospensione di una forma opportuna di λοιπός laquorestoraquo In realtagrave la forma che troviamo nella tabella egrave differente (tav 2b) e coincide con quella offerta quasi unanimemente dai manoscritti nella descrizione e in almeno un caso nella tabella del metodo di divisione attribuito a Pappo (tav 4) un lambda che accoglie al di sotto una legatura omicron-iota () sbarrata da uno slash di troncamento Qualcosa di simile si trova nel PVindob G 19996 (sec I) una specie di lambda maiuscolo molto aperto e dal vertice arrotondato che include un circoletto interpretato dagli editori come segno per περίεστιν o per λοιπόν59 Lo stesso segno si rintraccia ad esempio in un medesimo scolio tabellare di prima mano ad Alma-gestum nel Vat gr 1594 f 93v e nel Marc gr 313 f 135r ma stavolta la forma del lambda egrave molto ben definita
Fin qui i segni Ma il gioco egrave piugrave complesso La descrizione si muo-ve pericolosamente sulla linea di confine non sempre ben definita tra segno convenzionale e abbreviazione il primo ndash e il repertorio grafico matematico-astronomico ne egrave particolarmente fornito60 ndash puograve anche
59 Ho consultato lrsquoedizione Gerstinger ndash Vogel 1932 pp 46 e 48 la porzione rilevante del papiro egrave riprodotta nella tav 11 di Fowler 1999 Si veda ancora ivi pp 253-257 per la trascrizione di questo segmento di testo (con correzioni rispetto alla princeps) e per una messa a punto recente inclusa la proposta di datazione che ho riportato qui sopra Il verso del papiro che contiene una tavola aritmetica del tutto scorrelata dalla tematica del recto egrave edito come PRain Unterricht 151
60 La pratica di ridurre lo spazio occupato da un testo tecnico per mezzo di abbreviazioni e segni convenzionali era molto diffusa nei manoscritti in maiuscola contrariamente a quanto avviene per altri generi letterari vedremo tra breve cosa accade negli Arithmetica di Diofanto ma si leggano in proposito anche le considerazioni di Hei-berg nei prolegomena alla propria edizione dellrsquoAlmagesto in particolare riguardo al ricorso massiccio ad espedienti brachigrafici nel modello del Vat gr 180 POO II pp lxxxiv-xciii civ-cv cxxvii cxxxviii-cxxxix Agli elenchi dettagliati forniti da Heiberg possiamo aggiungere il piccolo prontuario stampato in Hultsch 1876-1878 III 2 pp 126-132 e basato sul testo e sugli scolii alla Collectio di Pappo nel Vat gr 218 (sec X in) Si vedano infine le osservazioni del copista del Par gr 2360 f 120v trascritte da Heiberg in AOO III pp x-xi sulle laquonotazioni tipiche a scopo di tagliar corto nello scrivereraquo impiegate nel pro-
Fabio Acerbi146
derivare dalla seconda (un caso egrave appunto il segno per ἐλάσσων che probabilmente trae origine da una legatura epsilon-lambda) ma poi il rapporto referente-relato si fissa convenzionalmente Quelli definiti nel testo che abbiamo letto sono appunto segni convenzionali non ci sarebbe bisogno di spiegarne forma e funzione se fossero intesi come abbreviazioni assumono nella tabella una funzione denotativa non esplicativa o discorsiva (come accade invece nella tav 1a) Ma come vengono descritti questi segni
I referenti delle descrizioni sono i segni sono introdotti da οὕτως (item i-ii) o in alternativa da un τό con il ruolo di lsquooperatore di citazionersquo (item iii-iv) che corrisponde esattamente alle nostre virgolette In entram-bi i casi gli enti sono menzionati e svolgono una funzione metalinguistica sono collocati materialmente nel testo ma egrave come se si trovassero fuori e la loro descrizione li additasse ndash in effetti i segni convenzionali scritti nel testo sono a loro volta i relata di quelli che si trovano nella tabella
I relata dei segni scritti nel testo sono di due tipi singoli vocaboli (item i-ii) o descrizioni della funzione dei segni per mezzo di clausole sintaticamente complesse (item ii e iv) I singoli vocaboli sono γίνεται e παρά e sono entrambi preceduti dal τό lsquocitazionalersquo in quanto relata di segni convenzionali le forme abbreviate con cui sono tracciati nei manoscritti vanno forzatamente sciolte Bisogna ammettere che la per-spicacia e le risorse grafiche dei copisti ndash di cui tutto si puograve dire fuor che commettano qui degli errori ndash sono messe a dura prova con lrsquointrodurre segni identici ad abbreviazioni o con lrsquoattivare un gioco metalinguistico particolarmente serrato in un contesto meno lsquonaturalersquo di come potreb-be esserlo ad esempio quello di un trattato grammaticale Lrsquoitem iii che presenta direttamente un segno identico ad unrsquoabbreviazione non egrave sorretto da una descrizione ma da una giustificazione in διὰ τό Lrsquoartico-lo τό vi assume una funzione metalinguistica anche se non lsquocitazionalersquo poicheacute al tempo stesso genera un infinito sostantivato e lo singolarizza per questo ho scritto laquosono sottrattiraquo in corsivo nella mia traduzione
prio modello archimedeo (nota 32 supra) egli ne compila anche una breve lista Un elenco antico di laquosegni della geometriaraquo sicuramente redatto per assistere il copista si trova anche al f 3v del ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 vergato da Efrem negli anni 950-960 (tav 8 in Acerbi 2010) Possiamo farci unrsquoidea quantitativa del guadagno di spazio in rapporto ad un testo privo di abbreviazioni e con le parole separate da spazi sulla base del fragmentum mathematicum Bobiense il testo vi egrave disposto a tutta pagina su 36 righe di circa 30 segni ciascuna nelle due pagine in questione figurano 2038 segni con 15 mezze righe occupate dalle due figure Ora nel testo dellrsquoedizione stabilita in Heiberg 1927 pp 87-90 le stesse pagine contano 4455 segni spazi compresi Ne risulta che la dimensione in caratteri di un testo matematico puograve essere ridotta di piugrave della metagrave con lrsquoimpiego di compendi e segni convenzionali
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 147
Negli item ii e iv il segno si collega ad una descrizione nel secondo caso in via esclusiva le descrizioni pertanto rinforzano o sostituiscono lrsquoidentificazione con lrsquoente linguistico denotato Le clausole descrittive sono precedute da ἀντί e dallrsquoarticolo τό con funzione di lsquooperatore di citazionersquo esse sono παρ᾿ ἃ δεῖ τὸν μερισμὸν γίνεσθαι (item ii) e λοιποὶ οἱ μέλλοντες ἐπιμερίζεσθαι (item iv) Nella descrizione della divisione lsquoalla Papporsquo che leggeremo tra breve i segni negli item iii e iv rice-vono lo stesso trattamento degli altri due il loro relatum egrave un singolo vocabolo e non una clausola descrittiva rispettivamente nelle espres-sioni τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε (sul participio ritorneremo nel punto 1 infra) e τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά (la forma del segno notato con λ οι egrave descritta supra nellrsquoitem iv) La descrizione del segno oslash per il divisore merita una discussione piugrave dettagliata In origine si trovava probabilmente scritto Π(ΑΡΑ)ΕΧΟΝ successivamente letto come π(αρ[α])έχον ndash dato che lrsquoabbreviazione per il preverbo egrave identica a quella per la preposizione (che sia Π᾽ o un pi seguito dal segno per ἄρα a sormontare) ndash invece di π(αρὰ) ἔχον I copisti e i correttori si dettero a tutte le possibili contorsioni per restituire un testo dotato di senso leggere appunto una forma verbale con preverbo modificare il preverbo (ma forse il segno per ἄρα era insidiosamente simile ad uno epsilon) correggere il testo rileggiamo lrsquoapparato sub τὸ παρὰ ἔχον οὕτως τὸ παρέχον οὕτως M et π(αρ-) comp Z οὕτως τὸ περιέχον S τὸ περιέχον οὕτως C προγράφοντας οὕτως ex corr m 2 P Nella clausola descrittiva seguente la presenza liminare di παρὰ (che ho corretto in παρ᾿ ἃ nella speranza di restituire una frase che abbia un senso senza intervenire sul testo) innesca un bel corto circuito il Π(ΑΡΑ) che sicuramente figu-rava nellrsquoarchetipo egrave un sintagma complesso una preposizione unrsquoab-breviazione o un segno per unrsquoabbreviazione Se lrsquoeditore si trova in conflitto con la propria inclinazione alla critica conservativa i copisti si rifiutarono di mettere mano ad un testo che doveva stridere anche per loro essendo il compito demandato al ritocco del revisore del Par gr 2390 o alla riscrittura radicale del recensore bizantino Il problema egrave che ci troviamo di fronte ad unrsquoespressione che descrive la funzione dellrsquooggetto denotato non lrsquooggetto stesso ma che lo contiene al suo interno per soprammercato qui il Π(ΑΡΑ) egrave usato per giustificare una menzione a sua volta relatum di un segno
Evidentemente questa maniera di procedere che giagrave aveva attirato interventi da parte di copisti e correttori della recensione di base parve insostenibilmente opaca allrsquoautore della recensione bizantina61 Egli
61 Uno dei manoscritti di questa recensione propone anche una tabella di divisione
Fabio Acerbi148
modifica tutte le descrizioni diluendo lrsquoidiomatismo dellrsquoarticolo lsquocita-zionalersquo con lrsquointroduzione sistematica del verbo δηλόω e di frasi atte a chiarire quale sia il segno denotante e quale il vocabolo (o il segno) denotato Egli introduce allo scopo di rendere esplicita la funzione de-notativa dei segni introdotti il termine σημείου curiosamente in tutte le sue tre occorrenze esso compare a sua volta nella forma dellrsquoabbrevia-zione per sospensione σΗ´ Egli traccia il segno per i massimi multipli ἀφ e quello per i resti λ οι` in modo che non vi siano ambiguitagrave quanto al loro carattere di abbreviazione Si faccia infine attenzione al residuo di barra sul παρᾱ con funzione denotativa (2 occorrenze) contenuto nella descrizione del segno per il divisore sostituita dallrsquoaccento grave nel παρὰ con funzione discorsiva (la differenza egrave nettissima nei manoscritti da me consultati) Questa osservazione ci permette di passare direttamente allrsquoitem seguente
b) Le barre sui numerali e sulle lettere denotative Egrave opportuno discutere questo punto adesso esattamente percheacute di barre siffatte che pure troviamo in tutti i manoscritti i nostri testi non fanno mai menzione si tratta infatti di una pratica condivisa sin dallrsquoantichitagrave La barra identifica una stringa di lettere dellrsquoalfabeto che non svolge una funzione grammaticale o sintattica propria allrsquointerno del discorso Ciograve avviene in particolare e si tratta della fattispecie piugrave frequente se la stringa di lettere non dagrave origine a un vocabolo della lingua greca lette-re denotative e numerali certo ma anche termini provenienti da altri idiomi e contrazioni di parole greche come i nomina sacra62 tali termi-ni possono essere o no preceduti da un articolo lsquocitazionalersquo a seconda dellrsquouso che ne viene fatto allrsquointerno del discorso Ma non si tratta dellrsquounica fattispecie i papiri grammaticali ed i manoscritti piugrave antichi dei trattati dello stesso argomento segnalano gli esempi delle parti del discorso (cioegrave di lsquoverersquo parole greche) per mezzo di barre sormontanti63 La differenza insomma egrave tra menzione e uso (come parte del discorso in atto) di una stringa di caratteri tra il porre le lsquovirgolettersquo e il non porle tra funzione denotativa e non Apparentemente la convenzione si limi-
corredata dei segni opportuni e contrariamente alle indicazioni della descrizione svilup-pata lsquoin verticalersquo ma per motivi misteriosi non completa (tav 7a Laur Plut 89 sup 48 f 13r)
62 Tutto ciograve egrave spiegato con estrema chiarezza giagrave in Traube 1907 pp 45-4763 Si veda il Par gr 2548 codex vetustissimus e testimone unico delle lsquoopere minorirsquo
di Apollonio Discolo il f 106v con le barre ben visibili egrave riprodotto come tav 19 in De Gregorio 2000 (ivi pp 137-138 per la datazione) Per la testimonianza dei papiri grammaticali si veda Wouters 1979 passim essi contengono di norma elenchi di parti del discorso nessuna delle quali egrave preceduta dallrsquoarticolo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 149
tava in questo secondo caso a segnalare con la barra singoli vocaboli le menzioni di frasi o di sintagmi complessi sono di norma identificate dallrsquoarticolo lsquocitazionalersquo Drsquoaltra parte le abbreviazioni convenzionali non rientrano nella casistica percheacute la loro resa grafica che contiene elementi non alfabetici come compendi per desinenze lettere supra li-neam marche di contrazione o sospensione quali slashes o barre sotto-poste o sormontanti eventualmente solo un sottinsieme della stringa di segni alfabetici le esclude automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
Venendo al discorso matematico una barra sormonta senza ecce-zione le lettere denotative64 che sia in papiri o in manoscritti in maiu-scola65 o minuscola ma solo allrsquointerno del testo comrsquoegrave da attendersi nei diagrammi esse la perdono per il semplice motivo che non crsquoegrave alcun testo ambiente un diagramma ha unicamente una funzione denotati-va Drsquoaltra parte le lettere numerali che a volte figurano nei diagrammi della tradizione metrica66 allo scopo di indicare la lunghezza dei seg-menti mantengono la barra in un diagramma il contesto denotativo geometrico egrave prevalente e i numerali vengono percepiti come entitagrave grafiche lsquoesternersquo al discorso Va da seacute a fortiori che le lettere numerali inserite in un testo dovranno essere segnalate da barre che a loro volta non servono nelle tavole67 in quanto queste ultime sono come abbiamo visto un vero e proprio testo che perograve funge da ambiente a quello al-fabetico limitato alle titolazioni e non a caso tracciato in unrsquoopportuna lsquomaiuscola distintivarsquo allo scopo di segnalarne il carattere denotativo e non discorsivo68 Una tabella operazionale egrave invece un paratesto e quindi le barre sulle lettere numerali che rappresentano gli interi sono
64 La notazione per le lettere denotative subigrave unrsquoevoluzione (il cui risultato finale egrave descritto per sommi capi nella nota 3 supra) di cui non mette conto occuparsi qui
65 I papiri di contenuto geometrico (o astronomici ma che presentano argomenti geometrici) sono rari si vedano il PHerc 1061 (sec II aC Demetrio Lacone De geome-tria) e il PFay 9 (sec II ex Elementi I 39 e 41) Gli importanti ostraka OBerl 12002 e 12609 (sec III aC m Elementi XIII) non pongono le barre sopra le lettere denotative Per i manoscritti in maiuscola si veda ad esempio passim nel Par gr 2389 una cui riproduzione digitale egrave consultabile in rete allrsquoindirizzo httpgallicabnffrark12148btv1b8470171d o il fragmentum mathematicum Bobiense
66 Si veda ancora il ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 codex unicus dei Metrica di Erone e contenente una raccolta importante di problemi del corpus metrologico
67 Si vedano come esempio le tavole citate alle note 10 e 14 supra Discorso a parte per il segno di lsquoposto vuotorsquo si veda il punto c che segue
68 Queste regole generali vanno prese cum grano salis si dagrave naturalmente un certo dominio di variabilitagrave legato verosimilmente al grado di cultura grafica del copista nel PMich III 144 i numerali sono quasi tutti senza barra sia nel testo che nelle tabelle ope-razionali
Fabio Acerbi150
necessarie esse mancano invece sui segni convenzionali che ho descrit-to nel punto precedente e fatto rilevante sulle lettere numerali relative agli ordini sessagesimali quando esse siano identificate da uno o piugrave apici la presenza di questo segno grafico non alfabetico69 le esclude ancora una volta automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo Unrsquoultima osservazione che ci saragrave utile nel seacuteguito la descrizio-ne di una stringa di lettere lsquoagrammaticalersquo non puograve prevedere la men-zione della presenza della barra che le pertiene in quanto tale si tratta di una pratica denotativa che egrave possibile formulare soltanto ad un livello di discorso superiore sia a quello dellrsquouso che a quello della menzione70
c) Il segno di lsquoposto vuotorsquo Si noti nella tav 2b la forma ŏ per il segno di lsquoposto vuotorsquo in un ordine sessagesimale coerentemente con la propria notazione il copista del Marc gr 313 lo scioglie talvolta allrsquoin-terno del testo principale come unrsquoabbreviazione per οὐδέν laquonienteraquo Altre convenzioni di scrittura del tratto che accompagna il circoletto e che si badi bene fa parte integrante del segno di lsquoposto vuotorsquo ndash e infatti nelle tavole troviamo sempre il segno completo mentre tutti gli altri numerali sono come abbiamo visto nel punto precedente privi di barra o di apice a causa del fatto che i vari ordini sessagesimali sono univocamente determinati dalle linee di giustificazione ndash un tratto an-golare anteposto (tav 3 Lar Plut 2818 f 136v)71 o una semplice barra a sormontare (tavv 4-9) si produce in questo modo il segno 65926 che sembra essere stata la forma di base72
69 Occorre dunque supporre come testimoniano papiri e manoscritti in maiuscola che la convenzione relativa allrsquouso della barra si sia consolidata ben prima dellrsquointroduzione di segni diacritici quali accenti e spiriti
70 Si veda il punto 2 infra per maggiori dettagli sulla questione delle barre e degli apici e per le indicazioni in merito che leggiamo in Diofanto
71 Come accennato questa tavola dei sottomultipli coincide con quella descritta ed esposta nei Prolegomena Fatto molto rilevante i numerali nella prima non recano neacute barre neacute apici contrariamente a quanto accade a tutte le istanze della seconda nei manoscritti Quella del Laur Plut 2818 preserva a mio avviso la forma originaria come abbiamo visto una tavola non richiede segni aggiuntivi sulle lettere numerali
72 Si vedano come esempio ancora le tavole citate alle note 10 e 14 supra oppure per una rassegna delle forme che il segno assume nei manoscritti piugrave antichi delle Tavole facili Tihon 2011 pp 58-59 e per quelle che assume nei papiri Jones 1999 I pp 61-62 Ovviamente non possiamo leggere il segno 65926 come un omicron con una barra in quanto ο = 70 nella notazione greca e la barra egrave di rigore quando il numerale figuri allrsquointerno di un testo Occorre ammettere che si dagrave origine ad un bel corto circuito notazionale con il concepire un segno con funzione di lsquoposto vuotorsquo ma che lsquosomigliarsquo ad una lettera dellrsquoalfabeto sormontata da una barra cioegrave ad un numerale in piugrave quando il lsquoposto vuotorsquo non corrisponda ad un intero ma ad una specie sessagesimale la presenza della barra a priori indistinguibile da quella che sormonta gli interi introduce unrsquoincongruenza con la notazione a mezzo di apici vista nellrsquoitem precedente
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 151
d) Errori di copia La tabella riprodotta nella tav 2b ha una forma simmetrica ma si tratta di una forzatura il grande rettangolo in basso a destra drsquoaltronde assente nella descrizione contiene uno scolio che fa notare come lrsquoultimo resto parziale ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ͵γτνζ´´´´´ κζ´´´´´´ cioegrave 0 0 0 0 0 3357 27 siano ἔγγιστα λ´λ´ δ´δ´ ξ laquocon ottima approssimazione 60 minuti quartiraquo dove si notino gli apici semplici per indicare il pas-saggio allrsquoordinale e il raddoppiamento del sistema segno + apice per significare il plurale Lo scolio debitamente accompagnato dal segno di rimando in forma di simbolo solare egrave stato probabilmente incluso nella tabella proprio allo scopo di renderla simmetrica A sua volta un errore precedente spiega lo spazio eccessivo accordato al rettangolo contenente lo scolio il secondo massimo multiplo ŏ λβ´ ξδ´´ ριβ´´´ σιϛ´´´´ egrave trascritto anche al di sotto del risultato
Passiamo ora alla descrizione del metodo di divisione attribuito a Pappo
ἵνα οὖν ταῦτα συναχθῇ τὰ ἐκ τοῦ μερισμοῦ ὁ εἰρημένος Πάππος εὐδιατύπῳ τινὶ καὶ πρὸς τοῦτο τάξει χρησάμενος ποιεῖται τὴν τῆς συλλήψεως τοῦ ζητουμένου ἀνεύρεσιν οὕτως ἐκθέμενος γὰρ τὸν μέλλοντα μερίζεσθαι τουτέστι τὰς τξ μοίρας ἐν ἀρχῇ ἀφαιρεῖ ἀπ᾽ αὐτῶν τὸν ἐν τῇ σελίδι τυγχάνοντα ἐλάττονα τουτέστι τὸν τδ κβ´ κ´´ ὄντα τῶν ἐγγὺς ἐλασσόνων ὡς πρὸς τοὺς ἐκκειμένους διὸ καὶ γράφει αὐτὸν προγράφων αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε καὶ εὑρίσκων τὰ παρακείμενα αὐτῷ τῷ ἀπογραφέντι ἐν τῷ σελιδίῳ λεπτὰ πρῶτα ν´ συναπογράφεται παρατιθῶν αὐτοῖς τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον ἀνατείνουσαν σημαῖνον τὸ εἶδος ὅτι πρῶτα λεπτά εὑρίσκει οὖν οὕτως τὸ τῶν τξ μέρος τὸ τδ κβ´ κ´´ ὃ μεριζόμενον παρὰ τὰς τξε ιδ´ μη´´ ἡμέρας καὶ ποιοῦν τὸν ἐκ τοῦ μερισμοῦ ἀριθμὸν πρῶτα λεπτὰ ν´ καὶ τὸν λοιπὸν ἀπογραφόμενος τὸν νε λζ´ μ´´ προτάσσει αὐτοῦ τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά τάσσει δὲ καὶ ἁπλῆν τινα διατείνουσαν γραμμὴν ὡς ἀπὸ τοῦ τξ ἐπὶ τὸν ἑξῆς ἐκτεθειμένον ἐγγὺς
1
5
10
1 εὐδιατύπῳ] ZSPC εὐδιατύπωτ M 4 ἀφαιρεῖ] MZSP ἀφ ι C 5 ἐλάττονα] P comp MZSC 6 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | αφ ] αφ ε M ἀφ ZS ἀφαί P ἄφ C | ἀντὶ] om C | ἄφελε] MZSP ἄφ C 8 ἀπογραφέντι] MZSP ἐγγραφέντι C | λεπτὰ πρῶτα] P λε πρωτα SC λεπτῶν πρωτ MZ | παρατιθῶν] MZS παρατιθεὶς C et ex corr m 2 P 9 ᾱ] Z αο P α´ MS α C | ἔχον] MPC ἔχων ZS 9-10 πρῶτα λεπτά] ZP πρωτ λ´λ´ M πρωτα λε S αα λε C 11 ἡμέρας] comp codd | ἀριθμὸν] P et comp MZ καὶ C et comp S 12 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M πρωτ λεπτ(α) Z πρωτ λ εᾱ S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C | ἀπογραφόμενος] MZSP ἐγγραφόμενος C | νε λζ´] MZSP λζ νζ C 13 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | λ οι] MZSC ex λ fecit λ οι P | προσσημαῖνον] MC et προσ- comp ZS προση- P | τὸ] MZC τὰ S et fecit m 2 P 14 ἀπὸ] MZSP πρὸς C ἐλάττονα] P comp MZSC
1 εὐδιατύπῳ] εὐδιατυπώτω K 6-7 αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ] τὸ ἀφ K 8 παρατιθῶν mdash 10 λεπτά] τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ σημαίνουσαν τὸ εἶδος αὐτῶν ὅτι ᾱ λεπτά εἰσιν K | τὸ (sec)] τὰ K 12 πρῶτα] πρώτων K | τε λ ] λ οι` K | προσσημαῖνον mdash
Fabio Acerbi152
ἐλάττονα τὸν τδ κβ´ κ´´ ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις καὶ ταύτην ἐπιδεικνύουσαν τὴν τάξιν τῆς προόδου τῆς ἐκθέσεως ἧστινος κλωμένης γραμμῆς πρὸς τῷ ἐγγὺς ἐλάσσονι ἡ ἀντανάκλασις ἐπὶ τὸν λοιπὸν γέγραπται φερομένη ὡς εἴρηται διὰ τὸ εὔτακτον τῆς προκοπῆς οὕτως τε ποιήσας ἑξῆς τὸ αφ ποιῶν ὃ προσσημαίνει ὡς εἴρηται τὸ ὅτι δεῖ ἀφελεῖν ὁμοίως ἀπὸ τοῦ λοιποῦ καὶ δὴ τὸν ἐγγὺς πάλιν ἐλάσσονα ὡς πρὸς τὴν ἐν τῷ σελιδίῳ ἔκθεσιν εὑρισκόμενον λαμβάνων ἑξῆς προγράφει αὐτὸν ὄντα νδ μζ´ ιγ´´ ιβ´´´ καὶ εὑρίσκει αὐτοῖς παρακείμενα ἐν τῷ σελιδίῳ πρῶτα λεπτὰ θ´ ἅτινα καὶ αὐτὰ προσαπογράφεται σὺν τῇ παρασημειώσει τῶν πρώτων γράφων τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον τὴν ἀνατείνουσαν καὶ ὡς εἴρηται τὴν γραμμὴν πάλιν διὰ τὴν τάξιν κλωμένην κατὰ δευτέραν κλάσιν προσέλκει γινομένου τοῦ μέρους αὐτῆς τούτου παραλλήλου τῷ ἐξ ἀρχῆς
16 ante κλωμένης add ἐπὶ C 18 τε] MZP om SC | αφ ] M ἀφ ZSC ἀφαί P 19 προσσημαίνει] MS προση- ZC et ex corr P | ὅτι] ZP comp MSC 20 δὴ] MZSC διὰ fecit m 2 P 21 πρὸς] MSP et supra lineam C ex ἀπὸ fecit m 2 Z | ιγ´´] MZSP νγ´´ C 22 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M ᾱᾱ λεπτὰ Z άάα λε S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C 23 προσαπο- γράφεται] απο suprascr in comp M 24 ᾱ] ZP α´ MS α C 25 κλάσιν] MP τάξιν ZSC | τοῦ] ZSPC τούτου M 26 τούτου] τοῦ bis ZSPC sed prius erasit m 2 P τοῦ M
mdash 18 προκοπῆς] om K | τε ποιήσας] ποιήσας καὶ K | αφ ] ἀφ K 19 τὸ] om K 21 προ-γράφει] γράφει K 22 σελιδίῳ] α´ σελιδίῳ K | ἅτινα] ἃ K 23 προσαπογράφεται] ἀπογράφεται K | τῶν πρώτων mdash 26 ἐξ ἀρχῆς] om K
lsquoAllo scopo di raccogliere ciograve che risulta dalla divisione il detto Pappo utilizzando anche in questo caso una certa disposizione ben strutturata determina nel modo seguente il lsaquonumerorsaquo cercato preso nel suo insieme collocando73 in testa il lsaquonumerorsaquo che sta per essere diviso cioegrave i 360 gradi iniziali sottrae loro tra i piugrave prossimi dei lsaquonumerirsaquo minori rispetto a quelli esposti quello che si trova essere minore nella colonna (cioegrave 304 22 20) Questo egrave il motivo per cui lo trascrive scrivendogli davanti lrsquoabbreviazio-ne laquosottrraquo per laquosottrairaquo e trovando che 50 minuti primi sono collocati accanto a quello stesso lsaquonumerorsaquo che egrave stato trascritto nella colonna li trascrive al tempo stesso collocando accanto74 ad essi la lettera A con un lsaquotrattorsaquo75 sopra che significa la specie minuti primi Trova dunque in que-sto modo la parte di 360 che egrave 304 22 20 la quale divisa per 365 giorni 14 48 fa il numero lsaquoche risultarsaquo dalla divisione 50 minuti primi Trascrivendo
73 La descrizione egrave strutturata come una procedura Acerbi 201274 Il purismo del correttore del Par gr 2390 di Clostomalle nel Marc gr 314 e
dellrsquoautore della recensione bizantina impone loro di modificare la terminazione ma forme tematiche e contratte di τιθεῖν sono correnti nel greco tardivo
75 Il testo greco ha solo il participio con γραμμήν sottinteso Per il significato del participio si veda il punto 2
15
20
25
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 153
poi il resto 55 37 40 gli pone altresigrave76 a prefisso laquoReraquo che significa laquorestiraquo e dispone anche una certa linea semplice77 che va da 360 al piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori che egrave esposto di seacuteguito 304 22 20 come nello lsaquoschemarsaquo esposto linea che mostra lrsquoordine del percorso dellrsquoesposizione Questa linea spezzata lagrave dove si trova il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori egrave tracciata inflessa allrsquoindietro lsaquoersaquo punta verso il resto come egrave stato detto in vista di una progressione ordinata E cosigrave facendo prendendo di seacuteguito il laquosottrraquo che significa come egrave stato detto laquoche occorre similmente sottrarre dal re-storaquo e ovviamente prendendo di nuovo il lsaquonumerorsaquo che egrave trovato essere il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori in relazione alla disposizione nella colonna ndash 54 47 13 12 ndash lo scrive di seacuteguito e trova che 9 minuti primi sono posti loro accanto nella colonna trascrive78 anche questi con la segnaletica dei primi scrivendo la lettera A con un lsaquotrattorsaquo sopra e come egrave stato detto prolunga di nuovo la linea spezzata in vista di una buona disposizione tramite una seconda inflessione essendo questa sua parte parallela a quella inizialersquo
La descrizione continua con una serie di laquoe cosigrave viaraquo e non fa ulte-riore riferimento alla tabella
1) La forma verbale ἐξεσμένον Egrave il neutro del participio perfetto medio-passivo di ξέω lett laquopialloraquo laquolevigoraquo Si danno tre possibilitagrave si tratta di un termine canonico per quanto non altrove attestato per designare unrsquoabbreviazione oppure lrsquoautore anonimo improvvisa sul piano metaforico come se unrsquoabbreviazione non fosse altro che la paro-la completa lsquoaccorciata a colpi di piallarsquo in maniera opportuna oppure il testo egrave corrotto e srsquoimpone una correzione ad esempio τὸ ἑξῆς μένον laquociograve che sta di seacuteguitoraquo Questrsquoultima strada mi pare chiusa dal senso delle frase lrsquoabbreviazione non lsquosta di seacuteguitorsquo a niente ma anzi precede la perifrasi τὸ ἑξῆς μένον se impiegata semplicemente per rimandare al segno αφ immediatamente seguente costituirebbe un intollerabile solecismo Se accettiamo la prima di queste letture considerando quin-di lrsquoabbreviazione αφ in posizione predicativa abbiamo a che fare con
76 Rendo in questo modo il τε isolato77 La linea egrave laquosempliceraquo in quanto egrave una retta la precisazione intende evidenziare per
anticipazione il carattere lsquonon semplicersquo che essa assumeragrave alla prima inflessione quando diventeragrave una spezzata linee siffatte erano in effetti concepite dallrsquoanonimo e prima di lui da tutta la tradizione matematica greca come una singola linea spezzata nei punti drsquoinfles-sione I due segmenti paralleli menzionati al termine del passo sono orizzontali
78 Il verbo egrave al medio in variatio rispetto ai due che precedono e che seguono egrave il matematico che lsquosirsquo trascrive le cifre
Fabio Acerbi154
uno hapax semantico nella grecitagrave superstite come egrave facile verificare con una ricerca sul TLG in rete La recensione bizantina risolve il pro-blema sopprimendo semplicemente τὸ ἐξεσμένον
2) La notazione per le specie numeriche Nella terminologia matema-tica greca gli ordini sessagesimali sono εἴδη laquospecieraquo numerici essi corri- spondono agli ordini di grandezza nel nostro sistema decimale e indica-no in analogia con il caso geometrico la lsquoformarsquo che assume un numero quadrato cubo ecc Centinaia e migliaia sono quindi degli εἴδη rispet-tivamente quadrati (100 egrave il quadrato di 10) e cubi (1000 egrave il cubo di 10) sono specie numeriche ma non numeri particolari e drsquoaltronde 300 non egrave un quadrato ma 3 item dellrsquoεἶδος lsquoquadratorsquo 100 3 egrave il numerale di molteplicitagrave della specie quadrata lsquocentinaiarsquo i due 0 che seguono il 3 segnalano esattamente questo fatto che la notazione greca per gli interi non posizionale fa scomparire al livello denotativo Ciograve non vale soltan-to per i numeri interi ma anche per le loro parti i minuti secondi appar-tengono alla specie lsquoquadratorsquo in quanto 13600 egrave il quadrato di 160
La concezione appare interamente dispiegata nellrsquointroduzione degli Arithmetica diofantei79 che si rivela giova farlo rimarcare un te-stimone fondamentale per la ricostruzione della notazione matematica antica Alle specie usate in questrsquoopera vengono assegnati una denomi-nazione ed un segno convenzionale costituito dallrsquoiniziale (di ognuno dei componenti) della denominazione al quadrato o δύναμις il segno ΔΥ al κύβος il segno ΚΥ alla lsquoquarta potenzarsquo o δυναμοδύναμις il segno ΔΥΔ ecc La descrizione di tali segni egrave del tipo καὶ ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον Κ ἐπίσημον ἔχον Υ ΚΥ κύβος laquoe il suo segno egrave un Κ che ha come indice un Υ ΚΥ cuboraquo dove in accordo con quanto abbiamo visto nel punto b supra e pur nel comprensibile imbarazzo del copista della prima parte del Matritensis (o di un suo passato collega) a districarsi in questo formidabile ginepraio notazionale80 le due lettere Κ e Υ ricevono una barra mentre ΚΥ non la richiede a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον il quale ancora una volta esclude automaticamente il segno dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
79 In particolare a DOO I pp 214-62180 Nel Matr 4678 riscontriamo i seguenti fenomeni nelle poche righe a cavallo dei ff
58r-v 1) accento acuto posto su tutti i segni come se fossero abbreviazioni 2) ripetizione sistematica segnodenominazione come in ΚΥ κύβος appena letto dovuta sicuramente allrsquointrusione di glosse interlineari esplicative dei segni ndash e successivo pentimento (δύναμις e κύβος sono in effetti cancellati dalla prima mano il primo con un tratto il secondo con dei punti supra lineam poi il copista si stanca di correggere) 3) nella descrizione del segno per la δυναμοδύναμις menzione di un δέλτα δύο che saragrave molto probabilmente stato ΔΔ subito dopo nella descrizione del κυβόκυβος si legge un incongruo δύο KK
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 155
Diofanto introduce poi dei segni anche per le specie delle parti dellrsquounitagrave (le nostre frazioni) che egli chiama ὁμώνυμα μορία laquoparti omonimeraquo di cui quelle sessagesimali sono casi particolari81 Egli spie-ga appunto che le loro denominazioni sono ottenute da quelle delle specie degli interi per sinonimia passando ad un lsquoordinalersquo82 formato semplicemente aggiungendo il suffisso -στον δυναμοστόν κυβοστόν δυναμοδυναμοστόν ecc (sott μόριον) I loro segni convenzionali sono invece ottenuti da quelli per le specie degli interi aggiungendo una γραμμὴν διαστέλλουσαν τὸ εἶδος laquolinea che distingue la specieraquo83 Una linea sui segni delle specie delle parti egrave richiesta si badi bene per distinguerli dai segni di quelle degli interi come giagrave osservato questi ultimi sono giagrave lsquoagrammaticalirsquo a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον a fortiori lo saranno anche i primi Si tratta della traduzione semio-tica del passaggio dal cardinale allrsquoordinale che a livello grammaticale egrave effettuato con il suffisso -στον Che forma ha questa linea Barra o apice (Egrave cervellotico pensare a forme piugrave complesse) La domanda non ammette una risposta immediata in quanto delle specie diofantee nessuno piugrave si occupa nellrsquoantichitagrave84 Se egrave vero che la prima risposta darebbe origine ad un conflitto tra due convenzioni denotative diffe-renti la barra lsquocitazionalersquo e la barra che distingue la specie lrsquoevidenza grafica del Matritensis lascia lievemente sgomenti (ricordiamoci che giagrave i segni di base sono indebitamente dotati di un accento dal copista) Le poche occorrenze del segno per le specie delle parti85 vedono lrsquoaggiunta di uno slash di sospensione di un doppio apice inverso ndash in tutta evi-
81 Questo fatto era giagrave chiaro nellrsquoantichitagrave Teone in Alm I 10 in iA p 45310-1682 Il parallelo con i cardinali e gli ordinali relativi agli interi egrave reso esplicito da Dio-
fanto ὥσπερ δὲ τῶν ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια παρομοίως καλεῖται τοῖς ἀριθμοῖς τοῦ μὲν τρία τὸ τρίτον τοῦ δὲ τέσσαρα τὸ τέταρτον οὕτως καὶ τῶν νῦν ἐπονομασθέντων ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια κληθήσεται παρομοίως τοῖς ἀριθμοῖς laquocome le parti omonime dei numeri sono chia-mate per assonanza con i numeri di lsquotrersquo lsquolsaquounrsaquo terzorsquo di lsquoquattrorsquo lsquolsaquounrsaquo quartorsquo cosigrave le parti omonime dei numeri appena nominati saranno chiamate per assonanza con i numeriraquo (DOO I p 69-13 si noti lrsquoarticolo lsquocitazionalersquo al singolare in τοῦ τρία e τοῦ τέσσαρα) Il parallelo prosegue anche al livello dei segni che rappresentano queste specie come vedremo tra un attimo
83 Diofanto Arithmetica prefazione in DOO I p 620-21 un passaggio maltrattato in questa edizione occorre espungere il participio ἔχον senza introdurre segni ulteriori oppure eliminare un precedente ἐπί come fa un correttore del Matritensis f 58v
84 Unica parzialissima eccezione lrsquoaccenno di Teone menzionato nella nota 81 supra85 Al f 59r e per di piugrave nel margine per sanare un lungo saut du mecircme au mecircme La
collocazione in margine egrave il motivo per cui troviamo una notazione abbreviata nel resto del trattato il primo copista scioglie tutti i segni prendendoli per abbreviazioni mentre il secondo elimina sistematicamente il tratto aggiuntivo delle specie delle parti dellrsquounitagrave Drsquoaltronde egli scrive ad esempio ΔΥ invece di ΔΥ ed egrave quindi indotto a porre la barra al di sopra della stringa di lettere risultante (passim ma si veda ad esempio il f 72r)
Fabio Acerbi156
denza il compendio per la desinenza -ον accentata il copista interpreta il segno come unrsquoabbreviazione ndash e di una barra a sormontare lo Υ Potremmo forse interpretarlo come il segno di contrazione del grafema -στ- lrsquounico tassello mancante in unrsquoabbreviazione come ad esempio (δυναμοδυναμο)(στ)(ὸν) ma uno scolio di prima mano al f 58v rela-tivo alle specie degli interi inficia questrsquoipotesi esse sono dotate di slash di sospensione accento acuto in un caso del compendio canonico per la terminazione -ον hellip ma tutti gli Υ a esponente sono a loro volta sormontati da una barra
Meno legata al singolo manoscritto ma nondimeno non uniforme si presenta la pratica di notazione dei segni che rappresentano gli enti numerici sessagesimali86 da una parte sta lrsquoevidenza del testo dei Pro-legomena e delle sue tabelle apici ndash drsquoaltronde come abbiamo visto la notazione universalmente impiegata per i numerali ordinali e per le fra-zioni unitarie ndash dallrsquoaltra sta lrsquoevidenza del testo dellrsquoAlmagesto in tutti i manoscritti piugrave antichi e lo stesso si dica del commentario teonino a questrsquoopera o del suo lsquoGrande commentariorsquo alle Tavole facili e dei testi astronomici su papiro barre87 Sembra insomma che la nostra docu-
86 Sia le molteplicitagrave che le specie ahimeacute entrambe rappresentate da lettere dellrsquoalfabeto Come osservato allrsquoinizio della sezione 3 ci sono in effetti due tipi di lettere numerali in gioco se facciamo astrazione da apici o barre lsquo4 minuti secondirsquo si trova scritto δ β la prima lettera numerale denota la molteplicitagrave degli item di una certa specie la se-conda la specie nei Prolegomena entrambe sono accompagnate da un doppio apice il che rende inutile la presenza delle seconde Si noti che la descrizione della tabella non fa parola della notazione da usare per le lettere numerali che denotano la molteplicitagrave barre o apici e quanti apici hellip In questo caso fa interamente fede la tabella cioegrave la pratica grafica condivisa instauratasi non egrave chiaro quando
87 I manoscritti piugrave antichi dellrsquoAlmagesto sono menzionati nella nota 10 supra quelli dei due commentarii teonini sono il Laur Plut 2818 e il celeberrimo Vat gr 190 (sec IX in Euclide Elementi Data Teone lsquoGrande commentariorsquo) per la notazione dei pa-piri astronomici si veda Jones 1999 II passim La notazione non sembra lsquoinquinatarsquo dalla pratica dei copisti bizantini e pare dipendere soltanto dalla data di composizione Tro-viamo ad esempio barre sopra tutti i numerali di molteplicitagrave (interi o sessagesimali) nel frammento di un commentario alle Tavole facili contenente un calcolo relativo al 24 aprile 213 (Par gr 2841 sec XIII ex-XIV in oltre al frammento ai ff 32r l 11-34v l 23 contiene Arato Phaenomena ed Efestione Apotelesmatica edizione in Jones 1990) Nel commentario alle Tavole facili composto ca 610-617 ed attribuito a Stefano di Alessandria la situazione egrave la seguente (Jean Lempire per litteras per lrsquoedizione si veda Lempire 2014 ho controllato il Vat gr 304 ff 135r-171v sec XIV am contiene in aggiunta Teone in Almagestum I-II lsquoPiccolo commentariorsquo alle Tavole facili Diofanto Arithmetica e De polygo-nis numeris varia astronomica tabulae) barre sopra gli interi sporadicamente rimpiazzate da apici apici sopra le parti sessagesimali in numero uguale alla denominazione doppio () apice per le frazioni unitarie Sono impiegate barre sopra gli interi e apici sopra le parti sessagesimali nei manoscritti principali di tutti i trattati di introduzione allrsquoAlmagesto o comunque di argomento logistico redatti in epoca bizantina Giorgio Pachimere (1242-ca 1310) Quadrivium (autografo nel manoscritto Roma Biblioteca Angelica gr 38 [RGK III nr 115] si veda Tannery ndash Steacutephanou 1940 per lrsquoedizione) Teodoro Metochita (1270-
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 157
mentazione si faccia testimone di un cambio notazionale avvenuto nel periodo intercorrente fra Teone (sec IV pm) e la scuola alessandrina di Ammonio e dei suoi allievi (sec VI in) e probabilmente innescato da questrsquoultimo ambiente lrsquoaspetto paradossale egrave che nello stesso codice si rintraccino due notazioni differenti per gli enti numerici sessagesimali e lrsquouna (apici) sia adottata sistematicamente e coerentemente in uno scritto (i Prolegomena) che si presenta esattamente come unrsquointroduzione tecnica alla pratica numerico-algoritmica del trattato (lrsquoAlmagesto) in cui egrave adottata lrsquoaltra (barre che ritroviamo senza eccezioni anche negli scolii)
Torniamo ai Prolegomena la descrizione del segno da porre a fianco di ogni singolo quoziente parziale e denotante la sua specie numerica (minuti primi minuti secondi ecc) solleva tre problemi
Primo problema Ci vuole una barra o un apice su τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquola lettera A [hellip] che significa la specieraquo quando lo scriviamo nella tabella Tutta la nostra discussione precedente fa pro-pendere per lrsquoapice e si ricordi anche la forma verbale ἀνατείνουσαν che suggerisce qualcosa che si lsquoestende verso lrsquoaltorsquo (la mia traduzione egrave volutamente neutra) se fosse apposta una barra la cosa dovrebbe passare
1231332) Compendium astronomicum (copia lsquoautorizzatarsquo coeva nei Vat gr 182 e 181 da parte del copista che integrograve le parti mancanti del Par gr 2389 [ff 207-210 255-270 374-375] Bianconi 2005a pp 425-427 Peacuterez Martiacuten 2008 p 436 e n 177) Teodoro Meliteniota (morto lrsquo831393) Tribiblos astronomica (autografo nel Vat gr 792 si vedano Leurquin 1991 per unrsquoanalisi del manoscritto Leurquin 1990 per lrsquoedizione) una com-pilazione anonima (per cui ho consultato il Par gr 2396 ff 87r-92v limitatamente a questi fogli manu Costantino Trivoli [RGK II nr 318 ma ovviamente questo codice non vi egrave segnalato] terzo quarto del XV secolo il resto del codice annotato da Niceforo Gregora egrave di etagrave planudea e parzialmente [ff 33v-76v] un autografo di Planude stesso contiene Teone in Almagestum I II IV Mondrain 2002 il codice va completato ndash limitatamente a stralci dei libri VIII-X XII-XIII del commentario teonino la cui parte intermedia si egrave persa ndash con 26 carte [ff 123-147] inserite nel Vat gr 1087 anchrsquoesso contenente anno-tazioni di Gregora Rome 1927 per la figura del copista dei ff 77r-86r del Par gr 2396 e dei ff appena nominati del Vat gr 1087 un anonimo collaboratore di Gregora si veda in ultimo Bianconi 2006a pp 147-151) si veda anche il calcolo effettuato da Niceforo Gre-gora (12921295-13581361) dellrsquoeclisse di sole del 16 luglio 1330 (attestata unicamente ai ff 1r-8v della miscellanea astronomica Marc gr 325 databile ca 1324-1329 in parte vergata e ovunque fittamente annotata da Gregora stesso edizione del testo in Mogenet et al 1983 annotazioni di Gregora elencate in Bianconi 2005a p 413) Unrsquoeccezione apparente il lsquoPiccolo commentariorsquo di Teone alle Tavole facili le parti sessagesimali sono segnalate da apici (ad esempio nel Vat gr 175 vergato da Giovanni Catrario e completato nel 1321-1322 sulla figura di Catrario si vedano in ultimo Bianconi 2005b pp 141-156 e 2006b) lrsquoopera egrave antica ma la sua tradizione non rimonta oltre la fine del XIII secolo a parte un frammento nel Leiden BPG 78 ff 156r-161v (minuscola del IX-X secolo) e in effetti in questo manoscritto tutti i numerali di molteplicitagrave sono sormontati da barre Unrsquoeccezione effettiva egrave il De hypotesibus planetarum nel Vat gr 1594 barre sugli interi e apici sulle parti sessagesimali
Fabio Acerbi158
sotto silenzio e la presenza dellrsquoapice la rende inutile88 Si tratta della stessa convenzione diofantea e coincide ancora con la notazione per i numerali ordinali e per le frazioni unitarie che egrave corrente nei mano- scritti matematici greci per questo motivo non percheacute la descrizione sia particolarmente perspicua nessuno dei copisti della recensione an-tica ha incertezze apici Ma questi apici si rintracciano soltanto sulle indicazioni di specie non contemplate dalla descrizione che sono ante-poste ai resti parziali a fianco dei quozienti parziali i segni di specie sono invece trasformati in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordi-nali corrispondenti del tipo πρωτ tavv 5 e 7b-8 Il recensore bizantino taglia invece la testa al toro elimina dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali elimina la seconda menzione della laquolet-tera Araquo contestualmente allrsquoazzeramento dellrsquoespediente della linea a zig-zag (si veda il punto seguente) modifica la descrizione che contiene la prima menzione in quella dellrsquoapice associato direttamente ai nume-rali di molteplicitagrave riciclando addirittura lrsquoalpha per adibirlo a desi-gnare un numero cardinale (come sorprendersi) τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ laquoponendo al di sopra di essi [scil dei 50 minuti primi] 1 solo lsaquoaccentorsaquo acutoraquo La scelta del recensore egrave assennata che rechi una barra o un apice in una tabella un alpha denota un numero non un numero drsquoordine
Secondo problema da tenere ben distinto dal precedente Cosa ci vuole sul segno α per la lettera alpha menzionata nella frase τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquolettera A [hellip] che significa la specieraquo89 Unrsquooc-chiata allrsquoapparato critico rivela una bella incertezza nei manoscritti Z scrive sempre ᾱ e in un caso lo fa anche P MS optano sempre per α´ C per α P scrive nellrsquoaltro caso αο Per quanto solo la barra sia congrua con il senso della frase in quanto la lettera alpha egrave qui menzionata (si tratta di un oggetto che compare nella tabella) e non cambia niente se essa egrave accompagnata dal suo nome di genere στοιχεῖον ad un livello grafico lrsquoincertezza fra il segno ᾱ che denota laquola lettera αraquo e il segno α´ (o lrsquoabbreviazione αο) per una forma di πρῶτος egrave per piugrave versi giustificata
88 Detto in altri termini la barra egrave uno strumento grafico non matematico e quindi la sua presenza non va segnalata mentre un apice lo egrave e la sua presenza lo deve
89 Notare che in questa frase il primo α non vuole la barra (egrave menzionato allrsquointerno di una frase che impiega convenzioni moderne) il secondo sigrave (idem ma con convenzioni antiche) ndash e nella traduzione la scelta di denotarlo con A (senza virgolette) e non con lsquoArsquo (con virgolette) egrave del tutto arbitraria ndash si noti inoltre che le necessarie precisazioni laquosenzacon virgoletteraquo mostrano che le lingue moderne palesano difficoltagrave analoghe a quelle del greco antico per quanto riguarda i livelli denotativi in ambito metadiscorsivo per non usare le due parentetiche avrei dovuto scrivere rispettivamente lsquoArsquo e lsquolsquoArsquorsquo (doppie virgolette semplici)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 159
ᾱ coincide con il numerale 1 α egrave la prima lettera dellrsquoalfabeto ed inoltre α´ egrave esattamente quello che va scritto nella tabella Potremmo dirci che il sostantivo στοιχεῖον chiude la questione la sua presenza congiunta ad un ipotetico α´ renderebbe la descrizione ridondante o inappropriata90 Ma a parte il fatto che α egrave proprio τὸ πρῶτον στοιχεῖον il segno α´ cat-tura in fondo il cuore della descrizione di uno στοιχεῖον ἔχον lsaquoγραμμὴνrsaquo ἀνατείνουσαν
Terzo problema Lrsquoautore dei Prolegomena che si arresta allrsquoesem-pio dei minuti primi non dice quanti apici occorre mettere sulle lettere numerali che identificano gli ordini superiori al primo se uno soltanto come nel caso diofanteo e delle frazioni unitarie o in numero uguale alla loro denominazione (cioegrave pari al numero denotato dal numerale stesso su cui vanno posti) come effettivamente avviene nei mano-scritti dei Prolegomena La tabella egrave quindi sottodeterminata dalla sua descrizione anzi in un certo senso prende il sopravvento su di essa la pratica di marcare i numerali di molteplicitagrave con gli apici che compe-tono allrsquoordine cui appartengono viene trasferita ai segni per gli ordini stessi per supplire ad una descrizione carente di questi ultimi E la tabella egrave sottodeterminata dalla descrizione in quanto egrave la descrizione di una tabella reale ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις laquocome nello lsaquoschemarsaquo espostoraquo leggiamo a un certo punto del testo
3) La linea a zig-zag Non possiamo che applaudire a questo geniale espediente grafico lo troviamo messo in opera solo nel Marc gr 313 Per quanto lrsquoautore non faccia parola di ciograve nel corso della sua descrizione la linea spezzata egrave intesa dover lsquosaltarersquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue Il copista del codice marciano effettua correttamente due salti nella prima delle sue tabelle (tav 4) ma inserisce un lsquodentersquo in piugrave in quella che considera corretta (tav 5) La linea a zig-zag egrave incompatibile con la presenza di linee di giustificazione nella tabella che in effetti mancano nel Marc gr 313 ciograve induce gli errori di allineamento dei primi 5 quozienti parziali di cui egrave vittima il copista Probabilmente per questo motivo in nessuno degli apografi del Vat gr 1594 la linea a zig-zag figura nella tabella inquadrata come si conviene da una (doppia) cornice esterna e le cui colonne sono appunto separate da linee verticali (tav 7b Vat gr 184 f 17v e tav 8 Par gr 2390 f 9v cui egrave sostanzialmente identica la tabella del Marc gr 314 che si trova
90 Trascuro lrsquoabbreviazione αο = πρῶτος percheacute la desinenza non egrave quella richiesta neacute nella frase (egrave richiesto πρῶτον) neacute nella tabella (πρῶτα)
Fabio Acerbi160
al f 248r ndash ma la mancanza di linee orizzontali causa un gigantesco pa-sticcio nel codice vaticano) Alla recensione bizantina che dipende per il suo testo di base dal Vat gr 1594 e quindi non trova la linea a zig-zag nella tabella non resta che sopprimere la sua descrizione ndash ma proprio per questo motivo e finalmente diventa possibile tracciare un apparato completo di linee di giustificazione (tav 9 Laur Plut 89 sup 48 f 14v) Dato che la descrizione di Teone di questo procedimento di divi-sione non fa cenno allrsquoesistenza della linea a zig-zag viene da chiedersi se essa non costituisca un espediente escogitato dallrsquoautore dei Prolegomena per vivacizzare la procedura originale di Pappo
4) Discrepanze tra descrizione e tabella Il gioco delle minime va-rianti mostra che la divisione era stata eseguita (e trasmessa) corret-tamente tutti i valori numerici sono esatti La tabella nel Marc gr 313 presenta perograve alcune discrepanze con la propria descrizione Essa omette (ma non nella versione lsquoscorrettarsquo lrsquoomissione non si riscontra neanche nel Par gr 2390) il segno per laquorestoraquo di fronte ai resti par-ziali ma aggiunge lrsquoindicazione della loro specie Essa trasforma invece come abbiamo visto le indicazioni di specie che seguono i quozienti parziali in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordinali corri-spondenti La descrizione prevede di chiudere la tabella con il risultato καὶ συνάγων ἅπαντα τὰ ἐκ τῶν μερισθέντων μερῶν λεπτὰ σημειοῦται ὑπὸ πάντας οὕτως γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoe raccogliendo tutti i minuti che provengono dalle parti divise lsaquoPapporsaquo nota sotto tutto cosigrave Ris 0 59 8 17 13 12 31raquo ma sotto la tabella tutta la tradizione ci consegna qualcosa di piugrave articolato ὁ ζητούμενος καθ᾽ ὃν μερίζεται ὁ τξε ιδ´ μη´´ π(αρὰ) τὸν τξ γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoil lsaquonumerorsaquo cercato secondo cui 365 14 48 egrave diviso per 360 risulta 0 59 8 17 13 12 31raquo frase che del resto contiene due errori lrsquoinversione del dividendo e del divisore e la confusione tra segno convenzionale (iuxta descrizione) e abbreviazione (come nella frase) nel caso di γι Oltre ad eliminare la linea a zig-zag91 la recensione bizantina sopprime dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali e modifica come abbiamo visto al punto 2 le loro descrizioni in quelle di apici associati diretta-mente ai numerali di molteplicitagrave
91 Le due righe che nella recensione di base contengono solo i resti parziali minori di 160 del divisore ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue sono in parte completate con lrsquoindicazione abbreviata ἀνάλ(υσις) laquoanalisiraquo il termine greco per questa procedura di riduzione In un sussulto di ipercorrettismo matematico tali resti parziali ridotti non sono preceduti dal segno per laquorestoraquo come nel Par gr 2390 ma da quello per laquorisultatoraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 161
Gli esempi che abbiamo discusso mostrano come i problemi di notazione pesino e non poco sullrsquoespressione discorsiva di un algorit-mo matematico lrsquoente di riferimento per lsquoformularersquo il procedimento di divisione fu considerata la tabella cioegrave un oggetto la cui costitu-zione egrave legata piugrave ad una pratica grafica che a considerazioni logico- algoritmiche non la sua descrizione che in effetti finisce per determi-nare la tabella in maniera non univoca Di questa sottodeterminazione si fa testimone la traiettoria che abbiamo cercato di seguire nelle mani di copisti e revisori il procedimento di divisione si modifica a volte in aspetti secondari a volte in punti piugrave sostanziali ndash fino a rendere neces-saria una radicale revisione della sua descrizione per renderla conforme alla tabella ndash in ogni caso mai per ragioni squisitamente matematiche92
Abstract
The article presents and discusses in detail two passages from the anonymous Prolegomena to the Almagest a VIth century primer to the elementary procedures of calculation needed in Ptolemyrsquos Almagest In the two passages we may follow the complex interplay between mathematical notation the auctor who employed and described it the tachygrapher who transcribed it in vivo copyists who reproduced it correctors who modified it Along this path misgivings and errors arise in the transmission of abbreviations and paratextual units such as diagrams tables operational schemes
Fabio AcerbiCNRS UMR8560 Centre Alexandre Koyreacute
fabacerbigmailcom
92 Sono grato a Daniele Bianconi Lucio del Corso Jean Lempire per alcune preziose indicazioni
AOO = Archimedis opera omnia cum commentariis Eutocii ed J L Heiberg I-III Lipsiae 1910-1915
DOO = Diophanti Alexandrini opera omnia cum Graecis commentariis ed P Tannery I-II Lipsiae 1893-1895
GC = Le laquoGrand Commentaireraquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Mogenet ndash A Tihon I-III Cittagrave del Vaticano 1985-1999
iA = Commentaires de Pappus et de Theacuteon drsquoAlexandrie sur lrsquoAlmageste ed A Rome I-III con paginazione continua Cittagrave del Vaticano 1931-1943
HOO = Heronis Alexandrini opera quae supersunt omnia ed G Schmidt ndash L Nix ndash W Schmidt ndash H Schoene ndash J L Heiberg I-V Lipsiae 1899-1914
PC = Le ldquoPetit Commentairerdquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed A Tihon Cittagrave del Vaticano 1978
POO = Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia ed J L Heiberg I-II in 3 parti Lipsiae 1898-1907
RGK = Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600 I Handschriften aus Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln II Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs und Nachtraumlge zu den Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln III Handschriften aus Bibliotheken Roms mit dem Vatikan A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg unter Mitarbeit von D Harlfinger und P Eleuteri B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln Wien 1981-1997 (Oumlsterreichische Akademie der Wissenschaften Veroumlffentlichungen der Kommission fuumlr Byzantinistik III1-3 A-C)
Sigla
Acerbi 2010 = F Acerbi Il silenzio delle sirene La matematica greca antica Roma 2010
Acerbi 2012 = F Acerbi I codici stilistici della matematica greca dimostrazioni procedure algoritmi laquoQUCCraquo 1012 (2012) pp 167-214
Acerbi et al 2010 = F Acerbi ndash N Vinel ndash B Vitrac Les Proleacutegomegravenes agrave lrsquoAlmageste Une eacutedition agrave partir des manuscrits les plus anciens Introduction geacuteneacuterale ndash Parties I-III laquoSCIAMVSraquo 11 (2010) pp 53-210
Agati 1992 = M L Agati La minuscola laquoBouleteacuteeraquo Cittagrave del Vaticano 1992
Belger 1881 = C Belger Ein neues Fragmentum mathematicum Bobiense laquoHermesraquo 16 (1881) pp 261-284
Bianconi 2005a = D Bianconi La biblioteca di Cora tra Massimo Planude e Niceforo Gregora Una questione di mani laquoSampTraquo 3 (2005) pp 391-438
Bianconi 2005b = D Bianconi Tessalonica nellrsquoetagrave dei Paleologi Le pratiche intellettuali nel riflesso della cultura scritta Paris 2005
Bianconi 2006a = D Bianconi Le pietre e il ponte ovvero identificazioni di mani e storia della cultura laquoBizantinisticaraquo 8 (2006) pp 135-181
Bianconi 2006b = D Bianconi Qualcosa di nuovo su Giovanni Catrario laquoMEGraquo 6 (2006) pp 69-91
Cavallo 1977 = G Cavallo Funzione e strutture della maiuscola greca tra i secoli VIII-XI in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Colloque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 95-137
Cereteli 1904 = G F Cereteli De compendiis scripturae codicum Graecorum praecipue Petropolitanorum et Mosquensium anni nota instructorum Sankt-Petersburg 1904
De Gregorio 2000 = G De Gregorio Materiali vecchi e nuovi per uno studio della minu-scola greca fra VII e IX secolo in G Prato (a cura di) I manoscritti greci tra riflessione e dibattito Atti del V Colloquio Internazionale di Paleografia Greca Cremona 4-10 ottobre 1998 Firenze 2000 pp 83-151
Follieri 1977 = E Follieri La minuscola libraria dei secoli IX e X in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Col-loque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 139-165
Fonkič 2005 = B Fonkič Venecianskaia rukopisrsquo laquoAlrsquomagestaraquo Ptolemeja (Marc gr 313690) o datirovke i proischoždenii kodeksa laquoVDIraquo s III 254 (2005) pp 162-167
Fowler 1999 = D H Fowler The Mathematics of Platorsquos Academy A New Reconstruction Second Edition Oxford 1999
Bibliografia
Fabio Acerbi164
Gerstinger ndash Vogel 1932 = H Gerstinger ndash K Vogel Eine stereometrische Aufgaben-sammlung im Papyrus Graecus [sic] Vindobonensis 19996 laquoMitteilungen aus der Papy-russammlung der Nationalbibliothek in Wienraquo Neue Serie Folge 1 Griechische literarische Papyri 1 Wien 1932 pp 11-76
Heiberg 1927 = Mathematici Graeci Minores ed J L Heiberg Kjoslashbenhavn 1927
Hultsch 1876-1878 = Pappi Alexandrini Collectionis quae supersunt ed F Hultsch I-III Berlin 1876-1878
Janz 2003 = T Janz The Scribes and the Date of the Vat gr 1291 in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae X Cittagrave del Vaticano 2003 pp 159-180
Jones 1990 = Ptolemyrsquos First Commentator ed A Jones Philadelphia 1990
Jones 1999 = Astronomical Papyri from Oxyrhynchus ed A Jones I-II Philadelphia 1999
Jones 2005 = A Jones Ptolemyrsquos Canobic Inscription and Heliodorusrsquo Observation Reports laquoSCIAMVSraquo 6 (2005) pp 53-97
Lempire 2014 = Steacutephanos drsquoAlexandrie Le commentaire aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Lempire Louvain 2014
Leurquin 1990 = Theacuteodore Meacuteliteacuteniote Tribiblos astronomique Livre I ed R Leurquin Amsterdam 1990
Leurquin 1991 = R Leurquin Un manuscrit autographe de la Tribiblos Astronomique de Theacuteodore Meacuteliteacuteniote le Vaticanus graecus 792 laquoScriptoriumraquo 45 (1991) pp 145-162
Maas 1927 = P Maas Griechische Palaeographie in A Gercke ndash E Norden (hrsg von) Einleitung in die Altertumswissenschaft I9 Leipzig 1927 pp 69-80
Martinelli Tempesta 2010 = S Martinelli Tempesta Il codice Milano Biblioteca Am-brosiana B 75 sup (gr 104) e lrsquoevoluzione della scrittura di Giovanni Scutariota in A B Garciacutea ndash I Peacuterez Martiacuten (ed by) The Legacy of Bernard de Montfaucon Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting Proceedings of the Seventh Inter-national Colloquium of Greek Palaeography Madrid-Salamanca 15-20 September 2008 Turnhout 2010 pp 171-186
Mazzucchi 1994 = C M Mazzucchi Leggere i classici durante la catastrofe (Costantino-poli maggio-agosto 1203) le note marginali al Diodoro Siculo Vaticano gr 130 Parte prima stratigrafia laquoAevumraquo 68 (1994) pp 164-218
Mioni 1976 = E Mioni Bessarione scriba e alcuni suoi collaboratori in Miscellanea marcia-na di studi bessarionei Padova 1976 pp 263-323
Mioni 1985 = Codices graeci manuscripti Bibliothecae Divi Marci Venetiarum II Thesaurus Antiquus Codices 300-625 recensuit E Mioni Roma 1985
Mogenet 1962 = J Mogenet Une scholie ineacutedite du Vat gr 1594 sur les rapports entre lrsquoastronomie arabe et Byzance laquoOsirisraquo 14 (1962) pp 198-221
Mogenet et al 1983 = Niceacutephore Greacutegoras Calcul de lrsquoeacuteclipse de soleil du 16 juillet 1330 ed J Mogenet ndash A Tihon ndash R Royez ndash A Berg Amsterdam 1983
Mondrain 2002 = B Mondrain Maxime Planude Niceacutephore Greacutegoras et Ptoleacutemeacutee laquoPa-laeoslavicaraquo 10 (2002) pp 312-322
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 165
Mondrain 2004 = B Mondrain Lrsquoancien empereur Jean VI Cantacuzegravene et ses copistes in A Rigo (a cura di) Gregorio Palamas e oltre Studi e documenti sulle controversie teologiche del XIV secolo bizantino Firenze 2004 pp 249-296
Mondrain 2007 = B Mondrain Les eacutecritures dans les manuscrits byzantins du XIV e siegravecle Quelques probleacutematiques laquoRSBNraquo n s 44 (2007) pp 157-196
Peacuterez Martiacuten 2006 = I Peacuterez Martiacuten Maxime Planude et le Diophantus Matritensis (Madrid Biblioteca Nacional ms 4678) un paradigme de la reacutecupeacuteration des textes anciens dans la ldquorenaissance paleacuteologuerdquo laquoByzantionraquo 76 (2006) pp 433-462
Peacuterez Martiacuten 2008 = I Peacuterez Martiacuten El lsquoestilo Hodegosrsquo y su proyeccioacuten en las escrituras constantinopolitanas laquoSampTraquo 6 (2008) pp 389-458
Perria 1991 = L Perria Scrittura e ornamentazione nei codici della laquocollezione filosoficaraquo laquoRSBNraquo n s 28 (1991) pp 45-111
Rollo 2012 = A Rollo LrsquoArchimede di Giorgio Valla in V Fera ndash D Gionta ndash A Rollo (a cura di) Archimede e le sue fortune Atti del Convegno di Siracusa-Messina 24-26 giugno 2008 Messina 2012 pp 99-147
Rome 1927 = A Rome Membra disjecta laquoRBenraquo 39 (1927) pp 187-188
Rome 1938 = A Rome Un manuscrit de la bibliothegraveque de Boniface VIII agrave la Meacutediceacuteenne de Florence laquoACraquo 7 (1938) pp 261-268
Ronconi 2013 = F Ronconi La collection philosophique un fantocircme historique laquoScripto-riumraquo 67 (2013) pp 119-140
Tannery ndash Steacutephanou 1940 = Quadrivium de Georges Pachymegravere ed P Tannery ndash E Steacutephanou Cittagrave del Vaticano 1940
Tihon 2011 = Πτολεμαίου Πρόχειροι Κανόνες Les Tables faciles de Ptoleacutemeacutee vol Ia Tables A1-A2 ed A Tihon Leuven 2011
Traube 1907 = L Traube Nomina Sacra Versuch einer Geschichte der christlichen Kuumlrzung Muumlnchen 1907
Vogel 1936 = K Vogel Beitraumlge zur griechischen Logistik laquoSBAWraquo Mathematisch-natur-wissenschaftliche Abteilung Jahrgang 1936 pp 357-472
Wouters 1979 = A Wouters The Grammatical Papyri from Graeco-Roman Egypt Contri-butions to the Study of the lsquoArs Grammaticarsquo in Antiquity Brussel 1979
F ACERBI Tav 1
b Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 65r
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 284 f 160r
F ACERBITav 2
b Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 13r
a Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 19v
F ACERBI Tav 3
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 136v
F ACERBITav 4
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17r
F ACERBI Tav 5
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17v
F ACERBITav 6
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 7v
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 145
caso lo slash di troncamento taglia orizzontalmente il tratto verticale del phi I copisti offrono molteplici varianti apponendo chi uno spirito dolce chi un ε chi un αί accentato a sormontare Tutti questi segni svolgono la funzione di abbreviazioni vere e proprie (e cosigrave doveva essere anche per lrsquoautore si veda il punto 1 di p 153 infra) la forma originale si ottiene a mio avviso incrociando i dati del Marc gr 313 e dei tre apografi del Vat gr 1594 αφ anche se lrsquoassenza dello spirito potrebbe essere semplicemente dovuta alla pratica del copista del codice veneziano di economizzare nei diacritici
iv Segno per i resti Un lambda completato da una barra a sormon-tare o da un apice che rinvia alle abbreviazioni per sospensione di una forma opportuna di λοιπός laquorestoraquo In realtagrave la forma che troviamo nella tabella egrave differente (tav 2b) e coincide con quella offerta quasi unanimemente dai manoscritti nella descrizione e in almeno un caso nella tabella del metodo di divisione attribuito a Pappo (tav 4) un lambda che accoglie al di sotto una legatura omicron-iota () sbarrata da uno slash di troncamento Qualcosa di simile si trova nel PVindob G 19996 (sec I) una specie di lambda maiuscolo molto aperto e dal vertice arrotondato che include un circoletto interpretato dagli editori come segno per περίεστιν o per λοιπόν59 Lo stesso segno si rintraccia ad esempio in un medesimo scolio tabellare di prima mano ad Alma-gestum nel Vat gr 1594 f 93v e nel Marc gr 313 f 135r ma stavolta la forma del lambda egrave molto ben definita
Fin qui i segni Ma il gioco egrave piugrave complesso La descrizione si muo-ve pericolosamente sulla linea di confine non sempre ben definita tra segno convenzionale e abbreviazione il primo ndash e il repertorio grafico matematico-astronomico ne egrave particolarmente fornito60 ndash puograve anche
59 Ho consultato lrsquoedizione Gerstinger ndash Vogel 1932 pp 46 e 48 la porzione rilevante del papiro egrave riprodotta nella tav 11 di Fowler 1999 Si veda ancora ivi pp 253-257 per la trascrizione di questo segmento di testo (con correzioni rispetto alla princeps) e per una messa a punto recente inclusa la proposta di datazione che ho riportato qui sopra Il verso del papiro che contiene una tavola aritmetica del tutto scorrelata dalla tematica del recto egrave edito come PRain Unterricht 151
60 La pratica di ridurre lo spazio occupato da un testo tecnico per mezzo di abbreviazioni e segni convenzionali era molto diffusa nei manoscritti in maiuscola contrariamente a quanto avviene per altri generi letterari vedremo tra breve cosa accade negli Arithmetica di Diofanto ma si leggano in proposito anche le considerazioni di Hei-berg nei prolegomena alla propria edizione dellrsquoAlmagesto in particolare riguardo al ricorso massiccio ad espedienti brachigrafici nel modello del Vat gr 180 POO II pp lxxxiv-xciii civ-cv cxxvii cxxxviii-cxxxix Agli elenchi dettagliati forniti da Heiberg possiamo aggiungere il piccolo prontuario stampato in Hultsch 1876-1878 III 2 pp 126-132 e basato sul testo e sugli scolii alla Collectio di Pappo nel Vat gr 218 (sec X in) Si vedano infine le osservazioni del copista del Par gr 2360 f 120v trascritte da Heiberg in AOO III pp x-xi sulle laquonotazioni tipiche a scopo di tagliar corto nello scrivereraquo impiegate nel pro-
Fabio Acerbi146
derivare dalla seconda (un caso egrave appunto il segno per ἐλάσσων che probabilmente trae origine da una legatura epsilon-lambda) ma poi il rapporto referente-relato si fissa convenzionalmente Quelli definiti nel testo che abbiamo letto sono appunto segni convenzionali non ci sarebbe bisogno di spiegarne forma e funzione se fossero intesi come abbreviazioni assumono nella tabella una funzione denotativa non esplicativa o discorsiva (come accade invece nella tav 1a) Ma come vengono descritti questi segni
I referenti delle descrizioni sono i segni sono introdotti da οὕτως (item i-ii) o in alternativa da un τό con il ruolo di lsquooperatore di citazionersquo (item iii-iv) che corrisponde esattamente alle nostre virgolette In entram-bi i casi gli enti sono menzionati e svolgono una funzione metalinguistica sono collocati materialmente nel testo ma egrave come se si trovassero fuori e la loro descrizione li additasse ndash in effetti i segni convenzionali scritti nel testo sono a loro volta i relata di quelli che si trovano nella tabella
I relata dei segni scritti nel testo sono di due tipi singoli vocaboli (item i-ii) o descrizioni della funzione dei segni per mezzo di clausole sintaticamente complesse (item ii e iv) I singoli vocaboli sono γίνεται e παρά e sono entrambi preceduti dal τό lsquocitazionalersquo in quanto relata di segni convenzionali le forme abbreviate con cui sono tracciati nei manoscritti vanno forzatamente sciolte Bisogna ammettere che la per-spicacia e le risorse grafiche dei copisti ndash di cui tutto si puograve dire fuor che commettano qui degli errori ndash sono messe a dura prova con lrsquointrodurre segni identici ad abbreviazioni o con lrsquoattivare un gioco metalinguistico particolarmente serrato in un contesto meno lsquonaturalersquo di come potreb-be esserlo ad esempio quello di un trattato grammaticale Lrsquoitem iii che presenta direttamente un segno identico ad unrsquoabbreviazione non egrave sorretto da una descrizione ma da una giustificazione in διὰ τό Lrsquoartico-lo τό vi assume una funzione metalinguistica anche se non lsquocitazionalersquo poicheacute al tempo stesso genera un infinito sostantivato e lo singolarizza per questo ho scritto laquosono sottrattiraquo in corsivo nella mia traduzione
prio modello archimedeo (nota 32 supra) egli ne compila anche una breve lista Un elenco antico di laquosegni della geometriaraquo sicuramente redatto per assistere il copista si trova anche al f 3v del ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 vergato da Efrem negli anni 950-960 (tav 8 in Acerbi 2010) Possiamo farci unrsquoidea quantitativa del guadagno di spazio in rapporto ad un testo privo di abbreviazioni e con le parole separate da spazi sulla base del fragmentum mathematicum Bobiense il testo vi egrave disposto a tutta pagina su 36 righe di circa 30 segni ciascuna nelle due pagine in questione figurano 2038 segni con 15 mezze righe occupate dalle due figure Ora nel testo dellrsquoedizione stabilita in Heiberg 1927 pp 87-90 le stesse pagine contano 4455 segni spazi compresi Ne risulta che la dimensione in caratteri di un testo matematico puograve essere ridotta di piugrave della metagrave con lrsquoimpiego di compendi e segni convenzionali
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 147
Negli item ii e iv il segno si collega ad una descrizione nel secondo caso in via esclusiva le descrizioni pertanto rinforzano o sostituiscono lrsquoidentificazione con lrsquoente linguistico denotato Le clausole descrittive sono precedute da ἀντί e dallrsquoarticolo τό con funzione di lsquooperatore di citazionersquo esse sono παρ᾿ ἃ δεῖ τὸν μερισμὸν γίνεσθαι (item ii) e λοιποὶ οἱ μέλλοντες ἐπιμερίζεσθαι (item iv) Nella descrizione della divisione lsquoalla Papporsquo che leggeremo tra breve i segni negli item iii e iv rice-vono lo stesso trattamento degli altri due il loro relatum egrave un singolo vocabolo e non una clausola descrittiva rispettivamente nelle espres-sioni τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε (sul participio ritorneremo nel punto 1 infra) e τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά (la forma del segno notato con λ οι egrave descritta supra nellrsquoitem iv) La descrizione del segno oslash per il divisore merita una discussione piugrave dettagliata In origine si trovava probabilmente scritto Π(ΑΡΑ)ΕΧΟΝ successivamente letto come π(αρ[α])έχον ndash dato che lrsquoabbreviazione per il preverbo egrave identica a quella per la preposizione (che sia Π᾽ o un pi seguito dal segno per ἄρα a sormontare) ndash invece di π(αρὰ) ἔχον I copisti e i correttori si dettero a tutte le possibili contorsioni per restituire un testo dotato di senso leggere appunto una forma verbale con preverbo modificare il preverbo (ma forse il segno per ἄρα era insidiosamente simile ad uno epsilon) correggere il testo rileggiamo lrsquoapparato sub τὸ παρὰ ἔχον οὕτως τὸ παρέχον οὕτως M et π(αρ-) comp Z οὕτως τὸ περιέχον S τὸ περιέχον οὕτως C προγράφοντας οὕτως ex corr m 2 P Nella clausola descrittiva seguente la presenza liminare di παρὰ (che ho corretto in παρ᾿ ἃ nella speranza di restituire una frase che abbia un senso senza intervenire sul testo) innesca un bel corto circuito il Π(ΑΡΑ) che sicuramente figu-rava nellrsquoarchetipo egrave un sintagma complesso una preposizione unrsquoab-breviazione o un segno per unrsquoabbreviazione Se lrsquoeditore si trova in conflitto con la propria inclinazione alla critica conservativa i copisti si rifiutarono di mettere mano ad un testo che doveva stridere anche per loro essendo il compito demandato al ritocco del revisore del Par gr 2390 o alla riscrittura radicale del recensore bizantino Il problema egrave che ci troviamo di fronte ad unrsquoespressione che descrive la funzione dellrsquooggetto denotato non lrsquooggetto stesso ma che lo contiene al suo interno per soprammercato qui il Π(ΑΡΑ) egrave usato per giustificare una menzione a sua volta relatum di un segno
Evidentemente questa maniera di procedere che giagrave aveva attirato interventi da parte di copisti e correttori della recensione di base parve insostenibilmente opaca allrsquoautore della recensione bizantina61 Egli
61 Uno dei manoscritti di questa recensione propone anche una tabella di divisione
Fabio Acerbi148
modifica tutte le descrizioni diluendo lrsquoidiomatismo dellrsquoarticolo lsquocita-zionalersquo con lrsquointroduzione sistematica del verbo δηλόω e di frasi atte a chiarire quale sia il segno denotante e quale il vocabolo (o il segno) denotato Egli introduce allo scopo di rendere esplicita la funzione de-notativa dei segni introdotti il termine σημείου curiosamente in tutte le sue tre occorrenze esso compare a sua volta nella forma dellrsquoabbrevia-zione per sospensione σΗ´ Egli traccia il segno per i massimi multipli ἀφ e quello per i resti λ οι` in modo che non vi siano ambiguitagrave quanto al loro carattere di abbreviazione Si faccia infine attenzione al residuo di barra sul παρᾱ con funzione denotativa (2 occorrenze) contenuto nella descrizione del segno per il divisore sostituita dallrsquoaccento grave nel παρὰ con funzione discorsiva (la differenza egrave nettissima nei manoscritti da me consultati) Questa osservazione ci permette di passare direttamente allrsquoitem seguente
b) Le barre sui numerali e sulle lettere denotative Egrave opportuno discutere questo punto adesso esattamente percheacute di barre siffatte che pure troviamo in tutti i manoscritti i nostri testi non fanno mai menzione si tratta infatti di una pratica condivisa sin dallrsquoantichitagrave La barra identifica una stringa di lettere dellrsquoalfabeto che non svolge una funzione grammaticale o sintattica propria allrsquointerno del discorso Ciograve avviene in particolare e si tratta della fattispecie piugrave frequente se la stringa di lettere non dagrave origine a un vocabolo della lingua greca lette-re denotative e numerali certo ma anche termini provenienti da altri idiomi e contrazioni di parole greche come i nomina sacra62 tali termi-ni possono essere o no preceduti da un articolo lsquocitazionalersquo a seconda dellrsquouso che ne viene fatto allrsquointerno del discorso Ma non si tratta dellrsquounica fattispecie i papiri grammaticali ed i manoscritti piugrave antichi dei trattati dello stesso argomento segnalano gli esempi delle parti del discorso (cioegrave di lsquoverersquo parole greche) per mezzo di barre sormontanti63 La differenza insomma egrave tra menzione e uso (come parte del discorso in atto) di una stringa di caratteri tra il porre le lsquovirgolettersquo e il non porle tra funzione denotativa e non Apparentemente la convenzione si limi-
corredata dei segni opportuni e contrariamente alle indicazioni della descrizione svilup-pata lsquoin verticalersquo ma per motivi misteriosi non completa (tav 7a Laur Plut 89 sup 48 f 13r)
62 Tutto ciograve egrave spiegato con estrema chiarezza giagrave in Traube 1907 pp 45-4763 Si veda il Par gr 2548 codex vetustissimus e testimone unico delle lsquoopere minorirsquo
di Apollonio Discolo il f 106v con le barre ben visibili egrave riprodotto come tav 19 in De Gregorio 2000 (ivi pp 137-138 per la datazione) Per la testimonianza dei papiri grammaticali si veda Wouters 1979 passim essi contengono di norma elenchi di parti del discorso nessuna delle quali egrave preceduta dallrsquoarticolo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 149
tava in questo secondo caso a segnalare con la barra singoli vocaboli le menzioni di frasi o di sintagmi complessi sono di norma identificate dallrsquoarticolo lsquocitazionalersquo Drsquoaltra parte le abbreviazioni convenzionali non rientrano nella casistica percheacute la loro resa grafica che contiene elementi non alfabetici come compendi per desinenze lettere supra li-neam marche di contrazione o sospensione quali slashes o barre sotto-poste o sormontanti eventualmente solo un sottinsieme della stringa di segni alfabetici le esclude automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
Venendo al discorso matematico una barra sormonta senza ecce-zione le lettere denotative64 che sia in papiri o in manoscritti in maiu-scola65 o minuscola ma solo allrsquointerno del testo comrsquoegrave da attendersi nei diagrammi esse la perdono per il semplice motivo che non crsquoegrave alcun testo ambiente un diagramma ha unicamente una funzione denotati-va Drsquoaltra parte le lettere numerali che a volte figurano nei diagrammi della tradizione metrica66 allo scopo di indicare la lunghezza dei seg-menti mantengono la barra in un diagramma il contesto denotativo geometrico egrave prevalente e i numerali vengono percepiti come entitagrave grafiche lsquoesternersquo al discorso Va da seacute a fortiori che le lettere numerali inserite in un testo dovranno essere segnalate da barre che a loro volta non servono nelle tavole67 in quanto queste ultime sono come abbiamo visto un vero e proprio testo che perograve funge da ambiente a quello al-fabetico limitato alle titolazioni e non a caso tracciato in unrsquoopportuna lsquomaiuscola distintivarsquo allo scopo di segnalarne il carattere denotativo e non discorsivo68 Una tabella operazionale egrave invece un paratesto e quindi le barre sulle lettere numerali che rappresentano gli interi sono
64 La notazione per le lettere denotative subigrave unrsquoevoluzione (il cui risultato finale egrave descritto per sommi capi nella nota 3 supra) di cui non mette conto occuparsi qui
65 I papiri di contenuto geometrico (o astronomici ma che presentano argomenti geometrici) sono rari si vedano il PHerc 1061 (sec II aC Demetrio Lacone De geome-tria) e il PFay 9 (sec II ex Elementi I 39 e 41) Gli importanti ostraka OBerl 12002 e 12609 (sec III aC m Elementi XIII) non pongono le barre sopra le lettere denotative Per i manoscritti in maiuscola si veda ad esempio passim nel Par gr 2389 una cui riproduzione digitale egrave consultabile in rete allrsquoindirizzo httpgallicabnffrark12148btv1b8470171d o il fragmentum mathematicum Bobiense
66 Si veda ancora il ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 codex unicus dei Metrica di Erone e contenente una raccolta importante di problemi del corpus metrologico
67 Si vedano come esempio le tavole citate alle note 10 e 14 supra Discorso a parte per il segno di lsquoposto vuotorsquo si veda il punto c che segue
68 Queste regole generali vanno prese cum grano salis si dagrave naturalmente un certo dominio di variabilitagrave legato verosimilmente al grado di cultura grafica del copista nel PMich III 144 i numerali sono quasi tutti senza barra sia nel testo che nelle tabelle ope-razionali
Fabio Acerbi150
necessarie esse mancano invece sui segni convenzionali che ho descrit-to nel punto precedente e fatto rilevante sulle lettere numerali relative agli ordini sessagesimali quando esse siano identificate da uno o piugrave apici la presenza di questo segno grafico non alfabetico69 le esclude ancora una volta automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo Unrsquoultima osservazione che ci saragrave utile nel seacuteguito la descrizio-ne di una stringa di lettere lsquoagrammaticalersquo non puograve prevedere la men-zione della presenza della barra che le pertiene in quanto tale si tratta di una pratica denotativa che egrave possibile formulare soltanto ad un livello di discorso superiore sia a quello dellrsquouso che a quello della menzione70
c) Il segno di lsquoposto vuotorsquo Si noti nella tav 2b la forma ŏ per il segno di lsquoposto vuotorsquo in un ordine sessagesimale coerentemente con la propria notazione il copista del Marc gr 313 lo scioglie talvolta allrsquoin-terno del testo principale come unrsquoabbreviazione per οὐδέν laquonienteraquo Altre convenzioni di scrittura del tratto che accompagna il circoletto e che si badi bene fa parte integrante del segno di lsquoposto vuotorsquo ndash e infatti nelle tavole troviamo sempre il segno completo mentre tutti gli altri numerali sono come abbiamo visto nel punto precedente privi di barra o di apice a causa del fatto che i vari ordini sessagesimali sono univocamente determinati dalle linee di giustificazione ndash un tratto an-golare anteposto (tav 3 Lar Plut 2818 f 136v)71 o una semplice barra a sormontare (tavv 4-9) si produce in questo modo il segno 65926 che sembra essere stata la forma di base72
69 Occorre dunque supporre come testimoniano papiri e manoscritti in maiuscola che la convenzione relativa allrsquouso della barra si sia consolidata ben prima dellrsquointroduzione di segni diacritici quali accenti e spiriti
70 Si veda il punto 2 infra per maggiori dettagli sulla questione delle barre e degli apici e per le indicazioni in merito che leggiamo in Diofanto
71 Come accennato questa tavola dei sottomultipli coincide con quella descritta ed esposta nei Prolegomena Fatto molto rilevante i numerali nella prima non recano neacute barre neacute apici contrariamente a quanto accade a tutte le istanze della seconda nei manoscritti Quella del Laur Plut 2818 preserva a mio avviso la forma originaria come abbiamo visto una tavola non richiede segni aggiuntivi sulle lettere numerali
72 Si vedano come esempio ancora le tavole citate alle note 10 e 14 supra oppure per una rassegna delle forme che il segno assume nei manoscritti piugrave antichi delle Tavole facili Tihon 2011 pp 58-59 e per quelle che assume nei papiri Jones 1999 I pp 61-62 Ovviamente non possiamo leggere il segno 65926 come un omicron con una barra in quanto ο = 70 nella notazione greca e la barra egrave di rigore quando il numerale figuri allrsquointerno di un testo Occorre ammettere che si dagrave origine ad un bel corto circuito notazionale con il concepire un segno con funzione di lsquoposto vuotorsquo ma che lsquosomigliarsquo ad una lettera dellrsquoalfabeto sormontata da una barra cioegrave ad un numerale in piugrave quando il lsquoposto vuotorsquo non corrisponda ad un intero ma ad una specie sessagesimale la presenza della barra a priori indistinguibile da quella che sormonta gli interi introduce unrsquoincongruenza con la notazione a mezzo di apici vista nellrsquoitem precedente
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 151
d) Errori di copia La tabella riprodotta nella tav 2b ha una forma simmetrica ma si tratta di una forzatura il grande rettangolo in basso a destra drsquoaltronde assente nella descrizione contiene uno scolio che fa notare come lrsquoultimo resto parziale ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ͵γτνζ´´´´´ κζ´´´´´´ cioegrave 0 0 0 0 0 3357 27 siano ἔγγιστα λ´λ´ δ´δ´ ξ laquocon ottima approssimazione 60 minuti quartiraquo dove si notino gli apici semplici per indicare il pas-saggio allrsquoordinale e il raddoppiamento del sistema segno + apice per significare il plurale Lo scolio debitamente accompagnato dal segno di rimando in forma di simbolo solare egrave stato probabilmente incluso nella tabella proprio allo scopo di renderla simmetrica A sua volta un errore precedente spiega lo spazio eccessivo accordato al rettangolo contenente lo scolio il secondo massimo multiplo ŏ λβ´ ξδ´´ ριβ´´´ σιϛ´´´´ egrave trascritto anche al di sotto del risultato
Passiamo ora alla descrizione del metodo di divisione attribuito a Pappo
ἵνα οὖν ταῦτα συναχθῇ τὰ ἐκ τοῦ μερισμοῦ ὁ εἰρημένος Πάππος εὐδιατύπῳ τινὶ καὶ πρὸς τοῦτο τάξει χρησάμενος ποιεῖται τὴν τῆς συλλήψεως τοῦ ζητουμένου ἀνεύρεσιν οὕτως ἐκθέμενος γὰρ τὸν μέλλοντα μερίζεσθαι τουτέστι τὰς τξ μοίρας ἐν ἀρχῇ ἀφαιρεῖ ἀπ᾽ αὐτῶν τὸν ἐν τῇ σελίδι τυγχάνοντα ἐλάττονα τουτέστι τὸν τδ κβ´ κ´´ ὄντα τῶν ἐγγὺς ἐλασσόνων ὡς πρὸς τοὺς ἐκκειμένους διὸ καὶ γράφει αὐτὸν προγράφων αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε καὶ εὑρίσκων τὰ παρακείμενα αὐτῷ τῷ ἀπογραφέντι ἐν τῷ σελιδίῳ λεπτὰ πρῶτα ν´ συναπογράφεται παρατιθῶν αὐτοῖς τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον ἀνατείνουσαν σημαῖνον τὸ εἶδος ὅτι πρῶτα λεπτά εὑρίσκει οὖν οὕτως τὸ τῶν τξ μέρος τὸ τδ κβ´ κ´´ ὃ μεριζόμενον παρὰ τὰς τξε ιδ´ μη´´ ἡμέρας καὶ ποιοῦν τὸν ἐκ τοῦ μερισμοῦ ἀριθμὸν πρῶτα λεπτὰ ν´ καὶ τὸν λοιπὸν ἀπογραφόμενος τὸν νε λζ´ μ´´ προτάσσει αὐτοῦ τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά τάσσει δὲ καὶ ἁπλῆν τινα διατείνουσαν γραμμὴν ὡς ἀπὸ τοῦ τξ ἐπὶ τὸν ἑξῆς ἐκτεθειμένον ἐγγὺς
1
5
10
1 εὐδιατύπῳ] ZSPC εὐδιατύπωτ M 4 ἀφαιρεῖ] MZSP ἀφ ι C 5 ἐλάττονα] P comp MZSC 6 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | αφ ] αφ ε M ἀφ ZS ἀφαί P ἄφ C | ἀντὶ] om C | ἄφελε] MZSP ἄφ C 8 ἀπογραφέντι] MZSP ἐγγραφέντι C | λεπτὰ πρῶτα] P λε πρωτα SC λεπτῶν πρωτ MZ | παρατιθῶν] MZS παρατιθεὶς C et ex corr m 2 P 9 ᾱ] Z αο P α´ MS α C | ἔχον] MPC ἔχων ZS 9-10 πρῶτα λεπτά] ZP πρωτ λ´λ´ M πρωτα λε S αα λε C 11 ἡμέρας] comp codd | ἀριθμὸν] P et comp MZ καὶ C et comp S 12 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M πρωτ λεπτ(α) Z πρωτ λ εᾱ S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C | ἀπογραφόμενος] MZSP ἐγγραφόμενος C | νε λζ´] MZSP λζ νζ C 13 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | λ οι] MZSC ex λ fecit λ οι P | προσσημαῖνον] MC et προσ- comp ZS προση- P | τὸ] MZC τὰ S et fecit m 2 P 14 ἀπὸ] MZSP πρὸς C ἐλάττονα] P comp MZSC
1 εὐδιατύπῳ] εὐδιατυπώτω K 6-7 αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ] τὸ ἀφ K 8 παρατιθῶν mdash 10 λεπτά] τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ σημαίνουσαν τὸ εἶδος αὐτῶν ὅτι ᾱ λεπτά εἰσιν K | τὸ (sec)] τὰ K 12 πρῶτα] πρώτων K | τε λ ] λ οι` K | προσσημαῖνον mdash
Fabio Acerbi152
ἐλάττονα τὸν τδ κβ´ κ´´ ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις καὶ ταύτην ἐπιδεικνύουσαν τὴν τάξιν τῆς προόδου τῆς ἐκθέσεως ἧστινος κλωμένης γραμμῆς πρὸς τῷ ἐγγὺς ἐλάσσονι ἡ ἀντανάκλασις ἐπὶ τὸν λοιπὸν γέγραπται φερομένη ὡς εἴρηται διὰ τὸ εὔτακτον τῆς προκοπῆς οὕτως τε ποιήσας ἑξῆς τὸ αφ ποιῶν ὃ προσσημαίνει ὡς εἴρηται τὸ ὅτι δεῖ ἀφελεῖν ὁμοίως ἀπὸ τοῦ λοιποῦ καὶ δὴ τὸν ἐγγὺς πάλιν ἐλάσσονα ὡς πρὸς τὴν ἐν τῷ σελιδίῳ ἔκθεσιν εὑρισκόμενον λαμβάνων ἑξῆς προγράφει αὐτὸν ὄντα νδ μζ´ ιγ´´ ιβ´´´ καὶ εὑρίσκει αὐτοῖς παρακείμενα ἐν τῷ σελιδίῳ πρῶτα λεπτὰ θ´ ἅτινα καὶ αὐτὰ προσαπογράφεται σὺν τῇ παρασημειώσει τῶν πρώτων γράφων τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον τὴν ἀνατείνουσαν καὶ ὡς εἴρηται τὴν γραμμὴν πάλιν διὰ τὴν τάξιν κλωμένην κατὰ δευτέραν κλάσιν προσέλκει γινομένου τοῦ μέρους αὐτῆς τούτου παραλλήλου τῷ ἐξ ἀρχῆς
16 ante κλωμένης add ἐπὶ C 18 τε] MZP om SC | αφ ] M ἀφ ZSC ἀφαί P 19 προσσημαίνει] MS προση- ZC et ex corr P | ὅτι] ZP comp MSC 20 δὴ] MZSC διὰ fecit m 2 P 21 πρὸς] MSP et supra lineam C ex ἀπὸ fecit m 2 Z | ιγ´´] MZSP νγ´´ C 22 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M ᾱᾱ λεπτὰ Z άάα λε S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C 23 προσαπο- γράφεται] απο suprascr in comp M 24 ᾱ] ZP α´ MS α C 25 κλάσιν] MP τάξιν ZSC | τοῦ] ZSPC τούτου M 26 τούτου] τοῦ bis ZSPC sed prius erasit m 2 P τοῦ M
mdash 18 προκοπῆς] om K | τε ποιήσας] ποιήσας καὶ K | αφ ] ἀφ K 19 τὸ] om K 21 προ-γράφει] γράφει K 22 σελιδίῳ] α´ σελιδίῳ K | ἅτινα] ἃ K 23 προσαπογράφεται] ἀπογράφεται K | τῶν πρώτων mdash 26 ἐξ ἀρχῆς] om K
lsquoAllo scopo di raccogliere ciograve che risulta dalla divisione il detto Pappo utilizzando anche in questo caso una certa disposizione ben strutturata determina nel modo seguente il lsaquonumerorsaquo cercato preso nel suo insieme collocando73 in testa il lsaquonumerorsaquo che sta per essere diviso cioegrave i 360 gradi iniziali sottrae loro tra i piugrave prossimi dei lsaquonumerirsaquo minori rispetto a quelli esposti quello che si trova essere minore nella colonna (cioegrave 304 22 20) Questo egrave il motivo per cui lo trascrive scrivendogli davanti lrsquoabbreviazio-ne laquosottrraquo per laquosottrairaquo e trovando che 50 minuti primi sono collocati accanto a quello stesso lsaquonumerorsaquo che egrave stato trascritto nella colonna li trascrive al tempo stesso collocando accanto74 ad essi la lettera A con un lsaquotrattorsaquo75 sopra che significa la specie minuti primi Trova dunque in que-sto modo la parte di 360 che egrave 304 22 20 la quale divisa per 365 giorni 14 48 fa il numero lsaquoche risultarsaquo dalla divisione 50 minuti primi Trascrivendo
73 La descrizione egrave strutturata come una procedura Acerbi 201274 Il purismo del correttore del Par gr 2390 di Clostomalle nel Marc gr 314 e
dellrsquoautore della recensione bizantina impone loro di modificare la terminazione ma forme tematiche e contratte di τιθεῖν sono correnti nel greco tardivo
75 Il testo greco ha solo il participio con γραμμήν sottinteso Per il significato del participio si veda il punto 2
15
20
25
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 153
poi il resto 55 37 40 gli pone altresigrave76 a prefisso laquoReraquo che significa laquorestiraquo e dispone anche una certa linea semplice77 che va da 360 al piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori che egrave esposto di seacuteguito 304 22 20 come nello lsaquoschemarsaquo esposto linea che mostra lrsquoordine del percorso dellrsquoesposizione Questa linea spezzata lagrave dove si trova il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori egrave tracciata inflessa allrsquoindietro lsaquoersaquo punta verso il resto come egrave stato detto in vista di una progressione ordinata E cosigrave facendo prendendo di seacuteguito il laquosottrraquo che significa come egrave stato detto laquoche occorre similmente sottrarre dal re-storaquo e ovviamente prendendo di nuovo il lsaquonumerorsaquo che egrave trovato essere il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori in relazione alla disposizione nella colonna ndash 54 47 13 12 ndash lo scrive di seacuteguito e trova che 9 minuti primi sono posti loro accanto nella colonna trascrive78 anche questi con la segnaletica dei primi scrivendo la lettera A con un lsaquotrattorsaquo sopra e come egrave stato detto prolunga di nuovo la linea spezzata in vista di una buona disposizione tramite una seconda inflessione essendo questa sua parte parallela a quella inizialersquo
La descrizione continua con una serie di laquoe cosigrave viaraquo e non fa ulte-riore riferimento alla tabella
1) La forma verbale ἐξεσμένον Egrave il neutro del participio perfetto medio-passivo di ξέω lett laquopialloraquo laquolevigoraquo Si danno tre possibilitagrave si tratta di un termine canonico per quanto non altrove attestato per designare unrsquoabbreviazione oppure lrsquoautore anonimo improvvisa sul piano metaforico come se unrsquoabbreviazione non fosse altro che la paro-la completa lsquoaccorciata a colpi di piallarsquo in maniera opportuna oppure il testo egrave corrotto e srsquoimpone una correzione ad esempio τὸ ἑξῆς μένον laquociograve che sta di seacuteguitoraquo Questrsquoultima strada mi pare chiusa dal senso delle frase lrsquoabbreviazione non lsquosta di seacuteguitorsquo a niente ma anzi precede la perifrasi τὸ ἑξῆς μένον se impiegata semplicemente per rimandare al segno αφ immediatamente seguente costituirebbe un intollerabile solecismo Se accettiamo la prima di queste letture considerando quin-di lrsquoabbreviazione αφ in posizione predicativa abbiamo a che fare con
76 Rendo in questo modo il τε isolato77 La linea egrave laquosempliceraquo in quanto egrave una retta la precisazione intende evidenziare per
anticipazione il carattere lsquonon semplicersquo che essa assumeragrave alla prima inflessione quando diventeragrave una spezzata linee siffatte erano in effetti concepite dallrsquoanonimo e prima di lui da tutta la tradizione matematica greca come una singola linea spezzata nei punti drsquoinfles-sione I due segmenti paralleli menzionati al termine del passo sono orizzontali
78 Il verbo egrave al medio in variatio rispetto ai due che precedono e che seguono egrave il matematico che lsquosirsquo trascrive le cifre
Fabio Acerbi154
uno hapax semantico nella grecitagrave superstite come egrave facile verificare con una ricerca sul TLG in rete La recensione bizantina risolve il pro-blema sopprimendo semplicemente τὸ ἐξεσμένον
2) La notazione per le specie numeriche Nella terminologia matema-tica greca gli ordini sessagesimali sono εἴδη laquospecieraquo numerici essi corri- spondono agli ordini di grandezza nel nostro sistema decimale e indica-no in analogia con il caso geometrico la lsquoformarsquo che assume un numero quadrato cubo ecc Centinaia e migliaia sono quindi degli εἴδη rispet-tivamente quadrati (100 egrave il quadrato di 10) e cubi (1000 egrave il cubo di 10) sono specie numeriche ma non numeri particolari e drsquoaltronde 300 non egrave un quadrato ma 3 item dellrsquoεἶδος lsquoquadratorsquo 100 3 egrave il numerale di molteplicitagrave della specie quadrata lsquocentinaiarsquo i due 0 che seguono il 3 segnalano esattamente questo fatto che la notazione greca per gli interi non posizionale fa scomparire al livello denotativo Ciograve non vale soltan-to per i numeri interi ma anche per le loro parti i minuti secondi appar-tengono alla specie lsquoquadratorsquo in quanto 13600 egrave il quadrato di 160
La concezione appare interamente dispiegata nellrsquointroduzione degli Arithmetica diofantei79 che si rivela giova farlo rimarcare un te-stimone fondamentale per la ricostruzione della notazione matematica antica Alle specie usate in questrsquoopera vengono assegnati una denomi-nazione ed un segno convenzionale costituito dallrsquoiniziale (di ognuno dei componenti) della denominazione al quadrato o δύναμις il segno ΔΥ al κύβος il segno ΚΥ alla lsquoquarta potenzarsquo o δυναμοδύναμις il segno ΔΥΔ ecc La descrizione di tali segni egrave del tipo καὶ ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον Κ ἐπίσημον ἔχον Υ ΚΥ κύβος laquoe il suo segno egrave un Κ che ha come indice un Υ ΚΥ cuboraquo dove in accordo con quanto abbiamo visto nel punto b supra e pur nel comprensibile imbarazzo del copista della prima parte del Matritensis (o di un suo passato collega) a districarsi in questo formidabile ginepraio notazionale80 le due lettere Κ e Υ ricevono una barra mentre ΚΥ non la richiede a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον il quale ancora una volta esclude automaticamente il segno dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
79 In particolare a DOO I pp 214-62180 Nel Matr 4678 riscontriamo i seguenti fenomeni nelle poche righe a cavallo dei ff
58r-v 1) accento acuto posto su tutti i segni come se fossero abbreviazioni 2) ripetizione sistematica segnodenominazione come in ΚΥ κύβος appena letto dovuta sicuramente allrsquointrusione di glosse interlineari esplicative dei segni ndash e successivo pentimento (δύναμις e κύβος sono in effetti cancellati dalla prima mano il primo con un tratto il secondo con dei punti supra lineam poi il copista si stanca di correggere) 3) nella descrizione del segno per la δυναμοδύναμις menzione di un δέλτα δύο che saragrave molto probabilmente stato ΔΔ subito dopo nella descrizione del κυβόκυβος si legge un incongruo δύο KK
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 155
Diofanto introduce poi dei segni anche per le specie delle parti dellrsquounitagrave (le nostre frazioni) che egli chiama ὁμώνυμα μορία laquoparti omonimeraquo di cui quelle sessagesimali sono casi particolari81 Egli spie-ga appunto che le loro denominazioni sono ottenute da quelle delle specie degli interi per sinonimia passando ad un lsquoordinalersquo82 formato semplicemente aggiungendo il suffisso -στον δυναμοστόν κυβοστόν δυναμοδυναμοστόν ecc (sott μόριον) I loro segni convenzionali sono invece ottenuti da quelli per le specie degli interi aggiungendo una γραμμὴν διαστέλλουσαν τὸ εἶδος laquolinea che distingue la specieraquo83 Una linea sui segni delle specie delle parti egrave richiesta si badi bene per distinguerli dai segni di quelle degli interi come giagrave osservato questi ultimi sono giagrave lsquoagrammaticalirsquo a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον a fortiori lo saranno anche i primi Si tratta della traduzione semio-tica del passaggio dal cardinale allrsquoordinale che a livello grammaticale egrave effettuato con il suffisso -στον Che forma ha questa linea Barra o apice (Egrave cervellotico pensare a forme piugrave complesse) La domanda non ammette una risposta immediata in quanto delle specie diofantee nessuno piugrave si occupa nellrsquoantichitagrave84 Se egrave vero che la prima risposta darebbe origine ad un conflitto tra due convenzioni denotative diffe-renti la barra lsquocitazionalersquo e la barra che distingue la specie lrsquoevidenza grafica del Matritensis lascia lievemente sgomenti (ricordiamoci che giagrave i segni di base sono indebitamente dotati di un accento dal copista) Le poche occorrenze del segno per le specie delle parti85 vedono lrsquoaggiunta di uno slash di sospensione di un doppio apice inverso ndash in tutta evi-
81 Questo fatto era giagrave chiaro nellrsquoantichitagrave Teone in Alm I 10 in iA p 45310-1682 Il parallelo con i cardinali e gli ordinali relativi agli interi egrave reso esplicito da Dio-
fanto ὥσπερ δὲ τῶν ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια παρομοίως καλεῖται τοῖς ἀριθμοῖς τοῦ μὲν τρία τὸ τρίτον τοῦ δὲ τέσσαρα τὸ τέταρτον οὕτως καὶ τῶν νῦν ἐπονομασθέντων ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια κληθήσεται παρομοίως τοῖς ἀριθμοῖς laquocome le parti omonime dei numeri sono chia-mate per assonanza con i numeri di lsquotrersquo lsquolsaquounrsaquo terzorsquo di lsquoquattrorsquo lsquolsaquounrsaquo quartorsquo cosigrave le parti omonime dei numeri appena nominati saranno chiamate per assonanza con i numeriraquo (DOO I p 69-13 si noti lrsquoarticolo lsquocitazionalersquo al singolare in τοῦ τρία e τοῦ τέσσαρα) Il parallelo prosegue anche al livello dei segni che rappresentano queste specie come vedremo tra un attimo
83 Diofanto Arithmetica prefazione in DOO I p 620-21 un passaggio maltrattato in questa edizione occorre espungere il participio ἔχον senza introdurre segni ulteriori oppure eliminare un precedente ἐπί come fa un correttore del Matritensis f 58v
84 Unica parzialissima eccezione lrsquoaccenno di Teone menzionato nella nota 81 supra85 Al f 59r e per di piugrave nel margine per sanare un lungo saut du mecircme au mecircme La
collocazione in margine egrave il motivo per cui troviamo una notazione abbreviata nel resto del trattato il primo copista scioglie tutti i segni prendendoli per abbreviazioni mentre il secondo elimina sistematicamente il tratto aggiuntivo delle specie delle parti dellrsquounitagrave Drsquoaltronde egli scrive ad esempio ΔΥ invece di ΔΥ ed egrave quindi indotto a porre la barra al di sopra della stringa di lettere risultante (passim ma si veda ad esempio il f 72r)
Fabio Acerbi156
denza il compendio per la desinenza -ον accentata il copista interpreta il segno come unrsquoabbreviazione ndash e di una barra a sormontare lo Υ Potremmo forse interpretarlo come il segno di contrazione del grafema -στ- lrsquounico tassello mancante in unrsquoabbreviazione come ad esempio (δυναμοδυναμο)(στ)(ὸν) ma uno scolio di prima mano al f 58v rela-tivo alle specie degli interi inficia questrsquoipotesi esse sono dotate di slash di sospensione accento acuto in un caso del compendio canonico per la terminazione -ον hellip ma tutti gli Υ a esponente sono a loro volta sormontati da una barra
Meno legata al singolo manoscritto ma nondimeno non uniforme si presenta la pratica di notazione dei segni che rappresentano gli enti numerici sessagesimali86 da una parte sta lrsquoevidenza del testo dei Pro-legomena e delle sue tabelle apici ndash drsquoaltronde come abbiamo visto la notazione universalmente impiegata per i numerali ordinali e per le fra-zioni unitarie ndash dallrsquoaltra sta lrsquoevidenza del testo dellrsquoAlmagesto in tutti i manoscritti piugrave antichi e lo stesso si dica del commentario teonino a questrsquoopera o del suo lsquoGrande commentariorsquo alle Tavole facili e dei testi astronomici su papiro barre87 Sembra insomma che la nostra docu-
86 Sia le molteplicitagrave che le specie ahimeacute entrambe rappresentate da lettere dellrsquoalfabeto Come osservato allrsquoinizio della sezione 3 ci sono in effetti due tipi di lettere numerali in gioco se facciamo astrazione da apici o barre lsquo4 minuti secondirsquo si trova scritto δ β la prima lettera numerale denota la molteplicitagrave degli item di una certa specie la se-conda la specie nei Prolegomena entrambe sono accompagnate da un doppio apice il che rende inutile la presenza delle seconde Si noti che la descrizione della tabella non fa parola della notazione da usare per le lettere numerali che denotano la molteplicitagrave barre o apici e quanti apici hellip In questo caso fa interamente fede la tabella cioegrave la pratica grafica condivisa instauratasi non egrave chiaro quando
87 I manoscritti piugrave antichi dellrsquoAlmagesto sono menzionati nella nota 10 supra quelli dei due commentarii teonini sono il Laur Plut 2818 e il celeberrimo Vat gr 190 (sec IX in Euclide Elementi Data Teone lsquoGrande commentariorsquo) per la notazione dei pa-piri astronomici si veda Jones 1999 II passim La notazione non sembra lsquoinquinatarsquo dalla pratica dei copisti bizantini e pare dipendere soltanto dalla data di composizione Tro-viamo ad esempio barre sopra tutti i numerali di molteplicitagrave (interi o sessagesimali) nel frammento di un commentario alle Tavole facili contenente un calcolo relativo al 24 aprile 213 (Par gr 2841 sec XIII ex-XIV in oltre al frammento ai ff 32r l 11-34v l 23 contiene Arato Phaenomena ed Efestione Apotelesmatica edizione in Jones 1990) Nel commentario alle Tavole facili composto ca 610-617 ed attribuito a Stefano di Alessandria la situazione egrave la seguente (Jean Lempire per litteras per lrsquoedizione si veda Lempire 2014 ho controllato il Vat gr 304 ff 135r-171v sec XIV am contiene in aggiunta Teone in Almagestum I-II lsquoPiccolo commentariorsquo alle Tavole facili Diofanto Arithmetica e De polygo-nis numeris varia astronomica tabulae) barre sopra gli interi sporadicamente rimpiazzate da apici apici sopra le parti sessagesimali in numero uguale alla denominazione doppio () apice per le frazioni unitarie Sono impiegate barre sopra gli interi e apici sopra le parti sessagesimali nei manoscritti principali di tutti i trattati di introduzione allrsquoAlmagesto o comunque di argomento logistico redatti in epoca bizantina Giorgio Pachimere (1242-ca 1310) Quadrivium (autografo nel manoscritto Roma Biblioteca Angelica gr 38 [RGK III nr 115] si veda Tannery ndash Steacutephanou 1940 per lrsquoedizione) Teodoro Metochita (1270-
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 157
mentazione si faccia testimone di un cambio notazionale avvenuto nel periodo intercorrente fra Teone (sec IV pm) e la scuola alessandrina di Ammonio e dei suoi allievi (sec VI in) e probabilmente innescato da questrsquoultimo ambiente lrsquoaspetto paradossale egrave che nello stesso codice si rintraccino due notazioni differenti per gli enti numerici sessagesimali e lrsquouna (apici) sia adottata sistematicamente e coerentemente in uno scritto (i Prolegomena) che si presenta esattamente come unrsquointroduzione tecnica alla pratica numerico-algoritmica del trattato (lrsquoAlmagesto) in cui egrave adottata lrsquoaltra (barre che ritroviamo senza eccezioni anche negli scolii)
Torniamo ai Prolegomena la descrizione del segno da porre a fianco di ogni singolo quoziente parziale e denotante la sua specie numerica (minuti primi minuti secondi ecc) solleva tre problemi
Primo problema Ci vuole una barra o un apice su τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquola lettera A [hellip] che significa la specieraquo quando lo scriviamo nella tabella Tutta la nostra discussione precedente fa pro-pendere per lrsquoapice e si ricordi anche la forma verbale ἀνατείνουσαν che suggerisce qualcosa che si lsquoestende verso lrsquoaltorsquo (la mia traduzione egrave volutamente neutra) se fosse apposta una barra la cosa dovrebbe passare
1231332) Compendium astronomicum (copia lsquoautorizzatarsquo coeva nei Vat gr 182 e 181 da parte del copista che integrograve le parti mancanti del Par gr 2389 [ff 207-210 255-270 374-375] Bianconi 2005a pp 425-427 Peacuterez Martiacuten 2008 p 436 e n 177) Teodoro Meliteniota (morto lrsquo831393) Tribiblos astronomica (autografo nel Vat gr 792 si vedano Leurquin 1991 per unrsquoanalisi del manoscritto Leurquin 1990 per lrsquoedizione) una com-pilazione anonima (per cui ho consultato il Par gr 2396 ff 87r-92v limitatamente a questi fogli manu Costantino Trivoli [RGK II nr 318 ma ovviamente questo codice non vi egrave segnalato] terzo quarto del XV secolo il resto del codice annotato da Niceforo Gregora egrave di etagrave planudea e parzialmente [ff 33v-76v] un autografo di Planude stesso contiene Teone in Almagestum I II IV Mondrain 2002 il codice va completato ndash limitatamente a stralci dei libri VIII-X XII-XIII del commentario teonino la cui parte intermedia si egrave persa ndash con 26 carte [ff 123-147] inserite nel Vat gr 1087 anchrsquoesso contenente anno-tazioni di Gregora Rome 1927 per la figura del copista dei ff 77r-86r del Par gr 2396 e dei ff appena nominati del Vat gr 1087 un anonimo collaboratore di Gregora si veda in ultimo Bianconi 2006a pp 147-151) si veda anche il calcolo effettuato da Niceforo Gre-gora (12921295-13581361) dellrsquoeclisse di sole del 16 luglio 1330 (attestata unicamente ai ff 1r-8v della miscellanea astronomica Marc gr 325 databile ca 1324-1329 in parte vergata e ovunque fittamente annotata da Gregora stesso edizione del testo in Mogenet et al 1983 annotazioni di Gregora elencate in Bianconi 2005a p 413) Unrsquoeccezione apparente il lsquoPiccolo commentariorsquo di Teone alle Tavole facili le parti sessagesimali sono segnalate da apici (ad esempio nel Vat gr 175 vergato da Giovanni Catrario e completato nel 1321-1322 sulla figura di Catrario si vedano in ultimo Bianconi 2005b pp 141-156 e 2006b) lrsquoopera egrave antica ma la sua tradizione non rimonta oltre la fine del XIII secolo a parte un frammento nel Leiden BPG 78 ff 156r-161v (minuscola del IX-X secolo) e in effetti in questo manoscritto tutti i numerali di molteplicitagrave sono sormontati da barre Unrsquoeccezione effettiva egrave il De hypotesibus planetarum nel Vat gr 1594 barre sugli interi e apici sulle parti sessagesimali
Fabio Acerbi158
sotto silenzio e la presenza dellrsquoapice la rende inutile88 Si tratta della stessa convenzione diofantea e coincide ancora con la notazione per i numerali ordinali e per le frazioni unitarie che egrave corrente nei mano- scritti matematici greci per questo motivo non percheacute la descrizione sia particolarmente perspicua nessuno dei copisti della recensione an-tica ha incertezze apici Ma questi apici si rintracciano soltanto sulle indicazioni di specie non contemplate dalla descrizione che sono ante-poste ai resti parziali a fianco dei quozienti parziali i segni di specie sono invece trasformati in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordi-nali corrispondenti del tipo πρωτ tavv 5 e 7b-8 Il recensore bizantino taglia invece la testa al toro elimina dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali elimina la seconda menzione della laquolet-tera Araquo contestualmente allrsquoazzeramento dellrsquoespediente della linea a zig-zag (si veda il punto seguente) modifica la descrizione che contiene la prima menzione in quella dellrsquoapice associato direttamente ai nume-rali di molteplicitagrave riciclando addirittura lrsquoalpha per adibirlo a desi-gnare un numero cardinale (come sorprendersi) τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ laquoponendo al di sopra di essi [scil dei 50 minuti primi] 1 solo lsaquoaccentorsaquo acutoraquo La scelta del recensore egrave assennata che rechi una barra o un apice in una tabella un alpha denota un numero non un numero drsquoordine
Secondo problema da tenere ben distinto dal precedente Cosa ci vuole sul segno α per la lettera alpha menzionata nella frase τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquolettera A [hellip] che significa la specieraquo89 Unrsquooc-chiata allrsquoapparato critico rivela una bella incertezza nei manoscritti Z scrive sempre ᾱ e in un caso lo fa anche P MS optano sempre per α´ C per α P scrive nellrsquoaltro caso αο Per quanto solo la barra sia congrua con il senso della frase in quanto la lettera alpha egrave qui menzionata (si tratta di un oggetto che compare nella tabella) e non cambia niente se essa egrave accompagnata dal suo nome di genere στοιχεῖον ad un livello grafico lrsquoincertezza fra il segno ᾱ che denota laquola lettera αraquo e il segno α´ (o lrsquoabbreviazione αο) per una forma di πρῶτος egrave per piugrave versi giustificata
88 Detto in altri termini la barra egrave uno strumento grafico non matematico e quindi la sua presenza non va segnalata mentre un apice lo egrave e la sua presenza lo deve
89 Notare che in questa frase il primo α non vuole la barra (egrave menzionato allrsquointerno di una frase che impiega convenzioni moderne) il secondo sigrave (idem ma con convenzioni antiche) ndash e nella traduzione la scelta di denotarlo con A (senza virgolette) e non con lsquoArsquo (con virgolette) egrave del tutto arbitraria ndash si noti inoltre che le necessarie precisazioni laquosenzacon virgoletteraquo mostrano che le lingue moderne palesano difficoltagrave analoghe a quelle del greco antico per quanto riguarda i livelli denotativi in ambito metadiscorsivo per non usare le due parentetiche avrei dovuto scrivere rispettivamente lsquoArsquo e lsquolsquoArsquorsquo (doppie virgolette semplici)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 159
ᾱ coincide con il numerale 1 α egrave la prima lettera dellrsquoalfabeto ed inoltre α´ egrave esattamente quello che va scritto nella tabella Potremmo dirci che il sostantivo στοιχεῖον chiude la questione la sua presenza congiunta ad un ipotetico α´ renderebbe la descrizione ridondante o inappropriata90 Ma a parte il fatto che α egrave proprio τὸ πρῶτον στοιχεῖον il segno α´ cat-tura in fondo il cuore della descrizione di uno στοιχεῖον ἔχον lsaquoγραμμὴνrsaquo ἀνατείνουσαν
Terzo problema Lrsquoautore dei Prolegomena che si arresta allrsquoesem-pio dei minuti primi non dice quanti apici occorre mettere sulle lettere numerali che identificano gli ordini superiori al primo se uno soltanto come nel caso diofanteo e delle frazioni unitarie o in numero uguale alla loro denominazione (cioegrave pari al numero denotato dal numerale stesso su cui vanno posti) come effettivamente avviene nei mano-scritti dei Prolegomena La tabella egrave quindi sottodeterminata dalla sua descrizione anzi in un certo senso prende il sopravvento su di essa la pratica di marcare i numerali di molteplicitagrave con gli apici che compe-tono allrsquoordine cui appartengono viene trasferita ai segni per gli ordini stessi per supplire ad una descrizione carente di questi ultimi E la tabella egrave sottodeterminata dalla descrizione in quanto egrave la descrizione di una tabella reale ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις laquocome nello lsaquoschemarsaquo espostoraquo leggiamo a un certo punto del testo
3) La linea a zig-zag Non possiamo che applaudire a questo geniale espediente grafico lo troviamo messo in opera solo nel Marc gr 313 Per quanto lrsquoautore non faccia parola di ciograve nel corso della sua descrizione la linea spezzata egrave intesa dover lsquosaltarersquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue Il copista del codice marciano effettua correttamente due salti nella prima delle sue tabelle (tav 4) ma inserisce un lsquodentersquo in piugrave in quella che considera corretta (tav 5) La linea a zig-zag egrave incompatibile con la presenza di linee di giustificazione nella tabella che in effetti mancano nel Marc gr 313 ciograve induce gli errori di allineamento dei primi 5 quozienti parziali di cui egrave vittima il copista Probabilmente per questo motivo in nessuno degli apografi del Vat gr 1594 la linea a zig-zag figura nella tabella inquadrata come si conviene da una (doppia) cornice esterna e le cui colonne sono appunto separate da linee verticali (tav 7b Vat gr 184 f 17v e tav 8 Par gr 2390 f 9v cui egrave sostanzialmente identica la tabella del Marc gr 314 che si trova
90 Trascuro lrsquoabbreviazione αο = πρῶτος percheacute la desinenza non egrave quella richiesta neacute nella frase (egrave richiesto πρῶτον) neacute nella tabella (πρῶτα)
Fabio Acerbi160
al f 248r ndash ma la mancanza di linee orizzontali causa un gigantesco pa-sticcio nel codice vaticano) Alla recensione bizantina che dipende per il suo testo di base dal Vat gr 1594 e quindi non trova la linea a zig-zag nella tabella non resta che sopprimere la sua descrizione ndash ma proprio per questo motivo e finalmente diventa possibile tracciare un apparato completo di linee di giustificazione (tav 9 Laur Plut 89 sup 48 f 14v) Dato che la descrizione di Teone di questo procedimento di divi-sione non fa cenno allrsquoesistenza della linea a zig-zag viene da chiedersi se essa non costituisca un espediente escogitato dallrsquoautore dei Prolegomena per vivacizzare la procedura originale di Pappo
4) Discrepanze tra descrizione e tabella Il gioco delle minime va-rianti mostra che la divisione era stata eseguita (e trasmessa) corret-tamente tutti i valori numerici sono esatti La tabella nel Marc gr 313 presenta perograve alcune discrepanze con la propria descrizione Essa omette (ma non nella versione lsquoscorrettarsquo lrsquoomissione non si riscontra neanche nel Par gr 2390) il segno per laquorestoraquo di fronte ai resti par-ziali ma aggiunge lrsquoindicazione della loro specie Essa trasforma invece come abbiamo visto le indicazioni di specie che seguono i quozienti parziali in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordinali corri-spondenti La descrizione prevede di chiudere la tabella con il risultato καὶ συνάγων ἅπαντα τὰ ἐκ τῶν μερισθέντων μερῶν λεπτὰ σημειοῦται ὑπὸ πάντας οὕτως γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoe raccogliendo tutti i minuti che provengono dalle parti divise lsaquoPapporsaquo nota sotto tutto cosigrave Ris 0 59 8 17 13 12 31raquo ma sotto la tabella tutta la tradizione ci consegna qualcosa di piugrave articolato ὁ ζητούμενος καθ᾽ ὃν μερίζεται ὁ τξε ιδ´ μη´´ π(αρὰ) τὸν τξ γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoil lsaquonumerorsaquo cercato secondo cui 365 14 48 egrave diviso per 360 risulta 0 59 8 17 13 12 31raquo frase che del resto contiene due errori lrsquoinversione del dividendo e del divisore e la confusione tra segno convenzionale (iuxta descrizione) e abbreviazione (come nella frase) nel caso di γι Oltre ad eliminare la linea a zig-zag91 la recensione bizantina sopprime dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali e modifica come abbiamo visto al punto 2 le loro descrizioni in quelle di apici associati diretta-mente ai numerali di molteplicitagrave
91 Le due righe che nella recensione di base contengono solo i resti parziali minori di 160 del divisore ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue sono in parte completate con lrsquoindicazione abbreviata ἀνάλ(υσις) laquoanalisiraquo il termine greco per questa procedura di riduzione In un sussulto di ipercorrettismo matematico tali resti parziali ridotti non sono preceduti dal segno per laquorestoraquo come nel Par gr 2390 ma da quello per laquorisultatoraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 161
Gli esempi che abbiamo discusso mostrano come i problemi di notazione pesino e non poco sullrsquoespressione discorsiva di un algorit-mo matematico lrsquoente di riferimento per lsquoformularersquo il procedimento di divisione fu considerata la tabella cioegrave un oggetto la cui costitu-zione egrave legata piugrave ad una pratica grafica che a considerazioni logico- algoritmiche non la sua descrizione che in effetti finisce per determi-nare la tabella in maniera non univoca Di questa sottodeterminazione si fa testimone la traiettoria che abbiamo cercato di seguire nelle mani di copisti e revisori il procedimento di divisione si modifica a volte in aspetti secondari a volte in punti piugrave sostanziali ndash fino a rendere neces-saria una radicale revisione della sua descrizione per renderla conforme alla tabella ndash in ogni caso mai per ragioni squisitamente matematiche92
Abstract
The article presents and discusses in detail two passages from the anonymous Prolegomena to the Almagest a VIth century primer to the elementary procedures of calculation needed in Ptolemyrsquos Almagest In the two passages we may follow the complex interplay between mathematical notation the auctor who employed and described it the tachygrapher who transcribed it in vivo copyists who reproduced it correctors who modified it Along this path misgivings and errors arise in the transmission of abbreviations and paratextual units such as diagrams tables operational schemes
Fabio AcerbiCNRS UMR8560 Centre Alexandre Koyreacute
fabacerbigmailcom
92 Sono grato a Daniele Bianconi Lucio del Corso Jean Lempire per alcune preziose indicazioni
AOO = Archimedis opera omnia cum commentariis Eutocii ed J L Heiberg I-III Lipsiae 1910-1915
DOO = Diophanti Alexandrini opera omnia cum Graecis commentariis ed P Tannery I-II Lipsiae 1893-1895
GC = Le laquoGrand Commentaireraquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Mogenet ndash A Tihon I-III Cittagrave del Vaticano 1985-1999
iA = Commentaires de Pappus et de Theacuteon drsquoAlexandrie sur lrsquoAlmageste ed A Rome I-III con paginazione continua Cittagrave del Vaticano 1931-1943
HOO = Heronis Alexandrini opera quae supersunt omnia ed G Schmidt ndash L Nix ndash W Schmidt ndash H Schoene ndash J L Heiberg I-V Lipsiae 1899-1914
PC = Le ldquoPetit Commentairerdquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed A Tihon Cittagrave del Vaticano 1978
POO = Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia ed J L Heiberg I-II in 3 parti Lipsiae 1898-1907
RGK = Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600 I Handschriften aus Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln II Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs und Nachtraumlge zu den Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln III Handschriften aus Bibliotheken Roms mit dem Vatikan A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg unter Mitarbeit von D Harlfinger und P Eleuteri B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln Wien 1981-1997 (Oumlsterreichische Akademie der Wissenschaften Veroumlffentlichungen der Kommission fuumlr Byzantinistik III1-3 A-C)
Sigla
Acerbi 2010 = F Acerbi Il silenzio delle sirene La matematica greca antica Roma 2010
Acerbi 2012 = F Acerbi I codici stilistici della matematica greca dimostrazioni procedure algoritmi laquoQUCCraquo 1012 (2012) pp 167-214
Acerbi et al 2010 = F Acerbi ndash N Vinel ndash B Vitrac Les Proleacutegomegravenes agrave lrsquoAlmageste Une eacutedition agrave partir des manuscrits les plus anciens Introduction geacuteneacuterale ndash Parties I-III laquoSCIAMVSraquo 11 (2010) pp 53-210
Agati 1992 = M L Agati La minuscola laquoBouleteacuteeraquo Cittagrave del Vaticano 1992
Belger 1881 = C Belger Ein neues Fragmentum mathematicum Bobiense laquoHermesraquo 16 (1881) pp 261-284
Bianconi 2005a = D Bianconi La biblioteca di Cora tra Massimo Planude e Niceforo Gregora Una questione di mani laquoSampTraquo 3 (2005) pp 391-438
Bianconi 2005b = D Bianconi Tessalonica nellrsquoetagrave dei Paleologi Le pratiche intellettuali nel riflesso della cultura scritta Paris 2005
Bianconi 2006a = D Bianconi Le pietre e il ponte ovvero identificazioni di mani e storia della cultura laquoBizantinisticaraquo 8 (2006) pp 135-181
Bianconi 2006b = D Bianconi Qualcosa di nuovo su Giovanni Catrario laquoMEGraquo 6 (2006) pp 69-91
Cavallo 1977 = G Cavallo Funzione e strutture della maiuscola greca tra i secoli VIII-XI in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Colloque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 95-137
Cereteli 1904 = G F Cereteli De compendiis scripturae codicum Graecorum praecipue Petropolitanorum et Mosquensium anni nota instructorum Sankt-Petersburg 1904
De Gregorio 2000 = G De Gregorio Materiali vecchi e nuovi per uno studio della minu-scola greca fra VII e IX secolo in G Prato (a cura di) I manoscritti greci tra riflessione e dibattito Atti del V Colloquio Internazionale di Paleografia Greca Cremona 4-10 ottobre 1998 Firenze 2000 pp 83-151
Follieri 1977 = E Follieri La minuscola libraria dei secoli IX e X in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Col-loque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 139-165
Fonkič 2005 = B Fonkič Venecianskaia rukopisrsquo laquoAlrsquomagestaraquo Ptolemeja (Marc gr 313690) o datirovke i proischoždenii kodeksa laquoVDIraquo s III 254 (2005) pp 162-167
Fowler 1999 = D H Fowler The Mathematics of Platorsquos Academy A New Reconstruction Second Edition Oxford 1999
Bibliografia
Fabio Acerbi164
Gerstinger ndash Vogel 1932 = H Gerstinger ndash K Vogel Eine stereometrische Aufgaben-sammlung im Papyrus Graecus [sic] Vindobonensis 19996 laquoMitteilungen aus der Papy-russammlung der Nationalbibliothek in Wienraquo Neue Serie Folge 1 Griechische literarische Papyri 1 Wien 1932 pp 11-76
Heiberg 1927 = Mathematici Graeci Minores ed J L Heiberg Kjoslashbenhavn 1927
Hultsch 1876-1878 = Pappi Alexandrini Collectionis quae supersunt ed F Hultsch I-III Berlin 1876-1878
Janz 2003 = T Janz The Scribes and the Date of the Vat gr 1291 in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae X Cittagrave del Vaticano 2003 pp 159-180
Jones 1990 = Ptolemyrsquos First Commentator ed A Jones Philadelphia 1990
Jones 1999 = Astronomical Papyri from Oxyrhynchus ed A Jones I-II Philadelphia 1999
Jones 2005 = A Jones Ptolemyrsquos Canobic Inscription and Heliodorusrsquo Observation Reports laquoSCIAMVSraquo 6 (2005) pp 53-97
Lempire 2014 = Steacutephanos drsquoAlexandrie Le commentaire aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Lempire Louvain 2014
Leurquin 1990 = Theacuteodore Meacuteliteacuteniote Tribiblos astronomique Livre I ed R Leurquin Amsterdam 1990
Leurquin 1991 = R Leurquin Un manuscrit autographe de la Tribiblos Astronomique de Theacuteodore Meacuteliteacuteniote le Vaticanus graecus 792 laquoScriptoriumraquo 45 (1991) pp 145-162
Maas 1927 = P Maas Griechische Palaeographie in A Gercke ndash E Norden (hrsg von) Einleitung in die Altertumswissenschaft I9 Leipzig 1927 pp 69-80
Martinelli Tempesta 2010 = S Martinelli Tempesta Il codice Milano Biblioteca Am-brosiana B 75 sup (gr 104) e lrsquoevoluzione della scrittura di Giovanni Scutariota in A B Garciacutea ndash I Peacuterez Martiacuten (ed by) The Legacy of Bernard de Montfaucon Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting Proceedings of the Seventh Inter-national Colloquium of Greek Palaeography Madrid-Salamanca 15-20 September 2008 Turnhout 2010 pp 171-186
Mazzucchi 1994 = C M Mazzucchi Leggere i classici durante la catastrofe (Costantino-poli maggio-agosto 1203) le note marginali al Diodoro Siculo Vaticano gr 130 Parte prima stratigrafia laquoAevumraquo 68 (1994) pp 164-218
Mioni 1976 = E Mioni Bessarione scriba e alcuni suoi collaboratori in Miscellanea marcia-na di studi bessarionei Padova 1976 pp 263-323
Mioni 1985 = Codices graeci manuscripti Bibliothecae Divi Marci Venetiarum II Thesaurus Antiquus Codices 300-625 recensuit E Mioni Roma 1985
Mogenet 1962 = J Mogenet Une scholie ineacutedite du Vat gr 1594 sur les rapports entre lrsquoastronomie arabe et Byzance laquoOsirisraquo 14 (1962) pp 198-221
Mogenet et al 1983 = Niceacutephore Greacutegoras Calcul de lrsquoeacuteclipse de soleil du 16 juillet 1330 ed J Mogenet ndash A Tihon ndash R Royez ndash A Berg Amsterdam 1983
Mondrain 2002 = B Mondrain Maxime Planude Niceacutephore Greacutegoras et Ptoleacutemeacutee laquoPa-laeoslavicaraquo 10 (2002) pp 312-322
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 165
Mondrain 2004 = B Mondrain Lrsquoancien empereur Jean VI Cantacuzegravene et ses copistes in A Rigo (a cura di) Gregorio Palamas e oltre Studi e documenti sulle controversie teologiche del XIV secolo bizantino Firenze 2004 pp 249-296
Mondrain 2007 = B Mondrain Les eacutecritures dans les manuscrits byzantins du XIV e siegravecle Quelques probleacutematiques laquoRSBNraquo n s 44 (2007) pp 157-196
Peacuterez Martiacuten 2006 = I Peacuterez Martiacuten Maxime Planude et le Diophantus Matritensis (Madrid Biblioteca Nacional ms 4678) un paradigme de la reacutecupeacuteration des textes anciens dans la ldquorenaissance paleacuteologuerdquo laquoByzantionraquo 76 (2006) pp 433-462
Peacuterez Martiacuten 2008 = I Peacuterez Martiacuten El lsquoestilo Hodegosrsquo y su proyeccioacuten en las escrituras constantinopolitanas laquoSampTraquo 6 (2008) pp 389-458
Perria 1991 = L Perria Scrittura e ornamentazione nei codici della laquocollezione filosoficaraquo laquoRSBNraquo n s 28 (1991) pp 45-111
Rollo 2012 = A Rollo LrsquoArchimede di Giorgio Valla in V Fera ndash D Gionta ndash A Rollo (a cura di) Archimede e le sue fortune Atti del Convegno di Siracusa-Messina 24-26 giugno 2008 Messina 2012 pp 99-147
Rome 1927 = A Rome Membra disjecta laquoRBenraquo 39 (1927) pp 187-188
Rome 1938 = A Rome Un manuscrit de la bibliothegraveque de Boniface VIII agrave la Meacutediceacuteenne de Florence laquoACraquo 7 (1938) pp 261-268
Ronconi 2013 = F Ronconi La collection philosophique un fantocircme historique laquoScripto-riumraquo 67 (2013) pp 119-140
Tannery ndash Steacutephanou 1940 = Quadrivium de Georges Pachymegravere ed P Tannery ndash E Steacutephanou Cittagrave del Vaticano 1940
Tihon 2011 = Πτολεμαίου Πρόχειροι Κανόνες Les Tables faciles de Ptoleacutemeacutee vol Ia Tables A1-A2 ed A Tihon Leuven 2011
Traube 1907 = L Traube Nomina Sacra Versuch einer Geschichte der christlichen Kuumlrzung Muumlnchen 1907
Vogel 1936 = K Vogel Beitraumlge zur griechischen Logistik laquoSBAWraquo Mathematisch-natur-wissenschaftliche Abteilung Jahrgang 1936 pp 357-472
Wouters 1979 = A Wouters The Grammatical Papyri from Graeco-Roman Egypt Contri-butions to the Study of the lsquoArs Grammaticarsquo in Antiquity Brussel 1979
F ACERBI Tav 1
b Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 65r
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 284 f 160r
F ACERBITav 2
b Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 13r
a Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 19v
F ACERBI Tav 3
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 136v
F ACERBITav 4
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17r
F ACERBI Tav 5
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17v
F ACERBITav 6
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 7v
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
Fabio Acerbi146
derivare dalla seconda (un caso egrave appunto il segno per ἐλάσσων che probabilmente trae origine da una legatura epsilon-lambda) ma poi il rapporto referente-relato si fissa convenzionalmente Quelli definiti nel testo che abbiamo letto sono appunto segni convenzionali non ci sarebbe bisogno di spiegarne forma e funzione se fossero intesi come abbreviazioni assumono nella tabella una funzione denotativa non esplicativa o discorsiva (come accade invece nella tav 1a) Ma come vengono descritti questi segni
I referenti delle descrizioni sono i segni sono introdotti da οὕτως (item i-ii) o in alternativa da un τό con il ruolo di lsquooperatore di citazionersquo (item iii-iv) che corrisponde esattamente alle nostre virgolette In entram-bi i casi gli enti sono menzionati e svolgono una funzione metalinguistica sono collocati materialmente nel testo ma egrave come se si trovassero fuori e la loro descrizione li additasse ndash in effetti i segni convenzionali scritti nel testo sono a loro volta i relata di quelli che si trovano nella tabella
I relata dei segni scritti nel testo sono di due tipi singoli vocaboli (item i-ii) o descrizioni della funzione dei segni per mezzo di clausole sintaticamente complesse (item ii e iv) I singoli vocaboli sono γίνεται e παρά e sono entrambi preceduti dal τό lsquocitazionalersquo in quanto relata di segni convenzionali le forme abbreviate con cui sono tracciati nei manoscritti vanno forzatamente sciolte Bisogna ammettere che la per-spicacia e le risorse grafiche dei copisti ndash di cui tutto si puograve dire fuor che commettano qui degli errori ndash sono messe a dura prova con lrsquointrodurre segni identici ad abbreviazioni o con lrsquoattivare un gioco metalinguistico particolarmente serrato in un contesto meno lsquonaturalersquo di come potreb-be esserlo ad esempio quello di un trattato grammaticale Lrsquoitem iii che presenta direttamente un segno identico ad unrsquoabbreviazione non egrave sorretto da una descrizione ma da una giustificazione in διὰ τό Lrsquoartico-lo τό vi assume una funzione metalinguistica anche se non lsquocitazionalersquo poicheacute al tempo stesso genera un infinito sostantivato e lo singolarizza per questo ho scritto laquosono sottrattiraquo in corsivo nella mia traduzione
prio modello archimedeo (nota 32 supra) egli ne compila anche una breve lista Un elenco antico di laquosegni della geometriaraquo sicuramente redatto per assistere il copista si trova anche al f 3v del ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 vergato da Efrem negli anni 950-960 (tav 8 in Acerbi 2010) Possiamo farci unrsquoidea quantitativa del guadagno di spazio in rapporto ad un testo privo di abbreviazioni e con le parole separate da spazi sulla base del fragmentum mathematicum Bobiense il testo vi egrave disposto a tutta pagina su 36 righe di circa 30 segni ciascuna nelle due pagine in questione figurano 2038 segni con 15 mezze righe occupate dalle due figure Ora nel testo dellrsquoedizione stabilita in Heiberg 1927 pp 87-90 le stesse pagine contano 4455 segni spazi compresi Ne risulta che la dimensione in caratteri di un testo matematico puograve essere ridotta di piugrave della metagrave con lrsquoimpiego di compendi e segni convenzionali
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 147
Negli item ii e iv il segno si collega ad una descrizione nel secondo caso in via esclusiva le descrizioni pertanto rinforzano o sostituiscono lrsquoidentificazione con lrsquoente linguistico denotato Le clausole descrittive sono precedute da ἀντί e dallrsquoarticolo τό con funzione di lsquooperatore di citazionersquo esse sono παρ᾿ ἃ δεῖ τὸν μερισμὸν γίνεσθαι (item ii) e λοιποὶ οἱ μέλλοντες ἐπιμερίζεσθαι (item iv) Nella descrizione della divisione lsquoalla Papporsquo che leggeremo tra breve i segni negli item iii e iv rice-vono lo stesso trattamento degli altri due il loro relatum egrave un singolo vocabolo e non una clausola descrittiva rispettivamente nelle espres-sioni τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε (sul participio ritorneremo nel punto 1 infra) e τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά (la forma del segno notato con λ οι egrave descritta supra nellrsquoitem iv) La descrizione del segno oslash per il divisore merita una discussione piugrave dettagliata In origine si trovava probabilmente scritto Π(ΑΡΑ)ΕΧΟΝ successivamente letto come π(αρ[α])έχον ndash dato che lrsquoabbreviazione per il preverbo egrave identica a quella per la preposizione (che sia Π᾽ o un pi seguito dal segno per ἄρα a sormontare) ndash invece di π(αρὰ) ἔχον I copisti e i correttori si dettero a tutte le possibili contorsioni per restituire un testo dotato di senso leggere appunto una forma verbale con preverbo modificare il preverbo (ma forse il segno per ἄρα era insidiosamente simile ad uno epsilon) correggere il testo rileggiamo lrsquoapparato sub τὸ παρὰ ἔχον οὕτως τὸ παρέχον οὕτως M et π(αρ-) comp Z οὕτως τὸ περιέχον S τὸ περιέχον οὕτως C προγράφοντας οὕτως ex corr m 2 P Nella clausola descrittiva seguente la presenza liminare di παρὰ (che ho corretto in παρ᾿ ἃ nella speranza di restituire una frase che abbia un senso senza intervenire sul testo) innesca un bel corto circuito il Π(ΑΡΑ) che sicuramente figu-rava nellrsquoarchetipo egrave un sintagma complesso una preposizione unrsquoab-breviazione o un segno per unrsquoabbreviazione Se lrsquoeditore si trova in conflitto con la propria inclinazione alla critica conservativa i copisti si rifiutarono di mettere mano ad un testo che doveva stridere anche per loro essendo il compito demandato al ritocco del revisore del Par gr 2390 o alla riscrittura radicale del recensore bizantino Il problema egrave che ci troviamo di fronte ad unrsquoespressione che descrive la funzione dellrsquooggetto denotato non lrsquooggetto stesso ma che lo contiene al suo interno per soprammercato qui il Π(ΑΡΑ) egrave usato per giustificare una menzione a sua volta relatum di un segno
Evidentemente questa maniera di procedere che giagrave aveva attirato interventi da parte di copisti e correttori della recensione di base parve insostenibilmente opaca allrsquoautore della recensione bizantina61 Egli
61 Uno dei manoscritti di questa recensione propone anche una tabella di divisione
Fabio Acerbi148
modifica tutte le descrizioni diluendo lrsquoidiomatismo dellrsquoarticolo lsquocita-zionalersquo con lrsquointroduzione sistematica del verbo δηλόω e di frasi atte a chiarire quale sia il segno denotante e quale il vocabolo (o il segno) denotato Egli introduce allo scopo di rendere esplicita la funzione de-notativa dei segni introdotti il termine σημείου curiosamente in tutte le sue tre occorrenze esso compare a sua volta nella forma dellrsquoabbrevia-zione per sospensione σΗ´ Egli traccia il segno per i massimi multipli ἀφ e quello per i resti λ οι` in modo che non vi siano ambiguitagrave quanto al loro carattere di abbreviazione Si faccia infine attenzione al residuo di barra sul παρᾱ con funzione denotativa (2 occorrenze) contenuto nella descrizione del segno per il divisore sostituita dallrsquoaccento grave nel παρὰ con funzione discorsiva (la differenza egrave nettissima nei manoscritti da me consultati) Questa osservazione ci permette di passare direttamente allrsquoitem seguente
b) Le barre sui numerali e sulle lettere denotative Egrave opportuno discutere questo punto adesso esattamente percheacute di barre siffatte che pure troviamo in tutti i manoscritti i nostri testi non fanno mai menzione si tratta infatti di una pratica condivisa sin dallrsquoantichitagrave La barra identifica una stringa di lettere dellrsquoalfabeto che non svolge una funzione grammaticale o sintattica propria allrsquointerno del discorso Ciograve avviene in particolare e si tratta della fattispecie piugrave frequente se la stringa di lettere non dagrave origine a un vocabolo della lingua greca lette-re denotative e numerali certo ma anche termini provenienti da altri idiomi e contrazioni di parole greche come i nomina sacra62 tali termi-ni possono essere o no preceduti da un articolo lsquocitazionalersquo a seconda dellrsquouso che ne viene fatto allrsquointerno del discorso Ma non si tratta dellrsquounica fattispecie i papiri grammaticali ed i manoscritti piugrave antichi dei trattati dello stesso argomento segnalano gli esempi delle parti del discorso (cioegrave di lsquoverersquo parole greche) per mezzo di barre sormontanti63 La differenza insomma egrave tra menzione e uso (come parte del discorso in atto) di una stringa di caratteri tra il porre le lsquovirgolettersquo e il non porle tra funzione denotativa e non Apparentemente la convenzione si limi-
corredata dei segni opportuni e contrariamente alle indicazioni della descrizione svilup-pata lsquoin verticalersquo ma per motivi misteriosi non completa (tav 7a Laur Plut 89 sup 48 f 13r)
62 Tutto ciograve egrave spiegato con estrema chiarezza giagrave in Traube 1907 pp 45-4763 Si veda il Par gr 2548 codex vetustissimus e testimone unico delle lsquoopere minorirsquo
di Apollonio Discolo il f 106v con le barre ben visibili egrave riprodotto come tav 19 in De Gregorio 2000 (ivi pp 137-138 per la datazione) Per la testimonianza dei papiri grammaticali si veda Wouters 1979 passim essi contengono di norma elenchi di parti del discorso nessuna delle quali egrave preceduta dallrsquoarticolo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 149
tava in questo secondo caso a segnalare con la barra singoli vocaboli le menzioni di frasi o di sintagmi complessi sono di norma identificate dallrsquoarticolo lsquocitazionalersquo Drsquoaltra parte le abbreviazioni convenzionali non rientrano nella casistica percheacute la loro resa grafica che contiene elementi non alfabetici come compendi per desinenze lettere supra li-neam marche di contrazione o sospensione quali slashes o barre sotto-poste o sormontanti eventualmente solo un sottinsieme della stringa di segni alfabetici le esclude automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
Venendo al discorso matematico una barra sormonta senza ecce-zione le lettere denotative64 che sia in papiri o in manoscritti in maiu-scola65 o minuscola ma solo allrsquointerno del testo comrsquoegrave da attendersi nei diagrammi esse la perdono per il semplice motivo che non crsquoegrave alcun testo ambiente un diagramma ha unicamente una funzione denotati-va Drsquoaltra parte le lettere numerali che a volte figurano nei diagrammi della tradizione metrica66 allo scopo di indicare la lunghezza dei seg-menti mantengono la barra in un diagramma il contesto denotativo geometrico egrave prevalente e i numerali vengono percepiti come entitagrave grafiche lsquoesternersquo al discorso Va da seacute a fortiori che le lettere numerali inserite in un testo dovranno essere segnalate da barre che a loro volta non servono nelle tavole67 in quanto queste ultime sono come abbiamo visto un vero e proprio testo che perograve funge da ambiente a quello al-fabetico limitato alle titolazioni e non a caso tracciato in unrsquoopportuna lsquomaiuscola distintivarsquo allo scopo di segnalarne il carattere denotativo e non discorsivo68 Una tabella operazionale egrave invece un paratesto e quindi le barre sulle lettere numerali che rappresentano gli interi sono
64 La notazione per le lettere denotative subigrave unrsquoevoluzione (il cui risultato finale egrave descritto per sommi capi nella nota 3 supra) di cui non mette conto occuparsi qui
65 I papiri di contenuto geometrico (o astronomici ma che presentano argomenti geometrici) sono rari si vedano il PHerc 1061 (sec II aC Demetrio Lacone De geome-tria) e il PFay 9 (sec II ex Elementi I 39 e 41) Gli importanti ostraka OBerl 12002 e 12609 (sec III aC m Elementi XIII) non pongono le barre sopra le lettere denotative Per i manoscritti in maiuscola si veda ad esempio passim nel Par gr 2389 una cui riproduzione digitale egrave consultabile in rete allrsquoindirizzo httpgallicabnffrark12148btv1b8470171d o il fragmentum mathematicum Bobiense
66 Si veda ancora il ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 codex unicus dei Metrica di Erone e contenente una raccolta importante di problemi del corpus metrologico
67 Si vedano come esempio le tavole citate alle note 10 e 14 supra Discorso a parte per il segno di lsquoposto vuotorsquo si veda il punto c che segue
68 Queste regole generali vanno prese cum grano salis si dagrave naturalmente un certo dominio di variabilitagrave legato verosimilmente al grado di cultura grafica del copista nel PMich III 144 i numerali sono quasi tutti senza barra sia nel testo che nelle tabelle ope-razionali
Fabio Acerbi150
necessarie esse mancano invece sui segni convenzionali che ho descrit-to nel punto precedente e fatto rilevante sulle lettere numerali relative agli ordini sessagesimali quando esse siano identificate da uno o piugrave apici la presenza di questo segno grafico non alfabetico69 le esclude ancora una volta automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo Unrsquoultima osservazione che ci saragrave utile nel seacuteguito la descrizio-ne di una stringa di lettere lsquoagrammaticalersquo non puograve prevedere la men-zione della presenza della barra che le pertiene in quanto tale si tratta di una pratica denotativa che egrave possibile formulare soltanto ad un livello di discorso superiore sia a quello dellrsquouso che a quello della menzione70
c) Il segno di lsquoposto vuotorsquo Si noti nella tav 2b la forma ŏ per il segno di lsquoposto vuotorsquo in un ordine sessagesimale coerentemente con la propria notazione il copista del Marc gr 313 lo scioglie talvolta allrsquoin-terno del testo principale come unrsquoabbreviazione per οὐδέν laquonienteraquo Altre convenzioni di scrittura del tratto che accompagna il circoletto e che si badi bene fa parte integrante del segno di lsquoposto vuotorsquo ndash e infatti nelle tavole troviamo sempre il segno completo mentre tutti gli altri numerali sono come abbiamo visto nel punto precedente privi di barra o di apice a causa del fatto che i vari ordini sessagesimali sono univocamente determinati dalle linee di giustificazione ndash un tratto an-golare anteposto (tav 3 Lar Plut 2818 f 136v)71 o una semplice barra a sormontare (tavv 4-9) si produce in questo modo il segno 65926 che sembra essere stata la forma di base72
69 Occorre dunque supporre come testimoniano papiri e manoscritti in maiuscola che la convenzione relativa allrsquouso della barra si sia consolidata ben prima dellrsquointroduzione di segni diacritici quali accenti e spiriti
70 Si veda il punto 2 infra per maggiori dettagli sulla questione delle barre e degli apici e per le indicazioni in merito che leggiamo in Diofanto
71 Come accennato questa tavola dei sottomultipli coincide con quella descritta ed esposta nei Prolegomena Fatto molto rilevante i numerali nella prima non recano neacute barre neacute apici contrariamente a quanto accade a tutte le istanze della seconda nei manoscritti Quella del Laur Plut 2818 preserva a mio avviso la forma originaria come abbiamo visto una tavola non richiede segni aggiuntivi sulle lettere numerali
72 Si vedano come esempio ancora le tavole citate alle note 10 e 14 supra oppure per una rassegna delle forme che il segno assume nei manoscritti piugrave antichi delle Tavole facili Tihon 2011 pp 58-59 e per quelle che assume nei papiri Jones 1999 I pp 61-62 Ovviamente non possiamo leggere il segno 65926 come un omicron con una barra in quanto ο = 70 nella notazione greca e la barra egrave di rigore quando il numerale figuri allrsquointerno di un testo Occorre ammettere che si dagrave origine ad un bel corto circuito notazionale con il concepire un segno con funzione di lsquoposto vuotorsquo ma che lsquosomigliarsquo ad una lettera dellrsquoalfabeto sormontata da una barra cioegrave ad un numerale in piugrave quando il lsquoposto vuotorsquo non corrisponda ad un intero ma ad una specie sessagesimale la presenza della barra a priori indistinguibile da quella che sormonta gli interi introduce unrsquoincongruenza con la notazione a mezzo di apici vista nellrsquoitem precedente
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 151
d) Errori di copia La tabella riprodotta nella tav 2b ha una forma simmetrica ma si tratta di una forzatura il grande rettangolo in basso a destra drsquoaltronde assente nella descrizione contiene uno scolio che fa notare come lrsquoultimo resto parziale ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ͵γτνζ´´´´´ κζ´´´´´´ cioegrave 0 0 0 0 0 3357 27 siano ἔγγιστα λ´λ´ δ´δ´ ξ laquocon ottima approssimazione 60 minuti quartiraquo dove si notino gli apici semplici per indicare il pas-saggio allrsquoordinale e il raddoppiamento del sistema segno + apice per significare il plurale Lo scolio debitamente accompagnato dal segno di rimando in forma di simbolo solare egrave stato probabilmente incluso nella tabella proprio allo scopo di renderla simmetrica A sua volta un errore precedente spiega lo spazio eccessivo accordato al rettangolo contenente lo scolio il secondo massimo multiplo ŏ λβ´ ξδ´´ ριβ´´´ σιϛ´´´´ egrave trascritto anche al di sotto del risultato
Passiamo ora alla descrizione del metodo di divisione attribuito a Pappo
ἵνα οὖν ταῦτα συναχθῇ τὰ ἐκ τοῦ μερισμοῦ ὁ εἰρημένος Πάππος εὐδιατύπῳ τινὶ καὶ πρὸς τοῦτο τάξει χρησάμενος ποιεῖται τὴν τῆς συλλήψεως τοῦ ζητουμένου ἀνεύρεσιν οὕτως ἐκθέμενος γὰρ τὸν μέλλοντα μερίζεσθαι τουτέστι τὰς τξ μοίρας ἐν ἀρχῇ ἀφαιρεῖ ἀπ᾽ αὐτῶν τὸν ἐν τῇ σελίδι τυγχάνοντα ἐλάττονα τουτέστι τὸν τδ κβ´ κ´´ ὄντα τῶν ἐγγὺς ἐλασσόνων ὡς πρὸς τοὺς ἐκκειμένους διὸ καὶ γράφει αὐτὸν προγράφων αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε καὶ εὑρίσκων τὰ παρακείμενα αὐτῷ τῷ ἀπογραφέντι ἐν τῷ σελιδίῳ λεπτὰ πρῶτα ν´ συναπογράφεται παρατιθῶν αὐτοῖς τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον ἀνατείνουσαν σημαῖνον τὸ εἶδος ὅτι πρῶτα λεπτά εὑρίσκει οὖν οὕτως τὸ τῶν τξ μέρος τὸ τδ κβ´ κ´´ ὃ μεριζόμενον παρὰ τὰς τξε ιδ´ μη´´ ἡμέρας καὶ ποιοῦν τὸν ἐκ τοῦ μερισμοῦ ἀριθμὸν πρῶτα λεπτὰ ν´ καὶ τὸν λοιπὸν ἀπογραφόμενος τὸν νε λζ´ μ´´ προτάσσει αὐτοῦ τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά τάσσει δὲ καὶ ἁπλῆν τινα διατείνουσαν γραμμὴν ὡς ἀπὸ τοῦ τξ ἐπὶ τὸν ἑξῆς ἐκτεθειμένον ἐγγὺς
1
5
10
1 εὐδιατύπῳ] ZSPC εὐδιατύπωτ M 4 ἀφαιρεῖ] MZSP ἀφ ι C 5 ἐλάττονα] P comp MZSC 6 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | αφ ] αφ ε M ἀφ ZS ἀφαί P ἄφ C | ἀντὶ] om C | ἄφελε] MZSP ἄφ C 8 ἀπογραφέντι] MZSP ἐγγραφέντι C | λεπτὰ πρῶτα] P λε πρωτα SC λεπτῶν πρωτ MZ | παρατιθῶν] MZS παρατιθεὶς C et ex corr m 2 P 9 ᾱ] Z αο P α´ MS α C | ἔχον] MPC ἔχων ZS 9-10 πρῶτα λεπτά] ZP πρωτ λ´λ´ M πρωτα λε S αα λε C 11 ἡμέρας] comp codd | ἀριθμὸν] P et comp MZ καὶ C et comp S 12 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M πρωτ λεπτ(α) Z πρωτ λ εᾱ S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C | ἀπογραφόμενος] MZSP ἐγγραφόμενος C | νε λζ´] MZSP λζ νζ C 13 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | λ οι] MZSC ex λ fecit λ οι P | προσσημαῖνον] MC et προσ- comp ZS προση- P | τὸ] MZC τὰ S et fecit m 2 P 14 ἀπὸ] MZSP πρὸς C ἐλάττονα] P comp MZSC
1 εὐδιατύπῳ] εὐδιατυπώτω K 6-7 αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ] τὸ ἀφ K 8 παρατιθῶν mdash 10 λεπτά] τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ σημαίνουσαν τὸ εἶδος αὐτῶν ὅτι ᾱ λεπτά εἰσιν K | τὸ (sec)] τὰ K 12 πρῶτα] πρώτων K | τε λ ] λ οι` K | προσσημαῖνον mdash
Fabio Acerbi152
ἐλάττονα τὸν τδ κβ´ κ´´ ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις καὶ ταύτην ἐπιδεικνύουσαν τὴν τάξιν τῆς προόδου τῆς ἐκθέσεως ἧστινος κλωμένης γραμμῆς πρὸς τῷ ἐγγὺς ἐλάσσονι ἡ ἀντανάκλασις ἐπὶ τὸν λοιπὸν γέγραπται φερομένη ὡς εἴρηται διὰ τὸ εὔτακτον τῆς προκοπῆς οὕτως τε ποιήσας ἑξῆς τὸ αφ ποιῶν ὃ προσσημαίνει ὡς εἴρηται τὸ ὅτι δεῖ ἀφελεῖν ὁμοίως ἀπὸ τοῦ λοιποῦ καὶ δὴ τὸν ἐγγὺς πάλιν ἐλάσσονα ὡς πρὸς τὴν ἐν τῷ σελιδίῳ ἔκθεσιν εὑρισκόμενον λαμβάνων ἑξῆς προγράφει αὐτὸν ὄντα νδ μζ´ ιγ´´ ιβ´´´ καὶ εὑρίσκει αὐτοῖς παρακείμενα ἐν τῷ σελιδίῳ πρῶτα λεπτὰ θ´ ἅτινα καὶ αὐτὰ προσαπογράφεται σὺν τῇ παρασημειώσει τῶν πρώτων γράφων τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον τὴν ἀνατείνουσαν καὶ ὡς εἴρηται τὴν γραμμὴν πάλιν διὰ τὴν τάξιν κλωμένην κατὰ δευτέραν κλάσιν προσέλκει γινομένου τοῦ μέρους αὐτῆς τούτου παραλλήλου τῷ ἐξ ἀρχῆς
16 ante κλωμένης add ἐπὶ C 18 τε] MZP om SC | αφ ] M ἀφ ZSC ἀφαί P 19 προσσημαίνει] MS προση- ZC et ex corr P | ὅτι] ZP comp MSC 20 δὴ] MZSC διὰ fecit m 2 P 21 πρὸς] MSP et supra lineam C ex ἀπὸ fecit m 2 Z | ιγ´´] MZSP νγ´´ C 22 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M ᾱᾱ λεπτὰ Z άάα λε S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C 23 προσαπο- γράφεται] απο suprascr in comp M 24 ᾱ] ZP α´ MS α C 25 κλάσιν] MP τάξιν ZSC | τοῦ] ZSPC τούτου M 26 τούτου] τοῦ bis ZSPC sed prius erasit m 2 P τοῦ M
mdash 18 προκοπῆς] om K | τε ποιήσας] ποιήσας καὶ K | αφ ] ἀφ K 19 τὸ] om K 21 προ-γράφει] γράφει K 22 σελιδίῳ] α´ σελιδίῳ K | ἅτινα] ἃ K 23 προσαπογράφεται] ἀπογράφεται K | τῶν πρώτων mdash 26 ἐξ ἀρχῆς] om K
lsquoAllo scopo di raccogliere ciograve che risulta dalla divisione il detto Pappo utilizzando anche in questo caso una certa disposizione ben strutturata determina nel modo seguente il lsaquonumerorsaquo cercato preso nel suo insieme collocando73 in testa il lsaquonumerorsaquo che sta per essere diviso cioegrave i 360 gradi iniziali sottrae loro tra i piugrave prossimi dei lsaquonumerirsaquo minori rispetto a quelli esposti quello che si trova essere minore nella colonna (cioegrave 304 22 20) Questo egrave il motivo per cui lo trascrive scrivendogli davanti lrsquoabbreviazio-ne laquosottrraquo per laquosottrairaquo e trovando che 50 minuti primi sono collocati accanto a quello stesso lsaquonumerorsaquo che egrave stato trascritto nella colonna li trascrive al tempo stesso collocando accanto74 ad essi la lettera A con un lsaquotrattorsaquo75 sopra che significa la specie minuti primi Trova dunque in que-sto modo la parte di 360 che egrave 304 22 20 la quale divisa per 365 giorni 14 48 fa il numero lsaquoche risultarsaquo dalla divisione 50 minuti primi Trascrivendo
73 La descrizione egrave strutturata come una procedura Acerbi 201274 Il purismo del correttore del Par gr 2390 di Clostomalle nel Marc gr 314 e
dellrsquoautore della recensione bizantina impone loro di modificare la terminazione ma forme tematiche e contratte di τιθεῖν sono correnti nel greco tardivo
75 Il testo greco ha solo il participio con γραμμήν sottinteso Per il significato del participio si veda il punto 2
15
20
25
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 153
poi il resto 55 37 40 gli pone altresigrave76 a prefisso laquoReraquo che significa laquorestiraquo e dispone anche una certa linea semplice77 che va da 360 al piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori che egrave esposto di seacuteguito 304 22 20 come nello lsaquoschemarsaquo esposto linea che mostra lrsquoordine del percorso dellrsquoesposizione Questa linea spezzata lagrave dove si trova il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori egrave tracciata inflessa allrsquoindietro lsaquoersaquo punta verso il resto come egrave stato detto in vista di una progressione ordinata E cosigrave facendo prendendo di seacuteguito il laquosottrraquo che significa come egrave stato detto laquoche occorre similmente sottrarre dal re-storaquo e ovviamente prendendo di nuovo il lsaquonumerorsaquo che egrave trovato essere il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori in relazione alla disposizione nella colonna ndash 54 47 13 12 ndash lo scrive di seacuteguito e trova che 9 minuti primi sono posti loro accanto nella colonna trascrive78 anche questi con la segnaletica dei primi scrivendo la lettera A con un lsaquotrattorsaquo sopra e come egrave stato detto prolunga di nuovo la linea spezzata in vista di una buona disposizione tramite una seconda inflessione essendo questa sua parte parallela a quella inizialersquo
La descrizione continua con una serie di laquoe cosigrave viaraquo e non fa ulte-riore riferimento alla tabella
1) La forma verbale ἐξεσμένον Egrave il neutro del participio perfetto medio-passivo di ξέω lett laquopialloraquo laquolevigoraquo Si danno tre possibilitagrave si tratta di un termine canonico per quanto non altrove attestato per designare unrsquoabbreviazione oppure lrsquoautore anonimo improvvisa sul piano metaforico come se unrsquoabbreviazione non fosse altro che la paro-la completa lsquoaccorciata a colpi di piallarsquo in maniera opportuna oppure il testo egrave corrotto e srsquoimpone una correzione ad esempio τὸ ἑξῆς μένον laquociograve che sta di seacuteguitoraquo Questrsquoultima strada mi pare chiusa dal senso delle frase lrsquoabbreviazione non lsquosta di seacuteguitorsquo a niente ma anzi precede la perifrasi τὸ ἑξῆς μένον se impiegata semplicemente per rimandare al segno αφ immediatamente seguente costituirebbe un intollerabile solecismo Se accettiamo la prima di queste letture considerando quin-di lrsquoabbreviazione αφ in posizione predicativa abbiamo a che fare con
76 Rendo in questo modo il τε isolato77 La linea egrave laquosempliceraquo in quanto egrave una retta la precisazione intende evidenziare per
anticipazione il carattere lsquonon semplicersquo che essa assumeragrave alla prima inflessione quando diventeragrave una spezzata linee siffatte erano in effetti concepite dallrsquoanonimo e prima di lui da tutta la tradizione matematica greca come una singola linea spezzata nei punti drsquoinfles-sione I due segmenti paralleli menzionati al termine del passo sono orizzontali
78 Il verbo egrave al medio in variatio rispetto ai due che precedono e che seguono egrave il matematico che lsquosirsquo trascrive le cifre
Fabio Acerbi154
uno hapax semantico nella grecitagrave superstite come egrave facile verificare con una ricerca sul TLG in rete La recensione bizantina risolve il pro-blema sopprimendo semplicemente τὸ ἐξεσμένον
2) La notazione per le specie numeriche Nella terminologia matema-tica greca gli ordini sessagesimali sono εἴδη laquospecieraquo numerici essi corri- spondono agli ordini di grandezza nel nostro sistema decimale e indica-no in analogia con il caso geometrico la lsquoformarsquo che assume un numero quadrato cubo ecc Centinaia e migliaia sono quindi degli εἴδη rispet-tivamente quadrati (100 egrave il quadrato di 10) e cubi (1000 egrave il cubo di 10) sono specie numeriche ma non numeri particolari e drsquoaltronde 300 non egrave un quadrato ma 3 item dellrsquoεἶδος lsquoquadratorsquo 100 3 egrave il numerale di molteplicitagrave della specie quadrata lsquocentinaiarsquo i due 0 che seguono il 3 segnalano esattamente questo fatto che la notazione greca per gli interi non posizionale fa scomparire al livello denotativo Ciograve non vale soltan-to per i numeri interi ma anche per le loro parti i minuti secondi appar-tengono alla specie lsquoquadratorsquo in quanto 13600 egrave il quadrato di 160
La concezione appare interamente dispiegata nellrsquointroduzione degli Arithmetica diofantei79 che si rivela giova farlo rimarcare un te-stimone fondamentale per la ricostruzione della notazione matematica antica Alle specie usate in questrsquoopera vengono assegnati una denomi-nazione ed un segno convenzionale costituito dallrsquoiniziale (di ognuno dei componenti) della denominazione al quadrato o δύναμις il segno ΔΥ al κύβος il segno ΚΥ alla lsquoquarta potenzarsquo o δυναμοδύναμις il segno ΔΥΔ ecc La descrizione di tali segni egrave del tipo καὶ ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον Κ ἐπίσημον ἔχον Υ ΚΥ κύβος laquoe il suo segno egrave un Κ che ha come indice un Υ ΚΥ cuboraquo dove in accordo con quanto abbiamo visto nel punto b supra e pur nel comprensibile imbarazzo del copista della prima parte del Matritensis (o di un suo passato collega) a districarsi in questo formidabile ginepraio notazionale80 le due lettere Κ e Υ ricevono una barra mentre ΚΥ non la richiede a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον il quale ancora una volta esclude automaticamente il segno dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
79 In particolare a DOO I pp 214-62180 Nel Matr 4678 riscontriamo i seguenti fenomeni nelle poche righe a cavallo dei ff
58r-v 1) accento acuto posto su tutti i segni come se fossero abbreviazioni 2) ripetizione sistematica segnodenominazione come in ΚΥ κύβος appena letto dovuta sicuramente allrsquointrusione di glosse interlineari esplicative dei segni ndash e successivo pentimento (δύναμις e κύβος sono in effetti cancellati dalla prima mano il primo con un tratto il secondo con dei punti supra lineam poi il copista si stanca di correggere) 3) nella descrizione del segno per la δυναμοδύναμις menzione di un δέλτα δύο che saragrave molto probabilmente stato ΔΔ subito dopo nella descrizione del κυβόκυβος si legge un incongruo δύο KK
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 155
Diofanto introduce poi dei segni anche per le specie delle parti dellrsquounitagrave (le nostre frazioni) che egli chiama ὁμώνυμα μορία laquoparti omonimeraquo di cui quelle sessagesimali sono casi particolari81 Egli spie-ga appunto che le loro denominazioni sono ottenute da quelle delle specie degli interi per sinonimia passando ad un lsquoordinalersquo82 formato semplicemente aggiungendo il suffisso -στον δυναμοστόν κυβοστόν δυναμοδυναμοστόν ecc (sott μόριον) I loro segni convenzionali sono invece ottenuti da quelli per le specie degli interi aggiungendo una γραμμὴν διαστέλλουσαν τὸ εἶδος laquolinea che distingue la specieraquo83 Una linea sui segni delle specie delle parti egrave richiesta si badi bene per distinguerli dai segni di quelle degli interi come giagrave osservato questi ultimi sono giagrave lsquoagrammaticalirsquo a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον a fortiori lo saranno anche i primi Si tratta della traduzione semio-tica del passaggio dal cardinale allrsquoordinale che a livello grammaticale egrave effettuato con il suffisso -στον Che forma ha questa linea Barra o apice (Egrave cervellotico pensare a forme piugrave complesse) La domanda non ammette una risposta immediata in quanto delle specie diofantee nessuno piugrave si occupa nellrsquoantichitagrave84 Se egrave vero che la prima risposta darebbe origine ad un conflitto tra due convenzioni denotative diffe-renti la barra lsquocitazionalersquo e la barra che distingue la specie lrsquoevidenza grafica del Matritensis lascia lievemente sgomenti (ricordiamoci che giagrave i segni di base sono indebitamente dotati di un accento dal copista) Le poche occorrenze del segno per le specie delle parti85 vedono lrsquoaggiunta di uno slash di sospensione di un doppio apice inverso ndash in tutta evi-
81 Questo fatto era giagrave chiaro nellrsquoantichitagrave Teone in Alm I 10 in iA p 45310-1682 Il parallelo con i cardinali e gli ordinali relativi agli interi egrave reso esplicito da Dio-
fanto ὥσπερ δὲ τῶν ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια παρομοίως καλεῖται τοῖς ἀριθμοῖς τοῦ μὲν τρία τὸ τρίτον τοῦ δὲ τέσσαρα τὸ τέταρτον οὕτως καὶ τῶν νῦν ἐπονομασθέντων ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια κληθήσεται παρομοίως τοῖς ἀριθμοῖς laquocome le parti omonime dei numeri sono chia-mate per assonanza con i numeri di lsquotrersquo lsquolsaquounrsaquo terzorsquo di lsquoquattrorsquo lsquolsaquounrsaquo quartorsquo cosigrave le parti omonime dei numeri appena nominati saranno chiamate per assonanza con i numeriraquo (DOO I p 69-13 si noti lrsquoarticolo lsquocitazionalersquo al singolare in τοῦ τρία e τοῦ τέσσαρα) Il parallelo prosegue anche al livello dei segni che rappresentano queste specie come vedremo tra un attimo
83 Diofanto Arithmetica prefazione in DOO I p 620-21 un passaggio maltrattato in questa edizione occorre espungere il participio ἔχον senza introdurre segni ulteriori oppure eliminare un precedente ἐπί come fa un correttore del Matritensis f 58v
84 Unica parzialissima eccezione lrsquoaccenno di Teone menzionato nella nota 81 supra85 Al f 59r e per di piugrave nel margine per sanare un lungo saut du mecircme au mecircme La
collocazione in margine egrave il motivo per cui troviamo una notazione abbreviata nel resto del trattato il primo copista scioglie tutti i segni prendendoli per abbreviazioni mentre il secondo elimina sistematicamente il tratto aggiuntivo delle specie delle parti dellrsquounitagrave Drsquoaltronde egli scrive ad esempio ΔΥ invece di ΔΥ ed egrave quindi indotto a porre la barra al di sopra della stringa di lettere risultante (passim ma si veda ad esempio il f 72r)
Fabio Acerbi156
denza il compendio per la desinenza -ον accentata il copista interpreta il segno come unrsquoabbreviazione ndash e di una barra a sormontare lo Υ Potremmo forse interpretarlo come il segno di contrazione del grafema -στ- lrsquounico tassello mancante in unrsquoabbreviazione come ad esempio (δυναμοδυναμο)(στ)(ὸν) ma uno scolio di prima mano al f 58v rela-tivo alle specie degli interi inficia questrsquoipotesi esse sono dotate di slash di sospensione accento acuto in un caso del compendio canonico per la terminazione -ον hellip ma tutti gli Υ a esponente sono a loro volta sormontati da una barra
Meno legata al singolo manoscritto ma nondimeno non uniforme si presenta la pratica di notazione dei segni che rappresentano gli enti numerici sessagesimali86 da una parte sta lrsquoevidenza del testo dei Pro-legomena e delle sue tabelle apici ndash drsquoaltronde come abbiamo visto la notazione universalmente impiegata per i numerali ordinali e per le fra-zioni unitarie ndash dallrsquoaltra sta lrsquoevidenza del testo dellrsquoAlmagesto in tutti i manoscritti piugrave antichi e lo stesso si dica del commentario teonino a questrsquoopera o del suo lsquoGrande commentariorsquo alle Tavole facili e dei testi astronomici su papiro barre87 Sembra insomma che la nostra docu-
86 Sia le molteplicitagrave che le specie ahimeacute entrambe rappresentate da lettere dellrsquoalfabeto Come osservato allrsquoinizio della sezione 3 ci sono in effetti due tipi di lettere numerali in gioco se facciamo astrazione da apici o barre lsquo4 minuti secondirsquo si trova scritto δ β la prima lettera numerale denota la molteplicitagrave degli item di una certa specie la se-conda la specie nei Prolegomena entrambe sono accompagnate da un doppio apice il che rende inutile la presenza delle seconde Si noti che la descrizione della tabella non fa parola della notazione da usare per le lettere numerali che denotano la molteplicitagrave barre o apici e quanti apici hellip In questo caso fa interamente fede la tabella cioegrave la pratica grafica condivisa instauratasi non egrave chiaro quando
87 I manoscritti piugrave antichi dellrsquoAlmagesto sono menzionati nella nota 10 supra quelli dei due commentarii teonini sono il Laur Plut 2818 e il celeberrimo Vat gr 190 (sec IX in Euclide Elementi Data Teone lsquoGrande commentariorsquo) per la notazione dei pa-piri astronomici si veda Jones 1999 II passim La notazione non sembra lsquoinquinatarsquo dalla pratica dei copisti bizantini e pare dipendere soltanto dalla data di composizione Tro-viamo ad esempio barre sopra tutti i numerali di molteplicitagrave (interi o sessagesimali) nel frammento di un commentario alle Tavole facili contenente un calcolo relativo al 24 aprile 213 (Par gr 2841 sec XIII ex-XIV in oltre al frammento ai ff 32r l 11-34v l 23 contiene Arato Phaenomena ed Efestione Apotelesmatica edizione in Jones 1990) Nel commentario alle Tavole facili composto ca 610-617 ed attribuito a Stefano di Alessandria la situazione egrave la seguente (Jean Lempire per litteras per lrsquoedizione si veda Lempire 2014 ho controllato il Vat gr 304 ff 135r-171v sec XIV am contiene in aggiunta Teone in Almagestum I-II lsquoPiccolo commentariorsquo alle Tavole facili Diofanto Arithmetica e De polygo-nis numeris varia astronomica tabulae) barre sopra gli interi sporadicamente rimpiazzate da apici apici sopra le parti sessagesimali in numero uguale alla denominazione doppio () apice per le frazioni unitarie Sono impiegate barre sopra gli interi e apici sopra le parti sessagesimali nei manoscritti principali di tutti i trattati di introduzione allrsquoAlmagesto o comunque di argomento logistico redatti in epoca bizantina Giorgio Pachimere (1242-ca 1310) Quadrivium (autografo nel manoscritto Roma Biblioteca Angelica gr 38 [RGK III nr 115] si veda Tannery ndash Steacutephanou 1940 per lrsquoedizione) Teodoro Metochita (1270-
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 157
mentazione si faccia testimone di un cambio notazionale avvenuto nel periodo intercorrente fra Teone (sec IV pm) e la scuola alessandrina di Ammonio e dei suoi allievi (sec VI in) e probabilmente innescato da questrsquoultimo ambiente lrsquoaspetto paradossale egrave che nello stesso codice si rintraccino due notazioni differenti per gli enti numerici sessagesimali e lrsquouna (apici) sia adottata sistematicamente e coerentemente in uno scritto (i Prolegomena) che si presenta esattamente come unrsquointroduzione tecnica alla pratica numerico-algoritmica del trattato (lrsquoAlmagesto) in cui egrave adottata lrsquoaltra (barre che ritroviamo senza eccezioni anche negli scolii)
Torniamo ai Prolegomena la descrizione del segno da porre a fianco di ogni singolo quoziente parziale e denotante la sua specie numerica (minuti primi minuti secondi ecc) solleva tre problemi
Primo problema Ci vuole una barra o un apice su τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquola lettera A [hellip] che significa la specieraquo quando lo scriviamo nella tabella Tutta la nostra discussione precedente fa pro-pendere per lrsquoapice e si ricordi anche la forma verbale ἀνατείνουσαν che suggerisce qualcosa che si lsquoestende verso lrsquoaltorsquo (la mia traduzione egrave volutamente neutra) se fosse apposta una barra la cosa dovrebbe passare
1231332) Compendium astronomicum (copia lsquoautorizzatarsquo coeva nei Vat gr 182 e 181 da parte del copista che integrograve le parti mancanti del Par gr 2389 [ff 207-210 255-270 374-375] Bianconi 2005a pp 425-427 Peacuterez Martiacuten 2008 p 436 e n 177) Teodoro Meliteniota (morto lrsquo831393) Tribiblos astronomica (autografo nel Vat gr 792 si vedano Leurquin 1991 per unrsquoanalisi del manoscritto Leurquin 1990 per lrsquoedizione) una com-pilazione anonima (per cui ho consultato il Par gr 2396 ff 87r-92v limitatamente a questi fogli manu Costantino Trivoli [RGK II nr 318 ma ovviamente questo codice non vi egrave segnalato] terzo quarto del XV secolo il resto del codice annotato da Niceforo Gregora egrave di etagrave planudea e parzialmente [ff 33v-76v] un autografo di Planude stesso contiene Teone in Almagestum I II IV Mondrain 2002 il codice va completato ndash limitatamente a stralci dei libri VIII-X XII-XIII del commentario teonino la cui parte intermedia si egrave persa ndash con 26 carte [ff 123-147] inserite nel Vat gr 1087 anchrsquoesso contenente anno-tazioni di Gregora Rome 1927 per la figura del copista dei ff 77r-86r del Par gr 2396 e dei ff appena nominati del Vat gr 1087 un anonimo collaboratore di Gregora si veda in ultimo Bianconi 2006a pp 147-151) si veda anche il calcolo effettuato da Niceforo Gre-gora (12921295-13581361) dellrsquoeclisse di sole del 16 luglio 1330 (attestata unicamente ai ff 1r-8v della miscellanea astronomica Marc gr 325 databile ca 1324-1329 in parte vergata e ovunque fittamente annotata da Gregora stesso edizione del testo in Mogenet et al 1983 annotazioni di Gregora elencate in Bianconi 2005a p 413) Unrsquoeccezione apparente il lsquoPiccolo commentariorsquo di Teone alle Tavole facili le parti sessagesimali sono segnalate da apici (ad esempio nel Vat gr 175 vergato da Giovanni Catrario e completato nel 1321-1322 sulla figura di Catrario si vedano in ultimo Bianconi 2005b pp 141-156 e 2006b) lrsquoopera egrave antica ma la sua tradizione non rimonta oltre la fine del XIII secolo a parte un frammento nel Leiden BPG 78 ff 156r-161v (minuscola del IX-X secolo) e in effetti in questo manoscritto tutti i numerali di molteplicitagrave sono sormontati da barre Unrsquoeccezione effettiva egrave il De hypotesibus planetarum nel Vat gr 1594 barre sugli interi e apici sulle parti sessagesimali
Fabio Acerbi158
sotto silenzio e la presenza dellrsquoapice la rende inutile88 Si tratta della stessa convenzione diofantea e coincide ancora con la notazione per i numerali ordinali e per le frazioni unitarie che egrave corrente nei mano- scritti matematici greci per questo motivo non percheacute la descrizione sia particolarmente perspicua nessuno dei copisti della recensione an-tica ha incertezze apici Ma questi apici si rintracciano soltanto sulle indicazioni di specie non contemplate dalla descrizione che sono ante-poste ai resti parziali a fianco dei quozienti parziali i segni di specie sono invece trasformati in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordi-nali corrispondenti del tipo πρωτ tavv 5 e 7b-8 Il recensore bizantino taglia invece la testa al toro elimina dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali elimina la seconda menzione della laquolet-tera Araquo contestualmente allrsquoazzeramento dellrsquoespediente della linea a zig-zag (si veda il punto seguente) modifica la descrizione che contiene la prima menzione in quella dellrsquoapice associato direttamente ai nume-rali di molteplicitagrave riciclando addirittura lrsquoalpha per adibirlo a desi-gnare un numero cardinale (come sorprendersi) τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ laquoponendo al di sopra di essi [scil dei 50 minuti primi] 1 solo lsaquoaccentorsaquo acutoraquo La scelta del recensore egrave assennata che rechi una barra o un apice in una tabella un alpha denota un numero non un numero drsquoordine
Secondo problema da tenere ben distinto dal precedente Cosa ci vuole sul segno α per la lettera alpha menzionata nella frase τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquolettera A [hellip] che significa la specieraquo89 Unrsquooc-chiata allrsquoapparato critico rivela una bella incertezza nei manoscritti Z scrive sempre ᾱ e in un caso lo fa anche P MS optano sempre per α´ C per α P scrive nellrsquoaltro caso αο Per quanto solo la barra sia congrua con il senso della frase in quanto la lettera alpha egrave qui menzionata (si tratta di un oggetto che compare nella tabella) e non cambia niente se essa egrave accompagnata dal suo nome di genere στοιχεῖον ad un livello grafico lrsquoincertezza fra il segno ᾱ che denota laquola lettera αraquo e il segno α´ (o lrsquoabbreviazione αο) per una forma di πρῶτος egrave per piugrave versi giustificata
88 Detto in altri termini la barra egrave uno strumento grafico non matematico e quindi la sua presenza non va segnalata mentre un apice lo egrave e la sua presenza lo deve
89 Notare che in questa frase il primo α non vuole la barra (egrave menzionato allrsquointerno di una frase che impiega convenzioni moderne) il secondo sigrave (idem ma con convenzioni antiche) ndash e nella traduzione la scelta di denotarlo con A (senza virgolette) e non con lsquoArsquo (con virgolette) egrave del tutto arbitraria ndash si noti inoltre che le necessarie precisazioni laquosenzacon virgoletteraquo mostrano che le lingue moderne palesano difficoltagrave analoghe a quelle del greco antico per quanto riguarda i livelli denotativi in ambito metadiscorsivo per non usare le due parentetiche avrei dovuto scrivere rispettivamente lsquoArsquo e lsquolsquoArsquorsquo (doppie virgolette semplici)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 159
ᾱ coincide con il numerale 1 α egrave la prima lettera dellrsquoalfabeto ed inoltre α´ egrave esattamente quello che va scritto nella tabella Potremmo dirci che il sostantivo στοιχεῖον chiude la questione la sua presenza congiunta ad un ipotetico α´ renderebbe la descrizione ridondante o inappropriata90 Ma a parte il fatto che α egrave proprio τὸ πρῶτον στοιχεῖον il segno α´ cat-tura in fondo il cuore della descrizione di uno στοιχεῖον ἔχον lsaquoγραμμὴνrsaquo ἀνατείνουσαν
Terzo problema Lrsquoautore dei Prolegomena che si arresta allrsquoesem-pio dei minuti primi non dice quanti apici occorre mettere sulle lettere numerali che identificano gli ordini superiori al primo se uno soltanto come nel caso diofanteo e delle frazioni unitarie o in numero uguale alla loro denominazione (cioegrave pari al numero denotato dal numerale stesso su cui vanno posti) come effettivamente avviene nei mano-scritti dei Prolegomena La tabella egrave quindi sottodeterminata dalla sua descrizione anzi in un certo senso prende il sopravvento su di essa la pratica di marcare i numerali di molteplicitagrave con gli apici che compe-tono allrsquoordine cui appartengono viene trasferita ai segni per gli ordini stessi per supplire ad una descrizione carente di questi ultimi E la tabella egrave sottodeterminata dalla descrizione in quanto egrave la descrizione di una tabella reale ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις laquocome nello lsaquoschemarsaquo espostoraquo leggiamo a un certo punto del testo
3) La linea a zig-zag Non possiamo che applaudire a questo geniale espediente grafico lo troviamo messo in opera solo nel Marc gr 313 Per quanto lrsquoautore non faccia parola di ciograve nel corso della sua descrizione la linea spezzata egrave intesa dover lsquosaltarersquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue Il copista del codice marciano effettua correttamente due salti nella prima delle sue tabelle (tav 4) ma inserisce un lsquodentersquo in piugrave in quella che considera corretta (tav 5) La linea a zig-zag egrave incompatibile con la presenza di linee di giustificazione nella tabella che in effetti mancano nel Marc gr 313 ciograve induce gli errori di allineamento dei primi 5 quozienti parziali di cui egrave vittima il copista Probabilmente per questo motivo in nessuno degli apografi del Vat gr 1594 la linea a zig-zag figura nella tabella inquadrata come si conviene da una (doppia) cornice esterna e le cui colonne sono appunto separate da linee verticali (tav 7b Vat gr 184 f 17v e tav 8 Par gr 2390 f 9v cui egrave sostanzialmente identica la tabella del Marc gr 314 che si trova
90 Trascuro lrsquoabbreviazione αο = πρῶτος percheacute la desinenza non egrave quella richiesta neacute nella frase (egrave richiesto πρῶτον) neacute nella tabella (πρῶτα)
Fabio Acerbi160
al f 248r ndash ma la mancanza di linee orizzontali causa un gigantesco pa-sticcio nel codice vaticano) Alla recensione bizantina che dipende per il suo testo di base dal Vat gr 1594 e quindi non trova la linea a zig-zag nella tabella non resta che sopprimere la sua descrizione ndash ma proprio per questo motivo e finalmente diventa possibile tracciare un apparato completo di linee di giustificazione (tav 9 Laur Plut 89 sup 48 f 14v) Dato che la descrizione di Teone di questo procedimento di divi-sione non fa cenno allrsquoesistenza della linea a zig-zag viene da chiedersi se essa non costituisca un espediente escogitato dallrsquoautore dei Prolegomena per vivacizzare la procedura originale di Pappo
4) Discrepanze tra descrizione e tabella Il gioco delle minime va-rianti mostra che la divisione era stata eseguita (e trasmessa) corret-tamente tutti i valori numerici sono esatti La tabella nel Marc gr 313 presenta perograve alcune discrepanze con la propria descrizione Essa omette (ma non nella versione lsquoscorrettarsquo lrsquoomissione non si riscontra neanche nel Par gr 2390) il segno per laquorestoraquo di fronte ai resti par-ziali ma aggiunge lrsquoindicazione della loro specie Essa trasforma invece come abbiamo visto le indicazioni di specie che seguono i quozienti parziali in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordinali corri-spondenti La descrizione prevede di chiudere la tabella con il risultato καὶ συνάγων ἅπαντα τὰ ἐκ τῶν μερισθέντων μερῶν λεπτὰ σημειοῦται ὑπὸ πάντας οὕτως γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoe raccogliendo tutti i minuti che provengono dalle parti divise lsaquoPapporsaquo nota sotto tutto cosigrave Ris 0 59 8 17 13 12 31raquo ma sotto la tabella tutta la tradizione ci consegna qualcosa di piugrave articolato ὁ ζητούμενος καθ᾽ ὃν μερίζεται ὁ τξε ιδ´ μη´´ π(αρὰ) τὸν τξ γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoil lsaquonumerorsaquo cercato secondo cui 365 14 48 egrave diviso per 360 risulta 0 59 8 17 13 12 31raquo frase che del resto contiene due errori lrsquoinversione del dividendo e del divisore e la confusione tra segno convenzionale (iuxta descrizione) e abbreviazione (come nella frase) nel caso di γι Oltre ad eliminare la linea a zig-zag91 la recensione bizantina sopprime dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali e modifica come abbiamo visto al punto 2 le loro descrizioni in quelle di apici associati diretta-mente ai numerali di molteplicitagrave
91 Le due righe che nella recensione di base contengono solo i resti parziali minori di 160 del divisore ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue sono in parte completate con lrsquoindicazione abbreviata ἀνάλ(υσις) laquoanalisiraquo il termine greco per questa procedura di riduzione In un sussulto di ipercorrettismo matematico tali resti parziali ridotti non sono preceduti dal segno per laquorestoraquo come nel Par gr 2390 ma da quello per laquorisultatoraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 161
Gli esempi che abbiamo discusso mostrano come i problemi di notazione pesino e non poco sullrsquoespressione discorsiva di un algorit-mo matematico lrsquoente di riferimento per lsquoformularersquo il procedimento di divisione fu considerata la tabella cioegrave un oggetto la cui costitu-zione egrave legata piugrave ad una pratica grafica che a considerazioni logico- algoritmiche non la sua descrizione che in effetti finisce per determi-nare la tabella in maniera non univoca Di questa sottodeterminazione si fa testimone la traiettoria che abbiamo cercato di seguire nelle mani di copisti e revisori il procedimento di divisione si modifica a volte in aspetti secondari a volte in punti piugrave sostanziali ndash fino a rendere neces-saria una radicale revisione della sua descrizione per renderla conforme alla tabella ndash in ogni caso mai per ragioni squisitamente matematiche92
Abstract
The article presents and discusses in detail two passages from the anonymous Prolegomena to the Almagest a VIth century primer to the elementary procedures of calculation needed in Ptolemyrsquos Almagest In the two passages we may follow the complex interplay between mathematical notation the auctor who employed and described it the tachygrapher who transcribed it in vivo copyists who reproduced it correctors who modified it Along this path misgivings and errors arise in the transmission of abbreviations and paratextual units such as diagrams tables operational schemes
Fabio AcerbiCNRS UMR8560 Centre Alexandre Koyreacute
fabacerbigmailcom
92 Sono grato a Daniele Bianconi Lucio del Corso Jean Lempire per alcune preziose indicazioni
AOO = Archimedis opera omnia cum commentariis Eutocii ed J L Heiberg I-III Lipsiae 1910-1915
DOO = Diophanti Alexandrini opera omnia cum Graecis commentariis ed P Tannery I-II Lipsiae 1893-1895
GC = Le laquoGrand Commentaireraquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Mogenet ndash A Tihon I-III Cittagrave del Vaticano 1985-1999
iA = Commentaires de Pappus et de Theacuteon drsquoAlexandrie sur lrsquoAlmageste ed A Rome I-III con paginazione continua Cittagrave del Vaticano 1931-1943
HOO = Heronis Alexandrini opera quae supersunt omnia ed G Schmidt ndash L Nix ndash W Schmidt ndash H Schoene ndash J L Heiberg I-V Lipsiae 1899-1914
PC = Le ldquoPetit Commentairerdquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed A Tihon Cittagrave del Vaticano 1978
POO = Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia ed J L Heiberg I-II in 3 parti Lipsiae 1898-1907
RGK = Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600 I Handschriften aus Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln II Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs und Nachtraumlge zu den Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln III Handschriften aus Bibliotheken Roms mit dem Vatikan A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg unter Mitarbeit von D Harlfinger und P Eleuteri B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln Wien 1981-1997 (Oumlsterreichische Akademie der Wissenschaften Veroumlffentlichungen der Kommission fuumlr Byzantinistik III1-3 A-C)
Sigla
Acerbi 2010 = F Acerbi Il silenzio delle sirene La matematica greca antica Roma 2010
Acerbi 2012 = F Acerbi I codici stilistici della matematica greca dimostrazioni procedure algoritmi laquoQUCCraquo 1012 (2012) pp 167-214
Acerbi et al 2010 = F Acerbi ndash N Vinel ndash B Vitrac Les Proleacutegomegravenes agrave lrsquoAlmageste Une eacutedition agrave partir des manuscrits les plus anciens Introduction geacuteneacuterale ndash Parties I-III laquoSCIAMVSraquo 11 (2010) pp 53-210
Agati 1992 = M L Agati La minuscola laquoBouleteacuteeraquo Cittagrave del Vaticano 1992
Belger 1881 = C Belger Ein neues Fragmentum mathematicum Bobiense laquoHermesraquo 16 (1881) pp 261-284
Bianconi 2005a = D Bianconi La biblioteca di Cora tra Massimo Planude e Niceforo Gregora Una questione di mani laquoSampTraquo 3 (2005) pp 391-438
Bianconi 2005b = D Bianconi Tessalonica nellrsquoetagrave dei Paleologi Le pratiche intellettuali nel riflesso della cultura scritta Paris 2005
Bianconi 2006a = D Bianconi Le pietre e il ponte ovvero identificazioni di mani e storia della cultura laquoBizantinisticaraquo 8 (2006) pp 135-181
Bianconi 2006b = D Bianconi Qualcosa di nuovo su Giovanni Catrario laquoMEGraquo 6 (2006) pp 69-91
Cavallo 1977 = G Cavallo Funzione e strutture della maiuscola greca tra i secoli VIII-XI in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Colloque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 95-137
Cereteli 1904 = G F Cereteli De compendiis scripturae codicum Graecorum praecipue Petropolitanorum et Mosquensium anni nota instructorum Sankt-Petersburg 1904
De Gregorio 2000 = G De Gregorio Materiali vecchi e nuovi per uno studio della minu-scola greca fra VII e IX secolo in G Prato (a cura di) I manoscritti greci tra riflessione e dibattito Atti del V Colloquio Internazionale di Paleografia Greca Cremona 4-10 ottobre 1998 Firenze 2000 pp 83-151
Follieri 1977 = E Follieri La minuscola libraria dei secoli IX e X in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Col-loque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 139-165
Fonkič 2005 = B Fonkič Venecianskaia rukopisrsquo laquoAlrsquomagestaraquo Ptolemeja (Marc gr 313690) o datirovke i proischoždenii kodeksa laquoVDIraquo s III 254 (2005) pp 162-167
Fowler 1999 = D H Fowler The Mathematics of Platorsquos Academy A New Reconstruction Second Edition Oxford 1999
Bibliografia
Fabio Acerbi164
Gerstinger ndash Vogel 1932 = H Gerstinger ndash K Vogel Eine stereometrische Aufgaben-sammlung im Papyrus Graecus [sic] Vindobonensis 19996 laquoMitteilungen aus der Papy-russammlung der Nationalbibliothek in Wienraquo Neue Serie Folge 1 Griechische literarische Papyri 1 Wien 1932 pp 11-76
Heiberg 1927 = Mathematici Graeci Minores ed J L Heiberg Kjoslashbenhavn 1927
Hultsch 1876-1878 = Pappi Alexandrini Collectionis quae supersunt ed F Hultsch I-III Berlin 1876-1878
Janz 2003 = T Janz The Scribes and the Date of the Vat gr 1291 in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae X Cittagrave del Vaticano 2003 pp 159-180
Jones 1990 = Ptolemyrsquos First Commentator ed A Jones Philadelphia 1990
Jones 1999 = Astronomical Papyri from Oxyrhynchus ed A Jones I-II Philadelphia 1999
Jones 2005 = A Jones Ptolemyrsquos Canobic Inscription and Heliodorusrsquo Observation Reports laquoSCIAMVSraquo 6 (2005) pp 53-97
Lempire 2014 = Steacutephanos drsquoAlexandrie Le commentaire aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Lempire Louvain 2014
Leurquin 1990 = Theacuteodore Meacuteliteacuteniote Tribiblos astronomique Livre I ed R Leurquin Amsterdam 1990
Leurquin 1991 = R Leurquin Un manuscrit autographe de la Tribiblos Astronomique de Theacuteodore Meacuteliteacuteniote le Vaticanus graecus 792 laquoScriptoriumraquo 45 (1991) pp 145-162
Maas 1927 = P Maas Griechische Palaeographie in A Gercke ndash E Norden (hrsg von) Einleitung in die Altertumswissenschaft I9 Leipzig 1927 pp 69-80
Martinelli Tempesta 2010 = S Martinelli Tempesta Il codice Milano Biblioteca Am-brosiana B 75 sup (gr 104) e lrsquoevoluzione della scrittura di Giovanni Scutariota in A B Garciacutea ndash I Peacuterez Martiacuten (ed by) The Legacy of Bernard de Montfaucon Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting Proceedings of the Seventh Inter-national Colloquium of Greek Palaeography Madrid-Salamanca 15-20 September 2008 Turnhout 2010 pp 171-186
Mazzucchi 1994 = C M Mazzucchi Leggere i classici durante la catastrofe (Costantino-poli maggio-agosto 1203) le note marginali al Diodoro Siculo Vaticano gr 130 Parte prima stratigrafia laquoAevumraquo 68 (1994) pp 164-218
Mioni 1976 = E Mioni Bessarione scriba e alcuni suoi collaboratori in Miscellanea marcia-na di studi bessarionei Padova 1976 pp 263-323
Mioni 1985 = Codices graeci manuscripti Bibliothecae Divi Marci Venetiarum II Thesaurus Antiquus Codices 300-625 recensuit E Mioni Roma 1985
Mogenet 1962 = J Mogenet Une scholie ineacutedite du Vat gr 1594 sur les rapports entre lrsquoastronomie arabe et Byzance laquoOsirisraquo 14 (1962) pp 198-221
Mogenet et al 1983 = Niceacutephore Greacutegoras Calcul de lrsquoeacuteclipse de soleil du 16 juillet 1330 ed J Mogenet ndash A Tihon ndash R Royez ndash A Berg Amsterdam 1983
Mondrain 2002 = B Mondrain Maxime Planude Niceacutephore Greacutegoras et Ptoleacutemeacutee laquoPa-laeoslavicaraquo 10 (2002) pp 312-322
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 165
Mondrain 2004 = B Mondrain Lrsquoancien empereur Jean VI Cantacuzegravene et ses copistes in A Rigo (a cura di) Gregorio Palamas e oltre Studi e documenti sulle controversie teologiche del XIV secolo bizantino Firenze 2004 pp 249-296
Mondrain 2007 = B Mondrain Les eacutecritures dans les manuscrits byzantins du XIV e siegravecle Quelques probleacutematiques laquoRSBNraquo n s 44 (2007) pp 157-196
Peacuterez Martiacuten 2006 = I Peacuterez Martiacuten Maxime Planude et le Diophantus Matritensis (Madrid Biblioteca Nacional ms 4678) un paradigme de la reacutecupeacuteration des textes anciens dans la ldquorenaissance paleacuteologuerdquo laquoByzantionraquo 76 (2006) pp 433-462
Peacuterez Martiacuten 2008 = I Peacuterez Martiacuten El lsquoestilo Hodegosrsquo y su proyeccioacuten en las escrituras constantinopolitanas laquoSampTraquo 6 (2008) pp 389-458
Perria 1991 = L Perria Scrittura e ornamentazione nei codici della laquocollezione filosoficaraquo laquoRSBNraquo n s 28 (1991) pp 45-111
Rollo 2012 = A Rollo LrsquoArchimede di Giorgio Valla in V Fera ndash D Gionta ndash A Rollo (a cura di) Archimede e le sue fortune Atti del Convegno di Siracusa-Messina 24-26 giugno 2008 Messina 2012 pp 99-147
Rome 1927 = A Rome Membra disjecta laquoRBenraquo 39 (1927) pp 187-188
Rome 1938 = A Rome Un manuscrit de la bibliothegraveque de Boniface VIII agrave la Meacutediceacuteenne de Florence laquoACraquo 7 (1938) pp 261-268
Ronconi 2013 = F Ronconi La collection philosophique un fantocircme historique laquoScripto-riumraquo 67 (2013) pp 119-140
Tannery ndash Steacutephanou 1940 = Quadrivium de Georges Pachymegravere ed P Tannery ndash E Steacutephanou Cittagrave del Vaticano 1940
Tihon 2011 = Πτολεμαίου Πρόχειροι Κανόνες Les Tables faciles de Ptoleacutemeacutee vol Ia Tables A1-A2 ed A Tihon Leuven 2011
Traube 1907 = L Traube Nomina Sacra Versuch einer Geschichte der christlichen Kuumlrzung Muumlnchen 1907
Vogel 1936 = K Vogel Beitraumlge zur griechischen Logistik laquoSBAWraquo Mathematisch-natur-wissenschaftliche Abteilung Jahrgang 1936 pp 357-472
Wouters 1979 = A Wouters The Grammatical Papyri from Graeco-Roman Egypt Contri-butions to the Study of the lsquoArs Grammaticarsquo in Antiquity Brussel 1979
F ACERBI Tav 1
b Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 65r
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 284 f 160r
F ACERBITav 2
b Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 13r
a Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 19v
F ACERBI Tav 3
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 136v
F ACERBITav 4
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17r
F ACERBI Tav 5
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17v
F ACERBITav 6
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 7v
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 147
Negli item ii e iv il segno si collega ad una descrizione nel secondo caso in via esclusiva le descrizioni pertanto rinforzano o sostituiscono lrsquoidentificazione con lrsquoente linguistico denotato Le clausole descrittive sono precedute da ἀντί e dallrsquoarticolo τό con funzione di lsquooperatore di citazionersquo esse sono παρ᾿ ἃ δεῖ τὸν μερισμὸν γίνεσθαι (item ii) e λοιποὶ οἱ μέλλοντες ἐπιμερίζεσθαι (item iv) Nella descrizione della divisione lsquoalla Papporsquo che leggeremo tra breve i segni negli item iii e iv rice-vono lo stesso trattamento degli altri due il loro relatum egrave un singolo vocabolo e non una clausola descrittiva rispettivamente nelle espres-sioni τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε (sul participio ritorneremo nel punto 1 infra) e τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά (la forma del segno notato con λ οι egrave descritta supra nellrsquoitem iv) La descrizione del segno oslash per il divisore merita una discussione piugrave dettagliata In origine si trovava probabilmente scritto Π(ΑΡΑ)ΕΧΟΝ successivamente letto come π(αρ[α])έχον ndash dato che lrsquoabbreviazione per il preverbo egrave identica a quella per la preposizione (che sia Π᾽ o un pi seguito dal segno per ἄρα a sormontare) ndash invece di π(αρὰ) ἔχον I copisti e i correttori si dettero a tutte le possibili contorsioni per restituire un testo dotato di senso leggere appunto una forma verbale con preverbo modificare il preverbo (ma forse il segno per ἄρα era insidiosamente simile ad uno epsilon) correggere il testo rileggiamo lrsquoapparato sub τὸ παρὰ ἔχον οὕτως τὸ παρέχον οὕτως M et π(αρ-) comp Z οὕτως τὸ περιέχον S τὸ περιέχον οὕτως C προγράφοντας οὕτως ex corr m 2 P Nella clausola descrittiva seguente la presenza liminare di παρὰ (che ho corretto in παρ᾿ ἃ nella speranza di restituire una frase che abbia un senso senza intervenire sul testo) innesca un bel corto circuito il Π(ΑΡΑ) che sicuramente figu-rava nellrsquoarchetipo egrave un sintagma complesso una preposizione unrsquoab-breviazione o un segno per unrsquoabbreviazione Se lrsquoeditore si trova in conflitto con la propria inclinazione alla critica conservativa i copisti si rifiutarono di mettere mano ad un testo che doveva stridere anche per loro essendo il compito demandato al ritocco del revisore del Par gr 2390 o alla riscrittura radicale del recensore bizantino Il problema egrave che ci troviamo di fronte ad unrsquoespressione che descrive la funzione dellrsquooggetto denotato non lrsquooggetto stesso ma che lo contiene al suo interno per soprammercato qui il Π(ΑΡΑ) egrave usato per giustificare una menzione a sua volta relatum di un segno
Evidentemente questa maniera di procedere che giagrave aveva attirato interventi da parte di copisti e correttori della recensione di base parve insostenibilmente opaca allrsquoautore della recensione bizantina61 Egli
61 Uno dei manoscritti di questa recensione propone anche una tabella di divisione
Fabio Acerbi148
modifica tutte le descrizioni diluendo lrsquoidiomatismo dellrsquoarticolo lsquocita-zionalersquo con lrsquointroduzione sistematica del verbo δηλόω e di frasi atte a chiarire quale sia il segno denotante e quale il vocabolo (o il segno) denotato Egli introduce allo scopo di rendere esplicita la funzione de-notativa dei segni introdotti il termine σημείου curiosamente in tutte le sue tre occorrenze esso compare a sua volta nella forma dellrsquoabbrevia-zione per sospensione σΗ´ Egli traccia il segno per i massimi multipli ἀφ e quello per i resti λ οι` in modo che non vi siano ambiguitagrave quanto al loro carattere di abbreviazione Si faccia infine attenzione al residuo di barra sul παρᾱ con funzione denotativa (2 occorrenze) contenuto nella descrizione del segno per il divisore sostituita dallrsquoaccento grave nel παρὰ con funzione discorsiva (la differenza egrave nettissima nei manoscritti da me consultati) Questa osservazione ci permette di passare direttamente allrsquoitem seguente
b) Le barre sui numerali e sulle lettere denotative Egrave opportuno discutere questo punto adesso esattamente percheacute di barre siffatte che pure troviamo in tutti i manoscritti i nostri testi non fanno mai menzione si tratta infatti di una pratica condivisa sin dallrsquoantichitagrave La barra identifica una stringa di lettere dellrsquoalfabeto che non svolge una funzione grammaticale o sintattica propria allrsquointerno del discorso Ciograve avviene in particolare e si tratta della fattispecie piugrave frequente se la stringa di lettere non dagrave origine a un vocabolo della lingua greca lette-re denotative e numerali certo ma anche termini provenienti da altri idiomi e contrazioni di parole greche come i nomina sacra62 tali termi-ni possono essere o no preceduti da un articolo lsquocitazionalersquo a seconda dellrsquouso che ne viene fatto allrsquointerno del discorso Ma non si tratta dellrsquounica fattispecie i papiri grammaticali ed i manoscritti piugrave antichi dei trattati dello stesso argomento segnalano gli esempi delle parti del discorso (cioegrave di lsquoverersquo parole greche) per mezzo di barre sormontanti63 La differenza insomma egrave tra menzione e uso (come parte del discorso in atto) di una stringa di caratteri tra il porre le lsquovirgolettersquo e il non porle tra funzione denotativa e non Apparentemente la convenzione si limi-
corredata dei segni opportuni e contrariamente alle indicazioni della descrizione svilup-pata lsquoin verticalersquo ma per motivi misteriosi non completa (tav 7a Laur Plut 89 sup 48 f 13r)
62 Tutto ciograve egrave spiegato con estrema chiarezza giagrave in Traube 1907 pp 45-4763 Si veda il Par gr 2548 codex vetustissimus e testimone unico delle lsquoopere minorirsquo
di Apollonio Discolo il f 106v con le barre ben visibili egrave riprodotto come tav 19 in De Gregorio 2000 (ivi pp 137-138 per la datazione) Per la testimonianza dei papiri grammaticali si veda Wouters 1979 passim essi contengono di norma elenchi di parti del discorso nessuna delle quali egrave preceduta dallrsquoarticolo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 149
tava in questo secondo caso a segnalare con la barra singoli vocaboli le menzioni di frasi o di sintagmi complessi sono di norma identificate dallrsquoarticolo lsquocitazionalersquo Drsquoaltra parte le abbreviazioni convenzionali non rientrano nella casistica percheacute la loro resa grafica che contiene elementi non alfabetici come compendi per desinenze lettere supra li-neam marche di contrazione o sospensione quali slashes o barre sotto-poste o sormontanti eventualmente solo un sottinsieme della stringa di segni alfabetici le esclude automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
Venendo al discorso matematico una barra sormonta senza ecce-zione le lettere denotative64 che sia in papiri o in manoscritti in maiu-scola65 o minuscola ma solo allrsquointerno del testo comrsquoegrave da attendersi nei diagrammi esse la perdono per il semplice motivo che non crsquoegrave alcun testo ambiente un diagramma ha unicamente una funzione denotati-va Drsquoaltra parte le lettere numerali che a volte figurano nei diagrammi della tradizione metrica66 allo scopo di indicare la lunghezza dei seg-menti mantengono la barra in un diagramma il contesto denotativo geometrico egrave prevalente e i numerali vengono percepiti come entitagrave grafiche lsquoesternersquo al discorso Va da seacute a fortiori che le lettere numerali inserite in un testo dovranno essere segnalate da barre che a loro volta non servono nelle tavole67 in quanto queste ultime sono come abbiamo visto un vero e proprio testo che perograve funge da ambiente a quello al-fabetico limitato alle titolazioni e non a caso tracciato in unrsquoopportuna lsquomaiuscola distintivarsquo allo scopo di segnalarne il carattere denotativo e non discorsivo68 Una tabella operazionale egrave invece un paratesto e quindi le barre sulle lettere numerali che rappresentano gli interi sono
64 La notazione per le lettere denotative subigrave unrsquoevoluzione (il cui risultato finale egrave descritto per sommi capi nella nota 3 supra) di cui non mette conto occuparsi qui
65 I papiri di contenuto geometrico (o astronomici ma che presentano argomenti geometrici) sono rari si vedano il PHerc 1061 (sec II aC Demetrio Lacone De geome-tria) e il PFay 9 (sec II ex Elementi I 39 e 41) Gli importanti ostraka OBerl 12002 e 12609 (sec III aC m Elementi XIII) non pongono le barre sopra le lettere denotative Per i manoscritti in maiuscola si veda ad esempio passim nel Par gr 2389 una cui riproduzione digitale egrave consultabile in rete allrsquoindirizzo httpgallicabnffrark12148btv1b8470171d o il fragmentum mathematicum Bobiense
66 Si veda ancora il ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 codex unicus dei Metrica di Erone e contenente una raccolta importante di problemi del corpus metrologico
67 Si vedano come esempio le tavole citate alle note 10 e 14 supra Discorso a parte per il segno di lsquoposto vuotorsquo si veda il punto c che segue
68 Queste regole generali vanno prese cum grano salis si dagrave naturalmente un certo dominio di variabilitagrave legato verosimilmente al grado di cultura grafica del copista nel PMich III 144 i numerali sono quasi tutti senza barra sia nel testo che nelle tabelle ope-razionali
Fabio Acerbi150
necessarie esse mancano invece sui segni convenzionali che ho descrit-to nel punto precedente e fatto rilevante sulle lettere numerali relative agli ordini sessagesimali quando esse siano identificate da uno o piugrave apici la presenza di questo segno grafico non alfabetico69 le esclude ancora una volta automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo Unrsquoultima osservazione che ci saragrave utile nel seacuteguito la descrizio-ne di una stringa di lettere lsquoagrammaticalersquo non puograve prevedere la men-zione della presenza della barra che le pertiene in quanto tale si tratta di una pratica denotativa che egrave possibile formulare soltanto ad un livello di discorso superiore sia a quello dellrsquouso che a quello della menzione70
c) Il segno di lsquoposto vuotorsquo Si noti nella tav 2b la forma ŏ per il segno di lsquoposto vuotorsquo in un ordine sessagesimale coerentemente con la propria notazione il copista del Marc gr 313 lo scioglie talvolta allrsquoin-terno del testo principale come unrsquoabbreviazione per οὐδέν laquonienteraquo Altre convenzioni di scrittura del tratto che accompagna il circoletto e che si badi bene fa parte integrante del segno di lsquoposto vuotorsquo ndash e infatti nelle tavole troviamo sempre il segno completo mentre tutti gli altri numerali sono come abbiamo visto nel punto precedente privi di barra o di apice a causa del fatto che i vari ordini sessagesimali sono univocamente determinati dalle linee di giustificazione ndash un tratto an-golare anteposto (tav 3 Lar Plut 2818 f 136v)71 o una semplice barra a sormontare (tavv 4-9) si produce in questo modo il segno 65926 che sembra essere stata la forma di base72
69 Occorre dunque supporre come testimoniano papiri e manoscritti in maiuscola che la convenzione relativa allrsquouso della barra si sia consolidata ben prima dellrsquointroduzione di segni diacritici quali accenti e spiriti
70 Si veda il punto 2 infra per maggiori dettagli sulla questione delle barre e degli apici e per le indicazioni in merito che leggiamo in Diofanto
71 Come accennato questa tavola dei sottomultipli coincide con quella descritta ed esposta nei Prolegomena Fatto molto rilevante i numerali nella prima non recano neacute barre neacute apici contrariamente a quanto accade a tutte le istanze della seconda nei manoscritti Quella del Laur Plut 2818 preserva a mio avviso la forma originaria come abbiamo visto una tavola non richiede segni aggiuntivi sulle lettere numerali
72 Si vedano come esempio ancora le tavole citate alle note 10 e 14 supra oppure per una rassegna delle forme che il segno assume nei manoscritti piugrave antichi delle Tavole facili Tihon 2011 pp 58-59 e per quelle che assume nei papiri Jones 1999 I pp 61-62 Ovviamente non possiamo leggere il segno 65926 come un omicron con una barra in quanto ο = 70 nella notazione greca e la barra egrave di rigore quando il numerale figuri allrsquointerno di un testo Occorre ammettere che si dagrave origine ad un bel corto circuito notazionale con il concepire un segno con funzione di lsquoposto vuotorsquo ma che lsquosomigliarsquo ad una lettera dellrsquoalfabeto sormontata da una barra cioegrave ad un numerale in piugrave quando il lsquoposto vuotorsquo non corrisponda ad un intero ma ad una specie sessagesimale la presenza della barra a priori indistinguibile da quella che sormonta gli interi introduce unrsquoincongruenza con la notazione a mezzo di apici vista nellrsquoitem precedente
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 151
d) Errori di copia La tabella riprodotta nella tav 2b ha una forma simmetrica ma si tratta di una forzatura il grande rettangolo in basso a destra drsquoaltronde assente nella descrizione contiene uno scolio che fa notare come lrsquoultimo resto parziale ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ͵γτνζ´´´´´ κζ´´´´´´ cioegrave 0 0 0 0 0 3357 27 siano ἔγγιστα λ´λ´ δ´δ´ ξ laquocon ottima approssimazione 60 minuti quartiraquo dove si notino gli apici semplici per indicare il pas-saggio allrsquoordinale e il raddoppiamento del sistema segno + apice per significare il plurale Lo scolio debitamente accompagnato dal segno di rimando in forma di simbolo solare egrave stato probabilmente incluso nella tabella proprio allo scopo di renderla simmetrica A sua volta un errore precedente spiega lo spazio eccessivo accordato al rettangolo contenente lo scolio il secondo massimo multiplo ŏ λβ´ ξδ´´ ριβ´´´ σιϛ´´´´ egrave trascritto anche al di sotto del risultato
Passiamo ora alla descrizione del metodo di divisione attribuito a Pappo
ἵνα οὖν ταῦτα συναχθῇ τὰ ἐκ τοῦ μερισμοῦ ὁ εἰρημένος Πάππος εὐδιατύπῳ τινὶ καὶ πρὸς τοῦτο τάξει χρησάμενος ποιεῖται τὴν τῆς συλλήψεως τοῦ ζητουμένου ἀνεύρεσιν οὕτως ἐκθέμενος γὰρ τὸν μέλλοντα μερίζεσθαι τουτέστι τὰς τξ μοίρας ἐν ἀρχῇ ἀφαιρεῖ ἀπ᾽ αὐτῶν τὸν ἐν τῇ σελίδι τυγχάνοντα ἐλάττονα τουτέστι τὸν τδ κβ´ κ´´ ὄντα τῶν ἐγγὺς ἐλασσόνων ὡς πρὸς τοὺς ἐκκειμένους διὸ καὶ γράφει αὐτὸν προγράφων αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε καὶ εὑρίσκων τὰ παρακείμενα αὐτῷ τῷ ἀπογραφέντι ἐν τῷ σελιδίῳ λεπτὰ πρῶτα ν´ συναπογράφεται παρατιθῶν αὐτοῖς τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον ἀνατείνουσαν σημαῖνον τὸ εἶδος ὅτι πρῶτα λεπτά εὑρίσκει οὖν οὕτως τὸ τῶν τξ μέρος τὸ τδ κβ´ κ´´ ὃ μεριζόμενον παρὰ τὰς τξε ιδ´ μη´´ ἡμέρας καὶ ποιοῦν τὸν ἐκ τοῦ μερισμοῦ ἀριθμὸν πρῶτα λεπτὰ ν´ καὶ τὸν λοιπὸν ἀπογραφόμενος τὸν νε λζ´ μ´´ προτάσσει αὐτοῦ τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά τάσσει δὲ καὶ ἁπλῆν τινα διατείνουσαν γραμμὴν ὡς ἀπὸ τοῦ τξ ἐπὶ τὸν ἑξῆς ἐκτεθειμένον ἐγγὺς
1
5
10
1 εὐδιατύπῳ] ZSPC εὐδιατύπωτ M 4 ἀφαιρεῖ] MZSP ἀφ ι C 5 ἐλάττονα] P comp MZSC 6 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | αφ ] αφ ε M ἀφ ZS ἀφαί P ἄφ C | ἀντὶ] om C | ἄφελε] MZSP ἄφ C 8 ἀπογραφέντι] MZSP ἐγγραφέντι C | λεπτὰ πρῶτα] P λε πρωτα SC λεπτῶν πρωτ MZ | παρατιθῶν] MZS παρατιθεὶς C et ex corr m 2 P 9 ᾱ] Z αο P α´ MS α C | ἔχον] MPC ἔχων ZS 9-10 πρῶτα λεπτά] ZP πρωτ λ´λ´ M πρωτα λε S αα λε C 11 ἡμέρας] comp codd | ἀριθμὸν] P et comp MZ καὶ C et comp S 12 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M πρωτ λεπτ(α) Z πρωτ λ εᾱ S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C | ἀπογραφόμενος] MZSP ἐγγραφόμενος C | νε λζ´] MZSP λζ νζ C 13 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | λ οι] MZSC ex λ fecit λ οι P | προσσημαῖνον] MC et προσ- comp ZS προση- P | τὸ] MZC τὰ S et fecit m 2 P 14 ἀπὸ] MZSP πρὸς C ἐλάττονα] P comp MZSC
1 εὐδιατύπῳ] εὐδιατυπώτω K 6-7 αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ] τὸ ἀφ K 8 παρατιθῶν mdash 10 λεπτά] τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ σημαίνουσαν τὸ εἶδος αὐτῶν ὅτι ᾱ λεπτά εἰσιν K | τὸ (sec)] τὰ K 12 πρῶτα] πρώτων K | τε λ ] λ οι` K | προσσημαῖνον mdash
Fabio Acerbi152
ἐλάττονα τὸν τδ κβ´ κ´´ ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις καὶ ταύτην ἐπιδεικνύουσαν τὴν τάξιν τῆς προόδου τῆς ἐκθέσεως ἧστινος κλωμένης γραμμῆς πρὸς τῷ ἐγγὺς ἐλάσσονι ἡ ἀντανάκλασις ἐπὶ τὸν λοιπὸν γέγραπται φερομένη ὡς εἴρηται διὰ τὸ εὔτακτον τῆς προκοπῆς οὕτως τε ποιήσας ἑξῆς τὸ αφ ποιῶν ὃ προσσημαίνει ὡς εἴρηται τὸ ὅτι δεῖ ἀφελεῖν ὁμοίως ἀπὸ τοῦ λοιποῦ καὶ δὴ τὸν ἐγγὺς πάλιν ἐλάσσονα ὡς πρὸς τὴν ἐν τῷ σελιδίῳ ἔκθεσιν εὑρισκόμενον λαμβάνων ἑξῆς προγράφει αὐτὸν ὄντα νδ μζ´ ιγ´´ ιβ´´´ καὶ εὑρίσκει αὐτοῖς παρακείμενα ἐν τῷ σελιδίῳ πρῶτα λεπτὰ θ´ ἅτινα καὶ αὐτὰ προσαπογράφεται σὺν τῇ παρασημειώσει τῶν πρώτων γράφων τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον τὴν ἀνατείνουσαν καὶ ὡς εἴρηται τὴν γραμμὴν πάλιν διὰ τὴν τάξιν κλωμένην κατὰ δευτέραν κλάσιν προσέλκει γινομένου τοῦ μέρους αὐτῆς τούτου παραλλήλου τῷ ἐξ ἀρχῆς
16 ante κλωμένης add ἐπὶ C 18 τε] MZP om SC | αφ ] M ἀφ ZSC ἀφαί P 19 προσσημαίνει] MS προση- ZC et ex corr P | ὅτι] ZP comp MSC 20 δὴ] MZSC διὰ fecit m 2 P 21 πρὸς] MSP et supra lineam C ex ἀπὸ fecit m 2 Z | ιγ´´] MZSP νγ´´ C 22 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M ᾱᾱ λεπτὰ Z άάα λε S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C 23 προσαπο- γράφεται] απο suprascr in comp M 24 ᾱ] ZP α´ MS α C 25 κλάσιν] MP τάξιν ZSC | τοῦ] ZSPC τούτου M 26 τούτου] τοῦ bis ZSPC sed prius erasit m 2 P τοῦ M
mdash 18 προκοπῆς] om K | τε ποιήσας] ποιήσας καὶ K | αφ ] ἀφ K 19 τὸ] om K 21 προ-γράφει] γράφει K 22 σελιδίῳ] α´ σελιδίῳ K | ἅτινα] ἃ K 23 προσαπογράφεται] ἀπογράφεται K | τῶν πρώτων mdash 26 ἐξ ἀρχῆς] om K
lsquoAllo scopo di raccogliere ciograve che risulta dalla divisione il detto Pappo utilizzando anche in questo caso una certa disposizione ben strutturata determina nel modo seguente il lsaquonumerorsaquo cercato preso nel suo insieme collocando73 in testa il lsaquonumerorsaquo che sta per essere diviso cioegrave i 360 gradi iniziali sottrae loro tra i piugrave prossimi dei lsaquonumerirsaquo minori rispetto a quelli esposti quello che si trova essere minore nella colonna (cioegrave 304 22 20) Questo egrave il motivo per cui lo trascrive scrivendogli davanti lrsquoabbreviazio-ne laquosottrraquo per laquosottrairaquo e trovando che 50 minuti primi sono collocati accanto a quello stesso lsaquonumerorsaquo che egrave stato trascritto nella colonna li trascrive al tempo stesso collocando accanto74 ad essi la lettera A con un lsaquotrattorsaquo75 sopra che significa la specie minuti primi Trova dunque in que-sto modo la parte di 360 che egrave 304 22 20 la quale divisa per 365 giorni 14 48 fa il numero lsaquoche risultarsaquo dalla divisione 50 minuti primi Trascrivendo
73 La descrizione egrave strutturata come una procedura Acerbi 201274 Il purismo del correttore del Par gr 2390 di Clostomalle nel Marc gr 314 e
dellrsquoautore della recensione bizantina impone loro di modificare la terminazione ma forme tematiche e contratte di τιθεῖν sono correnti nel greco tardivo
75 Il testo greco ha solo il participio con γραμμήν sottinteso Per il significato del participio si veda il punto 2
15
20
25
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 153
poi il resto 55 37 40 gli pone altresigrave76 a prefisso laquoReraquo che significa laquorestiraquo e dispone anche una certa linea semplice77 che va da 360 al piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori che egrave esposto di seacuteguito 304 22 20 come nello lsaquoschemarsaquo esposto linea che mostra lrsquoordine del percorso dellrsquoesposizione Questa linea spezzata lagrave dove si trova il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori egrave tracciata inflessa allrsquoindietro lsaquoersaquo punta verso il resto come egrave stato detto in vista di una progressione ordinata E cosigrave facendo prendendo di seacuteguito il laquosottrraquo che significa come egrave stato detto laquoche occorre similmente sottrarre dal re-storaquo e ovviamente prendendo di nuovo il lsaquonumerorsaquo che egrave trovato essere il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori in relazione alla disposizione nella colonna ndash 54 47 13 12 ndash lo scrive di seacuteguito e trova che 9 minuti primi sono posti loro accanto nella colonna trascrive78 anche questi con la segnaletica dei primi scrivendo la lettera A con un lsaquotrattorsaquo sopra e come egrave stato detto prolunga di nuovo la linea spezzata in vista di una buona disposizione tramite una seconda inflessione essendo questa sua parte parallela a quella inizialersquo
La descrizione continua con una serie di laquoe cosigrave viaraquo e non fa ulte-riore riferimento alla tabella
1) La forma verbale ἐξεσμένον Egrave il neutro del participio perfetto medio-passivo di ξέω lett laquopialloraquo laquolevigoraquo Si danno tre possibilitagrave si tratta di un termine canonico per quanto non altrove attestato per designare unrsquoabbreviazione oppure lrsquoautore anonimo improvvisa sul piano metaforico come se unrsquoabbreviazione non fosse altro che la paro-la completa lsquoaccorciata a colpi di piallarsquo in maniera opportuna oppure il testo egrave corrotto e srsquoimpone una correzione ad esempio τὸ ἑξῆς μένον laquociograve che sta di seacuteguitoraquo Questrsquoultima strada mi pare chiusa dal senso delle frase lrsquoabbreviazione non lsquosta di seacuteguitorsquo a niente ma anzi precede la perifrasi τὸ ἑξῆς μένον se impiegata semplicemente per rimandare al segno αφ immediatamente seguente costituirebbe un intollerabile solecismo Se accettiamo la prima di queste letture considerando quin-di lrsquoabbreviazione αφ in posizione predicativa abbiamo a che fare con
76 Rendo in questo modo il τε isolato77 La linea egrave laquosempliceraquo in quanto egrave una retta la precisazione intende evidenziare per
anticipazione il carattere lsquonon semplicersquo che essa assumeragrave alla prima inflessione quando diventeragrave una spezzata linee siffatte erano in effetti concepite dallrsquoanonimo e prima di lui da tutta la tradizione matematica greca come una singola linea spezzata nei punti drsquoinfles-sione I due segmenti paralleli menzionati al termine del passo sono orizzontali
78 Il verbo egrave al medio in variatio rispetto ai due che precedono e che seguono egrave il matematico che lsquosirsquo trascrive le cifre
Fabio Acerbi154
uno hapax semantico nella grecitagrave superstite come egrave facile verificare con una ricerca sul TLG in rete La recensione bizantina risolve il pro-blema sopprimendo semplicemente τὸ ἐξεσμένον
2) La notazione per le specie numeriche Nella terminologia matema-tica greca gli ordini sessagesimali sono εἴδη laquospecieraquo numerici essi corri- spondono agli ordini di grandezza nel nostro sistema decimale e indica-no in analogia con il caso geometrico la lsquoformarsquo che assume un numero quadrato cubo ecc Centinaia e migliaia sono quindi degli εἴδη rispet-tivamente quadrati (100 egrave il quadrato di 10) e cubi (1000 egrave il cubo di 10) sono specie numeriche ma non numeri particolari e drsquoaltronde 300 non egrave un quadrato ma 3 item dellrsquoεἶδος lsquoquadratorsquo 100 3 egrave il numerale di molteplicitagrave della specie quadrata lsquocentinaiarsquo i due 0 che seguono il 3 segnalano esattamente questo fatto che la notazione greca per gli interi non posizionale fa scomparire al livello denotativo Ciograve non vale soltan-to per i numeri interi ma anche per le loro parti i minuti secondi appar-tengono alla specie lsquoquadratorsquo in quanto 13600 egrave il quadrato di 160
La concezione appare interamente dispiegata nellrsquointroduzione degli Arithmetica diofantei79 che si rivela giova farlo rimarcare un te-stimone fondamentale per la ricostruzione della notazione matematica antica Alle specie usate in questrsquoopera vengono assegnati una denomi-nazione ed un segno convenzionale costituito dallrsquoiniziale (di ognuno dei componenti) della denominazione al quadrato o δύναμις il segno ΔΥ al κύβος il segno ΚΥ alla lsquoquarta potenzarsquo o δυναμοδύναμις il segno ΔΥΔ ecc La descrizione di tali segni egrave del tipo καὶ ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον Κ ἐπίσημον ἔχον Υ ΚΥ κύβος laquoe il suo segno egrave un Κ che ha come indice un Υ ΚΥ cuboraquo dove in accordo con quanto abbiamo visto nel punto b supra e pur nel comprensibile imbarazzo del copista della prima parte del Matritensis (o di un suo passato collega) a districarsi in questo formidabile ginepraio notazionale80 le due lettere Κ e Υ ricevono una barra mentre ΚΥ non la richiede a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον il quale ancora una volta esclude automaticamente il segno dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
79 In particolare a DOO I pp 214-62180 Nel Matr 4678 riscontriamo i seguenti fenomeni nelle poche righe a cavallo dei ff
58r-v 1) accento acuto posto su tutti i segni come se fossero abbreviazioni 2) ripetizione sistematica segnodenominazione come in ΚΥ κύβος appena letto dovuta sicuramente allrsquointrusione di glosse interlineari esplicative dei segni ndash e successivo pentimento (δύναμις e κύβος sono in effetti cancellati dalla prima mano il primo con un tratto il secondo con dei punti supra lineam poi il copista si stanca di correggere) 3) nella descrizione del segno per la δυναμοδύναμις menzione di un δέλτα δύο che saragrave molto probabilmente stato ΔΔ subito dopo nella descrizione del κυβόκυβος si legge un incongruo δύο KK
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 155
Diofanto introduce poi dei segni anche per le specie delle parti dellrsquounitagrave (le nostre frazioni) che egli chiama ὁμώνυμα μορία laquoparti omonimeraquo di cui quelle sessagesimali sono casi particolari81 Egli spie-ga appunto che le loro denominazioni sono ottenute da quelle delle specie degli interi per sinonimia passando ad un lsquoordinalersquo82 formato semplicemente aggiungendo il suffisso -στον δυναμοστόν κυβοστόν δυναμοδυναμοστόν ecc (sott μόριον) I loro segni convenzionali sono invece ottenuti da quelli per le specie degli interi aggiungendo una γραμμὴν διαστέλλουσαν τὸ εἶδος laquolinea che distingue la specieraquo83 Una linea sui segni delle specie delle parti egrave richiesta si badi bene per distinguerli dai segni di quelle degli interi come giagrave osservato questi ultimi sono giagrave lsquoagrammaticalirsquo a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον a fortiori lo saranno anche i primi Si tratta della traduzione semio-tica del passaggio dal cardinale allrsquoordinale che a livello grammaticale egrave effettuato con il suffisso -στον Che forma ha questa linea Barra o apice (Egrave cervellotico pensare a forme piugrave complesse) La domanda non ammette una risposta immediata in quanto delle specie diofantee nessuno piugrave si occupa nellrsquoantichitagrave84 Se egrave vero che la prima risposta darebbe origine ad un conflitto tra due convenzioni denotative diffe-renti la barra lsquocitazionalersquo e la barra che distingue la specie lrsquoevidenza grafica del Matritensis lascia lievemente sgomenti (ricordiamoci che giagrave i segni di base sono indebitamente dotati di un accento dal copista) Le poche occorrenze del segno per le specie delle parti85 vedono lrsquoaggiunta di uno slash di sospensione di un doppio apice inverso ndash in tutta evi-
81 Questo fatto era giagrave chiaro nellrsquoantichitagrave Teone in Alm I 10 in iA p 45310-1682 Il parallelo con i cardinali e gli ordinali relativi agli interi egrave reso esplicito da Dio-
fanto ὥσπερ δὲ τῶν ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια παρομοίως καλεῖται τοῖς ἀριθμοῖς τοῦ μὲν τρία τὸ τρίτον τοῦ δὲ τέσσαρα τὸ τέταρτον οὕτως καὶ τῶν νῦν ἐπονομασθέντων ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια κληθήσεται παρομοίως τοῖς ἀριθμοῖς laquocome le parti omonime dei numeri sono chia-mate per assonanza con i numeri di lsquotrersquo lsquolsaquounrsaquo terzorsquo di lsquoquattrorsquo lsquolsaquounrsaquo quartorsquo cosigrave le parti omonime dei numeri appena nominati saranno chiamate per assonanza con i numeriraquo (DOO I p 69-13 si noti lrsquoarticolo lsquocitazionalersquo al singolare in τοῦ τρία e τοῦ τέσσαρα) Il parallelo prosegue anche al livello dei segni che rappresentano queste specie come vedremo tra un attimo
83 Diofanto Arithmetica prefazione in DOO I p 620-21 un passaggio maltrattato in questa edizione occorre espungere il participio ἔχον senza introdurre segni ulteriori oppure eliminare un precedente ἐπί come fa un correttore del Matritensis f 58v
84 Unica parzialissima eccezione lrsquoaccenno di Teone menzionato nella nota 81 supra85 Al f 59r e per di piugrave nel margine per sanare un lungo saut du mecircme au mecircme La
collocazione in margine egrave il motivo per cui troviamo una notazione abbreviata nel resto del trattato il primo copista scioglie tutti i segni prendendoli per abbreviazioni mentre il secondo elimina sistematicamente il tratto aggiuntivo delle specie delle parti dellrsquounitagrave Drsquoaltronde egli scrive ad esempio ΔΥ invece di ΔΥ ed egrave quindi indotto a porre la barra al di sopra della stringa di lettere risultante (passim ma si veda ad esempio il f 72r)
Fabio Acerbi156
denza il compendio per la desinenza -ον accentata il copista interpreta il segno come unrsquoabbreviazione ndash e di una barra a sormontare lo Υ Potremmo forse interpretarlo come il segno di contrazione del grafema -στ- lrsquounico tassello mancante in unrsquoabbreviazione come ad esempio (δυναμοδυναμο)(στ)(ὸν) ma uno scolio di prima mano al f 58v rela-tivo alle specie degli interi inficia questrsquoipotesi esse sono dotate di slash di sospensione accento acuto in un caso del compendio canonico per la terminazione -ον hellip ma tutti gli Υ a esponente sono a loro volta sormontati da una barra
Meno legata al singolo manoscritto ma nondimeno non uniforme si presenta la pratica di notazione dei segni che rappresentano gli enti numerici sessagesimali86 da una parte sta lrsquoevidenza del testo dei Pro-legomena e delle sue tabelle apici ndash drsquoaltronde come abbiamo visto la notazione universalmente impiegata per i numerali ordinali e per le fra-zioni unitarie ndash dallrsquoaltra sta lrsquoevidenza del testo dellrsquoAlmagesto in tutti i manoscritti piugrave antichi e lo stesso si dica del commentario teonino a questrsquoopera o del suo lsquoGrande commentariorsquo alle Tavole facili e dei testi astronomici su papiro barre87 Sembra insomma che la nostra docu-
86 Sia le molteplicitagrave che le specie ahimeacute entrambe rappresentate da lettere dellrsquoalfabeto Come osservato allrsquoinizio della sezione 3 ci sono in effetti due tipi di lettere numerali in gioco se facciamo astrazione da apici o barre lsquo4 minuti secondirsquo si trova scritto δ β la prima lettera numerale denota la molteplicitagrave degli item di una certa specie la se-conda la specie nei Prolegomena entrambe sono accompagnate da un doppio apice il che rende inutile la presenza delle seconde Si noti che la descrizione della tabella non fa parola della notazione da usare per le lettere numerali che denotano la molteplicitagrave barre o apici e quanti apici hellip In questo caso fa interamente fede la tabella cioegrave la pratica grafica condivisa instauratasi non egrave chiaro quando
87 I manoscritti piugrave antichi dellrsquoAlmagesto sono menzionati nella nota 10 supra quelli dei due commentarii teonini sono il Laur Plut 2818 e il celeberrimo Vat gr 190 (sec IX in Euclide Elementi Data Teone lsquoGrande commentariorsquo) per la notazione dei pa-piri astronomici si veda Jones 1999 II passim La notazione non sembra lsquoinquinatarsquo dalla pratica dei copisti bizantini e pare dipendere soltanto dalla data di composizione Tro-viamo ad esempio barre sopra tutti i numerali di molteplicitagrave (interi o sessagesimali) nel frammento di un commentario alle Tavole facili contenente un calcolo relativo al 24 aprile 213 (Par gr 2841 sec XIII ex-XIV in oltre al frammento ai ff 32r l 11-34v l 23 contiene Arato Phaenomena ed Efestione Apotelesmatica edizione in Jones 1990) Nel commentario alle Tavole facili composto ca 610-617 ed attribuito a Stefano di Alessandria la situazione egrave la seguente (Jean Lempire per litteras per lrsquoedizione si veda Lempire 2014 ho controllato il Vat gr 304 ff 135r-171v sec XIV am contiene in aggiunta Teone in Almagestum I-II lsquoPiccolo commentariorsquo alle Tavole facili Diofanto Arithmetica e De polygo-nis numeris varia astronomica tabulae) barre sopra gli interi sporadicamente rimpiazzate da apici apici sopra le parti sessagesimali in numero uguale alla denominazione doppio () apice per le frazioni unitarie Sono impiegate barre sopra gli interi e apici sopra le parti sessagesimali nei manoscritti principali di tutti i trattati di introduzione allrsquoAlmagesto o comunque di argomento logistico redatti in epoca bizantina Giorgio Pachimere (1242-ca 1310) Quadrivium (autografo nel manoscritto Roma Biblioteca Angelica gr 38 [RGK III nr 115] si veda Tannery ndash Steacutephanou 1940 per lrsquoedizione) Teodoro Metochita (1270-
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 157
mentazione si faccia testimone di un cambio notazionale avvenuto nel periodo intercorrente fra Teone (sec IV pm) e la scuola alessandrina di Ammonio e dei suoi allievi (sec VI in) e probabilmente innescato da questrsquoultimo ambiente lrsquoaspetto paradossale egrave che nello stesso codice si rintraccino due notazioni differenti per gli enti numerici sessagesimali e lrsquouna (apici) sia adottata sistematicamente e coerentemente in uno scritto (i Prolegomena) che si presenta esattamente come unrsquointroduzione tecnica alla pratica numerico-algoritmica del trattato (lrsquoAlmagesto) in cui egrave adottata lrsquoaltra (barre che ritroviamo senza eccezioni anche negli scolii)
Torniamo ai Prolegomena la descrizione del segno da porre a fianco di ogni singolo quoziente parziale e denotante la sua specie numerica (minuti primi minuti secondi ecc) solleva tre problemi
Primo problema Ci vuole una barra o un apice su τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquola lettera A [hellip] che significa la specieraquo quando lo scriviamo nella tabella Tutta la nostra discussione precedente fa pro-pendere per lrsquoapice e si ricordi anche la forma verbale ἀνατείνουσαν che suggerisce qualcosa che si lsquoestende verso lrsquoaltorsquo (la mia traduzione egrave volutamente neutra) se fosse apposta una barra la cosa dovrebbe passare
1231332) Compendium astronomicum (copia lsquoautorizzatarsquo coeva nei Vat gr 182 e 181 da parte del copista che integrograve le parti mancanti del Par gr 2389 [ff 207-210 255-270 374-375] Bianconi 2005a pp 425-427 Peacuterez Martiacuten 2008 p 436 e n 177) Teodoro Meliteniota (morto lrsquo831393) Tribiblos astronomica (autografo nel Vat gr 792 si vedano Leurquin 1991 per unrsquoanalisi del manoscritto Leurquin 1990 per lrsquoedizione) una com-pilazione anonima (per cui ho consultato il Par gr 2396 ff 87r-92v limitatamente a questi fogli manu Costantino Trivoli [RGK II nr 318 ma ovviamente questo codice non vi egrave segnalato] terzo quarto del XV secolo il resto del codice annotato da Niceforo Gregora egrave di etagrave planudea e parzialmente [ff 33v-76v] un autografo di Planude stesso contiene Teone in Almagestum I II IV Mondrain 2002 il codice va completato ndash limitatamente a stralci dei libri VIII-X XII-XIII del commentario teonino la cui parte intermedia si egrave persa ndash con 26 carte [ff 123-147] inserite nel Vat gr 1087 anchrsquoesso contenente anno-tazioni di Gregora Rome 1927 per la figura del copista dei ff 77r-86r del Par gr 2396 e dei ff appena nominati del Vat gr 1087 un anonimo collaboratore di Gregora si veda in ultimo Bianconi 2006a pp 147-151) si veda anche il calcolo effettuato da Niceforo Gre-gora (12921295-13581361) dellrsquoeclisse di sole del 16 luglio 1330 (attestata unicamente ai ff 1r-8v della miscellanea astronomica Marc gr 325 databile ca 1324-1329 in parte vergata e ovunque fittamente annotata da Gregora stesso edizione del testo in Mogenet et al 1983 annotazioni di Gregora elencate in Bianconi 2005a p 413) Unrsquoeccezione apparente il lsquoPiccolo commentariorsquo di Teone alle Tavole facili le parti sessagesimali sono segnalate da apici (ad esempio nel Vat gr 175 vergato da Giovanni Catrario e completato nel 1321-1322 sulla figura di Catrario si vedano in ultimo Bianconi 2005b pp 141-156 e 2006b) lrsquoopera egrave antica ma la sua tradizione non rimonta oltre la fine del XIII secolo a parte un frammento nel Leiden BPG 78 ff 156r-161v (minuscola del IX-X secolo) e in effetti in questo manoscritto tutti i numerali di molteplicitagrave sono sormontati da barre Unrsquoeccezione effettiva egrave il De hypotesibus planetarum nel Vat gr 1594 barre sugli interi e apici sulle parti sessagesimali
Fabio Acerbi158
sotto silenzio e la presenza dellrsquoapice la rende inutile88 Si tratta della stessa convenzione diofantea e coincide ancora con la notazione per i numerali ordinali e per le frazioni unitarie che egrave corrente nei mano- scritti matematici greci per questo motivo non percheacute la descrizione sia particolarmente perspicua nessuno dei copisti della recensione an-tica ha incertezze apici Ma questi apici si rintracciano soltanto sulle indicazioni di specie non contemplate dalla descrizione che sono ante-poste ai resti parziali a fianco dei quozienti parziali i segni di specie sono invece trasformati in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordi-nali corrispondenti del tipo πρωτ tavv 5 e 7b-8 Il recensore bizantino taglia invece la testa al toro elimina dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali elimina la seconda menzione della laquolet-tera Araquo contestualmente allrsquoazzeramento dellrsquoespediente della linea a zig-zag (si veda il punto seguente) modifica la descrizione che contiene la prima menzione in quella dellrsquoapice associato direttamente ai nume-rali di molteplicitagrave riciclando addirittura lrsquoalpha per adibirlo a desi-gnare un numero cardinale (come sorprendersi) τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ laquoponendo al di sopra di essi [scil dei 50 minuti primi] 1 solo lsaquoaccentorsaquo acutoraquo La scelta del recensore egrave assennata che rechi una barra o un apice in una tabella un alpha denota un numero non un numero drsquoordine
Secondo problema da tenere ben distinto dal precedente Cosa ci vuole sul segno α per la lettera alpha menzionata nella frase τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquolettera A [hellip] che significa la specieraquo89 Unrsquooc-chiata allrsquoapparato critico rivela una bella incertezza nei manoscritti Z scrive sempre ᾱ e in un caso lo fa anche P MS optano sempre per α´ C per α P scrive nellrsquoaltro caso αο Per quanto solo la barra sia congrua con il senso della frase in quanto la lettera alpha egrave qui menzionata (si tratta di un oggetto che compare nella tabella) e non cambia niente se essa egrave accompagnata dal suo nome di genere στοιχεῖον ad un livello grafico lrsquoincertezza fra il segno ᾱ che denota laquola lettera αraquo e il segno α´ (o lrsquoabbreviazione αο) per una forma di πρῶτος egrave per piugrave versi giustificata
88 Detto in altri termini la barra egrave uno strumento grafico non matematico e quindi la sua presenza non va segnalata mentre un apice lo egrave e la sua presenza lo deve
89 Notare che in questa frase il primo α non vuole la barra (egrave menzionato allrsquointerno di una frase che impiega convenzioni moderne) il secondo sigrave (idem ma con convenzioni antiche) ndash e nella traduzione la scelta di denotarlo con A (senza virgolette) e non con lsquoArsquo (con virgolette) egrave del tutto arbitraria ndash si noti inoltre che le necessarie precisazioni laquosenzacon virgoletteraquo mostrano che le lingue moderne palesano difficoltagrave analoghe a quelle del greco antico per quanto riguarda i livelli denotativi in ambito metadiscorsivo per non usare le due parentetiche avrei dovuto scrivere rispettivamente lsquoArsquo e lsquolsquoArsquorsquo (doppie virgolette semplici)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 159
ᾱ coincide con il numerale 1 α egrave la prima lettera dellrsquoalfabeto ed inoltre α´ egrave esattamente quello che va scritto nella tabella Potremmo dirci che il sostantivo στοιχεῖον chiude la questione la sua presenza congiunta ad un ipotetico α´ renderebbe la descrizione ridondante o inappropriata90 Ma a parte il fatto che α egrave proprio τὸ πρῶτον στοιχεῖον il segno α´ cat-tura in fondo il cuore della descrizione di uno στοιχεῖον ἔχον lsaquoγραμμὴνrsaquo ἀνατείνουσαν
Terzo problema Lrsquoautore dei Prolegomena che si arresta allrsquoesem-pio dei minuti primi non dice quanti apici occorre mettere sulle lettere numerali che identificano gli ordini superiori al primo se uno soltanto come nel caso diofanteo e delle frazioni unitarie o in numero uguale alla loro denominazione (cioegrave pari al numero denotato dal numerale stesso su cui vanno posti) come effettivamente avviene nei mano-scritti dei Prolegomena La tabella egrave quindi sottodeterminata dalla sua descrizione anzi in un certo senso prende il sopravvento su di essa la pratica di marcare i numerali di molteplicitagrave con gli apici che compe-tono allrsquoordine cui appartengono viene trasferita ai segni per gli ordini stessi per supplire ad una descrizione carente di questi ultimi E la tabella egrave sottodeterminata dalla descrizione in quanto egrave la descrizione di una tabella reale ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις laquocome nello lsaquoschemarsaquo espostoraquo leggiamo a un certo punto del testo
3) La linea a zig-zag Non possiamo che applaudire a questo geniale espediente grafico lo troviamo messo in opera solo nel Marc gr 313 Per quanto lrsquoautore non faccia parola di ciograve nel corso della sua descrizione la linea spezzata egrave intesa dover lsquosaltarersquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue Il copista del codice marciano effettua correttamente due salti nella prima delle sue tabelle (tav 4) ma inserisce un lsquodentersquo in piugrave in quella che considera corretta (tav 5) La linea a zig-zag egrave incompatibile con la presenza di linee di giustificazione nella tabella che in effetti mancano nel Marc gr 313 ciograve induce gli errori di allineamento dei primi 5 quozienti parziali di cui egrave vittima il copista Probabilmente per questo motivo in nessuno degli apografi del Vat gr 1594 la linea a zig-zag figura nella tabella inquadrata come si conviene da una (doppia) cornice esterna e le cui colonne sono appunto separate da linee verticali (tav 7b Vat gr 184 f 17v e tav 8 Par gr 2390 f 9v cui egrave sostanzialmente identica la tabella del Marc gr 314 che si trova
90 Trascuro lrsquoabbreviazione αο = πρῶτος percheacute la desinenza non egrave quella richiesta neacute nella frase (egrave richiesto πρῶτον) neacute nella tabella (πρῶτα)
Fabio Acerbi160
al f 248r ndash ma la mancanza di linee orizzontali causa un gigantesco pa-sticcio nel codice vaticano) Alla recensione bizantina che dipende per il suo testo di base dal Vat gr 1594 e quindi non trova la linea a zig-zag nella tabella non resta che sopprimere la sua descrizione ndash ma proprio per questo motivo e finalmente diventa possibile tracciare un apparato completo di linee di giustificazione (tav 9 Laur Plut 89 sup 48 f 14v) Dato che la descrizione di Teone di questo procedimento di divi-sione non fa cenno allrsquoesistenza della linea a zig-zag viene da chiedersi se essa non costituisca un espediente escogitato dallrsquoautore dei Prolegomena per vivacizzare la procedura originale di Pappo
4) Discrepanze tra descrizione e tabella Il gioco delle minime va-rianti mostra che la divisione era stata eseguita (e trasmessa) corret-tamente tutti i valori numerici sono esatti La tabella nel Marc gr 313 presenta perograve alcune discrepanze con la propria descrizione Essa omette (ma non nella versione lsquoscorrettarsquo lrsquoomissione non si riscontra neanche nel Par gr 2390) il segno per laquorestoraquo di fronte ai resti par-ziali ma aggiunge lrsquoindicazione della loro specie Essa trasforma invece come abbiamo visto le indicazioni di specie che seguono i quozienti parziali in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordinali corri-spondenti La descrizione prevede di chiudere la tabella con il risultato καὶ συνάγων ἅπαντα τὰ ἐκ τῶν μερισθέντων μερῶν λεπτὰ σημειοῦται ὑπὸ πάντας οὕτως γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoe raccogliendo tutti i minuti che provengono dalle parti divise lsaquoPapporsaquo nota sotto tutto cosigrave Ris 0 59 8 17 13 12 31raquo ma sotto la tabella tutta la tradizione ci consegna qualcosa di piugrave articolato ὁ ζητούμενος καθ᾽ ὃν μερίζεται ὁ τξε ιδ´ μη´´ π(αρὰ) τὸν τξ γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoil lsaquonumerorsaquo cercato secondo cui 365 14 48 egrave diviso per 360 risulta 0 59 8 17 13 12 31raquo frase che del resto contiene due errori lrsquoinversione del dividendo e del divisore e la confusione tra segno convenzionale (iuxta descrizione) e abbreviazione (come nella frase) nel caso di γι Oltre ad eliminare la linea a zig-zag91 la recensione bizantina sopprime dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali e modifica come abbiamo visto al punto 2 le loro descrizioni in quelle di apici associati diretta-mente ai numerali di molteplicitagrave
91 Le due righe che nella recensione di base contengono solo i resti parziali minori di 160 del divisore ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue sono in parte completate con lrsquoindicazione abbreviata ἀνάλ(υσις) laquoanalisiraquo il termine greco per questa procedura di riduzione In un sussulto di ipercorrettismo matematico tali resti parziali ridotti non sono preceduti dal segno per laquorestoraquo come nel Par gr 2390 ma da quello per laquorisultatoraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 161
Gli esempi che abbiamo discusso mostrano come i problemi di notazione pesino e non poco sullrsquoespressione discorsiva di un algorit-mo matematico lrsquoente di riferimento per lsquoformularersquo il procedimento di divisione fu considerata la tabella cioegrave un oggetto la cui costitu-zione egrave legata piugrave ad una pratica grafica che a considerazioni logico- algoritmiche non la sua descrizione che in effetti finisce per determi-nare la tabella in maniera non univoca Di questa sottodeterminazione si fa testimone la traiettoria che abbiamo cercato di seguire nelle mani di copisti e revisori il procedimento di divisione si modifica a volte in aspetti secondari a volte in punti piugrave sostanziali ndash fino a rendere neces-saria una radicale revisione della sua descrizione per renderla conforme alla tabella ndash in ogni caso mai per ragioni squisitamente matematiche92
Abstract
The article presents and discusses in detail two passages from the anonymous Prolegomena to the Almagest a VIth century primer to the elementary procedures of calculation needed in Ptolemyrsquos Almagest In the two passages we may follow the complex interplay between mathematical notation the auctor who employed and described it the tachygrapher who transcribed it in vivo copyists who reproduced it correctors who modified it Along this path misgivings and errors arise in the transmission of abbreviations and paratextual units such as diagrams tables operational schemes
Fabio AcerbiCNRS UMR8560 Centre Alexandre Koyreacute
fabacerbigmailcom
92 Sono grato a Daniele Bianconi Lucio del Corso Jean Lempire per alcune preziose indicazioni
AOO = Archimedis opera omnia cum commentariis Eutocii ed J L Heiberg I-III Lipsiae 1910-1915
DOO = Diophanti Alexandrini opera omnia cum Graecis commentariis ed P Tannery I-II Lipsiae 1893-1895
GC = Le laquoGrand Commentaireraquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Mogenet ndash A Tihon I-III Cittagrave del Vaticano 1985-1999
iA = Commentaires de Pappus et de Theacuteon drsquoAlexandrie sur lrsquoAlmageste ed A Rome I-III con paginazione continua Cittagrave del Vaticano 1931-1943
HOO = Heronis Alexandrini opera quae supersunt omnia ed G Schmidt ndash L Nix ndash W Schmidt ndash H Schoene ndash J L Heiberg I-V Lipsiae 1899-1914
PC = Le ldquoPetit Commentairerdquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed A Tihon Cittagrave del Vaticano 1978
POO = Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia ed J L Heiberg I-II in 3 parti Lipsiae 1898-1907
RGK = Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600 I Handschriften aus Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln II Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs und Nachtraumlge zu den Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln III Handschriften aus Bibliotheken Roms mit dem Vatikan A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg unter Mitarbeit von D Harlfinger und P Eleuteri B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln Wien 1981-1997 (Oumlsterreichische Akademie der Wissenschaften Veroumlffentlichungen der Kommission fuumlr Byzantinistik III1-3 A-C)
Sigla
Acerbi 2010 = F Acerbi Il silenzio delle sirene La matematica greca antica Roma 2010
Acerbi 2012 = F Acerbi I codici stilistici della matematica greca dimostrazioni procedure algoritmi laquoQUCCraquo 1012 (2012) pp 167-214
Acerbi et al 2010 = F Acerbi ndash N Vinel ndash B Vitrac Les Proleacutegomegravenes agrave lrsquoAlmageste Une eacutedition agrave partir des manuscrits les plus anciens Introduction geacuteneacuterale ndash Parties I-III laquoSCIAMVSraquo 11 (2010) pp 53-210
Agati 1992 = M L Agati La minuscola laquoBouleteacuteeraquo Cittagrave del Vaticano 1992
Belger 1881 = C Belger Ein neues Fragmentum mathematicum Bobiense laquoHermesraquo 16 (1881) pp 261-284
Bianconi 2005a = D Bianconi La biblioteca di Cora tra Massimo Planude e Niceforo Gregora Una questione di mani laquoSampTraquo 3 (2005) pp 391-438
Bianconi 2005b = D Bianconi Tessalonica nellrsquoetagrave dei Paleologi Le pratiche intellettuali nel riflesso della cultura scritta Paris 2005
Bianconi 2006a = D Bianconi Le pietre e il ponte ovvero identificazioni di mani e storia della cultura laquoBizantinisticaraquo 8 (2006) pp 135-181
Bianconi 2006b = D Bianconi Qualcosa di nuovo su Giovanni Catrario laquoMEGraquo 6 (2006) pp 69-91
Cavallo 1977 = G Cavallo Funzione e strutture della maiuscola greca tra i secoli VIII-XI in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Colloque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 95-137
Cereteli 1904 = G F Cereteli De compendiis scripturae codicum Graecorum praecipue Petropolitanorum et Mosquensium anni nota instructorum Sankt-Petersburg 1904
De Gregorio 2000 = G De Gregorio Materiali vecchi e nuovi per uno studio della minu-scola greca fra VII e IX secolo in G Prato (a cura di) I manoscritti greci tra riflessione e dibattito Atti del V Colloquio Internazionale di Paleografia Greca Cremona 4-10 ottobre 1998 Firenze 2000 pp 83-151
Follieri 1977 = E Follieri La minuscola libraria dei secoli IX e X in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Col-loque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 139-165
Fonkič 2005 = B Fonkič Venecianskaia rukopisrsquo laquoAlrsquomagestaraquo Ptolemeja (Marc gr 313690) o datirovke i proischoždenii kodeksa laquoVDIraquo s III 254 (2005) pp 162-167
Fowler 1999 = D H Fowler The Mathematics of Platorsquos Academy A New Reconstruction Second Edition Oxford 1999
Bibliografia
Fabio Acerbi164
Gerstinger ndash Vogel 1932 = H Gerstinger ndash K Vogel Eine stereometrische Aufgaben-sammlung im Papyrus Graecus [sic] Vindobonensis 19996 laquoMitteilungen aus der Papy-russammlung der Nationalbibliothek in Wienraquo Neue Serie Folge 1 Griechische literarische Papyri 1 Wien 1932 pp 11-76
Heiberg 1927 = Mathematici Graeci Minores ed J L Heiberg Kjoslashbenhavn 1927
Hultsch 1876-1878 = Pappi Alexandrini Collectionis quae supersunt ed F Hultsch I-III Berlin 1876-1878
Janz 2003 = T Janz The Scribes and the Date of the Vat gr 1291 in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae X Cittagrave del Vaticano 2003 pp 159-180
Jones 1990 = Ptolemyrsquos First Commentator ed A Jones Philadelphia 1990
Jones 1999 = Astronomical Papyri from Oxyrhynchus ed A Jones I-II Philadelphia 1999
Jones 2005 = A Jones Ptolemyrsquos Canobic Inscription and Heliodorusrsquo Observation Reports laquoSCIAMVSraquo 6 (2005) pp 53-97
Lempire 2014 = Steacutephanos drsquoAlexandrie Le commentaire aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Lempire Louvain 2014
Leurquin 1990 = Theacuteodore Meacuteliteacuteniote Tribiblos astronomique Livre I ed R Leurquin Amsterdam 1990
Leurquin 1991 = R Leurquin Un manuscrit autographe de la Tribiblos Astronomique de Theacuteodore Meacuteliteacuteniote le Vaticanus graecus 792 laquoScriptoriumraquo 45 (1991) pp 145-162
Maas 1927 = P Maas Griechische Palaeographie in A Gercke ndash E Norden (hrsg von) Einleitung in die Altertumswissenschaft I9 Leipzig 1927 pp 69-80
Martinelli Tempesta 2010 = S Martinelli Tempesta Il codice Milano Biblioteca Am-brosiana B 75 sup (gr 104) e lrsquoevoluzione della scrittura di Giovanni Scutariota in A B Garciacutea ndash I Peacuterez Martiacuten (ed by) The Legacy of Bernard de Montfaucon Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting Proceedings of the Seventh Inter-national Colloquium of Greek Palaeography Madrid-Salamanca 15-20 September 2008 Turnhout 2010 pp 171-186
Mazzucchi 1994 = C M Mazzucchi Leggere i classici durante la catastrofe (Costantino-poli maggio-agosto 1203) le note marginali al Diodoro Siculo Vaticano gr 130 Parte prima stratigrafia laquoAevumraquo 68 (1994) pp 164-218
Mioni 1976 = E Mioni Bessarione scriba e alcuni suoi collaboratori in Miscellanea marcia-na di studi bessarionei Padova 1976 pp 263-323
Mioni 1985 = Codices graeci manuscripti Bibliothecae Divi Marci Venetiarum II Thesaurus Antiquus Codices 300-625 recensuit E Mioni Roma 1985
Mogenet 1962 = J Mogenet Une scholie ineacutedite du Vat gr 1594 sur les rapports entre lrsquoastronomie arabe et Byzance laquoOsirisraquo 14 (1962) pp 198-221
Mogenet et al 1983 = Niceacutephore Greacutegoras Calcul de lrsquoeacuteclipse de soleil du 16 juillet 1330 ed J Mogenet ndash A Tihon ndash R Royez ndash A Berg Amsterdam 1983
Mondrain 2002 = B Mondrain Maxime Planude Niceacutephore Greacutegoras et Ptoleacutemeacutee laquoPa-laeoslavicaraquo 10 (2002) pp 312-322
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 165
Mondrain 2004 = B Mondrain Lrsquoancien empereur Jean VI Cantacuzegravene et ses copistes in A Rigo (a cura di) Gregorio Palamas e oltre Studi e documenti sulle controversie teologiche del XIV secolo bizantino Firenze 2004 pp 249-296
Mondrain 2007 = B Mondrain Les eacutecritures dans les manuscrits byzantins du XIV e siegravecle Quelques probleacutematiques laquoRSBNraquo n s 44 (2007) pp 157-196
Peacuterez Martiacuten 2006 = I Peacuterez Martiacuten Maxime Planude et le Diophantus Matritensis (Madrid Biblioteca Nacional ms 4678) un paradigme de la reacutecupeacuteration des textes anciens dans la ldquorenaissance paleacuteologuerdquo laquoByzantionraquo 76 (2006) pp 433-462
Peacuterez Martiacuten 2008 = I Peacuterez Martiacuten El lsquoestilo Hodegosrsquo y su proyeccioacuten en las escrituras constantinopolitanas laquoSampTraquo 6 (2008) pp 389-458
Perria 1991 = L Perria Scrittura e ornamentazione nei codici della laquocollezione filosoficaraquo laquoRSBNraquo n s 28 (1991) pp 45-111
Rollo 2012 = A Rollo LrsquoArchimede di Giorgio Valla in V Fera ndash D Gionta ndash A Rollo (a cura di) Archimede e le sue fortune Atti del Convegno di Siracusa-Messina 24-26 giugno 2008 Messina 2012 pp 99-147
Rome 1927 = A Rome Membra disjecta laquoRBenraquo 39 (1927) pp 187-188
Rome 1938 = A Rome Un manuscrit de la bibliothegraveque de Boniface VIII agrave la Meacutediceacuteenne de Florence laquoACraquo 7 (1938) pp 261-268
Ronconi 2013 = F Ronconi La collection philosophique un fantocircme historique laquoScripto-riumraquo 67 (2013) pp 119-140
Tannery ndash Steacutephanou 1940 = Quadrivium de Georges Pachymegravere ed P Tannery ndash E Steacutephanou Cittagrave del Vaticano 1940
Tihon 2011 = Πτολεμαίου Πρόχειροι Κανόνες Les Tables faciles de Ptoleacutemeacutee vol Ia Tables A1-A2 ed A Tihon Leuven 2011
Traube 1907 = L Traube Nomina Sacra Versuch einer Geschichte der christlichen Kuumlrzung Muumlnchen 1907
Vogel 1936 = K Vogel Beitraumlge zur griechischen Logistik laquoSBAWraquo Mathematisch-natur-wissenschaftliche Abteilung Jahrgang 1936 pp 357-472
Wouters 1979 = A Wouters The Grammatical Papyri from Graeco-Roman Egypt Contri-butions to the Study of the lsquoArs Grammaticarsquo in Antiquity Brussel 1979
F ACERBI Tav 1
b Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 65r
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 284 f 160r
F ACERBITav 2
b Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 13r
a Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 19v
F ACERBI Tav 3
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 136v
F ACERBITav 4
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17r
F ACERBI Tav 5
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17v
F ACERBITav 6
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 7v
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
Fabio Acerbi148
modifica tutte le descrizioni diluendo lrsquoidiomatismo dellrsquoarticolo lsquocita-zionalersquo con lrsquointroduzione sistematica del verbo δηλόω e di frasi atte a chiarire quale sia il segno denotante e quale il vocabolo (o il segno) denotato Egli introduce allo scopo di rendere esplicita la funzione de-notativa dei segni introdotti il termine σημείου curiosamente in tutte le sue tre occorrenze esso compare a sua volta nella forma dellrsquoabbrevia-zione per sospensione σΗ´ Egli traccia il segno per i massimi multipli ἀφ e quello per i resti λ οι` in modo che non vi siano ambiguitagrave quanto al loro carattere di abbreviazione Si faccia infine attenzione al residuo di barra sul παρᾱ con funzione denotativa (2 occorrenze) contenuto nella descrizione del segno per il divisore sostituita dallrsquoaccento grave nel παρὰ con funzione discorsiva (la differenza egrave nettissima nei manoscritti da me consultati) Questa osservazione ci permette di passare direttamente allrsquoitem seguente
b) Le barre sui numerali e sulle lettere denotative Egrave opportuno discutere questo punto adesso esattamente percheacute di barre siffatte che pure troviamo in tutti i manoscritti i nostri testi non fanno mai menzione si tratta infatti di una pratica condivisa sin dallrsquoantichitagrave La barra identifica una stringa di lettere dellrsquoalfabeto che non svolge una funzione grammaticale o sintattica propria allrsquointerno del discorso Ciograve avviene in particolare e si tratta della fattispecie piugrave frequente se la stringa di lettere non dagrave origine a un vocabolo della lingua greca lette-re denotative e numerali certo ma anche termini provenienti da altri idiomi e contrazioni di parole greche come i nomina sacra62 tali termi-ni possono essere o no preceduti da un articolo lsquocitazionalersquo a seconda dellrsquouso che ne viene fatto allrsquointerno del discorso Ma non si tratta dellrsquounica fattispecie i papiri grammaticali ed i manoscritti piugrave antichi dei trattati dello stesso argomento segnalano gli esempi delle parti del discorso (cioegrave di lsquoverersquo parole greche) per mezzo di barre sormontanti63 La differenza insomma egrave tra menzione e uso (come parte del discorso in atto) di una stringa di caratteri tra il porre le lsquovirgolettersquo e il non porle tra funzione denotativa e non Apparentemente la convenzione si limi-
corredata dei segni opportuni e contrariamente alle indicazioni della descrizione svilup-pata lsquoin verticalersquo ma per motivi misteriosi non completa (tav 7a Laur Plut 89 sup 48 f 13r)
62 Tutto ciograve egrave spiegato con estrema chiarezza giagrave in Traube 1907 pp 45-4763 Si veda il Par gr 2548 codex vetustissimus e testimone unico delle lsquoopere minorirsquo
di Apollonio Discolo il f 106v con le barre ben visibili egrave riprodotto come tav 19 in De Gregorio 2000 (ivi pp 137-138 per la datazione) Per la testimonianza dei papiri grammaticali si veda Wouters 1979 passim essi contengono di norma elenchi di parti del discorso nessuna delle quali egrave preceduta dallrsquoarticolo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 149
tava in questo secondo caso a segnalare con la barra singoli vocaboli le menzioni di frasi o di sintagmi complessi sono di norma identificate dallrsquoarticolo lsquocitazionalersquo Drsquoaltra parte le abbreviazioni convenzionali non rientrano nella casistica percheacute la loro resa grafica che contiene elementi non alfabetici come compendi per desinenze lettere supra li-neam marche di contrazione o sospensione quali slashes o barre sotto-poste o sormontanti eventualmente solo un sottinsieme della stringa di segni alfabetici le esclude automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
Venendo al discorso matematico una barra sormonta senza ecce-zione le lettere denotative64 che sia in papiri o in manoscritti in maiu-scola65 o minuscola ma solo allrsquointerno del testo comrsquoegrave da attendersi nei diagrammi esse la perdono per il semplice motivo che non crsquoegrave alcun testo ambiente un diagramma ha unicamente una funzione denotati-va Drsquoaltra parte le lettere numerali che a volte figurano nei diagrammi della tradizione metrica66 allo scopo di indicare la lunghezza dei seg-menti mantengono la barra in un diagramma il contesto denotativo geometrico egrave prevalente e i numerali vengono percepiti come entitagrave grafiche lsquoesternersquo al discorso Va da seacute a fortiori che le lettere numerali inserite in un testo dovranno essere segnalate da barre che a loro volta non servono nelle tavole67 in quanto queste ultime sono come abbiamo visto un vero e proprio testo che perograve funge da ambiente a quello al-fabetico limitato alle titolazioni e non a caso tracciato in unrsquoopportuna lsquomaiuscola distintivarsquo allo scopo di segnalarne il carattere denotativo e non discorsivo68 Una tabella operazionale egrave invece un paratesto e quindi le barre sulle lettere numerali che rappresentano gli interi sono
64 La notazione per le lettere denotative subigrave unrsquoevoluzione (il cui risultato finale egrave descritto per sommi capi nella nota 3 supra) di cui non mette conto occuparsi qui
65 I papiri di contenuto geometrico (o astronomici ma che presentano argomenti geometrici) sono rari si vedano il PHerc 1061 (sec II aC Demetrio Lacone De geome-tria) e il PFay 9 (sec II ex Elementi I 39 e 41) Gli importanti ostraka OBerl 12002 e 12609 (sec III aC m Elementi XIII) non pongono le barre sopra le lettere denotative Per i manoscritti in maiuscola si veda ad esempio passim nel Par gr 2389 una cui riproduzione digitale egrave consultabile in rete allrsquoindirizzo httpgallicabnffrark12148btv1b8470171d o il fragmentum mathematicum Bobiense
66 Si veda ancora il ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 codex unicus dei Metrica di Erone e contenente una raccolta importante di problemi del corpus metrologico
67 Si vedano come esempio le tavole citate alle note 10 e 14 supra Discorso a parte per il segno di lsquoposto vuotorsquo si veda il punto c che segue
68 Queste regole generali vanno prese cum grano salis si dagrave naturalmente un certo dominio di variabilitagrave legato verosimilmente al grado di cultura grafica del copista nel PMich III 144 i numerali sono quasi tutti senza barra sia nel testo che nelle tabelle ope-razionali
Fabio Acerbi150
necessarie esse mancano invece sui segni convenzionali che ho descrit-to nel punto precedente e fatto rilevante sulle lettere numerali relative agli ordini sessagesimali quando esse siano identificate da uno o piugrave apici la presenza di questo segno grafico non alfabetico69 le esclude ancora una volta automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo Unrsquoultima osservazione che ci saragrave utile nel seacuteguito la descrizio-ne di una stringa di lettere lsquoagrammaticalersquo non puograve prevedere la men-zione della presenza della barra che le pertiene in quanto tale si tratta di una pratica denotativa che egrave possibile formulare soltanto ad un livello di discorso superiore sia a quello dellrsquouso che a quello della menzione70
c) Il segno di lsquoposto vuotorsquo Si noti nella tav 2b la forma ŏ per il segno di lsquoposto vuotorsquo in un ordine sessagesimale coerentemente con la propria notazione il copista del Marc gr 313 lo scioglie talvolta allrsquoin-terno del testo principale come unrsquoabbreviazione per οὐδέν laquonienteraquo Altre convenzioni di scrittura del tratto che accompagna il circoletto e che si badi bene fa parte integrante del segno di lsquoposto vuotorsquo ndash e infatti nelle tavole troviamo sempre il segno completo mentre tutti gli altri numerali sono come abbiamo visto nel punto precedente privi di barra o di apice a causa del fatto che i vari ordini sessagesimali sono univocamente determinati dalle linee di giustificazione ndash un tratto an-golare anteposto (tav 3 Lar Plut 2818 f 136v)71 o una semplice barra a sormontare (tavv 4-9) si produce in questo modo il segno 65926 che sembra essere stata la forma di base72
69 Occorre dunque supporre come testimoniano papiri e manoscritti in maiuscola che la convenzione relativa allrsquouso della barra si sia consolidata ben prima dellrsquointroduzione di segni diacritici quali accenti e spiriti
70 Si veda il punto 2 infra per maggiori dettagli sulla questione delle barre e degli apici e per le indicazioni in merito che leggiamo in Diofanto
71 Come accennato questa tavola dei sottomultipli coincide con quella descritta ed esposta nei Prolegomena Fatto molto rilevante i numerali nella prima non recano neacute barre neacute apici contrariamente a quanto accade a tutte le istanze della seconda nei manoscritti Quella del Laur Plut 2818 preserva a mio avviso la forma originaria come abbiamo visto una tavola non richiede segni aggiuntivi sulle lettere numerali
72 Si vedano come esempio ancora le tavole citate alle note 10 e 14 supra oppure per una rassegna delle forme che il segno assume nei manoscritti piugrave antichi delle Tavole facili Tihon 2011 pp 58-59 e per quelle che assume nei papiri Jones 1999 I pp 61-62 Ovviamente non possiamo leggere il segno 65926 come un omicron con una barra in quanto ο = 70 nella notazione greca e la barra egrave di rigore quando il numerale figuri allrsquointerno di un testo Occorre ammettere che si dagrave origine ad un bel corto circuito notazionale con il concepire un segno con funzione di lsquoposto vuotorsquo ma che lsquosomigliarsquo ad una lettera dellrsquoalfabeto sormontata da una barra cioegrave ad un numerale in piugrave quando il lsquoposto vuotorsquo non corrisponda ad un intero ma ad una specie sessagesimale la presenza della barra a priori indistinguibile da quella che sormonta gli interi introduce unrsquoincongruenza con la notazione a mezzo di apici vista nellrsquoitem precedente
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 151
d) Errori di copia La tabella riprodotta nella tav 2b ha una forma simmetrica ma si tratta di una forzatura il grande rettangolo in basso a destra drsquoaltronde assente nella descrizione contiene uno scolio che fa notare come lrsquoultimo resto parziale ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ͵γτνζ´´´´´ κζ´´´´´´ cioegrave 0 0 0 0 0 3357 27 siano ἔγγιστα λ´λ´ δ´δ´ ξ laquocon ottima approssimazione 60 minuti quartiraquo dove si notino gli apici semplici per indicare il pas-saggio allrsquoordinale e il raddoppiamento del sistema segno + apice per significare il plurale Lo scolio debitamente accompagnato dal segno di rimando in forma di simbolo solare egrave stato probabilmente incluso nella tabella proprio allo scopo di renderla simmetrica A sua volta un errore precedente spiega lo spazio eccessivo accordato al rettangolo contenente lo scolio il secondo massimo multiplo ŏ λβ´ ξδ´´ ριβ´´´ σιϛ´´´´ egrave trascritto anche al di sotto del risultato
Passiamo ora alla descrizione del metodo di divisione attribuito a Pappo
ἵνα οὖν ταῦτα συναχθῇ τὰ ἐκ τοῦ μερισμοῦ ὁ εἰρημένος Πάππος εὐδιατύπῳ τινὶ καὶ πρὸς τοῦτο τάξει χρησάμενος ποιεῖται τὴν τῆς συλλήψεως τοῦ ζητουμένου ἀνεύρεσιν οὕτως ἐκθέμενος γὰρ τὸν μέλλοντα μερίζεσθαι τουτέστι τὰς τξ μοίρας ἐν ἀρχῇ ἀφαιρεῖ ἀπ᾽ αὐτῶν τὸν ἐν τῇ σελίδι τυγχάνοντα ἐλάττονα τουτέστι τὸν τδ κβ´ κ´´ ὄντα τῶν ἐγγὺς ἐλασσόνων ὡς πρὸς τοὺς ἐκκειμένους διὸ καὶ γράφει αὐτὸν προγράφων αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε καὶ εὑρίσκων τὰ παρακείμενα αὐτῷ τῷ ἀπογραφέντι ἐν τῷ σελιδίῳ λεπτὰ πρῶτα ν´ συναπογράφεται παρατιθῶν αὐτοῖς τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον ἀνατείνουσαν σημαῖνον τὸ εἶδος ὅτι πρῶτα λεπτά εὑρίσκει οὖν οὕτως τὸ τῶν τξ μέρος τὸ τδ κβ´ κ´´ ὃ μεριζόμενον παρὰ τὰς τξε ιδ´ μη´´ ἡμέρας καὶ ποιοῦν τὸν ἐκ τοῦ μερισμοῦ ἀριθμὸν πρῶτα λεπτὰ ν´ καὶ τὸν λοιπὸν ἀπογραφόμενος τὸν νε λζ´ μ´´ προτάσσει αὐτοῦ τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά τάσσει δὲ καὶ ἁπλῆν τινα διατείνουσαν γραμμὴν ὡς ἀπὸ τοῦ τξ ἐπὶ τὸν ἑξῆς ἐκτεθειμένον ἐγγὺς
1
5
10
1 εὐδιατύπῳ] ZSPC εὐδιατύπωτ M 4 ἀφαιρεῖ] MZSP ἀφ ι C 5 ἐλάττονα] P comp MZSC 6 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | αφ ] αφ ε M ἀφ ZS ἀφαί P ἄφ C | ἀντὶ] om C | ἄφελε] MZSP ἄφ C 8 ἀπογραφέντι] MZSP ἐγγραφέντι C | λεπτὰ πρῶτα] P λε πρωτα SC λεπτῶν πρωτ MZ | παρατιθῶν] MZS παρατιθεὶς C et ex corr m 2 P 9 ᾱ] Z αο P α´ MS α C | ἔχον] MPC ἔχων ZS 9-10 πρῶτα λεπτά] ZP πρωτ λ´λ´ M πρωτα λε S αα λε C 11 ἡμέρας] comp codd | ἀριθμὸν] P et comp MZ καὶ C et comp S 12 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M πρωτ λεπτ(α) Z πρωτ λ εᾱ S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C | ἀπογραφόμενος] MZSP ἐγγραφόμενος C | νε λζ´] MZSP λζ νζ C 13 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | λ οι] MZSC ex λ fecit λ οι P | προσσημαῖνον] MC et προσ- comp ZS προση- P | τὸ] MZC τὰ S et fecit m 2 P 14 ἀπὸ] MZSP πρὸς C ἐλάττονα] P comp MZSC
1 εὐδιατύπῳ] εὐδιατυπώτω K 6-7 αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ] τὸ ἀφ K 8 παρατιθῶν mdash 10 λεπτά] τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ σημαίνουσαν τὸ εἶδος αὐτῶν ὅτι ᾱ λεπτά εἰσιν K | τὸ (sec)] τὰ K 12 πρῶτα] πρώτων K | τε λ ] λ οι` K | προσσημαῖνον mdash
Fabio Acerbi152
ἐλάττονα τὸν τδ κβ´ κ´´ ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις καὶ ταύτην ἐπιδεικνύουσαν τὴν τάξιν τῆς προόδου τῆς ἐκθέσεως ἧστινος κλωμένης γραμμῆς πρὸς τῷ ἐγγὺς ἐλάσσονι ἡ ἀντανάκλασις ἐπὶ τὸν λοιπὸν γέγραπται φερομένη ὡς εἴρηται διὰ τὸ εὔτακτον τῆς προκοπῆς οὕτως τε ποιήσας ἑξῆς τὸ αφ ποιῶν ὃ προσσημαίνει ὡς εἴρηται τὸ ὅτι δεῖ ἀφελεῖν ὁμοίως ἀπὸ τοῦ λοιποῦ καὶ δὴ τὸν ἐγγὺς πάλιν ἐλάσσονα ὡς πρὸς τὴν ἐν τῷ σελιδίῳ ἔκθεσιν εὑρισκόμενον λαμβάνων ἑξῆς προγράφει αὐτὸν ὄντα νδ μζ´ ιγ´´ ιβ´´´ καὶ εὑρίσκει αὐτοῖς παρακείμενα ἐν τῷ σελιδίῳ πρῶτα λεπτὰ θ´ ἅτινα καὶ αὐτὰ προσαπογράφεται σὺν τῇ παρασημειώσει τῶν πρώτων γράφων τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον τὴν ἀνατείνουσαν καὶ ὡς εἴρηται τὴν γραμμὴν πάλιν διὰ τὴν τάξιν κλωμένην κατὰ δευτέραν κλάσιν προσέλκει γινομένου τοῦ μέρους αὐτῆς τούτου παραλλήλου τῷ ἐξ ἀρχῆς
16 ante κλωμένης add ἐπὶ C 18 τε] MZP om SC | αφ ] M ἀφ ZSC ἀφαί P 19 προσσημαίνει] MS προση- ZC et ex corr P | ὅτι] ZP comp MSC 20 δὴ] MZSC διὰ fecit m 2 P 21 πρὸς] MSP et supra lineam C ex ἀπὸ fecit m 2 Z | ιγ´´] MZSP νγ´´ C 22 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M ᾱᾱ λεπτὰ Z άάα λε S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C 23 προσαπο- γράφεται] απο suprascr in comp M 24 ᾱ] ZP α´ MS α C 25 κλάσιν] MP τάξιν ZSC | τοῦ] ZSPC τούτου M 26 τούτου] τοῦ bis ZSPC sed prius erasit m 2 P τοῦ M
mdash 18 προκοπῆς] om K | τε ποιήσας] ποιήσας καὶ K | αφ ] ἀφ K 19 τὸ] om K 21 προ-γράφει] γράφει K 22 σελιδίῳ] α´ σελιδίῳ K | ἅτινα] ἃ K 23 προσαπογράφεται] ἀπογράφεται K | τῶν πρώτων mdash 26 ἐξ ἀρχῆς] om K
lsquoAllo scopo di raccogliere ciograve che risulta dalla divisione il detto Pappo utilizzando anche in questo caso una certa disposizione ben strutturata determina nel modo seguente il lsaquonumerorsaquo cercato preso nel suo insieme collocando73 in testa il lsaquonumerorsaquo che sta per essere diviso cioegrave i 360 gradi iniziali sottrae loro tra i piugrave prossimi dei lsaquonumerirsaquo minori rispetto a quelli esposti quello che si trova essere minore nella colonna (cioegrave 304 22 20) Questo egrave il motivo per cui lo trascrive scrivendogli davanti lrsquoabbreviazio-ne laquosottrraquo per laquosottrairaquo e trovando che 50 minuti primi sono collocati accanto a quello stesso lsaquonumerorsaquo che egrave stato trascritto nella colonna li trascrive al tempo stesso collocando accanto74 ad essi la lettera A con un lsaquotrattorsaquo75 sopra che significa la specie minuti primi Trova dunque in que-sto modo la parte di 360 che egrave 304 22 20 la quale divisa per 365 giorni 14 48 fa il numero lsaquoche risultarsaquo dalla divisione 50 minuti primi Trascrivendo
73 La descrizione egrave strutturata come una procedura Acerbi 201274 Il purismo del correttore del Par gr 2390 di Clostomalle nel Marc gr 314 e
dellrsquoautore della recensione bizantina impone loro di modificare la terminazione ma forme tematiche e contratte di τιθεῖν sono correnti nel greco tardivo
75 Il testo greco ha solo il participio con γραμμήν sottinteso Per il significato del participio si veda il punto 2
15
20
25
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 153
poi il resto 55 37 40 gli pone altresigrave76 a prefisso laquoReraquo che significa laquorestiraquo e dispone anche una certa linea semplice77 che va da 360 al piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori che egrave esposto di seacuteguito 304 22 20 come nello lsaquoschemarsaquo esposto linea che mostra lrsquoordine del percorso dellrsquoesposizione Questa linea spezzata lagrave dove si trova il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori egrave tracciata inflessa allrsquoindietro lsaquoersaquo punta verso il resto come egrave stato detto in vista di una progressione ordinata E cosigrave facendo prendendo di seacuteguito il laquosottrraquo che significa come egrave stato detto laquoche occorre similmente sottrarre dal re-storaquo e ovviamente prendendo di nuovo il lsaquonumerorsaquo che egrave trovato essere il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori in relazione alla disposizione nella colonna ndash 54 47 13 12 ndash lo scrive di seacuteguito e trova che 9 minuti primi sono posti loro accanto nella colonna trascrive78 anche questi con la segnaletica dei primi scrivendo la lettera A con un lsaquotrattorsaquo sopra e come egrave stato detto prolunga di nuovo la linea spezzata in vista di una buona disposizione tramite una seconda inflessione essendo questa sua parte parallela a quella inizialersquo
La descrizione continua con una serie di laquoe cosigrave viaraquo e non fa ulte-riore riferimento alla tabella
1) La forma verbale ἐξεσμένον Egrave il neutro del participio perfetto medio-passivo di ξέω lett laquopialloraquo laquolevigoraquo Si danno tre possibilitagrave si tratta di un termine canonico per quanto non altrove attestato per designare unrsquoabbreviazione oppure lrsquoautore anonimo improvvisa sul piano metaforico come se unrsquoabbreviazione non fosse altro che la paro-la completa lsquoaccorciata a colpi di piallarsquo in maniera opportuna oppure il testo egrave corrotto e srsquoimpone una correzione ad esempio τὸ ἑξῆς μένον laquociograve che sta di seacuteguitoraquo Questrsquoultima strada mi pare chiusa dal senso delle frase lrsquoabbreviazione non lsquosta di seacuteguitorsquo a niente ma anzi precede la perifrasi τὸ ἑξῆς μένον se impiegata semplicemente per rimandare al segno αφ immediatamente seguente costituirebbe un intollerabile solecismo Se accettiamo la prima di queste letture considerando quin-di lrsquoabbreviazione αφ in posizione predicativa abbiamo a che fare con
76 Rendo in questo modo il τε isolato77 La linea egrave laquosempliceraquo in quanto egrave una retta la precisazione intende evidenziare per
anticipazione il carattere lsquonon semplicersquo che essa assumeragrave alla prima inflessione quando diventeragrave una spezzata linee siffatte erano in effetti concepite dallrsquoanonimo e prima di lui da tutta la tradizione matematica greca come una singola linea spezzata nei punti drsquoinfles-sione I due segmenti paralleli menzionati al termine del passo sono orizzontali
78 Il verbo egrave al medio in variatio rispetto ai due che precedono e che seguono egrave il matematico che lsquosirsquo trascrive le cifre
Fabio Acerbi154
uno hapax semantico nella grecitagrave superstite come egrave facile verificare con una ricerca sul TLG in rete La recensione bizantina risolve il pro-blema sopprimendo semplicemente τὸ ἐξεσμένον
2) La notazione per le specie numeriche Nella terminologia matema-tica greca gli ordini sessagesimali sono εἴδη laquospecieraquo numerici essi corri- spondono agli ordini di grandezza nel nostro sistema decimale e indica-no in analogia con il caso geometrico la lsquoformarsquo che assume un numero quadrato cubo ecc Centinaia e migliaia sono quindi degli εἴδη rispet-tivamente quadrati (100 egrave il quadrato di 10) e cubi (1000 egrave il cubo di 10) sono specie numeriche ma non numeri particolari e drsquoaltronde 300 non egrave un quadrato ma 3 item dellrsquoεἶδος lsquoquadratorsquo 100 3 egrave il numerale di molteplicitagrave della specie quadrata lsquocentinaiarsquo i due 0 che seguono il 3 segnalano esattamente questo fatto che la notazione greca per gli interi non posizionale fa scomparire al livello denotativo Ciograve non vale soltan-to per i numeri interi ma anche per le loro parti i minuti secondi appar-tengono alla specie lsquoquadratorsquo in quanto 13600 egrave il quadrato di 160
La concezione appare interamente dispiegata nellrsquointroduzione degli Arithmetica diofantei79 che si rivela giova farlo rimarcare un te-stimone fondamentale per la ricostruzione della notazione matematica antica Alle specie usate in questrsquoopera vengono assegnati una denomi-nazione ed un segno convenzionale costituito dallrsquoiniziale (di ognuno dei componenti) della denominazione al quadrato o δύναμις il segno ΔΥ al κύβος il segno ΚΥ alla lsquoquarta potenzarsquo o δυναμοδύναμις il segno ΔΥΔ ecc La descrizione di tali segni egrave del tipo καὶ ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον Κ ἐπίσημον ἔχον Υ ΚΥ κύβος laquoe il suo segno egrave un Κ che ha come indice un Υ ΚΥ cuboraquo dove in accordo con quanto abbiamo visto nel punto b supra e pur nel comprensibile imbarazzo del copista della prima parte del Matritensis (o di un suo passato collega) a districarsi in questo formidabile ginepraio notazionale80 le due lettere Κ e Υ ricevono una barra mentre ΚΥ non la richiede a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον il quale ancora una volta esclude automaticamente il segno dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
79 In particolare a DOO I pp 214-62180 Nel Matr 4678 riscontriamo i seguenti fenomeni nelle poche righe a cavallo dei ff
58r-v 1) accento acuto posto su tutti i segni come se fossero abbreviazioni 2) ripetizione sistematica segnodenominazione come in ΚΥ κύβος appena letto dovuta sicuramente allrsquointrusione di glosse interlineari esplicative dei segni ndash e successivo pentimento (δύναμις e κύβος sono in effetti cancellati dalla prima mano il primo con un tratto il secondo con dei punti supra lineam poi il copista si stanca di correggere) 3) nella descrizione del segno per la δυναμοδύναμις menzione di un δέλτα δύο che saragrave molto probabilmente stato ΔΔ subito dopo nella descrizione del κυβόκυβος si legge un incongruo δύο KK
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 155
Diofanto introduce poi dei segni anche per le specie delle parti dellrsquounitagrave (le nostre frazioni) che egli chiama ὁμώνυμα μορία laquoparti omonimeraquo di cui quelle sessagesimali sono casi particolari81 Egli spie-ga appunto che le loro denominazioni sono ottenute da quelle delle specie degli interi per sinonimia passando ad un lsquoordinalersquo82 formato semplicemente aggiungendo il suffisso -στον δυναμοστόν κυβοστόν δυναμοδυναμοστόν ecc (sott μόριον) I loro segni convenzionali sono invece ottenuti da quelli per le specie degli interi aggiungendo una γραμμὴν διαστέλλουσαν τὸ εἶδος laquolinea che distingue la specieraquo83 Una linea sui segni delle specie delle parti egrave richiesta si badi bene per distinguerli dai segni di quelle degli interi come giagrave osservato questi ultimi sono giagrave lsquoagrammaticalirsquo a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον a fortiori lo saranno anche i primi Si tratta della traduzione semio-tica del passaggio dal cardinale allrsquoordinale che a livello grammaticale egrave effettuato con il suffisso -στον Che forma ha questa linea Barra o apice (Egrave cervellotico pensare a forme piugrave complesse) La domanda non ammette una risposta immediata in quanto delle specie diofantee nessuno piugrave si occupa nellrsquoantichitagrave84 Se egrave vero che la prima risposta darebbe origine ad un conflitto tra due convenzioni denotative diffe-renti la barra lsquocitazionalersquo e la barra che distingue la specie lrsquoevidenza grafica del Matritensis lascia lievemente sgomenti (ricordiamoci che giagrave i segni di base sono indebitamente dotati di un accento dal copista) Le poche occorrenze del segno per le specie delle parti85 vedono lrsquoaggiunta di uno slash di sospensione di un doppio apice inverso ndash in tutta evi-
81 Questo fatto era giagrave chiaro nellrsquoantichitagrave Teone in Alm I 10 in iA p 45310-1682 Il parallelo con i cardinali e gli ordinali relativi agli interi egrave reso esplicito da Dio-
fanto ὥσπερ δὲ τῶν ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια παρομοίως καλεῖται τοῖς ἀριθμοῖς τοῦ μὲν τρία τὸ τρίτον τοῦ δὲ τέσσαρα τὸ τέταρτον οὕτως καὶ τῶν νῦν ἐπονομασθέντων ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια κληθήσεται παρομοίως τοῖς ἀριθμοῖς laquocome le parti omonime dei numeri sono chia-mate per assonanza con i numeri di lsquotrersquo lsquolsaquounrsaquo terzorsquo di lsquoquattrorsquo lsquolsaquounrsaquo quartorsquo cosigrave le parti omonime dei numeri appena nominati saranno chiamate per assonanza con i numeriraquo (DOO I p 69-13 si noti lrsquoarticolo lsquocitazionalersquo al singolare in τοῦ τρία e τοῦ τέσσαρα) Il parallelo prosegue anche al livello dei segni che rappresentano queste specie come vedremo tra un attimo
83 Diofanto Arithmetica prefazione in DOO I p 620-21 un passaggio maltrattato in questa edizione occorre espungere il participio ἔχον senza introdurre segni ulteriori oppure eliminare un precedente ἐπί come fa un correttore del Matritensis f 58v
84 Unica parzialissima eccezione lrsquoaccenno di Teone menzionato nella nota 81 supra85 Al f 59r e per di piugrave nel margine per sanare un lungo saut du mecircme au mecircme La
collocazione in margine egrave il motivo per cui troviamo una notazione abbreviata nel resto del trattato il primo copista scioglie tutti i segni prendendoli per abbreviazioni mentre il secondo elimina sistematicamente il tratto aggiuntivo delle specie delle parti dellrsquounitagrave Drsquoaltronde egli scrive ad esempio ΔΥ invece di ΔΥ ed egrave quindi indotto a porre la barra al di sopra della stringa di lettere risultante (passim ma si veda ad esempio il f 72r)
Fabio Acerbi156
denza il compendio per la desinenza -ον accentata il copista interpreta il segno come unrsquoabbreviazione ndash e di una barra a sormontare lo Υ Potremmo forse interpretarlo come il segno di contrazione del grafema -στ- lrsquounico tassello mancante in unrsquoabbreviazione come ad esempio (δυναμοδυναμο)(στ)(ὸν) ma uno scolio di prima mano al f 58v rela-tivo alle specie degli interi inficia questrsquoipotesi esse sono dotate di slash di sospensione accento acuto in un caso del compendio canonico per la terminazione -ον hellip ma tutti gli Υ a esponente sono a loro volta sormontati da una barra
Meno legata al singolo manoscritto ma nondimeno non uniforme si presenta la pratica di notazione dei segni che rappresentano gli enti numerici sessagesimali86 da una parte sta lrsquoevidenza del testo dei Pro-legomena e delle sue tabelle apici ndash drsquoaltronde come abbiamo visto la notazione universalmente impiegata per i numerali ordinali e per le fra-zioni unitarie ndash dallrsquoaltra sta lrsquoevidenza del testo dellrsquoAlmagesto in tutti i manoscritti piugrave antichi e lo stesso si dica del commentario teonino a questrsquoopera o del suo lsquoGrande commentariorsquo alle Tavole facili e dei testi astronomici su papiro barre87 Sembra insomma che la nostra docu-
86 Sia le molteplicitagrave che le specie ahimeacute entrambe rappresentate da lettere dellrsquoalfabeto Come osservato allrsquoinizio della sezione 3 ci sono in effetti due tipi di lettere numerali in gioco se facciamo astrazione da apici o barre lsquo4 minuti secondirsquo si trova scritto δ β la prima lettera numerale denota la molteplicitagrave degli item di una certa specie la se-conda la specie nei Prolegomena entrambe sono accompagnate da un doppio apice il che rende inutile la presenza delle seconde Si noti che la descrizione della tabella non fa parola della notazione da usare per le lettere numerali che denotano la molteplicitagrave barre o apici e quanti apici hellip In questo caso fa interamente fede la tabella cioegrave la pratica grafica condivisa instauratasi non egrave chiaro quando
87 I manoscritti piugrave antichi dellrsquoAlmagesto sono menzionati nella nota 10 supra quelli dei due commentarii teonini sono il Laur Plut 2818 e il celeberrimo Vat gr 190 (sec IX in Euclide Elementi Data Teone lsquoGrande commentariorsquo) per la notazione dei pa-piri astronomici si veda Jones 1999 II passim La notazione non sembra lsquoinquinatarsquo dalla pratica dei copisti bizantini e pare dipendere soltanto dalla data di composizione Tro-viamo ad esempio barre sopra tutti i numerali di molteplicitagrave (interi o sessagesimali) nel frammento di un commentario alle Tavole facili contenente un calcolo relativo al 24 aprile 213 (Par gr 2841 sec XIII ex-XIV in oltre al frammento ai ff 32r l 11-34v l 23 contiene Arato Phaenomena ed Efestione Apotelesmatica edizione in Jones 1990) Nel commentario alle Tavole facili composto ca 610-617 ed attribuito a Stefano di Alessandria la situazione egrave la seguente (Jean Lempire per litteras per lrsquoedizione si veda Lempire 2014 ho controllato il Vat gr 304 ff 135r-171v sec XIV am contiene in aggiunta Teone in Almagestum I-II lsquoPiccolo commentariorsquo alle Tavole facili Diofanto Arithmetica e De polygo-nis numeris varia astronomica tabulae) barre sopra gli interi sporadicamente rimpiazzate da apici apici sopra le parti sessagesimali in numero uguale alla denominazione doppio () apice per le frazioni unitarie Sono impiegate barre sopra gli interi e apici sopra le parti sessagesimali nei manoscritti principali di tutti i trattati di introduzione allrsquoAlmagesto o comunque di argomento logistico redatti in epoca bizantina Giorgio Pachimere (1242-ca 1310) Quadrivium (autografo nel manoscritto Roma Biblioteca Angelica gr 38 [RGK III nr 115] si veda Tannery ndash Steacutephanou 1940 per lrsquoedizione) Teodoro Metochita (1270-
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 157
mentazione si faccia testimone di un cambio notazionale avvenuto nel periodo intercorrente fra Teone (sec IV pm) e la scuola alessandrina di Ammonio e dei suoi allievi (sec VI in) e probabilmente innescato da questrsquoultimo ambiente lrsquoaspetto paradossale egrave che nello stesso codice si rintraccino due notazioni differenti per gli enti numerici sessagesimali e lrsquouna (apici) sia adottata sistematicamente e coerentemente in uno scritto (i Prolegomena) che si presenta esattamente come unrsquointroduzione tecnica alla pratica numerico-algoritmica del trattato (lrsquoAlmagesto) in cui egrave adottata lrsquoaltra (barre che ritroviamo senza eccezioni anche negli scolii)
Torniamo ai Prolegomena la descrizione del segno da porre a fianco di ogni singolo quoziente parziale e denotante la sua specie numerica (minuti primi minuti secondi ecc) solleva tre problemi
Primo problema Ci vuole una barra o un apice su τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquola lettera A [hellip] che significa la specieraquo quando lo scriviamo nella tabella Tutta la nostra discussione precedente fa pro-pendere per lrsquoapice e si ricordi anche la forma verbale ἀνατείνουσαν che suggerisce qualcosa che si lsquoestende verso lrsquoaltorsquo (la mia traduzione egrave volutamente neutra) se fosse apposta una barra la cosa dovrebbe passare
1231332) Compendium astronomicum (copia lsquoautorizzatarsquo coeva nei Vat gr 182 e 181 da parte del copista che integrograve le parti mancanti del Par gr 2389 [ff 207-210 255-270 374-375] Bianconi 2005a pp 425-427 Peacuterez Martiacuten 2008 p 436 e n 177) Teodoro Meliteniota (morto lrsquo831393) Tribiblos astronomica (autografo nel Vat gr 792 si vedano Leurquin 1991 per unrsquoanalisi del manoscritto Leurquin 1990 per lrsquoedizione) una com-pilazione anonima (per cui ho consultato il Par gr 2396 ff 87r-92v limitatamente a questi fogli manu Costantino Trivoli [RGK II nr 318 ma ovviamente questo codice non vi egrave segnalato] terzo quarto del XV secolo il resto del codice annotato da Niceforo Gregora egrave di etagrave planudea e parzialmente [ff 33v-76v] un autografo di Planude stesso contiene Teone in Almagestum I II IV Mondrain 2002 il codice va completato ndash limitatamente a stralci dei libri VIII-X XII-XIII del commentario teonino la cui parte intermedia si egrave persa ndash con 26 carte [ff 123-147] inserite nel Vat gr 1087 anchrsquoesso contenente anno-tazioni di Gregora Rome 1927 per la figura del copista dei ff 77r-86r del Par gr 2396 e dei ff appena nominati del Vat gr 1087 un anonimo collaboratore di Gregora si veda in ultimo Bianconi 2006a pp 147-151) si veda anche il calcolo effettuato da Niceforo Gre-gora (12921295-13581361) dellrsquoeclisse di sole del 16 luglio 1330 (attestata unicamente ai ff 1r-8v della miscellanea astronomica Marc gr 325 databile ca 1324-1329 in parte vergata e ovunque fittamente annotata da Gregora stesso edizione del testo in Mogenet et al 1983 annotazioni di Gregora elencate in Bianconi 2005a p 413) Unrsquoeccezione apparente il lsquoPiccolo commentariorsquo di Teone alle Tavole facili le parti sessagesimali sono segnalate da apici (ad esempio nel Vat gr 175 vergato da Giovanni Catrario e completato nel 1321-1322 sulla figura di Catrario si vedano in ultimo Bianconi 2005b pp 141-156 e 2006b) lrsquoopera egrave antica ma la sua tradizione non rimonta oltre la fine del XIII secolo a parte un frammento nel Leiden BPG 78 ff 156r-161v (minuscola del IX-X secolo) e in effetti in questo manoscritto tutti i numerali di molteplicitagrave sono sormontati da barre Unrsquoeccezione effettiva egrave il De hypotesibus planetarum nel Vat gr 1594 barre sugli interi e apici sulle parti sessagesimali
Fabio Acerbi158
sotto silenzio e la presenza dellrsquoapice la rende inutile88 Si tratta della stessa convenzione diofantea e coincide ancora con la notazione per i numerali ordinali e per le frazioni unitarie che egrave corrente nei mano- scritti matematici greci per questo motivo non percheacute la descrizione sia particolarmente perspicua nessuno dei copisti della recensione an-tica ha incertezze apici Ma questi apici si rintracciano soltanto sulle indicazioni di specie non contemplate dalla descrizione che sono ante-poste ai resti parziali a fianco dei quozienti parziali i segni di specie sono invece trasformati in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordi-nali corrispondenti del tipo πρωτ tavv 5 e 7b-8 Il recensore bizantino taglia invece la testa al toro elimina dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali elimina la seconda menzione della laquolet-tera Araquo contestualmente allrsquoazzeramento dellrsquoespediente della linea a zig-zag (si veda il punto seguente) modifica la descrizione che contiene la prima menzione in quella dellrsquoapice associato direttamente ai nume-rali di molteplicitagrave riciclando addirittura lrsquoalpha per adibirlo a desi-gnare un numero cardinale (come sorprendersi) τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ laquoponendo al di sopra di essi [scil dei 50 minuti primi] 1 solo lsaquoaccentorsaquo acutoraquo La scelta del recensore egrave assennata che rechi una barra o un apice in una tabella un alpha denota un numero non un numero drsquoordine
Secondo problema da tenere ben distinto dal precedente Cosa ci vuole sul segno α per la lettera alpha menzionata nella frase τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquolettera A [hellip] che significa la specieraquo89 Unrsquooc-chiata allrsquoapparato critico rivela una bella incertezza nei manoscritti Z scrive sempre ᾱ e in un caso lo fa anche P MS optano sempre per α´ C per α P scrive nellrsquoaltro caso αο Per quanto solo la barra sia congrua con il senso della frase in quanto la lettera alpha egrave qui menzionata (si tratta di un oggetto che compare nella tabella) e non cambia niente se essa egrave accompagnata dal suo nome di genere στοιχεῖον ad un livello grafico lrsquoincertezza fra il segno ᾱ che denota laquola lettera αraquo e il segno α´ (o lrsquoabbreviazione αο) per una forma di πρῶτος egrave per piugrave versi giustificata
88 Detto in altri termini la barra egrave uno strumento grafico non matematico e quindi la sua presenza non va segnalata mentre un apice lo egrave e la sua presenza lo deve
89 Notare che in questa frase il primo α non vuole la barra (egrave menzionato allrsquointerno di una frase che impiega convenzioni moderne) il secondo sigrave (idem ma con convenzioni antiche) ndash e nella traduzione la scelta di denotarlo con A (senza virgolette) e non con lsquoArsquo (con virgolette) egrave del tutto arbitraria ndash si noti inoltre che le necessarie precisazioni laquosenzacon virgoletteraquo mostrano che le lingue moderne palesano difficoltagrave analoghe a quelle del greco antico per quanto riguarda i livelli denotativi in ambito metadiscorsivo per non usare le due parentetiche avrei dovuto scrivere rispettivamente lsquoArsquo e lsquolsquoArsquorsquo (doppie virgolette semplici)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 159
ᾱ coincide con il numerale 1 α egrave la prima lettera dellrsquoalfabeto ed inoltre α´ egrave esattamente quello che va scritto nella tabella Potremmo dirci che il sostantivo στοιχεῖον chiude la questione la sua presenza congiunta ad un ipotetico α´ renderebbe la descrizione ridondante o inappropriata90 Ma a parte il fatto che α egrave proprio τὸ πρῶτον στοιχεῖον il segno α´ cat-tura in fondo il cuore della descrizione di uno στοιχεῖον ἔχον lsaquoγραμμὴνrsaquo ἀνατείνουσαν
Terzo problema Lrsquoautore dei Prolegomena che si arresta allrsquoesem-pio dei minuti primi non dice quanti apici occorre mettere sulle lettere numerali che identificano gli ordini superiori al primo se uno soltanto come nel caso diofanteo e delle frazioni unitarie o in numero uguale alla loro denominazione (cioegrave pari al numero denotato dal numerale stesso su cui vanno posti) come effettivamente avviene nei mano-scritti dei Prolegomena La tabella egrave quindi sottodeterminata dalla sua descrizione anzi in un certo senso prende il sopravvento su di essa la pratica di marcare i numerali di molteplicitagrave con gli apici che compe-tono allrsquoordine cui appartengono viene trasferita ai segni per gli ordini stessi per supplire ad una descrizione carente di questi ultimi E la tabella egrave sottodeterminata dalla descrizione in quanto egrave la descrizione di una tabella reale ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις laquocome nello lsaquoschemarsaquo espostoraquo leggiamo a un certo punto del testo
3) La linea a zig-zag Non possiamo che applaudire a questo geniale espediente grafico lo troviamo messo in opera solo nel Marc gr 313 Per quanto lrsquoautore non faccia parola di ciograve nel corso della sua descrizione la linea spezzata egrave intesa dover lsquosaltarersquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue Il copista del codice marciano effettua correttamente due salti nella prima delle sue tabelle (tav 4) ma inserisce un lsquodentersquo in piugrave in quella che considera corretta (tav 5) La linea a zig-zag egrave incompatibile con la presenza di linee di giustificazione nella tabella che in effetti mancano nel Marc gr 313 ciograve induce gli errori di allineamento dei primi 5 quozienti parziali di cui egrave vittima il copista Probabilmente per questo motivo in nessuno degli apografi del Vat gr 1594 la linea a zig-zag figura nella tabella inquadrata come si conviene da una (doppia) cornice esterna e le cui colonne sono appunto separate da linee verticali (tav 7b Vat gr 184 f 17v e tav 8 Par gr 2390 f 9v cui egrave sostanzialmente identica la tabella del Marc gr 314 che si trova
90 Trascuro lrsquoabbreviazione αο = πρῶτος percheacute la desinenza non egrave quella richiesta neacute nella frase (egrave richiesto πρῶτον) neacute nella tabella (πρῶτα)
Fabio Acerbi160
al f 248r ndash ma la mancanza di linee orizzontali causa un gigantesco pa-sticcio nel codice vaticano) Alla recensione bizantina che dipende per il suo testo di base dal Vat gr 1594 e quindi non trova la linea a zig-zag nella tabella non resta che sopprimere la sua descrizione ndash ma proprio per questo motivo e finalmente diventa possibile tracciare un apparato completo di linee di giustificazione (tav 9 Laur Plut 89 sup 48 f 14v) Dato che la descrizione di Teone di questo procedimento di divi-sione non fa cenno allrsquoesistenza della linea a zig-zag viene da chiedersi se essa non costituisca un espediente escogitato dallrsquoautore dei Prolegomena per vivacizzare la procedura originale di Pappo
4) Discrepanze tra descrizione e tabella Il gioco delle minime va-rianti mostra che la divisione era stata eseguita (e trasmessa) corret-tamente tutti i valori numerici sono esatti La tabella nel Marc gr 313 presenta perograve alcune discrepanze con la propria descrizione Essa omette (ma non nella versione lsquoscorrettarsquo lrsquoomissione non si riscontra neanche nel Par gr 2390) il segno per laquorestoraquo di fronte ai resti par-ziali ma aggiunge lrsquoindicazione della loro specie Essa trasforma invece come abbiamo visto le indicazioni di specie che seguono i quozienti parziali in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordinali corri-spondenti La descrizione prevede di chiudere la tabella con il risultato καὶ συνάγων ἅπαντα τὰ ἐκ τῶν μερισθέντων μερῶν λεπτὰ σημειοῦται ὑπὸ πάντας οὕτως γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoe raccogliendo tutti i minuti che provengono dalle parti divise lsaquoPapporsaquo nota sotto tutto cosigrave Ris 0 59 8 17 13 12 31raquo ma sotto la tabella tutta la tradizione ci consegna qualcosa di piugrave articolato ὁ ζητούμενος καθ᾽ ὃν μερίζεται ὁ τξε ιδ´ μη´´ π(αρὰ) τὸν τξ γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoil lsaquonumerorsaquo cercato secondo cui 365 14 48 egrave diviso per 360 risulta 0 59 8 17 13 12 31raquo frase che del resto contiene due errori lrsquoinversione del dividendo e del divisore e la confusione tra segno convenzionale (iuxta descrizione) e abbreviazione (come nella frase) nel caso di γι Oltre ad eliminare la linea a zig-zag91 la recensione bizantina sopprime dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali e modifica come abbiamo visto al punto 2 le loro descrizioni in quelle di apici associati diretta-mente ai numerali di molteplicitagrave
91 Le due righe che nella recensione di base contengono solo i resti parziali minori di 160 del divisore ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue sono in parte completate con lrsquoindicazione abbreviata ἀνάλ(υσις) laquoanalisiraquo il termine greco per questa procedura di riduzione In un sussulto di ipercorrettismo matematico tali resti parziali ridotti non sono preceduti dal segno per laquorestoraquo come nel Par gr 2390 ma da quello per laquorisultatoraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 161
Gli esempi che abbiamo discusso mostrano come i problemi di notazione pesino e non poco sullrsquoespressione discorsiva di un algorit-mo matematico lrsquoente di riferimento per lsquoformularersquo il procedimento di divisione fu considerata la tabella cioegrave un oggetto la cui costitu-zione egrave legata piugrave ad una pratica grafica che a considerazioni logico- algoritmiche non la sua descrizione che in effetti finisce per determi-nare la tabella in maniera non univoca Di questa sottodeterminazione si fa testimone la traiettoria che abbiamo cercato di seguire nelle mani di copisti e revisori il procedimento di divisione si modifica a volte in aspetti secondari a volte in punti piugrave sostanziali ndash fino a rendere neces-saria una radicale revisione della sua descrizione per renderla conforme alla tabella ndash in ogni caso mai per ragioni squisitamente matematiche92
Abstract
The article presents and discusses in detail two passages from the anonymous Prolegomena to the Almagest a VIth century primer to the elementary procedures of calculation needed in Ptolemyrsquos Almagest In the two passages we may follow the complex interplay between mathematical notation the auctor who employed and described it the tachygrapher who transcribed it in vivo copyists who reproduced it correctors who modified it Along this path misgivings and errors arise in the transmission of abbreviations and paratextual units such as diagrams tables operational schemes
Fabio AcerbiCNRS UMR8560 Centre Alexandre Koyreacute
fabacerbigmailcom
92 Sono grato a Daniele Bianconi Lucio del Corso Jean Lempire per alcune preziose indicazioni
AOO = Archimedis opera omnia cum commentariis Eutocii ed J L Heiberg I-III Lipsiae 1910-1915
DOO = Diophanti Alexandrini opera omnia cum Graecis commentariis ed P Tannery I-II Lipsiae 1893-1895
GC = Le laquoGrand Commentaireraquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Mogenet ndash A Tihon I-III Cittagrave del Vaticano 1985-1999
iA = Commentaires de Pappus et de Theacuteon drsquoAlexandrie sur lrsquoAlmageste ed A Rome I-III con paginazione continua Cittagrave del Vaticano 1931-1943
HOO = Heronis Alexandrini opera quae supersunt omnia ed G Schmidt ndash L Nix ndash W Schmidt ndash H Schoene ndash J L Heiberg I-V Lipsiae 1899-1914
PC = Le ldquoPetit Commentairerdquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed A Tihon Cittagrave del Vaticano 1978
POO = Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia ed J L Heiberg I-II in 3 parti Lipsiae 1898-1907
RGK = Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600 I Handschriften aus Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln II Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs und Nachtraumlge zu den Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln III Handschriften aus Bibliotheken Roms mit dem Vatikan A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg unter Mitarbeit von D Harlfinger und P Eleuteri B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln Wien 1981-1997 (Oumlsterreichische Akademie der Wissenschaften Veroumlffentlichungen der Kommission fuumlr Byzantinistik III1-3 A-C)
Sigla
Acerbi 2010 = F Acerbi Il silenzio delle sirene La matematica greca antica Roma 2010
Acerbi 2012 = F Acerbi I codici stilistici della matematica greca dimostrazioni procedure algoritmi laquoQUCCraquo 1012 (2012) pp 167-214
Acerbi et al 2010 = F Acerbi ndash N Vinel ndash B Vitrac Les Proleacutegomegravenes agrave lrsquoAlmageste Une eacutedition agrave partir des manuscrits les plus anciens Introduction geacuteneacuterale ndash Parties I-III laquoSCIAMVSraquo 11 (2010) pp 53-210
Agati 1992 = M L Agati La minuscola laquoBouleteacuteeraquo Cittagrave del Vaticano 1992
Belger 1881 = C Belger Ein neues Fragmentum mathematicum Bobiense laquoHermesraquo 16 (1881) pp 261-284
Bianconi 2005a = D Bianconi La biblioteca di Cora tra Massimo Planude e Niceforo Gregora Una questione di mani laquoSampTraquo 3 (2005) pp 391-438
Bianconi 2005b = D Bianconi Tessalonica nellrsquoetagrave dei Paleologi Le pratiche intellettuali nel riflesso della cultura scritta Paris 2005
Bianconi 2006a = D Bianconi Le pietre e il ponte ovvero identificazioni di mani e storia della cultura laquoBizantinisticaraquo 8 (2006) pp 135-181
Bianconi 2006b = D Bianconi Qualcosa di nuovo su Giovanni Catrario laquoMEGraquo 6 (2006) pp 69-91
Cavallo 1977 = G Cavallo Funzione e strutture della maiuscola greca tra i secoli VIII-XI in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Colloque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 95-137
Cereteli 1904 = G F Cereteli De compendiis scripturae codicum Graecorum praecipue Petropolitanorum et Mosquensium anni nota instructorum Sankt-Petersburg 1904
De Gregorio 2000 = G De Gregorio Materiali vecchi e nuovi per uno studio della minu-scola greca fra VII e IX secolo in G Prato (a cura di) I manoscritti greci tra riflessione e dibattito Atti del V Colloquio Internazionale di Paleografia Greca Cremona 4-10 ottobre 1998 Firenze 2000 pp 83-151
Follieri 1977 = E Follieri La minuscola libraria dei secoli IX e X in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Col-loque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 139-165
Fonkič 2005 = B Fonkič Venecianskaia rukopisrsquo laquoAlrsquomagestaraquo Ptolemeja (Marc gr 313690) o datirovke i proischoždenii kodeksa laquoVDIraquo s III 254 (2005) pp 162-167
Fowler 1999 = D H Fowler The Mathematics of Platorsquos Academy A New Reconstruction Second Edition Oxford 1999
Bibliografia
Fabio Acerbi164
Gerstinger ndash Vogel 1932 = H Gerstinger ndash K Vogel Eine stereometrische Aufgaben-sammlung im Papyrus Graecus [sic] Vindobonensis 19996 laquoMitteilungen aus der Papy-russammlung der Nationalbibliothek in Wienraquo Neue Serie Folge 1 Griechische literarische Papyri 1 Wien 1932 pp 11-76
Heiberg 1927 = Mathematici Graeci Minores ed J L Heiberg Kjoslashbenhavn 1927
Hultsch 1876-1878 = Pappi Alexandrini Collectionis quae supersunt ed F Hultsch I-III Berlin 1876-1878
Janz 2003 = T Janz The Scribes and the Date of the Vat gr 1291 in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae X Cittagrave del Vaticano 2003 pp 159-180
Jones 1990 = Ptolemyrsquos First Commentator ed A Jones Philadelphia 1990
Jones 1999 = Astronomical Papyri from Oxyrhynchus ed A Jones I-II Philadelphia 1999
Jones 2005 = A Jones Ptolemyrsquos Canobic Inscription and Heliodorusrsquo Observation Reports laquoSCIAMVSraquo 6 (2005) pp 53-97
Lempire 2014 = Steacutephanos drsquoAlexandrie Le commentaire aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Lempire Louvain 2014
Leurquin 1990 = Theacuteodore Meacuteliteacuteniote Tribiblos astronomique Livre I ed R Leurquin Amsterdam 1990
Leurquin 1991 = R Leurquin Un manuscrit autographe de la Tribiblos Astronomique de Theacuteodore Meacuteliteacuteniote le Vaticanus graecus 792 laquoScriptoriumraquo 45 (1991) pp 145-162
Maas 1927 = P Maas Griechische Palaeographie in A Gercke ndash E Norden (hrsg von) Einleitung in die Altertumswissenschaft I9 Leipzig 1927 pp 69-80
Martinelli Tempesta 2010 = S Martinelli Tempesta Il codice Milano Biblioteca Am-brosiana B 75 sup (gr 104) e lrsquoevoluzione della scrittura di Giovanni Scutariota in A B Garciacutea ndash I Peacuterez Martiacuten (ed by) The Legacy of Bernard de Montfaucon Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting Proceedings of the Seventh Inter-national Colloquium of Greek Palaeography Madrid-Salamanca 15-20 September 2008 Turnhout 2010 pp 171-186
Mazzucchi 1994 = C M Mazzucchi Leggere i classici durante la catastrofe (Costantino-poli maggio-agosto 1203) le note marginali al Diodoro Siculo Vaticano gr 130 Parte prima stratigrafia laquoAevumraquo 68 (1994) pp 164-218
Mioni 1976 = E Mioni Bessarione scriba e alcuni suoi collaboratori in Miscellanea marcia-na di studi bessarionei Padova 1976 pp 263-323
Mioni 1985 = Codices graeci manuscripti Bibliothecae Divi Marci Venetiarum II Thesaurus Antiquus Codices 300-625 recensuit E Mioni Roma 1985
Mogenet 1962 = J Mogenet Une scholie ineacutedite du Vat gr 1594 sur les rapports entre lrsquoastronomie arabe et Byzance laquoOsirisraquo 14 (1962) pp 198-221
Mogenet et al 1983 = Niceacutephore Greacutegoras Calcul de lrsquoeacuteclipse de soleil du 16 juillet 1330 ed J Mogenet ndash A Tihon ndash R Royez ndash A Berg Amsterdam 1983
Mondrain 2002 = B Mondrain Maxime Planude Niceacutephore Greacutegoras et Ptoleacutemeacutee laquoPa-laeoslavicaraquo 10 (2002) pp 312-322
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 165
Mondrain 2004 = B Mondrain Lrsquoancien empereur Jean VI Cantacuzegravene et ses copistes in A Rigo (a cura di) Gregorio Palamas e oltre Studi e documenti sulle controversie teologiche del XIV secolo bizantino Firenze 2004 pp 249-296
Mondrain 2007 = B Mondrain Les eacutecritures dans les manuscrits byzantins du XIV e siegravecle Quelques probleacutematiques laquoRSBNraquo n s 44 (2007) pp 157-196
Peacuterez Martiacuten 2006 = I Peacuterez Martiacuten Maxime Planude et le Diophantus Matritensis (Madrid Biblioteca Nacional ms 4678) un paradigme de la reacutecupeacuteration des textes anciens dans la ldquorenaissance paleacuteologuerdquo laquoByzantionraquo 76 (2006) pp 433-462
Peacuterez Martiacuten 2008 = I Peacuterez Martiacuten El lsquoestilo Hodegosrsquo y su proyeccioacuten en las escrituras constantinopolitanas laquoSampTraquo 6 (2008) pp 389-458
Perria 1991 = L Perria Scrittura e ornamentazione nei codici della laquocollezione filosoficaraquo laquoRSBNraquo n s 28 (1991) pp 45-111
Rollo 2012 = A Rollo LrsquoArchimede di Giorgio Valla in V Fera ndash D Gionta ndash A Rollo (a cura di) Archimede e le sue fortune Atti del Convegno di Siracusa-Messina 24-26 giugno 2008 Messina 2012 pp 99-147
Rome 1927 = A Rome Membra disjecta laquoRBenraquo 39 (1927) pp 187-188
Rome 1938 = A Rome Un manuscrit de la bibliothegraveque de Boniface VIII agrave la Meacutediceacuteenne de Florence laquoACraquo 7 (1938) pp 261-268
Ronconi 2013 = F Ronconi La collection philosophique un fantocircme historique laquoScripto-riumraquo 67 (2013) pp 119-140
Tannery ndash Steacutephanou 1940 = Quadrivium de Georges Pachymegravere ed P Tannery ndash E Steacutephanou Cittagrave del Vaticano 1940
Tihon 2011 = Πτολεμαίου Πρόχειροι Κανόνες Les Tables faciles de Ptoleacutemeacutee vol Ia Tables A1-A2 ed A Tihon Leuven 2011
Traube 1907 = L Traube Nomina Sacra Versuch einer Geschichte der christlichen Kuumlrzung Muumlnchen 1907
Vogel 1936 = K Vogel Beitraumlge zur griechischen Logistik laquoSBAWraquo Mathematisch-natur-wissenschaftliche Abteilung Jahrgang 1936 pp 357-472
Wouters 1979 = A Wouters The Grammatical Papyri from Graeco-Roman Egypt Contri-butions to the Study of the lsquoArs Grammaticarsquo in Antiquity Brussel 1979
F ACERBI Tav 1
b Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 65r
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 284 f 160r
F ACERBITav 2
b Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 13r
a Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 19v
F ACERBI Tav 3
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 136v
F ACERBITav 4
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17r
F ACERBI Tav 5
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17v
F ACERBITav 6
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 7v
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 149
tava in questo secondo caso a segnalare con la barra singoli vocaboli le menzioni di frasi o di sintagmi complessi sono di norma identificate dallrsquoarticolo lsquocitazionalersquo Drsquoaltra parte le abbreviazioni convenzionali non rientrano nella casistica percheacute la loro resa grafica che contiene elementi non alfabetici come compendi per desinenze lettere supra li-neam marche di contrazione o sospensione quali slashes o barre sotto-poste o sormontanti eventualmente solo un sottinsieme della stringa di segni alfabetici le esclude automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
Venendo al discorso matematico una barra sormonta senza ecce-zione le lettere denotative64 che sia in papiri o in manoscritti in maiu-scola65 o minuscola ma solo allrsquointerno del testo comrsquoegrave da attendersi nei diagrammi esse la perdono per il semplice motivo che non crsquoegrave alcun testo ambiente un diagramma ha unicamente una funzione denotati-va Drsquoaltra parte le lettere numerali che a volte figurano nei diagrammi della tradizione metrica66 allo scopo di indicare la lunghezza dei seg-menti mantengono la barra in un diagramma il contesto denotativo geometrico egrave prevalente e i numerali vengono percepiti come entitagrave grafiche lsquoesternersquo al discorso Va da seacute a fortiori che le lettere numerali inserite in un testo dovranno essere segnalate da barre che a loro volta non servono nelle tavole67 in quanto queste ultime sono come abbiamo visto un vero e proprio testo che perograve funge da ambiente a quello al-fabetico limitato alle titolazioni e non a caso tracciato in unrsquoopportuna lsquomaiuscola distintivarsquo allo scopo di segnalarne il carattere denotativo e non discorsivo68 Una tabella operazionale egrave invece un paratesto e quindi le barre sulle lettere numerali che rappresentano gli interi sono
64 La notazione per le lettere denotative subigrave unrsquoevoluzione (il cui risultato finale egrave descritto per sommi capi nella nota 3 supra) di cui non mette conto occuparsi qui
65 I papiri di contenuto geometrico (o astronomici ma che presentano argomenti geometrici) sono rari si vedano il PHerc 1061 (sec II aC Demetrio Lacone De geome-tria) e il PFay 9 (sec II ex Elementi I 39 e 41) Gli importanti ostraka OBerl 12002 e 12609 (sec III aC m Elementi XIII) non pongono le barre sopra le lettere denotative Per i manoscritti in maiuscola si veda ad esempio passim nel Par gr 2389 una cui riproduzione digitale egrave consultabile in rete allrsquoindirizzo httpgallicabnffrark12148btv1b8470171d o il fragmentum mathematicum Bobiense
66 Si veda ancora il ms Istanbul Topkapı Sarayı Muzesi GI1 codex unicus dei Metrica di Erone e contenente una raccolta importante di problemi del corpus metrologico
67 Si vedano come esempio le tavole citate alle note 10 e 14 supra Discorso a parte per il segno di lsquoposto vuotorsquo si veda il punto c che segue
68 Queste regole generali vanno prese cum grano salis si dagrave naturalmente un certo dominio di variabilitagrave legato verosimilmente al grado di cultura grafica del copista nel PMich III 144 i numerali sono quasi tutti senza barra sia nel testo che nelle tabelle ope-razionali
Fabio Acerbi150
necessarie esse mancano invece sui segni convenzionali che ho descrit-to nel punto precedente e fatto rilevante sulle lettere numerali relative agli ordini sessagesimali quando esse siano identificate da uno o piugrave apici la presenza di questo segno grafico non alfabetico69 le esclude ancora una volta automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo Unrsquoultima osservazione che ci saragrave utile nel seacuteguito la descrizio-ne di una stringa di lettere lsquoagrammaticalersquo non puograve prevedere la men-zione della presenza della barra che le pertiene in quanto tale si tratta di una pratica denotativa che egrave possibile formulare soltanto ad un livello di discorso superiore sia a quello dellrsquouso che a quello della menzione70
c) Il segno di lsquoposto vuotorsquo Si noti nella tav 2b la forma ŏ per il segno di lsquoposto vuotorsquo in un ordine sessagesimale coerentemente con la propria notazione il copista del Marc gr 313 lo scioglie talvolta allrsquoin-terno del testo principale come unrsquoabbreviazione per οὐδέν laquonienteraquo Altre convenzioni di scrittura del tratto che accompagna il circoletto e che si badi bene fa parte integrante del segno di lsquoposto vuotorsquo ndash e infatti nelle tavole troviamo sempre il segno completo mentre tutti gli altri numerali sono come abbiamo visto nel punto precedente privi di barra o di apice a causa del fatto che i vari ordini sessagesimali sono univocamente determinati dalle linee di giustificazione ndash un tratto an-golare anteposto (tav 3 Lar Plut 2818 f 136v)71 o una semplice barra a sormontare (tavv 4-9) si produce in questo modo il segno 65926 che sembra essere stata la forma di base72
69 Occorre dunque supporre come testimoniano papiri e manoscritti in maiuscola che la convenzione relativa allrsquouso della barra si sia consolidata ben prima dellrsquointroduzione di segni diacritici quali accenti e spiriti
70 Si veda il punto 2 infra per maggiori dettagli sulla questione delle barre e degli apici e per le indicazioni in merito che leggiamo in Diofanto
71 Come accennato questa tavola dei sottomultipli coincide con quella descritta ed esposta nei Prolegomena Fatto molto rilevante i numerali nella prima non recano neacute barre neacute apici contrariamente a quanto accade a tutte le istanze della seconda nei manoscritti Quella del Laur Plut 2818 preserva a mio avviso la forma originaria come abbiamo visto una tavola non richiede segni aggiuntivi sulle lettere numerali
72 Si vedano come esempio ancora le tavole citate alle note 10 e 14 supra oppure per una rassegna delle forme che il segno assume nei manoscritti piugrave antichi delle Tavole facili Tihon 2011 pp 58-59 e per quelle che assume nei papiri Jones 1999 I pp 61-62 Ovviamente non possiamo leggere il segno 65926 come un omicron con una barra in quanto ο = 70 nella notazione greca e la barra egrave di rigore quando il numerale figuri allrsquointerno di un testo Occorre ammettere che si dagrave origine ad un bel corto circuito notazionale con il concepire un segno con funzione di lsquoposto vuotorsquo ma che lsquosomigliarsquo ad una lettera dellrsquoalfabeto sormontata da una barra cioegrave ad un numerale in piugrave quando il lsquoposto vuotorsquo non corrisponda ad un intero ma ad una specie sessagesimale la presenza della barra a priori indistinguibile da quella che sormonta gli interi introduce unrsquoincongruenza con la notazione a mezzo di apici vista nellrsquoitem precedente
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 151
d) Errori di copia La tabella riprodotta nella tav 2b ha una forma simmetrica ma si tratta di una forzatura il grande rettangolo in basso a destra drsquoaltronde assente nella descrizione contiene uno scolio che fa notare come lrsquoultimo resto parziale ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ͵γτνζ´´´´´ κζ´´´´´´ cioegrave 0 0 0 0 0 3357 27 siano ἔγγιστα λ´λ´ δ´δ´ ξ laquocon ottima approssimazione 60 minuti quartiraquo dove si notino gli apici semplici per indicare il pas-saggio allrsquoordinale e il raddoppiamento del sistema segno + apice per significare il plurale Lo scolio debitamente accompagnato dal segno di rimando in forma di simbolo solare egrave stato probabilmente incluso nella tabella proprio allo scopo di renderla simmetrica A sua volta un errore precedente spiega lo spazio eccessivo accordato al rettangolo contenente lo scolio il secondo massimo multiplo ŏ λβ´ ξδ´´ ριβ´´´ σιϛ´´´´ egrave trascritto anche al di sotto del risultato
Passiamo ora alla descrizione del metodo di divisione attribuito a Pappo
ἵνα οὖν ταῦτα συναχθῇ τὰ ἐκ τοῦ μερισμοῦ ὁ εἰρημένος Πάππος εὐδιατύπῳ τινὶ καὶ πρὸς τοῦτο τάξει χρησάμενος ποιεῖται τὴν τῆς συλλήψεως τοῦ ζητουμένου ἀνεύρεσιν οὕτως ἐκθέμενος γὰρ τὸν μέλλοντα μερίζεσθαι τουτέστι τὰς τξ μοίρας ἐν ἀρχῇ ἀφαιρεῖ ἀπ᾽ αὐτῶν τὸν ἐν τῇ σελίδι τυγχάνοντα ἐλάττονα τουτέστι τὸν τδ κβ´ κ´´ ὄντα τῶν ἐγγὺς ἐλασσόνων ὡς πρὸς τοὺς ἐκκειμένους διὸ καὶ γράφει αὐτὸν προγράφων αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε καὶ εὑρίσκων τὰ παρακείμενα αὐτῷ τῷ ἀπογραφέντι ἐν τῷ σελιδίῳ λεπτὰ πρῶτα ν´ συναπογράφεται παρατιθῶν αὐτοῖς τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον ἀνατείνουσαν σημαῖνον τὸ εἶδος ὅτι πρῶτα λεπτά εὑρίσκει οὖν οὕτως τὸ τῶν τξ μέρος τὸ τδ κβ´ κ´´ ὃ μεριζόμενον παρὰ τὰς τξε ιδ´ μη´´ ἡμέρας καὶ ποιοῦν τὸν ἐκ τοῦ μερισμοῦ ἀριθμὸν πρῶτα λεπτὰ ν´ καὶ τὸν λοιπὸν ἀπογραφόμενος τὸν νε λζ´ μ´´ προτάσσει αὐτοῦ τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά τάσσει δὲ καὶ ἁπλῆν τινα διατείνουσαν γραμμὴν ὡς ἀπὸ τοῦ τξ ἐπὶ τὸν ἑξῆς ἐκτεθειμένον ἐγγὺς
1
5
10
1 εὐδιατύπῳ] ZSPC εὐδιατύπωτ M 4 ἀφαιρεῖ] MZSP ἀφ ι C 5 ἐλάττονα] P comp MZSC 6 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | αφ ] αφ ε M ἀφ ZS ἀφαί P ἄφ C | ἀντὶ] om C | ἄφελε] MZSP ἄφ C 8 ἀπογραφέντι] MZSP ἐγγραφέντι C | λεπτὰ πρῶτα] P λε πρωτα SC λεπτῶν πρωτ MZ | παρατιθῶν] MZS παρατιθεὶς C et ex corr m 2 P 9 ᾱ] Z αο P α´ MS α C | ἔχον] MPC ἔχων ZS 9-10 πρῶτα λεπτά] ZP πρωτ λ´λ´ M πρωτα λε S αα λε C 11 ἡμέρας] comp codd | ἀριθμὸν] P et comp MZ καὶ C et comp S 12 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M πρωτ λεπτ(α) Z πρωτ λ εᾱ S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C | ἀπογραφόμενος] MZSP ἐγγραφόμενος C | νε λζ´] MZSP λζ νζ C 13 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | λ οι] MZSC ex λ fecit λ οι P | προσσημαῖνον] MC et προσ- comp ZS προση- P | τὸ] MZC τὰ S et fecit m 2 P 14 ἀπὸ] MZSP πρὸς C ἐλάττονα] P comp MZSC
1 εὐδιατύπῳ] εὐδιατυπώτω K 6-7 αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ] τὸ ἀφ K 8 παρατιθῶν mdash 10 λεπτά] τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ σημαίνουσαν τὸ εἶδος αὐτῶν ὅτι ᾱ λεπτά εἰσιν K | τὸ (sec)] τὰ K 12 πρῶτα] πρώτων K | τε λ ] λ οι` K | προσσημαῖνον mdash
Fabio Acerbi152
ἐλάττονα τὸν τδ κβ´ κ´´ ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις καὶ ταύτην ἐπιδεικνύουσαν τὴν τάξιν τῆς προόδου τῆς ἐκθέσεως ἧστινος κλωμένης γραμμῆς πρὸς τῷ ἐγγὺς ἐλάσσονι ἡ ἀντανάκλασις ἐπὶ τὸν λοιπὸν γέγραπται φερομένη ὡς εἴρηται διὰ τὸ εὔτακτον τῆς προκοπῆς οὕτως τε ποιήσας ἑξῆς τὸ αφ ποιῶν ὃ προσσημαίνει ὡς εἴρηται τὸ ὅτι δεῖ ἀφελεῖν ὁμοίως ἀπὸ τοῦ λοιποῦ καὶ δὴ τὸν ἐγγὺς πάλιν ἐλάσσονα ὡς πρὸς τὴν ἐν τῷ σελιδίῳ ἔκθεσιν εὑρισκόμενον λαμβάνων ἑξῆς προγράφει αὐτὸν ὄντα νδ μζ´ ιγ´´ ιβ´´´ καὶ εὑρίσκει αὐτοῖς παρακείμενα ἐν τῷ σελιδίῳ πρῶτα λεπτὰ θ´ ἅτινα καὶ αὐτὰ προσαπογράφεται σὺν τῇ παρασημειώσει τῶν πρώτων γράφων τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον τὴν ἀνατείνουσαν καὶ ὡς εἴρηται τὴν γραμμὴν πάλιν διὰ τὴν τάξιν κλωμένην κατὰ δευτέραν κλάσιν προσέλκει γινομένου τοῦ μέρους αὐτῆς τούτου παραλλήλου τῷ ἐξ ἀρχῆς
16 ante κλωμένης add ἐπὶ C 18 τε] MZP om SC | αφ ] M ἀφ ZSC ἀφαί P 19 προσσημαίνει] MS προση- ZC et ex corr P | ὅτι] ZP comp MSC 20 δὴ] MZSC διὰ fecit m 2 P 21 πρὸς] MSP et supra lineam C ex ἀπὸ fecit m 2 Z | ιγ´´] MZSP νγ´´ C 22 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M ᾱᾱ λεπτὰ Z άάα λε S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C 23 προσαπο- γράφεται] απο suprascr in comp M 24 ᾱ] ZP α´ MS α C 25 κλάσιν] MP τάξιν ZSC | τοῦ] ZSPC τούτου M 26 τούτου] τοῦ bis ZSPC sed prius erasit m 2 P τοῦ M
mdash 18 προκοπῆς] om K | τε ποιήσας] ποιήσας καὶ K | αφ ] ἀφ K 19 τὸ] om K 21 προ-γράφει] γράφει K 22 σελιδίῳ] α´ σελιδίῳ K | ἅτινα] ἃ K 23 προσαπογράφεται] ἀπογράφεται K | τῶν πρώτων mdash 26 ἐξ ἀρχῆς] om K
lsquoAllo scopo di raccogliere ciograve che risulta dalla divisione il detto Pappo utilizzando anche in questo caso una certa disposizione ben strutturata determina nel modo seguente il lsaquonumerorsaquo cercato preso nel suo insieme collocando73 in testa il lsaquonumerorsaquo che sta per essere diviso cioegrave i 360 gradi iniziali sottrae loro tra i piugrave prossimi dei lsaquonumerirsaquo minori rispetto a quelli esposti quello che si trova essere minore nella colonna (cioegrave 304 22 20) Questo egrave il motivo per cui lo trascrive scrivendogli davanti lrsquoabbreviazio-ne laquosottrraquo per laquosottrairaquo e trovando che 50 minuti primi sono collocati accanto a quello stesso lsaquonumerorsaquo che egrave stato trascritto nella colonna li trascrive al tempo stesso collocando accanto74 ad essi la lettera A con un lsaquotrattorsaquo75 sopra che significa la specie minuti primi Trova dunque in que-sto modo la parte di 360 che egrave 304 22 20 la quale divisa per 365 giorni 14 48 fa il numero lsaquoche risultarsaquo dalla divisione 50 minuti primi Trascrivendo
73 La descrizione egrave strutturata come una procedura Acerbi 201274 Il purismo del correttore del Par gr 2390 di Clostomalle nel Marc gr 314 e
dellrsquoautore della recensione bizantina impone loro di modificare la terminazione ma forme tematiche e contratte di τιθεῖν sono correnti nel greco tardivo
75 Il testo greco ha solo il participio con γραμμήν sottinteso Per il significato del participio si veda il punto 2
15
20
25
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 153
poi il resto 55 37 40 gli pone altresigrave76 a prefisso laquoReraquo che significa laquorestiraquo e dispone anche una certa linea semplice77 che va da 360 al piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori che egrave esposto di seacuteguito 304 22 20 come nello lsaquoschemarsaquo esposto linea che mostra lrsquoordine del percorso dellrsquoesposizione Questa linea spezzata lagrave dove si trova il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori egrave tracciata inflessa allrsquoindietro lsaquoersaquo punta verso il resto come egrave stato detto in vista di una progressione ordinata E cosigrave facendo prendendo di seacuteguito il laquosottrraquo che significa come egrave stato detto laquoche occorre similmente sottrarre dal re-storaquo e ovviamente prendendo di nuovo il lsaquonumerorsaquo che egrave trovato essere il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori in relazione alla disposizione nella colonna ndash 54 47 13 12 ndash lo scrive di seacuteguito e trova che 9 minuti primi sono posti loro accanto nella colonna trascrive78 anche questi con la segnaletica dei primi scrivendo la lettera A con un lsaquotrattorsaquo sopra e come egrave stato detto prolunga di nuovo la linea spezzata in vista di una buona disposizione tramite una seconda inflessione essendo questa sua parte parallela a quella inizialersquo
La descrizione continua con una serie di laquoe cosigrave viaraquo e non fa ulte-riore riferimento alla tabella
1) La forma verbale ἐξεσμένον Egrave il neutro del participio perfetto medio-passivo di ξέω lett laquopialloraquo laquolevigoraquo Si danno tre possibilitagrave si tratta di un termine canonico per quanto non altrove attestato per designare unrsquoabbreviazione oppure lrsquoautore anonimo improvvisa sul piano metaforico come se unrsquoabbreviazione non fosse altro che la paro-la completa lsquoaccorciata a colpi di piallarsquo in maniera opportuna oppure il testo egrave corrotto e srsquoimpone una correzione ad esempio τὸ ἑξῆς μένον laquociograve che sta di seacuteguitoraquo Questrsquoultima strada mi pare chiusa dal senso delle frase lrsquoabbreviazione non lsquosta di seacuteguitorsquo a niente ma anzi precede la perifrasi τὸ ἑξῆς μένον se impiegata semplicemente per rimandare al segno αφ immediatamente seguente costituirebbe un intollerabile solecismo Se accettiamo la prima di queste letture considerando quin-di lrsquoabbreviazione αφ in posizione predicativa abbiamo a che fare con
76 Rendo in questo modo il τε isolato77 La linea egrave laquosempliceraquo in quanto egrave una retta la precisazione intende evidenziare per
anticipazione il carattere lsquonon semplicersquo che essa assumeragrave alla prima inflessione quando diventeragrave una spezzata linee siffatte erano in effetti concepite dallrsquoanonimo e prima di lui da tutta la tradizione matematica greca come una singola linea spezzata nei punti drsquoinfles-sione I due segmenti paralleli menzionati al termine del passo sono orizzontali
78 Il verbo egrave al medio in variatio rispetto ai due che precedono e che seguono egrave il matematico che lsquosirsquo trascrive le cifre
Fabio Acerbi154
uno hapax semantico nella grecitagrave superstite come egrave facile verificare con una ricerca sul TLG in rete La recensione bizantina risolve il pro-blema sopprimendo semplicemente τὸ ἐξεσμένον
2) La notazione per le specie numeriche Nella terminologia matema-tica greca gli ordini sessagesimali sono εἴδη laquospecieraquo numerici essi corri- spondono agli ordini di grandezza nel nostro sistema decimale e indica-no in analogia con il caso geometrico la lsquoformarsquo che assume un numero quadrato cubo ecc Centinaia e migliaia sono quindi degli εἴδη rispet-tivamente quadrati (100 egrave il quadrato di 10) e cubi (1000 egrave il cubo di 10) sono specie numeriche ma non numeri particolari e drsquoaltronde 300 non egrave un quadrato ma 3 item dellrsquoεἶδος lsquoquadratorsquo 100 3 egrave il numerale di molteplicitagrave della specie quadrata lsquocentinaiarsquo i due 0 che seguono il 3 segnalano esattamente questo fatto che la notazione greca per gli interi non posizionale fa scomparire al livello denotativo Ciograve non vale soltan-to per i numeri interi ma anche per le loro parti i minuti secondi appar-tengono alla specie lsquoquadratorsquo in quanto 13600 egrave il quadrato di 160
La concezione appare interamente dispiegata nellrsquointroduzione degli Arithmetica diofantei79 che si rivela giova farlo rimarcare un te-stimone fondamentale per la ricostruzione della notazione matematica antica Alle specie usate in questrsquoopera vengono assegnati una denomi-nazione ed un segno convenzionale costituito dallrsquoiniziale (di ognuno dei componenti) della denominazione al quadrato o δύναμις il segno ΔΥ al κύβος il segno ΚΥ alla lsquoquarta potenzarsquo o δυναμοδύναμις il segno ΔΥΔ ecc La descrizione di tali segni egrave del tipo καὶ ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον Κ ἐπίσημον ἔχον Υ ΚΥ κύβος laquoe il suo segno egrave un Κ che ha come indice un Υ ΚΥ cuboraquo dove in accordo con quanto abbiamo visto nel punto b supra e pur nel comprensibile imbarazzo del copista della prima parte del Matritensis (o di un suo passato collega) a districarsi in questo formidabile ginepraio notazionale80 le due lettere Κ e Υ ricevono una barra mentre ΚΥ non la richiede a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον il quale ancora una volta esclude automaticamente il segno dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
79 In particolare a DOO I pp 214-62180 Nel Matr 4678 riscontriamo i seguenti fenomeni nelle poche righe a cavallo dei ff
58r-v 1) accento acuto posto su tutti i segni come se fossero abbreviazioni 2) ripetizione sistematica segnodenominazione come in ΚΥ κύβος appena letto dovuta sicuramente allrsquointrusione di glosse interlineari esplicative dei segni ndash e successivo pentimento (δύναμις e κύβος sono in effetti cancellati dalla prima mano il primo con un tratto il secondo con dei punti supra lineam poi il copista si stanca di correggere) 3) nella descrizione del segno per la δυναμοδύναμις menzione di un δέλτα δύο che saragrave molto probabilmente stato ΔΔ subito dopo nella descrizione del κυβόκυβος si legge un incongruo δύο KK
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 155
Diofanto introduce poi dei segni anche per le specie delle parti dellrsquounitagrave (le nostre frazioni) che egli chiama ὁμώνυμα μορία laquoparti omonimeraquo di cui quelle sessagesimali sono casi particolari81 Egli spie-ga appunto che le loro denominazioni sono ottenute da quelle delle specie degli interi per sinonimia passando ad un lsquoordinalersquo82 formato semplicemente aggiungendo il suffisso -στον δυναμοστόν κυβοστόν δυναμοδυναμοστόν ecc (sott μόριον) I loro segni convenzionali sono invece ottenuti da quelli per le specie degli interi aggiungendo una γραμμὴν διαστέλλουσαν τὸ εἶδος laquolinea che distingue la specieraquo83 Una linea sui segni delle specie delle parti egrave richiesta si badi bene per distinguerli dai segni di quelle degli interi come giagrave osservato questi ultimi sono giagrave lsquoagrammaticalirsquo a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον a fortiori lo saranno anche i primi Si tratta della traduzione semio-tica del passaggio dal cardinale allrsquoordinale che a livello grammaticale egrave effettuato con il suffisso -στον Che forma ha questa linea Barra o apice (Egrave cervellotico pensare a forme piugrave complesse) La domanda non ammette una risposta immediata in quanto delle specie diofantee nessuno piugrave si occupa nellrsquoantichitagrave84 Se egrave vero che la prima risposta darebbe origine ad un conflitto tra due convenzioni denotative diffe-renti la barra lsquocitazionalersquo e la barra che distingue la specie lrsquoevidenza grafica del Matritensis lascia lievemente sgomenti (ricordiamoci che giagrave i segni di base sono indebitamente dotati di un accento dal copista) Le poche occorrenze del segno per le specie delle parti85 vedono lrsquoaggiunta di uno slash di sospensione di un doppio apice inverso ndash in tutta evi-
81 Questo fatto era giagrave chiaro nellrsquoantichitagrave Teone in Alm I 10 in iA p 45310-1682 Il parallelo con i cardinali e gli ordinali relativi agli interi egrave reso esplicito da Dio-
fanto ὥσπερ δὲ τῶν ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια παρομοίως καλεῖται τοῖς ἀριθμοῖς τοῦ μὲν τρία τὸ τρίτον τοῦ δὲ τέσσαρα τὸ τέταρτον οὕτως καὶ τῶν νῦν ἐπονομασθέντων ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια κληθήσεται παρομοίως τοῖς ἀριθμοῖς laquocome le parti omonime dei numeri sono chia-mate per assonanza con i numeri di lsquotrersquo lsquolsaquounrsaquo terzorsquo di lsquoquattrorsquo lsquolsaquounrsaquo quartorsquo cosigrave le parti omonime dei numeri appena nominati saranno chiamate per assonanza con i numeriraquo (DOO I p 69-13 si noti lrsquoarticolo lsquocitazionalersquo al singolare in τοῦ τρία e τοῦ τέσσαρα) Il parallelo prosegue anche al livello dei segni che rappresentano queste specie come vedremo tra un attimo
83 Diofanto Arithmetica prefazione in DOO I p 620-21 un passaggio maltrattato in questa edizione occorre espungere il participio ἔχον senza introdurre segni ulteriori oppure eliminare un precedente ἐπί come fa un correttore del Matritensis f 58v
84 Unica parzialissima eccezione lrsquoaccenno di Teone menzionato nella nota 81 supra85 Al f 59r e per di piugrave nel margine per sanare un lungo saut du mecircme au mecircme La
collocazione in margine egrave il motivo per cui troviamo una notazione abbreviata nel resto del trattato il primo copista scioglie tutti i segni prendendoli per abbreviazioni mentre il secondo elimina sistematicamente il tratto aggiuntivo delle specie delle parti dellrsquounitagrave Drsquoaltronde egli scrive ad esempio ΔΥ invece di ΔΥ ed egrave quindi indotto a porre la barra al di sopra della stringa di lettere risultante (passim ma si veda ad esempio il f 72r)
Fabio Acerbi156
denza il compendio per la desinenza -ον accentata il copista interpreta il segno come unrsquoabbreviazione ndash e di una barra a sormontare lo Υ Potremmo forse interpretarlo come il segno di contrazione del grafema -στ- lrsquounico tassello mancante in unrsquoabbreviazione come ad esempio (δυναμοδυναμο)(στ)(ὸν) ma uno scolio di prima mano al f 58v rela-tivo alle specie degli interi inficia questrsquoipotesi esse sono dotate di slash di sospensione accento acuto in un caso del compendio canonico per la terminazione -ον hellip ma tutti gli Υ a esponente sono a loro volta sormontati da una barra
Meno legata al singolo manoscritto ma nondimeno non uniforme si presenta la pratica di notazione dei segni che rappresentano gli enti numerici sessagesimali86 da una parte sta lrsquoevidenza del testo dei Pro-legomena e delle sue tabelle apici ndash drsquoaltronde come abbiamo visto la notazione universalmente impiegata per i numerali ordinali e per le fra-zioni unitarie ndash dallrsquoaltra sta lrsquoevidenza del testo dellrsquoAlmagesto in tutti i manoscritti piugrave antichi e lo stesso si dica del commentario teonino a questrsquoopera o del suo lsquoGrande commentariorsquo alle Tavole facili e dei testi astronomici su papiro barre87 Sembra insomma che la nostra docu-
86 Sia le molteplicitagrave che le specie ahimeacute entrambe rappresentate da lettere dellrsquoalfabeto Come osservato allrsquoinizio della sezione 3 ci sono in effetti due tipi di lettere numerali in gioco se facciamo astrazione da apici o barre lsquo4 minuti secondirsquo si trova scritto δ β la prima lettera numerale denota la molteplicitagrave degli item di una certa specie la se-conda la specie nei Prolegomena entrambe sono accompagnate da un doppio apice il che rende inutile la presenza delle seconde Si noti che la descrizione della tabella non fa parola della notazione da usare per le lettere numerali che denotano la molteplicitagrave barre o apici e quanti apici hellip In questo caso fa interamente fede la tabella cioegrave la pratica grafica condivisa instauratasi non egrave chiaro quando
87 I manoscritti piugrave antichi dellrsquoAlmagesto sono menzionati nella nota 10 supra quelli dei due commentarii teonini sono il Laur Plut 2818 e il celeberrimo Vat gr 190 (sec IX in Euclide Elementi Data Teone lsquoGrande commentariorsquo) per la notazione dei pa-piri astronomici si veda Jones 1999 II passim La notazione non sembra lsquoinquinatarsquo dalla pratica dei copisti bizantini e pare dipendere soltanto dalla data di composizione Tro-viamo ad esempio barre sopra tutti i numerali di molteplicitagrave (interi o sessagesimali) nel frammento di un commentario alle Tavole facili contenente un calcolo relativo al 24 aprile 213 (Par gr 2841 sec XIII ex-XIV in oltre al frammento ai ff 32r l 11-34v l 23 contiene Arato Phaenomena ed Efestione Apotelesmatica edizione in Jones 1990) Nel commentario alle Tavole facili composto ca 610-617 ed attribuito a Stefano di Alessandria la situazione egrave la seguente (Jean Lempire per litteras per lrsquoedizione si veda Lempire 2014 ho controllato il Vat gr 304 ff 135r-171v sec XIV am contiene in aggiunta Teone in Almagestum I-II lsquoPiccolo commentariorsquo alle Tavole facili Diofanto Arithmetica e De polygo-nis numeris varia astronomica tabulae) barre sopra gli interi sporadicamente rimpiazzate da apici apici sopra le parti sessagesimali in numero uguale alla denominazione doppio () apice per le frazioni unitarie Sono impiegate barre sopra gli interi e apici sopra le parti sessagesimali nei manoscritti principali di tutti i trattati di introduzione allrsquoAlmagesto o comunque di argomento logistico redatti in epoca bizantina Giorgio Pachimere (1242-ca 1310) Quadrivium (autografo nel manoscritto Roma Biblioteca Angelica gr 38 [RGK III nr 115] si veda Tannery ndash Steacutephanou 1940 per lrsquoedizione) Teodoro Metochita (1270-
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 157
mentazione si faccia testimone di un cambio notazionale avvenuto nel periodo intercorrente fra Teone (sec IV pm) e la scuola alessandrina di Ammonio e dei suoi allievi (sec VI in) e probabilmente innescato da questrsquoultimo ambiente lrsquoaspetto paradossale egrave che nello stesso codice si rintraccino due notazioni differenti per gli enti numerici sessagesimali e lrsquouna (apici) sia adottata sistematicamente e coerentemente in uno scritto (i Prolegomena) che si presenta esattamente come unrsquointroduzione tecnica alla pratica numerico-algoritmica del trattato (lrsquoAlmagesto) in cui egrave adottata lrsquoaltra (barre che ritroviamo senza eccezioni anche negli scolii)
Torniamo ai Prolegomena la descrizione del segno da porre a fianco di ogni singolo quoziente parziale e denotante la sua specie numerica (minuti primi minuti secondi ecc) solleva tre problemi
Primo problema Ci vuole una barra o un apice su τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquola lettera A [hellip] che significa la specieraquo quando lo scriviamo nella tabella Tutta la nostra discussione precedente fa pro-pendere per lrsquoapice e si ricordi anche la forma verbale ἀνατείνουσαν che suggerisce qualcosa che si lsquoestende verso lrsquoaltorsquo (la mia traduzione egrave volutamente neutra) se fosse apposta una barra la cosa dovrebbe passare
1231332) Compendium astronomicum (copia lsquoautorizzatarsquo coeva nei Vat gr 182 e 181 da parte del copista che integrograve le parti mancanti del Par gr 2389 [ff 207-210 255-270 374-375] Bianconi 2005a pp 425-427 Peacuterez Martiacuten 2008 p 436 e n 177) Teodoro Meliteniota (morto lrsquo831393) Tribiblos astronomica (autografo nel Vat gr 792 si vedano Leurquin 1991 per unrsquoanalisi del manoscritto Leurquin 1990 per lrsquoedizione) una com-pilazione anonima (per cui ho consultato il Par gr 2396 ff 87r-92v limitatamente a questi fogli manu Costantino Trivoli [RGK II nr 318 ma ovviamente questo codice non vi egrave segnalato] terzo quarto del XV secolo il resto del codice annotato da Niceforo Gregora egrave di etagrave planudea e parzialmente [ff 33v-76v] un autografo di Planude stesso contiene Teone in Almagestum I II IV Mondrain 2002 il codice va completato ndash limitatamente a stralci dei libri VIII-X XII-XIII del commentario teonino la cui parte intermedia si egrave persa ndash con 26 carte [ff 123-147] inserite nel Vat gr 1087 anchrsquoesso contenente anno-tazioni di Gregora Rome 1927 per la figura del copista dei ff 77r-86r del Par gr 2396 e dei ff appena nominati del Vat gr 1087 un anonimo collaboratore di Gregora si veda in ultimo Bianconi 2006a pp 147-151) si veda anche il calcolo effettuato da Niceforo Gre-gora (12921295-13581361) dellrsquoeclisse di sole del 16 luglio 1330 (attestata unicamente ai ff 1r-8v della miscellanea astronomica Marc gr 325 databile ca 1324-1329 in parte vergata e ovunque fittamente annotata da Gregora stesso edizione del testo in Mogenet et al 1983 annotazioni di Gregora elencate in Bianconi 2005a p 413) Unrsquoeccezione apparente il lsquoPiccolo commentariorsquo di Teone alle Tavole facili le parti sessagesimali sono segnalate da apici (ad esempio nel Vat gr 175 vergato da Giovanni Catrario e completato nel 1321-1322 sulla figura di Catrario si vedano in ultimo Bianconi 2005b pp 141-156 e 2006b) lrsquoopera egrave antica ma la sua tradizione non rimonta oltre la fine del XIII secolo a parte un frammento nel Leiden BPG 78 ff 156r-161v (minuscola del IX-X secolo) e in effetti in questo manoscritto tutti i numerali di molteplicitagrave sono sormontati da barre Unrsquoeccezione effettiva egrave il De hypotesibus planetarum nel Vat gr 1594 barre sugli interi e apici sulle parti sessagesimali
Fabio Acerbi158
sotto silenzio e la presenza dellrsquoapice la rende inutile88 Si tratta della stessa convenzione diofantea e coincide ancora con la notazione per i numerali ordinali e per le frazioni unitarie che egrave corrente nei mano- scritti matematici greci per questo motivo non percheacute la descrizione sia particolarmente perspicua nessuno dei copisti della recensione an-tica ha incertezze apici Ma questi apici si rintracciano soltanto sulle indicazioni di specie non contemplate dalla descrizione che sono ante-poste ai resti parziali a fianco dei quozienti parziali i segni di specie sono invece trasformati in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordi-nali corrispondenti del tipo πρωτ tavv 5 e 7b-8 Il recensore bizantino taglia invece la testa al toro elimina dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali elimina la seconda menzione della laquolet-tera Araquo contestualmente allrsquoazzeramento dellrsquoespediente della linea a zig-zag (si veda il punto seguente) modifica la descrizione che contiene la prima menzione in quella dellrsquoapice associato direttamente ai nume-rali di molteplicitagrave riciclando addirittura lrsquoalpha per adibirlo a desi-gnare un numero cardinale (come sorprendersi) τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ laquoponendo al di sopra di essi [scil dei 50 minuti primi] 1 solo lsaquoaccentorsaquo acutoraquo La scelta del recensore egrave assennata che rechi una barra o un apice in una tabella un alpha denota un numero non un numero drsquoordine
Secondo problema da tenere ben distinto dal precedente Cosa ci vuole sul segno α per la lettera alpha menzionata nella frase τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquolettera A [hellip] che significa la specieraquo89 Unrsquooc-chiata allrsquoapparato critico rivela una bella incertezza nei manoscritti Z scrive sempre ᾱ e in un caso lo fa anche P MS optano sempre per α´ C per α P scrive nellrsquoaltro caso αο Per quanto solo la barra sia congrua con il senso della frase in quanto la lettera alpha egrave qui menzionata (si tratta di un oggetto che compare nella tabella) e non cambia niente se essa egrave accompagnata dal suo nome di genere στοιχεῖον ad un livello grafico lrsquoincertezza fra il segno ᾱ che denota laquola lettera αraquo e il segno α´ (o lrsquoabbreviazione αο) per una forma di πρῶτος egrave per piugrave versi giustificata
88 Detto in altri termini la barra egrave uno strumento grafico non matematico e quindi la sua presenza non va segnalata mentre un apice lo egrave e la sua presenza lo deve
89 Notare che in questa frase il primo α non vuole la barra (egrave menzionato allrsquointerno di una frase che impiega convenzioni moderne) il secondo sigrave (idem ma con convenzioni antiche) ndash e nella traduzione la scelta di denotarlo con A (senza virgolette) e non con lsquoArsquo (con virgolette) egrave del tutto arbitraria ndash si noti inoltre che le necessarie precisazioni laquosenzacon virgoletteraquo mostrano che le lingue moderne palesano difficoltagrave analoghe a quelle del greco antico per quanto riguarda i livelli denotativi in ambito metadiscorsivo per non usare le due parentetiche avrei dovuto scrivere rispettivamente lsquoArsquo e lsquolsquoArsquorsquo (doppie virgolette semplici)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 159
ᾱ coincide con il numerale 1 α egrave la prima lettera dellrsquoalfabeto ed inoltre α´ egrave esattamente quello che va scritto nella tabella Potremmo dirci che il sostantivo στοιχεῖον chiude la questione la sua presenza congiunta ad un ipotetico α´ renderebbe la descrizione ridondante o inappropriata90 Ma a parte il fatto che α egrave proprio τὸ πρῶτον στοιχεῖον il segno α´ cat-tura in fondo il cuore della descrizione di uno στοιχεῖον ἔχον lsaquoγραμμὴνrsaquo ἀνατείνουσαν
Terzo problema Lrsquoautore dei Prolegomena che si arresta allrsquoesem-pio dei minuti primi non dice quanti apici occorre mettere sulle lettere numerali che identificano gli ordini superiori al primo se uno soltanto come nel caso diofanteo e delle frazioni unitarie o in numero uguale alla loro denominazione (cioegrave pari al numero denotato dal numerale stesso su cui vanno posti) come effettivamente avviene nei mano-scritti dei Prolegomena La tabella egrave quindi sottodeterminata dalla sua descrizione anzi in un certo senso prende il sopravvento su di essa la pratica di marcare i numerali di molteplicitagrave con gli apici che compe-tono allrsquoordine cui appartengono viene trasferita ai segni per gli ordini stessi per supplire ad una descrizione carente di questi ultimi E la tabella egrave sottodeterminata dalla descrizione in quanto egrave la descrizione di una tabella reale ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις laquocome nello lsaquoschemarsaquo espostoraquo leggiamo a un certo punto del testo
3) La linea a zig-zag Non possiamo che applaudire a questo geniale espediente grafico lo troviamo messo in opera solo nel Marc gr 313 Per quanto lrsquoautore non faccia parola di ciograve nel corso della sua descrizione la linea spezzata egrave intesa dover lsquosaltarersquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue Il copista del codice marciano effettua correttamente due salti nella prima delle sue tabelle (tav 4) ma inserisce un lsquodentersquo in piugrave in quella che considera corretta (tav 5) La linea a zig-zag egrave incompatibile con la presenza di linee di giustificazione nella tabella che in effetti mancano nel Marc gr 313 ciograve induce gli errori di allineamento dei primi 5 quozienti parziali di cui egrave vittima il copista Probabilmente per questo motivo in nessuno degli apografi del Vat gr 1594 la linea a zig-zag figura nella tabella inquadrata come si conviene da una (doppia) cornice esterna e le cui colonne sono appunto separate da linee verticali (tav 7b Vat gr 184 f 17v e tav 8 Par gr 2390 f 9v cui egrave sostanzialmente identica la tabella del Marc gr 314 che si trova
90 Trascuro lrsquoabbreviazione αο = πρῶτος percheacute la desinenza non egrave quella richiesta neacute nella frase (egrave richiesto πρῶτον) neacute nella tabella (πρῶτα)
Fabio Acerbi160
al f 248r ndash ma la mancanza di linee orizzontali causa un gigantesco pa-sticcio nel codice vaticano) Alla recensione bizantina che dipende per il suo testo di base dal Vat gr 1594 e quindi non trova la linea a zig-zag nella tabella non resta che sopprimere la sua descrizione ndash ma proprio per questo motivo e finalmente diventa possibile tracciare un apparato completo di linee di giustificazione (tav 9 Laur Plut 89 sup 48 f 14v) Dato che la descrizione di Teone di questo procedimento di divi-sione non fa cenno allrsquoesistenza della linea a zig-zag viene da chiedersi se essa non costituisca un espediente escogitato dallrsquoautore dei Prolegomena per vivacizzare la procedura originale di Pappo
4) Discrepanze tra descrizione e tabella Il gioco delle minime va-rianti mostra che la divisione era stata eseguita (e trasmessa) corret-tamente tutti i valori numerici sono esatti La tabella nel Marc gr 313 presenta perograve alcune discrepanze con la propria descrizione Essa omette (ma non nella versione lsquoscorrettarsquo lrsquoomissione non si riscontra neanche nel Par gr 2390) il segno per laquorestoraquo di fronte ai resti par-ziali ma aggiunge lrsquoindicazione della loro specie Essa trasforma invece come abbiamo visto le indicazioni di specie che seguono i quozienti parziali in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordinali corri-spondenti La descrizione prevede di chiudere la tabella con il risultato καὶ συνάγων ἅπαντα τὰ ἐκ τῶν μερισθέντων μερῶν λεπτὰ σημειοῦται ὑπὸ πάντας οὕτως γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoe raccogliendo tutti i minuti che provengono dalle parti divise lsaquoPapporsaquo nota sotto tutto cosigrave Ris 0 59 8 17 13 12 31raquo ma sotto la tabella tutta la tradizione ci consegna qualcosa di piugrave articolato ὁ ζητούμενος καθ᾽ ὃν μερίζεται ὁ τξε ιδ´ μη´´ π(αρὰ) τὸν τξ γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoil lsaquonumerorsaquo cercato secondo cui 365 14 48 egrave diviso per 360 risulta 0 59 8 17 13 12 31raquo frase che del resto contiene due errori lrsquoinversione del dividendo e del divisore e la confusione tra segno convenzionale (iuxta descrizione) e abbreviazione (come nella frase) nel caso di γι Oltre ad eliminare la linea a zig-zag91 la recensione bizantina sopprime dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali e modifica come abbiamo visto al punto 2 le loro descrizioni in quelle di apici associati diretta-mente ai numerali di molteplicitagrave
91 Le due righe che nella recensione di base contengono solo i resti parziali minori di 160 del divisore ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue sono in parte completate con lrsquoindicazione abbreviata ἀνάλ(υσις) laquoanalisiraquo il termine greco per questa procedura di riduzione In un sussulto di ipercorrettismo matematico tali resti parziali ridotti non sono preceduti dal segno per laquorestoraquo come nel Par gr 2390 ma da quello per laquorisultatoraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 161
Gli esempi che abbiamo discusso mostrano come i problemi di notazione pesino e non poco sullrsquoespressione discorsiva di un algorit-mo matematico lrsquoente di riferimento per lsquoformularersquo il procedimento di divisione fu considerata la tabella cioegrave un oggetto la cui costitu-zione egrave legata piugrave ad una pratica grafica che a considerazioni logico- algoritmiche non la sua descrizione che in effetti finisce per determi-nare la tabella in maniera non univoca Di questa sottodeterminazione si fa testimone la traiettoria che abbiamo cercato di seguire nelle mani di copisti e revisori il procedimento di divisione si modifica a volte in aspetti secondari a volte in punti piugrave sostanziali ndash fino a rendere neces-saria una radicale revisione della sua descrizione per renderla conforme alla tabella ndash in ogni caso mai per ragioni squisitamente matematiche92
Abstract
The article presents and discusses in detail two passages from the anonymous Prolegomena to the Almagest a VIth century primer to the elementary procedures of calculation needed in Ptolemyrsquos Almagest In the two passages we may follow the complex interplay between mathematical notation the auctor who employed and described it the tachygrapher who transcribed it in vivo copyists who reproduced it correctors who modified it Along this path misgivings and errors arise in the transmission of abbreviations and paratextual units such as diagrams tables operational schemes
Fabio AcerbiCNRS UMR8560 Centre Alexandre Koyreacute
fabacerbigmailcom
92 Sono grato a Daniele Bianconi Lucio del Corso Jean Lempire per alcune preziose indicazioni
AOO = Archimedis opera omnia cum commentariis Eutocii ed J L Heiberg I-III Lipsiae 1910-1915
DOO = Diophanti Alexandrini opera omnia cum Graecis commentariis ed P Tannery I-II Lipsiae 1893-1895
GC = Le laquoGrand Commentaireraquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Mogenet ndash A Tihon I-III Cittagrave del Vaticano 1985-1999
iA = Commentaires de Pappus et de Theacuteon drsquoAlexandrie sur lrsquoAlmageste ed A Rome I-III con paginazione continua Cittagrave del Vaticano 1931-1943
HOO = Heronis Alexandrini opera quae supersunt omnia ed G Schmidt ndash L Nix ndash W Schmidt ndash H Schoene ndash J L Heiberg I-V Lipsiae 1899-1914
PC = Le ldquoPetit Commentairerdquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed A Tihon Cittagrave del Vaticano 1978
POO = Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia ed J L Heiberg I-II in 3 parti Lipsiae 1898-1907
RGK = Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600 I Handschriften aus Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln II Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs und Nachtraumlge zu den Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln III Handschriften aus Bibliotheken Roms mit dem Vatikan A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg unter Mitarbeit von D Harlfinger und P Eleuteri B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln Wien 1981-1997 (Oumlsterreichische Akademie der Wissenschaften Veroumlffentlichungen der Kommission fuumlr Byzantinistik III1-3 A-C)
Sigla
Acerbi 2010 = F Acerbi Il silenzio delle sirene La matematica greca antica Roma 2010
Acerbi 2012 = F Acerbi I codici stilistici della matematica greca dimostrazioni procedure algoritmi laquoQUCCraquo 1012 (2012) pp 167-214
Acerbi et al 2010 = F Acerbi ndash N Vinel ndash B Vitrac Les Proleacutegomegravenes agrave lrsquoAlmageste Une eacutedition agrave partir des manuscrits les plus anciens Introduction geacuteneacuterale ndash Parties I-III laquoSCIAMVSraquo 11 (2010) pp 53-210
Agati 1992 = M L Agati La minuscola laquoBouleteacuteeraquo Cittagrave del Vaticano 1992
Belger 1881 = C Belger Ein neues Fragmentum mathematicum Bobiense laquoHermesraquo 16 (1881) pp 261-284
Bianconi 2005a = D Bianconi La biblioteca di Cora tra Massimo Planude e Niceforo Gregora Una questione di mani laquoSampTraquo 3 (2005) pp 391-438
Bianconi 2005b = D Bianconi Tessalonica nellrsquoetagrave dei Paleologi Le pratiche intellettuali nel riflesso della cultura scritta Paris 2005
Bianconi 2006a = D Bianconi Le pietre e il ponte ovvero identificazioni di mani e storia della cultura laquoBizantinisticaraquo 8 (2006) pp 135-181
Bianconi 2006b = D Bianconi Qualcosa di nuovo su Giovanni Catrario laquoMEGraquo 6 (2006) pp 69-91
Cavallo 1977 = G Cavallo Funzione e strutture della maiuscola greca tra i secoli VIII-XI in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Colloque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 95-137
Cereteli 1904 = G F Cereteli De compendiis scripturae codicum Graecorum praecipue Petropolitanorum et Mosquensium anni nota instructorum Sankt-Petersburg 1904
De Gregorio 2000 = G De Gregorio Materiali vecchi e nuovi per uno studio della minu-scola greca fra VII e IX secolo in G Prato (a cura di) I manoscritti greci tra riflessione e dibattito Atti del V Colloquio Internazionale di Paleografia Greca Cremona 4-10 ottobre 1998 Firenze 2000 pp 83-151
Follieri 1977 = E Follieri La minuscola libraria dei secoli IX e X in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Col-loque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 139-165
Fonkič 2005 = B Fonkič Venecianskaia rukopisrsquo laquoAlrsquomagestaraquo Ptolemeja (Marc gr 313690) o datirovke i proischoždenii kodeksa laquoVDIraquo s III 254 (2005) pp 162-167
Fowler 1999 = D H Fowler The Mathematics of Platorsquos Academy A New Reconstruction Second Edition Oxford 1999
Bibliografia
Fabio Acerbi164
Gerstinger ndash Vogel 1932 = H Gerstinger ndash K Vogel Eine stereometrische Aufgaben-sammlung im Papyrus Graecus [sic] Vindobonensis 19996 laquoMitteilungen aus der Papy-russammlung der Nationalbibliothek in Wienraquo Neue Serie Folge 1 Griechische literarische Papyri 1 Wien 1932 pp 11-76
Heiberg 1927 = Mathematici Graeci Minores ed J L Heiberg Kjoslashbenhavn 1927
Hultsch 1876-1878 = Pappi Alexandrini Collectionis quae supersunt ed F Hultsch I-III Berlin 1876-1878
Janz 2003 = T Janz The Scribes and the Date of the Vat gr 1291 in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae X Cittagrave del Vaticano 2003 pp 159-180
Jones 1990 = Ptolemyrsquos First Commentator ed A Jones Philadelphia 1990
Jones 1999 = Astronomical Papyri from Oxyrhynchus ed A Jones I-II Philadelphia 1999
Jones 2005 = A Jones Ptolemyrsquos Canobic Inscription and Heliodorusrsquo Observation Reports laquoSCIAMVSraquo 6 (2005) pp 53-97
Lempire 2014 = Steacutephanos drsquoAlexandrie Le commentaire aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Lempire Louvain 2014
Leurquin 1990 = Theacuteodore Meacuteliteacuteniote Tribiblos astronomique Livre I ed R Leurquin Amsterdam 1990
Leurquin 1991 = R Leurquin Un manuscrit autographe de la Tribiblos Astronomique de Theacuteodore Meacuteliteacuteniote le Vaticanus graecus 792 laquoScriptoriumraquo 45 (1991) pp 145-162
Maas 1927 = P Maas Griechische Palaeographie in A Gercke ndash E Norden (hrsg von) Einleitung in die Altertumswissenschaft I9 Leipzig 1927 pp 69-80
Martinelli Tempesta 2010 = S Martinelli Tempesta Il codice Milano Biblioteca Am-brosiana B 75 sup (gr 104) e lrsquoevoluzione della scrittura di Giovanni Scutariota in A B Garciacutea ndash I Peacuterez Martiacuten (ed by) The Legacy of Bernard de Montfaucon Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting Proceedings of the Seventh Inter-national Colloquium of Greek Palaeography Madrid-Salamanca 15-20 September 2008 Turnhout 2010 pp 171-186
Mazzucchi 1994 = C M Mazzucchi Leggere i classici durante la catastrofe (Costantino-poli maggio-agosto 1203) le note marginali al Diodoro Siculo Vaticano gr 130 Parte prima stratigrafia laquoAevumraquo 68 (1994) pp 164-218
Mioni 1976 = E Mioni Bessarione scriba e alcuni suoi collaboratori in Miscellanea marcia-na di studi bessarionei Padova 1976 pp 263-323
Mioni 1985 = Codices graeci manuscripti Bibliothecae Divi Marci Venetiarum II Thesaurus Antiquus Codices 300-625 recensuit E Mioni Roma 1985
Mogenet 1962 = J Mogenet Une scholie ineacutedite du Vat gr 1594 sur les rapports entre lrsquoastronomie arabe et Byzance laquoOsirisraquo 14 (1962) pp 198-221
Mogenet et al 1983 = Niceacutephore Greacutegoras Calcul de lrsquoeacuteclipse de soleil du 16 juillet 1330 ed J Mogenet ndash A Tihon ndash R Royez ndash A Berg Amsterdam 1983
Mondrain 2002 = B Mondrain Maxime Planude Niceacutephore Greacutegoras et Ptoleacutemeacutee laquoPa-laeoslavicaraquo 10 (2002) pp 312-322
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 165
Mondrain 2004 = B Mondrain Lrsquoancien empereur Jean VI Cantacuzegravene et ses copistes in A Rigo (a cura di) Gregorio Palamas e oltre Studi e documenti sulle controversie teologiche del XIV secolo bizantino Firenze 2004 pp 249-296
Mondrain 2007 = B Mondrain Les eacutecritures dans les manuscrits byzantins du XIV e siegravecle Quelques probleacutematiques laquoRSBNraquo n s 44 (2007) pp 157-196
Peacuterez Martiacuten 2006 = I Peacuterez Martiacuten Maxime Planude et le Diophantus Matritensis (Madrid Biblioteca Nacional ms 4678) un paradigme de la reacutecupeacuteration des textes anciens dans la ldquorenaissance paleacuteologuerdquo laquoByzantionraquo 76 (2006) pp 433-462
Peacuterez Martiacuten 2008 = I Peacuterez Martiacuten El lsquoestilo Hodegosrsquo y su proyeccioacuten en las escrituras constantinopolitanas laquoSampTraquo 6 (2008) pp 389-458
Perria 1991 = L Perria Scrittura e ornamentazione nei codici della laquocollezione filosoficaraquo laquoRSBNraquo n s 28 (1991) pp 45-111
Rollo 2012 = A Rollo LrsquoArchimede di Giorgio Valla in V Fera ndash D Gionta ndash A Rollo (a cura di) Archimede e le sue fortune Atti del Convegno di Siracusa-Messina 24-26 giugno 2008 Messina 2012 pp 99-147
Rome 1927 = A Rome Membra disjecta laquoRBenraquo 39 (1927) pp 187-188
Rome 1938 = A Rome Un manuscrit de la bibliothegraveque de Boniface VIII agrave la Meacutediceacuteenne de Florence laquoACraquo 7 (1938) pp 261-268
Ronconi 2013 = F Ronconi La collection philosophique un fantocircme historique laquoScripto-riumraquo 67 (2013) pp 119-140
Tannery ndash Steacutephanou 1940 = Quadrivium de Georges Pachymegravere ed P Tannery ndash E Steacutephanou Cittagrave del Vaticano 1940
Tihon 2011 = Πτολεμαίου Πρόχειροι Κανόνες Les Tables faciles de Ptoleacutemeacutee vol Ia Tables A1-A2 ed A Tihon Leuven 2011
Traube 1907 = L Traube Nomina Sacra Versuch einer Geschichte der christlichen Kuumlrzung Muumlnchen 1907
Vogel 1936 = K Vogel Beitraumlge zur griechischen Logistik laquoSBAWraquo Mathematisch-natur-wissenschaftliche Abteilung Jahrgang 1936 pp 357-472
Wouters 1979 = A Wouters The Grammatical Papyri from Graeco-Roman Egypt Contri-butions to the Study of the lsquoArs Grammaticarsquo in Antiquity Brussel 1979
F ACERBI Tav 1
b Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 65r
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 284 f 160r
F ACERBITav 2
b Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 13r
a Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 19v
F ACERBI Tav 3
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 136v
F ACERBITav 4
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17r
F ACERBI Tav 5
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17v
F ACERBITav 6
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 7v
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
Fabio Acerbi150
necessarie esse mancano invece sui segni convenzionali che ho descrit-to nel punto precedente e fatto rilevante sulle lettere numerali relative agli ordini sessagesimali quando esse siano identificate da uno o piugrave apici la presenza di questo segno grafico non alfabetico69 le esclude ancora una volta automaticamente dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo Unrsquoultima osservazione che ci saragrave utile nel seacuteguito la descrizio-ne di una stringa di lettere lsquoagrammaticalersquo non puograve prevedere la men-zione della presenza della barra che le pertiene in quanto tale si tratta di una pratica denotativa che egrave possibile formulare soltanto ad un livello di discorso superiore sia a quello dellrsquouso che a quello della menzione70
c) Il segno di lsquoposto vuotorsquo Si noti nella tav 2b la forma ŏ per il segno di lsquoposto vuotorsquo in un ordine sessagesimale coerentemente con la propria notazione il copista del Marc gr 313 lo scioglie talvolta allrsquoin-terno del testo principale come unrsquoabbreviazione per οὐδέν laquonienteraquo Altre convenzioni di scrittura del tratto che accompagna il circoletto e che si badi bene fa parte integrante del segno di lsquoposto vuotorsquo ndash e infatti nelle tavole troviamo sempre il segno completo mentre tutti gli altri numerali sono come abbiamo visto nel punto precedente privi di barra o di apice a causa del fatto che i vari ordini sessagesimali sono univocamente determinati dalle linee di giustificazione ndash un tratto an-golare anteposto (tav 3 Lar Plut 2818 f 136v)71 o una semplice barra a sormontare (tavv 4-9) si produce in questo modo il segno 65926 che sembra essere stata la forma di base72
69 Occorre dunque supporre come testimoniano papiri e manoscritti in maiuscola che la convenzione relativa allrsquouso della barra si sia consolidata ben prima dellrsquointroduzione di segni diacritici quali accenti e spiriti
70 Si veda il punto 2 infra per maggiori dettagli sulla questione delle barre e degli apici e per le indicazioni in merito che leggiamo in Diofanto
71 Come accennato questa tavola dei sottomultipli coincide con quella descritta ed esposta nei Prolegomena Fatto molto rilevante i numerali nella prima non recano neacute barre neacute apici contrariamente a quanto accade a tutte le istanze della seconda nei manoscritti Quella del Laur Plut 2818 preserva a mio avviso la forma originaria come abbiamo visto una tavola non richiede segni aggiuntivi sulle lettere numerali
72 Si vedano come esempio ancora le tavole citate alle note 10 e 14 supra oppure per una rassegna delle forme che il segno assume nei manoscritti piugrave antichi delle Tavole facili Tihon 2011 pp 58-59 e per quelle che assume nei papiri Jones 1999 I pp 61-62 Ovviamente non possiamo leggere il segno 65926 come un omicron con una barra in quanto ο = 70 nella notazione greca e la barra egrave di rigore quando il numerale figuri allrsquointerno di un testo Occorre ammettere che si dagrave origine ad un bel corto circuito notazionale con il concepire un segno con funzione di lsquoposto vuotorsquo ma che lsquosomigliarsquo ad una lettera dellrsquoalfabeto sormontata da una barra cioegrave ad un numerale in piugrave quando il lsquoposto vuotorsquo non corrisponda ad un intero ma ad una specie sessagesimale la presenza della barra a priori indistinguibile da quella che sormonta gli interi introduce unrsquoincongruenza con la notazione a mezzo di apici vista nellrsquoitem precedente
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 151
d) Errori di copia La tabella riprodotta nella tav 2b ha una forma simmetrica ma si tratta di una forzatura il grande rettangolo in basso a destra drsquoaltronde assente nella descrizione contiene uno scolio che fa notare come lrsquoultimo resto parziale ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ͵γτνζ´´´´´ κζ´´´´´´ cioegrave 0 0 0 0 0 3357 27 siano ἔγγιστα λ´λ´ δ´δ´ ξ laquocon ottima approssimazione 60 minuti quartiraquo dove si notino gli apici semplici per indicare il pas-saggio allrsquoordinale e il raddoppiamento del sistema segno + apice per significare il plurale Lo scolio debitamente accompagnato dal segno di rimando in forma di simbolo solare egrave stato probabilmente incluso nella tabella proprio allo scopo di renderla simmetrica A sua volta un errore precedente spiega lo spazio eccessivo accordato al rettangolo contenente lo scolio il secondo massimo multiplo ŏ λβ´ ξδ´´ ριβ´´´ σιϛ´´´´ egrave trascritto anche al di sotto del risultato
Passiamo ora alla descrizione del metodo di divisione attribuito a Pappo
ἵνα οὖν ταῦτα συναχθῇ τὰ ἐκ τοῦ μερισμοῦ ὁ εἰρημένος Πάππος εὐδιατύπῳ τινὶ καὶ πρὸς τοῦτο τάξει χρησάμενος ποιεῖται τὴν τῆς συλλήψεως τοῦ ζητουμένου ἀνεύρεσιν οὕτως ἐκθέμενος γὰρ τὸν μέλλοντα μερίζεσθαι τουτέστι τὰς τξ μοίρας ἐν ἀρχῇ ἀφαιρεῖ ἀπ᾽ αὐτῶν τὸν ἐν τῇ σελίδι τυγχάνοντα ἐλάττονα τουτέστι τὸν τδ κβ´ κ´´ ὄντα τῶν ἐγγὺς ἐλασσόνων ὡς πρὸς τοὺς ἐκκειμένους διὸ καὶ γράφει αὐτὸν προγράφων αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε καὶ εὑρίσκων τὰ παρακείμενα αὐτῷ τῷ ἀπογραφέντι ἐν τῷ σελιδίῳ λεπτὰ πρῶτα ν´ συναπογράφεται παρατιθῶν αὐτοῖς τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον ἀνατείνουσαν σημαῖνον τὸ εἶδος ὅτι πρῶτα λεπτά εὑρίσκει οὖν οὕτως τὸ τῶν τξ μέρος τὸ τδ κβ´ κ´´ ὃ μεριζόμενον παρὰ τὰς τξε ιδ´ μη´´ ἡμέρας καὶ ποιοῦν τὸν ἐκ τοῦ μερισμοῦ ἀριθμὸν πρῶτα λεπτὰ ν´ καὶ τὸν λοιπὸν ἀπογραφόμενος τὸν νε λζ´ μ´´ προτάσσει αὐτοῦ τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά τάσσει δὲ καὶ ἁπλῆν τινα διατείνουσαν γραμμὴν ὡς ἀπὸ τοῦ τξ ἐπὶ τὸν ἑξῆς ἐκτεθειμένον ἐγγὺς
1
5
10
1 εὐδιατύπῳ] ZSPC εὐδιατύπωτ M 4 ἀφαιρεῖ] MZSP ἀφ ι C 5 ἐλάττονα] P comp MZSC 6 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | αφ ] αφ ε M ἀφ ZS ἀφαί P ἄφ C | ἀντὶ] om C | ἄφελε] MZSP ἄφ C 8 ἀπογραφέντι] MZSP ἐγγραφέντι C | λεπτὰ πρῶτα] P λε πρωτα SC λεπτῶν πρωτ MZ | παρατιθῶν] MZS παρατιθεὶς C et ex corr m 2 P 9 ᾱ] Z αο P α´ MS α C | ἔχον] MPC ἔχων ZS 9-10 πρῶτα λεπτά] ZP πρωτ λ´λ´ M πρωτα λε S αα λε C 11 ἡμέρας] comp codd | ἀριθμὸν] P et comp MZ καὶ C et comp S 12 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M πρωτ λεπτ(α) Z πρωτ λ εᾱ S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C | ἀπογραφόμενος] MZSP ἐγγραφόμενος C | νε λζ´] MZSP λζ νζ C 13 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | λ οι] MZSC ex λ fecit λ οι P | προσσημαῖνον] MC et προσ- comp ZS προση- P | τὸ] MZC τὰ S et fecit m 2 P 14 ἀπὸ] MZSP πρὸς C ἐλάττονα] P comp MZSC
1 εὐδιατύπῳ] εὐδιατυπώτω K 6-7 αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ] τὸ ἀφ K 8 παρατιθῶν mdash 10 λεπτά] τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ σημαίνουσαν τὸ εἶδος αὐτῶν ὅτι ᾱ λεπτά εἰσιν K | τὸ (sec)] τὰ K 12 πρῶτα] πρώτων K | τε λ ] λ οι` K | προσσημαῖνον mdash
Fabio Acerbi152
ἐλάττονα τὸν τδ κβ´ κ´´ ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις καὶ ταύτην ἐπιδεικνύουσαν τὴν τάξιν τῆς προόδου τῆς ἐκθέσεως ἧστινος κλωμένης γραμμῆς πρὸς τῷ ἐγγὺς ἐλάσσονι ἡ ἀντανάκλασις ἐπὶ τὸν λοιπὸν γέγραπται φερομένη ὡς εἴρηται διὰ τὸ εὔτακτον τῆς προκοπῆς οὕτως τε ποιήσας ἑξῆς τὸ αφ ποιῶν ὃ προσσημαίνει ὡς εἴρηται τὸ ὅτι δεῖ ἀφελεῖν ὁμοίως ἀπὸ τοῦ λοιποῦ καὶ δὴ τὸν ἐγγὺς πάλιν ἐλάσσονα ὡς πρὸς τὴν ἐν τῷ σελιδίῳ ἔκθεσιν εὑρισκόμενον λαμβάνων ἑξῆς προγράφει αὐτὸν ὄντα νδ μζ´ ιγ´´ ιβ´´´ καὶ εὑρίσκει αὐτοῖς παρακείμενα ἐν τῷ σελιδίῳ πρῶτα λεπτὰ θ´ ἅτινα καὶ αὐτὰ προσαπογράφεται σὺν τῇ παρασημειώσει τῶν πρώτων γράφων τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον τὴν ἀνατείνουσαν καὶ ὡς εἴρηται τὴν γραμμὴν πάλιν διὰ τὴν τάξιν κλωμένην κατὰ δευτέραν κλάσιν προσέλκει γινομένου τοῦ μέρους αὐτῆς τούτου παραλλήλου τῷ ἐξ ἀρχῆς
16 ante κλωμένης add ἐπὶ C 18 τε] MZP om SC | αφ ] M ἀφ ZSC ἀφαί P 19 προσσημαίνει] MS προση- ZC et ex corr P | ὅτι] ZP comp MSC 20 δὴ] MZSC διὰ fecit m 2 P 21 πρὸς] MSP et supra lineam C ex ἀπὸ fecit m 2 Z | ιγ´´] MZSP νγ´´ C 22 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M ᾱᾱ λεπτὰ Z άάα λε S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C 23 προσαπο- γράφεται] απο suprascr in comp M 24 ᾱ] ZP α´ MS α C 25 κλάσιν] MP τάξιν ZSC | τοῦ] ZSPC τούτου M 26 τούτου] τοῦ bis ZSPC sed prius erasit m 2 P τοῦ M
mdash 18 προκοπῆς] om K | τε ποιήσας] ποιήσας καὶ K | αφ ] ἀφ K 19 τὸ] om K 21 προ-γράφει] γράφει K 22 σελιδίῳ] α´ σελιδίῳ K | ἅτινα] ἃ K 23 προσαπογράφεται] ἀπογράφεται K | τῶν πρώτων mdash 26 ἐξ ἀρχῆς] om K
lsquoAllo scopo di raccogliere ciograve che risulta dalla divisione il detto Pappo utilizzando anche in questo caso una certa disposizione ben strutturata determina nel modo seguente il lsaquonumerorsaquo cercato preso nel suo insieme collocando73 in testa il lsaquonumerorsaquo che sta per essere diviso cioegrave i 360 gradi iniziali sottrae loro tra i piugrave prossimi dei lsaquonumerirsaquo minori rispetto a quelli esposti quello che si trova essere minore nella colonna (cioegrave 304 22 20) Questo egrave il motivo per cui lo trascrive scrivendogli davanti lrsquoabbreviazio-ne laquosottrraquo per laquosottrairaquo e trovando che 50 minuti primi sono collocati accanto a quello stesso lsaquonumerorsaquo che egrave stato trascritto nella colonna li trascrive al tempo stesso collocando accanto74 ad essi la lettera A con un lsaquotrattorsaquo75 sopra che significa la specie minuti primi Trova dunque in que-sto modo la parte di 360 che egrave 304 22 20 la quale divisa per 365 giorni 14 48 fa il numero lsaquoche risultarsaquo dalla divisione 50 minuti primi Trascrivendo
73 La descrizione egrave strutturata come una procedura Acerbi 201274 Il purismo del correttore del Par gr 2390 di Clostomalle nel Marc gr 314 e
dellrsquoautore della recensione bizantina impone loro di modificare la terminazione ma forme tematiche e contratte di τιθεῖν sono correnti nel greco tardivo
75 Il testo greco ha solo il participio con γραμμήν sottinteso Per il significato del participio si veda il punto 2
15
20
25
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 153
poi il resto 55 37 40 gli pone altresigrave76 a prefisso laquoReraquo che significa laquorestiraquo e dispone anche una certa linea semplice77 che va da 360 al piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori che egrave esposto di seacuteguito 304 22 20 come nello lsaquoschemarsaquo esposto linea che mostra lrsquoordine del percorso dellrsquoesposizione Questa linea spezzata lagrave dove si trova il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori egrave tracciata inflessa allrsquoindietro lsaquoersaquo punta verso il resto come egrave stato detto in vista di una progressione ordinata E cosigrave facendo prendendo di seacuteguito il laquosottrraquo che significa come egrave stato detto laquoche occorre similmente sottrarre dal re-storaquo e ovviamente prendendo di nuovo il lsaquonumerorsaquo che egrave trovato essere il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori in relazione alla disposizione nella colonna ndash 54 47 13 12 ndash lo scrive di seacuteguito e trova che 9 minuti primi sono posti loro accanto nella colonna trascrive78 anche questi con la segnaletica dei primi scrivendo la lettera A con un lsaquotrattorsaquo sopra e come egrave stato detto prolunga di nuovo la linea spezzata in vista di una buona disposizione tramite una seconda inflessione essendo questa sua parte parallela a quella inizialersquo
La descrizione continua con una serie di laquoe cosigrave viaraquo e non fa ulte-riore riferimento alla tabella
1) La forma verbale ἐξεσμένον Egrave il neutro del participio perfetto medio-passivo di ξέω lett laquopialloraquo laquolevigoraquo Si danno tre possibilitagrave si tratta di un termine canonico per quanto non altrove attestato per designare unrsquoabbreviazione oppure lrsquoautore anonimo improvvisa sul piano metaforico come se unrsquoabbreviazione non fosse altro che la paro-la completa lsquoaccorciata a colpi di piallarsquo in maniera opportuna oppure il testo egrave corrotto e srsquoimpone una correzione ad esempio τὸ ἑξῆς μένον laquociograve che sta di seacuteguitoraquo Questrsquoultima strada mi pare chiusa dal senso delle frase lrsquoabbreviazione non lsquosta di seacuteguitorsquo a niente ma anzi precede la perifrasi τὸ ἑξῆς μένον se impiegata semplicemente per rimandare al segno αφ immediatamente seguente costituirebbe un intollerabile solecismo Se accettiamo la prima di queste letture considerando quin-di lrsquoabbreviazione αφ in posizione predicativa abbiamo a che fare con
76 Rendo in questo modo il τε isolato77 La linea egrave laquosempliceraquo in quanto egrave una retta la precisazione intende evidenziare per
anticipazione il carattere lsquonon semplicersquo che essa assumeragrave alla prima inflessione quando diventeragrave una spezzata linee siffatte erano in effetti concepite dallrsquoanonimo e prima di lui da tutta la tradizione matematica greca come una singola linea spezzata nei punti drsquoinfles-sione I due segmenti paralleli menzionati al termine del passo sono orizzontali
78 Il verbo egrave al medio in variatio rispetto ai due che precedono e che seguono egrave il matematico che lsquosirsquo trascrive le cifre
Fabio Acerbi154
uno hapax semantico nella grecitagrave superstite come egrave facile verificare con una ricerca sul TLG in rete La recensione bizantina risolve il pro-blema sopprimendo semplicemente τὸ ἐξεσμένον
2) La notazione per le specie numeriche Nella terminologia matema-tica greca gli ordini sessagesimali sono εἴδη laquospecieraquo numerici essi corri- spondono agli ordini di grandezza nel nostro sistema decimale e indica-no in analogia con il caso geometrico la lsquoformarsquo che assume un numero quadrato cubo ecc Centinaia e migliaia sono quindi degli εἴδη rispet-tivamente quadrati (100 egrave il quadrato di 10) e cubi (1000 egrave il cubo di 10) sono specie numeriche ma non numeri particolari e drsquoaltronde 300 non egrave un quadrato ma 3 item dellrsquoεἶδος lsquoquadratorsquo 100 3 egrave il numerale di molteplicitagrave della specie quadrata lsquocentinaiarsquo i due 0 che seguono il 3 segnalano esattamente questo fatto che la notazione greca per gli interi non posizionale fa scomparire al livello denotativo Ciograve non vale soltan-to per i numeri interi ma anche per le loro parti i minuti secondi appar-tengono alla specie lsquoquadratorsquo in quanto 13600 egrave il quadrato di 160
La concezione appare interamente dispiegata nellrsquointroduzione degli Arithmetica diofantei79 che si rivela giova farlo rimarcare un te-stimone fondamentale per la ricostruzione della notazione matematica antica Alle specie usate in questrsquoopera vengono assegnati una denomi-nazione ed un segno convenzionale costituito dallrsquoiniziale (di ognuno dei componenti) della denominazione al quadrato o δύναμις il segno ΔΥ al κύβος il segno ΚΥ alla lsquoquarta potenzarsquo o δυναμοδύναμις il segno ΔΥΔ ecc La descrizione di tali segni egrave del tipo καὶ ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον Κ ἐπίσημον ἔχον Υ ΚΥ κύβος laquoe il suo segno egrave un Κ che ha come indice un Υ ΚΥ cuboraquo dove in accordo con quanto abbiamo visto nel punto b supra e pur nel comprensibile imbarazzo del copista della prima parte del Matritensis (o di un suo passato collega) a districarsi in questo formidabile ginepraio notazionale80 le due lettere Κ e Υ ricevono una barra mentre ΚΥ non la richiede a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον il quale ancora una volta esclude automaticamente il segno dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
79 In particolare a DOO I pp 214-62180 Nel Matr 4678 riscontriamo i seguenti fenomeni nelle poche righe a cavallo dei ff
58r-v 1) accento acuto posto su tutti i segni come se fossero abbreviazioni 2) ripetizione sistematica segnodenominazione come in ΚΥ κύβος appena letto dovuta sicuramente allrsquointrusione di glosse interlineari esplicative dei segni ndash e successivo pentimento (δύναμις e κύβος sono in effetti cancellati dalla prima mano il primo con un tratto il secondo con dei punti supra lineam poi il copista si stanca di correggere) 3) nella descrizione del segno per la δυναμοδύναμις menzione di un δέλτα δύο che saragrave molto probabilmente stato ΔΔ subito dopo nella descrizione del κυβόκυβος si legge un incongruo δύο KK
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 155
Diofanto introduce poi dei segni anche per le specie delle parti dellrsquounitagrave (le nostre frazioni) che egli chiama ὁμώνυμα μορία laquoparti omonimeraquo di cui quelle sessagesimali sono casi particolari81 Egli spie-ga appunto che le loro denominazioni sono ottenute da quelle delle specie degli interi per sinonimia passando ad un lsquoordinalersquo82 formato semplicemente aggiungendo il suffisso -στον δυναμοστόν κυβοστόν δυναμοδυναμοστόν ecc (sott μόριον) I loro segni convenzionali sono invece ottenuti da quelli per le specie degli interi aggiungendo una γραμμὴν διαστέλλουσαν τὸ εἶδος laquolinea che distingue la specieraquo83 Una linea sui segni delle specie delle parti egrave richiesta si badi bene per distinguerli dai segni di quelle degli interi come giagrave osservato questi ultimi sono giagrave lsquoagrammaticalirsquo a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον a fortiori lo saranno anche i primi Si tratta della traduzione semio-tica del passaggio dal cardinale allrsquoordinale che a livello grammaticale egrave effettuato con il suffisso -στον Che forma ha questa linea Barra o apice (Egrave cervellotico pensare a forme piugrave complesse) La domanda non ammette una risposta immediata in quanto delle specie diofantee nessuno piugrave si occupa nellrsquoantichitagrave84 Se egrave vero che la prima risposta darebbe origine ad un conflitto tra due convenzioni denotative diffe-renti la barra lsquocitazionalersquo e la barra che distingue la specie lrsquoevidenza grafica del Matritensis lascia lievemente sgomenti (ricordiamoci che giagrave i segni di base sono indebitamente dotati di un accento dal copista) Le poche occorrenze del segno per le specie delle parti85 vedono lrsquoaggiunta di uno slash di sospensione di un doppio apice inverso ndash in tutta evi-
81 Questo fatto era giagrave chiaro nellrsquoantichitagrave Teone in Alm I 10 in iA p 45310-1682 Il parallelo con i cardinali e gli ordinali relativi agli interi egrave reso esplicito da Dio-
fanto ὥσπερ δὲ τῶν ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια παρομοίως καλεῖται τοῖς ἀριθμοῖς τοῦ μὲν τρία τὸ τρίτον τοῦ δὲ τέσσαρα τὸ τέταρτον οὕτως καὶ τῶν νῦν ἐπονομασθέντων ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια κληθήσεται παρομοίως τοῖς ἀριθμοῖς laquocome le parti omonime dei numeri sono chia-mate per assonanza con i numeri di lsquotrersquo lsquolsaquounrsaquo terzorsquo di lsquoquattrorsquo lsquolsaquounrsaquo quartorsquo cosigrave le parti omonime dei numeri appena nominati saranno chiamate per assonanza con i numeriraquo (DOO I p 69-13 si noti lrsquoarticolo lsquocitazionalersquo al singolare in τοῦ τρία e τοῦ τέσσαρα) Il parallelo prosegue anche al livello dei segni che rappresentano queste specie come vedremo tra un attimo
83 Diofanto Arithmetica prefazione in DOO I p 620-21 un passaggio maltrattato in questa edizione occorre espungere il participio ἔχον senza introdurre segni ulteriori oppure eliminare un precedente ἐπί come fa un correttore del Matritensis f 58v
84 Unica parzialissima eccezione lrsquoaccenno di Teone menzionato nella nota 81 supra85 Al f 59r e per di piugrave nel margine per sanare un lungo saut du mecircme au mecircme La
collocazione in margine egrave il motivo per cui troviamo una notazione abbreviata nel resto del trattato il primo copista scioglie tutti i segni prendendoli per abbreviazioni mentre il secondo elimina sistematicamente il tratto aggiuntivo delle specie delle parti dellrsquounitagrave Drsquoaltronde egli scrive ad esempio ΔΥ invece di ΔΥ ed egrave quindi indotto a porre la barra al di sopra della stringa di lettere risultante (passim ma si veda ad esempio il f 72r)
Fabio Acerbi156
denza il compendio per la desinenza -ον accentata il copista interpreta il segno come unrsquoabbreviazione ndash e di una barra a sormontare lo Υ Potremmo forse interpretarlo come il segno di contrazione del grafema -στ- lrsquounico tassello mancante in unrsquoabbreviazione come ad esempio (δυναμοδυναμο)(στ)(ὸν) ma uno scolio di prima mano al f 58v rela-tivo alle specie degli interi inficia questrsquoipotesi esse sono dotate di slash di sospensione accento acuto in un caso del compendio canonico per la terminazione -ον hellip ma tutti gli Υ a esponente sono a loro volta sormontati da una barra
Meno legata al singolo manoscritto ma nondimeno non uniforme si presenta la pratica di notazione dei segni che rappresentano gli enti numerici sessagesimali86 da una parte sta lrsquoevidenza del testo dei Pro-legomena e delle sue tabelle apici ndash drsquoaltronde come abbiamo visto la notazione universalmente impiegata per i numerali ordinali e per le fra-zioni unitarie ndash dallrsquoaltra sta lrsquoevidenza del testo dellrsquoAlmagesto in tutti i manoscritti piugrave antichi e lo stesso si dica del commentario teonino a questrsquoopera o del suo lsquoGrande commentariorsquo alle Tavole facili e dei testi astronomici su papiro barre87 Sembra insomma che la nostra docu-
86 Sia le molteplicitagrave che le specie ahimeacute entrambe rappresentate da lettere dellrsquoalfabeto Come osservato allrsquoinizio della sezione 3 ci sono in effetti due tipi di lettere numerali in gioco se facciamo astrazione da apici o barre lsquo4 minuti secondirsquo si trova scritto δ β la prima lettera numerale denota la molteplicitagrave degli item di una certa specie la se-conda la specie nei Prolegomena entrambe sono accompagnate da un doppio apice il che rende inutile la presenza delle seconde Si noti che la descrizione della tabella non fa parola della notazione da usare per le lettere numerali che denotano la molteplicitagrave barre o apici e quanti apici hellip In questo caso fa interamente fede la tabella cioegrave la pratica grafica condivisa instauratasi non egrave chiaro quando
87 I manoscritti piugrave antichi dellrsquoAlmagesto sono menzionati nella nota 10 supra quelli dei due commentarii teonini sono il Laur Plut 2818 e il celeberrimo Vat gr 190 (sec IX in Euclide Elementi Data Teone lsquoGrande commentariorsquo) per la notazione dei pa-piri astronomici si veda Jones 1999 II passim La notazione non sembra lsquoinquinatarsquo dalla pratica dei copisti bizantini e pare dipendere soltanto dalla data di composizione Tro-viamo ad esempio barre sopra tutti i numerali di molteplicitagrave (interi o sessagesimali) nel frammento di un commentario alle Tavole facili contenente un calcolo relativo al 24 aprile 213 (Par gr 2841 sec XIII ex-XIV in oltre al frammento ai ff 32r l 11-34v l 23 contiene Arato Phaenomena ed Efestione Apotelesmatica edizione in Jones 1990) Nel commentario alle Tavole facili composto ca 610-617 ed attribuito a Stefano di Alessandria la situazione egrave la seguente (Jean Lempire per litteras per lrsquoedizione si veda Lempire 2014 ho controllato il Vat gr 304 ff 135r-171v sec XIV am contiene in aggiunta Teone in Almagestum I-II lsquoPiccolo commentariorsquo alle Tavole facili Diofanto Arithmetica e De polygo-nis numeris varia astronomica tabulae) barre sopra gli interi sporadicamente rimpiazzate da apici apici sopra le parti sessagesimali in numero uguale alla denominazione doppio () apice per le frazioni unitarie Sono impiegate barre sopra gli interi e apici sopra le parti sessagesimali nei manoscritti principali di tutti i trattati di introduzione allrsquoAlmagesto o comunque di argomento logistico redatti in epoca bizantina Giorgio Pachimere (1242-ca 1310) Quadrivium (autografo nel manoscritto Roma Biblioteca Angelica gr 38 [RGK III nr 115] si veda Tannery ndash Steacutephanou 1940 per lrsquoedizione) Teodoro Metochita (1270-
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 157
mentazione si faccia testimone di un cambio notazionale avvenuto nel periodo intercorrente fra Teone (sec IV pm) e la scuola alessandrina di Ammonio e dei suoi allievi (sec VI in) e probabilmente innescato da questrsquoultimo ambiente lrsquoaspetto paradossale egrave che nello stesso codice si rintraccino due notazioni differenti per gli enti numerici sessagesimali e lrsquouna (apici) sia adottata sistematicamente e coerentemente in uno scritto (i Prolegomena) che si presenta esattamente come unrsquointroduzione tecnica alla pratica numerico-algoritmica del trattato (lrsquoAlmagesto) in cui egrave adottata lrsquoaltra (barre che ritroviamo senza eccezioni anche negli scolii)
Torniamo ai Prolegomena la descrizione del segno da porre a fianco di ogni singolo quoziente parziale e denotante la sua specie numerica (minuti primi minuti secondi ecc) solleva tre problemi
Primo problema Ci vuole una barra o un apice su τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquola lettera A [hellip] che significa la specieraquo quando lo scriviamo nella tabella Tutta la nostra discussione precedente fa pro-pendere per lrsquoapice e si ricordi anche la forma verbale ἀνατείνουσαν che suggerisce qualcosa che si lsquoestende verso lrsquoaltorsquo (la mia traduzione egrave volutamente neutra) se fosse apposta una barra la cosa dovrebbe passare
1231332) Compendium astronomicum (copia lsquoautorizzatarsquo coeva nei Vat gr 182 e 181 da parte del copista che integrograve le parti mancanti del Par gr 2389 [ff 207-210 255-270 374-375] Bianconi 2005a pp 425-427 Peacuterez Martiacuten 2008 p 436 e n 177) Teodoro Meliteniota (morto lrsquo831393) Tribiblos astronomica (autografo nel Vat gr 792 si vedano Leurquin 1991 per unrsquoanalisi del manoscritto Leurquin 1990 per lrsquoedizione) una com-pilazione anonima (per cui ho consultato il Par gr 2396 ff 87r-92v limitatamente a questi fogli manu Costantino Trivoli [RGK II nr 318 ma ovviamente questo codice non vi egrave segnalato] terzo quarto del XV secolo il resto del codice annotato da Niceforo Gregora egrave di etagrave planudea e parzialmente [ff 33v-76v] un autografo di Planude stesso contiene Teone in Almagestum I II IV Mondrain 2002 il codice va completato ndash limitatamente a stralci dei libri VIII-X XII-XIII del commentario teonino la cui parte intermedia si egrave persa ndash con 26 carte [ff 123-147] inserite nel Vat gr 1087 anchrsquoesso contenente anno-tazioni di Gregora Rome 1927 per la figura del copista dei ff 77r-86r del Par gr 2396 e dei ff appena nominati del Vat gr 1087 un anonimo collaboratore di Gregora si veda in ultimo Bianconi 2006a pp 147-151) si veda anche il calcolo effettuato da Niceforo Gre-gora (12921295-13581361) dellrsquoeclisse di sole del 16 luglio 1330 (attestata unicamente ai ff 1r-8v della miscellanea astronomica Marc gr 325 databile ca 1324-1329 in parte vergata e ovunque fittamente annotata da Gregora stesso edizione del testo in Mogenet et al 1983 annotazioni di Gregora elencate in Bianconi 2005a p 413) Unrsquoeccezione apparente il lsquoPiccolo commentariorsquo di Teone alle Tavole facili le parti sessagesimali sono segnalate da apici (ad esempio nel Vat gr 175 vergato da Giovanni Catrario e completato nel 1321-1322 sulla figura di Catrario si vedano in ultimo Bianconi 2005b pp 141-156 e 2006b) lrsquoopera egrave antica ma la sua tradizione non rimonta oltre la fine del XIII secolo a parte un frammento nel Leiden BPG 78 ff 156r-161v (minuscola del IX-X secolo) e in effetti in questo manoscritto tutti i numerali di molteplicitagrave sono sormontati da barre Unrsquoeccezione effettiva egrave il De hypotesibus planetarum nel Vat gr 1594 barre sugli interi e apici sulle parti sessagesimali
Fabio Acerbi158
sotto silenzio e la presenza dellrsquoapice la rende inutile88 Si tratta della stessa convenzione diofantea e coincide ancora con la notazione per i numerali ordinali e per le frazioni unitarie che egrave corrente nei mano- scritti matematici greci per questo motivo non percheacute la descrizione sia particolarmente perspicua nessuno dei copisti della recensione an-tica ha incertezze apici Ma questi apici si rintracciano soltanto sulle indicazioni di specie non contemplate dalla descrizione che sono ante-poste ai resti parziali a fianco dei quozienti parziali i segni di specie sono invece trasformati in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordi-nali corrispondenti del tipo πρωτ tavv 5 e 7b-8 Il recensore bizantino taglia invece la testa al toro elimina dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali elimina la seconda menzione della laquolet-tera Araquo contestualmente allrsquoazzeramento dellrsquoespediente della linea a zig-zag (si veda il punto seguente) modifica la descrizione che contiene la prima menzione in quella dellrsquoapice associato direttamente ai nume-rali di molteplicitagrave riciclando addirittura lrsquoalpha per adibirlo a desi-gnare un numero cardinale (come sorprendersi) τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ laquoponendo al di sopra di essi [scil dei 50 minuti primi] 1 solo lsaquoaccentorsaquo acutoraquo La scelta del recensore egrave assennata che rechi una barra o un apice in una tabella un alpha denota un numero non un numero drsquoordine
Secondo problema da tenere ben distinto dal precedente Cosa ci vuole sul segno α per la lettera alpha menzionata nella frase τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquolettera A [hellip] che significa la specieraquo89 Unrsquooc-chiata allrsquoapparato critico rivela una bella incertezza nei manoscritti Z scrive sempre ᾱ e in un caso lo fa anche P MS optano sempre per α´ C per α P scrive nellrsquoaltro caso αο Per quanto solo la barra sia congrua con il senso della frase in quanto la lettera alpha egrave qui menzionata (si tratta di un oggetto che compare nella tabella) e non cambia niente se essa egrave accompagnata dal suo nome di genere στοιχεῖον ad un livello grafico lrsquoincertezza fra il segno ᾱ che denota laquola lettera αraquo e il segno α´ (o lrsquoabbreviazione αο) per una forma di πρῶτος egrave per piugrave versi giustificata
88 Detto in altri termini la barra egrave uno strumento grafico non matematico e quindi la sua presenza non va segnalata mentre un apice lo egrave e la sua presenza lo deve
89 Notare che in questa frase il primo α non vuole la barra (egrave menzionato allrsquointerno di una frase che impiega convenzioni moderne) il secondo sigrave (idem ma con convenzioni antiche) ndash e nella traduzione la scelta di denotarlo con A (senza virgolette) e non con lsquoArsquo (con virgolette) egrave del tutto arbitraria ndash si noti inoltre che le necessarie precisazioni laquosenzacon virgoletteraquo mostrano che le lingue moderne palesano difficoltagrave analoghe a quelle del greco antico per quanto riguarda i livelli denotativi in ambito metadiscorsivo per non usare le due parentetiche avrei dovuto scrivere rispettivamente lsquoArsquo e lsquolsquoArsquorsquo (doppie virgolette semplici)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 159
ᾱ coincide con il numerale 1 α egrave la prima lettera dellrsquoalfabeto ed inoltre α´ egrave esattamente quello che va scritto nella tabella Potremmo dirci che il sostantivo στοιχεῖον chiude la questione la sua presenza congiunta ad un ipotetico α´ renderebbe la descrizione ridondante o inappropriata90 Ma a parte il fatto che α egrave proprio τὸ πρῶτον στοιχεῖον il segno α´ cat-tura in fondo il cuore della descrizione di uno στοιχεῖον ἔχον lsaquoγραμμὴνrsaquo ἀνατείνουσαν
Terzo problema Lrsquoautore dei Prolegomena che si arresta allrsquoesem-pio dei minuti primi non dice quanti apici occorre mettere sulle lettere numerali che identificano gli ordini superiori al primo se uno soltanto come nel caso diofanteo e delle frazioni unitarie o in numero uguale alla loro denominazione (cioegrave pari al numero denotato dal numerale stesso su cui vanno posti) come effettivamente avviene nei mano-scritti dei Prolegomena La tabella egrave quindi sottodeterminata dalla sua descrizione anzi in un certo senso prende il sopravvento su di essa la pratica di marcare i numerali di molteplicitagrave con gli apici che compe-tono allrsquoordine cui appartengono viene trasferita ai segni per gli ordini stessi per supplire ad una descrizione carente di questi ultimi E la tabella egrave sottodeterminata dalla descrizione in quanto egrave la descrizione di una tabella reale ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις laquocome nello lsaquoschemarsaquo espostoraquo leggiamo a un certo punto del testo
3) La linea a zig-zag Non possiamo che applaudire a questo geniale espediente grafico lo troviamo messo in opera solo nel Marc gr 313 Per quanto lrsquoautore non faccia parola di ciograve nel corso della sua descrizione la linea spezzata egrave intesa dover lsquosaltarersquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue Il copista del codice marciano effettua correttamente due salti nella prima delle sue tabelle (tav 4) ma inserisce un lsquodentersquo in piugrave in quella che considera corretta (tav 5) La linea a zig-zag egrave incompatibile con la presenza di linee di giustificazione nella tabella che in effetti mancano nel Marc gr 313 ciograve induce gli errori di allineamento dei primi 5 quozienti parziali di cui egrave vittima il copista Probabilmente per questo motivo in nessuno degli apografi del Vat gr 1594 la linea a zig-zag figura nella tabella inquadrata come si conviene da una (doppia) cornice esterna e le cui colonne sono appunto separate da linee verticali (tav 7b Vat gr 184 f 17v e tav 8 Par gr 2390 f 9v cui egrave sostanzialmente identica la tabella del Marc gr 314 che si trova
90 Trascuro lrsquoabbreviazione αο = πρῶτος percheacute la desinenza non egrave quella richiesta neacute nella frase (egrave richiesto πρῶτον) neacute nella tabella (πρῶτα)
Fabio Acerbi160
al f 248r ndash ma la mancanza di linee orizzontali causa un gigantesco pa-sticcio nel codice vaticano) Alla recensione bizantina che dipende per il suo testo di base dal Vat gr 1594 e quindi non trova la linea a zig-zag nella tabella non resta che sopprimere la sua descrizione ndash ma proprio per questo motivo e finalmente diventa possibile tracciare un apparato completo di linee di giustificazione (tav 9 Laur Plut 89 sup 48 f 14v) Dato che la descrizione di Teone di questo procedimento di divi-sione non fa cenno allrsquoesistenza della linea a zig-zag viene da chiedersi se essa non costituisca un espediente escogitato dallrsquoautore dei Prolegomena per vivacizzare la procedura originale di Pappo
4) Discrepanze tra descrizione e tabella Il gioco delle minime va-rianti mostra che la divisione era stata eseguita (e trasmessa) corret-tamente tutti i valori numerici sono esatti La tabella nel Marc gr 313 presenta perograve alcune discrepanze con la propria descrizione Essa omette (ma non nella versione lsquoscorrettarsquo lrsquoomissione non si riscontra neanche nel Par gr 2390) il segno per laquorestoraquo di fronte ai resti par-ziali ma aggiunge lrsquoindicazione della loro specie Essa trasforma invece come abbiamo visto le indicazioni di specie che seguono i quozienti parziali in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordinali corri-spondenti La descrizione prevede di chiudere la tabella con il risultato καὶ συνάγων ἅπαντα τὰ ἐκ τῶν μερισθέντων μερῶν λεπτὰ σημειοῦται ὑπὸ πάντας οὕτως γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoe raccogliendo tutti i minuti che provengono dalle parti divise lsaquoPapporsaquo nota sotto tutto cosigrave Ris 0 59 8 17 13 12 31raquo ma sotto la tabella tutta la tradizione ci consegna qualcosa di piugrave articolato ὁ ζητούμενος καθ᾽ ὃν μερίζεται ὁ τξε ιδ´ μη´´ π(αρὰ) τὸν τξ γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoil lsaquonumerorsaquo cercato secondo cui 365 14 48 egrave diviso per 360 risulta 0 59 8 17 13 12 31raquo frase che del resto contiene due errori lrsquoinversione del dividendo e del divisore e la confusione tra segno convenzionale (iuxta descrizione) e abbreviazione (come nella frase) nel caso di γι Oltre ad eliminare la linea a zig-zag91 la recensione bizantina sopprime dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali e modifica come abbiamo visto al punto 2 le loro descrizioni in quelle di apici associati diretta-mente ai numerali di molteplicitagrave
91 Le due righe che nella recensione di base contengono solo i resti parziali minori di 160 del divisore ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue sono in parte completate con lrsquoindicazione abbreviata ἀνάλ(υσις) laquoanalisiraquo il termine greco per questa procedura di riduzione In un sussulto di ipercorrettismo matematico tali resti parziali ridotti non sono preceduti dal segno per laquorestoraquo come nel Par gr 2390 ma da quello per laquorisultatoraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 161
Gli esempi che abbiamo discusso mostrano come i problemi di notazione pesino e non poco sullrsquoespressione discorsiva di un algorit-mo matematico lrsquoente di riferimento per lsquoformularersquo il procedimento di divisione fu considerata la tabella cioegrave un oggetto la cui costitu-zione egrave legata piugrave ad una pratica grafica che a considerazioni logico- algoritmiche non la sua descrizione che in effetti finisce per determi-nare la tabella in maniera non univoca Di questa sottodeterminazione si fa testimone la traiettoria che abbiamo cercato di seguire nelle mani di copisti e revisori il procedimento di divisione si modifica a volte in aspetti secondari a volte in punti piugrave sostanziali ndash fino a rendere neces-saria una radicale revisione della sua descrizione per renderla conforme alla tabella ndash in ogni caso mai per ragioni squisitamente matematiche92
Abstract
The article presents and discusses in detail two passages from the anonymous Prolegomena to the Almagest a VIth century primer to the elementary procedures of calculation needed in Ptolemyrsquos Almagest In the two passages we may follow the complex interplay between mathematical notation the auctor who employed and described it the tachygrapher who transcribed it in vivo copyists who reproduced it correctors who modified it Along this path misgivings and errors arise in the transmission of abbreviations and paratextual units such as diagrams tables operational schemes
Fabio AcerbiCNRS UMR8560 Centre Alexandre Koyreacute
fabacerbigmailcom
92 Sono grato a Daniele Bianconi Lucio del Corso Jean Lempire per alcune preziose indicazioni
AOO = Archimedis opera omnia cum commentariis Eutocii ed J L Heiberg I-III Lipsiae 1910-1915
DOO = Diophanti Alexandrini opera omnia cum Graecis commentariis ed P Tannery I-II Lipsiae 1893-1895
GC = Le laquoGrand Commentaireraquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Mogenet ndash A Tihon I-III Cittagrave del Vaticano 1985-1999
iA = Commentaires de Pappus et de Theacuteon drsquoAlexandrie sur lrsquoAlmageste ed A Rome I-III con paginazione continua Cittagrave del Vaticano 1931-1943
HOO = Heronis Alexandrini opera quae supersunt omnia ed G Schmidt ndash L Nix ndash W Schmidt ndash H Schoene ndash J L Heiberg I-V Lipsiae 1899-1914
PC = Le ldquoPetit Commentairerdquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed A Tihon Cittagrave del Vaticano 1978
POO = Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia ed J L Heiberg I-II in 3 parti Lipsiae 1898-1907
RGK = Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600 I Handschriften aus Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln II Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs und Nachtraumlge zu den Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln III Handschriften aus Bibliotheken Roms mit dem Vatikan A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg unter Mitarbeit von D Harlfinger und P Eleuteri B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln Wien 1981-1997 (Oumlsterreichische Akademie der Wissenschaften Veroumlffentlichungen der Kommission fuumlr Byzantinistik III1-3 A-C)
Sigla
Acerbi 2010 = F Acerbi Il silenzio delle sirene La matematica greca antica Roma 2010
Acerbi 2012 = F Acerbi I codici stilistici della matematica greca dimostrazioni procedure algoritmi laquoQUCCraquo 1012 (2012) pp 167-214
Acerbi et al 2010 = F Acerbi ndash N Vinel ndash B Vitrac Les Proleacutegomegravenes agrave lrsquoAlmageste Une eacutedition agrave partir des manuscrits les plus anciens Introduction geacuteneacuterale ndash Parties I-III laquoSCIAMVSraquo 11 (2010) pp 53-210
Agati 1992 = M L Agati La minuscola laquoBouleteacuteeraquo Cittagrave del Vaticano 1992
Belger 1881 = C Belger Ein neues Fragmentum mathematicum Bobiense laquoHermesraquo 16 (1881) pp 261-284
Bianconi 2005a = D Bianconi La biblioteca di Cora tra Massimo Planude e Niceforo Gregora Una questione di mani laquoSampTraquo 3 (2005) pp 391-438
Bianconi 2005b = D Bianconi Tessalonica nellrsquoetagrave dei Paleologi Le pratiche intellettuali nel riflesso della cultura scritta Paris 2005
Bianconi 2006a = D Bianconi Le pietre e il ponte ovvero identificazioni di mani e storia della cultura laquoBizantinisticaraquo 8 (2006) pp 135-181
Bianconi 2006b = D Bianconi Qualcosa di nuovo su Giovanni Catrario laquoMEGraquo 6 (2006) pp 69-91
Cavallo 1977 = G Cavallo Funzione e strutture della maiuscola greca tra i secoli VIII-XI in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Colloque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 95-137
Cereteli 1904 = G F Cereteli De compendiis scripturae codicum Graecorum praecipue Petropolitanorum et Mosquensium anni nota instructorum Sankt-Petersburg 1904
De Gregorio 2000 = G De Gregorio Materiali vecchi e nuovi per uno studio della minu-scola greca fra VII e IX secolo in G Prato (a cura di) I manoscritti greci tra riflessione e dibattito Atti del V Colloquio Internazionale di Paleografia Greca Cremona 4-10 ottobre 1998 Firenze 2000 pp 83-151
Follieri 1977 = E Follieri La minuscola libraria dei secoli IX e X in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Col-loque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 139-165
Fonkič 2005 = B Fonkič Venecianskaia rukopisrsquo laquoAlrsquomagestaraquo Ptolemeja (Marc gr 313690) o datirovke i proischoždenii kodeksa laquoVDIraquo s III 254 (2005) pp 162-167
Fowler 1999 = D H Fowler The Mathematics of Platorsquos Academy A New Reconstruction Second Edition Oxford 1999
Bibliografia
Fabio Acerbi164
Gerstinger ndash Vogel 1932 = H Gerstinger ndash K Vogel Eine stereometrische Aufgaben-sammlung im Papyrus Graecus [sic] Vindobonensis 19996 laquoMitteilungen aus der Papy-russammlung der Nationalbibliothek in Wienraquo Neue Serie Folge 1 Griechische literarische Papyri 1 Wien 1932 pp 11-76
Heiberg 1927 = Mathematici Graeci Minores ed J L Heiberg Kjoslashbenhavn 1927
Hultsch 1876-1878 = Pappi Alexandrini Collectionis quae supersunt ed F Hultsch I-III Berlin 1876-1878
Janz 2003 = T Janz The Scribes and the Date of the Vat gr 1291 in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae X Cittagrave del Vaticano 2003 pp 159-180
Jones 1990 = Ptolemyrsquos First Commentator ed A Jones Philadelphia 1990
Jones 1999 = Astronomical Papyri from Oxyrhynchus ed A Jones I-II Philadelphia 1999
Jones 2005 = A Jones Ptolemyrsquos Canobic Inscription and Heliodorusrsquo Observation Reports laquoSCIAMVSraquo 6 (2005) pp 53-97
Lempire 2014 = Steacutephanos drsquoAlexandrie Le commentaire aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Lempire Louvain 2014
Leurquin 1990 = Theacuteodore Meacuteliteacuteniote Tribiblos astronomique Livre I ed R Leurquin Amsterdam 1990
Leurquin 1991 = R Leurquin Un manuscrit autographe de la Tribiblos Astronomique de Theacuteodore Meacuteliteacuteniote le Vaticanus graecus 792 laquoScriptoriumraquo 45 (1991) pp 145-162
Maas 1927 = P Maas Griechische Palaeographie in A Gercke ndash E Norden (hrsg von) Einleitung in die Altertumswissenschaft I9 Leipzig 1927 pp 69-80
Martinelli Tempesta 2010 = S Martinelli Tempesta Il codice Milano Biblioteca Am-brosiana B 75 sup (gr 104) e lrsquoevoluzione della scrittura di Giovanni Scutariota in A B Garciacutea ndash I Peacuterez Martiacuten (ed by) The Legacy of Bernard de Montfaucon Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting Proceedings of the Seventh Inter-national Colloquium of Greek Palaeography Madrid-Salamanca 15-20 September 2008 Turnhout 2010 pp 171-186
Mazzucchi 1994 = C M Mazzucchi Leggere i classici durante la catastrofe (Costantino-poli maggio-agosto 1203) le note marginali al Diodoro Siculo Vaticano gr 130 Parte prima stratigrafia laquoAevumraquo 68 (1994) pp 164-218
Mioni 1976 = E Mioni Bessarione scriba e alcuni suoi collaboratori in Miscellanea marcia-na di studi bessarionei Padova 1976 pp 263-323
Mioni 1985 = Codices graeci manuscripti Bibliothecae Divi Marci Venetiarum II Thesaurus Antiquus Codices 300-625 recensuit E Mioni Roma 1985
Mogenet 1962 = J Mogenet Une scholie ineacutedite du Vat gr 1594 sur les rapports entre lrsquoastronomie arabe et Byzance laquoOsirisraquo 14 (1962) pp 198-221
Mogenet et al 1983 = Niceacutephore Greacutegoras Calcul de lrsquoeacuteclipse de soleil du 16 juillet 1330 ed J Mogenet ndash A Tihon ndash R Royez ndash A Berg Amsterdam 1983
Mondrain 2002 = B Mondrain Maxime Planude Niceacutephore Greacutegoras et Ptoleacutemeacutee laquoPa-laeoslavicaraquo 10 (2002) pp 312-322
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 165
Mondrain 2004 = B Mondrain Lrsquoancien empereur Jean VI Cantacuzegravene et ses copistes in A Rigo (a cura di) Gregorio Palamas e oltre Studi e documenti sulle controversie teologiche del XIV secolo bizantino Firenze 2004 pp 249-296
Mondrain 2007 = B Mondrain Les eacutecritures dans les manuscrits byzantins du XIV e siegravecle Quelques probleacutematiques laquoRSBNraquo n s 44 (2007) pp 157-196
Peacuterez Martiacuten 2006 = I Peacuterez Martiacuten Maxime Planude et le Diophantus Matritensis (Madrid Biblioteca Nacional ms 4678) un paradigme de la reacutecupeacuteration des textes anciens dans la ldquorenaissance paleacuteologuerdquo laquoByzantionraquo 76 (2006) pp 433-462
Peacuterez Martiacuten 2008 = I Peacuterez Martiacuten El lsquoestilo Hodegosrsquo y su proyeccioacuten en las escrituras constantinopolitanas laquoSampTraquo 6 (2008) pp 389-458
Perria 1991 = L Perria Scrittura e ornamentazione nei codici della laquocollezione filosoficaraquo laquoRSBNraquo n s 28 (1991) pp 45-111
Rollo 2012 = A Rollo LrsquoArchimede di Giorgio Valla in V Fera ndash D Gionta ndash A Rollo (a cura di) Archimede e le sue fortune Atti del Convegno di Siracusa-Messina 24-26 giugno 2008 Messina 2012 pp 99-147
Rome 1927 = A Rome Membra disjecta laquoRBenraquo 39 (1927) pp 187-188
Rome 1938 = A Rome Un manuscrit de la bibliothegraveque de Boniface VIII agrave la Meacutediceacuteenne de Florence laquoACraquo 7 (1938) pp 261-268
Ronconi 2013 = F Ronconi La collection philosophique un fantocircme historique laquoScripto-riumraquo 67 (2013) pp 119-140
Tannery ndash Steacutephanou 1940 = Quadrivium de Georges Pachymegravere ed P Tannery ndash E Steacutephanou Cittagrave del Vaticano 1940
Tihon 2011 = Πτολεμαίου Πρόχειροι Κανόνες Les Tables faciles de Ptoleacutemeacutee vol Ia Tables A1-A2 ed A Tihon Leuven 2011
Traube 1907 = L Traube Nomina Sacra Versuch einer Geschichte der christlichen Kuumlrzung Muumlnchen 1907
Vogel 1936 = K Vogel Beitraumlge zur griechischen Logistik laquoSBAWraquo Mathematisch-natur-wissenschaftliche Abteilung Jahrgang 1936 pp 357-472
Wouters 1979 = A Wouters The Grammatical Papyri from Graeco-Roman Egypt Contri-butions to the Study of the lsquoArs Grammaticarsquo in Antiquity Brussel 1979
F ACERBI Tav 1
b Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 65r
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 284 f 160r
F ACERBITav 2
b Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 13r
a Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 19v
F ACERBI Tav 3
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 136v
F ACERBITav 4
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17r
F ACERBI Tav 5
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17v
F ACERBITav 6
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 7v
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 151
d) Errori di copia La tabella riprodotta nella tav 2b ha una forma simmetrica ma si tratta di una forzatura il grande rettangolo in basso a destra drsquoaltronde assente nella descrizione contiene uno scolio che fa notare come lrsquoultimo resto parziale ŏ ŏ ŏ ŏ ŏ ͵γτνζ´´´´´ κζ´´´´´´ cioegrave 0 0 0 0 0 3357 27 siano ἔγγιστα λ´λ´ δ´δ´ ξ laquocon ottima approssimazione 60 minuti quartiraquo dove si notino gli apici semplici per indicare il pas-saggio allrsquoordinale e il raddoppiamento del sistema segno + apice per significare il plurale Lo scolio debitamente accompagnato dal segno di rimando in forma di simbolo solare egrave stato probabilmente incluso nella tabella proprio allo scopo di renderla simmetrica A sua volta un errore precedente spiega lo spazio eccessivo accordato al rettangolo contenente lo scolio il secondo massimo multiplo ŏ λβ´ ξδ´´ ριβ´´´ σιϛ´´´´ egrave trascritto anche al di sotto del risultato
Passiamo ora alla descrizione del metodo di divisione attribuito a Pappo
ἵνα οὖν ταῦτα συναχθῇ τὰ ἐκ τοῦ μερισμοῦ ὁ εἰρημένος Πάππος εὐδιατύπῳ τινὶ καὶ πρὸς τοῦτο τάξει χρησάμενος ποιεῖται τὴν τῆς συλλήψεως τοῦ ζητουμένου ἀνεύρεσιν οὕτως ἐκθέμενος γὰρ τὸν μέλλοντα μερίζεσθαι τουτέστι τὰς τξ μοίρας ἐν ἀρχῇ ἀφαιρεῖ ἀπ᾽ αὐτῶν τὸν ἐν τῇ σελίδι τυγχάνοντα ἐλάττονα τουτέστι τὸν τδ κβ´ κ´´ ὄντα τῶν ἐγγὺς ἐλασσόνων ὡς πρὸς τοὺς ἐκκειμένους διὸ καὶ γράφει αὐτὸν προγράφων αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ἀντὶ τοῦ ἄφελε καὶ εὑρίσκων τὰ παρακείμενα αὐτῷ τῷ ἀπογραφέντι ἐν τῷ σελιδίῳ λεπτὰ πρῶτα ν´ συναπογράφεται παρατιθῶν αὐτοῖς τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον ἀνατείνουσαν σημαῖνον τὸ εἶδος ὅτι πρῶτα λεπτά εὑρίσκει οὖν οὕτως τὸ τῶν τξ μέρος τὸ τδ κβ´ κ´´ ὃ μεριζόμενον παρὰ τὰς τξε ιδ´ μη´´ ἡμέρας καὶ ποιοῦν τὸν ἐκ τοῦ μερισμοῦ ἀριθμὸν πρῶτα λεπτὰ ν´ καὶ τὸν λοιπὸν ἀπογραφόμενος τὸν νε λζ´ μ´´ προτάσσει αὐτοῦ τό τε λ οι προσσημαῖνον τὸ λοιπά τάσσει δὲ καὶ ἁπλῆν τινα διατείνουσαν γραμμὴν ὡς ἀπὸ τοῦ τξ ἐπὶ τὸν ἑξῆς ἐκτεθειμένον ἐγγὺς
1
5
10
1 εὐδιατύπῳ] ZSPC εὐδιατύπωτ M 4 ἀφαιρεῖ] MZSP ἀφ ι C 5 ἐλάττονα] P comp MZSC 6 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | αφ ] αφ ε M ἀφ ZS ἀφαί P ἄφ C | ἀντὶ] om C | ἄφελε] MZSP ἄφ C 8 ἀπογραφέντι] MZSP ἐγγραφέντι C | λεπτὰ πρῶτα] P λε πρωτα SC λεπτῶν πρωτ MZ | παρατιθῶν] MZS παρατιθεὶς C et ex corr m 2 P 9 ᾱ] Z αο P α´ MS α C | ἔχον] MPC ἔχων ZS 9-10 πρῶτα λεπτά] ZP πρωτ λ´λ´ M πρωτα λε S αα λε C 11 ἡμέρας] comp codd | ἀριθμὸν] P et comp MZ καὶ C et comp S 12 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M πρωτ λεπτ(α) Z πρωτ λ εᾱ S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C | ἀπογραφόμενος] MZSP ἐγγραφόμενος C | νε λζ´] MZSP λζ νζ C 13 αὐτοῦ] MZPC αὐτῷ S | λ οι] MZSC ex λ fecit λ οι P | προσσημαῖνον] MC et προσ- comp ZS προση- P | τὸ] MZC τὰ S et fecit m 2 P 14 ἀπὸ] MZSP πρὸς C ἐλάττονα] P comp MZSC
1 εὐδιατύπῳ] εὐδιατυπώτω K 6-7 αὐτοῦ τὸ ἐξεσμένον αφ ] τὸ ἀφ K 8 παρατιθῶν mdash 10 λεπτά] τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ σημαίνουσαν τὸ εἶδος αὐτῶν ὅτι ᾱ λεπτά εἰσιν K | τὸ (sec)] τὰ K 12 πρῶτα] πρώτων K | τε λ ] λ οι` K | προσσημαῖνον mdash
Fabio Acerbi152
ἐλάττονα τὸν τδ κβ´ κ´´ ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις καὶ ταύτην ἐπιδεικνύουσαν τὴν τάξιν τῆς προόδου τῆς ἐκθέσεως ἧστινος κλωμένης γραμμῆς πρὸς τῷ ἐγγὺς ἐλάσσονι ἡ ἀντανάκλασις ἐπὶ τὸν λοιπὸν γέγραπται φερομένη ὡς εἴρηται διὰ τὸ εὔτακτον τῆς προκοπῆς οὕτως τε ποιήσας ἑξῆς τὸ αφ ποιῶν ὃ προσσημαίνει ὡς εἴρηται τὸ ὅτι δεῖ ἀφελεῖν ὁμοίως ἀπὸ τοῦ λοιποῦ καὶ δὴ τὸν ἐγγὺς πάλιν ἐλάσσονα ὡς πρὸς τὴν ἐν τῷ σελιδίῳ ἔκθεσιν εὑρισκόμενον λαμβάνων ἑξῆς προγράφει αὐτὸν ὄντα νδ μζ´ ιγ´´ ιβ´´´ καὶ εὑρίσκει αὐτοῖς παρακείμενα ἐν τῷ σελιδίῳ πρῶτα λεπτὰ θ´ ἅτινα καὶ αὐτὰ προσαπογράφεται σὺν τῇ παρασημειώσει τῶν πρώτων γράφων τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον τὴν ἀνατείνουσαν καὶ ὡς εἴρηται τὴν γραμμὴν πάλιν διὰ τὴν τάξιν κλωμένην κατὰ δευτέραν κλάσιν προσέλκει γινομένου τοῦ μέρους αὐτῆς τούτου παραλλήλου τῷ ἐξ ἀρχῆς
16 ante κλωμένης add ἐπὶ C 18 τε] MZP om SC | αφ ] M ἀφ ZSC ἀφαί P 19 προσσημαίνει] MS προση- ZC et ex corr P | ὅτι] ZP comp MSC 20 δὴ] MZSC διὰ fecit m 2 P 21 πρὸς] MSP et supra lineam C ex ἀπὸ fecit m 2 Z | ιγ´´] MZSP νγ´´ C 22 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M ᾱᾱ λεπτὰ Z άάα λε S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C 23 προσαπο- γράφεται] απο suprascr in comp M 24 ᾱ] ZP α´ MS α C 25 κλάσιν] MP τάξιν ZSC | τοῦ] ZSPC τούτου M 26 τούτου] τοῦ bis ZSPC sed prius erasit m 2 P τοῦ M
mdash 18 προκοπῆς] om K | τε ποιήσας] ποιήσας καὶ K | αφ ] ἀφ K 19 τὸ] om K 21 προ-γράφει] γράφει K 22 σελιδίῳ] α´ σελιδίῳ K | ἅτινα] ἃ K 23 προσαπογράφεται] ἀπογράφεται K | τῶν πρώτων mdash 26 ἐξ ἀρχῆς] om K
lsquoAllo scopo di raccogliere ciograve che risulta dalla divisione il detto Pappo utilizzando anche in questo caso una certa disposizione ben strutturata determina nel modo seguente il lsaquonumerorsaquo cercato preso nel suo insieme collocando73 in testa il lsaquonumerorsaquo che sta per essere diviso cioegrave i 360 gradi iniziali sottrae loro tra i piugrave prossimi dei lsaquonumerirsaquo minori rispetto a quelli esposti quello che si trova essere minore nella colonna (cioegrave 304 22 20) Questo egrave il motivo per cui lo trascrive scrivendogli davanti lrsquoabbreviazio-ne laquosottrraquo per laquosottrairaquo e trovando che 50 minuti primi sono collocati accanto a quello stesso lsaquonumerorsaquo che egrave stato trascritto nella colonna li trascrive al tempo stesso collocando accanto74 ad essi la lettera A con un lsaquotrattorsaquo75 sopra che significa la specie minuti primi Trova dunque in que-sto modo la parte di 360 che egrave 304 22 20 la quale divisa per 365 giorni 14 48 fa il numero lsaquoche risultarsaquo dalla divisione 50 minuti primi Trascrivendo
73 La descrizione egrave strutturata come una procedura Acerbi 201274 Il purismo del correttore del Par gr 2390 di Clostomalle nel Marc gr 314 e
dellrsquoautore della recensione bizantina impone loro di modificare la terminazione ma forme tematiche e contratte di τιθεῖν sono correnti nel greco tardivo
75 Il testo greco ha solo il participio con γραμμήν sottinteso Per il significato del participio si veda il punto 2
15
20
25
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 153
poi il resto 55 37 40 gli pone altresigrave76 a prefisso laquoReraquo che significa laquorestiraquo e dispone anche una certa linea semplice77 che va da 360 al piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori che egrave esposto di seacuteguito 304 22 20 come nello lsaquoschemarsaquo esposto linea che mostra lrsquoordine del percorso dellrsquoesposizione Questa linea spezzata lagrave dove si trova il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori egrave tracciata inflessa allrsquoindietro lsaquoersaquo punta verso il resto come egrave stato detto in vista di una progressione ordinata E cosigrave facendo prendendo di seacuteguito il laquosottrraquo che significa come egrave stato detto laquoche occorre similmente sottrarre dal re-storaquo e ovviamente prendendo di nuovo il lsaquonumerorsaquo che egrave trovato essere il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori in relazione alla disposizione nella colonna ndash 54 47 13 12 ndash lo scrive di seacuteguito e trova che 9 minuti primi sono posti loro accanto nella colonna trascrive78 anche questi con la segnaletica dei primi scrivendo la lettera A con un lsaquotrattorsaquo sopra e come egrave stato detto prolunga di nuovo la linea spezzata in vista di una buona disposizione tramite una seconda inflessione essendo questa sua parte parallela a quella inizialersquo
La descrizione continua con una serie di laquoe cosigrave viaraquo e non fa ulte-riore riferimento alla tabella
1) La forma verbale ἐξεσμένον Egrave il neutro del participio perfetto medio-passivo di ξέω lett laquopialloraquo laquolevigoraquo Si danno tre possibilitagrave si tratta di un termine canonico per quanto non altrove attestato per designare unrsquoabbreviazione oppure lrsquoautore anonimo improvvisa sul piano metaforico come se unrsquoabbreviazione non fosse altro che la paro-la completa lsquoaccorciata a colpi di piallarsquo in maniera opportuna oppure il testo egrave corrotto e srsquoimpone una correzione ad esempio τὸ ἑξῆς μένον laquociograve che sta di seacuteguitoraquo Questrsquoultima strada mi pare chiusa dal senso delle frase lrsquoabbreviazione non lsquosta di seacuteguitorsquo a niente ma anzi precede la perifrasi τὸ ἑξῆς μένον se impiegata semplicemente per rimandare al segno αφ immediatamente seguente costituirebbe un intollerabile solecismo Se accettiamo la prima di queste letture considerando quin-di lrsquoabbreviazione αφ in posizione predicativa abbiamo a che fare con
76 Rendo in questo modo il τε isolato77 La linea egrave laquosempliceraquo in quanto egrave una retta la precisazione intende evidenziare per
anticipazione il carattere lsquonon semplicersquo che essa assumeragrave alla prima inflessione quando diventeragrave una spezzata linee siffatte erano in effetti concepite dallrsquoanonimo e prima di lui da tutta la tradizione matematica greca come una singola linea spezzata nei punti drsquoinfles-sione I due segmenti paralleli menzionati al termine del passo sono orizzontali
78 Il verbo egrave al medio in variatio rispetto ai due che precedono e che seguono egrave il matematico che lsquosirsquo trascrive le cifre
Fabio Acerbi154
uno hapax semantico nella grecitagrave superstite come egrave facile verificare con una ricerca sul TLG in rete La recensione bizantina risolve il pro-blema sopprimendo semplicemente τὸ ἐξεσμένον
2) La notazione per le specie numeriche Nella terminologia matema-tica greca gli ordini sessagesimali sono εἴδη laquospecieraquo numerici essi corri- spondono agli ordini di grandezza nel nostro sistema decimale e indica-no in analogia con il caso geometrico la lsquoformarsquo che assume un numero quadrato cubo ecc Centinaia e migliaia sono quindi degli εἴδη rispet-tivamente quadrati (100 egrave il quadrato di 10) e cubi (1000 egrave il cubo di 10) sono specie numeriche ma non numeri particolari e drsquoaltronde 300 non egrave un quadrato ma 3 item dellrsquoεἶδος lsquoquadratorsquo 100 3 egrave il numerale di molteplicitagrave della specie quadrata lsquocentinaiarsquo i due 0 che seguono il 3 segnalano esattamente questo fatto che la notazione greca per gli interi non posizionale fa scomparire al livello denotativo Ciograve non vale soltan-to per i numeri interi ma anche per le loro parti i minuti secondi appar-tengono alla specie lsquoquadratorsquo in quanto 13600 egrave il quadrato di 160
La concezione appare interamente dispiegata nellrsquointroduzione degli Arithmetica diofantei79 che si rivela giova farlo rimarcare un te-stimone fondamentale per la ricostruzione della notazione matematica antica Alle specie usate in questrsquoopera vengono assegnati una denomi-nazione ed un segno convenzionale costituito dallrsquoiniziale (di ognuno dei componenti) della denominazione al quadrato o δύναμις il segno ΔΥ al κύβος il segno ΚΥ alla lsquoquarta potenzarsquo o δυναμοδύναμις il segno ΔΥΔ ecc La descrizione di tali segni egrave del tipo καὶ ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον Κ ἐπίσημον ἔχον Υ ΚΥ κύβος laquoe il suo segno egrave un Κ che ha come indice un Υ ΚΥ cuboraquo dove in accordo con quanto abbiamo visto nel punto b supra e pur nel comprensibile imbarazzo del copista della prima parte del Matritensis (o di un suo passato collega) a districarsi in questo formidabile ginepraio notazionale80 le due lettere Κ e Υ ricevono una barra mentre ΚΥ non la richiede a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον il quale ancora una volta esclude automaticamente il segno dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
79 In particolare a DOO I pp 214-62180 Nel Matr 4678 riscontriamo i seguenti fenomeni nelle poche righe a cavallo dei ff
58r-v 1) accento acuto posto su tutti i segni come se fossero abbreviazioni 2) ripetizione sistematica segnodenominazione come in ΚΥ κύβος appena letto dovuta sicuramente allrsquointrusione di glosse interlineari esplicative dei segni ndash e successivo pentimento (δύναμις e κύβος sono in effetti cancellati dalla prima mano il primo con un tratto il secondo con dei punti supra lineam poi il copista si stanca di correggere) 3) nella descrizione del segno per la δυναμοδύναμις menzione di un δέλτα δύο che saragrave molto probabilmente stato ΔΔ subito dopo nella descrizione del κυβόκυβος si legge un incongruo δύο KK
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 155
Diofanto introduce poi dei segni anche per le specie delle parti dellrsquounitagrave (le nostre frazioni) che egli chiama ὁμώνυμα μορία laquoparti omonimeraquo di cui quelle sessagesimali sono casi particolari81 Egli spie-ga appunto che le loro denominazioni sono ottenute da quelle delle specie degli interi per sinonimia passando ad un lsquoordinalersquo82 formato semplicemente aggiungendo il suffisso -στον δυναμοστόν κυβοστόν δυναμοδυναμοστόν ecc (sott μόριον) I loro segni convenzionali sono invece ottenuti da quelli per le specie degli interi aggiungendo una γραμμὴν διαστέλλουσαν τὸ εἶδος laquolinea che distingue la specieraquo83 Una linea sui segni delle specie delle parti egrave richiesta si badi bene per distinguerli dai segni di quelle degli interi come giagrave osservato questi ultimi sono giagrave lsquoagrammaticalirsquo a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον a fortiori lo saranno anche i primi Si tratta della traduzione semio-tica del passaggio dal cardinale allrsquoordinale che a livello grammaticale egrave effettuato con il suffisso -στον Che forma ha questa linea Barra o apice (Egrave cervellotico pensare a forme piugrave complesse) La domanda non ammette una risposta immediata in quanto delle specie diofantee nessuno piugrave si occupa nellrsquoantichitagrave84 Se egrave vero che la prima risposta darebbe origine ad un conflitto tra due convenzioni denotative diffe-renti la barra lsquocitazionalersquo e la barra che distingue la specie lrsquoevidenza grafica del Matritensis lascia lievemente sgomenti (ricordiamoci che giagrave i segni di base sono indebitamente dotati di un accento dal copista) Le poche occorrenze del segno per le specie delle parti85 vedono lrsquoaggiunta di uno slash di sospensione di un doppio apice inverso ndash in tutta evi-
81 Questo fatto era giagrave chiaro nellrsquoantichitagrave Teone in Alm I 10 in iA p 45310-1682 Il parallelo con i cardinali e gli ordinali relativi agli interi egrave reso esplicito da Dio-
fanto ὥσπερ δὲ τῶν ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια παρομοίως καλεῖται τοῖς ἀριθμοῖς τοῦ μὲν τρία τὸ τρίτον τοῦ δὲ τέσσαρα τὸ τέταρτον οὕτως καὶ τῶν νῦν ἐπονομασθέντων ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια κληθήσεται παρομοίως τοῖς ἀριθμοῖς laquocome le parti omonime dei numeri sono chia-mate per assonanza con i numeri di lsquotrersquo lsquolsaquounrsaquo terzorsquo di lsquoquattrorsquo lsquolsaquounrsaquo quartorsquo cosigrave le parti omonime dei numeri appena nominati saranno chiamate per assonanza con i numeriraquo (DOO I p 69-13 si noti lrsquoarticolo lsquocitazionalersquo al singolare in τοῦ τρία e τοῦ τέσσαρα) Il parallelo prosegue anche al livello dei segni che rappresentano queste specie come vedremo tra un attimo
83 Diofanto Arithmetica prefazione in DOO I p 620-21 un passaggio maltrattato in questa edizione occorre espungere il participio ἔχον senza introdurre segni ulteriori oppure eliminare un precedente ἐπί come fa un correttore del Matritensis f 58v
84 Unica parzialissima eccezione lrsquoaccenno di Teone menzionato nella nota 81 supra85 Al f 59r e per di piugrave nel margine per sanare un lungo saut du mecircme au mecircme La
collocazione in margine egrave il motivo per cui troviamo una notazione abbreviata nel resto del trattato il primo copista scioglie tutti i segni prendendoli per abbreviazioni mentre il secondo elimina sistematicamente il tratto aggiuntivo delle specie delle parti dellrsquounitagrave Drsquoaltronde egli scrive ad esempio ΔΥ invece di ΔΥ ed egrave quindi indotto a porre la barra al di sopra della stringa di lettere risultante (passim ma si veda ad esempio il f 72r)
Fabio Acerbi156
denza il compendio per la desinenza -ον accentata il copista interpreta il segno come unrsquoabbreviazione ndash e di una barra a sormontare lo Υ Potremmo forse interpretarlo come il segno di contrazione del grafema -στ- lrsquounico tassello mancante in unrsquoabbreviazione come ad esempio (δυναμοδυναμο)(στ)(ὸν) ma uno scolio di prima mano al f 58v rela-tivo alle specie degli interi inficia questrsquoipotesi esse sono dotate di slash di sospensione accento acuto in un caso del compendio canonico per la terminazione -ον hellip ma tutti gli Υ a esponente sono a loro volta sormontati da una barra
Meno legata al singolo manoscritto ma nondimeno non uniforme si presenta la pratica di notazione dei segni che rappresentano gli enti numerici sessagesimali86 da una parte sta lrsquoevidenza del testo dei Pro-legomena e delle sue tabelle apici ndash drsquoaltronde come abbiamo visto la notazione universalmente impiegata per i numerali ordinali e per le fra-zioni unitarie ndash dallrsquoaltra sta lrsquoevidenza del testo dellrsquoAlmagesto in tutti i manoscritti piugrave antichi e lo stesso si dica del commentario teonino a questrsquoopera o del suo lsquoGrande commentariorsquo alle Tavole facili e dei testi astronomici su papiro barre87 Sembra insomma che la nostra docu-
86 Sia le molteplicitagrave che le specie ahimeacute entrambe rappresentate da lettere dellrsquoalfabeto Come osservato allrsquoinizio della sezione 3 ci sono in effetti due tipi di lettere numerali in gioco se facciamo astrazione da apici o barre lsquo4 minuti secondirsquo si trova scritto δ β la prima lettera numerale denota la molteplicitagrave degli item di una certa specie la se-conda la specie nei Prolegomena entrambe sono accompagnate da un doppio apice il che rende inutile la presenza delle seconde Si noti che la descrizione della tabella non fa parola della notazione da usare per le lettere numerali che denotano la molteplicitagrave barre o apici e quanti apici hellip In questo caso fa interamente fede la tabella cioegrave la pratica grafica condivisa instauratasi non egrave chiaro quando
87 I manoscritti piugrave antichi dellrsquoAlmagesto sono menzionati nella nota 10 supra quelli dei due commentarii teonini sono il Laur Plut 2818 e il celeberrimo Vat gr 190 (sec IX in Euclide Elementi Data Teone lsquoGrande commentariorsquo) per la notazione dei pa-piri astronomici si veda Jones 1999 II passim La notazione non sembra lsquoinquinatarsquo dalla pratica dei copisti bizantini e pare dipendere soltanto dalla data di composizione Tro-viamo ad esempio barre sopra tutti i numerali di molteplicitagrave (interi o sessagesimali) nel frammento di un commentario alle Tavole facili contenente un calcolo relativo al 24 aprile 213 (Par gr 2841 sec XIII ex-XIV in oltre al frammento ai ff 32r l 11-34v l 23 contiene Arato Phaenomena ed Efestione Apotelesmatica edizione in Jones 1990) Nel commentario alle Tavole facili composto ca 610-617 ed attribuito a Stefano di Alessandria la situazione egrave la seguente (Jean Lempire per litteras per lrsquoedizione si veda Lempire 2014 ho controllato il Vat gr 304 ff 135r-171v sec XIV am contiene in aggiunta Teone in Almagestum I-II lsquoPiccolo commentariorsquo alle Tavole facili Diofanto Arithmetica e De polygo-nis numeris varia astronomica tabulae) barre sopra gli interi sporadicamente rimpiazzate da apici apici sopra le parti sessagesimali in numero uguale alla denominazione doppio () apice per le frazioni unitarie Sono impiegate barre sopra gli interi e apici sopra le parti sessagesimali nei manoscritti principali di tutti i trattati di introduzione allrsquoAlmagesto o comunque di argomento logistico redatti in epoca bizantina Giorgio Pachimere (1242-ca 1310) Quadrivium (autografo nel manoscritto Roma Biblioteca Angelica gr 38 [RGK III nr 115] si veda Tannery ndash Steacutephanou 1940 per lrsquoedizione) Teodoro Metochita (1270-
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 157
mentazione si faccia testimone di un cambio notazionale avvenuto nel periodo intercorrente fra Teone (sec IV pm) e la scuola alessandrina di Ammonio e dei suoi allievi (sec VI in) e probabilmente innescato da questrsquoultimo ambiente lrsquoaspetto paradossale egrave che nello stesso codice si rintraccino due notazioni differenti per gli enti numerici sessagesimali e lrsquouna (apici) sia adottata sistematicamente e coerentemente in uno scritto (i Prolegomena) che si presenta esattamente come unrsquointroduzione tecnica alla pratica numerico-algoritmica del trattato (lrsquoAlmagesto) in cui egrave adottata lrsquoaltra (barre che ritroviamo senza eccezioni anche negli scolii)
Torniamo ai Prolegomena la descrizione del segno da porre a fianco di ogni singolo quoziente parziale e denotante la sua specie numerica (minuti primi minuti secondi ecc) solleva tre problemi
Primo problema Ci vuole una barra o un apice su τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquola lettera A [hellip] che significa la specieraquo quando lo scriviamo nella tabella Tutta la nostra discussione precedente fa pro-pendere per lrsquoapice e si ricordi anche la forma verbale ἀνατείνουσαν che suggerisce qualcosa che si lsquoestende verso lrsquoaltorsquo (la mia traduzione egrave volutamente neutra) se fosse apposta una barra la cosa dovrebbe passare
1231332) Compendium astronomicum (copia lsquoautorizzatarsquo coeva nei Vat gr 182 e 181 da parte del copista che integrograve le parti mancanti del Par gr 2389 [ff 207-210 255-270 374-375] Bianconi 2005a pp 425-427 Peacuterez Martiacuten 2008 p 436 e n 177) Teodoro Meliteniota (morto lrsquo831393) Tribiblos astronomica (autografo nel Vat gr 792 si vedano Leurquin 1991 per unrsquoanalisi del manoscritto Leurquin 1990 per lrsquoedizione) una com-pilazione anonima (per cui ho consultato il Par gr 2396 ff 87r-92v limitatamente a questi fogli manu Costantino Trivoli [RGK II nr 318 ma ovviamente questo codice non vi egrave segnalato] terzo quarto del XV secolo il resto del codice annotato da Niceforo Gregora egrave di etagrave planudea e parzialmente [ff 33v-76v] un autografo di Planude stesso contiene Teone in Almagestum I II IV Mondrain 2002 il codice va completato ndash limitatamente a stralci dei libri VIII-X XII-XIII del commentario teonino la cui parte intermedia si egrave persa ndash con 26 carte [ff 123-147] inserite nel Vat gr 1087 anchrsquoesso contenente anno-tazioni di Gregora Rome 1927 per la figura del copista dei ff 77r-86r del Par gr 2396 e dei ff appena nominati del Vat gr 1087 un anonimo collaboratore di Gregora si veda in ultimo Bianconi 2006a pp 147-151) si veda anche il calcolo effettuato da Niceforo Gre-gora (12921295-13581361) dellrsquoeclisse di sole del 16 luglio 1330 (attestata unicamente ai ff 1r-8v della miscellanea astronomica Marc gr 325 databile ca 1324-1329 in parte vergata e ovunque fittamente annotata da Gregora stesso edizione del testo in Mogenet et al 1983 annotazioni di Gregora elencate in Bianconi 2005a p 413) Unrsquoeccezione apparente il lsquoPiccolo commentariorsquo di Teone alle Tavole facili le parti sessagesimali sono segnalate da apici (ad esempio nel Vat gr 175 vergato da Giovanni Catrario e completato nel 1321-1322 sulla figura di Catrario si vedano in ultimo Bianconi 2005b pp 141-156 e 2006b) lrsquoopera egrave antica ma la sua tradizione non rimonta oltre la fine del XIII secolo a parte un frammento nel Leiden BPG 78 ff 156r-161v (minuscola del IX-X secolo) e in effetti in questo manoscritto tutti i numerali di molteplicitagrave sono sormontati da barre Unrsquoeccezione effettiva egrave il De hypotesibus planetarum nel Vat gr 1594 barre sugli interi e apici sulle parti sessagesimali
Fabio Acerbi158
sotto silenzio e la presenza dellrsquoapice la rende inutile88 Si tratta della stessa convenzione diofantea e coincide ancora con la notazione per i numerali ordinali e per le frazioni unitarie che egrave corrente nei mano- scritti matematici greci per questo motivo non percheacute la descrizione sia particolarmente perspicua nessuno dei copisti della recensione an-tica ha incertezze apici Ma questi apici si rintracciano soltanto sulle indicazioni di specie non contemplate dalla descrizione che sono ante-poste ai resti parziali a fianco dei quozienti parziali i segni di specie sono invece trasformati in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordi-nali corrispondenti del tipo πρωτ tavv 5 e 7b-8 Il recensore bizantino taglia invece la testa al toro elimina dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali elimina la seconda menzione della laquolet-tera Araquo contestualmente allrsquoazzeramento dellrsquoespediente della linea a zig-zag (si veda il punto seguente) modifica la descrizione che contiene la prima menzione in quella dellrsquoapice associato direttamente ai nume-rali di molteplicitagrave riciclando addirittura lrsquoalpha per adibirlo a desi-gnare un numero cardinale (come sorprendersi) τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ laquoponendo al di sopra di essi [scil dei 50 minuti primi] 1 solo lsaquoaccentorsaquo acutoraquo La scelta del recensore egrave assennata che rechi una barra o un apice in una tabella un alpha denota un numero non un numero drsquoordine
Secondo problema da tenere ben distinto dal precedente Cosa ci vuole sul segno α per la lettera alpha menzionata nella frase τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquolettera A [hellip] che significa la specieraquo89 Unrsquooc-chiata allrsquoapparato critico rivela una bella incertezza nei manoscritti Z scrive sempre ᾱ e in un caso lo fa anche P MS optano sempre per α´ C per α P scrive nellrsquoaltro caso αο Per quanto solo la barra sia congrua con il senso della frase in quanto la lettera alpha egrave qui menzionata (si tratta di un oggetto che compare nella tabella) e non cambia niente se essa egrave accompagnata dal suo nome di genere στοιχεῖον ad un livello grafico lrsquoincertezza fra il segno ᾱ che denota laquola lettera αraquo e il segno α´ (o lrsquoabbreviazione αο) per una forma di πρῶτος egrave per piugrave versi giustificata
88 Detto in altri termini la barra egrave uno strumento grafico non matematico e quindi la sua presenza non va segnalata mentre un apice lo egrave e la sua presenza lo deve
89 Notare che in questa frase il primo α non vuole la barra (egrave menzionato allrsquointerno di una frase che impiega convenzioni moderne) il secondo sigrave (idem ma con convenzioni antiche) ndash e nella traduzione la scelta di denotarlo con A (senza virgolette) e non con lsquoArsquo (con virgolette) egrave del tutto arbitraria ndash si noti inoltre che le necessarie precisazioni laquosenzacon virgoletteraquo mostrano che le lingue moderne palesano difficoltagrave analoghe a quelle del greco antico per quanto riguarda i livelli denotativi in ambito metadiscorsivo per non usare le due parentetiche avrei dovuto scrivere rispettivamente lsquoArsquo e lsquolsquoArsquorsquo (doppie virgolette semplici)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 159
ᾱ coincide con il numerale 1 α egrave la prima lettera dellrsquoalfabeto ed inoltre α´ egrave esattamente quello che va scritto nella tabella Potremmo dirci che il sostantivo στοιχεῖον chiude la questione la sua presenza congiunta ad un ipotetico α´ renderebbe la descrizione ridondante o inappropriata90 Ma a parte il fatto che α egrave proprio τὸ πρῶτον στοιχεῖον il segno α´ cat-tura in fondo il cuore della descrizione di uno στοιχεῖον ἔχον lsaquoγραμμὴνrsaquo ἀνατείνουσαν
Terzo problema Lrsquoautore dei Prolegomena che si arresta allrsquoesem-pio dei minuti primi non dice quanti apici occorre mettere sulle lettere numerali che identificano gli ordini superiori al primo se uno soltanto come nel caso diofanteo e delle frazioni unitarie o in numero uguale alla loro denominazione (cioegrave pari al numero denotato dal numerale stesso su cui vanno posti) come effettivamente avviene nei mano-scritti dei Prolegomena La tabella egrave quindi sottodeterminata dalla sua descrizione anzi in un certo senso prende il sopravvento su di essa la pratica di marcare i numerali di molteplicitagrave con gli apici che compe-tono allrsquoordine cui appartengono viene trasferita ai segni per gli ordini stessi per supplire ad una descrizione carente di questi ultimi E la tabella egrave sottodeterminata dalla descrizione in quanto egrave la descrizione di una tabella reale ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις laquocome nello lsaquoschemarsaquo espostoraquo leggiamo a un certo punto del testo
3) La linea a zig-zag Non possiamo che applaudire a questo geniale espediente grafico lo troviamo messo in opera solo nel Marc gr 313 Per quanto lrsquoautore non faccia parola di ciograve nel corso della sua descrizione la linea spezzata egrave intesa dover lsquosaltarersquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue Il copista del codice marciano effettua correttamente due salti nella prima delle sue tabelle (tav 4) ma inserisce un lsquodentersquo in piugrave in quella che considera corretta (tav 5) La linea a zig-zag egrave incompatibile con la presenza di linee di giustificazione nella tabella che in effetti mancano nel Marc gr 313 ciograve induce gli errori di allineamento dei primi 5 quozienti parziali di cui egrave vittima il copista Probabilmente per questo motivo in nessuno degli apografi del Vat gr 1594 la linea a zig-zag figura nella tabella inquadrata come si conviene da una (doppia) cornice esterna e le cui colonne sono appunto separate da linee verticali (tav 7b Vat gr 184 f 17v e tav 8 Par gr 2390 f 9v cui egrave sostanzialmente identica la tabella del Marc gr 314 che si trova
90 Trascuro lrsquoabbreviazione αο = πρῶτος percheacute la desinenza non egrave quella richiesta neacute nella frase (egrave richiesto πρῶτον) neacute nella tabella (πρῶτα)
Fabio Acerbi160
al f 248r ndash ma la mancanza di linee orizzontali causa un gigantesco pa-sticcio nel codice vaticano) Alla recensione bizantina che dipende per il suo testo di base dal Vat gr 1594 e quindi non trova la linea a zig-zag nella tabella non resta che sopprimere la sua descrizione ndash ma proprio per questo motivo e finalmente diventa possibile tracciare un apparato completo di linee di giustificazione (tav 9 Laur Plut 89 sup 48 f 14v) Dato che la descrizione di Teone di questo procedimento di divi-sione non fa cenno allrsquoesistenza della linea a zig-zag viene da chiedersi se essa non costituisca un espediente escogitato dallrsquoautore dei Prolegomena per vivacizzare la procedura originale di Pappo
4) Discrepanze tra descrizione e tabella Il gioco delle minime va-rianti mostra che la divisione era stata eseguita (e trasmessa) corret-tamente tutti i valori numerici sono esatti La tabella nel Marc gr 313 presenta perograve alcune discrepanze con la propria descrizione Essa omette (ma non nella versione lsquoscorrettarsquo lrsquoomissione non si riscontra neanche nel Par gr 2390) il segno per laquorestoraquo di fronte ai resti par-ziali ma aggiunge lrsquoindicazione della loro specie Essa trasforma invece come abbiamo visto le indicazioni di specie che seguono i quozienti parziali in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordinali corri-spondenti La descrizione prevede di chiudere la tabella con il risultato καὶ συνάγων ἅπαντα τὰ ἐκ τῶν μερισθέντων μερῶν λεπτὰ σημειοῦται ὑπὸ πάντας οὕτως γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoe raccogliendo tutti i minuti che provengono dalle parti divise lsaquoPapporsaquo nota sotto tutto cosigrave Ris 0 59 8 17 13 12 31raquo ma sotto la tabella tutta la tradizione ci consegna qualcosa di piugrave articolato ὁ ζητούμενος καθ᾽ ὃν μερίζεται ὁ τξε ιδ´ μη´´ π(αρὰ) τὸν τξ γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoil lsaquonumerorsaquo cercato secondo cui 365 14 48 egrave diviso per 360 risulta 0 59 8 17 13 12 31raquo frase che del resto contiene due errori lrsquoinversione del dividendo e del divisore e la confusione tra segno convenzionale (iuxta descrizione) e abbreviazione (come nella frase) nel caso di γι Oltre ad eliminare la linea a zig-zag91 la recensione bizantina sopprime dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali e modifica come abbiamo visto al punto 2 le loro descrizioni in quelle di apici associati diretta-mente ai numerali di molteplicitagrave
91 Le due righe che nella recensione di base contengono solo i resti parziali minori di 160 del divisore ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue sono in parte completate con lrsquoindicazione abbreviata ἀνάλ(υσις) laquoanalisiraquo il termine greco per questa procedura di riduzione In un sussulto di ipercorrettismo matematico tali resti parziali ridotti non sono preceduti dal segno per laquorestoraquo come nel Par gr 2390 ma da quello per laquorisultatoraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 161
Gli esempi che abbiamo discusso mostrano come i problemi di notazione pesino e non poco sullrsquoespressione discorsiva di un algorit-mo matematico lrsquoente di riferimento per lsquoformularersquo il procedimento di divisione fu considerata la tabella cioegrave un oggetto la cui costitu-zione egrave legata piugrave ad una pratica grafica che a considerazioni logico- algoritmiche non la sua descrizione che in effetti finisce per determi-nare la tabella in maniera non univoca Di questa sottodeterminazione si fa testimone la traiettoria che abbiamo cercato di seguire nelle mani di copisti e revisori il procedimento di divisione si modifica a volte in aspetti secondari a volte in punti piugrave sostanziali ndash fino a rendere neces-saria una radicale revisione della sua descrizione per renderla conforme alla tabella ndash in ogni caso mai per ragioni squisitamente matematiche92
Abstract
The article presents and discusses in detail two passages from the anonymous Prolegomena to the Almagest a VIth century primer to the elementary procedures of calculation needed in Ptolemyrsquos Almagest In the two passages we may follow the complex interplay between mathematical notation the auctor who employed and described it the tachygrapher who transcribed it in vivo copyists who reproduced it correctors who modified it Along this path misgivings and errors arise in the transmission of abbreviations and paratextual units such as diagrams tables operational schemes
Fabio AcerbiCNRS UMR8560 Centre Alexandre Koyreacute
fabacerbigmailcom
92 Sono grato a Daniele Bianconi Lucio del Corso Jean Lempire per alcune preziose indicazioni
AOO = Archimedis opera omnia cum commentariis Eutocii ed J L Heiberg I-III Lipsiae 1910-1915
DOO = Diophanti Alexandrini opera omnia cum Graecis commentariis ed P Tannery I-II Lipsiae 1893-1895
GC = Le laquoGrand Commentaireraquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Mogenet ndash A Tihon I-III Cittagrave del Vaticano 1985-1999
iA = Commentaires de Pappus et de Theacuteon drsquoAlexandrie sur lrsquoAlmageste ed A Rome I-III con paginazione continua Cittagrave del Vaticano 1931-1943
HOO = Heronis Alexandrini opera quae supersunt omnia ed G Schmidt ndash L Nix ndash W Schmidt ndash H Schoene ndash J L Heiberg I-V Lipsiae 1899-1914
PC = Le ldquoPetit Commentairerdquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed A Tihon Cittagrave del Vaticano 1978
POO = Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia ed J L Heiberg I-II in 3 parti Lipsiae 1898-1907
RGK = Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600 I Handschriften aus Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln II Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs und Nachtraumlge zu den Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln III Handschriften aus Bibliotheken Roms mit dem Vatikan A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg unter Mitarbeit von D Harlfinger und P Eleuteri B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln Wien 1981-1997 (Oumlsterreichische Akademie der Wissenschaften Veroumlffentlichungen der Kommission fuumlr Byzantinistik III1-3 A-C)
Sigla
Acerbi 2010 = F Acerbi Il silenzio delle sirene La matematica greca antica Roma 2010
Acerbi 2012 = F Acerbi I codici stilistici della matematica greca dimostrazioni procedure algoritmi laquoQUCCraquo 1012 (2012) pp 167-214
Acerbi et al 2010 = F Acerbi ndash N Vinel ndash B Vitrac Les Proleacutegomegravenes agrave lrsquoAlmageste Une eacutedition agrave partir des manuscrits les plus anciens Introduction geacuteneacuterale ndash Parties I-III laquoSCIAMVSraquo 11 (2010) pp 53-210
Agati 1992 = M L Agati La minuscola laquoBouleteacuteeraquo Cittagrave del Vaticano 1992
Belger 1881 = C Belger Ein neues Fragmentum mathematicum Bobiense laquoHermesraquo 16 (1881) pp 261-284
Bianconi 2005a = D Bianconi La biblioteca di Cora tra Massimo Planude e Niceforo Gregora Una questione di mani laquoSampTraquo 3 (2005) pp 391-438
Bianconi 2005b = D Bianconi Tessalonica nellrsquoetagrave dei Paleologi Le pratiche intellettuali nel riflesso della cultura scritta Paris 2005
Bianconi 2006a = D Bianconi Le pietre e il ponte ovvero identificazioni di mani e storia della cultura laquoBizantinisticaraquo 8 (2006) pp 135-181
Bianconi 2006b = D Bianconi Qualcosa di nuovo su Giovanni Catrario laquoMEGraquo 6 (2006) pp 69-91
Cavallo 1977 = G Cavallo Funzione e strutture della maiuscola greca tra i secoli VIII-XI in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Colloque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 95-137
Cereteli 1904 = G F Cereteli De compendiis scripturae codicum Graecorum praecipue Petropolitanorum et Mosquensium anni nota instructorum Sankt-Petersburg 1904
De Gregorio 2000 = G De Gregorio Materiali vecchi e nuovi per uno studio della minu-scola greca fra VII e IX secolo in G Prato (a cura di) I manoscritti greci tra riflessione e dibattito Atti del V Colloquio Internazionale di Paleografia Greca Cremona 4-10 ottobre 1998 Firenze 2000 pp 83-151
Follieri 1977 = E Follieri La minuscola libraria dei secoli IX e X in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Col-loque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 139-165
Fonkič 2005 = B Fonkič Venecianskaia rukopisrsquo laquoAlrsquomagestaraquo Ptolemeja (Marc gr 313690) o datirovke i proischoždenii kodeksa laquoVDIraquo s III 254 (2005) pp 162-167
Fowler 1999 = D H Fowler The Mathematics of Platorsquos Academy A New Reconstruction Second Edition Oxford 1999
Bibliografia
Fabio Acerbi164
Gerstinger ndash Vogel 1932 = H Gerstinger ndash K Vogel Eine stereometrische Aufgaben-sammlung im Papyrus Graecus [sic] Vindobonensis 19996 laquoMitteilungen aus der Papy-russammlung der Nationalbibliothek in Wienraquo Neue Serie Folge 1 Griechische literarische Papyri 1 Wien 1932 pp 11-76
Heiberg 1927 = Mathematici Graeci Minores ed J L Heiberg Kjoslashbenhavn 1927
Hultsch 1876-1878 = Pappi Alexandrini Collectionis quae supersunt ed F Hultsch I-III Berlin 1876-1878
Janz 2003 = T Janz The Scribes and the Date of the Vat gr 1291 in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae X Cittagrave del Vaticano 2003 pp 159-180
Jones 1990 = Ptolemyrsquos First Commentator ed A Jones Philadelphia 1990
Jones 1999 = Astronomical Papyri from Oxyrhynchus ed A Jones I-II Philadelphia 1999
Jones 2005 = A Jones Ptolemyrsquos Canobic Inscription and Heliodorusrsquo Observation Reports laquoSCIAMVSraquo 6 (2005) pp 53-97
Lempire 2014 = Steacutephanos drsquoAlexandrie Le commentaire aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Lempire Louvain 2014
Leurquin 1990 = Theacuteodore Meacuteliteacuteniote Tribiblos astronomique Livre I ed R Leurquin Amsterdam 1990
Leurquin 1991 = R Leurquin Un manuscrit autographe de la Tribiblos Astronomique de Theacuteodore Meacuteliteacuteniote le Vaticanus graecus 792 laquoScriptoriumraquo 45 (1991) pp 145-162
Maas 1927 = P Maas Griechische Palaeographie in A Gercke ndash E Norden (hrsg von) Einleitung in die Altertumswissenschaft I9 Leipzig 1927 pp 69-80
Martinelli Tempesta 2010 = S Martinelli Tempesta Il codice Milano Biblioteca Am-brosiana B 75 sup (gr 104) e lrsquoevoluzione della scrittura di Giovanni Scutariota in A B Garciacutea ndash I Peacuterez Martiacuten (ed by) The Legacy of Bernard de Montfaucon Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting Proceedings of the Seventh Inter-national Colloquium of Greek Palaeography Madrid-Salamanca 15-20 September 2008 Turnhout 2010 pp 171-186
Mazzucchi 1994 = C M Mazzucchi Leggere i classici durante la catastrofe (Costantino-poli maggio-agosto 1203) le note marginali al Diodoro Siculo Vaticano gr 130 Parte prima stratigrafia laquoAevumraquo 68 (1994) pp 164-218
Mioni 1976 = E Mioni Bessarione scriba e alcuni suoi collaboratori in Miscellanea marcia-na di studi bessarionei Padova 1976 pp 263-323
Mioni 1985 = Codices graeci manuscripti Bibliothecae Divi Marci Venetiarum II Thesaurus Antiquus Codices 300-625 recensuit E Mioni Roma 1985
Mogenet 1962 = J Mogenet Une scholie ineacutedite du Vat gr 1594 sur les rapports entre lrsquoastronomie arabe et Byzance laquoOsirisraquo 14 (1962) pp 198-221
Mogenet et al 1983 = Niceacutephore Greacutegoras Calcul de lrsquoeacuteclipse de soleil du 16 juillet 1330 ed J Mogenet ndash A Tihon ndash R Royez ndash A Berg Amsterdam 1983
Mondrain 2002 = B Mondrain Maxime Planude Niceacutephore Greacutegoras et Ptoleacutemeacutee laquoPa-laeoslavicaraquo 10 (2002) pp 312-322
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 165
Mondrain 2004 = B Mondrain Lrsquoancien empereur Jean VI Cantacuzegravene et ses copistes in A Rigo (a cura di) Gregorio Palamas e oltre Studi e documenti sulle controversie teologiche del XIV secolo bizantino Firenze 2004 pp 249-296
Mondrain 2007 = B Mondrain Les eacutecritures dans les manuscrits byzantins du XIV e siegravecle Quelques probleacutematiques laquoRSBNraquo n s 44 (2007) pp 157-196
Peacuterez Martiacuten 2006 = I Peacuterez Martiacuten Maxime Planude et le Diophantus Matritensis (Madrid Biblioteca Nacional ms 4678) un paradigme de la reacutecupeacuteration des textes anciens dans la ldquorenaissance paleacuteologuerdquo laquoByzantionraquo 76 (2006) pp 433-462
Peacuterez Martiacuten 2008 = I Peacuterez Martiacuten El lsquoestilo Hodegosrsquo y su proyeccioacuten en las escrituras constantinopolitanas laquoSampTraquo 6 (2008) pp 389-458
Perria 1991 = L Perria Scrittura e ornamentazione nei codici della laquocollezione filosoficaraquo laquoRSBNraquo n s 28 (1991) pp 45-111
Rollo 2012 = A Rollo LrsquoArchimede di Giorgio Valla in V Fera ndash D Gionta ndash A Rollo (a cura di) Archimede e le sue fortune Atti del Convegno di Siracusa-Messina 24-26 giugno 2008 Messina 2012 pp 99-147
Rome 1927 = A Rome Membra disjecta laquoRBenraquo 39 (1927) pp 187-188
Rome 1938 = A Rome Un manuscrit de la bibliothegraveque de Boniface VIII agrave la Meacutediceacuteenne de Florence laquoACraquo 7 (1938) pp 261-268
Ronconi 2013 = F Ronconi La collection philosophique un fantocircme historique laquoScripto-riumraquo 67 (2013) pp 119-140
Tannery ndash Steacutephanou 1940 = Quadrivium de Georges Pachymegravere ed P Tannery ndash E Steacutephanou Cittagrave del Vaticano 1940
Tihon 2011 = Πτολεμαίου Πρόχειροι Κανόνες Les Tables faciles de Ptoleacutemeacutee vol Ia Tables A1-A2 ed A Tihon Leuven 2011
Traube 1907 = L Traube Nomina Sacra Versuch einer Geschichte der christlichen Kuumlrzung Muumlnchen 1907
Vogel 1936 = K Vogel Beitraumlge zur griechischen Logistik laquoSBAWraquo Mathematisch-natur-wissenschaftliche Abteilung Jahrgang 1936 pp 357-472
Wouters 1979 = A Wouters The Grammatical Papyri from Graeco-Roman Egypt Contri-butions to the Study of the lsquoArs Grammaticarsquo in Antiquity Brussel 1979
F ACERBI Tav 1
b Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 65r
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 284 f 160r
F ACERBITav 2
b Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 13r
a Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 19v
F ACERBI Tav 3
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 136v
F ACERBITav 4
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17r
F ACERBI Tav 5
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17v
F ACERBITav 6
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 7v
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
Fabio Acerbi152
ἐλάττονα τὸν τδ κβ´ κ´´ ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις καὶ ταύτην ἐπιδεικνύουσαν τὴν τάξιν τῆς προόδου τῆς ἐκθέσεως ἧστινος κλωμένης γραμμῆς πρὸς τῷ ἐγγὺς ἐλάσσονι ἡ ἀντανάκλασις ἐπὶ τὸν λοιπὸν γέγραπται φερομένη ὡς εἴρηται διὰ τὸ εὔτακτον τῆς προκοπῆς οὕτως τε ποιήσας ἑξῆς τὸ αφ ποιῶν ὃ προσσημαίνει ὡς εἴρηται τὸ ὅτι δεῖ ἀφελεῖν ὁμοίως ἀπὸ τοῦ λοιποῦ καὶ δὴ τὸν ἐγγὺς πάλιν ἐλάσσονα ὡς πρὸς τὴν ἐν τῷ σελιδίῳ ἔκθεσιν εὑρισκόμενον λαμβάνων ἑξῆς προγράφει αὐτὸν ὄντα νδ μζ´ ιγ´´ ιβ´´´ καὶ εὑρίσκει αὐτοῖς παρακείμενα ἐν τῷ σελιδίῳ πρῶτα λεπτὰ θ´ ἅτινα καὶ αὐτὰ προσαπογράφεται σὺν τῇ παρασημειώσει τῶν πρώτων γράφων τὸ ᾱ στοιχεῖον ἔχον τὴν ἀνατείνουσαν καὶ ὡς εἴρηται τὴν γραμμὴν πάλιν διὰ τὴν τάξιν κλωμένην κατὰ δευτέραν κλάσιν προσέλκει γινομένου τοῦ μέρους αὐτῆς τούτου παραλλήλου τῷ ἐξ ἀρχῆς
16 ante κλωμένης add ἐπὶ C 18 τε] MZP om SC | αφ ] M ἀφ ZSC ἀφαί P 19 προσσημαίνει] MS προση- ZC et ex corr P | ὅτι] ZP comp MSC 20 δὴ] MZSC διὰ fecit m 2 P 21 πρὸς] MSP et supra lineam C ex ἀπὸ fecit m 2 Z | ιγ´´] MZSP νγ´´ C 22 πρῶτα λεπτὰ] πρωτ λε M ᾱᾱ λεπτὰ Z άάα λε S πρῶτα λ εᾱ P αα λε C 23 προσαπο- γράφεται] απο suprascr in comp M 24 ᾱ] ZP α´ MS α C 25 κλάσιν] MP τάξιν ZSC | τοῦ] ZSPC τούτου M 26 τούτου] τοῦ bis ZSPC sed prius erasit m 2 P τοῦ M
mdash 18 προκοπῆς] om K | τε ποιήσας] ποιήσας καὶ K | αφ ] ἀφ K 19 τὸ] om K 21 προ-γράφει] γράφει K 22 σελιδίῳ] α´ σελιδίῳ K | ἅτινα] ἃ K 23 προσαπογράφεται] ἀπογράφεται K | τῶν πρώτων mdash 26 ἐξ ἀρχῆς] om K
lsquoAllo scopo di raccogliere ciograve che risulta dalla divisione il detto Pappo utilizzando anche in questo caso una certa disposizione ben strutturata determina nel modo seguente il lsaquonumerorsaquo cercato preso nel suo insieme collocando73 in testa il lsaquonumerorsaquo che sta per essere diviso cioegrave i 360 gradi iniziali sottrae loro tra i piugrave prossimi dei lsaquonumerirsaquo minori rispetto a quelli esposti quello che si trova essere minore nella colonna (cioegrave 304 22 20) Questo egrave il motivo per cui lo trascrive scrivendogli davanti lrsquoabbreviazio-ne laquosottrraquo per laquosottrairaquo e trovando che 50 minuti primi sono collocati accanto a quello stesso lsaquonumerorsaquo che egrave stato trascritto nella colonna li trascrive al tempo stesso collocando accanto74 ad essi la lettera A con un lsaquotrattorsaquo75 sopra che significa la specie minuti primi Trova dunque in que-sto modo la parte di 360 che egrave 304 22 20 la quale divisa per 365 giorni 14 48 fa il numero lsaquoche risultarsaquo dalla divisione 50 minuti primi Trascrivendo
73 La descrizione egrave strutturata come una procedura Acerbi 201274 Il purismo del correttore del Par gr 2390 di Clostomalle nel Marc gr 314 e
dellrsquoautore della recensione bizantina impone loro di modificare la terminazione ma forme tematiche e contratte di τιθεῖν sono correnti nel greco tardivo
75 Il testo greco ha solo il participio con γραμμήν sottinteso Per il significato del participio si veda il punto 2
15
20
25
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 153
poi il resto 55 37 40 gli pone altresigrave76 a prefisso laquoReraquo che significa laquorestiraquo e dispone anche una certa linea semplice77 che va da 360 al piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori che egrave esposto di seacuteguito 304 22 20 come nello lsaquoschemarsaquo esposto linea che mostra lrsquoordine del percorso dellrsquoesposizione Questa linea spezzata lagrave dove si trova il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori egrave tracciata inflessa allrsquoindietro lsaquoersaquo punta verso il resto come egrave stato detto in vista di una progressione ordinata E cosigrave facendo prendendo di seacuteguito il laquosottrraquo che significa come egrave stato detto laquoche occorre similmente sottrarre dal re-storaquo e ovviamente prendendo di nuovo il lsaquonumerorsaquo che egrave trovato essere il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori in relazione alla disposizione nella colonna ndash 54 47 13 12 ndash lo scrive di seacuteguito e trova che 9 minuti primi sono posti loro accanto nella colonna trascrive78 anche questi con la segnaletica dei primi scrivendo la lettera A con un lsaquotrattorsaquo sopra e come egrave stato detto prolunga di nuovo la linea spezzata in vista di una buona disposizione tramite una seconda inflessione essendo questa sua parte parallela a quella inizialersquo
La descrizione continua con una serie di laquoe cosigrave viaraquo e non fa ulte-riore riferimento alla tabella
1) La forma verbale ἐξεσμένον Egrave il neutro del participio perfetto medio-passivo di ξέω lett laquopialloraquo laquolevigoraquo Si danno tre possibilitagrave si tratta di un termine canonico per quanto non altrove attestato per designare unrsquoabbreviazione oppure lrsquoautore anonimo improvvisa sul piano metaforico come se unrsquoabbreviazione non fosse altro che la paro-la completa lsquoaccorciata a colpi di piallarsquo in maniera opportuna oppure il testo egrave corrotto e srsquoimpone una correzione ad esempio τὸ ἑξῆς μένον laquociograve che sta di seacuteguitoraquo Questrsquoultima strada mi pare chiusa dal senso delle frase lrsquoabbreviazione non lsquosta di seacuteguitorsquo a niente ma anzi precede la perifrasi τὸ ἑξῆς μένον se impiegata semplicemente per rimandare al segno αφ immediatamente seguente costituirebbe un intollerabile solecismo Se accettiamo la prima di queste letture considerando quin-di lrsquoabbreviazione αφ in posizione predicativa abbiamo a che fare con
76 Rendo in questo modo il τε isolato77 La linea egrave laquosempliceraquo in quanto egrave una retta la precisazione intende evidenziare per
anticipazione il carattere lsquonon semplicersquo che essa assumeragrave alla prima inflessione quando diventeragrave una spezzata linee siffatte erano in effetti concepite dallrsquoanonimo e prima di lui da tutta la tradizione matematica greca come una singola linea spezzata nei punti drsquoinfles-sione I due segmenti paralleli menzionati al termine del passo sono orizzontali
78 Il verbo egrave al medio in variatio rispetto ai due che precedono e che seguono egrave il matematico che lsquosirsquo trascrive le cifre
Fabio Acerbi154
uno hapax semantico nella grecitagrave superstite come egrave facile verificare con una ricerca sul TLG in rete La recensione bizantina risolve il pro-blema sopprimendo semplicemente τὸ ἐξεσμένον
2) La notazione per le specie numeriche Nella terminologia matema-tica greca gli ordini sessagesimali sono εἴδη laquospecieraquo numerici essi corri- spondono agli ordini di grandezza nel nostro sistema decimale e indica-no in analogia con il caso geometrico la lsquoformarsquo che assume un numero quadrato cubo ecc Centinaia e migliaia sono quindi degli εἴδη rispet-tivamente quadrati (100 egrave il quadrato di 10) e cubi (1000 egrave il cubo di 10) sono specie numeriche ma non numeri particolari e drsquoaltronde 300 non egrave un quadrato ma 3 item dellrsquoεἶδος lsquoquadratorsquo 100 3 egrave il numerale di molteplicitagrave della specie quadrata lsquocentinaiarsquo i due 0 che seguono il 3 segnalano esattamente questo fatto che la notazione greca per gli interi non posizionale fa scomparire al livello denotativo Ciograve non vale soltan-to per i numeri interi ma anche per le loro parti i minuti secondi appar-tengono alla specie lsquoquadratorsquo in quanto 13600 egrave il quadrato di 160
La concezione appare interamente dispiegata nellrsquointroduzione degli Arithmetica diofantei79 che si rivela giova farlo rimarcare un te-stimone fondamentale per la ricostruzione della notazione matematica antica Alle specie usate in questrsquoopera vengono assegnati una denomi-nazione ed un segno convenzionale costituito dallrsquoiniziale (di ognuno dei componenti) della denominazione al quadrato o δύναμις il segno ΔΥ al κύβος il segno ΚΥ alla lsquoquarta potenzarsquo o δυναμοδύναμις il segno ΔΥΔ ecc La descrizione di tali segni egrave del tipo καὶ ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον Κ ἐπίσημον ἔχον Υ ΚΥ κύβος laquoe il suo segno egrave un Κ che ha come indice un Υ ΚΥ cuboraquo dove in accordo con quanto abbiamo visto nel punto b supra e pur nel comprensibile imbarazzo del copista della prima parte del Matritensis (o di un suo passato collega) a districarsi in questo formidabile ginepraio notazionale80 le due lettere Κ e Υ ricevono una barra mentre ΚΥ non la richiede a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον il quale ancora una volta esclude automaticamente il segno dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
79 In particolare a DOO I pp 214-62180 Nel Matr 4678 riscontriamo i seguenti fenomeni nelle poche righe a cavallo dei ff
58r-v 1) accento acuto posto su tutti i segni come se fossero abbreviazioni 2) ripetizione sistematica segnodenominazione come in ΚΥ κύβος appena letto dovuta sicuramente allrsquointrusione di glosse interlineari esplicative dei segni ndash e successivo pentimento (δύναμις e κύβος sono in effetti cancellati dalla prima mano il primo con un tratto il secondo con dei punti supra lineam poi il copista si stanca di correggere) 3) nella descrizione del segno per la δυναμοδύναμις menzione di un δέλτα δύο che saragrave molto probabilmente stato ΔΔ subito dopo nella descrizione del κυβόκυβος si legge un incongruo δύο KK
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 155
Diofanto introduce poi dei segni anche per le specie delle parti dellrsquounitagrave (le nostre frazioni) che egli chiama ὁμώνυμα μορία laquoparti omonimeraquo di cui quelle sessagesimali sono casi particolari81 Egli spie-ga appunto che le loro denominazioni sono ottenute da quelle delle specie degli interi per sinonimia passando ad un lsquoordinalersquo82 formato semplicemente aggiungendo il suffisso -στον δυναμοστόν κυβοστόν δυναμοδυναμοστόν ecc (sott μόριον) I loro segni convenzionali sono invece ottenuti da quelli per le specie degli interi aggiungendo una γραμμὴν διαστέλλουσαν τὸ εἶδος laquolinea che distingue la specieraquo83 Una linea sui segni delle specie delle parti egrave richiesta si badi bene per distinguerli dai segni di quelle degli interi come giagrave osservato questi ultimi sono giagrave lsquoagrammaticalirsquo a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον a fortiori lo saranno anche i primi Si tratta della traduzione semio-tica del passaggio dal cardinale allrsquoordinale che a livello grammaticale egrave effettuato con il suffisso -στον Che forma ha questa linea Barra o apice (Egrave cervellotico pensare a forme piugrave complesse) La domanda non ammette una risposta immediata in quanto delle specie diofantee nessuno piugrave si occupa nellrsquoantichitagrave84 Se egrave vero che la prima risposta darebbe origine ad un conflitto tra due convenzioni denotative diffe-renti la barra lsquocitazionalersquo e la barra che distingue la specie lrsquoevidenza grafica del Matritensis lascia lievemente sgomenti (ricordiamoci che giagrave i segni di base sono indebitamente dotati di un accento dal copista) Le poche occorrenze del segno per le specie delle parti85 vedono lrsquoaggiunta di uno slash di sospensione di un doppio apice inverso ndash in tutta evi-
81 Questo fatto era giagrave chiaro nellrsquoantichitagrave Teone in Alm I 10 in iA p 45310-1682 Il parallelo con i cardinali e gli ordinali relativi agli interi egrave reso esplicito da Dio-
fanto ὥσπερ δὲ τῶν ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια παρομοίως καλεῖται τοῖς ἀριθμοῖς τοῦ μὲν τρία τὸ τρίτον τοῦ δὲ τέσσαρα τὸ τέταρτον οὕτως καὶ τῶν νῦν ἐπονομασθέντων ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια κληθήσεται παρομοίως τοῖς ἀριθμοῖς laquocome le parti omonime dei numeri sono chia-mate per assonanza con i numeri di lsquotrersquo lsquolsaquounrsaquo terzorsquo di lsquoquattrorsquo lsquolsaquounrsaquo quartorsquo cosigrave le parti omonime dei numeri appena nominati saranno chiamate per assonanza con i numeriraquo (DOO I p 69-13 si noti lrsquoarticolo lsquocitazionalersquo al singolare in τοῦ τρία e τοῦ τέσσαρα) Il parallelo prosegue anche al livello dei segni che rappresentano queste specie come vedremo tra un attimo
83 Diofanto Arithmetica prefazione in DOO I p 620-21 un passaggio maltrattato in questa edizione occorre espungere il participio ἔχον senza introdurre segni ulteriori oppure eliminare un precedente ἐπί come fa un correttore del Matritensis f 58v
84 Unica parzialissima eccezione lrsquoaccenno di Teone menzionato nella nota 81 supra85 Al f 59r e per di piugrave nel margine per sanare un lungo saut du mecircme au mecircme La
collocazione in margine egrave il motivo per cui troviamo una notazione abbreviata nel resto del trattato il primo copista scioglie tutti i segni prendendoli per abbreviazioni mentre il secondo elimina sistematicamente il tratto aggiuntivo delle specie delle parti dellrsquounitagrave Drsquoaltronde egli scrive ad esempio ΔΥ invece di ΔΥ ed egrave quindi indotto a porre la barra al di sopra della stringa di lettere risultante (passim ma si veda ad esempio il f 72r)
Fabio Acerbi156
denza il compendio per la desinenza -ον accentata il copista interpreta il segno come unrsquoabbreviazione ndash e di una barra a sormontare lo Υ Potremmo forse interpretarlo come il segno di contrazione del grafema -στ- lrsquounico tassello mancante in unrsquoabbreviazione come ad esempio (δυναμοδυναμο)(στ)(ὸν) ma uno scolio di prima mano al f 58v rela-tivo alle specie degli interi inficia questrsquoipotesi esse sono dotate di slash di sospensione accento acuto in un caso del compendio canonico per la terminazione -ον hellip ma tutti gli Υ a esponente sono a loro volta sormontati da una barra
Meno legata al singolo manoscritto ma nondimeno non uniforme si presenta la pratica di notazione dei segni che rappresentano gli enti numerici sessagesimali86 da una parte sta lrsquoevidenza del testo dei Pro-legomena e delle sue tabelle apici ndash drsquoaltronde come abbiamo visto la notazione universalmente impiegata per i numerali ordinali e per le fra-zioni unitarie ndash dallrsquoaltra sta lrsquoevidenza del testo dellrsquoAlmagesto in tutti i manoscritti piugrave antichi e lo stesso si dica del commentario teonino a questrsquoopera o del suo lsquoGrande commentariorsquo alle Tavole facili e dei testi astronomici su papiro barre87 Sembra insomma che la nostra docu-
86 Sia le molteplicitagrave che le specie ahimeacute entrambe rappresentate da lettere dellrsquoalfabeto Come osservato allrsquoinizio della sezione 3 ci sono in effetti due tipi di lettere numerali in gioco se facciamo astrazione da apici o barre lsquo4 minuti secondirsquo si trova scritto δ β la prima lettera numerale denota la molteplicitagrave degli item di una certa specie la se-conda la specie nei Prolegomena entrambe sono accompagnate da un doppio apice il che rende inutile la presenza delle seconde Si noti che la descrizione della tabella non fa parola della notazione da usare per le lettere numerali che denotano la molteplicitagrave barre o apici e quanti apici hellip In questo caso fa interamente fede la tabella cioegrave la pratica grafica condivisa instauratasi non egrave chiaro quando
87 I manoscritti piugrave antichi dellrsquoAlmagesto sono menzionati nella nota 10 supra quelli dei due commentarii teonini sono il Laur Plut 2818 e il celeberrimo Vat gr 190 (sec IX in Euclide Elementi Data Teone lsquoGrande commentariorsquo) per la notazione dei pa-piri astronomici si veda Jones 1999 II passim La notazione non sembra lsquoinquinatarsquo dalla pratica dei copisti bizantini e pare dipendere soltanto dalla data di composizione Tro-viamo ad esempio barre sopra tutti i numerali di molteplicitagrave (interi o sessagesimali) nel frammento di un commentario alle Tavole facili contenente un calcolo relativo al 24 aprile 213 (Par gr 2841 sec XIII ex-XIV in oltre al frammento ai ff 32r l 11-34v l 23 contiene Arato Phaenomena ed Efestione Apotelesmatica edizione in Jones 1990) Nel commentario alle Tavole facili composto ca 610-617 ed attribuito a Stefano di Alessandria la situazione egrave la seguente (Jean Lempire per litteras per lrsquoedizione si veda Lempire 2014 ho controllato il Vat gr 304 ff 135r-171v sec XIV am contiene in aggiunta Teone in Almagestum I-II lsquoPiccolo commentariorsquo alle Tavole facili Diofanto Arithmetica e De polygo-nis numeris varia astronomica tabulae) barre sopra gli interi sporadicamente rimpiazzate da apici apici sopra le parti sessagesimali in numero uguale alla denominazione doppio () apice per le frazioni unitarie Sono impiegate barre sopra gli interi e apici sopra le parti sessagesimali nei manoscritti principali di tutti i trattati di introduzione allrsquoAlmagesto o comunque di argomento logistico redatti in epoca bizantina Giorgio Pachimere (1242-ca 1310) Quadrivium (autografo nel manoscritto Roma Biblioteca Angelica gr 38 [RGK III nr 115] si veda Tannery ndash Steacutephanou 1940 per lrsquoedizione) Teodoro Metochita (1270-
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 157
mentazione si faccia testimone di un cambio notazionale avvenuto nel periodo intercorrente fra Teone (sec IV pm) e la scuola alessandrina di Ammonio e dei suoi allievi (sec VI in) e probabilmente innescato da questrsquoultimo ambiente lrsquoaspetto paradossale egrave che nello stesso codice si rintraccino due notazioni differenti per gli enti numerici sessagesimali e lrsquouna (apici) sia adottata sistematicamente e coerentemente in uno scritto (i Prolegomena) che si presenta esattamente come unrsquointroduzione tecnica alla pratica numerico-algoritmica del trattato (lrsquoAlmagesto) in cui egrave adottata lrsquoaltra (barre che ritroviamo senza eccezioni anche negli scolii)
Torniamo ai Prolegomena la descrizione del segno da porre a fianco di ogni singolo quoziente parziale e denotante la sua specie numerica (minuti primi minuti secondi ecc) solleva tre problemi
Primo problema Ci vuole una barra o un apice su τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquola lettera A [hellip] che significa la specieraquo quando lo scriviamo nella tabella Tutta la nostra discussione precedente fa pro-pendere per lrsquoapice e si ricordi anche la forma verbale ἀνατείνουσαν che suggerisce qualcosa che si lsquoestende verso lrsquoaltorsquo (la mia traduzione egrave volutamente neutra) se fosse apposta una barra la cosa dovrebbe passare
1231332) Compendium astronomicum (copia lsquoautorizzatarsquo coeva nei Vat gr 182 e 181 da parte del copista che integrograve le parti mancanti del Par gr 2389 [ff 207-210 255-270 374-375] Bianconi 2005a pp 425-427 Peacuterez Martiacuten 2008 p 436 e n 177) Teodoro Meliteniota (morto lrsquo831393) Tribiblos astronomica (autografo nel Vat gr 792 si vedano Leurquin 1991 per unrsquoanalisi del manoscritto Leurquin 1990 per lrsquoedizione) una com-pilazione anonima (per cui ho consultato il Par gr 2396 ff 87r-92v limitatamente a questi fogli manu Costantino Trivoli [RGK II nr 318 ma ovviamente questo codice non vi egrave segnalato] terzo quarto del XV secolo il resto del codice annotato da Niceforo Gregora egrave di etagrave planudea e parzialmente [ff 33v-76v] un autografo di Planude stesso contiene Teone in Almagestum I II IV Mondrain 2002 il codice va completato ndash limitatamente a stralci dei libri VIII-X XII-XIII del commentario teonino la cui parte intermedia si egrave persa ndash con 26 carte [ff 123-147] inserite nel Vat gr 1087 anchrsquoesso contenente anno-tazioni di Gregora Rome 1927 per la figura del copista dei ff 77r-86r del Par gr 2396 e dei ff appena nominati del Vat gr 1087 un anonimo collaboratore di Gregora si veda in ultimo Bianconi 2006a pp 147-151) si veda anche il calcolo effettuato da Niceforo Gre-gora (12921295-13581361) dellrsquoeclisse di sole del 16 luglio 1330 (attestata unicamente ai ff 1r-8v della miscellanea astronomica Marc gr 325 databile ca 1324-1329 in parte vergata e ovunque fittamente annotata da Gregora stesso edizione del testo in Mogenet et al 1983 annotazioni di Gregora elencate in Bianconi 2005a p 413) Unrsquoeccezione apparente il lsquoPiccolo commentariorsquo di Teone alle Tavole facili le parti sessagesimali sono segnalate da apici (ad esempio nel Vat gr 175 vergato da Giovanni Catrario e completato nel 1321-1322 sulla figura di Catrario si vedano in ultimo Bianconi 2005b pp 141-156 e 2006b) lrsquoopera egrave antica ma la sua tradizione non rimonta oltre la fine del XIII secolo a parte un frammento nel Leiden BPG 78 ff 156r-161v (minuscola del IX-X secolo) e in effetti in questo manoscritto tutti i numerali di molteplicitagrave sono sormontati da barre Unrsquoeccezione effettiva egrave il De hypotesibus planetarum nel Vat gr 1594 barre sugli interi e apici sulle parti sessagesimali
Fabio Acerbi158
sotto silenzio e la presenza dellrsquoapice la rende inutile88 Si tratta della stessa convenzione diofantea e coincide ancora con la notazione per i numerali ordinali e per le frazioni unitarie che egrave corrente nei mano- scritti matematici greci per questo motivo non percheacute la descrizione sia particolarmente perspicua nessuno dei copisti della recensione an-tica ha incertezze apici Ma questi apici si rintracciano soltanto sulle indicazioni di specie non contemplate dalla descrizione che sono ante-poste ai resti parziali a fianco dei quozienti parziali i segni di specie sono invece trasformati in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordi-nali corrispondenti del tipo πρωτ tavv 5 e 7b-8 Il recensore bizantino taglia invece la testa al toro elimina dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali elimina la seconda menzione della laquolet-tera Araquo contestualmente allrsquoazzeramento dellrsquoespediente della linea a zig-zag (si veda il punto seguente) modifica la descrizione che contiene la prima menzione in quella dellrsquoapice associato direttamente ai nume-rali di molteplicitagrave riciclando addirittura lrsquoalpha per adibirlo a desi-gnare un numero cardinale (come sorprendersi) τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ laquoponendo al di sopra di essi [scil dei 50 minuti primi] 1 solo lsaquoaccentorsaquo acutoraquo La scelta del recensore egrave assennata che rechi una barra o un apice in una tabella un alpha denota un numero non un numero drsquoordine
Secondo problema da tenere ben distinto dal precedente Cosa ci vuole sul segno α per la lettera alpha menzionata nella frase τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquolettera A [hellip] che significa la specieraquo89 Unrsquooc-chiata allrsquoapparato critico rivela una bella incertezza nei manoscritti Z scrive sempre ᾱ e in un caso lo fa anche P MS optano sempre per α´ C per α P scrive nellrsquoaltro caso αο Per quanto solo la barra sia congrua con il senso della frase in quanto la lettera alpha egrave qui menzionata (si tratta di un oggetto che compare nella tabella) e non cambia niente se essa egrave accompagnata dal suo nome di genere στοιχεῖον ad un livello grafico lrsquoincertezza fra il segno ᾱ che denota laquola lettera αraquo e il segno α´ (o lrsquoabbreviazione αο) per una forma di πρῶτος egrave per piugrave versi giustificata
88 Detto in altri termini la barra egrave uno strumento grafico non matematico e quindi la sua presenza non va segnalata mentre un apice lo egrave e la sua presenza lo deve
89 Notare che in questa frase il primo α non vuole la barra (egrave menzionato allrsquointerno di una frase che impiega convenzioni moderne) il secondo sigrave (idem ma con convenzioni antiche) ndash e nella traduzione la scelta di denotarlo con A (senza virgolette) e non con lsquoArsquo (con virgolette) egrave del tutto arbitraria ndash si noti inoltre che le necessarie precisazioni laquosenzacon virgoletteraquo mostrano che le lingue moderne palesano difficoltagrave analoghe a quelle del greco antico per quanto riguarda i livelli denotativi in ambito metadiscorsivo per non usare le due parentetiche avrei dovuto scrivere rispettivamente lsquoArsquo e lsquolsquoArsquorsquo (doppie virgolette semplici)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 159
ᾱ coincide con il numerale 1 α egrave la prima lettera dellrsquoalfabeto ed inoltre α´ egrave esattamente quello che va scritto nella tabella Potremmo dirci che il sostantivo στοιχεῖον chiude la questione la sua presenza congiunta ad un ipotetico α´ renderebbe la descrizione ridondante o inappropriata90 Ma a parte il fatto che α egrave proprio τὸ πρῶτον στοιχεῖον il segno α´ cat-tura in fondo il cuore della descrizione di uno στοιχεῖον ἔχον lsaquoγραμμὴνrsaquo ἀνατείνουσαν
Terzo problema Lrsquoautore dei Prolegomena che si arresta allrsquoesem-pio dei minuti primi non dice quanti apici occorre mettere sulle lettere numerali che identificano gli ordini superiori al primo se uno soltanto come nel caso diofanteo e delle frazioni unitarie o in numero uguale alla loro denominazione (cioegrave pari al numero denotato dal numerale stesso su cui vanno posti) come effettivamente avviene nei mano-scritti dei Prolegomena La tabella egrave quindi sottodeterminata dalla sua descrizione anzi in un certo senso prende il sopravvento su di essa la pratica di marcare i numerali di molteplicitagrave con gli apici che compe-tono allrsquoordine cui appartengono viene trasferita ai segni per gli ordini stessi per supplire ad una descrizione carente di questi ultimi E la tabella egrave sottodeterminata dalla descrizione in quanto egrave la descrizione di una tabella reale ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις laquocome nello lsaquoschemarsaquo espostoraquo leggiamo a un certo punto del testo
3) La linea a zig-zag Non possiamo che applaudire a questo geniale espediente grafico lo troviamo messo in opera solo nel Marc gr 313 Per quanto lrsquoautore non faccia parola di ciograve nel corso della sua descrizione la linea spezzata egrave intesa dover lsquosaltarersquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue Il copista del codice marciano effettua correttamente due salti nella prima delle sue tabelle (tav 4) ma inserisce un lsquodentersquo in piugrave in quella che considera corretta (tav 5) La linea a zig-zag egrave incompatibile con la presenza di linee di giustificazione nella tabella che in effetti mancano nel Marc gr 313 ciograve induce gli errori di allineamento dei primi 5 quozienti parziali di cui egrave vittima il copista Probabilmente per questo motivo in nessuno degli apografi del Vat gr 1594 la linea a zig-zag figura nella tabella inquadrata come si conviene da una (doppia) cornice esterna e le cui colonne sono appunto separate da linee verticali (tav 7b Vat gr 184 f 17v e tav 8 Par gr 2390 f 9v cui egrave sostanzialmente identica la tabella del Marc gr 314 che si trova
90 Trascuro lrsquoabbreviazione αο = πρῶτος percheacute la desinenza non egrave quella richiesta neacute nella frase (egrave richiesto πρῶτον) neacute nella tabella (πρῶτα)
Fabio Acerbi160
al f 248r ndash ma la mancanza di linee orizzontali causa un gigantesco pa-sticcio nel codice vaticano) Alla recensione bizantina che dipende per il suo testo di base dal Vat gr 1594 e quindi non trova la linea a zig-zag nella tabella non resta che sopprimere la sua descrizione ndash ma proprio per questo motivo e finalmente diventa possibile tracciare un apparato completo di linee di giustificazione (tav 9 Laur Plut 89 sup 48 f 14v) Dato che la descrizione di Teone di questo procedimento di divi-sione non fa cenno allrsquoesistenza della linea a zig-zag viene da chiedersi se essa non costituisca un espediente escogitato dallrsquoautore dei Prolegomena per vivacizzare la procedura originale di Pappo
4) Discrepanze tra descrizione e tabella Il gioco delle minime va-rianti mostra che la divisione era stata eseguita (e trasmessa) corret-tamente tutti i valori numerici sono esatti La tabella nel Marc gr 313 presenta perograve alcune discrepanze con la propria descrizione Essa omette (ma non nella versione lsquoscorrettarsquo lrsquoomissione non si riscontra neanche nel Par gr 2390) il segno per laquorestoraquo di fronte ai resti par-ziali ma aggiunge lrsquoindicazione della loro specie Essa trasforma invece come abbiamo visto le indicazioni di specie che seguono i quozienti parziali in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordinali corri-spondenti La descrizione prevede di chiudere la tabella con il risultato καὶ συνάγων ἅπαντα τὰ ἐκ τῶν μερισθέντων μερῶν λεπτὰ σημειοῦται ὑπὸ πάντας οὕτως γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoe raccogliendo tutti i minuti che provengono dalle parti divise lsaquoPapporsaquo nota sotto tutto cosigrave Ris 0 59 8 17 13 12 31raquo ma sotto la tabella tutta la tradizione ci consegna qualcosa di piugrave articolato ὁ ζητούμενος καθ᾽ ὃν μερίζεται ὁ τξε ιδ´ μη´´ π(αρὰ) τὸν τξ γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoil lsaquonumerorsaquo cercato secondo cui 365 14 48 egrave diviso per 360 risulta 0 59 8 17 13 12 31raquo frase che del resto contiene due errori lrsquoinversione del dividendo e del divisore e la confusione tra segno convenzionale (iuxta descrizione) e abbreviazione (come nella frase) nel caso di γι Oltre ad eliminare la linea a zig-zag91 la recensione bizantina sopprime dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali e modifica come abbiamo visto al punto 2 le loro descrizioni in quelle di apici associati diretta-mente ai numerali di molteplicitagrave
91 Le due righe che nella recensione di base contengono solo i resti parziali minori di 160 del divisore ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue sono in parte completate con lrsquoindicazione abbreviata ἀνάλ(υσις) laquoanalisiraquo il termine greco per questa procedura di riduzione In un sussulto di ipercorrettismo matematico tali resti parziali ridotti non sono preceduti dal segno per laquorestoraquo come nel Par gr 2390 ma da quello per laquorisultatoraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 161
Gli esempi che abbiamo discusso mostrano come i problemi di notazione pesino e non poco sullrsquoespressione discorsiva di un algorit-mo matematico lrsquoente di riferimento per lsquoformularersquo il procedimento di divisione fu considerata la tabella cioegrave un oggetto la cui costitu-zione egrave legata piugrave ad una pratica grafica che a considerazioni logico- algoritmiche non la sua descrizione che in effetti finisce per determi-nare la tabella in maniera non univoca Di questa sottodeterminazione si fa testimone la traiettoria che abbiamo cercato di seguire nelle mani di copisti e revisori il procedimento di divisione si modifica a volte in aspetti secondari a volte in punti piugrave sostanziali ndash fino a rendere neces-saria una radicale revisione della sua descrizione per renderla conforme alla tabella ndash in ogni caso mai per ragioni squisitamente matematiche92
Abstract
The article presents and discusses in detail two passages from the anonymous Prolegomena to the Almagest a VIth century primer to the elementary procedures of calculation needed in Ptolemyrsquos Almagest In the two passages we may follow the complex interplay between mathematical notation the auctor who employed and described it the tachygrapher who transcribed it in vivo copyists who reproduced it correctors who modified it Along this path misgivings and errors arise in the transmission of abbreviations and paratextual units such as diagrams tables operational schemes
Fabio AcerbiCNRS UMR8560 Centre Alexandre Koyreacute
fabacerbigmailcom
92 Sono grato a Daniele Bianconi Lucio del Corso Jean Lempire per alcune preziose indicazioni
AOO = Archimedis opera omnia cum commentariis Eutocii ed J L Heiberg I-III Lipsiae 1910-1915
DOO = Diophanti Alexandrini opera omnia cum Graecis commentariis ed P Tannery I-II Lipsiae 1893-1895
GC = Le laquoGrand Commentaireraquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Mogenet ndash A Tihon I-III Cittagrave del Vaticano 1985-1999
iA = Commentaires de Pappus et de Theacuteon drsquoAlexandrie sur lrsquoAlmageste ed A Rome I-III con paginazione continua Cittagrave del Vaticano 1931-1943
HOO = Heronis Alexandrini opera quae supersunt omnia ed G Schmidt ndash L Nix ndash W Schmidt ndash H Schoene ndash J L Heiberg I-V Lipsiae 1899-1914
PC = Le ldquoPetit Commentairerdquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed A Tihon Cittagrave del Vaticano 1978
POO = Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia ed J L Heiberg I-II in 3 parti Lipsiae 1898-1907
RGK = Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600 I Handschriften aus Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln II Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs und Nachtraumlge zu den Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln III Handschriften aus Bibliotheken Roms mit dem Vatikan A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg unter Mitarbeit von D Harlfinger und P Eleuteri B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln Wien 1981-1997 (Oumlsterreichische Akademie der Wissenschaften Veroumlffentlichungen der Kommission fuumlr Byzantinistik III1-3 A-C)
Sigla
Acerbi 2010 = F Acerbi Il silenzio delle sirene La matematica greca antica Roma 2010
Acerbi 2012 = F Acerbi I codici stilistici della matematica greca dimostrazioni procedure algoritmi laquoQUCCraquo 1012 (2012) pp 167-214
Acerbi et al 2010 = F Acerbi ndash N Vinel ndash B Vitrac Les Proleacutegomegravenes agrave lrsquoAlmageste Une eacutedition agrave partir des manuscrits les plus anciens Introduction geacuteneacuterale ndash Parties I-III laquoSCIAMVSraquo 11 (2010) pp 53-210
Agati 1992 = M L Agati La minuscola laquoBouleteacuteeraquo Cittagrave del Vaticano 1992
Belger 1881 = C Belger Ein neues Fragmentum mathematicum Bobiense laquoHermesraquo 16 (1881) pp 261-284
Bianconi 2005a = D Bianconi La biblioteca di Cora tra Massimo Planude e Niceforo Gregora Una questione di mani laquoSampTraquo 3 (2005) pp 391-438
Bianconi 2005b = D Bianconi Tessalonica nellrsquoetagrave dei Paleologi Le pratiche intellettuali nel riflesso della cultura scritta Paris 2005
Bianconi 2006a = D Bianconi Le pietre e il ponte ovvero identificazioni di mani e storia della cultura laquoBizantinisticaraquo 8 (2006) pp 135-181
Bianconi 2006b = D Bianconi Qualcosa di nuovo su Giovanni Catrario laquoMEGraquo 6 (2006) pp 69-91
Cavallo 1977 = G Cavallo Funzione e strutture della maiuscola greca tra i secoli VIII-XI in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Colloque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 95-137
Cereteli 1904 = G F Cereteli De compendiis scripturae codicum Graecorum praecipue Petropolitanorum et Mosquensium anni nota instructorum Sankt-Petersburg 1904
De Gregorio 2000 = G De Gregorio Materiali vecchi e nuovi per uno studio della minu-scola greca fra VII e IX secolo in G Prato (a cura di) I manoscritti greci tra riflessione e dibattito Atti del V Colloquio Internazionale di Paleografia Greca Cremona 4-10 ottobre 1998 Firenze 2000 pp 83-151
Follieri 1977 = E Follieri La minuscola libraria dei secoli IX e X in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Col-loque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 139-165
Fonkič 2005 = B Fonkič Venecianskaia rukopisrsquo laquoAlrsquomagestaraquo Ptolemeja (Marc gr 313690) o datirovke i proischoždenii kodeksa laquoVDIraquo s III 254 (2005) pp 162-167
Fowler 1999 = D H Fowler The Mathematics of Platorsquos Academy A New Reconstruction Second Edition Oxford 1999
Bibliografia
Fabio Acerbi164
Gerstinger ndash Vogel 1932 = H Gerstinger ndash K Vogel Eine stereometrische Aufgaben-sammlung im Papyrus Graecus [sic] Vindobonensis 19996 laquoMitteilungen aus der Papy-russammlung der Nationalbibliothek in Wienraquo Neue Serie Folge 1 Griechische literarische Papyri 1 Wien 1932 pp 11-76
Heiberg 1927 = Mathematici Graeci Minores ed J L Heiberg Kjoslashbenhavn 1927
Hultsch 1876-1878 = Pappi Alexandrini Collectionis quae supersunt ed F Hultsch I-III Berlin 1876-1878
Janz 2003 = T Janz The Scribes and the Date of the Vat gr 1291 in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae X Cittagrave del Vaticano 2003 pp 159-180
Jones 1990 = Ptolemyrsquos First Commentator ed A Jones Philadelphia 1990
Jones 1999 = Astronomical Papyri from Oxyrhynchus ed A Jones I-II Philadelphia 1999
Jones 2005 = A Jones Ptolemyrsquos Canobic Inscription and Heliodorusrsquo Observation Reports laquoSCIAMVSraquo 6 (2005) pp 53-97
Lempire 2014 = Steacutephanos drsquoAlexandrie Le commentaire aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Lempire Louvain 2014
Leurquin 1990 = Theacuteodore Meacuteliteacuteniote Tribiblos astronomique Livre I ed R Leurquin Amsterdam 1990
Leurquin 1991 = R Leurquin Un manuscrit autographe de la Tribiblos Astronomique de Theacuteodore Meacuteliteacuteniote le Vaticanus graecus 792 laquoScriptoriumraquo 45 (1991) pp 145-162
Maas 1927 = P Maas Griechische Palaeographie in A Gercke ndash E Norden (hrsg von) Einleitung in die Altertumswissenschaft I9 Leipzig 1927 pp 69-80
Martinelli Tempesta 2010 = S Martinelli Tempesta Il codice Milano Biblioteca Am-brosiana B 75 sup (gr 104) e lrsquoevoluzione della scrittura di Giovanni Scutariota in A B Garciacutea ndash I Peacuterez Martiacuten (ed by) The Legacy of Bernard de Montfaucon Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting Proceedings of the Seventh Inter-national Colloquium of Greek Palaeography Madrid-Salamanca 15-20 September 2008 Turnhout 2010 pp 171-186
Mazzucchi 1994 = C M Mazzucchi Leggere i classici durante la catastrofe (Costantino-poli maggio-agosto 1203) le note marginali al Diodoro Siculo Vaticano gr 130 Parte prima stratigrafia laquoAevumraquo 68 (1994) pp 164-218
Mioni 1976 = E Mioni Bessarione scriba e alcuni suoi collaboratori in Miscellanea marcia-na di studi bessarionei Padova 1976 pp 263-323
Mioni 1985 = Codices graeci manuscripti Bibliothecae Divi Marci Venetiarum II Thesaurus Antiquus Codices 300-625 recensuit E Mioni Roma 1985
Mogenet 1962 = J Mogenet Une scholie ineacutedite du Vat gr 1594 sur les rapports entre lrsquoastronomie arabe et Byzance laquoOsirisraquo 14 (1962) pp 198-221
Mogenet et al 1983 = Niceacutephore Greacutegoras Calcul de lrsquoeacuteclipse de soleil du 16 juillet 1330 ed J Mogenet ndash A Tihon ndash R Royez ndash A Berg Amsterdam 1983
Mondrain 2002 = B Mondrain Maxime Planude Niceacutephore Greacutegoras et Ptoleacutemeacutee laquoPa-laeoslavicaraquo 10 (2002) pp 312-322
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 165
Mondrain 2004 = B Mondrain Lrsquoancien empereur Jean VI Cantacuzegravene et ses copistes in A Rigo (a cura di) Gregorio Palamas e oltre Studi e documenti sulle controversie teologiche del XIV secolo bizantino Firenze 2004 pp 249-296
Mondrain 2007 = B Mondrain Les eacutecritures dans les manuscrits byzantins du XIV e siegravecle Quelques probleacutematiques laquoRSBNraquo n s 44 (2007) pp 157-196
Peacuterez Martiacuten 2006 = I Peacuterez Martiacuten Maxime Planude et le Diophantus Matritensis (Madrid Biblioteca Nacional ms 4678) un paradigme de la reacutecupeacuteration des textes anciens dans la ldquorenaissance paleacuteologuerdquo laquoByzantionraquo 76 (2006) pp 433-462
Peacuterez Martiacuten 2008 = I Peacuterez Martiacuten El lsquoestilo Hodegosrsquo y su proyeccioacuten en las escrituras constantinopolitanas laquoSampTraquo 6 (2008) pp 389-458
Perria 1991 = L Perria Scrittura e ornamentazione nei codici della laquocollezione filosoficaraquo laquoRSBNraquo n s 28 (1991) pp 45-111
Rollo 2012 = A Rollo LrsquoArchimede di Giorgio Valla in V Fera ndash D Gionta ndash A Rollo (a cura di) Archimede e le sue fortune Atti del Convegno di Siracusa-Messina 24-26 giugno 2008 Messina 2012 pp 99-147
Rome 1927 = A Rome Membra disjecta laquoRBenraquo 39 (1927) pp 187-188
Rome 1938 = A Rome Un manuscrit de la bibliothegraveque de Boniface VIII agrave la Meacutediceacuteenne de Florence laquoACraquo 7 (1938) pp 261-268
Ronconi 2013 = F Ronconi La collection philosophique un fantocircme historique laquoScripto-riumraquo 67 (2013) pp 119-140
Tannery ndash Steacutephanou 1940 = Quadrivium de Georges Pachymegravere ed P Tannery ndash E Steacutephanou Cittagrave del Vaticano 1940
Tihon 2011 = Πτολεμαίου Πρόχειροι Κανόνες Les Tables faciles de Ptoleacutemeacutee vol Ia Tables A1-A2 ed A Tihon Leuven 2011
Traube 1907 = L Traube Nomina Sacra Versuch einer Geschichte der christlichen Kuumlrzung Muumlnchen 1907
Vogel 1936 = K Vogel Beitraumlge zur griechischen Logistik laquoSBAWraquo Mathematisch-natur-wissenschaftliche Abteilung Jahrgang 1936 pp 357-472
Wouters 1979 = A Wouters The Grammatical Papyri from Graeco-Roman Egypt Contri-butions to the Study of the lsquoArs Grammaticarsquo in Antiquity Brussel 1979
F ACERBI Tav 1
b Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 65r
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 284 f 160r
F ACERBITav 2
b Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 13r
a Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 19v
F ACERBI Tav 3
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 136v
F ACERBITav 4
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17r
F ACERBI Tav 5
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17v
F ACERBITav 6
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 7v
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 153
poi il resto 55 37 40 gli pone altresigrave76 a prefisso laquoReraquo che significa laquorestiraquo e dispone anche una certa linea semplice77 che va da 360 al piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori che egrave esposto di seacuteguito 304 22 20 come nello lsaquoschemarsaquo esposto linea che mostra lrsquoordine del percorso dellrsquoesposizione Questa linea spezzata lagrave dove si trova il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori egrave tracciata inflessa allrsquoindietro lsaquoersaquo punta verso il resto come egrave stato detto in vista di una progressione ordinata E cosigrave facendo prendendo di seacuteguito il laquosottrraquo che significa come egrave stato detto laquoche occorre similmente sottrarre dal re-storaquo e ovviamente prendendo di nuovo il lsaquonumerorsaquo che egrave trovato essere il piugrave vicino lsaquodei numerirsaquo minori in relazione alla disposizione nella colonna ndash 54 47 13 12 ndash lo scrive di seacuteguito e trova che 9 minuti primi sono posti loro accanto nella colonna trascrive78 anche questi con la segnaletica dei primi scrivendo la lettera A con un lsaquotrattorsaquo sopra e come egrave stato detto prolunga di nuovo la linea spezzata in vista di una buona disposizione tramite una seconda inflessione essendo questa sua parte parallela a quella inizialersquo
La descrizione continua con una serie di laquoe cosigrave viaraquo e non fa ulte-riore riferimento alla tabella
1) La forma verbale ἐξεσμένον Egrave il neutro del participio perfetto medio-passivo di ξέω lett laquopialloraquo laquolevigoraquo Si danno tre possibilitagrave si tratta di un termine canonico per quanto non altrove attestato per designare unrsquoabbreviazione oppure lrsquoautore anonimo improvvisa sul piano metaforico come se unrsquoabbreviazione non fosse altro che la paro-la completa lsquoaccorciata a colpi di piallarsquo in maniera opportuna oppure il testo egrave corrotto e srsquoimpone una correzione ad esempio τὸ ἑξῆς μένον laquociograve che sta di seacuteguitoraquo Questrsquoultima strada mi pare chiusa dal senso delle frase lrsquoabbreviazione non lsquosta di seacuteguitorsquo a niente ma anzi precede la perifrasi τὸ ἑξῆς μένον se impiegata semplicemente per rimandare al segno αφ immediatamente seguente costituirebbe un intollerabile solecismo Se accettiamo la prima di queste letture considerando quin-di lrsquoabbreviazione αφ in posizione predicativa abbiamo a che fare con
76 Rendo in questo modo il τε isolato77 La linea egrave laquosempliceraquo in quanto egrave una retta la precisazione intende evidenziare per
anticipazione il carattere lsquonon semplicersquo che essa assumeragrave alla prima inflessione quando diventeragrave una spezzata linee siffatte erano in effetti concepite dallrsquoanonimo e prima di lui da tutta la tradizione matematica greca come una singola linea spezzata nei punti drsquoinfles-sione I due segmenti paralleli menzionati al termine del passo sono orizzontali
78 Il verbo egrave al medio in variatio rispetto ai due che precedono e che seguono egrave il matematico che lsquosirsquo trascrive le cifre
Fabio Acerbi154
uno hapax semantico nella grecitagrave superstite come egrave facile verificare con una ricerca sul TLG in rete La recensione bizantina risolve il pro-blema sopprimendo semplicemente τὸ ἐξεσμένον
2) La notazione per le specie numeriche Nella terminologia matema-tica greca gli ordini sessagesimali sono εἴδη laquospecieraquo numerici essi corri- spondono agli ordini di grandezza nel nostro sistema decimale e indica-no in analogia con il caso geometrico la lsquoformarsquo che assume un numero quadrato cubo ecc Centinaia e migliaia sono quindi degli εἴδη rispet-tivamente quadrati (100 egrave il quadrato di 10) e cubi (1000 egrave il cubo di 10) sono specie numeriche ma non numeri particolari e drsquoaltronde 300 non egrave un quadrato ma 3 item dellrsquoεἶδος lsquoquadratorsquo 100 3 egrave il numerale di molteplicitagrave della specie quadrata lsquocentinaiarsquo i due 0 che seguono il 3 segnalano esattamente questo fatto che la notazione greca per gli interi non posizionale fa scomparire al livello denotativo Ciograve non vale soltan-to per i numeri interi ma anche per le loro parti i minuti secondi appar-tengono alla specie lsquoquadratorsquo in quanto 13600 egrave il quadrato di 160
La concezione appare interamente dispiegata nellrsquointroduzione degli Arithmetica diofantei79 che si rivela giova farlo rimarcare un te-stimone fondamentale per la ricostruzione della notazione matematica antica Alle specie usate in questrsquoopera vengono assegnati una denomi-nazione ed un segno convenzionale costituito dallrsquoiniziale (di ognuno dei componenti) della denominazione al quadrato o δύναμις il segno ΔΥ al κύβος il segno ΚΥ alla lsquoquarta potenzarsquo o δυναμοδύναμις il segno ΔΥΔ ecc La descrizione di tali segni egrave del tipo καὶ ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον Κ ἐπίσημον ἔχον Υ ΚΥ κύβος laquoe il suo segno egrave un Κ che ha come indice un Υ ΚΥ cuboraquo dove in accordo con quanto abbiamo visto nel punto b supra e pur nel comprensibile imbarazzo del copista della prima parte del Matritensis (o di un suo passato collega) a districarsi in questo formidabile ginepraio notazionale80 le due lettere Κ e Υ ricevono una barra mentre ΚΥ non la richiede a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον il quale ancora una volta esclude automaticamente il segno dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
79 In particolare a DOO I pp 214-62180 Nel Matr 4678 riscontriamo i seguenti fenomeni nelle poche righe a cavallo dei ff
58r-v 1) accento acuto posto su tutti i segni come se fossero abbreviazioni 2) ripetizione sistematica segnodenominazione come in ΚΥ κύβος appena letto dovuta sicuramente allrsquointrusione di glosse interlineari esplicative dei segni ndash e successivo pentimento (δύναμις e κύβος sono in effetti cancellati dalla prima mano il primo con un tratto il secondo con dei punti supra lineam poi il copista si stanca di correggere) 3) nella descrizione del segno per la δυναμοδύναμις menzione di un δέλτα δύο che saragrave molto probabilmente stato ΔΔ subito dopo nella descrizione del κυβόκυβος si legge un incongruo δύο KK
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 155
Diofanto introduce poi dei segni anche per le specie delle parti dellrsquounitagrave (le nostre frazioni) che egli chiama ὁμώνυμα μορία laquoparti omonimeraquo di cui quelle sessagesimali sono casi particolari81 Egli spie-ga appunto che le loro denominazioni sono ottenute da quelle delle specie degli interi per sinonimia passando ad un lsquoordinalersquo82 formato semplicemente aggiungendo il suffisso -στον δυναμοστόν κυβοστόν δυναμοδυναμοστόν ecc (sott μόριον) I loro segni convenzionali sono invece ottenuti da quelli per le specie degli interi aggiungendo una γραμμὴν διαστέλλουσαν τὸ εἶδος laquolinea che distingue la specieraquo83 Una linea sui segni delle specie delle parti egrave richiesta si badi bene per distinguerli dai segni di quelle degli interi come giagrave osservato questi ultimi sono giagrave lsquoagrammaticalirsquo a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον a fortiori lo saranno anche i primi Si tratta della traduzione semio-tica del passaggio dal cardinale allrsquoordinale che a livello grammaticale egrave effettuato con il suffisso -στον Che forma ha questa linea Barra o apice (Egrave cervellotico pensare a forme piugrave complesse) La domanda non ammette una risposta immediata in quanto delle specie diofantee nessuno piugrave si occupa nellrsquoantichitagrave84 Se egrave vero che la prima risposta darebbe origine ad un conflitto tra due convenzioni denotative diffe-renti la barra lsquocitazionalersquo e la barra che distingue la specie lrsquoevidenza grafica del Matritensis lascia lievemente sgomenti (ricordiamoci che giagrave i segni di base sono indebitamente dotati di un accento dal copista) Le poche occorrenze del segno per le specie delle parti85 vedono lrsquoaggiunta di uno slash di sospensione di un doppio apice inverso ndash in tutta evi-
81 Questo fatto era giagrave chiaro nellrsquoantichitagrave Teone in Alm I 10 in iA p 45310-1682 Il parallelo con i cardinali e gli ordinali relativi agli interi egrave reso esplicito da Dio-
fanto ὥσπερ δὲ τῶν ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια παρομοίως καλεῖται τοῖς ἀριθμοῖς τοῦ μὲν τρία τὸ τρίτον τοῦ δὲ τέσσαρα τὸ τέταρτον οὕτως καὶ τῶν νῦν ἐπονομασθέντων ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια κληθήσεται παρομοίως τοῖς ἀριθμοῖς laquocome le parti omonime dei numeri sono chia-mate per assonanza con i numeri di lsquotrersquo lsquolsaquounrsaquo terzorsquo di lsquoquattrorsquo lsquolsaquounrsaquo quartorsquo cosigrave le parti omonime dei numeri appena nominati saranno chiamate per assonanza con i numeriraquo (DOO I p 69-13 si noti lrsquoarticolo lsquocitazionalersquo al singolare in τοῦ τρία e τοῦ τέσσαρα) Il parallelo prosegue anche al livello dei segni che rappresentano queste specie come vedremo tra un attimo
83 Diofanto Arithmetica prefazione in DOO I p 620-21 un passaggio maltrattato in questa edizione occorre espungere il participio ἔχον senza introdurre segni ulteriori oppure eliminare un precedente ἐπί come fa un correttore del Matritensis f 58v
84 Unica parzialissima eccezione lrsquoaccenno di Teone menzionato nella nota 81 supra85 Al f 59r e per di piugrave nel margine per sanare un lungo saut du mecircme au mecircme La
collocazione in margine egrave il motivo per cui troviamo una notazione abbreviata nel resto del trattato il primo copista scioglie tutti i segni prendendoli per abbreviazioni mentre il secondo elimina sistematicamente il tratto aggiuntivo delle specie delle parti dellrsquounitagrave Drsquoaltronde egli scrive ad esempio ΔΥ invece di ΔΥ ed egrave quindi indotto a porre la barra al di sopra della stringa di lettere risultante (passim ma si veda ad esempio il f 72r)
Fabio Acerbi156
denza il compendio per la desinenza -ον accentata il copista interpreta il segno come unrsquoabbreviazione ndash e di una barra a sormontare lo Υ Potremmo forse interpretarlo come il segno di contrazione del grafema -στ- lrsquounico tassello mancante in unrsquoabbreviazione come ad esempio (δυναμοδυναμο)(στ)(ὸν) ma uno scolio di prima mano al f 58v rela-tivo alle specie degli interi inficia questrsquoipotesi esse sono dotate di slash di sospensione accento acuto in un caso del compendio canonico per la terminazione -ον hellip ma tutti gli Υ a esponente sono a loro volta sormontati da una barra
Meno legata al singolo manoscritto ma nondimeno non uniforme si presenta la pratica di notazione dei segni che rappresentano gli enti numerici sessagesimali86 da una parte sta lrsquoevidenza del testo dei Pro-legomena e delle sue tabelle apici ndash drsquoaltronde come abbiamo visto la notazione universalmente impiegata per i numerali ordinali e per le fra-zioni unitarie ndash dallrsquoaltra sta lrsquoevidenza del testo dellrsquoAlmagesto in tutti i manoscritti piugrave antichi e lo stesso si dica del commentario teonino a questrsquoopera o del suo lsquoGrande commentariorsquo alle Tavole facili e dei testi astronomici su papiro barre87 Sembra insomma che la nostra docu-
86 Sia le molteplicitagrave che le specie ahimeacute entrambe rappresentate da lettere dellrsquoalfabeto Come osservato allrsquoinizio della sezione 3 ci sono in effetti due tipi di lettere numerali in gioco se facciamo astrazione da apici o barre lsquo4 minuti secondirsquo si trova scritto δ β la prima lettera numerale denota la molteplicitagrave degli item di una certa specie la se-conda la specie nei Prolegomena entrambe sono accompagnate da un doppio apice il che rende inutile la presenza delle seconde Si noti che la descrizione della tabella non fa parola della notazione da usare per le lettere numerali che denotano la molteplicitagrave barre o apici e quanti apici hellip In questo caso fa interamente fede la tabella cioegrave la pratica grafica condivisa instauratasi non egrave chiaro quando
87 I manoscritti piugrave antichi dellrsquoAlmagesto sono menzionati nella nota 10 supra quelli dei due commentarii teonini sono il Laur Plut 2818 e il celeberrimo Vat gr 190 (sec IX in Euclide Elementi Data Teone lsquoGrande commentariorsquo) per la notazione dei pa-piri astronomici si veda Jones 1999 II passim La notazione non sembra lsquoinquinatarsquo dalla pratica dei copisti bizantini e pare dipendere soltanto dalla data di composizione Tro-viamo ad esempio barre sopra tutti i numerali di molteplicitagrave (interi o sessagesimali) nel frammento di un commentario alle Tavole facili contenente un calcolo relativo al 24 aprile 213 (Par gr 2841 sec XIII ex-XIV in oltre al frammento ai ff 32r l 11-34v l 23 contiene Arato Phaenomena ed Efestione Apotelesmatica edizione in Jones 1990) Nel commentario alle Tavole facili composto ca 610-617 ed attribuito a Stefano di Alessandria la situazione egrave la seguente (Jean Lempire per litteras per lrsquoedizione si veda Lempire 2014 ho controllato il Vat gr 304 ff 135r-171v sec XIV am contiene in aggiunta Teone in Almagestum I-II lsquoPiccolo commentariorsquo alle Tavole facili Diofanto Arithmetica e De polygo-nis numeris varia astronomica tabulae) barre sopra gli interi sporadicamente rimpiazzate da apici apici sopra le parti sessagesimali in numero uguale alla denominazione doppio () apice per le frazioni unitarie Sono impiegate barre sopra gli interi e apici sopra le parti sessagesimali nei manoscritti principali di tutti i trattati di introduzione allrsquoAlmagesto o comunque di argomento logistico redatti in epoca bizantina Giorgio Pachimere (1242-ca 1310) Quadrivium (autografo nel manoscritto Roma Biblioteca Angelica gr 38 [RGK III nr 115] si veda Tannery ndash Steacutephanou 1940 per lrsquoedizione) Teodoro Metochita (1270-
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 157
mentazione si faccia testimone di un cambio notazionale avvenuto nel periodo intercorrente fra Teone (sec IV pm) e la scuola alessandrina di Ammonio e dei suoi allievi (sec VI in) e probabilmente innescato da questrsquoultimo ambiente lrsquoaspetto paradossale egrave che nello stesso codice si rintraccino due notazioni differenti per gli enti numerici sessagesimali e lrsquouna (apici) sia adottata sistematicamente e coerentemente in uno scritto (i Prolegomena) che si presenta esattamente come unrsquointroduzione tecnica alla pratica numerico-algoritmica del trattato (lrsquoAlmagesto) in cui egrave adottata lrsquoaltra (barre che ritroviamo senza eccezioni anche negli scolii)
Torniamo ai Prolegomena la descrizione del segno da porre a fianco di ogni singolo quoziente parziale e denotante la sua specie numerica (minuti primi minuti secondi ecc) solleva tre problemi
Primo problema Ci vuole una barra o un apice su τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquola lettera A [hellip] che significa la specieraquo quando lo scriviamo nella tabella Tutta la nostra discussione precedente fa pro-pendere per lrsquoapice e si ricordi anche la forma verbale ἀνατείνουσαν che suggerisce qualcosa che si lsquoestende verso lrsquoaltorsquo (la mia traduzione egrave volutamente neutra) se fosse apposta una barra la cosa dovrebbe passare
1231332) Compendium astronomicum (copia lsquoautorizzatarsquo coeva nei Vat gr 182 e 181 da parte del copista che integrograve le parti mancanti del Par gr 2389 [ff 207-210 255-270 374-375] Bianconi 2005a pp 425-427 Peacuterez Martiacuten 2008 p 436 e n 177) Teodoro Meliteniota (morto lrsquo831393) Tribiblos astronomica (autografo nel Vat gr 792 si vedano Leurquin 1991 per unrsquoanalisi del manoscritto Leurquin 1990 per lrsquoedizione) una com-pilazione anonima (per cui ho consultato il Par gr 2396 ff 87r-92v limitatamente a questi fogli manu Costantino Trivoli [RGK II nr 318 ma ovviamente questo codice non vi egrave segnalato] terzo quarto del XV secolo il resto del codice annotato da Niceforo Gregora egrave di etagrave planudea e parzialmente [ff 33v-76v] un autografo di Planude stesso contiene Teone in Almagestum I II IV Mondrain 2002 il codice va completato ndash limitatamente a stralci dei libri VIII-X XII-XIII del commentario teonino la cui parte intermedia si egrave persa ndash con 26 carte [ff 123-147] inserite nel Vat gr 1087 anchrsquoesso contenente anno-tazioni di Gregora Rome 1927 per la figura del copista dei ff 77r-86r del Par gr 2396 e dei ff appena nominati del Vat gr 1087 un anonimo collaboratore di Gregora si veda in ultimo Bianconi 2006a pp 147-151) si veda anche il calcolo effettuato da Niceforo Gre-gora (12921295-13581361) dellrsquoeclisse di sole del 16 luglio 1330 (attestata unicamente ai ff 1r-8v della miscellanea astronomica Marc gr 325 databile ca 1324-1329 in parte vergata e ovunque fittamente annotata da Gregora stesso edizione del testo in Mogenet et al 1983 annotazioni di Gregora elencate in Bianconi 2005a p 413) Unrsquoeccezione apparente il lsquoPiccolo commentariorsquo di Teone alle Tavole facili le parti sessagesimali sono segnalate da apici (ad esempio nel Vat gr 175 vergato da Giovanni Catrario e completato nel 1321-1322 sulla figura di Catrario si vedano in ultimo Bianconi 2005b pp 141-156 e 2006b) lrsquoopera egrave antica ma la sua tradizione non rimonta oltre la fine del XIII secolo a parte un frammento nel Leiden BPG 78 ff 156r-161v (minuscola del IX-X secolo) e in effetti in questo manoscritto tutti i numerali di molteplicitagrave sono sormontati da barre Unrsquoeccezione effettiva egrave il De hypotesibus planetarum nel Vat gr 1594 barre sugli interi e apici sulle parti sessagesimali
Fabio Acerbi158
sotto silenzio e la presenza dellrsquoapice la rende inutile88 Si tratta della stessa convenzione diofantea e coincide ancora con la notazione per i numerali ordinali e per le frazioni unitarie che egrave corrente nei mano- scritti matematici greci per questo motivo non percheacute la descrizione sia particolarmente perspicua nessuno dei copisti della recensione an-tica ha incertezze apici Ma questi apici si rintracciano soltanto sulle indicazioni di specie non contemplate dalla descrizione che sono ante-poste ai resti parziali a fianco dei quozienti parziali i segni di specie sono invece trasformati in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordi-nali corrispondenti del tipo πρωτ tavv 5 e 7b-8 Il recensore bizantino taglia invece la testa al toro elimina dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali elimina la seconda menzione della laquolet-tera Araquo contestualmente allrsquoazzeramento dellrsquoespediente della linea a zig-zag (si veda il punto seguente) modifica la descrizione che contiene la prima menzione in quella dellrsquoapice associato direttamente ai nume-rali di molteplicitagrave riciclando addirittura lrsquoalpha per adibirlo a desi-gnare un numero cardinale (come sorprendersi) τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ laquoponendo al di sopra di essi [scil dei 50 minuti primi] 1 solo lsaquoaccentorsaquo acutoraquo La scelta del recensore egrave assennata che rechi una barra o un apice in una tabella un alpha denota un numero non un numero drsquoordine
Secondo problema da tenere ben distinto dal precedente Cosa ci vuole sul segno α per la lettera alpha menzionata nella frase τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquolettera A [hellip] che significa la specieraquo89 Unrsquooc-chiata allrsquoapparato critico rivela una bella incertezza nei manoscritti Z scrive sempre ᾱ e in un caso lo fa anche P MS optano sempre per α´ C per α P scrive nellrsquoaltro caso αο Per quanto solo la barra sia congrua con il senso della frase in quanto la lettera alpha egrave qui menzionata (si tratta di un oggetto che compare nella tabella) e non cambia niente se essa egrave accompagnata dal suo nome di genere στοιχεῖον ad un livello grafico lrsquoincertezza fra il segno ᾱ che denota laquola lettera αraquo e il segno α´ (o lrsquoabbreviazione αο) per una forma di πρῶτος egrave per piugrave versi giustificata
88 Detto in altri termini la barra egrave uno strumento grafico non matematico e quindi la sua presenza non va segnalata mentre un apice lo egrave e la sua presenza lo deve
89 Notare che in questa frase il primo α non vuole la barra (egrave menzionato allrsquointerno di una frase che impiega convenzioni moderne) il secondo sigrave (idem ma con convenzioni antiche) ndash e nella traduzione la scelta di denotarlo con A (senza virgolette) e non con lsquoArsquo (con virgolette) egrave del tutto arbitraria ndash si noti inoltre che le necessarie precisazioni laquosenzacon virgoletteraquo mostrano che le lingue moderne palesano difficoltagrave analoghe a quelle del greco antico per quanto riguarda i livelli denotativi in ambito metadiscorsivo per non usare le due parentetiche avrei dovuto scrivere rispettivamente lsquoArsquo e lsquolsquoArsquorsquo (doppie virgolette semplici)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 159
ᾱ coincide con il numerale 1 α egrave la prima lettera dellrsquoalfabeto ed inoltre α´ egrave esattamente quello che va scritto nella tabella Potremmo dirci che il sostantivo στοιχεῖον chiude la questione la sua presenza congiunta ad un ipotetico α´ renderebbe la descrizione ridondante o inappropriata90 Ma a parte il fatto che α egrave proprio τὸ πρῶτον στοιχεῖον il segno α´ cat-tura in fondo il cuore della descrizione di uno στοιχεῖον ἔχον lsaquoγραμμὴνrsaquo ἀνατείνουσαν
Terzo problema Lrsquoautore dei Prolegomena che si arresta allrsquoesem-pio dei minuti primi non dice quanti apici occorre mettere sulle lettere numerali che identificano gli ordini superiori al primo se uno soltanto come nel caso diofanteo e delle frazioni unitarie o in numero uguale alla loro denominazione (cioegrave pari al numero denotato dal numerale stesso su cui vanno posti) come effettivamente avviene nei mano-scritti dei Prolegomena La tabella egrave quindi sottodeterminata dalla sua descrizione anzi in un certo senso prende il sopravvento su di essa la pratica di marcare i numerali di molteplicitagrave con gli apici che compe-tono allrsquoordine cui appartengono viene trasferita ai segni per gli ordini stessi per supplire ad una descrizione carente di questi ultimi E la tabella egrave sottodeterminata dalla descrizione in quanto egrave la descrizione di una tabella reale ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις laquocome nello lsaquoschemarsaquo espostoraquo leggiamo a un certo punto del testo
3) La linea a zig-zag Non possiamo che applaudire a questo geniale espediente grafico lo troviamo messo in opera solo nel Marc gr 313 Per quanto lrsquoautore non faccia parola di ciograve nel corso della sua descrizione la linea spezzata egrave intesa dover lsquosaltarersquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue Il copista del codice marciano effettua correttamente due salti nella prima delle sue tabelle (tav 4) ma inserisce un lsquodentersquo in piugrave in quella che considera corretta (tav 5) La linea a zig-zag egrave incompatibile con la presenza di linee di giustificazione nella tabella che in effetti mancano nel Marc gr 313 ciograve induce gli errori di allineamento dei primi 5 quozienti parziali di cui egrave vittima il copista Probabilmente per questo motivo in nessuno degli apografi del Vat gr 1594 la linea a zig-zag figura nella tabella inquadrata come si conviene da una (doppia) cornice esterna e le cui colonne sono appunto separate da linee verticali (tav 7b Vat gr 184 f 17v e tav 8 Par gr 2390 f 9v cui egrave sostanzialmente identica la tabella del Marc gr 314 che si trova
90 Trascuro lrsquoabbreviazione αο = πρῶτος percheacute la desinenza non egrave quella richiesta neacute nella frase (egrave richiesto πρῶτον) neacute nella tabella (πρῶτα)
Fabio Acerbi160
al f 248r ndash ma la mancanza di linee orizzontali causa un gigantesco pa-sticcio nel codice vaticano) Alla recensione bizantina che dipende per il suo testo di base dal Vat gr 1594 e quindi non trova la linea a zig-zag nella tabella non resta che sopprimere la sua descrizione ndash ma proprio per questo motivo e finalmente diventa possibile tracciare un apparato completo di linee di giustificazione (tav 9 Laur Plut 89 sup 48 f 14v) Dato che la descrizione di Teone di questo procedimento di divi-sione non fa cenno allrsquoesistenza della linea a zig-zag viene da chiedersi se essa non costituisca un espediente escogitato dallrsquoautore dei Prolegomena per vivacizzare la procedura originale di Pappo
4) Discrepanze tra descrizione e tabella Il gioco delle minime va-rianti mostra che la divisione era stata eseguita (e trasmessa) corret-tamente tutti i valori numerici sono esatti La tabella nel Marc gr 313 presenta perograve alcune discrepanze con la propria descrizione Essa omette (ma non nella versione lsquoscorrettarsquo lrsquoomissione non si riscontra neanche nel Par gr 2390) il segno per laquorestoraquo di fronte ai resti par-ziali ma aggiunge lrsquoindicazione della loro specie Essa trasforma invece come abbiamo visto le indicazioni di specie che seguono i quozienti parziali in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordinali corri-spondenti La descrizione prevede di chiudere la tabella con il risultato καὶ συνάγων ἅπαντα τὰ ἐκ τῶν μερισθέντων μερῶν λεπτὰ σημειοῦται ὑπὸ πάντας οὕτως γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoe raccogliendo tutti i minuti che provengono dalle parti divise lsaquoPapporsaquo nota sotto tutto cosigrave Ris 0 59 8 17 13 12 31raquo ma sotto la tabella tutta la tradizione ci consegna qualcosa di piugrave articolato ὁ ζητούμενος καθ᾽ ὃν μερίζεται ὁ τξε ιδ´ μη´´ π(αρὰ) τὸν τξ γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoil lsaquonumerorsaquo cercato secondo cui 365 14 48 egrave diviso per 360 risulta 0 59 8 17 13 12 31raquo frase che del resto contiene due errori lrsquoinversione del dividendo e del divisore e la confusione tra segno convenzionale (iuxta descrizione) e abbreviazione (come nella frase) nel caso di γι Oltre ad eliminare la linea a zig-zag91 la recensione bizantina sopprime dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali e modifica come abbiamo visto al punto 2 le loro descrizioni in quelle di apici associati diretta-mente ai numerali di molteplicitagrave
91 Le due righe che nella recensione di base contengono solo i resti parziali minori di 160 del divisore ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue sono in parte completate con lrsquoindicazione abbreviata ἀνάλ(υσις) laquoanalisiraquo il termine greco per questa procedura di riduzione In un sussulto di ipercorrettismo matematico tali resti parziali ridotti non sono preceduti dal segno per laquorestoraquo come nel Par gr 2390 ma da quello per laquorisultatoraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 161
Gli esempi che abbiamo discusso mostrano come i problemi di notazione pesino e non poco sullrsquoespressione discorsiva di un algorit-mo matematico lrsquoente di riferimento per lsquoformularersquo il procedimento di divisione fu considerata la tabella cioegrave un oggetto la cui costitu-zione egrave legata piugrave ad una pratica grafica che a considerazioni logico- algoritmiche non la sua descrizione che in effetti finisce per determi-nare la tabella in maniera non univoca Di questa sottodeterminazione si fa testimone la traiettoria che abbiamo cercato di seguire nelle mani di copisti e revisori il procedimento di divisione si modifica a volte in aspetti secondari a volte in punti piugrave sostanziali ndash fino a rendere neces-saria una radicale revisione della sua descrizione per renderla conforme alla tabella ndash in ogni caso mai per ragioni squisitamente matematiche92
Abstract
The article presents and discusses in detail two passages from the anonymous Prolegomena to the Almagest a VIth century primer to the elementary procedures of calculation needed in Ptolemyrsquos Almagest In the two passages we may follow the complex interplay between mathematical notation the auctor who employed and described it the tachygrapher who transcribed it in vivo copyists who reproduced it correctors who modified it Along this path misgivings and errors arise in the transmission of abbreviations and paratextual units such as diagrams tables operational schemes
Fabio AcerbiCNRS UMR8560 Centre Alexandre Koyreacute
fabacerbigmailcom
92 Sono grato a Daniele Bianconi Lucio del Corso Jean Lempire per alcune preziose indicazioni
AOO = Archimedis opera omnia cum commentariis Eutocii ed J L Heiberg I-III Lipsiae 1910-1915
DOO = Diophanti Alexandrini opera omnia cum Graecis commentariis ed P Tannery I-II Lipsiae 1893-1895
GC = Le laquoGrand Commentaireraquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Mogenet ndash A Tihon I-III Cittagrave del Vaticano 1985-1999
iA = Commentaires de Pappus et de Theacuteon drsquoAlexandrie sur lrsquoAlmageste ed A Rome I-III con paginazione continua Cittagrave del Vaticano 1931-1943
HOO = Heronis Alexandrini opera quae supersunt omnia ed G Schmidt ndash L Nix ndash W Schmidt ndash H Schoene ndash J L Heiberg I-V Lipsiae 1899-1914
PC = Le ldquoPetit Commentairerdquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed A Tihon Cittagrave del Vaticano 1978
POO = Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia ed J L Heiberg I-II in 3 parti Lipsiae 1898-1907
RGK = Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600 I Handschriften aus Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln II Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs und Nachtraumlge zu den Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln III Handschriften aus Bibliotheken Roms mit dem Vatikan A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg unter Mitarbeit von D Harlfinger und P Eleuteri B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln Wien 1981-1997 (Oumlsterreichische Akademie der Wissenschaften Veroumlffentlichungen der Kommission fuumlr Byzantinistik III1-3 A-C)
Sigla
Acerbi 2010 = F Acerbi Il silenzio delle sirene La matematica greca antica Roma 2010
Acerbi 2012 = F Acerbi I codici stilistici della matematica greca dimostrazioni procedure algoritmi laquoQUCCraquo 1012 (2012) pp 167-214
Acerbi et al 2010 = F Acerbi ndash N Vinel ndash B Vitrac Les Proleacutegomegravenes agrave lrsquoAlmageste Une eacutedition agrave partir des manuscrits les plus anciens Introduction geacuteneacuterale ndash Parties I-III laquoSCIAMVSraquo 11 (2010) pp 53-210
Agati 1992 = M L Agati La minuscola laquoBouleteacuteeraquo Cittagrave del Vaticano 1992
Belger 1881 = C Belger Ein neues Fragmentum mathematicum Bobiense laquoHermesraquo 16 (1881) pp 261-284
Bianconi 2005a = D Bianconi La biblioteca di Cora tra Massimo Planude e Niceforo Gregora Una questione di mani laquoSampTraquo 3 (2005) pp 391-438
Bianconi 2005b = D Bianconi Tessalonica nellrsquoetagrave dei Paleologi Le pratiche intellettuali nel riflesso della cultura scritta Paris 2005
Bianconi 2006a = D Bianconi Le pietre e il ponte ovvero identificazioni di mani e storia della cultura laquoBizantinisticaraquo 8 (2006) pp 135-181
Bianconi 2006b = D Bianconi Qualcosa di nuovo su Giovanni Catrario laquoMEGraquo 6 (2006) pp 69-91
Cavallo 1977 = G Cavallo Funzione e strutture della maiuscola greca tra i secoli VIII-XI in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Colloque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 95-137
Cereteli 1904 = G F Cereteli De compendiis scripturae codicum Graecorum praecipue Petropolitanorum et Mosquensium anni nota instructorum Sankt-Petersburg 1904
De Gregorio 2000 = G De Gregorio Materiali vecchi e nuovi per uno studio della minu-scola greca fra VII e IX secolo in G Prato (a cura di) I manoscritti greci tra riflessione e dibattito Atti del V Colloquio Internazionale di Paleografia Greca Cremona 4-10 ottobre 1998 Firenze 2000 pp 83-151
Follieri 1977 = E Follieri La minuscola libraria dei secoli IX e X in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Col-loque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 139-165
Fonkič 2005 = B Fonkič Venecianskaia rukopisrsquo laquoAlrsquomagestaraquo Ptolemeja (Marc gr 313690) o datirovke i proischoždenii kodeksa laquoVDIraquo s III 254 (2005) pp 162-167
Fowler 1999 = D H Fowler The Mathematics of Platorsquos Academy A New Reconstruction Second Edition Oxford 1999
Bibliografia
Fabio Acerbi164
Gerstinger ndash Vogel 1932 = H Gerstinger ndash K Vogel Eine stereometrische Aufgaben-sammlung im Papyrus Graecus [sic] Vindobonensis 19996 laquoMitteilungen aus der Papy-russammlung der Nationalbibliothek in Wienraquo Neue Serie Folge 1 Griechische literarische Papyri 1 Wien 1932 pp 11-76
Heiberg 1927 = Mathematici Graeci Minores ed J L Heiberg Kjoslashbenhavn 1927
Hultsch 1876-1878 = Pappi Alexandrini Collectionis quae supersunt ed F Hultsch I-III Berlin 1876-1878
Janz 2003 = T Janz The Scribes and the Date of the Vat gr 1291 in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae X Cittagrave del Vaticano 2003 pp 159-180
Jones 1990 = Ptolemyrsquos First Commentator ed A Jones Philadelphia 1990
Jones 1999 = Astronomical Papyri from Oxyrhynchus ed A Jones I-II Philadelphia 1999
Jones 2005 = A Jones Ptolemyrsquos Canobic Inscription and Heliodorusrsquo Observation Reports laquoSCIAMVSraquo 6 (2005) pp 53-97
Lempire 2014 = Steacutephanos drsquoAlexandrie Le commentaire aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Lempire Louvain 2014
Leurquin 1990 = Theacuteodore Meacuteliteacuteniote Tribiblos astronomique Livre I ed R Leurquin Amsterdam 1990
Leurquin 1991 = R Leurquin Un manuscrit autographe de la Tribiblos Astronomique de Theacuteodore Meacuteliteacuteniote le Vaticanus graecus 792 laquoScriptoriumraquo 45 (1991) pp 145-162
Maas 1927 = P Maas Griechische Palaeographie in A Gercke ndash E Norden (hrsg von) Einleitung in die Altertumswissenschaft I9 Leipzig 1927 pp 69-80
Martinelli Tempesta 2010 = S Martinelli Tempesta Il codice Milano Biblioteca Am-brosiana B 75 sup (gr 104) e lrsquoevoluzione della scrittura di Giovanni Scutariota in A B Garciacutea ndash I Peacuterez Martiacuten (ed by) The Legacy of Bernard de Montfaucon Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting Proceedings of the Seventh Inter-national Colloquium of Greek Palaeography Madrid-Salamanca 15-20 September 2008 Turnhout 2010 pp 171-186
Mazzucchi 1994 = C M Mazzucchi Leggere i classici durante la catastrofe (Costantino-poli maggio-agosto 1203) le note marginali al Diodoro Siculo Vaticano gr 130 Parte prima stratigrafia laquoAevumraquo 68 (1994) pp 164-218
Mioni 1976 = E Mioni Bessarione scriba e alcuni suoi collaboratori in Miscellanea marcia-na di studi bessarionei Padova 1976 pp 263-323
Mioni 1985 = Codices graeci manuscripti Bibliothecae Divi Marci Venetiarum II Thesaurus Antiquus Codices 300-625 recensuit E Mioni Roma 1985
Mogenet 1962 = J Mogenet Une scholie ineacutedite du Vat gr 1594 sur les rapports entre lrsquoastronomie arabe et Byzance laquoOsirisraquo 14 (1962) pp 198-221
Mogenet et al 1983 = Niceacutephore Greacutegoras Calcul de lrsquoeacuteclipse de soleil du 16 juillet 1330 ed J Mogenet ndash A Tihon ndash R Royez ndash A Berg Amsterdam 1983
Mondrain 2002 = B Mondrain Maxime Planude Niceacutephore Greacutegoras et Ptoleacutemeacutee laquoPa-laeoslavicaraquo 10 (2002) pp 312-322
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 165
Mondrain 2004 = B Mondrain Lrsquoancien empereur Jean VI Cantacuzegravene et ses copistes in A Rigo (a cura di) Gregorio Palamas e oltre Studi e documenti sulle controversie teologiche del XIV secolo bizantino Firenze 2004 pp 249-296
Mondrain 2007 = B Mondrain Les eacutecritures dans les manuscrits byzantins du XIV e siegravecle Quelques probleacutematiques laquoRSBNraquo n s 44 (2007) pp 157-196
Peacuterez Martiacuten 2006 = I Peacuterez Martiacuten Maxime Planude et le Diophantus Matritensis (Madrid Biblioteca Nacional ms 4678) un paradigme de la reacutecupeacuteration des textes anciens dans la ldquorenaissance paleacuteologuerdquo laquoByzantionraquo 76 (2006) pp 433-462
Peacuterez Martiacuten 2008 = I Peacuterez Martiacuten El lsquoestilo Hodegosrsquo y su proyeccioacuten en las escrituras constantinopolitanas laquoSampTraquo 6 (2008) pp 389-458
Perria 1991 = L Perria Scrittura e ornamentazione nei codici della laquocollezione filosoficaraquo laquoRSBNraquo n s 28 (1991) pp 45-111
Rollo 2012 = A Rollo LrsquoArchimede di Giorgio Valla in V Fera ndash D Gionta ndash A Rollo (a cura di) Archimede e le sue fortune Atti del Convegno di Siracusa-Messina 24-26 giugno 2008 Messina 2012 pp 99-147
Rome 1927 = A Rome Membra disjecta laquoRBenraquo 39 (1927) pp 187-188
Rome 1938 = A Rome Un manuscrit de la bibliothegraveque de Boniface VIII agrave la Meacutediceacuteenne de Florence laquoACraquo 7 (1938) pp 261-268
Ronconi 2013 = F Ronconi La collection philosophique un fantocircme historique laquoScripto-riumraquo 67 (2013) pp 119-140
Tannery ndash Steacutephanou 1940 = Quadrivium de Georges Pachymegravere ed P Tannery ndash E Steacutephanou Cittagrave del Vaticano 1940
Tihon 2011 = Πτολεμαίου Πρόχειροι Κανόνες Les Tables faciles de Ptoleacutemeacutee vol Ia Tables A1-A2 ed A Tihon Leuven 2011
Traube 1907 = L Traube Nomina Sacra Versuch einer Geschichte der christlichen Kuumlrzung Muumlnchen 1907
Vogel 1936 = K Vogel Beitraumlge zur griechischen Logistik laquoSBAWraquo Mathematisch-natur-wissenschaftliche Abteilung Jahrgang 1936 pp 357-472
Wouters 1979 = A Wouters The Grammatical Papyri from Graeco-Roman Egypt Contri-butions to the Study of the lsquoArs Grammaticarsquo in Antiquity Brussel 1979
F ACERBI Tav 1
b Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 65r
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 284 f 160r
F ACERBITav 2
b Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 13r
a Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 19v
F ACERBI Tav 3
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 136v
F ACERBITav 4
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17r
F ACERBI Tav 5
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17v
F ACERBITav 6
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 7v
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
Fabio Acerbi154
uno hapax semantico nella grecitagrave superstite come egrave facile verificare con una ricerca sul TLG in rete La recensione bizantina risolve il pro-blema sopprimendo semplicemente τὸ ἐξεσμένον
2) La notazione per le specie numeriche Nella terminologia matema-tica greca gli ordini sessagesimali sono εἴδη laquospecieraquo numerici essi corri- spondono agli ordini di grandezza nel nostro sistema decimale e indica-no in analogia con il caso geometrico la lsquoformarsquo che assume un numero quadrato cubo ecc Centinaia e migliaia sono quindi degli εἴδη rispet-tivamente quadrati (100 egrave il quadrato di 10) e cubi (1000 egrave il cubo di 10) sono specie numeriche ma non numeri particolari e drsquoaltronde 300 non egrave un quadrato ma 3 item dellrsquoεἶδος lsquoquadratorsquo 100 3 egrave il numerale di molteplicitagrave della specie quadrata lsquocentinaiarsquo i due 0 che seguono il 3 segnalano esattamente questo fatto che la notazione greca per gli interi non posizionale fa scomparire al livello denotativo Ciograve non vale soltan-to per i numeri interi ma anche per le loro parti i minuti secondi appar-tengono alla specie lsquoquadratorsquo in quanto 13600 egrave il quadrato di 160
La concezione appare interamente dispiegata nellrsquointroduzione degli Arithmetica diofantei79 che si rivela giova farlo rimarcare un te-stimone fondamentale per la ricostruzione della notazione matematica antica Alle specie usate in questrsquoopera vengono assegnati una denomi-nazione ed un segno convenzionale costituito dallrsquoiniziale (di ognuno dei componenti) della denominazione al quadrato o δύναμις il segno ΔΥ al κύβος il segno ΚΥ alla lsquoquarta potenzarsquo o δυναμοδύναμις il segno ΔΥΔ ecc La descrizione di tali segni egrave del tipo καὶ ἔστιν αὐτοῦ σημεῖον Κ ἐπίσημον ἔχον Υ ΚΥ κύβος laquoe il suo segno egrave un Κ che ha come indice un Υ ΚΥ cuboraquo dove in accordo con quanto abbiamo visto nel punto b supra e pur nel comprensibile imbarazzo del copista della prima parte del Matritensis (o di un suo passato collega) a districarsi in questo formidabile ginepraio notazionale80 le due lettere Κ e Υ ricevono una barra mentre ΚΥ non la richiede a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον il quale ancora una volta esclude automaticamente il segno dal novero dei lsquotermini possibili in grecorsquo
79 In particolare a DOO I pp 214-62180 Nel Matr 4678 riscontriamo i seguenti fenomeni nelle poche righe a cavallo dei ff
58r-v 1) accento acuto posto su tutti i segni come se fossero abbreviazioni 2) ripetizione sistematica segnodenominazione come in ΚΥ κύβος appena letto dovuta sicuramente allrsquointrusione di glosse interlineari esplicative dei segni ndash e successivo pentimento (δύναμις e κύβος sono in effetti cancellati dalla prima mano il primo con un tratto il secondo con dei punti supra lineam poi il copista si stanca di correggere) 3) nella descrizione del segno per la δυναμοδύναμις menzione di un δέλτα δύο che saragrave molto probabilmente stato ΔΔ subito dopo nella descrizione del κυβόκυβος si legge un incongruo δύο KK
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 155
Diofanto introduce poi dei segni anche per le specie delle parti dellrsquounitagrave (le nostre frazioni) che egli chiama ὁμώνυμα μορία laquoparti omonimeraquo di cui quelle sessagesimali sono casi particolari81 Egli spie-ga appunto che le loro denominazioni sono ottenute da quelle delle specie degli interi per sinonimia passando ad un lsquoordinalersquo82 formato semplicemente aggiungendo il suffisso -στον δυναμοστόν κυβοστόν δυναμοδυναμοστόν ecc (sott μόριον) I loro segni convenzionali sono invece ottenuti da quelli per le specie degli interi aggiungendo una γραμμὴν διαστέλλουσαν τὸ εἶδος laquolinea che distingue la specieraquo83 Una linea sui segni delle specie delle parti egrave richiesta si badi bene per distinguerli dai segni di quelle degli interi come giagrave osservato questi ultimi sono giagrave lsquoagrammaticalirsquo a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον a fortiori lo saranno anche i primi Si tratta della traduzione semio-tica del passaggio dal cardinale allrsquoordinale che a livello grammaticale egrave effettuato con il suffisso -στον Che forma ha questa linea Barra o apice (Egrave cervellotico pensare a forme piugrave complesse) La domanda non ammette una risposta immediata in quanto delle specie diofantee nessuno piugrave si occupa nellrsquoantichitagrave84 Se egrave vero che la prima risposta darebbe origine ad un conflitto tra due convenzioni denotative diffe-renti la barra lsquocitazionalersquo e la barra che distingue la specie lrsquoevidenza grafica del Matritensis lascia lievemente sgomenti (ricordiamoci che giagrave i segni di base sono indebitamente dotati di un accento dal copista) Le poche occorrenze del segno per le specie delle parti85 vedono lrsquoaggiunta di uno slash di sospensione di un doppio apice inverso ndash in tutta evi-
81 Questo fatto era giagrave chiaro nellrsquoantichitagrave Teone in Alm I 10 in iA p 45310-1682 Il parallelo con i cardinali e gli ordinali relativi agli interi egrave reso esplicito da Dio-
fanto ὥσπερ δὲ τῶν ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια παρομοίως καλεῖται τοῖς ἀριθμοῖς τοῦ μὲν τρία τὸ τρίτον τοῦ δὲ τέσσαρα τὸ τέταρτον οὕτως καὶ τῶν νῦν ἐπονομασθέντων ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια κληθήσεται παρομοίως τοῖς ἀριθμοῖς laquocome le parti omonime dei numeri sono chia-mate per assonanza con i numeri di lsquotrersquo lsquolsaquounrsaquo terzorsquo di lsquoquattrorsquo lsquolsaquounrsaquo quartorsquo cosigrave le parti omonime dei numeri appena nominati saranno chiamate per assonanza con i numeriraquo (DOO I p 69-13 si noti lrsquoarticolo lsquocitazionalersquo al singolare in τοῦ τρία e τοῦ τέσσαρα) Il parallelo prosegue anche al livello dei segni che rappresentano queste specie come vedremo tra un attimo
83 Diofanto Arithmetica prefazione in DOO I p 620-21 un passaggio maltrattato in questa edizione occorre espungere il participio ἔχον senza introdurre segni ulteriori oppure eliminare un precedente ἐπί come fa un correttore del Matritensis f 58v
84 Unica parzialissima eccezione lrsquoaccenno di Teone menzionato nella nota 81 supra85 Al f 59r e per di piugrave nel margine per sanare un lungo saut du mecircme au mecircme La
collocazione in margine egrave il motivo per cui troviamo una notazione abbreviata nel resto del trattato il primo copista scioglie tutti i segni prendendoli per abbreviazioni mentre il secondo elimina sistematicamente il tratto aggiuntivo delle specie delle parti dellrsquounitagrave Drsquoaltronde egli scrive ad esempio ΔΥ invece di ΔΥ ed egrave quindi indotto a porre la barra al di sopra della stringa di lettere risultante (passim ma si veda ad esempio il f 72r)
Fabio Acerbi156
denza il compendio per la desinenza -ον accentata il copista interpreta il segno come unrsquoabbreviazione ndash e di una barra a sormontare lo Υ Potremmo forse interpretarlo come il segno di contrazione del grafema -στ- lrsquounico tassello mancante in unrsquoabbreviazione come ad esempio (δυναμοδυναμο)(στ)(ὸν) ma uno scolio di prima mano al f 58v rela-tivo alle specie degli interi inficia questrsquoipotesi esse sono dotate di slash di sospensione accento acuto in un caso del compendio canonico per la terminazione -ον hellip ma tutti gli Υ a esponente sono a loro volta sormontati da una barra
Meno legata al singolo manoscritto ma nondimeno non uniforme si presenta la pratica di notazione dei segni che rappresentano gli enti numerici sessagesimali86 da una parte sta lrsquoevidenza del testo dei Pro-legomena e delle sue tabelle apici ndash drsquoaltronde come abbiamo visto la notazione universalmente impiegata per i numerali ordinali e per le fra-zioni unitarie ndash dallrsquoaltra sta lrsquoevidenza del testo dellrsquoAlmagesto in tutti i manoscritti piugrave antichi e lo stesso si dica del commentario teonino a questrsquoopera o del suo lsquoGrande commentariorsquo alle Tavole facili e dei testi astronomici su papiro barre87 Sembra insomma che la nostra docu-
86 Sia le molteplicitagrave che le specie ahimeacute entrambe rappresentate da lettere dellrsquoalfabeto Come osservato allrsquoinizio della sezione 3 ci sono in effetti due tipi di lettere numerali in gioco se facciamo astrazione da apici o barre lsquo4 minuti secondirsquo si trova scritto δ β la prima lettera numerale denota la molteplicitagrave degli item di una certa specie la se-conda la specie nei Prolegomena entrambe sono accompagnate da un doppio apice il che rende inutile la presenza delle seconde Si noti che la descrizione della tabella non fa parola della notazione da usare per le lettere numerali che denotano la molteplicitagrave barre o apici e quanti apici hellip In questo caso fa interamente fede la tabella cioegrave la pratica grafica condivisa instauratasi non egrave chiaro quando
87 I manoscritti piugrave antichi dellrsquoAlmagesto sono menzionati nella nota 10 supra quelli dei due commentarii teonini sono il Laur Plut 2818 e il celeberrimo Vat gr 190 (sec IX in Euclide Elementi Data Teone lsquoGrande commentariorsquo) per la notazione dei pa-piri astronomici si veda Jones 1999 II passim La notazione non sembra lsquoinquinatarsquo dalla pratica dei copisti bizantini e pare dipendere soltanto dalla data di composizione Tro-viamo ad esempio barre sopra tutti i numerali di molteplicitagrave (interi o sessagesimali) nel frammento di un commentario alle Tavole facili contenente un calcolo relativo al 24 aprile 213 (Par gr 2841 sec XIII ex-XIV in oltre al frammento ai ff 32r l 11-34v l 23 contiene Arato Phaenomena ed Efestione Apotelesmatica edizione in Jones 1990) Nel commentario alle Tavole facili composto ca 610-617 ed attribuito a Stefano di Alessandria la situazione egrave la seguente (Jean Lempire per litteras per lrsquoedizione si veda Lempire 2014 ho controllato il Vat gr 304 ff 135r-171v sec XIV am contiene in aggiunta Teone in Almagestum I-II lsquoPiccolo commentariorsquo alle Tavole facili Diofanto Arithmetica e De polygo-nis numeris varia astronomica tabulae) barre sopra gli interi sporadicamente rimpiazzate da apici apici sopra le parti sessagesimali in numero uguale alla denominazione doppio () apice per le frazioni unitarie Sono impiegate barre sopra gli interi e apici sopra le parti sessagesimali nei manoscritti principali di tutti i trattati di introduzione allrsquoAlmagesto o comunque di argomento logistico redatti in epoca bizantina Giorgio Pachimere (1242-ca 1310) Quadrivium (autografo nel manoscritto Roma Biblioteca Angelica gr 38 [RGK III nr 115] si veda Tannery ndash Steacutephanou 1940 per lrsquoedizione) Teodoro Metochita (1270-
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 157
mentazione si faccia testimone di un cambio notazionale avvenuto nel periodo intercorrente fra Teone (sec IV pm) e la scuola alessandrina di Ammonio e dei suoi allievi (sec VI in) e probabilmente innescato da questrsquoultimo ambiente lrsquoaspetto paradossale egrave che nello stesso codice si rintraccino due notazioni differenti per gli enti numerici sessagesimali e lrsquouna (apici) sia adottata sistematicamente e coerentemente in uno scritto (i Prolegomena) che si presenta esattamente come unrsquointroduzione tecnica alla pratica numerico-algoritmica del trattato (lrsquoAlmagesto) in cui egrave adottata lrsquoaltra (barre che ritroviamo senza eccezioni anche negli scolii)
Torniamo ai Prolegomena la descrizione del segno da porre a fianco di ogni singolo quoziente parziale e denotante la sua specie numerica (minuti primi minuti secondi ecc) solleva tre problemi
Primo problema Ci vuole una barra o un apice su τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquola lettera A [hellip] che significa la specieraquo quando lo scriviamo nella tabella Tutta la nostra discussione precedente fa pro-pendere per lrsquoapice e si ricordi anche la forma verbale ἀνατείνουσαν che suggerisce qualcosa che si lsquoestende verso lrsquoaltorsquo (la mia traduzione egrave volutamente neutra) se fosse apposta una barra la cosa dovrebbe passare
1231332) Compendium astronomicum (copia lsquoautorizzatarsquo coeva nei Vat gr 182 e 181 da parte del copista che integrograve le parti mancanti del Par gr 2389 [ff 207-210 255-270 374-375] Bianconi 2005a pp 425-427 Peacuterez Martiacuten 2008 p 436 e n 177) Teodoro Meliteniota (morto lrsquo831393) Tribiblos astronomica (autografo nel Vat gr 792 si vedano Leurquin 1991 per unrsquoanalisi del manoscritto Leurquin 1990 per lrsquoedizione) una com-pilazione anonima (per cui ho consultato il Par gr 2396 ff 87r-92v limitatamente a questi fogli manu Costantino Trivoli [RGK II nr 318 ma ovviamente questo codice non vi egrave segnalato] terzo quarto del XV secolo il resto del codice annotato da Niceforo Gregora egrave di etagrave planudea e parzialmente [ff 33v-76v] un autografo di Planude stesso contiene Teone in Almagestum I II IV Mondrain 2002 il codice va completato ndash limitatamente a stralci dei libri VIII-X XII-XIII del commentario teonino la cui parte intermedia si egrave persa ndash con 26 carte [ff 123-147] inserite nel Vat gr 1087 anchrsquoesso contenente anno-tazioni di Gregora Rome 1927 per la figura del copista dei ff 77r-86r del Par gr 2396 e dei ff appena nominati del Vat gr 1087 un anonimo collaboratore di Gregora si veda in ultimo Bianconi 2006a pp 147-151) si veda anche il calcolo effettuato da Niceforo Gre-gora (12921295-13581361) dellrsquoeclisse di sole del 16 luglio 1330 (attestata unicamente ai ff 1r-8v della miscellanea astronomica Marc gr 325 databile ca 1324-1329 in parte vergata e ovunque fittamente annotata da Gregora stesso edizione del testo in Mogenet et al 1983 annotazioni di Gregora elencate in Bianconi 2005a p 413) Unrsquoeccezione apparente il lsquoPiccolo commentariorsquo di Teone alle Tavole facili le parti sessagesimali sono segnalate da apici (ad esempio nel Vat gr 175 vergato da Giovanni Catrario e completato nel 1321-1322 sulla figura di Catrario si vedano in ultimo Bianconi 2005b pp 141-156 e 2006b) lrsquoopera egrave antica ma la sua tradizione non rimonta oltre la fine del XIII secolo a parte un frammento nel Leiden BPG 78 ff 156r-161v (minuscola del IX-X secolo) e in effetti in questo manoscritto tutti i numerali di molteplicitagrave sono sormontati da barre Unrsquoeccezione effettiva egrave il De hypotesibus planetarum nel Vat gr 1594 barre sugli interi e apici sulle parti sessagesimali
Fabio Acerbi158
sotto silenzio e la presenza dellrsquoapice la rende inutile88 Si tratta della stessa convenzione diofantea e coincide ancora con la notazione per i numerali ordinali e per le frazioni unitarie che egrave corrente nei mano- scritti matematici greci per questo motivo non percheacute la descrizione sia particolarmente perspicua nessuno dei copisti della recensione an-tica ha incertezze apici Ma questi apici si rintracciano soltanto sulle indicazioni di specie non contemplate dalla descrizione che sono ante-poste ai resti parziali a fianco dei quozienti parziali i segni di specie sono invece trasformati in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordi-nali corrispondenti del tipo πρωτ tavv 5 e 7b-8 Il recensore bizantino taglia invece la testa al toro elimina dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali elimina la seconda menzione della laquolet-tera Araquo contestualmente allrsquoazzeramento dellrsquoespediente della linea a zig-zag (si veda il punto seguente) modifica la descrizione che contiene la prima menzione in quella dellrsquoapice associato direttamente ai nume-rali di molteplicitagrave riciclando addirittura lrsquoalpha per adibirlo a desi-gnare un numero cardinale (come sorprendersi) τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ laquoponendo al di sopra di essi [scil dei 50 minuti primi] 1 solo lsaquoaccentorsaquo acutoraquo La scelta del recensore egrave assennata che rechi una barra o un apice in una tabella un alpha denota un numero non un numero drsquoordine
Secondo problema da tenere ben distinto dal precedente Cosa ci vuole sul segno α per la lettera alpha menzionata nella frase τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquolettera A [hellip] che significa la specieraquo89 Unrsquooc-chiata allrsquoapparato critico rivela una bella incertezza nei manoscritti Z scrive sempre ᾱ e in un caso lo fa anche P MS optano sempre per α´ C per α P scrive nellrsquoaltro caso αο Per quanto solo la barra sia congrua con il senso della frase in quanto la lettera alpha egrave qui menzionata (si tratta di un oggetto che compare nella tabella) e non cambia niente se essa egrave accompagnata dal suo nome di genere στοιχεῖον ad un livello grafico lrsquoincertezza fra il segno ᾱ che denota laquola lettera αraquo e il segno α´ (o lrsquoabbreviazione αο) per una forma di πρῶτος egrave per piugrave versi giustificata
88 Detto in altri termini la barra egrave uno strumento grafico non matematico e quindi la sua presenza non va segnalata mentre un apice lo egrave e la sua presenza lo deve
89 Notare che in questa frase il primo α non vuole la barra (egrave menzionato allrsquointerno di una frase che impiega convenzioni moderne) il secondo sigrave (idem ma con convenzioni antiche) ndash e nella traduzione la scelta di denotarlo con A (senza virgolette) e non con lsquoArsquo (con virgolette) egrave del tutto arbitraria ndash si noti inoltre che le necessarie precisazioni laquosenzacon virgoletteraquo mostrano che le lingue moderne palesano difficoltagrave analoghe a quelle del greco antico per quanto riguarda i livelli denotativi in ambito metadiscorsivo per non usare le due parentetiche avrei dovuto scrivere rispettivamente lsquoArsquo e lsquolsquoArsquorsquo (doppie virgolette semplici)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 159
ᾱ coincide con il numerale 1 α egrave la prima lettera dellrsquoalfabeto ed inoltre α´ egrave esattamente quello che va scritto nella tabella Potremmo dirci che il sostantivo στοιχεῖον chiude la questione la sua presenza congiunta ad un ipotetico α´ renderebbe la descrizione ridondante o inappropriata90 Ma a parte il fatto che α egrave proprio τὸ πρῶτον στοιχεῖον il segno α´ cat-tura in fondo il cuore della descrizione di uno στοιχεῖον ἔχον lsaquoγραμμὴνrsaquo ἀνατείνουσαν
Terzo problema Lrsquoautore dei Prolegomena che si arresta allrsquoesem-pio dei minuti primi non dice quanti apici occorre mettere sulle lettere numerali che identificano gli ordini superiori al primo se uno soltanto come nel caso diofanteo e delle frazioni unitarie o in numero uguale alla loro denominazione (cioegrave pari al numero denotato dal numerale stesso su cui vanno posti) come effettivamente avviene nei mano-scritti dei Prolegomena La tabella egrave quindi sottodeterminata dalla sua descrizione anzi in un certo senso prende il sopravvento su di essa la pratica di marcare i numerali di molteplicitagrave con gli apici che compe-tono allrsquoordine cui appartengono viene trasferita ai segni per gli ordini stessi per supplire ad una descrizione carente di questi ultimi E la tabella egrave sottodeterminata dalla descrizione in quanto egrave la descrizione di una tabella reale ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις laquocome nello lsaquoschemarsaquo espostoraquo leggiamo a un certo punto del testo
3) La linea a zig-zag Non possiamo che applaudire a questo geniale espediente grafico lo troviamo messo in opera solo nel Marc gr 313 Per quanto lrsquoautore non faccia parola di ciograve nel corso della sua descrizione la linea spezzata egrave intesa dover lsquosaltarersquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue Il copista del codice marciano effettua correttamente due salti nella prima delle sue tabelle (tav 4) ma inserisce un lsquodentersquo in piugrave in quella che considera corretta (tav 5) La linea a zig-zag egrave incompatibile con la presenza di linee di giustificazione nella tabella che in effetti mancano nel Marc gr 313 ciograve induce gli errori di allineamento dei primi 5 quozienti parziali di cui egrave vittima il copista Probabilmente per questo motivo in nessuno degli apografi del Vat gr 1594 la linea a zig-zag figura nella tabella inquadrata come si conviene da una (doppia) cornice esterna e le cui colonne sono appunto separate da linee verticali (tav 7b Vat gr 184 f 17v e tav 8 Par gr 2390 f 9v cui egrave sostanzialmente identica la tabella del Marc gr 314 che si trova
90 Trascuro lrsquoabbreviazione αο = πρῶτος percheacute la desinenza non egrave quella richiesta neacute nella frase (egrave richiesto πρῶτον) neacute nella tabella (πρῶτα)
Fabio Acerbi160
al f 248r ndash ma la mancanza di linee orizzontali causa un gigantesco pa-sticcio nel codice vaticano) Alla recensione bizantina che dipende per il suo testo di base dal Vat gr 1594 e quindi non trova la linea a zig-zag nella tabella non resta che sopprimere la sua descrizione ndash ma proprio per questo motivo e finalmente diventa possibile tracciare un apparato completo di linee di giustificazione (tav 9 Laur Plut 89 sup 48 f 14v) Dato che la descrizione di Teone di questo procedimento di divi-sione non fa cenno allrsquoesistenza della linea a zig-zag viene da chiedersi se essa non costituisca un espediente escogitato dallrsquoautore dei Prolegomena per vivacizzare la procedura originale di Pappo
4) Discrepanze tra descrizione e tabella Il gioco delle minime va-rianti mostra che la divisione era stata eseguita (e trasmessa) corret-tamente tutti i valori numerici sono esatti La tabella nel Marc gr 313 presenta perograve alcune discrepanze con la propria descrizione Essa omette (ma non nella versione lsquoscorrettarsquo lrsquoomissione non si riscontra neanche nel Par gr 2390) il segno per laquorestoraquo di fronte ai resti par-ziali ma aggiunge lrsquoindicazione della loro specie Essa trasforma invece come abbiamo visto le indicazioni di specie che seguono i quozienti parziali in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordinali corri-spondenti La descrizione prevede di chiudere la tabella con il risultato καὶ συνάγων ἅπαντα τὰ ἐκ τῶν μερισθέντων μερῶν λεπτὰ σημειοῦται ὑπὸ πάντας οὕτως γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoe raccogliendo tutti i minuti che provengono dalle parti divise lsaquoPapporsaquo nota sotto tutto cosigrave Ris 0 59 8 17 13 12 31raquo ma sotto la tabella tutta la tradizione ci consegna qualcosa di piugrave articolato ὁ ζητούμενος καθ᾽ ὃν μερίζεται ὁ τξε ιδ´ μη´´ π(αρὰ) τὸν τξ γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoil lsaquonumerorsaquo cercato secondo cui 365 14 48 egrave diviso per 360 risulta 0 59 8 17 13 12 31raquo frase che del resto contiene due errori lrsquoinversione del dividendo e del divisore e la confusione tra segno convenzionale (iuxta descrizione) e abbreviazione (come nella frase) nel caso di γι Oltre ad eliminare la linea a zig-zag91 la recensione bizantina sopprime dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali e modifica come abbiamo visto al punto 2 le loro descrizioni in quelle di apici associati diretta-mente ai numerali di molteplicitagrave
91 Le due righe che nella recensione di base contengono solo i resti parziali minori di 160 del divisore ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue sono in parte completate con lrsquoindicazione abbreviata ἀνάλ(υσις) laquoanalisiraquo il termine greco per questa procedura di riduzione In un sussulto di ipercorrettismo matematico tali resti parziali ridotti non sono preceduti dal segno per laquorestoraquo come nel Par gr 2390 ma da quello per laquorisultatoraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 161
Gli esempi che abbiamo discusso mostrano come i problemi di notazione pesino e non poco sullrsquoespressione discorsiva di un algorit-mo matematico lrsquoente di riferimento per lsquoformularersquo il procedimento di divisione fu considerata la tabella cioegrave un oggetto la cui costitu-zione egrave legata piugrave ad una pratica grafica che a considerazioni logico- algoritmiche non la sua descrizione che in effetti finisce per determi-nare la tabella in maniera non univoca Di questa sottodeterminazione si fa testimone la traiettoria che abbiamo cercato di seguire nelle mani di copisti e revisori il procedimento di divisione si modifica a volte in aspetti secondari a volte in punti piugrave sostanziali ndash fino a rendere neces-saria una radicale revisione della sua descrizione per renderla conforme alla tabella ndash in ogni caso mai per ragioni squisitamente matematiche92
Abstract
The article presents and discusses in detail two passages from the anonymous Prolegomena to the Almagest a VIth century primer to the elementary procedures of calculation needed in Ptolemyrsquos Almagest In the two passages we may follow the complex interplay between mathematical notation the auctor who employed and described it the tachygrapher who transcribed it in vivo copyists who reproduced it correctors who modified it Along this path misgivings and errors arise in the transmission of abbreviations and paratextual units such as diagrams tables operational schemes
Fabio AcerbiCNRS UMR8560 Centre Alexandre Koyreacute
fabacerbigmailcom
92 Sono grato a Daniele Bianconi Lucio del Corso Jean Lempire per alcune preziose indicazioni
AOO = Archimedis opera omnia cum commentariis Eutocii ed J L Heiberg I-III Lipsiae 1910-1915
DOO = Diophanti Alexandrini opera omnia cum Graecis commentariis ed P Tannery I-II Lipsiae 1893-1895
GC = Le laquoGrand Commentaireraquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Mogenet ndash A Tihon I-III Cittagrave del Vaticano 1985-1999
iA = Commentaires de Pappus et de Theacuteon drsquoAlexandrie sur lrsquoAlmageste ed A Rome I-III con paginazione continua Cittagrave del Vaticano 1931-1943
HOO = Heronis Alexandrini opera quae supersunt omnia ed G Schmidt ndash L Nix ndash W Schmidt ndash H Schoene ndash J L Heiberg I-V Lipsiae 1899-1914
PC = Le ldquoPetit Commentairerdquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed A Tihon Cittagrave del Vaticano 1978
POO = Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia ed J L Heiberg I-II in 3 parti Lipsiae 1898-1907
RGK = Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600 I Handschriften aus Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln II Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs und Nachtraumlge zu den Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln III Handschriften aus Bibliotheken Roms mit dem Vatikan A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg unter Mitarbeit von D Harlfinger und P Eleuteri B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln Wien 1981-1997 (Oumlsterreichische Akademie der Wissenschaften Veroumlffentlichungen der Kommission fuumlr Byzantinistik III1-3 A-C)
Sigla
Acerbi 2010 = F Acerbi Il silenzio delle sirene La matematica greca antica Roma 2010
Acerbi 2012 = F Acerbi I codici stilistici della matematica greca dimostrazioni procedure algoritmi laquoQUCCraquo 1012 (2012) pp 167-214
Acerbi et al 2010 = F Acerbi ndash N Vinel ndash B Vitrac Les Proleacutegomegravenes agrave lrsquoAlmageste Une eacutedition agrave partir des manuscrits les plus anciens Introduction geacuteneacuterale ndash Parties I-III laquoSCIAMVSraquo 11 (2010) pp 53-210
Agati 1992 = M L Agati La minuscola laquoBouleteacuteeraquo Cittagrave del Vaticano 1992
Belger 1881 = C Belger Ein neues Fragmentum mathematicum Bobiense laquoHermesraquo 16 (1881) pp 261-284
Bianconi 2005a = D Bianconi La biblioteca di Cora tra Massimo Planude e Niceforo Gregora Una questione di mani laquoSampTraquo 3 (2005) pp 391-438
Bianconi 2005b = D Bianconi Tessalonica nellrsquoetagrave dei Paleologi Le pratiche intellettuali nel riflesso della cultura scritta Paris 2005
Bianconi 2006a = D Bianconi Le pietre e il ponte ovvero identificazioni di mani e storia della cultura laquoBizantinisticaraquo 8 (2006) pp 135-181
Bianconi 2006b = D Bianconi Qualcosa di nuovo su Giovanni Catrario laquoMEGraquo 6 (2006) pp 69-91
Cavallo 1977 = G Cavallo Funzione e strutture della maiuscola greca tra i secoli VIII-XI in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Colloque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 95-137
Cereteli 1904 = G F Cereteli De compendiis scripturae codicum Graecorum praecipue Petropolitanorum et Mosquensium anni nota instructorum Sankt-Petersburg 1904
De Gregorio 2000 = G De Gregorio Materiali vecchi e nuovi per uno studio della minu-scola greca fra VII e IX secolo in G Prato (a cura di) I manoscritti greci tra riflessione e dibattito Atti del V Colloquio Internazionale di Paleografia Greca Cremona 4-10 ottobre 1998 Firenze 2000 pp 83-151
Follieri 1977 = E Follieri La minuscola libraria dei secoli IX e X in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Col-loque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 139-165
Fonkič 2005 = B Fonkič Venecianskaia rukopisrsquo laquoAlrsquomagestaraquo Ptolemeja (Marc gr 313690) o datirovke i proischoždenii kodeksa laquoVDIraquo s III 254 (2005) pp 162-167
Fowler 1999 = D H Fowler The Mathematics of Platorsquos Academy A New Reconstruction Second Edition Oxford 1999
Bibliografia
Fabio Acerbi164
Gerstinger ndash Vogel 1932 = H Gerstinger ndash K Vogel Eine stereometrische Aufgaben-sammlung im Papyrus Graecus [sic] Vindobonensis 19996 laquoMitteilungen aus der Papy-russammlung der Nationalbibliothek in Wienraquo Neue Serie Folge 1 Griechische literarische Papyri 1 Wien 1932 pp 11-76
Heiberg 1927 = Mathematici Graeci Minores ed J L Heiberg Kjoslashbenhavn 1927
Hultsch 1876-1878 = Pappi Alexandrini Collectionis quae supersunt ed F Hultsch I-III Berlin 1876-1878
Janz 2003 = T Janz The Scribes and the Date of the Vat gr 1291 in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae X Cittagrave del Vaticano 2003 pp 159-180
Jones 1990 = Ptolemyrsquos First Commentator ed A Jones Philadelphia 1990
Jones 1999 = Astronomical Papyri from Oxyrhynchus ed A Jones I-II Philadelphia 1999
Jones 2005 = A Jones Ptolemyrsquos Canobic Inscription and Heliodorusrsquo Observation Reports laquoSCIAMVSraquo 6 (2005) pp 53-97
Lempire 2014 = Steacutephanos drsquoAlexandrie Le commentaire aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Lempire Louvain 2014
Leurquin 1990 = Theacuteodore Meacuteliteacuteniote Tribiblos astronomique Livre I ed R Leurquin Amsterdam 1990
Leurquin 1991 = R Leurquin Un manuscrit autographe de la Tribiblos Astronomique de Theacuteodore Meacuteliteacuteniote le Vaticanus graecus 792 laquoScriptoriumraquo 45 (1991) pp 145-162
Maas 1927 = P Maas Griechische Palaeographie in A Gercke ndash E Norden (hrsg von) Einleitung in die Altertumswissenschaft I9 Leipzig 1927 pp 69-80
Martinelli Tempesta 2010 = S Martinelli Tempesta Il codice Milano Biblioteca Am-brosiana B 75 sup (gr 104) e lrsquoevoluzione della scrittura di Giovanni Scutariota in A B Garciacutea ndash I Peacuterez Martiacuten (ed by) The Legacy of Bernard de Montfaucon Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting Proceedings of the Seventh Inter-national Colloquium of Greek Palaeography Madrid-Salamanca 15-20 September 2008 Turnhout 2010 pp 171-186
Mazzucchi 1994 = C M Mazzucchi Leggere i classici durante la catastrofe (Costantino-poli maggio-agosto 1203) le note marginali al Diodoro Siculo Vaticano gr 130 Parte prima stratigrafia laquoAevumraquo 68 (1994) pp 164-218
Mioni 1976 = E Mioni Bessarione scriba e alcuni suoi collaboratori in Miscellanea marcia-na di studi bessarionei Padova 1976 pp 263-323
Mioni 1985 = Codices graeci manuscripti Bibliothecae Divi Marci Venetiarum II Thesaurus Antiquus Codices 300-625 recensuit E Mioni Roma 1985
Mogenet 1962 = J Mogenet Une scholie ineacutedite du Vat gr 1594 sur les rapports entre lrsquoastronomie arabe et Byzance laquoOsirisraquo 14 (1962) pp 198-221
Mogenet et al 1983 = Niceacutephore Greacutegoras Calcul de lrsquoeacuteclipse de soleil du 16 juillet 1330 ed J Mogenet ndash A Tihon ndash R Royez ndash A Berg Amsterdam 1983
Mondrain 2002 = B Mondrain Maxime Planude Niceacutephore Greacutegoras et Ptoleacutemeacutee laquoPa-laeoslavicaraquo 10 (2002) pp 312-322
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 165
Mondrain 2004 = B Mondrain Lrsquoancien empereur Jean VI Cantacuzegravene et ses copistes in A Rigo (a cura di) Gregorio Palamas e oltre Studi e documenti sulle controversie teologiche del XIV secolo bizantino Firenze 2004 pp 249-296
Mondrain 2007 = B Mondrain Les eacutecritures dans les manuscrits byzantins du XIV e siegravecle Quelques probleacutematiques laquoRSBNraquo n s 44 (2007) pp 157-196
Peacuterez Martiacuten 2006 = I Peacuterez Martiacuten Maxime Planude et le Diophantus Matritensis (Madrid Biblioteca Nacional ms 4678) un paradigme de la reacutecupeacuteration des textes anciens dans la ldquorenaissance paleacuteologuerdquo laquoByzantionraquo 76 (2006) pp 433-462
Peacuterez Martiacuten 2008 = I Peacuterez Martiacuten El lsquoestilo Hodegosrsquo y su proyeccioacuten en las escrituras constantinopolitanas laquoSampTraquo 6 (2008) pp 389-458
Perria 1991 = L Perria Scrittura e ornamentazione nei codici della laquocollezione filosoficaraquo laquoRSBNraquo n s 28 (1991) pp 45-111
Rollo 2012 = A Rollo LrsquoArchimede di Giorgio Valla in V Fera ndash D Gionta ndash A Rollo (a cura di) Archimede e le sue fortune Atti del Convegno di Siracusa-Messina 24-26 giugno 2008 Messina 2012 pp 99-147
Rome 1927 = A Rome Membra disjecta laquoRBenraquo 39 (1927) pp 187-188
Rome 1938 = A Rome Un manuscrit de la bibliothegraveque de Boniface VIII agrave la Meacutediceacuteenne de Florence laquoACraquo 7 (1938) pp 261-268
Ronconi 2013 = F Ronconi La collection philosophique un fantocircme historique laquoScripto-riumraquo 67 (2013) pp 119-140
Tannery ndash Steacutephanou 1940 = Quadrivium de Georges Pachymegravere ed P Tannery ndash E Steacutephanou Cittagrave del Vaticano 1940
Tihon 2011 = Πτολεμαίου Πρόχειροι Κανόνες Les Tables faciles de Ptoleacutemeacutee vol Ia Tables A1-A2 ed A Tihon Leuven 2011
Traube 1907 = L Traube Nomina Sacra Versuch einer Geschichte der christlichen Kuumlrzung Muumlnchen 1907
Vogel 1936 = K Vogel Beitraumlge zur griechischen Logistik laquoSBAWraquo Mathematisch-natur-wissenschaftliche Abteilung Jahrgang 1936 pp 357-472
Wouters 1979 = A Wouters The Grammatical Papyri from Graeco-Roman Egypt Contri-butions to the Study of the lsquoArs Grammaticarsquo in Antiquity Brussel 1979
F ACERBI Tav 1
b Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 65r
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 284 f 160r
F ACERBITav 2
b Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 13r
a Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 19v
F ACERBI Tav 3
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 136v
F ACERBITav 4
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17r
F ACERBI Tav 5
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17v
F ACERBITav 6
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 7v
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 155
Diofanto introduce poi dei segni anche per le specie delle parti dellrsquounitagrave (le nostre frazioni) che egli chiama ὁμώνυμα μορία laquoparti omonimeraquo di cui quelle sessagesimali sono casi particolari81 Egli spie-ga appunto che le loro denominazioni sono ottenute da quelle delle specie degli interi per sinonimia passando ad un lsquoordinalersquo82 formato semplicemente aggiungendo il suffisso -στον δυναμοστόν κυβοστόν δυναμοδυναμοστόν ecc (sott μόριον) I loro segni convenzionali sono invece ottenuti da quelli per le specie degli interi aggiungendo una γραμμὴν διαστέλλουσαν τὸ εἶδος laquolinea che distingue la specieraquo83 Una linea sui segni delle specie delle parti egrave richiesta si badi bene per distinguerli dai segni di quelle degli interi come giagrave osservato questi ultimi sono giagrave lsquoagrammaticalirsquo a causa della presenza dellrsquoἐπίσημον a fortiori lo saranno anche i primi Si tratta della traduzione semio-tica del passaggio dal cardinale allrsquoordinale che a livello grammaticale egrave effettuato con il suffisso -στον Che forma ha questa linea Barra o apice (Egrave cervellotico pensare a forme piugrave complesse) La domanda non ammette una risposta immediata in quanto delle specie diofantee nessuno piugrave si occupa nellrsquoantichitagrave84 Se egrave vero che la prima risposta darebbe origine ad un conflitto tra due convenzioni denotative diffe-renti la barra lsquocitazionalersquo e la barra che distingue la specie lrsquoevidenza grafica del Matritensis lascia lievemente sgomenti (ricordiamoci che giagrave i segni di base sono indebitamente dotati di un accento dal copista) Le poche occorrenze del segno per le specie delle parti85 vedono lrsquoaggiunta di uno slash di sospensione di un doppio apice inverso ndash in tutta evi-
81 Questo fatto era giagrave chiaro nellrsquoantichitagrave Teone in Alm I 10 in iA p 45310-1682 Il parallelo con i cardinali e gli ordinali relativi agli interi egrave reso esplicito da Dio-
fanto ὥσπερ δὲ τῶν ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια παρομοίως καλεῖται τοῖς ἀριθμοῖς τοῦ μὲν τρία τὸ τρίτον τοῦ δὲ τέσσαρα τὸ τέταρτον οὕτως καὶ τῶν νῦν ἐπονομασθέντων ἀριθμῶν τὰ ὁμώνυμα μόρια κληθήσεται παρομοίως τοῖς ἀριθμοῖς laquocome le parti omonime dei numeri sono chia-mate per assonanza con i numeri di lsquotrersquo lsquolsaquounrsaquo terzorsquo di lsquoquattrorsquo lsquolsaquounrsaquo quartorsquo cosigrave le parti omonime dei numeri appena nominati saranno chiamate per assonanza con i numeriraquo (DOO I p 69-13 si noti lrsquoarticolo lsquocitazionalersquo al singolare in τοῦ τρία e τοῦ τέσσαρα) Il parallelo prosegue anche al livello dei segni che rappresentano queste specie come vedremo tra un attimo
83 Diofanto Arithmetica prefazione in DOO I p 620-21 un passaggio maltrattato in questa edizione occorre espungere il participio ἔχον senza introdurre segni ulteriori oppure eliminare un precedente ἐπί come fa un correttore del Matritensis f 58v
84 Unica parzialissima eccezione lrsquoaccenno di Teone menzionato nella nota 81 supra85 Al f 59r e per di piugrave nel margine per sanare un lungo saut du mecircme au mecircme La
collocazione in margine egrave il motivo per cui troviamo una notazione abbreviata nel resto del trattato il primo copista scioglie tutti i segni prendendoli per abbreviazioni mentre il secondo elimina sistematicamente il tratto aggiuntivo delle specie delle parti dellrsquounitagrave Drsquoaltronde egli scrive ad esempio ΔΥ invece di ΔΥ ed egrave quindi indotto a porre la barra al di sopra della stringa di lettere risultante (passim ma si veda ad esempio il f 72r)
Fabio Acerbi156
denza il compendio per la desinenza -ον accentata il copista interpreta il segno come unrsquoabbreviazione ndash e di una barra a sormontare lo Υ Potremmo forse interpretarlo come il segno di contrazione del grafema -στ- lrsquounico tassello mancante in unrsquoabbreviazione come ad esempio (δυναμοδυναμο)(στ)(ὸν) ma uno scolio di prima mano al f 58v rela-tivo alle specie degli interi inficia questrsquoipotesi esse sono dotate di slash di sospensione accento acuto in un caso del compendio canonico per la terminazione -ον hellip ma tutti gli Υ a esponente sono a loro volta sormontati da una barra
Meno legata al singolo manoscritto ma nondimeno non uniforme si presenta la pratica di notazione dei segni che rappresentano gli enti numerici sessagesimali86 da una parte sta lrsquoevidenza del testo dei Pro-legomena e delle sue tabelle apici ndash drsquoaltronde come abbiamo visto la notazione universalmente impiegata per i numerali ordinali e per le fra-zioni unitarie ndash dallrsquoaltra sta lrsquoevidenza del testo dellrsquoAlmagesto in tutti i manoscritti piugrave antichi e lo stesso si dica del commentario teonino a questrsquoopera o del suo lsquoGrande commentariorsquo alle Tavole facili e dei testi astronomici su papiro barre87 Sembra insomma che la nostra docu-
86 Sia le molteplicitagrave che le specie ahimeacute entrambe rappresentate da lettere dellrsquoalfabeto Come osservato allrsquoinizio della sezione 3 ci sono in effetti due tipi di lettere numerali in gioco se facciamo astrazione da apici o barre lsquo4 minuti secondirsquo si trova scritto δ β la prima lettera numerale denota la molteplicitagrave degli item di una certa specie la se-conda la specie nei Prolegomena entrambe sono accompagnate da un doppio apice il che rende inutile la presenza delle seconde Si noti che la descrizione della tabella non fa parola della notazione da usare per le lettere numerali che denotano la molteplicitagrave barre o apici e quanti apici hellip In questo caso fa interamente fede la tabella cioegrave la pratica grafica condivisa instauratasi non egrave chiaro quando
87 I manoscritti piugrave antichi dellrsquoAlmagesto sono menzionati nella nota 10 supra quelli dei due commentarii teonini sono il Laur Plut 2818 e il celeberrimo Vat gr 190 (sec IX in Euclide Elementi Data Teone lsquoGrande commentariorsquo) per la notazione dei pa-piri astronomici si veda Jones 1999 II passim La notazione non sembra lsquoinquinatarsquo dalla pratica dei copisti bizantini e pare dipendere soltanto dalla data di composizione Tro-viamo ad esempio barre sopra tutti i numerali di molteplicitagrave (interi o sessagesimali) nel frammento di un commentario alle Tavole facili contenente un calcolo relativo al 24 aprile 213 (Par gr 2841 sec XIII ex-XIV in oltre al frammento ai ff 32r l 11-34v l 23 contiene Arato Phaenomena ed Efestione Apotelesmatica edizione in Jones 1990) Nel commentario alle Tavole facili composto ca 610-617 ed attribuito a Stefano di Alessandria la situazione egrave la seguente (Jean Lempire per litteras per lrsquoedizione si veda Lempire 2014 ho controllato il Vat gr 304 ff 135r-171v sec XIV am contiene in aggiunta Teone in Almagestum I-II lsquoPiccolo commentariorsquo alle Tavole facili Diofanto Arithmetica e De polygo-nis numeris varia astronomica tabulae) barre sopra gli interi sporadicamente rimpiazzate da apici apici sopra le parti sessagesimali in numero uguale alla denominazione doppio () apice per le frazioni unitarie Sono impiegate barre sopra gli interi e apici sopra le parti sessagesimali nei manoscritti principali di tutti i trattati di introduzione allrsquoAlmagesto o comunque di argomento logistico redatti in epoca bizantina Giorgio Pachimere (1242-ca 1310) Quadrivium (autografo nel manoscritto Roma Biblioteca Angelica gr 38 [RGK III nr 115] si veda Tannery ndash Steacutephanou 1940 per lrsquoedizione) Teodoro Metochita (1270-
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 157
mentazione si faccia testimone di un cambio notazionale avvenuto nel periodo intercorrente fra Teone (sec IV pm) e la scuola alessandrina di Ammonio e dei suoi allievi (sec VI in) e probabilmente innescato da questrsquoultimo ambiente lrsquoaspetto paradossale egrave che nello stesso codice si rintraccino due notazioni differenti per gli enti numerici sessagesimali e lrsquouna (apici) sia adottata sistematicamente e coerentemente in uno scritto (i Prolegomena) che si presenta esattamente come unrsquointroduzione tecnica alla pratica numerico-algoritmica del trattato (lrsquoAlmagesto) in cui egrave adottata lrsquoaltra (barre che ritroviamo senza eccezioni anche negli scolii)
Torniamo ai Prolegomena la descrizione del segno da porre a fianco di ogni singolo quoziente parziale e denotante la sua specie numerica (minuti primi minuti secondi ecc) solleva tre problemi
Primo problema Ci vuole una barra o un apice su τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquola lettera A [hellip] che significa la specieraquo quando lo scriviamo nella tabella Tutta la nostra discussione precedente fa pro-pendere per lrsquoapice e si ricordi anche la forma verbale ἀνατείνουσαν che suggerisce qualcosa che si lsquoestende verso lrsquoaltorsquo (la mia traduzione egrave volutamente neutra) se fosse apposta una barra la cosa dovrebbe passare
1231332) Compendium astronomicum (copia lsquoautorizzatarsquo coeva nei Vat gr 182 e 181 da parte del copista che integrograve le parti mancanti del Par gr 2389 [ff 207-210 255-270 374-375] Bianconi 2005a pp 425-427 Peacuterez Martiacuten 2008 p 436 e n 177) Teodoro Meliteniota (morto lrsquo831393) Tribiblos astronomica (autografo nel Vat gr 792 si vedano Leurquin 1991 per unrsquoanalisi del manoscritto Leurquin 1990 per lrsquoedizione) una com-pilazione anonima (per cui ho consultato il Par gr 2396 ff 87r-92v limitatamente a questi fogli manu Costantino Trivoli [RGK II nr 318 ma ovviamente questo codice non vi egrave segnalato] terzo quarto del XV secolo il resto del codice annotato da Niceforo Gregora egrave di etagrave planudea e parzialmente [ff 33v-76v] un autografo di Planude stesso contiene Teone in Almagestum I II IV Mondrain 2002 il codice va completato ndash limitatamente a stralci dei libri VIII-X XII-XIII del commentario teonino la cui parte intermedia si egrave persa ndash con 26 carte [ff 123-147] inserite nel Vat gr 1087 anchrsquoesso contenente anno-tazioni di Gregora Rome 1927 per la figura del copista dei ff 77r-86r del Par gr 2396 e dei ff appena nominati del Vat gr 1087 un anonimo collaboratore di Gregora si veda in ultimo Bianconi 2006a pp 147-151) si veda anche il calcolo effettuato da Niceforo Gre-gora (12921295-13581361) dellrsquoeclisse di sole del 16 luglio 1330 (attestata unicamente ai ff 1r-8v della miscellanea astronomica Marc gr 325 databile ca 1324-1329 in parte vergata e ovunque fittamente annotata da Gregora stesso edizione del testo in Mogenet et al 1983 annotazioni di Gregora elencate in Bianconi 2005a p 413) Unrsquoeccezione apparente il lsquoPiccolo commentariorsquo di Teone alle Tavole facili le parti sessagesimali sono segnalate da apici (ad esempio nel Vat gr 175 vergato da Giovanni Catrario e completato nel 1321-1322 sulla figura di Catrario si vedano in ultimo Bianconi 2005b pp 141-156 e 2006b) lrsquoopera egrave antica ma la sua tradizione non rimonta oltre la fine del XIII secolo a parte un frammento nel Leiden BPG 78 ff 156r-161v (minuscola del IX-X secolo) e in effetti in questo manoscritto tutti i numerali di molteplicitagrave sono sormontati da barre Unrsquoeccezione effettiva egrave il De hypotesibus planetarum nel Vat gr 1594 barre sugli interi e apici sulle parti sessagesimali
Fabio Acerbi158
sotto silenzio e la presenza dellrsquoapice la rende inutile88 Si tratta della stessa convenzione diofantea e coincide ancora con la notazione per i numerali ordinali e per le frazioni unitarie che egrave corrente nei mano- scritti matematici greci per questo motivo non percheacute la descrizione sia particolarmente perspicua nessuno dei copisti della recensione an-tica ha incertezze apici Ma questi apici si rintracciano soltanto sulle indicazioni di specie non contemplate dalla descrizione che sono ante-poste ai resti parziali a fianco dei quozienti parziali i segni di specie sono invece trasformati in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordi-nali corrispondenti del tipo πρωτ tavv 5 e 7b-8 Il recensore bizantino taglia invece la testa al toro elimina dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali elimina la seconda menzione della laquolet-tera Araquo contestualmente allrsquoazzeramento dellrsquoespediente della linea a zig-zag (si veda il punto seguente) modifica la descrizione che contiene la prima menzione in quella dellrsquoapice associato direttamente ai nume-rali di molteplicitagrave riciclando addirittura lrsquoalpha per adibirlo a desi-gnare un numero cardinale (come sorprendersi) τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ laquoponendo al di sopra di essi [scil dei 50 minuti primi] 1 solo lsaquoaccentorsaquo acutoraquo La scelta del recensore egrave assennata che rechi una barra o un apice in una tabella un alpha denota un numero non un numero drsquoordine
Secondo problema da tenere ben distinto dal precedente Cosa ci vuole sul segno α per la lettera alpha menzionata nella frase τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquolettera A [hellip] che significa la specieraquo89 Unrsquooc-chiata allrsquoapparato critico rivela una bella incertezza nei manoscritti Z scrive sempre ᾱ e in un caso lo fa anche P MS optano sempre per α´ C per α P scrive nellrsquoaltro caso αο Per quanto solo la barra sia congrua con il senso della frase in quanto la lettera alpha egrave qui menzionata (si tratta di un oggetto che compare nella tabella) e non cambia niente se essa egrave accompagnata dal suo nome di genere στοιχεῖον ad un livello grafico lrsquoincertezza fra il segno ᾱ che denota laquola lettera αraquo e il segno α´ (o lrsquoabbreviazione αο) per una forma di πρῶτος egrave per piugrave versi giustificata
88 Detto in altri termini la barra egrave uno strumento grafico non matematico e quindi la sua presenza non va segnalata mentre un apice lo egrave e la sua presenza lo deve
89 Notare che in questa frase il primo α non vuole la barra (egrave menzionato allrsquointerno di una frase che impiega convenzioni moderne) il secondo sigrave (idem ma con convenzioni antiche) ndash e nella traduzione la scelta di denotarlo con A (senza virgolette) e non con lsquoArsquo (con virgolette) egrave del tutto arbitraria ndash si noti inoltre che le necessarie precisazioni laquosenzacon virgoletteraquo mostrano che le lingue moderne palesano difficoltagrave analoghe a quelle del greco antico per quanto riguarda i livelli denotativi in ambito metadiscorsivo per non usare le due parentetiche avrei dovuto scrivere rispettivamente lsquoArsquo e lsquolsquoArsquorsquo (doppie virgolette semplici)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 159
ᾱ coincide con il numerale 1 α egrave la prima lettera dellrsquoalfabeto ed inoltre α´ egrave esattamente quello che va scritto nella tabella Potremmo dirci che il sostantivo στοιχεῖον chiude la questione la sua presenza congiunta ad un ipotetico α´ renderebbe la descrizione ridondante o inappropriata90 Ma a parte il fatto che α egrave proprio τὸ πρῶτον στοιχεῖον il segno α´ cat-tura in fondo il cuore della descrizione di uno στοιχεῖον ἔχον lsaquoγραμμὴνrsaquo ἀνατείνουσαν
Terzo problema Lrsquoautore dei Prolegomena che si arresta allrsquoesem-pio dei minuti primi non dice quanti apici occorre mettere sulle lettere numerali che identificano gli ordini superiori al primo se uno soltanto come nel caso diofanteo e delle frazioni unitarie o in numero uguale alla loro denominazione (cioegrave pari al numero denotato dal numerale stesso su cui vanno posti) come effettivamente avviene nei mano-scritti dei Prolegomena La tabella egrave quindi sottodeterminata dalla sua descrizione anzi in un certo senso prende il sopravvento su di essa la pratica di marcare i numerali di molteplicitagrave con gli apici che compe-tono allrsquoordine cui appartengono viene trasferita ai segni per gli ordini stessi per supplire ad una descrizione carente di questi ultimi E la tabella egrave sottodeterminata dalla descrizione in quanto egrave la descrizione di una tabella reale ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις laquocome nello lsaquoschemarsaquo espostoraquo leggiamo a un certo punto del testo
3) La linea a zig-zag Non possiamo che applaudire a questo geniale espediente grafico lo troviamo messo in opera solo nel Marc gr 313 Per quanto lrsquoautore non faccia parola di ciograve nel corso della sua descrizione la linea spezzata egrave intesa dover lsquosaltarersquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue Il copista del codice marciano effettua correttamente due salti nella prima delle sue tabelle (tav 4) ma inserisce un lsquodentersquo in piugrave in quella che considera corretta (tav 5) La linea a zig-zag egrave incompatibile con la presenza di linee di giustificazione nella tabella che in effetti mancano nel Marc gr 313 ciograve induce gli errori di allineamento dei primi 5 quozienti parziali di cui egrave vittima il copista Probabilmente per questo motivo in nessuno degli apografi del Vat gr 1594 la linea a zig-zag figura nella tabella inquadrata come si conviene da una (doppia) cornice esterna e le cui colonne sono appunto separate da linee verticali (tav 7b Vat gr 184 f 17v e tav 8 Par gr 2390 f 9v cui egrave sostanzialmente identica la tabella del Marc gr 314 che si trova
90 Trascuro lrsquoabbreviazione αο = πρῶτος percheacute la desinenza non egrave quella richiesta neacute nella frase (egrave richiesto πρῶτον) neacute nella tabella (πρῶτα)
Fabio Acerbi160
al f 248r ndash ma la mancanza di linee orizzontali causa un gigantesco pa-sticcio nel codice vaticano) Alla recensione bizantina che dipende per il suo testo di base dal Vat gr 1594 e quindi non trova la linea a zig-zag nella tabella non resta che sopprimere la sua descrizione ndash ma proprio per questo motivo e finalmente diventa possibile tracciare un apparato completo di linee di giustificazione (tav 9 Laur Plut 89 sup 48 f 14v) Dato che la descrizione di Teone di questo procedimento di divi-sione non fa cenno allrsquoesistenza della linea a zig-zag viene da chiedersi se essa non costituisca un espediente escogitato dallrsquoautore dei Prolegomena per vivacizzare la procedura originale di Pappo
4) Discrepanze tra descrizione e tabella Il gioco delle minime va-rianti mostra che la divisione era stata eseguita (e trasmessa) corret-tamente tutti i valori numerici sono esatti La tabella nel Marc gr 313 presenta perograve alcune discrepanze con la propria descrizione Essa omette (ma non nella versione lsquoscorrettarsquo lrsquoomissione non si riscontra neanche nel Par gr 2390) il segno per laquorestoraquo di fronte ai resti par-ziali ma aggiunge lrsquoindicazione della loro specie Essa trasforma invece come abbiamo visto le indicazioni di specie che seguono i quozienti parziali in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordinali corri-spondenti La descrizione prevede di chiudere la tabella con il risultato καὶ συνάγων ἅπαντα τὰ ἐκ τῶν μερισθέντων μερῶν λεπτὰ σημειοῦται ὑπὸ πάντας οὕτως γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoe raccogliendo tutti i minuti che provengono dalle parti divise lsaquoPapporsaquo nota sotto tutto cosigrave Ris 0 59 8 17 13 12 31raquo ma sotto la tabella tutta la tradizione ci consegna qualcosa di piugrave articolato ὁ ζητούμενος καθ᾽ ὃν μερίζεται ὁ τξε ιδ´ μη´´ π(αρὰ) τὸν τξ γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoil lsaquonumerorsaquo cercato secondo cui 365 14 48 egrave diviso per 360 risulta 0 59 8 17 13 12 31raquo frase che del resto contiene due errori lrsquoinversione del dividendo e del divisore e la confusione tra segno convenzionale (iuxta descrizione) e abbreviazione (come nella frase) nel caso di γι Oltre ad eliminare la linea a zig-zag91 la recensione bizantina sopprime dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali e modifica come abbiamo visto al punto 2 le loro descrizioni in quelle di apici associati diretta-mente ai numerali di molteplicitagrave
91 Le due righe che nella recensione di base contengono solo i resti parziali minori di 160 del divisore ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue sono in parte completate con lrsquoindicazione abbreviata ἀνάλ(υσις) laquoanalisiraquo il termine greco per questa procedura di riduzione In un sussulto di ipercorrettismo matematico tali resti parziali ridotti non sono preceduti dal segno per laquorestoraquo come nel Par gr 2390 ma da quello per laquorisultatoraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 161
Gli esempi che abbiamo discusso mostrano come i problemi di notazione pesino e non poco sullrsquoespressione discorsiva di un algorit-mo matematico lrsquoente di riferimento per lsquoformularersquo il procedimento di divisione fu considerata la tabella cioegrave un oggetto la cui costitu-zione egrave legata piugrave ad una pratica grafica che a considerazioni logico- algoritmiche non la sua descrizione che in effetti finisce per determi-nare la tabella in maniera non univoca Di questa sottodeterminazione si fa testimone la traiettoria che abbiamo cercato di seguire nelle mani di copisti e revisori il procedimento di divisione si modifica a volte in aspetti secondari a volte in punti piugrave sostanziali ndash fino a rendere neces-saria una radicale revisione della sua descrizione per renderla conforme alla tabella ndash in ogni caso mai per ragioni squisitamente matematiche92
Abstract
The article presents and discusses in detail two passages from the anonymous Prolegomena to the Almagest a VIth century primer to the elementary procedures of calculation needed in Ptolemyrsquos Almagest In the two passages we may follow the complex interplay between mathematical notation the auctor who employed and described it the tachygrapher who transcribed it in vivo copyists who reproduced it correctors who modified it Along this path misgivings and errors arise in the transmission of abbreviations and paratextual units such as diagrams tables operational schemes
Fabio AcerbiCNRS UMR8560 Centre Alexandre Koyreacute
fabacerbigmailcom
92 Sono grato a Daniele Bianconi Lucio del Corso Jean Lempire per alcune preziose indicazioni
AOO = Archimedis opera omnia cum commentariis Eutocii ed J L Heiberg I-III Lipsiae 1910-1915
DOO = Diophanti Alexandrini opera omnia cum Graecis commentariis ed P Tannery I-II Lipsiae 1893-1895
GC = Le laquoGrand Commentaireraquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Mogenet ndash A Tihon I-III Cittagrave del Vaticano 1985-1999
iA = Commentaires de Pappus et de Theacuteon drsquoAlexandrie sur lrsquoAlmageste ed A Rome I-III con paginazione continua Cittagrave del Vaticano 1931-1943
HOO = Heronis Alexandrini opera quae supersunt omnia ed G Schmidt ndash L Nix ndash W Schmidt ndash H Schoene ndash J L Heiberg I-V Lipsiae 1899-1914
PC = Le ldquoPetit Commentairerdquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed A Tihon Cittagrave del Vaticano 1978
POO = Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia ed J L Heiberg I-II in 3 parti Lipsiae 1898-1907
RGK = Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600 I Handschriften aus Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln II Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs und Nachtraumlge zu den Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln III Handschriften aus Bibliotheken Roms mit dem Vatikan A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg unter Mitarbeit von D Harlfinger und P Eleuteri B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln Wien 1981-1997 (Oumlsterreichische Akademie der Wissenschaften Veroumlffentlichungen der Kommission fuumlr Byzantinistik III1-3 A-C)
Sigla
Acerbi 2010 = F Acerbi Il silenzio delle sirene La matematica greca antica Roma 2010
Acerbi 2012 = F Acerbi I codici stilistici della matematica greca dimostrazioni procedure algoritmi laquoQUCCraquo 1012 (2012) pp 167-214
Acerbi et al 2010 = F Acerbi ndash N Vinel ndash B Vitrac Les Proleacutegomegravenes agrave lrsquoAlmageste Une eacutedition agrave partir des manuscrits les plus anciens Introduction geacuteneacuterale ndash Parties I-III laquoSCIAMVSraquo 11 (2010) pp 53-210
Agati 1992 = M L Agati La minuscola laquoBouleteacuteeraquo Cittagrave del Vaticano 1992
Belger 1881 = C Belger Ein neues Fragmentum mathematicum Bobiense laquoHermesraquo 16 (1881) pp 261-284
Bianconi 2005a = D Bianconi La biblioteca di Cora tra Massimo Planude e Niceforo Gregora Una questione di mani laquoSampTraquo 3 (2005) pp 391-438
Bianconi 2005b = D Bianconi Tessalonica nellrsquoetagrave dei Paleologi Le pratiche intellettuali nel riflesso della cultura scritta Paris 2005
Bianconi 2006a = D Bianconi Le pietre e il ponte ovvero identificazioni di mani e storia della cultura laquoBizantinisticaraquo 8 (2006) pp 135-181
Bianconi 2006b = D Bianconi Qualcosa di nuovo su Giovanni Catrario laquoMEGraquo 6 (2006) pp 69-91
Cavallo 1977 = G Cavallo Funzione e strutture della maiuscola greca tra i secoli VIII-XI in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Colloque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 95-137
Cereteli 1904 = G F Cereteli De compendiis scripturae codicum Graecorum praecipue Petropolitanorum et Mosquensium anni nota instructorum Sankt-Petersburg 1904
De Gregorio 2000 = G De Gregorio Materiali vecchi e nuovi per uno studio della minu-scola greca fra VII e IX secolo in G Prato (a cura di) I manoscritti greci tra riflessione e dibattito Atti del V Colloquio Internazionale di Paleografia Greca Cremona 4-10 ottobre 1998 Firenze 2000 pp 83-151
Follieri 1977 = E Follieri La minuscola libraria dei secoli IX e X in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Col-loque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 139-165
Fonkič 2005 = B Fonkič Venecianskaia rukopisrsquo laquoAlrsquomagestaraquo Ptolemeja (Marc gr 313690) o datirovke i proischoždenii kodeksa laquoVDIraquo s III 254 (2005) pp 162-167
Fowler 1999 = D H Fowler The Mathematics of Platorsquos Academy A New Reconstruction Second Edition Oxford 1999
Bibliografia
Fabio Acerbi164
Gerstinger ndash Vogel 1932 = H Gerstinger ndash K Vogel Eine stereometrische Aufgaben-sammlung im Papyrus Graecus [sic] Vindobonensis 19996 laquoMitteilungen aus der Papy-russammlung der Nationalbibliothek in Wienraquo Neue Serie Folge 1 Griechische literarische Papyri 1 Wien 1932 pp 11-76
Heiberg 1927 = Mathematici Graeci Minores ed J L Heiberg Kjoslashbenhavn 1927
Hultsch 1876-1878 = Pappi Alexandrini Collectionis quae supersunt ed F Hultsch I-III Berlin 1876-1878
Janz 2003 = T Janz The Scribes and the Date of the Vat gr 1291 in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae X Cittagrave del Vaticano 2003 pp 159-180
Jones 1990 = Ptolemyrsquos First Commentator ed A Jones Philadelphia 1990
Jones 1999 = Astronomical Papyri from Oxyrhynchus ed A Jones I-II Philadelphia 1999
Jones 2005 = A Jones Ptolemyrsquos Canobic Inscription and Heliodorusrsquo Observation Reports laquoSCIAMVSraquo 6 (2005) pp 53-97
Lempire 2014 = Steacutephanos drsquoAlexandrie Le commentaire aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Lempire Louvain 2014
Leurquin 1990 = Theacuteodore Meacuteliteacuteniote Tribiblos astronomique Livre I ed R Leurquin Amsterdam 1990
Leurquin 1991 = R Leurquin Un manuscrit autographe de la Tribiblos Astronomique de Theacuteodore Meacuteliteacuteniote le Vaticanus graecus 792 laquoScriptoriumraquo 45 (1991) pp 145-162
Maas 1927 = P Maas Griechische Palaeographie in A Gercke ndash E Norden (hrsg von) Einleitung in die Altertumswissenschaft I9 Leipzig 1927 pp 69-80
Martinelli Tempesta 2010 = S Martinelli Tempesta Il codice Milano Biblioteca Am-brosiana B 75 sup (gr 104) e lrsquoevoluzione della scrittura di Giovanni Scutariota in A B Garciacutea ndash I Peacuterez Martiacuten (ed by) The Legacy of Bernard de Montfaucon Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting Proceedings of the Seventh Inter-national Colloquium of Greek Palaeography Madrid-Salamanca 15-20 September 2008 Turnhout 2010 pp 171-186
Mazzucchi 1994 = C M Mazzucchi Leggere i classici durante la catastrofe (Costantino-poli maggio-agosto 1203) le note marginali al Diodoro Siculo Vaticano gr 130 Parte prima stratigrafia laquoAevumraquo 68 (1994) pp 164-218
Mioni 1976 = E Mioni Bessarione scriba e alcuni suoi collaboratori in Miscellanea marcia-na di studi bessarionei Padova 1976 pp 263-323
Mioni 1985 = Codices graeci manuscripti Bibliothecae Divi Marci Venetiarum II Thesaurus Antiquus Codices 300-625 recensuit E Mioni Roma 1985
Mogenet 1962 = J Mogenet Une scholie ineacutedite du Vat gr 1594 sur les rapports entre lrsquoastronomie arabe et Byzance laquoOsirisraquo 14 (1962) pp 198-221
Mogenet et al 1983 = Niceacutephore Greacutegoras Calcul de lrsquoeacuteclipse de soleil du 16 juillet 1330 ed J Mogenet ndash A Tihon ndash R Royez ndash A Berg Amsterdam 1983
Mondrain 2002 = B Mondrain Maxime Planude Niceacutephore Greacutegoras et Ptoleacutemeacutee laquoPa-laeoslavicaraquo 10 (2002) pp 312-322
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 165
Mondrain 2004 = B Mondrain Lrsquoancien empereur Jean VI Cantacuzegravene et ses copistes in A Rigo (a cura di) Gregorio Palamas e oltre Studi e documenti sulle controversie teologiche del XIV secolo bizantino Firenze 2004 pp 249-296
Mondrain 2007 = B Mondrain Les eacutecritures dans les manuscrits byzantins du XIV e siegravecle Quelques probleacutematiques laquoRSBNraquo n s 44 (2007) pp 157-196
Peacuterez Martiacuten 2006 = I Peacuterez Martiacuten Maxime Planude et le Diophantus Matritensis (Madrid Biblioteca Nacional ms 4678) un paradigme de la reacutecupeacuteration des textes anciens dans la ldquorenaissance paleacuteologuerdquo laquoByzantionraquo 76 (2006) pp 433-462
Peacuterez Martiacuten 2008 = I Peacuterez Martiacuten El lsquoestilo Hodegosrsquo y su proyeccioacuten en las escrituras constantinopolitanas laquoSampTraquo 6 (2008) pp 389-458
Perria 1991 = L Perria Scrittura e ornamentazione nei codici della laquocollezione filosoficaraquo laquoRSBNraquo n s 28 (1991) pp 45-111
Rollo 2012 = A Rollo LrsquoArchimede di Giorgio Valla in V Fera ndash D Gionta ndash A Rollo (a cura di) Archimede e le sue fortune Atti del Convegno di Siracusa-Messina 24-26 giugno 2008 Messina 2012 pp 99-147
Rome 1927 = A Rome Membra disjecta laquoRBenraquo 39 (1927) pp 187-188
Rome 1938 = A Rome Un manuscrit de la bibliothegraveque de Boniface VIII agrave la Meacutediceacuteenne de Florence laquoACraquo 7 (1938) pp 261-268
Ronconi 2013 = F Ronconi La collection philosophique un fantocircme historique laquoScripto-riumraquo 67 (2013) pp 119-140
Tannery ndash Steacutephanou 1940 = Quadrivium de Georges Pachymegravere ed P Tannery ndash E Steacutephanou Cittagrave del Vaticano 1940
Tihon 2011 = Πτολεμαίου Πρόχειροι Κανόνες Les Tables faciles de Ptoleacutemeacutee vol Ia Tables A1-A2 ed A Tihon Leuven 2011
Traube 1907 = L Traube Nomina Sacra Versuch einer Geschichte der christlichen Kuumlrzung Muumlnchen 1907
Vogel 1936 = K Vogel Beitraumlge zur griechischen Logistik laquoSBAWraquo Mathematisch-natur-wissenschaftliche Abteilung Jahrgang 1936 pp 357-472
Wouters 1979 = A Wouters The Grammatical Papyri from Graeco-Roman Egypt Contri-butions to the Study of the lsquoArs Grammaticarsquo in Antiquity Brussel 1979
F ACERBI Tav 1
b Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 65r
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 284 f 160r
F ACERBITav 2
b Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 13r
a Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 19v
F ACERBI Tav 3
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 136v
F ACERBITav 4
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17r
F ACERBI Tav 5
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17v
F ACERBITav 6
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 7v
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
Fabio Acerbi156
denza il compendio per la desinenza -ον accentata il copista interpreta il segno come unrsquoabbreviazione ndash e di una barra a sormontare lo Υ Potremmo forse interpretarlo come il segno di contrazione del grafema -στ- lrsquounico tassello mancante in unrsquoabbreviazione come ad esempio (δυναμοδυναμο)(στ)(ὸν) ma uno scolio di prima mano al f 58v rela-tivo alle specie degli interi inficia questrsquoipotesi esse sono dotate di slash di sospensione accento acuto in un caso del compendio canonico per la terminazione -ον hellip ma tutti gli Υ a esponente sono a loro volta sormontati da una barra
Meno legata al singolo manoscritto ma nondimeno non uniforme si presenta la pratica di notazione dei segni che rappresentano gli enti numerici sessagesimali86 da una parte sta lrsquoevidenza del testo dei Pro-legomena e delle sue tabelle apici ndash drsquoaltronde come abbiamo visto la notazione universalmente impiegata per i numerali ordinali e per le fra-zioni unitarie ndash dallrsquoaltra sta lrsquoevidenza del testo dellrsquoAlmagesto in tutti i manoscritti piugrave antichi e lo stesso si dica del commentario teonino a questrsquoopera o del suo lsquoGrande commentariorsquo alle Tavole facili e dei testi astronomici su papiro barre87 Sembra insomma che la nostra docu-
86 Sia le molteplicitagrave che le specie ahimeacute entrambe rappresentate da lettere dellrsquoalfabeto Come osservato allrsquoinizio della sezione 3 ci sono in effetti due tipi di lettere numerali in gioco se facciamo astrazione da apici o barre lsquo4 minuti secondirsquo si trova scritto δ β la prima lettera numerale denota la molteplicitagrave degli item di una certa specie la se-conda la specie nei Prolegomena entrambe sono accompagnate da un doppio apice il che rende inutile la presenza delle seconde Si noti che la descrizione della tabella non fa parola della notazione da usare per le lettere numerali che denotano la molteplicitagrave barre o apici e quanti apici hellip In questo caso fa interamente fede la tabella cioegrave la pratica grafica condivisa instauratasi non egrave chiaro quando
87 I manoscritti piugrave antichi dellrsquoAlmagesto sono menzionati nella nota 10 supra quelli dei due commentarii teonini sono il Laur Plut 2818 e il celeberrimo Vat gr 190 (sec IX in Euclide Elementi Data Teone lsquoGrande commentariorsquo) per la notazione dei pa-piri astronomici si veda Jones 1999 II passim La notazione non sembra lsquoinquinatarsquo dalla pratica dei copisti bizantini e pare dipendere soltanto dalla data di composizione Tro-viamo ad esempio barre sopra tutti i numerali di molteplicitagrave (interi o sessagesimali) nel frammento di un commentario alle Tavole facili contenente un calcolo relativo al 24 aprile 213 (Par gr 2841 sec XIII ex-XIV in oltre al frammento ai ff 32r l 11-34v l 23 contiene Arato Phaenomena ed Efestione Apotelesmatica edizione in Jones 1990) Nel commentario alle Tavole facili composto ca 610-617 ed attribuito a Stefano di Alessandria la situazione egrave la seguente (Jean Lempire per litteras per lrsquoedizione si veda Lempire 2014 ho controllato il Vat gr 304 ff 135r-171v sec XIV am contiene in aggiunta Teone in Almagestum I-II lsquoPiccolo commentariorsquo alle Tavole facili Diofanto Arithmetica e De polygo-nis numeris varia astronomica tabulae) barre sopra gli interi sporadicamente rimpiazzate da apici apici sopra le parti sessagesimali in numero uguale alla denominazione doppio () apice per le frazioni unitarie Sono impiegate barre sopra gli interi e apici sopra le parti sessagesimali nei manoscritti principali di tutti i trattati di introduzione allrsquoAlmagesto o comunque di argomento logistico redatti in epoca bizantina Giorgio Pachimere (1242-ca 1310) Quadrivium (autografo nel manoscritto Roma Biblioteca Angelica gr 38 [RGK III nr 115] si veda Tannery ndash Steacutephanou 1940 per lrsquoedizione) Teodoro Metochita (1270-
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 157
mentazione si faccia testimone di un cambio notazionale avvenuto nel periodo intercorrente fra Teone (sec IV pm) e la scuola alessandrina di Ammonio e dei suoi allievi (sec VI in) e probabilmente innescato da questrsquoultimo ambiente lrsquoaspetto paradossale egrave che nello stesso codice si rintraccino due notazioni differenti per gli enti numerici sessagesimali e lrsquouna (apici) sia adottata sistematicamente e coerentemente in uno scritto (i Prolegomena) che si presenta esattamente come unrsquointroduzione tecnica alla pratica numerico-algoritmica del trattato (lrsquoAlmagesto) in cui egrave adottata lrsquoaltra (barre che ritroviamo senza eccezioni anche negli scolii)
Torniamo ai Prolegomena la descrizione del segno da porre a fianco di ogni singolo quoziente parziale e denotante la sua specie numerica (minuti primi minuti secondi ecc) solleva tre problemi
Primo problema Ci vuole una barra o un apice su τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquola lettera A [hellip] che significa la specieraquo quando lo scriviamo nella tabella Tutta la nostra discussione precedente fa pro-pendere per lrsquoapice e si ricordi anche la forma verbale ἀνατείνουσαν che suggerisce qualcosa che si lsquoestende verso lrsquoaltorsquo (la mia traduzione egrave volutamente neutra) se fosse apposta una barra la cosa dovrebbe passare
1231332) Compendium astronomicum (copia lsquoautorizzatarsquo coeva nei Vat gr 182 e 181 da parte del copista che integrograve le parti mancanti del Par gr 2389 [ff 207-210 255-270 374-375] Bianconi 2005a pp 425-427 Peacuterez Martiacuten 2008 p 436 e n 177) Teodoro Meliteniota (morto lrsquo831393) Tribiblos astronomica (autografo nel Vat gr 792 si vedano Leurquin 1991 per unrsquoanalisi del manoscritto Leurquin 1990 per lrsquoedizione) una com-pilazione anonima (per cui ho consultato il Par gr 2396 ff 87r-92v limitatamente a questi fogli manu Costantino Trivoli [RGK II nr 318 ma ovviamente questo codice non vi egrave segnalato] terzo quarto del XV secolo il resto del codice annotato da Niceforo Gregora egrave di etagrave planudea e parzialmente [ff 33v-76v] un autografo di Planude stesso contiene Teone in Almagestum I II IV Mondrain 2002 il codice va completato ndash limitatamente a stralci dei libri VIII-X XII-XIII del commentario teonino la cui parte intermedia si egrave persa ndash con 26 carte [ff 123-147] inserite nel Vat gr 1087 anchrsquoesso contenente anno-tazioni di Gregora Rome 1927 per la figura del copista dei ff 77r-86r del Par gr 2396 e dei ff appena nominati del Vat gr 1087 un anonimo collaboratore di Gregora si veda in ultimo Bianconi 2006a pp 147-151) si veda anche il calcolo effettuato da Niceforo Gre-gora (12921295-13581361) dellrsquoeclisse di sole del 16 luglio 1330 (attestata unicamente ai ff 1r-8v della miscellanea astronomica Marc gr 325 databile ca 1324-1329 in parte vergata e ovunque fittamente annotata da Gregora stesso edizione del testo in Mogenet et al 1983 annotazioni di Gregora elencate in Bianconi 2005a p 413) Unrsquoeccezione apparente il lsquoPiccolo commentariorsquo di Teone alle Tavole facili le parti sessagesimali sono segnalate da apici (ad esempio nel Vat gr 175 vergato da Giovanni Catrario e completato nel 1321-1322 sulla figura di Catrario si vedano in ultimo Bianconi 2005b pp 141-156 e 2006b) lrsquoopera egrave antica ma la sua tradizione non rimonta oltre la fine del XIII secolo a parte un frammento nel Leiden BPG 78 ff 156r-161v (minuscola del IX-X secolo) e in effetti in questo manoscritto tutti i numerali di molteplicitagrave sono sormontati da barre Unrsquoeccezione effettiva egrave il De hypotesibus planetarum nel Vat gr 1594 barre sugli interi e apici sulle parti sessagesimali
Fabio Acerbi158
sotto silenzio e la presenza dellrsquoapice la rende inutile88 Si tratta della stessa convenzione diofantea e coincide ancora con la notazione per i numerali ordinali e per le frazioni unitarie che egrave corrente nei mano- scritti matematici greci per questo motivo non percheacute la descrizione sia particolarmente perspicua nessuno dei copisti della recensione an-tica ha incertezze apici Ma questi apici si rintracciano soltanto sulle indicazioni di specie non contemplate dalla descrizione che sono ante-poste ai resti parziali a fianco dei quozienti parziali i segni di specie sono invece trasformati in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordi-nali corrispondenti del tipo πρωτ tavv 5 e 7b-8 Il recensore bizantino taglia invece la testa al toro elimina dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali elimina la seconda menzione della laquolet-tera Araquo contestualmente allrsquoazzeramento dellrsquoespediente della linea a zig-zag (si veda il punto seguente) modifica la descrizione che contiene la prima menzione in quella dellrsquoapice associato direttamente ai nume-rali di molteplicitagrave riciclando addirittura lrsquoalpha per adibirlo a desi-gnare un numero cardinale (come sorprendersi) τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ laquoponendo al di sopra di essi [scil dei 50 minuti primi] 1 solo lsaquoaccentorsaquo acutoraquo La scelta del recensore egrave assennata che rechi una barra o un apice in una tabella un alpha denota un numero non un numero drsquoordine
Secondo problema da tenere ben distinto dal precedente Cosa ci vuole sul segno α per la lettera alpha menzionata nella frase τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquolettera A [hellip] che significa la specieraquo89 Unrsquooc-chiata allrsquoapparato critico rivela una bella incertezza nei manoscritti Z scrive sempre ᾱ e in un caso lo fa anche P MS optano sempre per α´ C per α P scrive nellrsquoaltro caso αο Per quanto solo la barra sia congrua con il senso della frase in quanto la lettera alpha egrave qui menzionata (si tratta di un oggetto che compare nella tabella) e non cambia niente se essa egrave accompagnata dal suo nome di genere στοιχεῖον ad un livello grafico lrsquoincertezza fra il segno ᾱ che denota laquola lettera αraquo e il segno α´ (o lrsquoabbreviazione αο) per una forma di πρῶτος egrave per piugrave versi giustificata
88 Detto in altri termini la barra egrave uno strumento grafico non matematico e quindi la sua presenza non va segnalata mentre un apice lo egrave e la sua presenza lo deve
89 Notare che in questa frase il primo α non vuole la barra (egrave menzionato allrsquointerno di una frase che impiega convenzioni moderne) il secondo sigrave (idem ma con convenzioni antiche) ndash e nella traduzione la scelta di denotarlo con A (senza virgolette) e non con lsquoArsquo (con virgolette) egrave del tutto arbitraria ndash si noti inoltre che le necessarie precisazioni laquosenzacon virgoletteraquo mostrano che le lingue moderne palesano difficoltagrave analoghe a quelle del greco antico per quanto riguarda i livelli denotativi in ambito metadiscorsivo per non usare le due parentetiche avrei dovuto scrivere rispettivamente lsquoArsquo e lsquolsquoArsquorsquo (doppie virgolette semplici)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 159
ᾱ coincide con il numerale 1 α egrave la prima lettera dellrsquoalfabeto ed inoltre α´ egrave esattamente quello che va scritto nella tabella Potremmo dirci che il sostantivo στοιχεῖον chiude la questione la sua presenza congiunta ad un ipotetico α´ renderebbe la descrizione ridondante o inappropriata90 Ma a parte il fatto che α egrave proprio τὸ πρῶτον στοιχεῖον il segno α´ cat-tura in fondo il cuore della descrizione di uno στοιχεῖον ἔχον lsaquoγραμμὴνrsaquo ἀνατείνουσαν
Terzo problema Lrsquoautore dei Prolegomena che si arresta allrsquoesem-pio dei minuti primi non dice quanti apici occorre mettere sulle lettere numerali che identificano gli ordini superiori al primo se uno soltanto come nel caso diofanteo e delle frazioni unitarie o in numero uguale alla loro denominazione (cioegrave pari al numero denotato dal numerale stesso su cui vanno posti) come effettivamente avviene nei mano-scritti dei Prolegomena La tabella egrave quindi sottodeterminata dalla sua descrizione anzi in un certo senso prende il sopravvento su di essa la pratica di marcare i numerali di molteplicitagrave con gli apici che compe-tono allrsquoordine cui appartengono viene trasferita ai segni per gli ordini stessi per supplire ad una descrizione carente di questi ultimi E la tabella egrave sottodeterminata dalla descrizione in quanto egrave la descrizione di una tabella reale ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις laquocome nello lsaquoschemarsaquo espostoraquo leggiamo a un certo punto del testo
3) La linea a zig-zag Non possiamo che applaudire a questo geniale espediente grafico lo troviamo messo in opera solo nel Marc gr 313 Per quanto lrsquoautore non faccia parola di ciograve nel corso della sua descrizione la linea spezzata egrave intesa dover lsquosaltarersquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue Il copista del codice marciano effettua correttamente due salti nella prima delle sue tabelle (tav 4) ma inserisce un lsquodentersquo in piugrave in quella che considera corretta (tav 5) La linea a zig-zag egrave incompatibile con la presenza di linee di giustificazione nella tabella che in effetti mancano nel Marc gr 313 ciograve induce gli errori di allineamento dei primi 5 quozienti parziali di cui egrave vittima il copista Probabilmente per questo motivo in nessuno degli apografi del Vat gr 1594 la linea a zig-zag figura nella tabella inquadrata come si conviene da una (doppia) cornice esterna e le cui colonne sono appunto separate da linee verticali (tav 7b Vat gr 184 f 17v e tav 8 Par gr 2390 f 9v cui egrave sostanzialmente identica la tabella del Marc gr 314 che si trova
90 Trascuro lrsquoabbreviazione αο = πρῶτος percheacute la desinenza non egrave quella richiesta neacute nella frase (egrave richiesto πρῶτον) neacute nella tabella (πρῶτα)
Fabio Acerbi160
al f 248r ndash ma la mancanza di linee orizzontali causa un gigantesco pa-sticcio nel codice vaticano) Alla recensione bizantina che dipende per il suo testo di base dal Vat gr 1594 e quindi non trova la linea a zig-zag nella tabella non resta che sopprimere la sua descrizione ndash ma proprio per questo motivo e finalmente diventa possibile tracciare un apparato completo di linee di giustificazione (tav 9 Laur Plut 89 sup 48 f 14v) Dato che la descrizione di Teone di questo procedimento di divi-sione non fa cenno allrsquoesistenza della linea a zig-zag viene da chiedersi se essa non costituisca un espediente escogitato dallrsquoautore dei Prolegomena per vivacizzare la procedura originale di Pappo
4) Discrepanze tra descrizione e tabella Il gioco delle minime va-rianti mostra che la divisione era stata eseguita (e trasmessa) corret-tamente tutti i valori numerici sono esatti La tabella nel Marc gr 313 presenta perograve alcune discrepanze con la propria descrizione Essa omette (ma non nella versione lsquoscorrettarsquo lrsquoomissione non si riscontra neanche nel Par gr 2390) il segno per laquorestoraquo di fronte ai resti par-ziali ma aggiunge lrsquoindicazione della loro specie Essa trasforma invece come abbiamo visto le indicazioni di specie che seguono i quozienti parziali in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordinali corri-spondenti La descrizione prevede di chiudere la tabella con il risultato καὶ συνάγων ἅπαντα τὰ ἐκ τῶν μερισθέντων μερῶν λεπτὰ σημειοῦται ὑπὸ πάντας οὕτως γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoe raccogliendo tutti i minuti che provengono dalle parti divise lsaquoPapporsaquo nota sotto tutto cosigrave Ris 0 59 8 17 13 12 31raquo ma sotto la tabella tutta la tradizione ci consegna qualcosa di piugrave articolato ὁ ζητούμενος καθ᾽ ὃν μερίζεται ὁ τξε ιδ´ μη´´ π(αρὰ) τὸν τξ γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoil lsaquonumerorsaquo cercato secondo cui 365 14 48 egrave diviso per 360 risulta 0 59 8 17 13 12 31raquo frase che del resto contiene due errori lrsquoinversione del dividendo e del divisore e la confusione tra segno convenzionale (iuxta descrizione) e abbreviazione (come nella frase) nel caso di γι Oltre ad eliminare la linea a zig-zag91 la recensione bizantina sopprime dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali e modifica come abbiamo visto al punto 2 le loro descrizioni in quelle di apici associati diretta-mente ai numerali di molteplicitagrave
91 Le due righe che nella recensione di base contengono solo i resti parziali minori di 160 del divisore ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue sono in parte completate con lrsquoindicazione abbreviata ἀνάλ(υσις) laquoanalisiraquo il termine greco per questa procedura di riduzione In un sussulto di ipercorrettismo matematico tali resti parziali ridotti non sono preceduti dal segno per laquorestoraquo come nel Par gr 2390 ma da quello per laquorisultatoraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 161
Gli esempi che abbiamo discusso mostrano come i problemi di notazione pesino e non poco sullrsquoespressione discorsiva di un algorit-mo matematico lrsquoente di riferimento per lsquoformularersquo il procedimento di divisione fu considerata la tabella cioegrave un oggetto la cui costitu-zione egrave legata piugrave ad una pratica grafica che a considerazioni logico- algoritmiche non la sua descrizione che in effetti finisce per determi-nare la tabella in maniera non univoca Di questa sottodeterminazione si fa testimone la traiettoria che abbiamo cercato di seguire nelle mani di copisti e revisori il procedimento di divisione si modifica a volte in aspetti secondari a volte in punti piugrave sostanziali ndash fino a rendere neces-saria una radicale revisione della sua descrizione per renderla conforme alla tabella ndash in ogni caso mai per ragioni squisitamente matematiche92
Abstract
The article presents and discusses in detail two passages from the anonymous Prolegomena to the Almagest a VIth century primer to the elementary procedures of calculation needed in Ptolemyrsquos Almagest In the two passages we may follow the complex interplay between mathematical notation the auctor who employed and described it the tachygrapher who transcribed it in vivo copyists who reproduced it correctors who modified it Along this path misgivings and errors arise in the transmission of abbreviations and paratextual units such as diagrams tables operational schemes
Fabio AcerbiCNRS UMR8560 Centre Alexandre Koyreacute
fabacerbigmailcom
92 Sono grato a Daniele Bianconi Lucio del Corso Jean Lempire per alcune preziose indicazioni
AOO = Archimedis opera omnia cum commentariis Eutocii ed J L Heiberg I-III Lipsiae 1910-1915
DOO = Diophanti Alexandrini opera omnia cum Graecis commentariis ed P Tannery I-II Lipsiae 1893-1895
GC = Le laquoGrand Commentaireraquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Mogenet ndash A Tihon I-III Cittagrave del Vaticano 1985-1999
iA = Commentaires de Pappus et de Theacuteon drsquoAlexandrie sur lrsquoAlmageste ed A Rome I-III con paginazione continua Cittagrave del Vaticano 1931-1943
HOO = Heronis Alexandrini opera quae supersunt omnia ed G Schmidt ndash L Nix ndash W Schmidt ndash H Schoene ndash J L Heiberg I-V Lipsiae 1899-1914
PC = Le ldquoPetit Commentairerdquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed A Tihon Cittagrave del Vaticano 1978
POO = Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia ed J L Heiberg I-II in 3 parti Lipsiae 1898-1907
RGK = Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600 I Handschriften aus Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln II Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs und Nachtraumlge zu den Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln III Handschriften aus Bibliotheken Roms mit dem Vatikan A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg unter Mitarbeit von D Harlfinger und P Eleuteri B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln Wien 1981-1997 (Oumlsterreichische Akademie der Wissenschaften Veroumlffentlichungen der Kommission fuumlr Byzantinistik III1-3 A-C)
Sigla
Acerbi 2010 = F Acerbi Il silenzio delle sirene La matematica greca antica Roma 2010
Acerbi 2012 = F Acerbi I codici stilistici della matematica greca dimostrazioni procedure algoritmi laquoQUCCraquo 1012 (2012) pp 167-214
Acerbi et al 2010 = F Acerbi ndash N Vinel ndash B Vitrac Les Proleacutegomegravenes agrave lrsquoAlmageste Une eacutedition agrave partir des manuscrits les plus anciens Introduction geacuteneacuterale ndash Parties I-III laquoSCIAMVSraquo 11 (2010) pp 53-210
Agati 1992 = M L Agati La minuscola laquoBouleteacuteeraquo Cittagrave del Vaticano 1992
Belger 1881 = C Belger Ein neues Fragmentum mathematicum Bobiense laquoHermesraquo 16 (1881) pp 261-284
Bianconi 2005a = D Bianconi La biblioteca di Cora tra Massimo Planude e Niceforo Gregora Una questione di mani laquoSampTraquo 3 (2005) pp 391-438
Bianconi 2005b = D Bianconi Tessalonica nellrsquoetagrave dei Paleologi Le pratiche intellettuali nel riflesso della cultura scritta Paris 2005
Bianconi 2006a = D Bianconi Le pietre e il ponte ovvero identificazioni di mani e storia della cultura laquoBizantinisticaraquo 8 (2006) pp 135-181
Bianconi 2006b = D Bianconi Qualcosa di nuovo su Giovanni Catrario laquoMEGraquo 6 (2006) pp 69-91
Cavallo 1977 = G Cavallo Funzione e strutture della maiuscola greca tra i secoli VIII-XI in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Colloque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 95-137
Cereteli 1904 = G F Cereteli De compendiis scripturae codicum Graecorum praecipue Petropolitanorum et Mosquensium anni nota instructorum Sankt-Petersburg 1904
De Gregorio 2000 = G De Gregorio Materiali vecchi e nuovi per uno studio della minu-scola greca fra VII e IX secolo in G Prato (a cura di) I manoscritti greci tra riflessione e dibattito Atti del V Colloquio Internazionale di Paleografia Greca Cremona 4-10 ottobre 1998 Firenze 2000 pp 83-151
Follieri 1977 = E Follieri La minuscola libraria dei secoli IX e X in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Col-loque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 139-165
Fonkič 2005 = B Fonkič Venecianskaia rukopisrsquo laquoAlrsquomagestaraquo Ptolemeja (Marc gr 313690) o datirovke i proischoždenii kodeksa laquoVDIraquo s III 254 (2005) pp 162-167
Fowler 1999 = D H Fowler The Mathematics of Platorsquos Academy A New Reconstruction Second Edition Oxford 1999
Bibliografia
Fabio Acerbi164
Gerstinger ndash Vogel 1932 = H Gerstinger ndash K Vogel Eine stereometrische Aufgaben-sammlung im Papyrus Graecus [sic] Vindobonensis 19996 laquoMitteilungen aus der Papy-russammlung der Nationalbibliothek in Wienraquo Neue Serie Folge 1 Griechische literarische Papyri 1 Wien 1932 pp 11-76
Heiberg 1927 = Mathematici Graeci Minores ed J L Heiberg Kjoslashbenhavn 1927
Hultsch 1876-1878 = Pappi Alexandrini Collectionis quae supersunt ed F Hultsch I-III Berlin 1876-1878
Janz 2003 = T Janz The Scribes and the Date of the Vat gr 1291 in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae X Cittagrave del Vaticano 2003 pp 159-180
Jones 1990 = Ptolemyrsquos First Commentator ed A Jones Philadelphia 1990
Jones 1999 = Astronomical Papyri from Oxyrhynchus ed A Jones I-II Philadelphia 1999
Jones 2005 = A Jones Ptolemyrsquos Canobic Inscription and Heliodorusrsquo Observation Reports laquoSCIAMVSraquo 6 (2005) pp 53-97
Lempire 2014 = Steacutephanos drsquoAlexandrie Le commentaire aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Lempire Louvain 2014
Leurquin 1990 = Theacuteodore Meacuteliteacuteniote Tribiblos astronomique Livre I ed R Leurquin Amsterdam 1990
Leurquin 1991 = R Leurquin Un manuscrit autographe de la Tribiblos Astronomique de Theacuteodore Meacuteliteacuteniote le Vaticanus graecus 792 laquoScriptoriumraquo 45 (1991) pp 145-162
Maas 1927 = P Maas Griechische Palaeographie in A Gercke ndash E Norden (hrsg von) Einleitung in die Altertumswissenschaft I9 Leipzig 1927 pp 69-80
Martinelli Tempesta 2010 = S Martinelli Tempesta Il codice Milano Biblioteca Am-brosiana B 75 sup (gr 104) e lrsquoevoluzione della scrittura di Giovanni Scutariota in A B Garciacutea ndash I Peacuterez Martiacuten (ed by) The Legacy of Bernard de Montfaucon Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting Proceedings of the Seventh Inter-national Colloquium of Greek Palaeography Madrid-Salamanca 15-20 September 2008 Turnhout 2010 pp 171-186
Mazzucchi 1994 = C M Mazzucchi Leggere i classici durante la catastrofe (Costantino-poli maggio-agosto 1203) le note marginali al Diodoro Siculo Vaticano gr 130 Parte prima stratigrafia laquoAevumraquo 68 (1994) pp 164-218
Mioni 1976 = E Mioni Bessarione scriba e alcuni suoi collaboratori in Miscellanea marcia-na di studi bessarionei Padova 1976 pp 263-323
Mioni 1985 = Codices graeci manuscripti Bibliothecae Divi Marci Venetiarum II Thesaurus Antiquus Codices 300-625 recensuit E Mioni Roma 1985
Mogenet 1962 = J Mogenet Une scholie ineacutedite du Vat gr 1594 sur les rapports entre lrsquoastronomie arabe et Byzance laquoOsirisraquo 14 (1962) pp 198-221
Mogenet et al 1983 = Niceacutephore Greacutegoras Calcul de lrsquoeacuteclipse de soleil du 16 juillet 1330 ed J Mogenet ndash A Tihon ndash R Royez ndash A Berg Amsterdam 1983
Mondrain 2002 = B Mondrain Maxime Planude Niceacutephore Greacutegoras et Ptoleacutemeacutee laquoPa-laeoslavicaraquo 10 (2002) pp 312-322
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 165
Mondrain 2004 = B Mondrain Lrsquoancien empereur Jean VI Cantacuzegravene et ses copistes in A Rigo (a cura di) Gregorio Palamas e oltre Studi e documenti sulle controversie teologiche del XIV secolo bizantino Firenze 2004 pp 249-296
Mondrain 2007 = B Mondrain Les eacutecritures dans les manuscrits byzantins du XIV e siegravecle Quelques probleacutematiques laquoRSBNraquo n s 44 (2007) pp 157-196
Peacuterez Martiacuten 2006 = I Peacuterez Martiacuten Maxime Planude et le Diophantus Matritensis (Madrid Biblioteca Nacional ms 4678) un paradigme de la reacutecupeacuteration des textes anciens dans la ldquorenaissance paleacuteologuerdquo laquoByzantionraquo 76 (2006) pp 433-462
Peacuterez Martiacuten 2008 = I Peacuterez Martiacuten El lsquoestilo Hodegosrsquo y su proyeccioacuten en las escrituras constantinopolitanas laquoSampTraquo 6 (2008) pp 389-458
Perria 1991 = L Perria Scrittura e ornamentazione nei codici della laquocollezione filosoficaraquo laquoRSBNraquo n s 28 (1991) pp 45-111
Rollo 2012 = A Rollo LrsquoArchimede di Giorgio Valla in V Fera ndash D Gionta ndash A Rollo (a cura di) Archimede e le sue fortune Atti del Convegno di Siracusa-Messina 24-26 giugno 2008 Messina 2012 pp 99-147
Rome 1927 = A Rome Membra disjecta laquoRBenraquo 39 (1927) pp 187-188
Rome 1938 = A Rome Un manuscrit de la bibliothegraveque de Boniface VIII agrave la Meacutediceacuteenne de Florence laquoACraquo 7 (1938) pp 261-268
Ronconi 2013 = F Ronconi La collection philosophique un fantocircme historique laquoScripto-riumraquo 67 (2013) pp 119-140
Tannery ndash Steacutephanou 1940 = Quadrivium de Georges Pachymegravere ed P Tannery ndash E Steacutephanou Cittagrave del Vaticano 1940
Tihon 2011 = Πτολεμαίου Πρόχειροι Κανόνες Les Tables faciles de Ptoleacutemeacutee vol Ia Tables A1-A2 ed A Tihon Leuven 2011
Traube 1907 = L Traube Nomina Sacra Versuch einer Geschichte der christlichen Kuumlrzung Muumlnchen 1907
Vogel 1936 = K Vogel Beitraumlge zur griechischen Logistik laquoSBAWraquo Mathematisch-natur-wissenschaftliche Abteilung Jahrgang 1936 pp 357-472
Wouters 1979 = A Wouters The Grammatical Papyri from Graeco-Roman Egypt Contri-butions to the Study of the lsquoArs Grammaticarsquo in Antiquity Brussel 1979
F ACERBI Tav 1
b Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 65r
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 284 f 160r
F ACERBITav 2
b Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 13r
a Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 19v
F ACERBI Tav 3
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 136v
F ACERBITav 4
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17r
F ACERBI Tav 5
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17v
F ACERBITav 6
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 7v
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 157
mentazione si faccia testimone di un cambio notazionale avvenuto nel periodo intercorrente fra Teone (sec IV pm) e la scuola alessandrina di Ammonio e dei suoi allievi (sec VI in) e probabilmente innescato da questrsquoultimo ambiente lrsquoaspetto paradossale egrave che nello stesso codice si rintraccino due notazioni differenti per gli enti numerici sessagesimali e lrsquouna (apici) sia adottata sistematicamente e coerentemente in uno scritto (i Prolegomena) che si presenta esattamente come unrsquointroduzione tecnica alla pratica numerico-algoritmica del trattato (lrsquoAlmagesto) in cui egrave adottata lrsquoaltra (barre che ritroviamo senza eccezioni anche negli scolii)
Torniamo ai Prolegomena la descrizione del segno da porre a fianco di ogni singolo quoziente parziale e denotante la sua specie numerica (minuti primi minuti secondi ecc) solleva tre problemi
Primo problema Ci vuole una barra o un apice su τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquola lettera A [hellip] che significa la specieraquo quando lo scriviamo nella tabella Tutta la nostra discussione precedente fa pro-pendere per lrsquoapice e si ricordi anche la forma verbale ἀνατείνουσαν che suggerisce qualcosa che si lsquoestende verso lrsquoaltorsquo (la mia traduzione egrave volutamente neutra) se fosse apposta una barra la cosa dovrebbe passare
1231332) Compendium astronomicum (copia lsquoautorizzatarsquo coeva nei Vat gr 182 e 181 da parte del copista che integrograve le parti mancanti del Par gr 2389 [ff 207-210 255-270 374-375] Bianconi 2005a pp 425-427 Peacuterez Martiacuten 2008 p 436 e n 177) Teodoro Meliteniota (morto lrsquo831393) Tribiblos astronomica (autografo nel Vat gr 792 si vedano Leurquin 1991 per unrsquoanalisi del manoscritto Leurquin 1990 per lrsquoedizione) una com-pilazione anonima (per cui ho consultato il Par gr 2396 ff 87r-92v limitatamente a questi fogli manu Costantino Trivoli [RGK II nr 318 ma ovviamente questo codice non vi egrave segnalato] terzo quarto del XV secolo il resto del codice annotato da Niceforo Gregora egrave di etagrave planudea e parzialmente [ff 33v-76v] un autografo di Planude stesso contiene Teone in Almagestum I II IV Mondrain 2002 il codice va completato ndash limitatamente a stralci dei libri VIII-X XII-XIII del commentario teonino la cui parte intermedia si egrave persa ndash con 26 carte [ff 123-147] inserite nel Vat gr 1087 anchrsquoesso contenente anno-tazioni di Gregora Rome 1927 per la figura del copista dei ff 77r-86r del Par gr 2396 e dei ff appena nominati del Vat gr 1087 un anonimo collaboratore di Gregora si veda in ultimo Bianconi 2006a pp 147-151) si veda anche il calcolo effettuato da Niceforo Gre-gora (12921295-13581361) dellrsquoeclisse di sole del 16 luglio 1330 (attestata unicamente ai ff 1r-8v della miscellanea astronomica Marc gr 325 databile ca 1324-1329 in parte vergata e ovunque fittamente annotata da Gregora stesso edizione del testo in Mogenet et al 1983 annotazioni di Gregora elencate in Bianconi 2005a p 413) Unrsquoeccezione apparente il lsquoPiccolo commentariorsquo di Teone alle Tavole facili le parti sessagesimali sono segnalate da apici (ad esempio nel Vat gr 175 vergato da Giovanni Catrario e completato nel 1321-1322 sulla figura di Catrario si vedano in ultimo Bianconi 2005b pp 141-156 e 2006b) lrsquoopera egrave antica ma la sua tradizione non rimonta oltre la fine del XIII secolo a parte un frammento nel Leiden BPG 78 ff 156r-161v (minuscola del IX-X secolo) e in effetti in questo manoscritto tutti i numerali di molteplicitagrave sono sormontati da barre Unrsquoeccezione effettiva egrave il De hypotesibus planetarum nel Vat gr 1594 barre sugli interi e apici sulle parti sessagesimali
Fabio Acerbi158
sotto silenzio e la presenza dellrsquoapice la rende inutile88 Si tratta della stessa convenzione diofantea e coincide ancora con la notazione per i numerali ordinali e per le frazioni unitarie che egrave corrente nei mano- scritti matematici greci per questo motivo non percheacute la descrizione sia particolarmente perspicua nessuno dei copisti della recensione an-tica ha incertezze apici Ma questi apici si rintracciano soltanto sulle indicazioni di specie non contemplate dalla descrizione che sono ante-poste ai resti parziali a fianco dei quozienti parziali i segni di specie sono invece trasformati in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordi-nali corrispondenti del tipo πρωτ tavv 5 e 7b-8 Il recensore bizantino taglia invece la testa al toro elimina dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali elimina la seconda menzione della laquolet-tera Araquo contestualmente allrsquoazzeramento dellrsquoespediente della linea a zig-zag (si veda il punto seguente) modifica la descrizione che contiene la prima menzione in quella dellrsquoapice associato direttamente ai nume-rali di molteplicitagrave riciclando addirittura lrsquoalpha per adibirlo a desi-gnare un numero cardinale (come sorprendersi) τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ laquoponendo al di sopra di essi [scil dei 50 minuti primi] 1 solo lsaquoaccentorsaquo acutoraquo La scelta del recensore egrave assennata che rechi una barra o un apice in una tabella un alpha denota un numero non un numero drsquoordine
Secondo problema da tenere ben distinto dal precedente Cosa ci vuole sul segno α per la lettera alpha menzionata nella frase τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquolettera A [hellip] che significa la specieraquo89 Unrsquooc-chiata allrsquoapparato critico rivela una bella incertezza nei manoscritti Z scrive sempre ᾱ e in un caso lo fa anche P MS optano sempre per α´ C per α P scrive nellrsquoaltro caso αο Per quanto solo la barra sia congrua con il senso della frase in quanto la lettera alpha egrave qui menzionata (si tratta di un oggetto che compare nella tabella) e non cambia niente se essa egrave accompagnata dal suo nome di genere στοιχεῖον ad un livello grafico lrsquoincertezza fra il segno ᾱ che denota laquola lettera αraquo e il segno α´ (o lrsquoabbreviazione αο) per una forma di πρῶτος egrave per piugrave versi giustificata
88 Detto in altri termini la barra egrave uno strumento grafico non matematico e quindi la sua presenza non va segnalata mentre un apice lo egrave e la sua presenza lo deve
89 Notare che in questa frase il primo α non vuole la barra (egrave menzionato allrsquointerno di una frase che impiega convenzioni moderne) il secondo sigrave (idem ma con convenzioni antiche) ndash e nella traduzione la scelta di denotarlo con A (senza virgolette) e non con lsquoArsquo (con virgolette) egrave del tutto arbitraria ndash si noti inoltre che le necessarie precisazioni laquosenzacon virgoletteraquo mostrano che le lingue moderne palesano difficoltagrave analoghe a quelle del greco antico per quanto riguarda i livelli denotativi in ambito metadiscorsivo per non usare le due parentetiche avrei dovuto scrivere rispettivamente lsquoArsquo e lsquolsquoArsquorsquo (doppie virgolette semplici)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 159
ᾱ coincide con il numerale 1 α egrave la prima lettera dellrsquoalfabeto ed inoltre α´ egrave esattamente quello che va scritto nella tabella Potremmo dirci che il sostantivo στοιχεῖον chiude la questione la sua presenza congiunta ad un ipotetico α´ renderebbe la descrizione ridondante o inappropriata90 Ma a parte il fatto che α egrave proprio τὸ πρῶτον στοιχεῖον il segno α´ cat-tura in fondo il cuore della descrizione di uno στοιχεῖον ἔχον lsaquoγραμμὴνrsaquo ἀνατείνουσαν
Terzo problema Lrsquoautore dei Prolegomena che si arresta allrsquoesem-pio dei minuti primi non dice quanti apici occorre mettere sulle lettere numerali che identificano gli ordini superiori al primo se uno soltanto come nel caso diofanteo e delle frazioni unitarie o in numero uguale alla loro denominazione (cioegrave pari al numero denotato dal numerale stesso su cui vanno posti) come effettivamente avviene nei mano-scritti dei Prolegomena La tabella egrave quindi sottodeterminata dalla sua descrizione anzi in un certo senso prende il sopravvento su di essa la pratica di marcare i numerali di molteplicitagrave con gli apici che compe-tono allrsquoordine cui appartengono viene trasferita ai segni per gli ordini stessi per supplire ad una descrizione carente di questi ultimi E la tabella egrave sottodeterminata dalla descrizione in quanto egrave la descrizione di una tabella reale ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις laquocome nello lsaquoschemarsaquo espostoraquo leggiamo a un certo punto del testo
3) La linea a zig-zag Non possiamo che applaudire a questo geniale espediente grafico lo troviamo messo in opera solo nel Marc gr 313 Per quanto lrsquoautore non faccia parola di ciograve nel corso della sua descrizione la linea spezzata egrave intesa dover lsquosaltarersquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue Il copista del codice marciano effettua correttamente due salti nella prima delle sue tabelle (tav 4) ma inserisce un lsquodentersquo in piugrave in quella che considera corretta (tav 5) La linea a zig-zag egrave incompatibile con la presenza di linee di giustificazione nella tabella che in effetti mancano nel Marc gr 313 ciograve induce gli errori di allineamento dei primi 5 quozienti parziali di cui egrave vittima il copista Probabilmente per questo motivo in nessuno degli apografi del Vat gr 1594 la linea a zig-zag figura nella tabella inquadrata come si conviene da una (doppia) cornice esterna e le cui colonne sono appunto separate da linee verticali (tav 7b Vat gr 184 f 17v e tav 8 Par gr 2390 f 9v cui egrave sostanzialmente identica la tabella del Marc gr 314 che si trova
90 Trascuro lrsquoabbreviazione αο = πρῶτος percheacute la desinenza non egrave quella richiesta neacute nella frase (egrave richiesto πρῶτον) neacute nella tabella (πρῶτα)
Fabio Acerbi160
al f 248r ndash ma la mancanza di linee orizzontali causa un gigantesco pa-sticcio nel codice vaticano) Alla recensione bizantina che dipende per il suo testo di base dal Vat gr 1594 e quindi non trova la linea a zig-zag nella tabella non resta che sopprimere la sua descrizione ndash ma proprio per questo motivo e finalmente diventa possibile tracciare un apparato completo di linee di giustificazione (tav 9 Laur Plut 89 sup 48 f 14v) Dato che la descrizione di Teone di questo procedimento di divi-sione non fa cenno allrsquoesistenza della linea a zig-zag viene da chiedersi se essa non costituisca un espediente escogitato dallrsquoautore dei Prolegomena per vivacizzare la procedura originale di Pappo
4) Discrepanze tra descrizione e tabella Il gioco delle minime va-rianti mostra che la divisione era stata eseguita (e trasmessa) corret-tamente tutti i valori numerici sono esatti La tabella nel Marc gr 313 presenta perograve alcune discrepanze con la propria descrizione Essa omette (ma non nella versione lsquoscorrettarsquo lrsquoomissione non si riscontra neanche nel Par gr 2390) il segno per laquorestoraquo di fronte ai resti par-ziali ma aggiunge lrsquoindicazione della loro specie Essa trasforma invece come abbiamo visto le indicazioni di specie che seguono i quozienti parziali in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordinali corri-spondenti La descrizione prevede di chiudere la tabella con il risultato καὶ συνάγων ἅπαντα τὰ ἐκ τῶν μερισθέντων μερῶν λεπτὰ σημειοῦται ὑπὸ πάντας οὕτως γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoe raccogliendo tutti i minuti che provengono dalle parti divise lsaquoPapporsaquo nota sotto tutto cosigrave Ris 0 59 8 17 13 12 31raquo ma sotto la tabella tutta la tradizione ci consegna qualcosa di piugrave articolato ὁ ζητούμενος καθ᾽ ὃν μερίζεται ὁ τξε ιδ´ μη´´ π(αρὰ) τὸν τξ γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoil lsaquonumerorsaquo cercato secondo cui 365 14 48 egrave diviso per 360 risulta 0 59 8 17 13 12 31raquo frase che del resto contiene due errori lrsquoinversione del dividendo e del divisore e la confusione tra segno convenzionale (iuxta descrizione) e abbreviazione (come nella frase) nel caso di γι Oltre ad eliminare la linea a zig-zag91 la recensione bizantina sopprime dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali e modifica come abbiamo visto al punto 2 le loro descrizioni in quelle di apici associati diretta-mente ai numerali di molteplicitagrave
91 Le due righe che nella recensione di base contengono solo i resti parziali minori di 160 del divisore ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue sono in parte completate con lrsquoindicazione abbreviata ἀνάλ(υσις) laquoanalisiraquo il termine greco per questa procedura di riduzione In un sussulto di ipercorrettismo matematico tali resti parziali ridotti non sono preceduti dal segno per laquorestoraquo come nel Par gr 2390 ma da quello per laquorisultatoraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 161
Gli esempi che abbiamo discusso mostrano come i problemi di notazione pesino e non poco sullrsquoespressione discorsiva di un algorit-mo matematico lrsquoente di riferimento per lsquoformularersquo il procedimento di divisione fu considerata la tabella cioegrave un oggetto la cui costitu-zione egrave legata piugrave ad una pratica grafica che a considerazioni logico- algoritmiche non la sua descrizione che in effetti finisce per determi-nare la tabella in maniera non univoca Di questa sottodeterminazione si fa testimone la traiettoria che abbiamo cercato di seguire nelle mani di copisti e revisori il procedimento di divisione si modifica a volte in aspetti secondari a volte in punti piugrave sostanziali ndash fino a rendere neces-saria una radicale revisione della sua descrizione per renderla conforme alla tabella ndash in ogni caso mai per ragioni squisitamente matematiche92
Abstract
The article presents and discusses in detail two passages from the anonymous Prolegomena to the Almagest a VIth century primer to the elementary procedures of calculation needed in Ptolemyrsquos Almagest In the two passages we may follow the complex interplay between mathematical notation the auctor who employed and described it the tachygrapher who transcribed it in vivo copyists who reproduced it correctors who modified it Along this path misgivings and errors arise in the transmission of abbreviations and paratextual units such as diagrams tables operational schemes
Fabio AcerbiCNRS UMR8560 Centre Alexandre Koyreacute
fabacerbigmailcom
92 Sono grato a Daniele Bianconi Lucio del Corso Jean Lempire per alcune preziose indicazioni
AOO = Archimedis opera omnia cum commentariis Eutocii ed J L Heiberg I-III Lipsiae 1910-1915
DOO = Diophanti Alexandrini opera omnia cum Graecis commentariis ed P Tannery I-II Lipsiae 1893-1895
GC = Le laquoGrand Commentaireraquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Mogenet ndash A Tihon I-III Cittagrave del Vaticano 1985-1999
iA = Commentaires de Pappus et de Theacuteon drsquoAlexandrie sur lrsquoAlmageste ed A Rome I-III con paginazione continua Cittagrave del Vaticano 1931-1943
HOO = Heronis Alexandrini opera quae supersunt omnia ed G Schmidt ndash L Nix ndash W Schmidt ndash H Schoene ndash J L Heiberg I-V Lipsiae 1899-1914
PC = Le ldquoPetit Commentairerdquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed A Tihon Cittagrave del Vaticano 1978
POO = Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia ed J L Heiberg I-II in 3 parti Lipsiae 1898-1907
RGK = Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600 I Handschriften aus Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln II Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs und Nachtraumlge zu den Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln III Handschriften aus Bibliotheken Roms mit dem Vatikan A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg unter Mitarbeit von D Harlfinger und P Eleuteri B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln Wien 1981-1997 (Oumlsterreichische Akademie der Wissenschaften Veroumlffentlichungen der Kommission fuumlr Byzantinistik III1-3 A-C)
Sigla
Acerbi 2010 = F Acerbi Il silenzio delle sirene La matematica greca antica Roma 2010
Acerbi 2012 = F Acerbi I codici stilistici della matematica greca dimostrazioni procedure algoritmi laquoQUCCraquo 1012 (2012) pp 167-214
Acerbi et al 2010 = F Acerbi ndash N Vinel ndash B Vitrac Les Proleacutegomegravenes agrave lrsquoAlmageste Une eacutedition agrave partir des manuscrits les plus anciens Introduction geacuteneacuterale ndash Parties I-III laquoSCIAMVSraquo 11 (2010) pp 53-210
Agati 1992 = M L Agati La minuscola laquoBouleteacuteeraquo Cittagrave del Vaticano 1992
Belger 1881 = C Belger Ein neues Fragmentum mathematicum Bobiense laquoHermesraquo 16 (1881) pp 261-284
Bianconi 2005a = D Bianconi La biblioteca di Cora tra Massimo Planude e Niceforo Gregora Una questione di mani laquoSampTraquo 3 (2005) pp 391-438
Bianconi 2005b = D Bianconi Tessalonica nellrsquoetagrave dei Paleologi Le pratiche intellettuali nel riflesso della cultura scritta Paris 2005
Bianconi 2006a = D Bianconi Le pietre e il ponte ovvero identificazioni di mani e storia della cultura laquoBizantinisticaraquo 8 (2006) pp 135-181
Bianconi 2006b = D Bianconi Qualcosa di nuovo su Giovanni Catrario laquoMEGraquo 6 (2006) pp 69-91
Cavallo 1977 = G Cavallo Funzione e strutture della maiuscola greca tra i secoli VIII-XI in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Colloque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 95-137
Cereteli 1904 = G F Cereteli De compendiis scripturae codicum Graecorum praecipue Petropolitanorum et Mosquensium anni nota instructorum Sankt-Petersburg 1904
De Gregorio 2000 = G De Gregorio Materiali vecchi e nuovi per uno studio della minu-scola greca fra VII e IX secolo in G Prato (a cura di) I manoscritti greci tra riflessione e dibattito Atti del V Colloquio Internazionale di Paleografia Greca Cremona 4-10 ottobre 1998 Firenze 2000 pp 83-151
Follieri 1977 = E Follieri La minuscola libraria dei secoli IX e X in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Col-loque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 139-165
Fonkič 2005 = B Fonkič Venecianskaia rukopisrsquo laquoAlrsquomagestaraquo Ptolemeja (Marc gr 313690) o datirovke i proischoždenii kodeksa laquoVDIraquo s III 254 (2005) pp 162-167
Fowler 1999 = D H Fowler The Mathematics of Platorsquos Academy A New Reconstruction Second Edition Oxford 1999
Bibliografia
Fabio Acerbi164
Gerstinger ndash Vogel 1932 = H Gerstinger ndash K Vogel Eine stereometrische Aufgaben-sammlung im Papyrus Graecus [sic] Vindobonensis 19996 laquoMitteilungen aus der Papy-russammlung der Nationalbibliothek in Wienraquo Neue Serie Folge 1 Griechische literarische Papyri 1 Wien 1932 pp 11-76
Heiberg 1927 = Mathematici Graeci Minores ed J L Heiberg Kjoslashbenhavn 1927
Hultsch 1876-1878 = Pappi Alexandrini Collectionis quae supersunt ed F Hultsch I-III Berlin 1876-1878
Janz 2003 = T Janz The Scribes and the Date of the Vat gr 1291 in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae X Cittagrave del Vaticano 2003 pp 159-180
Jones 1990 = Ptolemyrsquos First Commentator ed A Jones Philadelphia 1990
Jones 1999 = Astronomical Papyri from Oxyrhynchus ed A Jones I-II Philadelphia 1999
Jones 2005 = A Jones Ptolemyrsquos Canobic Inscription and Heliodorusrsquo Observation Reports laquoSCIAMVSraquo 6 (2005) pp 53-97
Lempire 2014 = Steacutephanos drsquoAlexandrie Le commentaire aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Lempire Louvain 2014
Leurquin 1990 = Theacuteodore Meacuteliteacuteniote Tribiblos astronomique Livre I ed R Leurquin Amsterdam 1990
Leurquin 1991 = R Leurquin Un manuscrit autographe de la Tribiblos Astronomique de Theacuteodore Meacuteliteacuteniote le Vaticanus graecus 792 laquoScriptoriumraquo 45 (1991) pp 145-162
Maas 1927 = P Maas Griechische Palaeographie in A Gercke ndash E Norden (hrsg von) Einleitung in die Altertumswissenschaft I9 Leipzig 1927 pp 69-80
Martinelli Tempesta 2010 = S Martinelli Tempesta Il codice Milano Biblioteca Am-brosiana B 75 sup (gr 104) e lrsquoevoluzione della scrittura di Giovanni Scutariota in A B Garciacutea ndash I Peacuterez Martiacuten (ed by) The Legacy of Bernard de Montfaucon Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting Proceedings of the Seventh Inter-national Colloquium of Greek Palaeography Madrid-Salamanca 15-20 September 2008 Turnhout 2010 pp 171-186
Mazzucchi 1994 = C M Mazzucchi Leggere i classici durante la catastrofe (Costantino-poli maggio-agosto 1203) le note marginali al Diodoro Siculo Vaticano gr 130 Parte prima stratigrafia laquoAevumraquo 68 (1994) pp 164-218
Mioni 1976 = E Mioni Bessarione scriba e alcuni suoi collaboratori in Miscellanea marcia-na di studi bessarionei Padova 1976 pp 263-323
Mioni 1985 = Codices graeci manuscripti Bibliothecae Divi Marci Venetiarum II Thesaurus Antiquus Codices 300-625 recensuit E Mioni Roma 1985
Mogenet 1962 = J Mogenet Une scholie ineacutedite du Vat gr 1594 sur les rapports entre lrsquoastronomie arabe et Byzance laquoOsirisraquo 14 (1962) pp 198-221
Mogenet et al 1983 = Niceacutephore Greacutegoras Calcul de lrsquoeacuteclipse de soleil du 16 juillet 1330 ed J Mogenet ndash A Tihon ndash R Royez ndash A Berg Amsterdam 1983
Mondrain 2002 = B Mondrain Maxime Planude Niceacutephore Greacutegoras et Ptoleacutemeacutee laquoPa-laeoslavicaraquo 10 (2002) pp 312-322
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 165
Mondrain 2004 = B Mondrain Lrsquoancien empereur Jean VI Cantacuzegravene et ses copistes in A Rigo (a cura di) Gregorio Palamas e oltre Studi e documenti sulle controversie teologiche del XIV secolo bizantino Firenze 2004 pp 249-296
Mondrain 2007 = B Mondrain Les eacutecritures dans les manuscrits byzantins du XIV e siegravecle Quelques probleacutematiques laquoRSBNraquo n s 44 (2007) pp 157-196
Peacuterez Martiacuten 2006 = I Peacuterez Martiacuten Maxime Planude et le Diophantus Matritensis (Madrid Biblioteca Nacional ms 4678) un paradigme de la reacutecupeacuteration des textes anciens dans la ldquorenaissance paleacuteologuerdquo laquoByzantionraquo 76 (2006) pp 433-462
Peacuterez Martiacuten 2008 = I Peacuterez Martiacuten El lsquoestilo Hodegosrsquo y su proyeccioacuten en las escrituras constantinopolitanas laquoSampTraquo 6 (2008) pp 389-458
Perria 1991 = L Perria Scrittura e ornamentazione nei codici della laquocollezione filosoficaraquo laquoRSBNraquo n s 28 (1991) pp 45-111
Rollo 2012 = A Rollo LrsquoArchimede di Giorgio Valla in V Fera ndash D Gionta ndash A Rollo (a cura di) Archimede e le sue fortune Atti del Convegno di Siracusa-Messina 24-26 giugno 2008 Messina 2012 pp 99-147
Rome 1927 = A Rome Membra disjecta laquoRBenraquo 39 (1927) pp 187-188
Rome 1938 = A Rome Un manuscrit de la bibliothegraveque de Boniface VIII agrave la Meacutediceacuteenne de Florence laquoACraquo 7 (1938) pp 261-268
Ronconi 2013 = F Ronconi La collection philosophique un fantocircme historique laquoScripto-riumraquo 67 (2013) pp 119-140
Tannery ndash Steacutephanou 1940 = Quadrivium de Georges Pachymegravere ed P Tannery ndash E Steacutephanou Cittagrave del Vaticano 1940
Tihon 2011 = Πτολεμαίου Πρόχειροι Κανόνες Les Tables faciles de Ptoleacutemeacutee vol Ia Tables A1-A2 ed A Tihon Leuven 2011
Traube 1907 = L Traube Nomina Sacra Versuch einer Geschichte der christlichen Kuumlrzung Muumlnchen 1907
Vogel 1936 = K Vogel Beitraumlge zur griechischen Logistik laquoSBAWraquo Mathematisch-natur-wissenschaftliche Abteilung Jahrgang 1936 pp 357-472
Wouters 1979 = A Wouters The Grammatical Papyri from Graeco-Roman Egypt Contri-butions to the Study of the lsquoArs Grammaticarsquo in Antiquity Brussel 1979
F ACERBI Tav 1
b Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 65r
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 284 f 160r
F ACERBITav 2
b Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 13r
a Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 19v
F ACERBI Tav 3
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 136v
F ACERBITav 4
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17r
F ACERBI Tav 5
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17v
F ACERBITav 6
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 7v
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
Fabio Acerbi158
sotto silenzio e la presenza dellrsquoapice la rende inutile88 Si tratta della stessa convenzione diofantea e coincide ancora con la notazione per i numerali ordinali e per le frazioni unitarie che egrave corrente nei mano- scritti matematici greci per questo motivo non percheacute la descrizione sia particolarmente perspicua nessuno dei copisti della recensione an-tica ha incertezze apici Ma questi apici si rintracciano soltanto sulle indicazioni di specie non contemplate dalla descrizione che sono ante-poste ai resti parziali a fianco dei quozienti parziali i segni di specie sono invece trasformati in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordi-nali corrispondenti del tipo πρωτ tavv 5 e 7b-8 Il recensore bizantino taglia invece la testa al toro elimina dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali elimina la seconda menzione della laquolet-tera Araquo contestualmente allrsquoazzeramento dellrsquoespediente della linea a zig-zag (si veda il punto seguente) modifica la descrizione che contiene la prima menzione in quella dellrsquoapice associato direttamente ai nume-rali di molteplicitagrave riciclando addirittura lrsquoalpha per adibirlo a desi-gnare un numero cardinale (come sorprendersi) τιθεὶς ἐπάνω αὐτῶν ὀξεῖαν ᾱ laquoponendo al di sopra di essi [scil dei 50 minuti primi] 1 solo lsaquoaccentorsaquo acutoraquo La scelta del recensore egrave assennata che rechi una barra o un apice in una tabella un alpha denota un numero non un numero drsquoordine
Secondo problema da tenere ben distinto dal precedente Cosa ci vuole sul segno α per la lettera alpha menzionata nella frase τὸ ᾱ στοιχεῖον [hellip] σημαῖνον τὸ εἶδος laquolettera A [hellip] che significa la specieraquo89 Unrsquooc-chiata allrsquoapparato critico rivela una bella incertezza nei manoscritti Z scrive sempre ᾱ e in un caso lo fa anche P MS optano sempre per α´ C per α P scrive nellrsquoaltro caso αο Per quanto solo la barra sia congrua con il senso della frase in quanto la lettera alpha egrave qui menzionata (si tratta di un oggetto che compare nella tabella) e non cambia niente se essa egrave accompagnata dal suo nome di genere στοιχεῖον ad un livello grafico lrsquoincertezza fra il segno ᾱ che denota laquola lettera αraquo e il segno α´ (o lrsquoabbreviazione αο) per una forma di πρῶτος egrave per piugrave versi giustificata
88 Detto in altri termini la barra egrave uno strumento grafico non matematico e quindi la sua presenza non va segnalata mentre un apice lo egrave e la sua presenza lo deve
89 Notare che in questa frase il primo α non vuole la barra (egrave menzionato allrsquointerno di una frase che impiega convenzioni moderne) il secondo sigrave (idem ma con convenzioni antiche) ndash e nella traduzione la scelta di denotarlo con A (senza virgolette) e non con lsquoArsquo (con virgolette) egrave del tutto arbitraria ndash si noti inoltre che le necessarie precisazioni laquosenzacon virgoletteraquo mostrano che le lingue moderne palesano difficoltagrave analoghe a quelle del greco antico per quanto riguarda i livelli denotativi in ambito metadiscorsivo per non usare le due parentetiche avrei dovuto scrivere rispettivamente lsquoArsquo e lsquolsquoArsquorsquo (doppie virgolette semplici)
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 159
ᾱ coincide con il numerale 1 α egrave la prima lettera dellrsquoalfabeto ed inoltre α´ egrave esattamente quello che va scritto nella tabella Potremmo dirci che il sostantivo στοιχεῖον chiude la questione la sua presenza congiunta ad un ipotetico α´ renderebbe la descrizione ridondante o inappropriata90 Ma a parte il fatto che α egrave proprio τὸ πρῶτον στοιχεῖον il segno α´ cat-tura in fondo il cuore della descrizione di uno στοιχεῖον ἔχον lsaquoγραμμὴνrsaquo ἀνατείνουσαν
Terzo problema Lrsquoautore dei Prolegomena che si arresta allrsquoesem-pio dei minuti primi non dice quanti apici occorre mettere sulle lettere numerali che identificano gli ordini superiori al primo se uno soltanto come nel caso diofanteo e delle frazioni unitarie o in numero uguale alla loro denominazione (cioegrave pari al numero denotato dal numerale stesso su cui vanno posti) come effettivamente avviene nei mano-scritti dei Prolegomena La tabella egrave quindi sottodeterminata dalla sua descrizione anzi in un certo senso prende il sopravvento su di essa la pratica di marcare i numerali di molteplicitagrave con gli apici che compe-tono allrsquoordine cui appartengono viene trasferita ai segni per gli ordini stessi per supplire ad una descrizione carente di questi ultimi E la tabella egrave sottodeterminata dalla descrizione in quanto egrave la descrizione di una tabella reale ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις laquocome nello lsaquoschemarsaquo espostoraquo leggiamo a un certo punto del testo
3) La linea a zig-zag Non possiamo che applaudire a questo geniale espediente grafico lo troviamo messo in opera solo nel Marc gr 313 Per quanto lrsquoautore non faccia parola di ciograve nel corso della sua descrizione la linea spezzata egrave intesa dover lsquosaltarersquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue Il copista del codice marciano effettua correttamente due salti nella prima delle sue tabelle (tav 4) ma inserisce un lsquodentersquo in piugrave in quella che considera corretta (tav 5) La linea a zig-zag egrave incompatibile con la presenza di linee di giustificazione nella tabella che in effetti mancano nel Marc gr 313 ciograve induce gli errori di allineamento dei primi 5 quozienti parziali di cui egrave vittima il copista Probabilmente per questo motivo in nessuno degli apografi del Vat gr 1594 la linea a zig-zag figura nella tabella inquadrata come si conviene da una (doppia) cornice esterna e le cui colonne sono appunto separate da linee verticali (tav 7b Vat gr 184 f 17v e tav 8 Par gr 2390 f 9v cui egrave sostanzialmente identica la tabella del Marc gr 314 che si trova
90 Trascuro lrsquoabbreviazione αο = πρῶτος percheacute la desinenza non egrave quella richiesta neacute nella frase (egrave richiesto πρῶτον) neacute nella tabella (πρῶτα)
Fabio Acerbi160
al f 248r ndash ma la mancanza di linee orizzontali causa un gigantesco pa-sticcio nel codice vaticano) Alla recensione bizantina che dipende per il suo testo di base dal Vat gr 1594 e quindi non trova la linea a zig-zag nella tabella non resta che sopprimere la sua descrizione ndash ma proprio per questo motivo e finalmente diventa possibile tracciare un apparato completo di linee di giustificazione (tav 9 Laur Plut 89 sup 48 f 14v) Dato che la descrizione di Teone di questo procedimento di divi-sione non fa cenno allrsquoesistenza della linea a zig-zag viene da chiedersi se essa non costituisca un espediente escogitato dallrsquoautore dei Prolegomena per vivacizzare la procedura originale di Pappo
4) Discrepanze tra descrizione e tabella Il gioco delle minime va-rianti mostra che la divisione era stata eseguita (e trasmessa) corret-tamente tutti i valori numerici sono esatti La tabella nel Marc gr 313 presenta perograve alcune discrepanze con la propria descrizione Essa omette (ma non nella versione lsquoscorrettarsquo lrsquoomissione non si riscontra neanche nel Par gr 2390) il segno per laquorestoraquo di fronte ai resti par-ziali ma aggiunge lrsquoindicazione della loro specie Essa trasforma invece come abbiamo visto le indicazioni di specie che seguono i quozienti parziali in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordinali corri-spondenti La descrizione prevede di chiudere la tabella con il risultato καὶ συνάγων ἅπαντα τὰ ἐκ τῶν μερισθέντων μερῶν λεπτὰ σημειοῦται ὑπὸ πάντας οὕτως γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoe raccogliendo tutti i minuti che provengono dalle parti divise lsaquoPapporsaquo nota sotto tutto cosigrave Ris 0 59 8 17 13 12 31raquo ma sotto la tabella tutta la tradizione ci consegna qualcosa di piugrave articolato ὁ ζητούμενος καθ᾽ ὃν μερίζεται ὁ τξε ιδ´ μη´´ π(αρὰ) τὸν τξ γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoil lsaquonumerorsaquo cercato secondo cui 365 14 48 egrave diviso per 360 risulta 0 59 8 17 13 12 31raquo frase che del resto contiene due errori lrsquoinversione del dividendo e del divisore e la confusione tra segno convenzionale (iuxta descrizione) e abbreviazione (come nella frase) nel caso di γι Oltre ad eliminare la linea a zig-zag91 la recensione bizantina sopprime dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali e modifica come abbiamo visto al punto 2 le loro descrizioni in quelle di apici associati diretta-mente ai numerali di molteplicitagrave
91 Le due righe che nella recensione di base contengono solo i resti parziali minori di 160 del divisore ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue sono in parte completate con lrsquoindicazione abbreviata ἀνάλ(υσις) laquoanalisiraquo il termine greco per questa procedura di riduzione In un sussulto di ipercorrettismo matematico tali resti parziali ridotti non sono preceduti dal segno per laquorestoraquo come nel Par gr 2390 ma da quello per laquorisultatoraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 161
Gli esempi che abbiamo discusso mostrano come i problemi di notazione pesino e non poco sullrsquoespressione discorsiva di un algorit-mo matematico lrsquoente di riferimento per lsquoformularersquo il procedimento di divisione fu considerata la tabella cioegrave un oggetto la cui costitu-zione egrave legata piugrave ad una pratica grafica che a considerazioni logico- algoritmiche non la sua descrizione che in effetti finisce per determi-nare la tabella in maniera non univoca Di questa sottodeterminazione si fa testimone la traiettoria che abbiamo cercato di seguire nelle mani di copisti e revisori il procedimento di divisione si modifica a volte in aspetti secondari a volte in punti piugrave sostanziali ndash fino a rendere neces-saria una radicale revisione della sua descrizione per renderla conforme alla tabella ndash in ogni caso mai per ragioni squisitamente matematiche92
Abstract
The article presents and discusses in detail two passages from the anonymous Prolegomena to the Almagest a VIth century primer to the elementary procedures of calculation needed in Ptolemyrsquos Almagest In the two passages we may follow the complex interplay between mathematical notation the auctor who employed and described it the tachygrapher who transcribed it in vivo copyists who reproduced it correctors who modified it Along this path misgivings and errors arise in the transmission of abbreviations and paratextual units such as diagrams tables operational schemes
Fabio AcerbiCNRS UMR8560 Centre Alexandre Koyreacute
fabacerbigmailcom
92 Sono grato a Daniele Bianconi Lucio del Corso Jean Lempire per alcune preziose indicazioni
AOO = Archimedis opera omnia cum commentariis Eutocii ed J L Heiberg I-III Lipsiae 1910-1915
DOO = Diophanti Alexandrini opera omnia cum Graecis commentariis ed P Tannery I-II Lipsiae 1893-1895
GC = Le laquoGrand Commentaireraquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Mogenet ndash A Tihon I-III Cittagrave del Vaticano 1985-1999
iA = Commentaires de Pappus et de Theacuteon drsquoAlexandrie sur lrsquoAlmageste ed A Rome I-III con paginazione continua Cittagrave del Vaticano 1931-1943
HOO = Heronis Alexandrini opera quae supersunt omnia ed G Schmidt ndash L Nix ndash W Schmidt ndash H Schoene ndash J L Heiberg I-V Lipsiae 1899-1914
PC = Le ldquoPetit Commentairerdquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed A Tihon Cittagrave del Vaticano 1978
POO = Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia ed J L Heiberg I-II in 3 parti Lipsiae 1898-1907
RGK = Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600 I Handschriften aus Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln II Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs und Nachtraumlge zu den Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln III Handschriften aus Bibliotheken Roms mit dem Vatikan A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg unter Mitarbeit von D Harlfinger und P Eleuteri B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln Wien 1981-1997 (Oumlsterreichische Akademie der Wissenschaften Veroumlffentlichungen der Kommission fuumlr Byzantinistik III1-3 A-C)
Sigla
Acerbi 2010 = F Acerbi Il silenzio delle sirene La matematica greca antica Roma 2010
Acerbi 2012 = F Acerbi I codici stilistici della matematica greca dimostrazioni procedure algoritmi laquoQUCCraquo 1012 (2012) pp 167-214
Acerbi et al 2010 = F Acerbi ndash N Vinel ndash B Vitrac Les Proleacutegomegravenes agrave lrsquoAlmageste Une eacutedition agrave partir des manuscrits les plus anciens Introduction geacuteneacuterale ndash Parties I-III laquoSCIAMVSraquo 11 (2010) pp 53-210
Agati 1992 = M L Agati La minuscola laquoBouleteacuteeraquo Cittagrave del Vaticano 1992
Belger 1881 = C Belger Ein neues Fragmentum mathematicum Bobiense laquoHermesraquo 16 (1881) pp 261-284
Bianconi 2005a = D Bianconi La biblioteca di Cora tra Massimo Planude e Niceforo Gregora Una questione di mani laquoSampTraquo 3 (2005) pp 391-438
Bianconi 2005b = D Bianconi Tessalonica nellrsquoetagrave dei Paleologi Le pratiche intellettuali nel riflesso della cultura scritta Paris 2005
Bianconi 2006a = D Bianconi Le pietre e il ponte ovvero identificazioni di mani e storia della cultura laquoBizantinisticaraquo 8 (2006) pp 135-181
Bianconi 2006b = D Bianconi Qualcosa di nuovo su Giovanni Catrario laquoMEGraquo 6 (2006) pp 69-91
Cavallo 1977 = G Cavallo Funzione e strutture della maiuscola greca tra i secoli VIII-XI in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Colloque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 95-137
Cereteli 1904 = G F Cereteli De compendiis scripturae codicum Graecorum praecipue Petropolitanorum et Mosquensium anni nota instructorum Sankt-Petersburg 1904
De Gregorio 2000 = G De Gregorio Materiali vecchi e nuovi per uno studio della minu-scola greca fra VII e IX secolo in G Prato (a cura di) I manoscritti greci tra riflessione e dibattito Atti del V Colloquio Internazionale di Paleografia Greca Cremona 4-10 ottobre 1998 Firenze 2000 pp 83-151
Follieri 1977 = E Follieri La minuscola libraria dei secoli IX e X in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Col-loque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 139-165
Fonkič 2005 = B Fonkič Venecianskaia rukopisrsquo laquoAlrsquomagestaraquo Ptolemeja (Marc gr 313690) o datirovke i proischoždenii kodeksa laquoVDIraquo s III 254 (2005) pp 162-167
Fowler 1999 = D H Fowler The Mathematics of Platorsquos Academy A New Reconstruction Second Edition Oxford 1999
Bibliografia
Fabio Acerbi164
Gerstinger ndash Vogel 1932 = H Gerstinger ndash K Vogel Eine stereometrische Aufgaben-sammlung im Papyrus Graecus [sic] Vindobonensis 19996 laquoMitteilungen aus der Papy-russammlung der Nationalbibliothek in Wienraquo Neue Serie Folge 1 Griechische literarische Papyri 1 Wien 1932 pp 11-76
Heiberg 1927 = Mathematici Graeci Minores ed J L Heiberg Kjoslashbenhavn 1927
Hultsch 1876-1878 = Pappi Alexandrini Collectionis quae supersunt ed F Hultsch I-III Berlin 1876-1878
Janz 2003 = T Janz The Scribes and the Date of the Vat gr 1291 in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae X Cittagrave del Vaticano 2003 pp 159-180
Jones 1990 = Ptolemyrsquos First Commentator ed A Jones Philadelphia 1990
Jones 1999 = Astronomical Papyri from Oxyrhynchus ed A Jones I-II Philadelphia 1999
Jones 2005 = A Jones Ptolemyrsquos Canobic Inscription and Heliodorusrsquo Observation Reports laquoSCIAMVSraquo 6 (2005) pp 53-97
Lempire 2014 = Steacutephanos drsquoAlexandrie Le commentaire aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Lempire Louvain 2014
Leurquin 1990 = Theacuteodore Meacuteliteacuteniote Tribiblos astronomique Livre I ed R Leurquin Amsterdam 1990
Leurquin 1991 = R Leurquin Un manuscrit autographe de la Tribiblos Astronomique de Theacuteodore Meacuteliteacuteniote le Vaticanus graecus 792 laquoScriptoriumraquo 45 (1991) pp 145-162
Maas 1927 = P Maas Griechische Palaeographie in A Gercke ndash E Norden (hrsg von) Einleitung in die Altertumswissenschaft I9 Leipzig 1927 pp 69-80
Martinelli Tempesta 2010 = S Martinelli Tempesta Il codice Milano Biblioteca Am-brosiana B 75 sup (gr 104) e lrsquoevoluzione della scrittura di Giovanni Scutariota in A B Garciacutea ndash I Peacuterez Martiacuten (ed by) The Legacy of Bernard de Montfaucon Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting Proceedings of the Seventh Inter-national Colloquium of Greek Palaeography Madrid-Salamanca 15-20 September 2008 Turnhout 2010 pp 171-186
Mazzucchi 1994 = C M Mazzucchi Leggere i classici durante la catastrofe (Costantino-poli maggio-agosto 1203) le note marginali al Diodoro Siculo Vaticano gr 130 Parte prima stratigrafia laquoAevumraquo 68 (1994) pp 164-218
Mioni 1976 = E Mioni Bessarione scriba e alcuni suoi collaboratori in Miscellanea marcia-na di studi bessarionei Padova 1976 pp 263-323
Mioni 1985 = Codices graeci manuscripti Bibliothecae Divi Marci Venetiarum II Thesaurus Antiquus Codices 300-625 recensuit E Mioni Roma 1985
Mogenet 1962 = J Mogenet Une scholie ineacutedite du Vat gr 1594 sur les rapports entre lrsquoastronomie arabe et Byzance laquoOsirisraquo 14 (1962) pp 198-221
Mogenet et al 1983 = Niceacutephore Greacutegoras Calcul de lrsquoeacuteclipse de soleil du 16 juillet 1330 ed J Mogenet ndash A Tihon ndash R Royez ndash A Berg Amsterdam 1983
Mondrain 2002 = B Mondrain Maxime Planude Niceacutephore Greacutegoras et Ptoleacutemeacutee laquoPa-laeoslavicaraquo 10 (2002) pp 312-322
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 165
Mondrain 2004 = B Mondrain Lrsquoancien empereur Jean VI Cantacuzegravene et ses copistes in A Rigo (a cura di) Gregorio Palamas e oltre Studi e documenti sulle controversie teologiche del XIV secolo bizantino Firenze 2004 pp 249-296
Mondrain 2007 = B Mondrain Les eacutecritures dans les manuscrits byzantins du XIV e siegravecle Quelques probleacutematiques laquoRSBNraquo n s 44 (2007) pp 157-196
Peacuterez Martiacuten 2006 = I Peacuterez Martiacuten Maxime Planude et le Diophantus Matritensis (Madrid Biblioteca Nacional ms 4678) un paradigme de la reacutecupeacuteration des textes anciens dans la ldquorenaissance paleacuteologuerdquo laquoByzantionraquo 76 (2006) pp 433-462
Peacuterez Martiacuten 2008 = I Peacuterez Martiacuten El lsquoestilo Hodegosrsquo y su proyeccioacuten en las escrituras constantinopolitanas laquoSampTraquo 6 (2008) pp 389-458
Perria 1991 = L Perria Scrittura e ornamentazione nei codici della laquocollezione filosoficaraquo laquoRSBNraquo n s 28 (1991) pp 45-111
Rollo 2012 = A Rollo LrsquoArchimede di Giorgio Valla in V Fera ndash D Gionta ndash A Rollo (a cura di) Archimede e le sue fortune Atti del Convegno di Siracusa-Messina 24-26 giugno 2008 Messina 2012 pp 99-147
Rome 1927 = A Rome Membra disjecta laquoRBenraquo 39 (1927) pp 187-188
Rome 1938 = A Rome Un manuscrit de la bibliothegraveque de Boniface VIII agrave la Meacutediceacuteenne de Florence laquoACraquo 7 (1938) pp 261-268
Ronconi 2013 = F Ronconi La collection philosophique un fantocircme historique laquoScripto-riumraquo 67 (2013) pp 119-140
Tannery ndash Steacutephanou 1940 = Quadrivium de Georges Pachymegravere ed P Tannery ndash E Steacutephanou Cittagrave del Vaticano 1940
Tihon 2011 = Πτολεμαίου Πρόχειροι Κανόνες Les Tables faciles de Ptoleacutemeacutee vol Ia Tables A1-A2 ed A Tihon Leuven 2011
Traube 1907 = L Traube Nomina Sacra Versuch einer Geschichte der christlichen Kuumlrzung Muumlnchen 1907
Vogel 1936 = K Vogel Beitraumlge zur griechischen Logistik laquoSBAWraquo Mathematisch-natur-wissenschaftliche Abteilung Jahrgang 1936 pp 357-472
Wouters 1979 = A Wouters The Grammatical Papyri from Graeco-Roman Egypt Contri-butions to the Study of the lsquoArs Grammaticarsquo in Antiquity Brussel 1979
F ACERBI Tav 1
b Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 65r
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 284 f 160r
F ACERBITav 2
b Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 13r
a Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 19v
F ACERBI Tav 3
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 136v
F ACERBITav 4
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17r
F ACERBI Tav 5
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17v
F ACERBITav 6
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 7v
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 159
ᾱ coincide con il numerale 1 α egrave la prima lettera dellrsquoalfabeto ed inoltre α´ egrave esattamente quello che va scritto nella tabella Potremmo dirci che il sostantivo στοιχεῖον chiude la questione la sua presenza congiunta ad un ipotetico α´ renderebbe la descrizione ridondante o inappropriata90 Ma a parte il fatto che α egrave proprio τὸ πρῶτον στοιχεῖον il segno α´ cat-tura in fondo il cuore della descrizione di uno στοιχεῖον ἔχον lsaquoγραμμὴνrsaquo ἀνατείνουσαν
Terzo problema Lrsquoautore dei Prolegomena che si arresta allrsquoesem-pio dei minuti primi non dice quanti apici occorre mettere sulle lettere numerali che identificano gli ordini superiori al primo se uno soltanto come nel caso diofanteo e delle frazioni unitarie o in numero uguale alla loro denominazione (cioegrave pari al numero denotato dal numerale stesso su cui vanno posti) come effettivamente avviene nei mano-scritti dei Prolegomena La tabella egrave quindi sottodeterminata dalla sua descrizione anzi in un certo senso prende il sopravvento su di essa la pratica di marcare i numerali di molteplicitagrave con gli apici che compe-tono allrsquoordine cui appartengono viene trasferita ai segni per gli ordini stessi per supplire ad una descrizione carente di questi ultimi E la tabella egrave sottodeterminata dalla descrizione in quanto egrave la descrizione di una tabella reale ὡς ἔχει ἡ ἔκθεσις laquocome nello lsaquoschemarsaquo espostoraquo leggiamo a un certo punto del testo
3) La linea a zig-zag Non possiamo che applaudire a questo geniale espediente grafico lo troviamo messo in opera solo nel Marc gr 313 Per quanto lrsquoautore non faccia parola di ciograve nel corso della sua descrizione la linea spezzata egrave intesa dover lsquosaltarersquo i resti parziali che sono minori di 160 del divisore e che sono ripresi ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue Il copista del codice marciano effettua correttamente due salti nella prima delle sue tabelle (tav 4) ma inserisce un lsquodentersquo in piugrave in quella che considera corretta (tav 5) La linea a zig-zag egrave incompatibile con la presenza di linee di giustificazione nella tabella che in effetti mancano nel Marc gr 313 ciograve induce gli errori di allineamento dei primi 5 quozienti parziali di cui egrave vittima il copista Probabilmente per questo motivo in nessuno degli apografi del Vat gr 1594 la linea a zig-zag figura nella tabella inquadrata come si conviene da una (doppia) cornice esterna e le cui colonne sono appunto separate da linee verticali (tav 7b Vat gr 184 f 17v e tav 8 Par gr 2390 f 9v cui egrave sostanzialmente identica la tabella del Marc gr 314 che si trova
90 Trascuro lrsquoabbreviazione αο = πρῶτος percheacute la desinenza non egrave quella richiesta neacute nella frase (egrave richiesto πρῶτον) neacute nella tabella (πρῶτα)
Fabio Acerbi160
al f 248r ndash ma la mancanza di linee orizzontali causa un gigantesco pa-sticcio nel codice vaticano) Alla recensione bizantina che dipende per il suo testo di base dal Vat gr 1594 e quindi non trova la linea a zig-zag nella tabella non resta che sopprimere la sua descrizione ndash ma proprio per questo motivo e finalmente diventa possibile tracciare un apparato completo di linee di giustificazione (tav 9 Laur Plut 89 sup 48 f 14v) Dato che la descrizione di Teone di questo procedimento di divi-sione non fa cenno allrsquoesistenza della linea a zig-zag viene da chiedersi se essa non costituisca un espediente escogitato dallrsquoautore dei Prolegomena per vivacizzare la procedura originale di Pappo
4) Discrepanze tra descrizione e tabella Il gioco delle minime va-rianti mostra che la divisione era stata eseguita (e trasmessa) corret-tamente tutti i valori numerici sono esatti La tabella nel Marc gr 313 presenta perograve alcune discrepanze con la propria descrizione Essa omette (ma non nella versione lsquoscorrettarsquo lrsquoomissione non si riscontra neanche nel Par gr 2390) il segno per laquorestoraquo di fronte ai resti par-ziali ma aggiunge lrsquoindicazione della loro specie Essa trasforma invece come abbiamo visto le indicazioni di specie che seguono i quozienti parziali in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordinali corri-spondenti La descrizione prevede di chiudere la tabella con il risultato καὶ συνάγων ἅπαντα τὰ ἐκ τῶν μερισθέντων μερῶν λεπτὰ σημειοῦται ὑπὸ πάντας οὕτως γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoe raccogliendo tutti i minuti che provengono dalle parti divise lsaquoPapporsaquo nota sotto tutto cosigrave Ris 0 59 8 17 13 12 31raquo ma sotto la tabella tutta la tradizione ci consegna qualcosa di piugrave articolato ὁ ζητούμενος καθ᾽ ὃν μερίζεται ὁ τξε ιδ´ μη´´ π(αρὰ) τὸν τξ γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoil lsaquonumerorsaquo cercato secondo cui 365 14 48 egrave diviso per 360 risulta 0 59 8 17 13 12 31raquo frase che del resto contiene due errori lrsquoinversione del dividendo e del divisore e la confusione tra segno convenzionale (iuxta descrizione) e abbreviazione (come nella frase) nel caso di γι Oltre ad eliminare la linea a zig-zag91 la recensione bizantina sopprime dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali e modifica come abbiamo visto al punto 2 le loro descrizioni in quelle di apici associati diretta-mente ai numerali di molteplicitagrave
91 Le due righe che nella recensione di base contengono solo i resti parziali minori di 160 del divisore ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue sono in parte completate con lrsquoindicazione abbreviata ἀνάλ(υσις) laquoanalisiraquo il termine greco per questa procedura di riduzione In un sussulto di ipercorrettismo matematico tali resti parziali ridotti non sono preceduti dal segno per laquorestoraquo come nel Par gr 2390 ma da quello per laquorisultatoraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 161
Gli esempi che abbiamo discusso mostrano come i problemi di notazione pesino e non poco sullrsquoespressione discorsiva di un algorit-mo matematico lrsquoente di riferimento per lsquoformularersquo il procedimento di divisione fu considerata la tabella cioegrave un oggetto la cui costitu-zione egrave legata piugrave ad una pratica grafica che a considerazioni logico- algoritmiche non la sua descrizione che in effetti finisce per determi-nare la tabella in maniera non univoca Di questa sottodeterminazione si fa testimone la traiettoria che abbiamo cercato di seguire nelle mani di copisti e revisori il procedimento di divisione si modifica a volte in aspetti secondari a volte in punti piugrave sostanziali ndash fino a rendere neces-saria una radicale revisione della sua descrizione per renderla conforme alla tabella ndash in ogni caso mai per ragioni squisitamente matematiche92
Abstract
The article presents and discusses in detail two passages from the anonymous Prolegomena to the Almagest a VIth century primer to the elementary procedures of calculation needed in Ptolemyrsquos Almagest In the two passages we may follow the complex interplay between mathematical notation the auctor who employed and described it the tachygrapher who transcribed it in vivo copyists who reproduced it correctors who modified it Along this path misgivings and errors arise in the transmission of abbreviations and paratextual units such as diagrams tables operational schemes
Fabio AcerbiCNRS UMR8560 Centre Alexandre Koyreacute
fabacerbigmailcom
92 Sono grato a Daniele Bianconi Lucio del Corso Jean Lempire per alcune preziose indicazioni
AOO = Archimedis opera omnia cum commentariis Eutocii ed J L Heiberg I-III Lipsiae 1910-1915
DOO = Diophanti Alexandrini opera omnia cum Graecis commentariis ed P Tannery I-II Lipsiae 1893-1895
GC = Le laquoGrand Commentaireraquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Mogenet ndash A Tihon I-III Cittagrave del Vaticano 1985-1999
iA = Commentaires de Pappus et de Theacuteon drsquoAlexandrie sur lrsquoAlmageste ed A Rome I-III con paginazione continua Cittagrave del Vaticano 1931-1943
HOO = Heronis Alexandrini opera quae supersunt omnia ed G Schmidt ndash L Nix ndash W Schmidt ndash H Schoene ndash J L Heiberg I-V Lipsiae 1899-1914
PC = Le ldquoPetit Commentairerdquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed A Tihon Cittagrave del Vaticano 1978
POO = Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia ed J L Heiberg I-II in 3 parti Lipsiae 1898-1907
RGK = Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600 I Handschriften aus Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln II Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs und Nachtraumlge zu den Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln III Handschriften aus Bibliotheken Roms mit dem Vatikan A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg unter Mitarbeit von D Harlfinger und P Eleuteri B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln Wien 1981-1997 (Oumlsterreichische Akademie der Wissenschaften Veroumlffentlichungen der Kommission fuumlr Byzantinistik III1-3 A-C)
Sigla
Acerbi 2010 = F Acerbi Il silenzio delle sirene La matematica greca antica Roma 2010
Acerbi 2012 = F Acerbi I codici stilistici della matematica greca dimostrazioni procedure algoritmi laquoQUCCraquo 1012 (2012) pp 167-214
Acerbi et al 2010 = F Acerbi ndash N Vinel ndash B Vitrac Les Proleacutegomegravenes agrave lrsquoAlmageste Une eacutedition agrave partir des manuscrits les plus anciens Introduction geacuteneacuterale ndash Parties I-III laquoSCIAMVSraquo 11 (2010) pp 53-210
Agati 1992 = M L Agati La minuscola laquoBouleteacuteeraquo Cittagrave del Vaticano 1992
Belger 1881 = C Belger Ein neues Fragmentum mathematicum Bobiense laquoHermesraquo 16 (1881) pp 261-284
Bianconi 2005a = D Bianconi La biblioteca di Cora tra Massimo Planude e Niceforo Gregora Una questione di mani laquoSampTraquo 3 (2005) pp 391-438
Bianconi 2005b = D Bianconi Tessalonica nellrsquoetagrave dei Paleologi Le pratiche intellettuali nel riflesso della cultura scritta Paris 2005
Bianconi 2006a = D Bianconi Le pietre e il ponte ovvero identificazioni di mani e storia della cultura laquoBizantinisticaraquo 8 (2006) pp 135-181
Bianconi 2006b = D Bianconi Qualcosa di nuovo su Giovanni Catrario laquoMEGraquo 6 (2006) pp 69-91
Cavallo 1977 = G Cavallo Funzione e strutture della maiuscola greca tra i secoli VIII-XI in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Colloque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 95-137
Cereteli 1904 = G F Cereteli De compendiis scripturae codicum Graecorum praecipue Petropolitanorum et Mosquensium anni nota instructorum Sankt-Petersburg 1904
De Gregorio 2000 = G De Gregorio Materiali vecchi e nuovi per uno studio della minu-scola greca fra VII e IX secolo in G Prato (a cura di) I manoscritti greci tra riflessione e dibattito Atti del V Colloquio Internazionale di Paleografia Greca Cremona 4-10 ottobre 1998 Firenze 2000 pp 83-151
Follieri 1977 = E Follieri La minuscola libraria dei secoli IX e X in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Col-loque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 139-165
Fonkič 2005 = B Fonkič Venecianskaia rukopisrsquo laquoAlrsquomagestaraquo Ptolemeja (Marc gr 313690) o datirovke i proischoždenii kodeksa laquoVDIraquo s III 254 (2005) pp 162-167
Fowler 1999 = D H Fowler The Mathematics of Platorsquos Academy A New Reconstruction Second Edition Oxford 1999
Bibliografia
Fabio Acerbi164
Gerstinger ndash Vogel 1932 = H Gerstinger ndash K Vogel Eine stereometrische Aufgaben-sammlung im Papyrus Graecus [sic] Vindobonensis 19996 laquoMitteilungen aus der Papy-russammlung der Nationalbibliothek in Wienraquo Neue Serie Folge 1 Griechische literarische Papyri 1 Wien 1932 pp 11-76
Heiberg 1927 = Mathematici Graeci Minores ed J L Heiberg Kjoslashbenhavn 1927
Hultsch 1876-1878 = Pappi Alexandrini Collectionis quae supersunt ed F Hultsch I-III Berlin 1876-1878
Janz 2003 = T Janz The Scribes and the Date of the Vat gr 1291 in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae X Cittagrave del Vaticano 2003 pp 159-180
Jones 1990 = Ptolemyrsquos First Commentator ed A Jones Philadelphia 1990
Jones 1999 = Astronomical Papyri from Oxyrhynchus ed A Jones I-II Philadelphia 1999
Jones 2005 = A Jones Ptolemyrsquos Canobic Inscription and Heliodorusrsquo Observation Reports laquoSCIAMVSraquo 6 (2005) pp 53-97
Lempire 2014 = Steacutephanos drsquoAlexandrie Le commentaire aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Lempire Louvain 2014
Leurquin 1990 = Theacuteodore Meacuteliteacuteniote Tribiblos astronomique Livre I ed R Leurquin Amsterdam 1990
Leurquin 1991 = R Leurquin Un manuscrit autographe de la Tribiblos Astronomique de Theacuteodore Meacuteliteacuteniote le Vaticanus graecus 792 laquoScriptoriumraquo 45 (1991) pp 145-162
Maas 1927 = P Maas Griechische Palaeographie in A Gercke ndash E Norden (hrsg von) Einleitung in die Altertumswissenschaft I9 Leipzig 1927 pp 69-80
Martinelli Tempesta 2010 = S Martinelli Tempesta Il codice Milano Biblioteca Am-brosiana B 75 sup (gr 104) e lrsquoevoluzione della scrittura di Giovanni Scutariota in A B Garciacutea ndash I Peacuterez Martiacuten (ed by) The Legacy of Bernard de Montfaucon Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting Proceedings of the Seventh Inter-national Colloquium of Greek Palaeography Madrid-Salamanca 15-20 September 2008 Turnhout 2010 pp 171-186
Mazzucchi 1994 = C M Mazzucchi Leggere i classici durante la catastrofe (Costantino-poli maggio-agosto 1203) le note marginali al Diodoro Siculo Vaticano gr 130 Parte prima stratigrafia laquoAevumraquo 68 (1994) pp 164-218
Mioni 1976 = E Mioni Bessarione scriba e alcuni suoi collaboratori in Miscellanea marcia-na di studi bessarionei Padova 1976 pp 263-323
Mioni 1985 = Codices graeci manuscripti Bibliothecae Divi Marci Venetiarum II Thesaurus Antiquus Codices 300-625 recensuit E Mioni Roma 1985
Mogenet 1962 = J Mogenet Une scholie ineacutedite du Vat gr 1594 sur les rapports entre lrsquoastronomie arabe et Byzance laquoOsirisraquo 14 (1962) pp 198-221
Mogenet et al 1983 = Niceacutephore Greacutegoras Calcul de lrsquoeacuteclipse de soleil du 16 juillet 1330 ed J Mogenet ndash A Tihon ndash R Royez ndash A Berg Amsterdam 1983
Mondrain 2002 = B Mondrain Maxime Planude Niceacutephore Greacutegoras et Ptoleacutemeacutee laquoPa-laeoslavicaraquo 10 (2002) pp 312-322
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 165
Mondrain 2004 = B Mondrain Lrsquoancien empereur Jean VI Cantacuzegravene et ses copistes in A Rigo (a cura di) Gregorio Palamas e oltre Studi e documenti sulle controversie teologiche del XIV secolo bizantino Firenze 2004 pp 249-296
Mondrain 2007 = B Mondrain Les eacutecritures dans les manuscrits byzantins du XIV e siegravecle Quelques probleacutematiques laquoRSBNraquo n s 44 (2007) pp 157-196
Peacuterez Martiacuten 2006 = I Peacuterez Martiacuten Maxime Planude et le Diophantus Matritensis (Madrid Biblioteca Nacional ms 4678) un paradigme de la reacutecupeacuteration des textes anciens dans la ldquorenaissance paleacuteologuerdquo laquoByzantionraquo 76 (2006) pp 433-462
Peacuterez Martiacuten 2008 = I Peacuterez Martiacuten El lsquoestilo Hodegosrsquo y su proyeccioacuten en las escrituras constantinopolitanas laquoSampTraquo 6 (2008) pp 389-458
Perria 1991 = L Perria Scrittura e ornamentazione nei codici della laquocollezione filosoficaraquo laquoRSBNraquo n s 28 (1991) pp 45-111
Rollo 2012 = A Rollo LrsquoArchimede di Giorgio Valla in V Fera ndash D Gionta ndash A Rollo (a cura di) Archimede e le sue fortune Atti del Convegno di Siracusa-Messina 24-26 giugno 2008 Messina 2012 pp 99-147
Rome 1927 = A Rome Membra disjecta laquoRBenraquo 39 (1927) pp 187-188
Rome 1938 = A Rome Un manuscrit de la bibliothegraveque de Boniface VIII agrave la Meacutediceacuteenne de Florence laquoACraquo 7 (1938) pp 261-268
Ronconi 2013 = F Ronconi La collection philosophique un fantocircme historique laquoScripto-riumraquo 67 (2013) pp 119-140
Tannery ndash Steacutephanou 1940 = Quadrivium de Georges Pachymegravere ed P Tannery ndash E Steacutephanou Cittagrave del Vaticano 1940
Tihon 2011 = Πτολεμαίου Πρόχειροι Κανόνες Les Tables faciles de Ptoleacutemeacutee vol Ia Tables A1-A2 ed A Tihon Leuven 2011
Traube 1907 = L Traube Nomina Sacra Versuch einer Geschichte der christlichen Kuumlrzung Muumlnchen 1907
Vogel 1936 = K Vogel Beitraumlge zur griechischen Logistik laquoSBAWraquo Mathematisch-natur-wissenschaftliche Abteilung Jahrgang 1936 pp 357-472
Wouters 1979 = A Wouters The Grammatical Papyri from Graeco-Roman Egypt Contri-butions to the Study of the lsquoArs Grammaticarsquo in Antiquity Brussel 1979
F ACERBI Tav 1
b Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 65r
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 284 f 160r
F ACERBITav 2
b Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 13r
a Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 19v
F ACERBI Tav 3
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 136v
F ACERBITav 4
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17r
F ACERBI Tav 5
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17v
F ACERBITav 6
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 7v
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
Fabio Acerbi160
al f 248r ndash ma la mancanza di linee orizzontali causa un gigantesco pa-sticcio nel codice vaticano) Alla recensione bizantina che dipende per il suo testo di base dal Vat gr 1594 e quindi non trova la linea a zig-zag nella tabella non resta che sopprimere la sua descrizione ndash ma proprio per questo motivo e finalmente diventa possibile tracciare un apparato completo di linee di giustificazione (tav 9 Laur Plut 89 sup 48 f 14v) Dato che la descrizione di Teone di questo procedimento di divi-sione non fa cenno allrsquoesistenza della linea a zig-zag viene da chiedersi se essa non costituisca un espediente escogitato dallrsquoautore dei Prolegomena per vivacizzare la procedura originale di Pappo
4) Discrepanze tra descrizione e tabella Il gioco delle minime va-rianti mostra che la divisione era stata eseguita (e trasmessa) corret-tamente tutti i valori numerici sono esatti La tabella nel Marc gr 313 presenta perograve alcune discrepanze con la propria descrizione Essa omette (ma non nella versione lsquoscorrettarsquo lrsquoomissione non si riscontra neanche nel Par gr 2390) il segno per laquorestoraquo di fronte ai resti par-ziali ma aggiunge lrsquoindicazione della loro specie Essa trasforma invece come abbiamo visto le indicazioni di specie che seguono i quozienti parziali in scritture abbreviate degli aggettivi numerali ordinali corri-spondenti La descrizione prevede di chiudere la tabella con il risultato καὶ συνάγων ἅπαντα τὰ ἐκ τῶν μερισθέντων μερῶν λεπτὰ σημειοῦται ὑπὸ πάντας οὕτως γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoe raccogliendo tutti i minuti che provengono dalle parti divise lsaquoPapporsaquo nota sotto tutto cosigrave Ris 0 59 8 17 13 12 31raquo ma sotto la tabella tutta la tradizione ci consegna qualcosa di piugrave articolato ὁ ζητούμενος καθ᾽ ὃν μερίζεται ὁ τξε ιδ´ μη´´ π(αρὰ) τὸν τξ γι ŏ νθ´ η´´ ιζ´´´ ιγ´´´´ ιβ´´´´´ λα´´´´´´ laquoil lsaquonumerorsaquo cercato secondo cui 365 14 48 egrave diviso per 360 risulta 0 59 8 17 13 12 31raquo frase che del resto contiene due errori lrsquoinversione del dividendo e del divisore e la confusione tra segno convenzionale (iuxta descrizione) e abbreviazione (come nella frase) nel caso di γι Oltre ad eliminare la linea a zig-zag91 la recensione bizantina sopprime dalla tabella tutte le indicazioni di specie dei quozienti parziali e modifica come abbiamo visto al punto 2 le loro descrizioni in quelle di apici associati diretta-mente ai numerali di molteplicitagrave
91 Le due righe che nella recensione di base contengono solo i resti parziali minori di 160 del divisore ridotti allrsquoordine sessagesimale successivo nella riga che segue sono in parte completate con lrsquoindicazione abbreviata ἀνάλ(υσις) laquoanalisiraquo il termine greco per questa procedura di riduzione In un sussulto di ipercorrettismo matematico tali resti parziali ridotti non sono preceduti dal segno per laquorestoraquo come nel Par gr 2390 ma da quello per laquorisultatoraquo
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 161
Gli esempi che abbiamo discusso mostrano come i problemi di notazione pesino e non poco sullrsquoespressione discorsiva di un algorit-mo matematico lrsquoente di riferimento per lsquoformularersquo il procedimento di divisione fu considerata la tabella cioegrave un oggetto la cui costitu-zione egrave legata piugrave ad una pratica grafica che a considerazioni logico- algoritmiche non la sua descrizione che in effetti finisce per determi-nare la tabella in maniera non univoca Di questa sottodeterminazione si fa testimone la traiettoria che abbiamo cercato di seguire nelle mani di copisti e revisori il procedimento di divisione si modifica a volte in aspetti secondari a volte in punti piugrave sostanziali ndash fino a rendere neces-saria una radicale revisione della sua descrizione per renderla conforme alla tabella ndash in ogni caso mai per ragioni squisitamente matematiche92
Abstract
The article presents and discusses in detail two passages from the anonymous Prolegomena to the Almagest a VIth century primer to the elementary procedures of calculation needed in Ptolemyrsquos Almagest In the two passages we may follow the complex interplay between mathematical notation the auctor who employed and described it the tachygrapher who transcribed it in vivo copyists who reproduced it correctors who modified it Along this path misgivings and errors arise in the transmission of abbreviations and paratextual units such as diagrams tables operational schemes
Fabio AcerbiCNRS UMR8560 Centre Alexandre Koyreacute
fabacerbigmailcom
92 Sono grato a Daniele Bianconi Lucio del Corso Jean Lempire per alcune preziose indicazioni
AOO = Archimedis opera omnia cum commentariis Eutocii ed J L Heiberg I-III Lipsiae 1910-1915
DOO = Diophanti Alexandrini opera omnia cum Graecis commentariis ed P Tannery I-II Lipsiae 1893-1895
GC = Le laquoGrand Commentaireraquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Mogenet ndash A Tihon I-III Cittagrave del Vaticano 1985-1999
iA = Commentaires de Pappus et de Theacuteon drsquoAlexandrie sur lrsquoAlmageste ed A Rome I-III con paginazione continua Cittagrave del Vaticano 1931-1943
HOO = Heronis Alexandrini opera quae supersunt omnia ed G Schmidt ndash L Nix ndash W Schmidt ndash H Schoene ndash J L Heiberg I-V Lipsiae 1899-1914
PC = Le ldquoPetit Commentairerdquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed A Tihon Cittagrave del Vaticano 1978
POO = Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia ed J L Heiberg I-II in 3 parti Lipsiae 1898-1907
RGK = Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600 I Handschriften aus Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln II Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs und Nachtraumlge zu den Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln III Handschriften aus Bibliotheken Roms mit dem Vatikan A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg unter Mitarbeit von D Harlfinger und P Eleuteri B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln Wien 1981-1997 (Oumlsterreichische Akademie der Wissenschaften Veroumlffentlichungen der Kommission fuumlr Byzantinistik III1-3 A-C)
Sigla
Acerbi 2010 = F Acerbi Il silenzio delle sirene La matematica greca antica Roma 2010
Acerbi 2012 = F Acerbi I codici stilistici della matematica greca dimostrazioni procedure algoritmi laquoQUCCraquo 1012 (2012) pp 167-214
Acerbi et al 2010 = F Acerbi ndash N Vinel ndash B Vitrac Les Proleacutegomegravenes agrave lrsquoAlmageste Une eacutedition agrave partir des manuscrits les plus anciens Introduction geacuteneacuterale ndash Parties I-III laquoSCIAMVSraquo 11 (2010) pp 53-210
Agati 1992 = M L Agati La minuscola laquoBouleteacuteeraquo Cittagrave del Vaticano 1992
Belger 1881 = C Belger Ein neues Fragmentum mathematicum Bobiense laquoHermesraquo 16 (1881) pp 261-284
Bianconi 2005a = D Bianconi La biblioteca di Cora tra Massimo Planude e Niceforo Gregora Una questione di mani laquoSampTraquo 3 (2005) pp 391-438
Bianconi 2005b = D Bianconi Tessalonica nellrsquoetagrave dei Paleologi Le pratiche intellettuali nel riflesso della cultura scritta Paris 2005
Bianconi 2006a = D Bianconi Le pietre e il ponte ovvero identificazioni di mani e storia della cultura laquoBizantinisticaraquo 8 (2006) pp 135-181
Bianconi 2006b = D Bianconi Qualcosa di nuovo su Giovanni Catrario laquoMEGraquo 6 (2006) pp 69-91
Cavallo 1977 = G Cavallo Funzione e strutture della maiuscola greca tra i secoli VIII-XI in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Colloque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 95-137
Cereteli 1904 = G F Cereteli De compendiis scripturae codicum Graecorum praecipue Petropolitanorum et Mosquensium anni nota instructorum Sankt-Petersburg 1904
De Gregorio 2000 = G De Gregorio Materiali vecchi e nuovi per uno studio della minu-scola greca fra VII e IX secolo in G Prato (a cura di) I manoscritti greci tra riflessione e dibattito Atti del V Colloquio Internazionale di Paleografia Greca Cremona 4-10 ottobre 1998 Firenze 2000 pp 83-151
Follieri 1977 = E Follieri La minuscola libraria dei secoli IX e X in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Col-loque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 139-165
Fonkič 2005 = B Fonkič Venecianskaia rukopisrsquo laquoAlrsquomagestaraquo Ptolemeja (Marc gr 313690) o datirovke i proischoždenii kodeksa laquoVDIraquo s III 254 (2005) pp 162-167
Fowler 1999 = D H Fowler The Mathematics of Platorsquos Academy A New Reconstruction Second Edition Oxford 1999
Bibliografia
Fabio Acerbi164
Gerstinger ndash Vogel 1932 = H Gerstinger ndash K Vogel Eine stereometrische Aufgaben-sammlung im Papyrus Graecus [sic] Vindobonensis 19996 laquoMitteilungen aus der Papy-russammlung der Nationalbibliothek in Wienraquo Neue Serie Folge 1 Griechische literarische Papyri 1 Wien 1932 pp 11-76
Heiberg 1927 = Mathematici Graeci Minores ed J L Heiberg Kjoslashbenhavn 1927
Hultsch 1876-1878 = Pappi Alexandrini Collectionis quae supersunt ed F Hultsch I-III Berlin 1876-1878
Janz 2003 = T Janz The Scribes and the Date of the Vat gr 1291 in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae X Cittagrave del Vaticano 2003 pp 159-180
Jones 1990 = Ptolemyrsquos First Commentator ed A Jones Philadelphia 1990
Jones 1999 = Astronomical Papyri from Oxyrhynchus ed A Jones I-II Philadelphia 1999
Jones 2005 = A Jones Ptolemyrsquos Canobic Inscription and Heliodorusrsquo Observation Reports laquoSCIAMVSraquo 6 (2005) pp 53-97
Lempire 2014 = Steacutephanos drsquoAlexandrie Le commentaire aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Lempire Louvain 2014
Leurquin 1990 = Theacuteodore Meacuteliteacuteniote Tribiblos astronomique Livre I ed R Leurquin Amsterdam 1990
Leurquin 1991 = R Leurquin Un manuscrit autographe de la Tribiblos Astronomique de Theacuteodore Meacuteliteacuteniote le Vaticanus graecus 792 laquoScriptoriumraquo 45 (1991) pp 145-162
Maas 1927 = P Maas Griechische Palaeographie in A Gercke ndash E Norden (hrsg von) Einleitung in die Altertumswissenschaft I9 Leipzig 1927 pp 69-80
Martinelli Tempesta 2010 = S Martinelli Tempesta Il codice Milano Biblioteca Am-brosiana B 75 sup (gr 104) e lrsquoevoluzione della scrittura di Giovanni Scutariota in A B Garciacutea ndash I Peacuterez Martiacuten (ed by) The Legacy of Bernard de Montfaucon Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting Proceedings of the Seventh Inter-national Colloquium of Greek Palaeography Madrid-Salamanca 15-20 September 2008 Turnhout 2010 pp 171-186
Mazzucchi 1994 = C M Mazzucchi Leggere i classici durante la catastrofe (Costantino-poli maggio-agosto 1203) le note marginali al Diodoro Siculo Vaticano gr 130 Parte prima stratigrafia laquoAevumraquo 68 (1994) pp 164-218
Mioni 1976 = E Mioni Bessarione scriba e alcuni suoi collaboratori in Miscellanea marcia-na di studi bessarionei Padova 1976 pp 263-323
Mioni 1985 = Codices graeci manuscripti Bibliothecae Divi Marci Venetiarum II Thesaurus Antiquus Codices 300-625 recensuit E Mioni Roma 1985
Mogenet 1962 = J Mogenet Une scholie ineacutedite du Vat gr 1594 sur les rapports entre lrsquoastronomie arabe et Byzance laquoOsirisraquo 14 (1962) pp 198-221
Mogenet et al 1983 = Niceacutephore Greacutegoras Calcul de lrsquoeacuteclipse de soleil du 16 juillet 1330 ed J Mogenet ndash A Tihon ndash R Royez ndash A Berg Amsterdam 1983
Mondrain 2002 = B Mondrain Maxime Planude Niceacutephore Greacutegoras et Ptoleacutemeacutee laquoPa-laeoslavicaraquo 10 (2002) pp 312-322
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 165
Mondrain 2004 = B Mondrain Lrsquoancien empereur Jean VI Cantacuzegravene et ses copistes in A Rigo (a cura di) Gregorio Palamas e oltre Studi e documenti sulle controversie teologiche del XIV secolo bizantino Firenze 2004 pp 249-296
Mondrain 2007 = B Mondrain Les eacutecritures dans les manuscrits byzantins du XIV e siegravecle Quelques probleacutematiques laquoRSBNraquo n s 44 (2007) pp 157-196
Peacuterez Martiacuten 2006 = I Peacuterez Martiacuten Maxime Planude et le Diophantus Matritensis (Madrid Biblioteca Nacional ms 4678) un paradigme de la reacutecupeacuteration des textes anciens dans la ldquorenaissance paleacuteologuerdquo laquoByzantionraquo 76 (2006) pp 433-462
Peacuterez Martiacuten 2008 = I Peacuterez Martiacuten El lsquoestilo Hodegosrsquo y su proyeccioacuten en las escrituras constantinopolitanas laquoSampTraquo 6 (2008) pp 389-458
Perria 1991 = L Perria Scrittura e ornamentazione nei codici della laquocollezione filosoficaraquo laquoRSBNraquo n s 28 (1991) pp 45-111
Rollo 2012 = A Rollo LrsquoArchimede di Giorgio Valla in V Fera ndash D Gionta ndash A Rollo (a cura di) Archimede e le sue fortune Atti del Convegno di Siracusa-Messina 24-26 giugno 2008 Messina 2012 pp 99-147
Rome 1927 = A Rome Membra disjecta laquoRBenraquo 39 (1927) pp 187-188
Rome 1938 = A Rome Un manuscrit de la bibliothegraveque de Boniface VIII agrave la Meacutediceacuteenne de Florence laquoACraquo 7 (1938) pp 261-268
Ronconi 2013 = F Ronconi La collection philosophique un fantocircme historique laquoScripto-riumraquo 67 (2013) pp 119-140
Tannery ndash Steacutephanou 1940 = Quadrivium de Georges Pachymegravere ed P Tannery ndash E Steacutephanou Cittagrave del Vaticano 1940
Tihon 2011 = Πτολεμαίου Πρόχειροι Κανόνες Les Tables faciles de Ptoleacutemeacutee vol Ia Tables A1-A2 ed A Tihon Leuven 2011
Traube 1907 = L Traube Nomina Sacra Versuch einer Geschichte der christlichen Kuumlrzung Muumlnchen 1907
Vogel 1936 = K Vogel Beitraumlge zur griechischen Logistik laquoSBAWraquo Mathematisch-natur-wissenschaftliche Abteilung Jahrgang 1936 pp 357-472
Wouters 1979 = A Wouters The Grammatical Papyri from Graeco-Roman Egypt Contri-butions to the Study of the lsquoArs Grammaticarsquo in Antiquity Brussel 1979
F ACERBI Tav 1
b Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 65r
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 284 f 160r
F ACERBITav 2
b Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 13r
a Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 19v
F ACERBI Tav 3
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 136v
F ACERBITav 4
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17r
F ACERBI Tav 5
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17v
F ACERBITav 6
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 7v
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 161
Gli esempi che abbiamo discusso mostrano come i problemi di notazione pesino e non poco sullrsquoespressione discorsiva di un algorit-mo matematico lrsquoente di riferimento per lsquoformularersquo il procedimento di divisione fu considerata la tabella cioegrave un oggetto la cui costitu-zione egrave legata piugrave ad una pratica grafica che a considerazioni logico- algoritmiche non la sua descrizione che in effetti finisce per determi-nare la tabella in maniera non univoca Di questa sottodeterminazione si fa testimone la traiettoria che abbiamo cercato di seguire nelle mani di copisti e revisori il procedimento di divisione si modifica a volte in aspetti secondari a volte in punti piugrave sostanziali ndash fino a rendere neces-saria una radicale revisione della sua descrizione per renderla conforme alla tabella ndash in ogni caso mai per ragioni squisitamente matematiche92
Abstract
The article presents and discusses in detail two passages from the anonymous Prolegomena to the Almagest a VIth century primer to the elementary procedures of calculation needed in Ptolemyrsquos Almagest In the two passages we may follow the complex interplay between mathematical notation the auctor who employed and described it the tachygrapher who transcribed it in vivo copyists who reproduced it correctors who modified it Along this path misgivings and errors arise in the transmission of abbreviations and paratextual units such as diagrams tables operational schemes
Fabio AcerbiCNRS UMR8560 Centre Alexandre Koyreacute
fabacerbigmailcom
92 Sono grato a Daniele Bianconi Lucio del Corso Jean Lempire per alcune preziose indicazioni
AOO = Archimedis opera omnia cum commentariis Eutocii ed J L Heiberg I-III Lipsiae 1910-1915
DOO = Diophanti Alexandrini opera omnia cum Graecis commentariis ed P Tannery I-II Lipsiae 1893-1895
GC = Le laquoGrand Commentaireraquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Mogenet ndash A Tihon I-III Cittagrave del Vaticano 1985-1999
iA = Commentaires de Pappus et de Theacuteon drsquoAlexandrie sur lrsquoAlmageste ed A Rome I-III con paginazione continua Cittagrave del Vaticano 1931-1943
HOO = Heronis Alexandrini opera quae supersunt omnia ed G Schmidt ndash L Nix ndash W Schmidt ndash H Schoene ndash J L Heiberg I-V Lipsiae 1899-1914
PC = Le ldquoPetit Commentairerdquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed A Tihon Cittagrave del Vaticano 1978
POO = Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia ed J L Heiberg I-II in 3 parti Lipsiae 1898-1907
RGK = Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600 I Handschriften aus Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln II Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs und Nachtraumlge zu den Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln III Handschriften aus Bibliotheken Roms mit dem Vatikan A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg unter Mitarbeit von D Harlfinger und P Eleuteri B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln Wien 1981-1997 (Oumlsterreichische Akademie der Wissenschaften Veroumlffentlichungen der Kommission fuumlr Byzantinistik III1-3 A-C)
Sigla
Acerbi 2010 = F Acerbi Il silenzio delle sirene La matematica greca antica Roma 2010
Acerbi 2012 = F Acerbi I codici stilistici della matematica greca dimostrazioni procedure algoritmi laquoQUCCraquo 1012 (2012) pp 167-214
Acerbi et al 2010 = F Acerbi ndash N Vinel ndash B Vitrac Les Proleacutegomegravenes agrave lrsquoAlmageste Une eacutedition agrave partir des manuscrits les plus anciens Introduction geacuteneacuterale ndash Parties I-III laquoSCIAMVSraquo 11 (2010) pp 53-210
Agati 1992 = M L Agati La minuscola laquoBouleteacuteeraquo Cittagrave del Vaticano 1992
Belger 1881 = C Belger Ein neues Fragmentum mathematicum Bobiense laquoHermesraquo 16 (1881) pp 261-284
Bianconi 2005a = D Bianconi La biblioteca di Cora tra Massimo Planude e Niceforo Gregora Una questione di mani laquoSampTraquo 3 (2005) pp 391-438
Bianconi 2005b = D Bianconi Tessalonica nellrsquoetagrave dei Paleologi Le pratiche intellettuali nel riflesso della cultura scritta Paris 2005
Bianconi 2006a = D Bianconi Le pietre e il ponte ovvero identificazioni di mani e storia della cultura laquoBizantinisticaraquo 8 (2006) pp 135-181
Bianconi 2006b = D Bianconi Qualcosa di nuovo su Giovanni Catrario laquoMEGraquo 6 (2006) pp 69-91
Cavallo 1977 = G Cavallo Funzione e strutture della maiuscola greca tra i secoli VIII-XI in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Colloque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 95-137
Cereteli 1904 = G F Cereteli De compendiis scripturae codicum Graecorum praecipue Petropolitanorum et Mosquensium anni nota instructorum Sankt-Petersburg 1904
De Gregorio 2000 = G De Gregorio Materiali vecchi e nuovi per uno studio della minu-scola greca fra VII e IX secolo in G Prato (a cura di) I manoscritti greci tra riflessione e dibattito Atti del V Colloquio Internazionale di Paleografia Greca Cremona 4-10 ottobre 1998 Firenze 2000 pp 83-151
Follieri 1977 = E Follieri La minuscola libraria dei secoli IX e X in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Col-loque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 139-165
Fonkič 2005 = B Fonkič Venecianskaia rukopisrsquo laquoAlrsquomagestaraquo Ptolemeja (Marc gr 313690) o datirovke i proischoždenii kodeksa laquoVDIraquo s III 254 (2005) pp 162-167
Fowler 1999 = D H Fowler The Mathematics of Platorsquos Academy A New Reconstruction Second Edition Oxford 1999
Bibliografia
Fabio Acerbi164
Gerstinger ndash Vogel 1932 = H Gerstinger ndash K Vogel Eine stereometrische Aufgaben-sammlung im Papyrus Graecus [sic] Vindobonensis 19996 laquoMitteilungen aus der Papy-russammlung der Nationalbibliothek in Wienraquo Neue Serie Folge 1 Griechische literarische Papyri 1 Wien 1932 pp 11-76
Heiberg 1927 = Mathematici Graeci Minores ed J L Heiberg Kjoslashbenhavn 1927
Hultsch 1876-1878 = Pappi Alexandrini Collectionis quae supersunt ed F Hultsch I-III Berlin 1876-1878
Janz 2003 = T Janz The Scribes and the Date of the Vat gr 1291 in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae X Cittagrave del Vaticano 2003 pp 159-180
Jones 1990 = Ptolemyrsquos First Commentator ed A Jones Philadelphia 1990
Jones 1999 = Astronomical Papyri from Oxyrhynchus ed A Jones I-II Philadelphia 1999
Jones 2005 = A Jones Ptolemyrsquos Canobic Inscription and Heliodorusrsquo Observation Reports laquoSCIAMVSraquo 6 (2005) pp 53-97
Lempire 2014 = Steacutephanos drsquoAlexandrie Le commentaire aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Lempire Louvain 2014
Leurquin 1990 = Theacuteodore Meacuteliteacuteniote Tribiblos astronomique Livre I ed R Leurquin Amsterdam 1990
Leurquin 1991 = R Leurquin Un manuscrit autographe de la Tribiblos Astronomique de Theacuteodore Meacuteliteacuteniote le Vaticanus graecus 792 laquoScriptoriumraquo 45 (1991) pp 145-162
Maas 1927 = P Maas Griechische Palaeographie in A Gercke ndash E Norden (hrsg von) Einleitung in die Altertumswissenschaft I9 Leipzig 1927 pp 69-80
Martinelli Tempesta 2010 = S Martinelli Tempesta Il codice Milano Biblioteca Am-brosiana B 75 sup (gr 104) e lrsquoevoluzione della scrittura di Giovanni Scutariota in A B Garciacutea ndash I Peacuterez Martiacuten (ed by) The Legacy of Bernard de Montfaucon Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting Proceedings of the Seventh Inter-national Colloquium of Greek Palaeography Madrid-Salamanca 15-20 September 2008 Turnhout 2010 pp 171-186
Mazzucchi 1994 = C M Mazzucchi Leggere i classici durante la catastrofe (Costantino-poli maggio-agosto 1203) le note marginali al Diodoro Siculo Vaticano gr 130 Parte prima stratigrafia laquoAevumraquo 68 (1994) pp 164-218
Mioni 1976 = E Mioni Bessarione scriba e alcuni suoi collaboratori in Miscellanea marcia-na di studi bessarionei Padova 1976 pp 263-323
Mioni 1985 = Codices graeci manuscripti Bibliothecae Divi Marci Venetiarum II Thesaurus Antiquus Codices 300-625 recensuit E Mioni Roma 1985
Mogenet 1962 = J Mogenet Une scholie ineacutedite du Vat gr 1594 sur les rapports entre lrsquoastronomie arabe et Byzance laquoOsirisraquo 14 (1962) pp 198-221
Mogenet et al 1983 = Niceacutephore Greacutegoras Calcul de lrsquoeacuteclipse de soleil du 16 juillet 1330 ed J Mogenet ndash A Tihon ndash R Royez ndash A Berg Amsterdam 1983
Mondrain 2002 = B Mondrain Maxime Planude Niceacutephore Greacutegoras et Ptoleacutemeacutee laquoPa-laeoslavicaraquo 10 (2002) pp 312-322
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 165
Mondrain 2004 = B Mondrain Lrsquoancien empereur Jean VI Cantacuzegravene et ses copistes in A Rigo (a cura di) Gregorio Palamas e oltre Studi e documenti sulle controversie teologiche del XIV secolo bizantino Firenze 2004 pp 249-296
Mondrain 2007 = B Mondrain Les eacutecritures dans les manuscrits byzantins du XIV e siegravecle Quelques probleacutematiques laquoRSBNraquo n s 44 (2007) pp 157-196
Peacuterez Martiacuten 2006 = I Peacuterez Martiacuten Maxime Planude et le Diophantus Matritensis (Madrid Biblioteca Nacional ms 4678) un paradigme de la reacutecupeacuteration des textes anciens dans la ldquorenaissance paleacuteologuerdquo laquoByzantionraquo 76 (2006) pp 433-462
Peacuterez Martiacuten 2008 = I Peacuterez Martiacuten El lsquoestilo Hodegosrsquo y su proyeccioacuten en las escrituras constantinopolitanas laquoSampTraquo 6 (2008) pp 389-458
Perria 1991 = L Perria Scrittura e ornamentazione nei codici della laquocollezione filosoficaraquo laquoRSBNraquo n s 28 (1991) pp 45-111
Rollo 2012 = A Rollo LrsquoArchimede di Giorgio Valla in V Fera ndash D Gionta ndash A Rollo (a cura di) Archimede e le sue fortune Atti del Convegno di Siracusa-Messina 24-26 giugno 2008 Messina 2012 pp 99-147
Rome 1927 = A Rome Membra disjecta laquoRBenraquo 39 (1927) pp 187-188
Rome 1938 = A Rome Un manuscrit de la bibliothegraveque de Boniface VIII agrave la Meacutediceacuteenne de Florence laquoACraquo 7 (1938) pp 261-268
Ronconi 2013 = F Ronconi La collection philosophique un fantocircme historique laquoScripto-riumraquo 67 (2013) pp 119-140
Tannery ndash Steacutephanou 1940 = Quadrivium de Georges Pachymegravere ed P Tannery ndash E Steacutephanou Cittagrave del Vaticano 1940
Tihon 2011 = Πτολεμαίου Πρόχειροι Κανόνες Les Tables faciles de Ptoleacutemeacutee vol Ia Tables A1-A2 ed A Tihon Leuven 2011
Traube 1907 = L Traube Nomina Sacra Versuch einer Geschichte der christlichen Kuumlrzung Muumlnchen 1907
Vogel 1936 = K Vogel Beitraumlge zur griechischen Logistik laquoSBAWraquo Mathematisch-natur-wissenschaftliche Abteilung Jahrgang 1936 pp 357-472
Wouters 1979 = A Wouters The Grammatical Papyri from Graeco-Roman Egypt Contri-butions to the Study of the lsquoArs Grammaticarsquo in Antiquity Brussel 1979
F ACERBI Tav 1
b Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 65r
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 284 f 160r
F ACERBITav 2
b Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 13r
a Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 19v
F ACERBI Tav 3
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 136v
F ACERBITav 4
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17r
F ACERBI Tav 5
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17v
F ACERBITav 6
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 7v
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
AOO = Archimedis opera omnia cum commentariis Eutocii ed J L Heiberg I-III Lipsiae 1910-1915
DOO = Diophanti Alexandrini opera omnia cum Graecis commentariis ed P Tannery I-II Lipsiae 1893-1895
GC = Le laquoGrand Commentaireraquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Mogenet ndash A Tihon I-III Cittagrave del Vaticano 1985-1999
iA = Commentaires de Pappus et de Theacuteon drsquoAlexandrie sur lrsquoAlmageste ed A Rome I-III con paginazione continua Cittagrave del Vaticano 1931-1943
HOO = Heronis Alexandrini opera quae supersunt omnia ed G Schmidt ndash L Nix ndash W Schmidt ndash H Schoene ndash J L Heiberg I-V Lipsiae 1899-1914
PC = Le ldquoPetit Commentairerdquo de Theacuteon drsquoAlexandrie aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed A Tihon Cittagrave del Vaticano 1978
POO = Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia ed J L Heiberg I-II in 3 parti Lipsiae 1898-1907
RGK = Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600 I Handschriften aus Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln II Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs und Nachtraumlge zu den Bibliotheken Groszligbritanniens A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg und D Harlfinger B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln III Handschriften aus Bibliotheken Roms mit dem Vatikan A Verzeichnis der Kopisten erst von E Gamillscheg unter Mitarbeit von D Harlfinger und P Eleuteri B Palaumlographische Charakteristika erst von H Hunger C Tafeln Wien 1981-1997 (Oumlsterreichische Akademie der Wissenschaften Veroumlffentlichungen der Kommission fuumlr Byzantinistik III1-3 A-C)
Sigla
Acerbi 2010 = F Acerbi Il silenzio delle sirene La matematica greca antica Roma 2010
Acerbi 2012 = F Acerbi I codici stilistici della matematica greca dimostrazioni procedure algoritmi laquoQUCCraquo 1012 (2012) pp 167-214
Acerbi et al 2010 = F Acerbi ndash N Vinel ndash B Vitrac Les Proleacutegomegravenes agrave lrsquoAlmageste Une eacutedition agrave partir des manuscrits les plus anciens Introduction geacuteneacuterale ndash Parties I-III laquoSCIAMVSraquo 11 (2010) pp 53-210
Agati 1992 = M L Agati La minuscola laquoBouleteacuteeraquo Cittagrave del Vaticano 1992
Belger 1881 = C Belger Ein neues Fragmentum mathematicum Bobiense laquoHermesraquo 16 (1881) pp 261-284
Bianconi 2005a = D Bianconi La biblioteca di Cora tra Massimo Planude e Niceforo Gregora Una questione di mani laquoSampTraquo 3 (2005) pp 391-438
Bianconi 2005b = D Bianconi Tessalonica nellrsquoetagrave dei Paleologi Le pratiche intellettuali nel riflesso della cultura scritta Paris 2005
Bianconi 2006a = D Bianconi Le pietre e il ponte ovvero identificazioni di mani e storia della cultura laquoBizantinisticaraquo 8 (2006) pp 135-181
Bianconi 2006b = D Bianconi Qualcosa di nuovo su Giovanni Catrario laquoMEGraquo 6 (2006) pp 69-91
Cavallo 1977 = G Cavallo Funzione e strutture della maiuscola greca tra i secoli VIII-XI in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Colloque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 95-137
Cereteli 1904 = G F Cereteli De compendiis scripturae codicum Graecorum praecipue Petropolitanorum et Mosquensium anni nota instructorum Sankt-Petersburg 1904
De Gregorio 2000 = G De Gregorio Materiali vecchi e nuovi per uno studio della minu-scola greca fra VII e IX secolo in G Prato (a cura di) I manoscritti greci tra riflessione e dibattito Atti del V Colloquio Internazionale di Paleografia Greca Cremona 4-10 ottobre 1998 Firenze 2000 pp 83-151
Follieri 1977 = E Follieri La minuscola libraria dei secoli IX e X in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Col-loque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 139-165
Fonkič 2005 = B Fonkič Venecianskaia rukopisrsquo laquoAlrsquomagestaraquo Ptolemeja (Marc gr 313690) o datirovke i proischoždenii kodeksa laquoVDIraquo s III 254 (2005) pp 162-167
Fowler 1999 = D H Fowler The Mathematics of Platorsquos Academy A New Reconstruction Second Edition Oxford 1999
Bibliografia
Fabio Acerbi164
Gerstinger ndash Vogel 1932 = H Gerstinger ndash K Vogel Eine stereometrische Aufgaben-sammlung im Papyrus Graecus [sic] Vindobonensis 19996 laquoMitteilungen aus der Papy-russammlung der Nationalbibliothek in Wienraquo Neue Serie Folge 1 Griechische literarische Papyri 1 Wien 1932 pp 11-76
Heiberg 1927 = Mathematici Graeci Minores ed J L Heiberg Kjoslashbenhavn 1927
Hultsch 1876-1878 = Pappi Alexandrini Collectionis quae supersunt ed F Hultsch I-III Berlin 1876-1878
Janz 2003 = T Janz The Scribes and the Date of the Vat gr 1291 in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae X Cittagrave del Vaticano 2003 pp 159-180
Jones 1990 = Ptolemyrsquos First Commentator ed A Jones Philadelphia 1990
Jones 1999 = Astronomical Papyri from Oxyrhynchus ed A Jones I-II Philadelphia 1999
Jones 2005 = A Jones Ptolemyrsquos Canobic Inscription and Heliodorusrsquo Observation Reports laquoSCIAMVSraquo 6 (2005) pp 53-97
Lempire 2014 = Steacutephanos drsquoAlexandrie Le commentaire aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Lempire Louvain 2014
Leurquin 1990 = Theacuteodore Meacuteliteacuteniote Tribiblos astronomique Livre I ed R Leurquin Amsterdam 1990
Leurquin 1991 = R Leurquin Un manuscrit autographe de la Tribiblos Astronomique de Theacuteodore Meacuteliteacuteniote le Vaticanus graecus 792 laquoScriptoriumraquo 45 (1991) pp 145-162
Maas 1927 = P Maas Griechische Palaeographie in A Gercke ndash E Norden (hrsg von) Einleitung in die Altertumswissenschaft I9 Leipzig 1927 pp 69-80
Martinelli Tempesta 2010 = S Martinelli Tempesta Il codice Milano Biblioteca Am-brosiana B 75 sup (gr 104) e lrsquoevoluzione della scrittura di Giovanni Scutariota in A B Garciacutea ndash I Peacuterez Martiacuten (ed by) The Legacy of Bernard de Montfaucon Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting Proceedings of the Seventh Inter-national Colloquium of Greek Palaeography Madrid-Salamanca 15-20 September 2008 Turnhout 2010 pp 171-186
Mazzucchi 1994 = C M Mazzucchi Leggere i classici durante la catastrofe (Costantino-poli maggio-agosto 1203) le note marginali al Diodoro Siculo Vaticano gr 130 Parte prima stratigrafia laquoAevumraquo 68 (1994) pp 164-218
Mioni 1976 = E Mioni Bessarione scriba e alcuni suoi collaboratori in Miscellanea marcia-na di studi bessarionei Padova 1976 pp 263-323
Mioni 1985 = Codices graeci manuscripti Bibliothecae Divi Marci Venetiarum II Thesaurus Antiquus Codices 300-625 recensuit E Mioni Roma 1985
Mogenet 1962 = J Mogenet Une scholie ineacutedite du Vat gr 1594 sur les rapports entre lrsquoastronomie arabe et Byzance laquoOsirisraquo 14 (1962) pp 198-221
Mogenet et al 1983 = Niceacutephore Greacutegoras Calcul de lrsquoeacuteclipse de soleil du 16 juillet 1330 ed J Mogenet ndash A Tihon ndash R Royez ndash A Berg Amsterdam 1983
Mondrain 2002 = B Mondrain Maxime Planude Niceacutephore Greacutegoras et Ptoleacutemeacutee laquoPa-laeoslavicaraquo 10 (2002) pp 312-322
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 165
Mondrain 2004 = B Mondrain Lrsquoancien empereur Jean VI Cantacuzegravene et ses copistes in A Rigo (a cura di) Gregorio Palamas e oltre Studi e documenti sulle controversie teologiche del XIV secolo bizantino Firenze 2004 pp 249-296
Mondrain 2007 = B Mondrain Les eacutecritures dans les manuscrits byzantins du XIV e siegravecle Quelques probleacutematiques laquoRSBNraquo n s 44 (2007) pp 157-196
Peacuterez Martiacuten 2006 = I Peacuterez Martiacuten Maxime Planude et le Diophantus Matritensis (Madrid Biblioteca Nacional ms 4678) un paradigme de la reacutecupeacuteration des textes anciens dans la ldquorenaissance paleacuteologuerdquo laquoByzantionraquo 76 (2006) pp 433-462
Peacuterez Martiacuten 2008 = I Peacuterez Martiacuten El lsquoestilo Hodegosrsquo y su proyeccioacuten en las escrituras constantinopolitanas laquoSampTraquo 6 (2008) pp 389-458
Perria 1991 = L Perria Scrittura e ornamentazione nei codici della laquocollezione filosoficaraquo laquoRSBNraquo n s 28 (1991) pp 45-111
Rollo 2012 = A Rollo LrsquoArchimede di Giorgio Valla in V Fera ndash D Gionta ndash A Rollo (a cura di) Archimede e le sue fortune Atti del Convegno di Siracusa-Messina 24-26 giugno 2008 Messina 2012 pp 99-147
Rome 1927 = A Rome Membra disjecta laquoRBenraquo 39 (1927) pp 187-188
Rome 1938 = A Rome Un manuscrit de la bibliothegraveque de Boniface VIII agrave la Meacutediceacuteenne de Florence laquoACraquo 7 (1938) pp 261-268
Ronconi 2013 = F Ronconi La collection philosophique un fantocircme historique laquoScripto-riumraquo 67 (2013) pp 119-140
Tannery ndash Steacutephanou 1940 = Quadrivium de Georges Pachymegravere ed P Tannery ndash E Steacutephanou Cittagrave del Vaticano 1940
Tihon 2011 = Πτολεμαίου Πρόχειροι Κανόνες Les Tables faciles de Ptoleacutemeacutee vol Ia Tables A1-A2 ed A Tihon Leuven 2011
Traube 1907 = L Traube Nomina Sacra Versuch einer Geschichte der christlichen Kuumlrzung Muumlnchen 1907
Vogel 1936 = K Vogel Beitraumlge zur griechischen Logistik laquoSBAWraquo Mathematisch-natur-wissenschaftliche Abteilung Jahrgang 1936 pp 357-472
Wouters 1979 = A Wouters The Grammatical Papyri from Graeco-Roman Egypt Contri-butions to the Study of the lsquoArs Grammaticarsquo in Antiquity Brussel 1979
F ACERBI Tav 1
b Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 65r
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 284 f 160r
F ACERBITav 2
b Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 13r
a Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 19v
F ACERBI Tav 3
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 136v
F ACERBITav 4
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17r
F ACERBI Tav 5
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17v
F ACERBITav 6
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 7v
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
Acerbi 2010 = F Acerbi Il silenzio delle sirene La matematica greca antica Roma 2010
Acerbi 2012 = F Acerbi I codici stilistici della matematica greca dimostrazioni procedure algoritmi laquoQUCCraquo 1012 (2012) pp 167-214
Acerbi et al 2010 = F Acerbi ndash N Vinel ndash B Vitrac Les Proleacutegomegravenes agrave lrsquoAlmageste Une eacutedition agrave partir des manuscrits les plus anciens Introduction geacuteneacuterale ndash Parties I-III laquoSCIAMVSraquo 11 (2010) pp 53-210
Agati 1992 = M L Agati La minuscola laquoBouleteacuteeraquo Cittagrave del Vaticano 1992
Belger 1881 = C Belger Ein neues Fragmentum mathematicum Bobiense laquoHermesraquo 16 (1881) pp 261-284
Bianconi 2005a = D Bianconi La biblioteca di Cora tra Massimo Planude e Niceforo Gregora Una questione di mani laquoSampTraquo 3 (2005) pp 391-438
Bianconi 2005b = D Bianconi Tessalonica nellrsquoetagrave dei Paleologi Le pratiche intellettuali nel riflesso della cultura scritta Paris 2005
Bianconi 2006a = D Bianconi Le pietre e il ponte ovvero identificazioni di mani e storia della cultura laquoBizantinisticaraquo 8 (2006) pp 135-181
Bianconi 2006b = D Bianconi Qualcosa di nuovo su Giovanni Catrario laquoMEGraquo 6 (2006) pp 69-91
Cavallo 1977 = G Cavallo Funzione e strutture della maiuscola greca tra i secoli VIII-XI in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Colloque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 95-137
Cereteli 1904 = G F Cereteli De compendiis scripturae codicum Graecorum praecipue Petropolitanorum et Mosquensium anni nota instructorum Sankt-Petersburg 1904
De Gregorio 2000 = G De Gregorio Materiali vecchi e nuovi per uno studio della minu-scola greca fra VII e IX secolo in G Prato (a cura di) I manoscritti greci tra riflessione e dibattito Atti del V Colloquio Internazionale di Paleografia Greca Cremona 4-10 ottobre 1998 Firenze 2000 pp 83-151
Follieri 1977 = E Follieri La minuscola libraria dei secoli IX e X in J Gleacutenisson ndash J Bompaire ndash J Irigoin (eacuted par) La paleacuteographie grecque et byzantine Actes du Col-loque Paris 21-25 octobre 1974 Paris 1977 pp 139-165
Fonkič 2005 = B Fonkič Venecianskaia rukopisrsquo laquoAlrsquomagestaraquo Ptolemeja (Marc gr 313690) o datirovke i proischoždenii kodeksa laquoVDIraquo s III 254 (2005) pp 162-167
Fowler 1999 = D H Fowler The Mathematics of Platorsquos Academy A New Reconstruction Second Edition Oxford 1999
Bibliografia
Fabio Acerbi164
Gerstinger ndash Vogel 1932 = H Gerstinger ndash K Vogel Eine stereometrische Aufgaben-sammlung im Papyrus Graecus [sic] Vindobonensis 19996 laquoMitteilungen aus der Papy-russammlung der Nationalbibliothek in Wienraquo Neue Serie Folge 1 Griechische literarische Papyri 1 Wien 1932 pp 11-76
Heiberg 1927 = Mathematici Graeci Minores ed J L Heiberg Kjoslashbenhavn 1927
Hultsch 1876-1878 = Pappi Alexandrini Collectionis quae supersunt ed F Hultsch I-III Berlin 1876-1878
Janz 2003 = T Janz The Scribes and the Date of the Vat gr 1291 in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae X Cittagrave del Vaticano 2003 pp 159-180
Jones 1990 = Ptolemyrsquos First Commentator ed A Jones Philadelphia 1990
Jones 1999 = Astronomical Papyri from Oxyrhynchus ed A Jones I-II Philadelphia 1999
Jones 2005 = A Jones Ptolemyrsquos Canobic Inscription and Heliodorusrsquo Observation Reports laquoSCIAMVSraquo 6 (2005) pp 53-97
Lempire 2014 = Steacutephanos drsquoAlexandrie Le commentaire aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Lempire Louvain 2014
Leurquin 1990 = Theacuteodore Meacuteliteacuteniote Tribiblos astronomique Livre I ed R Leurquin Amsterdam 1990
Leurquin 1991 = R Leurquin Un manuscrit autographe de la Tribiblos Astronomique de Theacuteodore Meacuteliteacuteniote le Vaticanus graecus 792 laquoScriptoriumraquo 45 (1991) pp 145-162
Maas 1927 = P Maas Griechische Palaeographie in A Gercke ndash E Norden (hrsg von) Einleitung in die Altertumswissenschaft I9 Leipzig 1927 pp 69-80
Martinelli Tempesta 2010 = S Martinelli Tempesta Il codice Milano Biblioteca Am-brosiana B 75 sup (gr 104) e lrsquoevoluzione della scrittura di Giovanni Scutariota in A B Garciacutea ndash I Peacuterez Martiacuten (ed by) The Legacy of Bernard de Montfaucon Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting Proceedings of the Seventh Inter-national Colloquium of Greek Palaeography Madrid-Salamanca 15-20 September 2008 Turnhout 2010 pp 171-186
Mazzucchi 1994 = C M Mazzucchi Leggere i classici durante la catastrofe (Costantino-poli maggio-agosto 1203) le note marginali al Diodoro Siculo Vaticano gr 130 Parte prima stratigrafia laquoAevumraquo 68 (1994) pp 164-218
Mioni 1976 = E Mioni Bessarione scriba e alcuni suoi collaboratori in Miscellanea marcia-na di studi bessarionei Padova 1976 pp 263-323
Mioni 1985 = Codices graeci manuscripti Bibliothecae Divi Marci Venetiarum II Thesaurus Antiquus Codices 300-625 recensuit E Mioni Roma 1985
Mogenet 1962 = J Mogenet Une scholie ineacutedite du Vat gr 1594 sur les rapports entre lrsquoastronomie arabe et Byzance laquoOsirisraquo 14 (1962) pp 198-221
Mogenet et al 1983 = Niceacutephore Greacutegoras Calcul de lrsquoeacuteclipse de soleil du 16 juillet 1330 ed J Mogenet ndash A Tihon ndash R Royez ndash A Berg Amsterdam 1983
Mondrain 2002 = B Mondrain Maxime Planude Niceacutephore Greacutegoras et Ptoleacutemeacutee laquoPa-laeoslavicaraquo 10 (2002) pp 312-322
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 165
Mondrain 2004 = B Mondrain Lrsquoancien empereur Jean VI Cantacuzegravene et ses copistes in A Rigo (a cura di) Gregorio Palamas e oltre Studi e documenti sulle controversie teologiche del XIV secolo bizantino Firenze 2004 pp 249-296
Mondrain 2007 = B Mondrain Les eacutecritures dans les manuscrits byzantins du XIV e siegravecle Quelques probleacutematiques laquoRSBNraquo n s 44 (2007) pp 157-196
Peacuterez Martiacuten 2006 = I Peacuterez Martiacuten Maxime Planude et le Diophantus Matritensis (Madrid Biblioteca Nacional ms 4678) un paradigme de la reacutecupeacuteration des textes anciens dans la ldquorenaissance paleacuteologuerdquo laquoByzantionraquo 76 (2006) pp 433-462
Peacuterez Martiacuten 2008 = I Peacuterez Martiacuten El lsquoestilo Hodegosrsquo y su proyeccioacuten en las escrituras constantinopolitanas laquoSampTraquo 6 (2008) pp 389-458
Perria 1991 = L Perria Scrittura e ornamentazione nei codici della laquocollezione filosoficaraquo laquoRSBNraquo n s 28 (1991) pp 45-111
Rollo 2012 = A Rollo LrsquoArchimede di Giorgio Valla in V Fera ndash D Gionta ndash A Rollo (a cura di) Archimede e le sue fortune Atti del Convegno di Siracusa-Messina 24-26 giugno 2008 Messina 2012 pp 99-147
Rome 1927 = A Rome Membra disjecta laquoRBenraquo 39 (1927) pp 187-188
Rome 1938 = A Rome Un manuscrit de la bibliothegraveque de Boniface VIII agrave la Meacutediceacuteenne de Florence laquoACraquo 7 (1938) pp 261-268
Ronconi 2013 = F Ronconi La collection philosophique un fantocircme historique laquoScripto-riumraquo 67 (2013) pp 119-140
Tannery ndash Steacutephanou 1940 = Quadrivium de Georges Pachymegravere ed P Tannery ndash E Steacutephanou Cittagrave del Vaticano 1940
Tihon 2011 = Πτολεμαίου Πρόχειροι Κανόνες Les Tables faciles de Ptoleacutemeacutee vol Ia Tables A1-A2 ed A Tihon Leuven 2011
Traube 1907 = L Traube Nomina Sacra Versuch einer Geschichte der christlichen Kuumlrzung Muumlnchen 1907
Vogel 1936 = K Vogel Beitraumlge zur griechischen Logistik laquoSBAWraquo Mathematisch-natur-wissenschaftliche Abteilung Jahrgang 1936 pp 357-472
Wouters 1979 = A Wouters The Grammatical Papyri from Graeco-Roman Egypt Contri-butions to the Study of the lsquoArs Grammaticarsquo in Antiquity Brussel 1979
F ACERBI Tav 1
b Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 65r
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 284 f 160r
F ACERBITav 2
b Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 13r
a Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 19v
F ACERBI Tav 3
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 136v
F ACERBITav 4
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17r
F ACERBI Tav 5
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17v
F ACERBITav 6
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 7v
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
Fabio Acerbi164
Gerstinger ndash Vogel 1932 = H Gerstinger ndash K Vogel Eine stereometrische Aufgaben-sammlung im Papyrus Graecus [sic] Vindobonensis 19996 laquoMitteilungen aus der Papy-russammlung der Nationalbibliothek in Wienraquo Neue Serie Folge 1 Griechische literarische Papyri 1 Wien 1932 pp 11-76
Heiberg 1927 = Mathematici Graeci Minores ed J L Heiberg Kjoslashbenhavn 1927
Hultsch 1876-1878 = Pappi Alexandrini Collectionis quae supersunt ed F Hultsch I-III Berlin 1876-1878
Janz 2003 = T Janz The Scribes and the Date of the Vat gr 1291 in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae X Cittagrave del Vaticano 2003 pp 159-180
Jones 1990 = Ptolemyrsquos First Commentator ed A Jones Philadelphia 1990
Jones 1999 = Astronomical Papyri from Oxyrhynchus ed A Jones I-II Philadelphia 1999
Jones 2005 = A Jones Ptolemyrsquos Canobic Inscription and Heliodorusrsquo Observation Reports laquoSCIAMVSraquo 6 (2005) pp 53-97
Lempire 2014 = Steacutephanos drsquoAlexandrie Le commentaire aux Tables Faciles de Ptoleacutemeacutee ed J Lempire Louvain 2014
Leurquin 1990 = Theacuteodore Meacuteliteacuteniote Tribiblos astronomique Livre I ed R Leurquin Amsterdam 1990
Leurquin 1991 = R Leurquin Un manuscrit autographe de la Tribiblos Astronomique de Theacuteodore Meacuteliteacuteniote le Vaticanus graecus 792 laquoScriptoriumraquo 45 (1991) pp 145-162
Maas 1927 = P Maas Griechische Palaeographie in A Gercke ndash E Norden (hrsg von) Einleitung in die Altertumswissenschaft I9 Leipzig 1927 pp 69-80
Martinelli Tempesta 2010 = S Martinelli Tempesta Il codice Milano Biblioteca Am-brosiana B 75 sup (gr 104) e lrsquoevoluzione della scrittura di Giovanni Scutariota in A B Garciacutea ndash I Peacuterez Martiacuten (ed by) The Legacy of Bernard de Montfaucon Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting Proceedings of the Seventh Inter-national Colloquium of Greek Palaeography Madrid-Salamanca 15-20 September 2008 Turnhout 2010 pp 171-186
Mazzucchi 1994 = C M Mazzucchi Leggere i classici durante la catastrofe (Costantino-poli maggio-agosto 1203) le note marginali al Diodoro Siculo Vaticano gr 130 Parte prima stratigrafia laquoAevumraquo 68 (1994) pp 164-218
Mioni 1976 = E Mioni Bessarione scriba e alcuni suoi collaboratori in Miscellanea marcia-na di studi bessarionei Padova 1976 pp 263-323
Mioni 1985 = Codices graeci manuscripti Bibliothecae Divi Marci Venetiarum II Thesaurus Antiquus Codices 300-625 recensuit E Mioni Roma 1985
Mogenet 1962 = J Mogenet Une scholie ineacutedite du Vat gr 1594 sur les rapports entre lrsquoastronomie arabe et Byzance laquoOsirisraquo 14 (1962) pp 198-221
Mogenet et al 1983 = Niceacutephore Greacutegoras Calcul de lrsquoeacuteclipse de soleil du 16 juillet 1330 ed J Mogenet ndash A Tihon ndash R Royez ndash A Berg Amsterdam 1983
Mondrain 2002 = B Mondrain Maxime Planude Niceacutephore Greacutegoras et Ptoleacutemeacutee laquoPa-laeoslavicaraquo 10 (2002) pp 312-322
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 165
Mondrain 2004 = B Mondrain Lrsquoancien empereur Jean VI Cantacuzegravene et ses copistes in A Rigo (a cura di) Gregorio Palamas e oltre Studi e documenti sulle controversie teologiche del XIV secolo bizantino Firenze 2004 pp 249-296
Mondrain 2007 = B Mondrain Les eacutecritures dans les manuscrits byzantins du XIV e siegravecle Quelques probleacutematiques laquoRSBNraquo n s 44 (2007) pp 157-196
Peacuterez Martiacuten 2006 = I Peacuterez Martiacuten Maxime Planude et le Diophantus Matritensis (Madrid Biblioteca Nacional ms 4678) un paradigme de la reacutecupeacuteration des textes anciens dans la ldquorenaissance paleacuteologuerdquo laquoByzantionraquo 76 (2006) pp 433-462
Peacuterez Martiacuten 2008 = I Peacuterez Martiacuten El lsquoestilo Hodegosrsquo y su proyeccioacuten en las escrituras constantinopolitanas laquoSampTraquo 6 (2008) pp 389-458
Perria 1991 = L Perria Scrittura e ornamentazione nei codici della laquocollezione filosoficaraquo laquoRSBNraquo n s 28 (1991) pp 45-111
Rollo 2012 = A Rollo LrsquoArchimede di Giorgio Valla in V Fera ndash D Gionta ndash A Rollo (a cura di) Archimede e le sue fortune Atti del Convegno di Siracusa-Messina 24-26 giugno 2008 Messina 2012 pp 99-147
Rome 1927 = A Rome Membra disjecta laquoRBenraquo 39 (1927) pp 187-188
Rome 1938 = A Rome Un manuscrit de la bibliothegraveque de Boniface VIII agrave la Meacutediceacuteenne de Florence laquoACraquo 7 (1938) pp 261-268
Ronconi 2013 = F Ronconi La collection philosophique un fantocircme historique laquoScripto-riumraquo 67 (2013) pp 119-140
Tannery ndash Steacutephanou 1940 = Quadrivium de Georges Pachymegravere ed P Tannery ndash E Steacutephanou Cittagrave del Vaticano 1940
Tihon 2011 = Πτολεμαίου Πρόχειροι Κανόνες Les Tables faciles de Ptoleacutemeacutee vol Ia Tables A1-A2 ed A Tihon Leuven 2011
Traube 1907 = L Traube Nomina Sacra Versuch einer Geschichte der christlichen Kuumlrzung Muumlnchen 1907
Vogel 1936 = K Vogel Beitraumlge zur griechischen Logistik laquoSBAWraquo Mathematisch-natur-wissenschaftliche Abteilung Jahrgang 1936 pp 357-472
Wouters 1979 = A Wouters The Grammatical Papyri from Graeco-Roman Egypt Contri-butions to the Study of the lsquoArs Grammaticarsquo in Antiquity Brussel 1979
F ACERBI Tav 1
b Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 65r
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 284 f 160r
F ACERBITav 2
b Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 13r
a Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 19v
F ACERBI Tav 3
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 136v
F ACERBITav 4
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17r
F ACERBI Tav 5
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17v
F ACERBITav 6
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 7v
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
Funzioni e modalitagrave di trasmissione 165
Mondrain 2004 = B Mondrain Lrsquoancien empereur Jean VI Cantacuzegravene et ses copistes in A Rigo (a cura di) Gregorio Palamas e oltre Studi e documenti sulle controversie teologiche del XIV secolo bizantino Firenze 2004 pp 249-296
Mondrain 2007 = B Mondrain Les eacutecritures dans les manuscrits byzantins du XIV e siegravecle Quelques probleacutematiques laquoRSBNraquo n s 44 (2007) pp 157-196
Peacuterez Martiacuten 2006 = I Peacuterez Martiacuten Maxime Planude et le Diophantus Matritensis (Madrid Biblioteca Nacional ms 4678) un paradigme de la reacutecupeacuteration des textes anciens dans la ldquorenaissance paleacuteologuerdquo laquoByzantionraquo 76 (2006) pp 433-462
Peacuterez Martiacuten 2008 = I Peacuterez Martiacuten El lsquoestilo Hodegosrsquo y su proyeccioacuten en las escrituras constantinopolitanas laquoSampTraquo 6 (2008) pp 389-458
Perria 1991 = L Perria Scrittura e ornamentazione nei codici della laquocollezione filosoficaraquo laquoRSBNraquo n s 28 (1991) pp 45-111
Rollo 2012 = A Rollo LrsquoArchimede di Giorgio Valla in V Fera ndash D Gionta ndash A Rollo (a cura di) Archimede e le sue fortune Atti del Convegno di Siracusa-Messina 24-26 giugno 2008 Messina 2012 pp 99-147
Rome 1927 = A Rome Membra disjecta laquoRBenraquo 39 (1927) pp 187-188
Rome 1938 = A Rome Un manuscrit de la bibliothegraveque de Boniface VIII agrave la Meacutediceacuteenne de Florence laquoACraquo 7 (1938) pp 261-268
Ronconi 2013 = F Ronconi La collection philosophique un fantocircme historique laquoScripto-riumraquo 67 (2013) pp 119-140
Tannery ndash Steacutephanou 1940 = Quadrivium de Georges Pachymegravere ed P Tannery ndash E Steacutephanou Cittagrave del Vaticano 1940
Tihon 2011 = Πτολεμαίου Πρόχειροι Κανόνες Les Tables faciles de Ptoleacutemeacutee vol Ia Tables A1-A2 ed A Tihon Leuven 2011
Traube 1907 = L Traube Nomina Sacra Versuch einer Geschichte der christlichen Kuumlrzung Muumlnchen 1907
Vogel 1936 = K Vogel Beitraumlge zur griechischen Logistik laquoSBAWraquo Mathematisch-natur-wissenschaftliche Abteilung Jahrgang 1936 pp 357-472
Wouters 1979 = A Wouters The Grammatical Papyri from Graeco-Roman Egypt Contri-butions to the Study of the lsquoArs Grammaticarsquo in Antiquity Brussel 1979
F ACERBI Tav 1
b Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 65r
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 284 f 160r
F ACERBITav 2
b Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 13r
a Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 19v
F ACERBI Tav 3
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 136v
F ACERBITav 4
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17r
F ACERBI Tav 5
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17v
F ACERBITav 6
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 7v
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
F ACERBI Tav 1
b Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 65r
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 284 f 160r
F ACERBITav 2
b Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 13r
a Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 19v
F ACERBI Tav 3
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 136v
F ACERBITav 4
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17r
F ACERBI Tav 5
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17v
F ACERBITav 6
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 7v
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
F ACERBITav 2
b Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 13r
a Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 19v
F ACERBI Tav 3
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 136v
F ACERBITav 4
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17r
F ACERBI Tav 5
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17v
F ACERBITav 6
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 7v
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
F ACERBI Tav 3
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 2818 f 136v
F ACERBITav 4
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17r
F ACERBI Tav 5
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17v
F ACERBITav 6
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 7v
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
F ACERBITav 4
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17r
F ACERBI Tav 5
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17v
F ACERBITav 6
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 7v
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
F ACERBI Tav 5
Venezia Biblioteca Nazionale Marciana gr 313 f 17v
F ACERBITav 6
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 7v
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
F ACERBITav 6
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 7v
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
F ACERBI Tav 7
b Cittagrave del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat gr 184 f 17v
a Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 13r
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
F ACERBITav 8
Paris Bibliothegraveque nationale de France gr 2390 f 9v
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
F ACERBI Tav 9
Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana Plut 89 sup 48 f 14v
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
Indice generale
Guglielmo Cavallo PMil Vogl I 19 Galeno e la produzione di libri greci a Roma in etagrave imperiale p 1
Elisabetta Todisco Sebuini o Sesuini Una nuova lettura e interpretazione dellrsquoiscrizione dei vicani di Angera (CIL V 5471) p 15
Daniela Colomo The avis phoenix in the Schools of Rhetoric PMil Vogl I 20 and PLond Lit 193 Revisited p 29
Alessandro Fusi La recensio gennadiana e il testo di Marziale p 79
Fabio Acerbi Funzioni e modalitagrave di trasmissione delle notazioni numeriche nella trattatistica matematica greca due esempi paradigmatici p 123
Claudio Giammona Copia incolla sostituisci il dialogo con le fonti di un grammatico altomedievale p 167
Emanuela Colombi Assetto librario ed elementi paratestuali nei manoscritti tardoantichi e carolingi del De civitate dei di Agostino alcune riflessioni p 183
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397
Indici414
Francesca Piccioni SullrsquoAssisiate 706 del De magia di Apuleio p 273
Bart Huelsenbeck A Nexus of Manuscripts Copied at Corbie ca 850-880 A Typology of Script Style and Copying Procedure p 287
Lidia Buono Un omeliario di Cava del XII secolo in frammenti ricostruzione codicologica e commento liturgico p 311
Daniele Bianconi Un nuovo codice appartenuto a Manuele Crisolora (Pal Heid gr 375) p 375
Filippo Ronconi The Patriarch and the Assyrians New Evidence for the Date of Photiosrsquo Library p 387
Indici p 397



























































![Paul de Chantelou e la trattatistica italiana del Cinquecento in “Bulletin de l’association des Historiens de l’Art Italien”, 12, 2006 [2007], pp. 24-33](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63236b465f71497ea9045266/paul-de-chantelou-e-la-trattatistica-italiana-del-cinquecento-in-bulletin-de.jpg)