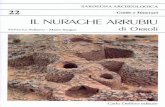Il monitoraggio degli strumenti urbanistici: tecniche e modalità operative. Il caso di Campi...
Transcript of Il monitoraggio degli strumenti urbanistici: tecniche e modalità operative. Il caso di Campi...
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Facoltà di Architettura
Corso di Laurea in Pianificazione della Città del Territorio e del Paesaggio
A.A. 2010 - 2011
Il monitoraggio degli strumenti urbanistici: tecniche e modalità operative. Il caso di Campi Bisenzio (FI)
Relatore: Laureanda: Prof. Giuseppe De Luca Debora Iacopini
Sessione Straordinaria 3 Aprile 2012
5
INDICE Introduzione 7
1. Campi Bisenzio a cavallo del millennio 9
1.1 Inquadramento ed evoluzione economico-sociale 9 1.2 Storia urbanistica 33 1.3 La necessità del monitoraggio a Campi Bisenzio 56
2. Il monitoraggio: che cos’è e a che cosa serve 57
2.1 Evoluzione normativa 57 2.2 Il monitoraggio nella legislazione 59 2.3 Tecniche utilizzate 61 2.4 Problematiche riscontrate 65 2.5 Il monitoraggio a Campi Bisenzio 66
3. Una proposta 71
3.1 La tecnica utilizzata 71 3.2 Schede di monitoraggio 73 3.3 Considerazioni finali 137
Conclusioni 143 Bibliografia 145 Allegati 146
7
INTRODUZIONE Scelte, azioni, effetti: in estrema sintesi si possono scomporre così le fasi di un qualsiasi processo decisionale. E, dato che, di solito, ogni processo decisionale non è mai fine a se stesso, ma si inserisce sempre in un percorso fatto da molti altri cicli di scelte-azioni-effetti, che col tempo delineano e trasformano l’iter compiuto e, soprattutto, influiscono sulle possibili decisioni future, è bene saper mantenere attiva la capacità di fare un continuo bilancio di ciò che è stato, di tener conto dei risultati ottenuti in rapporto ai propositi iniziali, per proseguire in modo più consapevole. Quando questo ragionamento viene calato nella pianificazione territoriale, il processo descritto è costituito dall’avvicendarsi degli strumenti urbanistici, i quali altro non sono che decisioni politiche assistite tecnicamente (all’interno della sfera politica viene definito il sistema degli obiettivi, nell’ambito di quella tecnica, invece, si organizzano i mezzi e le modalità di trasformazione), che produrranno degli effetti – fisici, sociali, economici – sul territorio. Quella capacità di continua verifica e di controllo sul percorso compiuto in previsione di quello futuro, in pianificazione, si chiama monitoraggio. La legislazione toscana, con la legge regionale del 3 gennaio 2005, n. 1, introduce il concetto di monitoraggio nell’articolo 13, dove si legge che: “Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio sono sottoposti, da parte dei soggetti istituzionali competenti […], al monitoraggio degli effetti […]”. Il presente lavoro ha lo scopo di produrre un’indagine sulle tecniche e le modalità operative per monitorare gli esiti delle decisioni degli strumenti urbanistici sulle trasformazioni fisiche sul territorio, analizzando un caso specifico: quello del Comune di Campi Bisenzio (FI). Pertanto, la trattazione prenderà avvio tracciando un primo inquadramento e un profilo di storia economico-sociale e urbanistica del comune oggetto di studio, necessari come base introduttiva per l’argomento principale della tesi: la proposta di un sistema di monitoraggio applicato alla strumentazione urbanistica del Comune di Campi Bisenzio. Tale fase del lavoro, la più sperimentale e operativa, verrà anticipata da un capitolo che vuole spiegare, in termini tecnici e più appropriati rispetto a quelli usati in questa breve introduzione, che cosa sia e a cosa serva il monitoraggio, con riferimento alla normativa che lo prevede, alle modalità per realizzarlo, ai problemi ancora irrisolti che presenta; l’attività di monitoraggio ha il compito di condurre, appunto, la verifica degli esiti delle decisioni contenute nel Piano Strutturale (strumento della pianificazione territoriale) e nel Regolamento Urbanistico (atto di governo del territorio) del Comune di Campi Bisenzio, analizzando le trasformazioni e gli interventi avvenuti, attraverso un continuo confronto tra le previsioni di piano e le fotografie aeree. Si precisa, infine, che l’input per l’idea e la realizzazione del presente lavoro nasce dallo studio della relazione di monitoraggio del RU del Comune di Empoli (FI), redatta da un gruppo di lavoro coordinato dall’Arch. Mario Lopomo.
9
1. CAMPI BISENZIO A CAVALLO DEL MILLENNIO
1.1 Inquadramento ed evoluzione economico-sociale Campi Bisenzio è un comune della provincia fiorentina che si estende su una superficie di 28 chilometri quadrati e conta ad oggi quasi 44.000 abitanti; si situa nella piana tra le due maggiori città di Firenze e Prato. Proprio questa sua ubicazione strategica – al centro di una pianura alluvionale che si trova all’incrocio tra due direttrici fondamentali: quella Nord-Sud dell’Italia e quella della valle dell’Arno – ha, come si può immaginare, da sempre influito sulle sue vicende. La piana, che deriva da un esteso bacino lacustre formatosi nel Pleistocene e colmato con l’apporto di materiali alluvionali da parte del fiume Arno e di altri corsi d’acqua, infatti, per la sua posizione, è stata l’area più densamente popolata della regione fin dal Medioevo1; la colonizzazione del territorio da parte dell’uomo è tuttavia molto più antica, essendo stati ritrovati in zona reperti di epoca preistorica e importanti resti della presenza etrusca2; in epoca romana, come noto, la piana fu divisa in centurie (quadrati di circa 710 m di lato): di tale organizzazione territoriale rimangono tracce evidenti anche oggi, soprattutto nell’impianto dei percorsi (il decumano massimo che traeva origine dalla città di Florentia si allungava in direzione Nord-Ovest attraversando proprio la piana); Campi si sviluppò come borgo agricolo lungo il corso del fiume Bisenzio, che ha rappresentato fin da subito sia una risorsa economica, per i mulini, che un problema, per le numerose inondazioni; l'opera di bonifica del territorio durò molti anni e richiese ingenti risorse, di conventi, comunità e cittadini che avevano acquistato un podere nel contado. La struttura insediativa di questa piccola sezione della piana fiorentina era costituita, da un lato, da case sparse e ville padronali e, dall’altro, da borghi e borghetti3; le borgate – o “popoli” – di allora sono quelle che ancora oggi si ritrovano nella denominazione delle località e delle frazioni e nella suddivisione delle parrocchie; nel borgo più popoloso, corrispondente alla Pieve di Santo Stefano, si trovava (e si trova) la famosa Rocca, che fu dei Mazzinghi e poi degli Strozzi. La storia di Campi scorre attraverso i secoli sostanzialmente come quella di un paese prevalentemente agricolo: terra buona per i cereali, ma non altrettanto per la vite, contrastata dall’umidità imperante, come ci informa il Repetti4 nel suo celebre Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana (pubblicato tra il 1833 e il 1846: il salto temporale operato nella trattazione di questo breve inquadramento della storia campigiana è dovuto non certo alla carenza di informazioni sulle trasformazioni avvenute nel frattempo, quanto alla necessità di una sintesi funzionale al lavoro, che opera pertanto una selezione degli elementi più interessanti ai fini dell’elaborato); una discreta presenza di prati permetteva inoltre l’uso non banale del territorio
1 Lando Bortolotti, Giuseppe De Luca, Come nasce un’area metropolitana. Firenze Prato Pistoia: 1848-2000, Alinea, Firenze, 2000, p. 10 2 Alessandro Monti, La terra sul fiume. Storia di Campi dalle origini al Medioevo, Campi Bisenzio, Edizioni del Comune di Campi Bisenzio, 2003, pp. 14-22 3 Roberto Aiazzi, Sandra Baffetti, Stefano Bettini, Campi Bisenzio profilo di un territorio fiorentino (anni 1950 – anni 2000) Trasformazioni strutturali ed immagine della città, NTE, Firenze, 2009, pp. 13-14 4 Emanuele Repetti, Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana, Firenze, 1833-1846, vol. I, p. 415
10
Immagine 1.1: L’ubicazione di Campi Bisenzio nella Piana FI-PO-PT (fonte: Atlante Geografico Italia, Touring Editore, Milano, 2006)
Immagine 1.2: Confini amministrativi comunali
11
per il pascolo delle pecore5; nei borghi e nei borghetti, inoltre, era possibile ritrovare una gamma abbastanza articolata di attività artigianali ed una rete piuttosto fitta di commercio minuto; in particolare, è da segnalare il primo dei veri cambiamenti economico-sociali che interessano il Comune: quello dell’avvento della lavorazione della paglia. E’ necessario cominciare da questo evento per tracciare al meglio il profilo economico di questo territorio: infatti la storia di Campi Bisenzio è storia dell’industria manifatturiera in primo luogo, e può essere scandita in tre fasi6. La prima è quella sopra accennata, e si estende dall’inizio del XIX secolo fino agli anni Venti del secolo successivo, quando le attività extra-agricole del Comune sono dominate dal “ciclo della paglia”; dagli anni Venti fino all’avvento della guerra, tale attività entra in crisi e per Campi si prospetta un periodo di difficoltà. La seconda fase è legata invece all’industria del tessile, quando il Comune si inserisce nel ciclo del Distretto Pratese, a partire dall’immediato dopoguerra. La terza, prende avvio con gli anni Ottanta del Novecento; si inserisce in un processo di rilocalizzazione industriale in un contesto sempre più metropolitano, ed è caratterizzata dallo sviluppo del settore della meccanica, anche se il sistema moda continua a costituire una parte importante dell’economia. L’obiettivo è quello di descrivere per sommi capi i primi due momenti, per andare a comporre una base conoscitiva utile ai fini dell’approfondimento dell’ultima fase, la più interessante per lo studio, in quanto è quella che ha dato luogo alla situazione attuale. Riprendendo, quindi, a parlare del primo periodo, è da sottolineare il fatto che la manifattura della paglia, di cui Campi fu, e restò a lungo, l’epicentro, insieme a Signa e Lastra a Signa, non costituì solo un cambiamento economico, ma anche e soprattutto una piccola rivoluzione sociale: infatti, fino a quel momento, il grosso della popolazione campigiana era formato da manodopera bracciantile, cioè da contadini a cui non era stato assegnato nessun podere; la loro condizione era pertanto quella di fascia rurale miserabile, che occupava la maggior parte del tempo nei lavori agricoli, ma che, per sopravvivere, praticava anche una vasta gamma di altre attività, senza disdegnare i furti campestri. Lo sviluppo dell’industria della paglia fu, per queste persone, l’occasione per trovare uno sbocco lavorativo che potesse essere una fonte di sostentamento per la famiglia, con la possibilità di costituire in non pochi casi la parte maggioritaria dei redditi dei pigionali; inoltre, anche se il lavoro prevalente era a domicilio, dato che la manifattura della paglia non ha mai avuto bisogno di attrezzature meccaniche di grande complessità – anche quando, nei primi decenni del Novecento, conoscerà l’accentramento in piccole fabbriche –, la condizione di coloro che prima erano manodopera bracciantile passa ad essere quella dei primi proletari, in senso moderno, del tempo (con l’acquisizione anche di una prima coscienza di classe, dimostrata, ad esempio, nell’occasione dello sciopero delle trecciaiole di fine Ottocento)7. Una fra le conseguenze immediate dello sviluppo dell’industria del cappello di paglia fu un’abbondante fioritura di esercizi commerciali, anche a causa
5 Roberto Aiazzi, Sandra Baffetti, Stefano Bettini, Campi Bisenzio…, cit., p. 18 6 Roberto Aiazzi, Sandra Baffetti, Stefano Bettini, Campi Bisenzio…, cit., pp. 157-231 7 Lando Bortolott i, Giuseppe De Luca, Come nasce…, cit., pp. 43-44
13
della posizione baricentrica del centro lungo le strade di collegamento tra Firenze e Prato, che garantiva un discreto flusso di clienti e favoriva il lavoro dei venditori ambulanti; a tal proposito, l’inizio del Novecento fu per Campi anche il periodo in cui venne istituito il primo mercato settimanale, che si svolgeva il mercoledì sulle tre principali piazze del centro storico, dividendo così i diversi settori merceologici: all’inizio del dicembre 1909 in tutta la città vennero affissi manifesti che annunciavano tale novità8. Da un punto di vista demografico, questa prima fase è caratterizzata da una sostanziale crescita della popolazione, soprattutto fino agli anni Trenta del XIX secolo (1819: 6.622 abitanti, 1861: 10.604 abitanti, 1881: 12.235 abitanti), mentre negli anni Venti del Novecento si assiste ad una vera e propria regressione, ma in questo caso bisogna mettere in conto gli effetti della grande guerra e dell’epidemia dell’influenza “spagnola” (1911: 14.309 abitanti, 1921: 13.717 abitanti). Nel 1928, inoltre, Campi Bisenzio subisce l’unica congrua modifica territoriale, annettendo dal disciolto Comune di Brozzi l’importante frazione di San Donnino, decisione che comporta un incremento della popolazione di 2.929 unità9. Questo è anche il periodo in cui vengono costruite delle infrastrutture considerevoli per i collegamenti nella piana: nel 1848 viene inaugurata la ferrovia Leopolda, che si sviluppa su un tragitto che collega Firenze, Pisa e Livorno, e serve anche San Donnino; nel 1851 è invece inaugurata la ferrovia che collega Firenze a Lucca, passando per Prato e Pistoia; Campi era tuttavia il più importante fra i comuni che non erano serviti dalla ferrovia (con il suo ponte sul Bisenzio, era un passaggio obbligatorio tra Firenze e Prato): nel 1879, è così realizzata la prima tranvia a vapore tra Campi e Firenze, prolungata fino a Prato l’anno successivo; questa effettuava nel 1910 sette corse al giorno in ciascun senso10. Tuttavia, all’inizio del XX secolo, la diffusione delle auto e degli autobus è crescente e nel 1921 anche a Campi il servizio della tranvia viene sostituito con un autobus della Sita, cioè della FIAT11. A tal proposito, tra il 1928 e il 1932 viene realizzata, tra varie vicissitudini finanziarie e diverse ipotesi di tracciato, l’Autostrada A11 Firenze-Mare, che attraversando la pianura dell’Arno, si dirige verso Prato, Pistoia, la Valdinievole, la piana di Lucca, con il tronco finale che si colloca a metà strada tra Pisa e Viareggio. Inoltre, nel 1927 prende avvio la vicenda dell’aeroporto di Firenze, che si decide di collocare in un’area a nord-est dell’abitato di Peretola. Inaugurato nei primi anni Trenta, è inizialmente utilizzato a scopi militari, mentre i primi voli passeggeri sono effettuati solo alla fine degli anni Quaranta. Come già accennato, la fine degli anni Venti, segnati dal famoso crollo di Wall Street del 1929, che influenzò i mercati mondiali, decretò la crisi dell’industria della paglia, e a Campi la disoccupazione crebbe vertiginosamente; cominciò un lungo periodo di precariato in cui centinaia di operai riuscirono a vivere grazie a lavoretti saltuari nei campi, emigrando – soprattutto in Francia –, o lanciandosi nel piccolo commercio ambulante,
8 Fabrizio Nucci, Debora Pellegrinotti, La miglio r genìa. Storia del Novecento di una cittadina toscana: Campi Bisenzio, Campi Bisenzio, Edizioni del Comune di Campi Bisenzio, 2002, tomo I, pp. 82-85 9 Roberto Aiazzi, Sandra Baffetti, Stefano Bettini, Campi Bisenzio…, cit., pp. 20-29 10 Lando Bortolotti, Giuseppe De Luca, Come nasce…, cit., p. 69 e Saverio Mariotti, L’urbanizzazione
della campagna: il caso di Campi Bisenzio dal 1865 al 1945, Franco Angeli, Milano, 1993, pp. 53-73 11 Lando Bortolotti, Giuseppe De Luca, Come nasce…, cit., p. 72
14
Immagine 1.4: Grafico dell’andamento della popolazione tra il 1819 e il 1921 (elaborazione su dati tratti da: Roberto Aiazzi, Sandra Baffetti, Stefano Bettini, Campi Bisenzio…, cit., su fonte Repetti, Zuccagni Orlandini, MAIC ed ISTAT)
15
Immagine 1.5: Manifesto della direzione del tranvai del 13 ottobre 1891 (ASC. Aff. 145/1891, immagine tratta da: Saverio Mariotti, L’urbanizzazione della
campagna…, cit.)
Immagine 1.6: La fermata del tranvai in piazza Dante (foto A. Bartolini, tratta da: Saverio Mariotti, L’urbanizzazione della campagna…,
cit.)
16
consolidando quella tradizione di campigiani “venditori di tutto” protagonisti nei mercati settimanali delle piazze pratesi o fiorentine12. Subito dopo la guerra, comincia per Campi Bisenzio il “ciclo del tessile”, ovvero quel periodo che è stato definito come la seconda delle tre importanti fasi dello sviluppo socio-economico campigiano. Infatti, è proprio dall’industria tessile pratese, uno dei primi comparti produttivi a riprendersi dal dopoguerra, che l’economia campigiana ritrova una spinta propulsiva quando le macerie dei bombardamenti non sono ancora state finite di sgombrare13. Il grande confronto che si può operare rispetto all’epoca precedente è il seguente: mentre per l’industria della paglia il nostro comune era l’epicentro della vicenda, in questo caso è solo un tassello del mosaico pratese e del cuore del Distretto Tessile (Prato, Vaiano, Montemurlo e Carmignano). E’ in effetti proprio questa la caratteristica da mettere in evidenza per capire l’evoluzione che ha poi portato alla situazione economica e sociale degli anni Ottanta e Novanta: comuni come Campi Bisenzio (o come Calenzano) hanno fatto parte del Distretto Tessile Pratese, con notevoli addensamenti di imprese, ma non tali da poterli definire a dimensione monoproduttiva, presentando una composizione settoriale più variegata. Infatti, gli addetti al settore dell’industria tessile aumentano considerevolmente dal 1951 al 1971 (le date di riferimento sono quelle dei Censimenti), mentre diminuiscono in modo ragguardevole nel 1981. A questo calo di addetti nel settore tessile, fa da contropartita lo sviluppo della metalmeccanica, che si inserisce in un processo di delocalizzazione industriale imponente dal capoluogo provinciale verso i comuni minori, cominciato a partire dagli anni Sessanta e in cui Campi arriva ad essere coinvolta in epoca leggermente successiva. Inoltre, anche se in modo minore e meno marcatamente rispetto ad altri comuni contermini, questo è il periodo in cui anche nel nostro territorio crescono il settore del commercio e quello dei servizi. In particolare, per il commercio, cominciano a modificarsi i rapporti di forza tra il capoluogo e i comuni della prima cintura fiorentina: il peso commerciale di Firenze, storico baricentro dei consumi su scala vasta, dall’inizio degli anni Sessanta decade progressivamente ed in maniera consistente, a vantaggio di comuni come Sesto Fiorentino o Scandicci; Campi Bisenzio, in questo senso, registra in quegli anni una crescita meno elevata, mentre continua ad avere una certa rilevanza la figura sociale del commerciante ambulante nella composizione socio-professionale del commercio campigiano (tra gli anni Sessanta e Settanta gli ambulanti rappresentavano infatti circa il 14% sul totale degli addetti al commercio)14. La crescita dei settori del commercio, dei servizi, e soprattutto della metalmeccanica sono tutte tendenze che andranno accentuandosi nell’ultima fase esaminata. Da un punto di vista infrastrutturale, degna di nota è la costruzione, negli anni Sessanta, dell’Autostrada A1 Milano-Napoli, detta anche Autostrada del Sole, che attraversa il territorio comunale di Campi nella sua parte orientale; tra il 1960 e il 1964, l’architetto Giovanni Michelucci realizza, in prossimità dell’incrocio tra questa autostrada e la Firenze-Mare, nella
12 Fabrizio Nucci, Debora Pellegrinotti, La miglior genìa…, cit., tomo I, pp. 239-244
13 Fabrizio Nucci, Debora Pellegrinotti, La miglior genìa…, cit., tomo II, pp. 87-92
14 Roberto Aiazzi, Sandra Baffetti, Stefano Bettini, Campi Bisenzio…, cit., pp. 157-231
17
Immagine 1.7: Grafico dell’andamento della popolazione tra il 1921 e il 1981 (elaborazione su dati tratti da: Roberto Aiazzi, Sandra Baffetti, Stefano Bettini,
Campi Bisenzio…, cit., su fonte MAIC ed ISTAT)
18
frazione di Limite, la Chiesa di San Giovanni Battista, che va a costituire un importante esempio di architettura religiosa moderna sul territorio campigiano. Per quanto riguarda l’andamento demografico, gli anni che coprono il periodo descritto, sono caratterizzati da due fasi: la prima, corrispondente al momento della ripresa post-bellica, in cui si rileva una sostanziale stagnazione demografica; la seconda, invece (dagli anni Sessanta agli anni Ottanta) è caratterizzata da una marcata crescita. A Campi in un ventennio si passa da 18.030 abitanti (1961) a 33.153 (1981)15. Questo è un fenomeno collegato anche a quel fondamentale processo di formazione dell’area metropolitana fiorentina, in cui, in questo periodo, si assiste ad una fase di suburbanizzazione, che vede una perdita di popolazione da parte di Firenze rispetto all’aumento di quella dei comuni di corona. In effetti, la piana, in questi anni, investita da un sempre crescente processo di industrializzazione e da uno sviluppo urbanistico tendenzialmente spontaneo, che determina la perdita della forma-città, non tenendo conto degli elementi costitutivi del territorio, da sistema policentrico e multipolare che era nell’immediato dopoguerra, diventa una conurbazione, tanto che nel 1981 è possibile identificare un tessuto urbano compatto da Grassina (Bagno a Ripoli) a Fornacelle (Montemurlo)16. Il modo migliore per iniziare a trattare la terza e ultima fase, densa e ricca di avvenimenti che hanno fortemente inciso sulla storia economico-sociale recente e sulla situazione attuale, è descrivere la vicenda che ha segnato una svolta importantissima nell’economia campigiana: l’apertura del nuovo stabilimento delle Officine Galileo nella zona industriale di Tomerello, nel 1980. Del trasferimento della storica azienda fiorentina specializzata in produzioni quali la strumentazione ottica, il meccanotessile e la meccanica di precisione, e ubicata negli stabilimenti di Rifredi, si era già cominciato a parlare all’inizio degli anni Sessanta, ma il 1973 fu l’anno decisivo per l’accordo sul trasferimento a Campi Bisenzio. I lavori cominciarono nel 1978 e terminarono nel 1980. Per il Comune, l’arrivo della grande industria fiorentina segnava una svolta importantissima nella vita economica, e soprattutto costituiva la possibilità dell’inserimento al centro del processo di ristrutturazione della grande industria nell’area di Firenze, Prato e Pistoia. Inoltre, introduceva un altro elemento di novità: la presenza del settore meccanica e alta precisione (le Officine Galileo sono oggi specializzate nella produzione di strumenti scientifici ed astronomici) che andava così a diversificare ulteriormente ed arricchire il panorama produttivo della città, imperniato fino a quel momento soprattutto sul tessile e sull’abbigliamento17. Come già accennato, infatti, il periodo che prende avvio dagli anni Ottanta è caratterizzato, per Campi, dallo sviluppo del settore della meccanica, che si inserisce, però, in una sempre più complessa e variegata traiettoria metropolitana, in un contesto che concede sempre più ampi spazi al terziario commerciale e ai servizi. Vediamo in dettaglio, ed anche attraverso l’aiuto dei dati numerici18, le dinamiche di questo fenomeno.
15 Roberto Aiazzi, Sandra Baffetti, Stefano Bettini, Campi Bisenzio…, cit., pp. 72-80
16 Lando Bortolotti, Giuseppe De Luca, Come nasce…, cit., pp. 134-138
17 Fabrizio Nucci, Debora Pellegrinotti, La miglior genìa…, cit., tomo II, pp. 231-233
18 Roberto Aiazzi, Sandra Baffetti, Stefano Bettini, Campi Bisenzio…, cit., pp. 157-231
19
Immagine 1.8: L’industria manifatturiera: pesi percentuali degli addetti su scala provinciale
(fonte: Roberto Aiazzi, Sandra Baffetti, Stefano Bettini, Campi Bisenzio…, cit., su fonte ISTAT)
(*) comprende anche il territorio comunale di Poggio a Caiano, costituito in Comune a sé stante nel 1962
20
Immagine 1.9: I servizi: pesi percentuali degli addetti su scala provinciale (fonte: Roberto Aiazzi, Sandra Baffetti, Stefano Bettini, Campi Bisenzio…, cit., su
fonte ISTAT)
21
Immagine 1.10: Il commercio: pesi percentuali degli addetti su scala provinciale e analisi re lativa al commercio ambulante
(fonte: Roberto Aiazzi, Sandra Baffetti, Stefano Bettini, Campi Bisenzio…, cit., su fonte ISTAT)
22
Prendendo in considerazione il settore dell’industria manifatturiera nel suo complesso, il decennio che va dal 1981 al 1991 vede Campi Bisenzio perdere terreno: infatti, in linea con quello che succede nel resto della provincia (con la sola eccezione di Scandicci) e a Prato, globalmente, gli addetti al settore diminuiscono; come già ripetuto, però, all’interno di questo fenomeno va ricercato il sostanziale cambiamento che ha interessato il Comune in questo periodo: all’interno dell’industria manifatturiera, infatti, è quella tessile che si ridimensiona – in senso negativo – in modo ragguardevole, andando a pesare fortemente sul totale del settore secondario. Se analizziamo i dati riguardanti la metalmeccanica, si può vedere che la variazione di addetti al settore, dal 1981 (2.674 addetti) al 1991 (2.557), non è di grande entità, anche in considerazione del fatto che al censimento del 1971 questi erano 462. In particolare, all’interno della metalmeccanica, al censimento del 1991, il Comune si distingue soprattutto per una robusta performance nella strumentazione di precisione: ciò è da attribuire soprattutto ai processi di rilocalizzazione di produzioni tecnologicamente avanzate (la già trattata vicenda delle Officine Galileo) da Firenze. Per quanto riguarda invece la sfera del commercio, Campi si inserisce nel più generale contesto di urbanizzazione e “metropolitanizzazione” della piana fiorentina, che si è portato dietro una marcata crescita diffusa degli esercizi commerciali, durante gli anni Ottanta. Con intensità diversa da comune a comune, la rete commerciale prima è cresciuta in termini numerici (unità locali e addetti), e poi ha ricercato un miglior grado di qualità (gamma dei prodotti venduti, professionalità, ecc.). Ed accanto ai piccoli esercizi distributivi si sono formati medi e grandi magazzini commerciali. Campi Bisenzio, in questo processo, ha conosciuto anch’esso una crescita, anche se non di pari intensità a quella dei comuni maggiori della cintura fiorentina. Gli addetti al settore, nel decennio considerato, vanno da 1.580 a 2.002. Inoltre, si assiste ad un progressivo affermarsi del commercio all’ingrosso soprattutto nei comuni a nord-ovest di Firenze, anche se non con uniformità territoriale: ed in effetti nel Comune di Campi Bisenzio (come del resto in quelli di Scandicci, Signa, Prato, ed ancor più a Firenze) il peso del commercio al dettaglio, anche al Censimento del 1991, supera la soglia del 50%; si può affermare che, comunque, si è prodotto un ridisegno dei rapporti di forza tra grande e piccola distribuzione (ed in anni più vicini, andrà aumentando la potenza dei grandi magazzini e dei centri commerciali). Per ciò che invece concerne la sfera dei servizi, si può affermare che la redistribuzione ha teso a mantenere a Firenze i “servizi di eccellenza” (studi professionali prestigiosi, Università e Biblioteche, Ospedali e laboratori d’analisi, ecc.), mentre si sono decentrati servizi tecnicamente definiti come “banali” (ad esempio, i servizi alla persona). Per quel che attiene alla storia economica di Campi Bisenzio, questo comune non sfugge alla logica che ha caratterizzato i rapporti di forza tra Firenze e le aree limitrofe; forse, ancor più che comuni come Scandicci e Sesto Fiorentino, Campi presenta una maggior consistenza relativa proprio nei servizi “banali”. Il comune, nel decennio 1981-1991, è interessato da una crescita di addetti al settore dei servizi che, in valore assoluto, vanno da 1.360 a 1.879. In tale fenomeno, che vedremo proseguire anche nel decennio successivo, vanno a confluire sia gli effetti del complessificarsi del sistema delle
23
Pubbliche Amministrazioni (Regioni, Province, Comuni, ASL, Enti Parchi…) sia la rilevazione delle Associazioni no profit. Ma per poter meglio apprezzare le dinamiche dello sviluppo del terziario è utile considerare non solo il numero degli addetti, ma il rapporto di questo sulla superficie territoriale, e soprattutto sulla popolazione residente: infatti, detto in parole povere, una forte crescita demografica può attenuare, anche molto, una discreta o buona spinta ascensionale degli addetti ad un settore o ad un comparto. Per quanto riguarda il commercio, al Censimento del 1981, a Campi si contavano 68 addetti per chilometro quadrato, mentre nel 1991, 90 addetti per chilometro quadrato. Il dato che rapporta gli addetti alla popolazione residente è ancora più significativo, perché mette a confronto grandezze che entrambe variano nel tempo; a tal proposito, si riscontra che nel 1981 si trovavano 58 addetti ogni 1.000 abitanti e nel 1991, 75 addetti ogni 1.000 abitanti. Le stesse analisi si possono condurre per la sfera dei servizi, con questi risultati: nel 1981 si rileva un valore di 47 addetti per chilometro quadrato e 41 ogni 1.000 abitanti, mentre nel 1991, di 66 addetti per chilometro quadrato e 54 ogni 1.000 abitanti. Detto questo, non si può non fare un richiamo alla dinamica demografica19 del decennio appena preso in considerazione: il periodo 1981-1991, è per Campi Bisenzio, un arco temporale di lieve crescita-assestamento, dopo il boom degli anni Sessanta e Settanta; la popolazione residente, da 33.153 abitanti, diventa di 34.444 abitanti; la densità aumenta così, da 1.158,39 a 1.203,49 abitanti per chilometro quadrato, divenendo una delle più alte della Toscana. Anche le caratteristiche demografiche delle famiglie campigiane stavano profondamente cambiando: da una parte, un netto invecchiamento della popolazione aveva portato il rapporto tra giovani e anziani di uno a uno, dall’altra, c’era stato un notevole innalzamento del livello di istruzione medio, con un forte incremento della diffusione dei titoli di studio superiori, che segnava una svolta rispetto al livello storicamente basso dell’istruzione nel Comune. Il Censimento del 1991 segnalò anche un miglioramento della situazione abitativa, infatti, con la costruzione di nuove aree di edilizia popolare risultava praticamente scomparso il problema della coabitazione, che invece aveva caratterizzato gli anni precedenti. Da un punto di vista sociale, gli anni Ottanta sono contraddistinti da luci e ombre20: i problemi innescati dallo sviluppo incondizionato e dal boom demografico degli anni Sessanta e Settanta cominciano a farsi sentire, e Campi Bisenzio balza in testa alle graduatorie provinciali per la diffusione della droga, il che contribuisce, nel 1988, all’apertura del centro operativo contro le tossicodipendenze dell’Usl. Nello stesso periodo, del resto, il Comune si dota di strutture e servizi culturali, clamorosamente mancati nel decennio precedente: oltre all’inaugurazione di un asilo nido, quattro scuole elementari e una scuola media (necessarie per superare il problema dell’edilizia scolastica – ancora praticamente ferma all’epoca fascista – per una città che aveva superato i 30.000 abitanti), si assiste all’apertura del centro culturale e della biblioteca per ragazzi “Gianni Rodari”. Questi sono gli anni in cui l’amministrazione comunale comincia a promuovere anche la
19 Roberto Aiazzi, Sandra Baffetti, Stefano Bettini, Campi Bisenzio…, cit., pp. 72-80
20 Fabrizio Nucci, Debora Pellegrinotti, La miglior genìa…, cit., tomo II, pp. 237-239
24
Immagine 1.11: Grafico dell’andamento della popolazione tra il 1981 e il
2010 (elaborazione su dati tratti da: Roberto Aiazzi, Sandra Baffetti, Stefano Bettini, Campi Bisenzio…, cit., su fonte MAIC ed ISTAT, aggiornati al 2010 attraverso le statistiche annuali consultabili sul sito internet del Comune di Campi Bisenzio)
25
riappropriazione dell’identità storica di Campi, sostenendo la ricerca e dando alle stampe alcune pubblicazioni per colmare il vuoto storiografico esistente. Nel 1988, inoltre, Campi sale alla ribalta delle cronache come luogo per lo svolgimento del festival nazionale de “L’Unità”. L’area teatro dell’evento è quella di Villa Montalvo, ovvero quella dei poderi della villa-fattoria (di origine trecentesca, appartenuta nel tempo a numerosi proprietari, tra cui le famiglie dei Medici e dei Ramirez de Montalvo, da cui prende il nome, e acquistata dall’amministrazione comunale nel 1984) che si estendono lungo il torrente Marina fino all’autostrada, per un totale di 19 ettari; il progetto del parco attrezzato per la festa è finanziato inizialmente dal PCI, poi abbandonato negli anni successivi, una volta spenti i riflettori sull’evento, e portato a termine solo nel corso degli anni Novanta, quando il Comune acquista i terreni e realizza, in otto anni, una vasta area a verde pubblico, di respiro metropolitano, cornice di numerose manifestazioni sportive e culturali. Per l’evoluzione economico-sociale del territorio, inoltre, uno degli eventi degni di nota, è sicuramente la decisione di spostare lo stabilimento Fiat di Novoli a Campi – che si concretizzerà alla fine degli anni Novanta –, con l’approvazione del progetto Fiat Fondiaria da parte del consiglio comunale di Firenze nel 1988. Il trasferimento delle Officine Galileo aveva aperto un nuovo fronte, e questa seconda scelta confermava la precedente. Proprio questo episodio è significativo per continuare la trattazione, affrontando il secondo decennio di quella che è stata definita la terza fase della storia economica della città. Infatti, analizzando le dinamiche del settore dell’industria manifatturiera, se negli anni Ottanta si era registrata una decrescita negli addetti, l’ultimo decennio del secolo vede una Campi Bisenzio in marcata progressione in questo campo, che ridimensiona la posizione del Comune all’interno della situazione provinciale: gli addetti alle attività manifatturiere sono, nel 2001, il 5,61% del totale provinciale; questo dato produce un importante allineamento con il polo manifatturiero di Scandicci (5,65%), mentre viene abbondantemente superata la posizione di Calenzano (3,67%). Inutile dire che questa crescita è determinata, con sempre maggior nitidezza, dall’affermarsi di una specializzazione meccanica. Parallelamente, si rileva uno sviluppo forse ancora più consistente nel settore terziario; in particolare, per ciò che concerne il commercio, il Censimento del 2001 ci pone di fronte ad un valore importante: gli addetti aumentano di ben 1.413 unità, andando a raggiungere quota 3.415 ed a costituire il 3,53% sul totale provinciale; in questo fenomeno ha modo di manifestarsi l’insediamento, sul territorio campigiano, di grandi concentrazioni commerciali21. Alla base di questi processi, per Campi, c’è una delle più significative operazioni urbanistiche del secolo, la cosiddetta “Variante Nord” di Capalle22, che concretizza il progetto del trasferimento dello stabilimento Fiat di Novoli, a cui aggiunge quello della costruzione di un grande centro commerciale di moderna concezione. La firma per l’accordo per lo spostamento della Fiat avviene il 27 aprile 1993, alla presenza dei sindaci di Campi (Adriano Chini) e di Firenze (Giorgio Morales), dei presidenti della Provincia (Mila Pieralli) e della Regione (Vannino Chiti), e dell’ingegner Gilberto Pane in rappresentanza della Fiat. Qualche mese dopo l’azienda rende noto che lo stabilimento di Campi sarebbe stato destinato alla
21 Roberto Aiazzi, Sandra Baffetti, Stefano Bettini, Campi Bisenzio…, cit., pp. 157-231
22 Variante al PRG del 1985
26
Immagine 1.12: I primi anni Duemila: quadro generale dei settori economici
e analisi delle attività manifatturiere (fonte: Roberto Aiazzi, Sandra Baffetti, Stefano Bettini, Campi Bisenzio…, cit., su
fonte ISTAT; dati aggiornati al 2005) (**) la Provincia è considerata con i vecchi confini (comprendendo la Provincia di Prato)
27
produzione di giunti, in collaborazione con la multinazionale inglese GKN. Già nel 1996 i lavori sono terminati, e l’industria funziona a pieno ritmo. Per il centro commerciale, a cui è destinata un’area prospiciente a quella occupata dalla Fiat-GKN, ci si affida al progetto degli architetti Adolfo e Fabrizio Natalini (gli stessi che firmeranno la realizzazione del nuovo polo universitario delle Scienze Sociali, sorto proprio su parte dello spazio da recuperare di Novoli); la struttura, chiamata “I Gigli”, diventerà la più grande di questo genere, in Italia, e sarà inaugurata il 29 maggio 1997, dopo un’intensa campagna pubblicitaria senza precedenti. Non c’è dubbio che il centro commerciale “I Gigli” abbia fatto molto parlare di sé, non solo per la portata dell’opera (che si estende su 257.175 m², di cui 70.000 m² di superficie utile lorda, 35.000 m² di parcheggi pubblici e 63.452 m² di parco fluviale) ma anche e soprattutto per le implicazioni sociali, economiche ed infrastrutturali che ha determinato. A riguardo si sono profuse numerosissime pubblicazioni, che ne hanno messo in luce i pro e i contro; senza voler negare l’importanza dell’evento – che ha proiettato la cittadina, per così dire, “nel nuovo millennio”, con qualche anno di anticipo23, con l’inserimento, insieme allo stabilimento Fiat-GKN, di una struttura a forte valenza metropolitana – sicuramente devono essere considerati anche alcuni fattori critici: prima di tutto, l’effetto anti-urbano che la cittadella del commercio e dei divertimenti si porta dietro, come luogo della banalizzazione e della massificazione delle differenze culturali, senza alcuna relazione identitaria con il territorio, destinato alla circolazione accelerata delle persone e dei beni di consumo; poi, l’impatto che un tale intervento apporta alla rete della piccola distribuzione: non si può dire, infatti, che la nascita de “I Gigli” abbia giovato al commercio di vicinato del centro storico di Campi. Inoltre, la costruzione della cosiddetta “Mezzana Perfetti Ricasoli”, una strada di scorrimento tra Prato e Firenze, che attraversa l’area industriale di Capalle, la cui completa realizzazione si è protratta nel tempo e non è ancora oggi conclusa, è stata funzionale di fronte all’evidenza che l’apertura del centro non poteva essere affrontata con la viabilità esistente. Per quanto riguarda la viabilità, sono da segnalare anche le (quasi) contestuali inaugurazioni delle due Circonvallazioni della città, che hanno tuttavia una storia molto diversa: la Circonvallazione Sud, costruita in tempi brevi, è inaugurata nel settembre del 1997, mentre la Circonvallazione Nord è terminata nel 2001, dopo una lunga serie di vicissitudini cominciate negli anni Ottanta a partire da un contenzioso tra il Comune e il Ministero. Riprendendo il filo del discorso, nell’ambito dell’analisi socio-economica settore per settore, dopo aver parlato di industria e commercio, resta da affrontare la sfera dei servizi24. Il censimento del 2001 conferma la progressiva crescita degli addetti in questo campo, che aumentano dalle 1.879 unità del 1991 alle 2.506. Campi Bisenzio conosce tuttavia un incremento sensibilmente più contenuto rispetto ad altri comuni (soprattutto, in ordine gerarchico: Firenze, Prato, Sesto Fiorentino e Scandicci), cui fa da contraltare, come è stato descritto, una maggior frequenza degli addetti all’industria manifatturiera. Per un confronto ancora più approfondito del settore terziario, rispetto al decennio precedente, è costruttivo fare nuovamente riferimento al rapporto tra addetti e superficie territoriale e addetti e popolazione residente. I 90
23 Fabrizio Nucci, Debora Pellegrinotti, La miglior genìa…, cit., tomo II, pp. 256-260
24 Roberto Aiazzi, Sandra Baffetti, Stefano Bettini, Campi Bisenzio…, cit., pp. 157-231
28
addetti al commercio per chilometro quadrato del 1991 sono diventati 137 nel 2001; e, se nel ’91 se ne contavano 75 ogni 1.000 abitanti, nel 2001 sono 106. Per quanto riguarda i servizi, invece, gli addetti per chilometro quadrato sono 87 (nel ’91 erano 66), e ogni 1.000 abitanti se ne trovano 67 (54 nel ’91). Da un punto di vista demografico25, è interessante notare come, in controtendenza rispetto agli altri comuni della cintura fiorentina, Campi Bisenzio cresca nel decennio 1991-2001, fino ad arrivare ad una popolazione di 37.249 abitanti. Tale saldo positivo è dato, in parte, da un numero di nascite maggiore rispetto a quello delle morti, ma soprattutto dal fenomeno dell’immigrazione (anche se sono consistenti pure i flussi in uscita). E proprio da questo dato è utile cominciare per affrontare una delle questioni sociali più rilevanti degli ultimi anni: quella, appunto, dell’immigrazione di cittadini extracomunitari, e, in particolare, per Campi, della formazione di una consistente comunità cinese. Il problema è inserito in un contesto europeo, nazionale e metropolitano (in particolare, in Toscana, riguarda sezioni come il Pratese, i comuni a nord-ovest di Firenze, e il Circondario di Empoli), e quindi non assolutamente peculiare del Comune, che tuttavia negli anni Novanta ha dovuto affrontare momenti di grande tensione26. L’emergenza è legata alla sempre più massiccia presenza di persone cinesi nelle frazioni di San Piero a Ponti e, soprattutto, di San Donnino, dove, a partire dagli anni Ottanta, i primi immigrati hanno cominciato ad impiantare le proprie aziende del settore pelletteria, che proprio in zona vantava una consolidata tradizione. Alla fine del 1991, delle 190 aziende di questo comparto presenti sul territorio, 88 sono cinesi; circa due anni dopo, nel 1993, le 132 aziende cinesi hanno ormai superato le 91 italiane. Davanti alle pressioni sempre più insistenti della popolazione, l’amministrazione comunale cerca una politica di concertazione con gli altri comuni dell’area fiorentina per una distribuzione più oculata della numerosa comunità cinese, e dà impulso ad esperienze pilota nella didattica per l’alfabetizzazione dei bambini stranieri; un ruolo di non poco conto, nella vicenda, spetta al parroco di San Donnino, don Giovanni Momigli, che ha cercato, da un lato, di promuovere un’apertura nei confronti della comunità cinese, favorendo una progressiva integrazione di una quota ragionevole di immigrati, e dall’altro, di lavorare per migliorare la situazione anche nella comunità italiana, favorendo attività socio-culturali e ricreative. I problemi non sono certo ad oggi risolti, però tali iniziative hanno determinato un miglioramento nella coesistenza tra le due comunità, e l’amministrazione cerca di portare avanti una discreta politica di integrazione (del resto, nel 2009, Campi Bisenzio è stato il primo comune italiano ad avere un assessore cinese, Honguy Lin, che si occupa, appunto, dei rapporti con la comunità cinese). Gli anni Novanta sono anche il periodo in cui il fiume Bisenzio torna prepotentemente ad essere il protagonista della storia della città, dopo aver perso il legame con la vita sociale di Campi, per lo sviluppo dell’industria e l’abbandono delle antiche attività ad esso correlate27. Infatti, dopo 25 anni dall’ultima inondazione (quella del 1966, nello stesso periodo della disastrosa alluvione di Firenze), la sera del 15 novembre 1991,
25 Roberto Aiazzi, Sandra Baffetti, Stefano Bettini, Campi Bisenzio…, cit., pp. 72-80
26 Fabrizio Nucci, Debora Pellegrinotti, La miglior genìa…, cit., tomo II, pp. 247-252
27 Fabrizio Nucci, Debora Pellegrinotti, La miglior genìa…, cit., tomo II, pp. 253-255
29
il Bisenzio rompe l’argine nella zona delle Corti, riversandosi con forza verso via Fornello e via Tipitapa, investendo con le sue acque una vasta porzione del centro, negozi, uffici, scantinati e i pianterreni di migliaia di abitazioni, provocando danni per 144 miliardi di lire e anche una vittima. A partire da questo episodio, l’amministrazione comunale promuove una serie di interventi volti alla messa in sicurezza del fiume e al risanamento idraulico, nonché al miglioramento delle condizioni di degrado degli argini e dell’inquinamento delle acque. Nel corso degli anni, grazie a questa politica, il fiume è tornato ad essere parte integrante della città, meta di passeggiate lungo il suo corso, e, mediante il diffondersi degli impianti di depurazione, si è assistito anche alla ricomparsa della fauna ittica, scomparsa per oltre venti anni. A questo punto, la trattazione ha delineato linee sufficienti per poter capire quale sia la situazione economica e sociale con cui Campi Bisenzio si affaccia al nuovo millennio, e poter tracciare ancora un breve profilo dell’ultimo decennio, analizzando i tratti salienti che hanno caratterizzato gli anni dal 2001 fino ad oggi. Le peculiarità della situazione attuale sono, ovviamente, un’evoluzione di quelle dell’ultimo periodo del Novecento, e infatti, nei primi anni Duemila, la città conferma ancora la sua preminenza come polo manifatturiero28, all’interno dell’area metropolitana (cui si avvicinano le prestazioni dei confinanti comuni di Calenzano e Signa), centrato sulla meccanica (e, in particolare, per l’ormai affermata presenza sul territorio delle Officine Galileo e dello stabilimento Fiat-GKN, sulla progettazione e produzione degli strumenti di precisione e sulla realizzazione di componenti essenziali nel ciclo degli autoveicoli); parallelamente a questa qualificata esistenza di produzioni meccaniche, restano anche nuclei di produzione tessile e piccole imprese occupate nel settore della pelletteria, entro una comune linea evolutiva segnata dalla contrazione, in questo campo. Per quanto riguarda le strutture della distribuzione commerciale, oltre ai Gigli si sono insediate sul territorio altre unità di commercio all’ingrosso, in gran parte ancora nella zona industriale di Capalle; ma in questi ultimi anni, si è cercato di rivitalizzare anche la rete commerciale presente nel centro storico di Campi: a questo proposito sono collegate due circostanze: quella della riqualificazione urbanistico-edilizia del vecchio centro urbano e l’altra, relativa alla nascita del Consorzio “Fare Centro Insieme”. A partire dal 2003, infatti, con un investimento di 4 milioni di euro, di cui 2 milioni e 196mila finanziati dall’Unione Europea29, il centro è stato oggetto di una riqualificazione, con lo scopo di valorizzare la centrale via Santo Stefano e le strade e le piazze ad essa adiacenti; inoltre, il 16 novembre 2003, è stata introdotta la Zona a Traffico Limitato tra piazza Dante e piazza Gramsci, che ha portato una modifica storica per il capoluogo: accantonare, per la prima volta, la secolare sudditanza al ponte sul Bisenzio. L’amministrazione comunale ha tentato di ridare a via Santo Stefano il ruolo di nodo centrale anche per le attività economiche; uno dei primi provvedimenti (del 2000) è stato quello di riportarvi il mercato settimanale, per anni svolto in un’area decentrata; oltre a ciò, il 30 maggio 2002 il Consiglio Comunale ha approvato il PIR (Piano Integrato di Rivitalizzazione),
28 Roberto Aiazzi, Sandra Baffetti, Stefano Bettini, Campi Bisenzio…, cit., pp. 213-231
29 Tra recupero della propria identità e crescita, il comune diventa città: Campi Bisenzio dal 1990 al
2004, Adriano Chini, Campi Bisenzio, 2004, pp. 54-63
30
che ha portato 40 piccole aziende a consorziarsi in “Fare Centro Insieme”, per promuovere una serie di iniziative con l’obiettivo di incentivare azioni di marketing30. Il consorzio, nel dicembre 2010, si è evoluto in un’associazione, che eredita le finalità di promozione del centro di Campi Bisenzio31. A proposito di associazioni, c’è da dire che quella dell’aggregazione a scopo sociale è una caratteristica tradizionale e abbastanza considerevole, sul territorio: nel 1999 è stato istituito un apposito Albo Comunale delle Forme Associative e del Volontariato32, che conta, ad oggi, l’iscrizione di più di 400 associazioni33, suddivise in sei settori di attività (socio-assistenziali e umanitarie; culturali, celebrative, educative e scientifiche; sportivo-ricreative e del tempo libero; per la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali; per la difesa dei diritti dei cittadini e degli utenti; per la tutela e rappresentanza delle attività economiche). Inoltre, nel 2004, a San Donnino è stato inaugurato un nuovo Spazio polivalente di aggregazione sociale ed eventi sportivi, a fianco della parrocchia; tale circostanza permette di aprire una breve parentesi su alcuni interventi che hanno interessato questa frazione negli ultimi anni34, annessa al territorio campigiano, come è stato già detto, solo nel 1928: è da sottolineare, infatti, il ripristino della fermata dei treni alla stazione di San Donnino – posta sulla linea della ferrovia Leopolda – all’inizio del 2009, e l’apertura di una nuova strada di Circonvallazione che, seguendo un tracciato che costeggia la frazione di San Piero a Ponti, collega il capoluogo con San Donnino. Circa la situazione sul versante dei servizi, c’è da sottolineare un deficit in questo settore, che va considerato però in termini di area vasta, in cui i servizi “pregiati” sono andati sempre più concentrandosi, rendendo anacronistica l’idea di un’autosufficienza terziaria di un territorio, per di più di dimensioni contenute, come quello campigiano. Ad ogni modo, negli anni Duemila, le categorie di servizi maggiormente presenti sono quelli alle Imprese in senso lato (che possono comprendere attività immobiliari, noleggio di macchinari e attrezzature, informatica, attività di ricerca e sviluppo, attività professionali in senso stretto come gli studi di ingegneria o di architettura, …), seguiti da quelli tradizionali alla persona (smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili, attività di organizzazioni associative n.c.a., attività ricreative, culturali e sportive, …)35. Per quanto riguarda l’andamento demografico, anche quest’ultimo decennio è segnato ancora da un aumento della popolazione residente: sono positivi non solo i saldi migratori (infatti è sempre crescente la presenza di componenti etniche extra-comunitarie), ma anche quelli naturali. Comportamenti demografici simili si possono riscontrare solo nei comuni di Signa e di Prato, con cui Campi condivide inoltre, all’interno di una pur diffusa tendenza all’invecchiamento della popolazione, un profilo invece abbastanza “giovane” rispetto ad altre circoscrizioni territoriali (al 2006,
30 Tra recupero della propria identità e crescita…, cit., pp. 196-201
31 Come si legge nel sito internet dell’associazione: www.campi-bisenzio.eu
32 Tra recupero della propria identità e crescita…, cit., pp. 18-20
33 L’Albo delle Associazioni è consultabile all’indirizzo internet:
www.comune.campibisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/986 34 Tra recupero della propria identità e crescita…, cit., pp. 42-47
35 Roberto Aiazzi, Sandra Baffetti, Stefano Bettini, Campi Bisenzio…, cit., pp. 213-231
31
l’età media è di 42,3 anni, la più piccola tra i comuni della cintura fiorentina)36. Per capire l’entità dello sviluppo demografico, si descrive l’andamento della popolazione attraverso i valori numerici, con salti temporali di tre anni: al 31 dicembre 2004 vivevano a Campi Bisenzio 39.176 abitanti, suddivisi in 13.924 famiglie; di questi, 4.403 erano stranieri; alla stessa data del 2007 i residenti erano 41.849 (in 15.754 famiglie) di cui 5.256 stranieri; al 31 dicembre 2010, infine, la popolazione ha raggiunto quota 43.901 abitanti, (in 16.721 famiglie e 9 convivenze), in cui 6.419 non sono italiani. Le comunità straniere più numerose sono (in ordine decrescente) quella cinese, quella albanese e quella rumena37.
36 Roberto Aiazzi, Sandra Baffetti, Stefano Bettini, Campi Bisenzio…, cit., pp. 99-103
37 Dati tratti dalla sezione “Statistiche annuali” del sito internet del comune di Campi Bisenzio,
consultabile all’indirizzo: www.comune.campibisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5840
32
Immagine 1.13: Grafico di sintesi sull’andamento della popolazione nel
lungo periodo (elaborazione su dati tratti da: Roberto Aiazzi, Sandra Baffetti, Stefano Bettini,
Campi Bisenzio…, cit., su fonte MAIC ed ISTAT, aggiornati al 2010 attraverso le statistiche annuali consultabili sul sito internet del Comune di Campi Bisenzio)
33
1.2 Storia urbanistica Per descrivere la dinamica della storia urbanistica di Campi Bisenzio, saranno presi in considerazione i momenti più importanti per la pianificazione comunale, dagli anni Settanta ad oggi: il Piano Regolatore Generale del 1971 (approvato nel 1973, su progetto dell’Architetto Sandro Mori), il Piano Regolatore Generale del 1985 (approvato nel 1988, su progetto dell’Architetto Sergio Sozzi e del Dottore Vincenzo Bentivegna), integrato e modificato dalle successive Varianti, tra cui la già citata – nel paragrafo relativo all’evoluzione economico-sociale – Variante Nord al PRG (adottata nel 1992 e approvata l’anno successivo), e il Piano Strutturale (adottato nel 2003 ed approvato nel 2004, su progetto dell’Architetto Pietro Pasquale Felice) e il Regolamento Urbanistico (adottato nel 2004 e approvato nel 2005, su progetto originale dello stesso Architetto Pietro Pasquale Felice) vigenti. Parlare della storia urbanistica recente di Campi Bisenzio, significa anche – e purtroppo – fare riferimento alla sua storia giudiziaria. Il Comune fu, infatti, coinvolto, nel 2007, in un grande scandalo, in cui, in estrema sintesi, si evidenziò la non conformità del Regolamento Urbanistico con il Piano Strutturale, che poneva dei limiti volumetrici al fabbisogno residenziale complessivo, abbondantemente superati dall’insieme dei permessi di costruire rilasciati a partire dall’adozione del PS stesso. Tale vicenda gravò sul mondo tecnico e politico del Comune, e venne affidato ad un nuovo architetto il compito di redigere una Variante al RU, finalizzata al riallineamento con il Piano Strutturale. Ma l’argomento, ora anticipato, verrà trattato in modo più dettagliato in seguito. L’obiettivo del paragrafo è soprattutto quello di individuare, confrontando i piani, le rilevanti opzioni strategiche che dal PRG del ’71 ad oggi sono rimaste nell’agenda politica e urbanistica locale (sia da un punto di vista normativo che da quello progettuale), senza dimenticare che, come qualsiasi altra, anche l’attività di pianificazione deve essere necessariamente calata nel periodo storico in cui si è svolta, e pertanto, molti dei contenuti dei piani comunali analizzati derivano dalla filosofia che ha influenzato le vicende urbanistiche nazionali e l’impostazione legislativa. Il PRG del 1971, infatti, basato sull’idea che l’espansione urbana fosse una crescita necessaria, indiscutibile, da razionalizzare e da non limitare, opera attraverso una rigida zonizzazione, un razionale disegno delle infrastrutture, con scarsa attenzione alle zone non urbane; negli anni Ottanta nasce invece l’esigenza di un piano che sia più dinamico, capace di gestire i cambiamenti economici, sociali e culturali in atto: il PRG del 1985 nasce come Variante Generale a quello del 1971 e cerca di dare maggiore importanza al flusso di informazioni, determinanti per garantire una visione realistica sullo stato di attuazione del piano, con la consapevolezza che le questioni locali debbano essere inserite in un contesto più ampio, percependo che si stanno realizzando le condizioni per la formazione di un sistema metropolitano. Il piano si propone di aumentare la quantità di urbanizzazione del Comune, nell’accezione di attuare un processo di trasformazione del territorio che lo adegui alle nuove esigenze scaturite dai già citati cambiamenti economici-sociali (si fa particolare riferimento al sistema infrastrutturale) e di promuovere un aumento della qualità del sistema produttivo locale e della vita sociale.
34
Ai fini del presente lavoro, è stato ritenuto interessante, con l’obiettivo di delineare i tratti salienti dell’evoluzione urbanistica del Comune e di determinare quali siano stati gli elementi di persistenza normativi e di progetto, ricostruire un excursus di analisi sulla dinamica degli indici e dei parametri urbanistici che, nel tempo, hanno disciplinato i tessuti insediativi; ogni piano, attuando le disposizioni dell’articolo 2 del Decreto Ministeriale 1444 del 1968, prevede una zonizzazione territoriale, secondo la quale: le zone A sono “le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”, le zone B “le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq”, le zone C “le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B)”, le zone D “le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati”, le zone E “le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C)” e le zone F “le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale”. A tal proposito, per le zone A sia il PRG del 1971 che quello del 1985 prevedono, come principale strumento di intervento il Piano di Recupero, essendo tali zone descritte come “di particolare interesse, ma giunte oggi ad un alto livello di degradazione, situate in punti nevralgici del territorio comunale” (art. 15 delle Norme di Attuazione del PRG del 1971) e “insediamenti che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, ma interessate in generale da uno stato di degrado” (art. 20 delle Norme per l’Attuazione del PRG del 1985). Il Regolamento Urbanistico vigente, propone, invece, una diversa definizione delle zone A, descrivendole come “insediamenti che rivestono carattere storico, artistico, di particolare pregio ambientale e di elevata sensorialità” (art. 110 delle Norme Tecniche di Attuazione) ammettendo Piani di Recupero e PIR (Programmi Integrati per la Rivitalizzazione della rete distributiva, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Regionale 4/99). Per quanto riguarda le zone B, il PRG del 1971 le divide in quattro sottozone (art. 16): B1, B2, B3, che si distinguono per la differenza di indici e parametri, e B4, definita “zona di risanamento edilizio” e assimilabile alle zone A. Per quest’ultima sono specificati i seguenti indici e parametri: B4 altezza massima: 10,5 m indice di fabbricabilità fondiaria: 2,5 m³/m² rapporto di copertura: 0,40 mentre le altre tre sottozone sono così definite:
35
B1 altezza massima: 17 m indice di fabbricabilità fondiaria: 3 m³/m² rapporto di copertura: 0,50 B2 altezza massima: 13,5 m indice di fabbricabilità fondiaria: 2 m³/m² rapporto di copertura: 0,50 B3 altezza massima: 10,5 m indice di fabbricabilità fondiaria: 1,5 m³/m² rapporto di copertura: 0,40 Questi stessi parametri e indici delle tre sottozone B1, B2 e B3 si ritrovano anche nel PRG del 1985; infatti, si riscontra che in tale piano le zone B siano così suddivise e definite (art. 21): BO: di conservazione, a sua volta suddivisa in:
- conservazione del vecchio tessuto urbanistico ed edilizio (assimilabile alla zona A), per la quale si prevedono interventi di recupero - conservazione architettonico-ambientale di formazione recente, per cui sono ammessi ampliamenti planivolumetrici fino al raggiungimento di un rapporto di copertura non superiore al 75% - conservazione tipologica-ambientale, per cui si prevede il mantenimento delle tipologie e dei volumi, anche ammettendo interventi di sostituzione edilizia
B1: di sostituzione edilizia a pari volume B2: di completamento e sostituzione edilizia secondo parametri urbanistici, suddivisa in tre ulteriori sottozone, per le quali i parametri e gli indici sono esattamente gli stessi di quelli definiti per le B1, B2 e B3 nel ’71, e pertanto: 1 altezza massima: 17 m indice di fabbricabilità fondiaria: 3 m³/m² rapporto di copertura: 0,50 2 altezza massima: 13,5 m indice di fabbricabilità fondiaria: 2 m³/m² rapporto di copertura: 0,50 3 altezza massima: 10,5 m indice di fabbricabilità fondiaria: 1,5 m³/m² rapporto di copertura: 0,40 B3: di ristrutturazione urbanistica (zone degradate che necessitano di un intervento radicale), per le quali si stabilisce: altezza massima: 17 m rapporto di copertura: 0,50
36
volumi edificabili: pari a quelli esistenti, aumentati nel limite del 10% In particolare, gli indici e i parametri della sottozona 2 delle sottozone B2 del PRG del 1985 (che, come già detto, sono gli stessi delle sottozone B2 del PRG del 1971) si riscontrano anche nelle norme del RU vigente; infatti, questo suddivide le zone B in: B: zone residenziali da consolidare (art. 116); hanno appunto gli stessi indici e parametri sopra accennati: altezza massima: 13,5 m indice di fabbricabilità fondiaria: 2 m³/m² rapporto di copertura: 0,50 Bc: zone residenziali di completamento del tessuto insediativo (art. 118): altezza massima: 13,5 m indice di fabbricabilità territoriale: 1 m³/m² rapporto di copertura: 0,40 Br: zone residenziali di ristrutturazione urbanistica (art. 119); sono assimilabili alle zone B3 del PRG del 1985, ma hanno altri indici e parametri: altezza massima: 13,5 m indice di fabbricabilità fondiaria: 2 m³/m² rapporto di copertura: 0,40 Bp: zone residenziali del PEEP (Piano per l’Edilizia Economica e Popolare) vigente e per la residenza sociale (art. 120) Le zone C, invece, nel PRG del 1971 sono suddivise in (art. 17): C1: zone per l’edilizia economica e popolare (per quanto riguarda l’edilizia sociale, si è visto come nel RU vigente essa sia compresa nelle zone Bp, mentre nel PRG del 1985 viene semplicemente specificato, all’art. 22, che l’attuazione delle zone C di espansione residenziale avverrà mediante PP (Piani Particolareggiati), PEEP o lottizzazioni di iniziativa privata o pubblica) C2 e C3, che si differenziano per diversi parametri e indici: C2 altezza massima: 13,5 m indice di fabbricabilità fondiaria: 2 m³/m² rapporto di copertura: 0,50 C3 altezza massima: 10,5 m indice di fabbricabilità fondiaria: 1,5 m³/m² rapporto di copertura: 0,40 Anche nel PRG del 1985 le zone C sono suddivise in tre sottozone (art. 22):
37
1 altezza massima: 16,5 m indice di fabbricabilità territoriale: 2,5 m³/m² rapporto di copertura: 0,35 2 altezza massima: 11,5 m indice di fabbricabilità territoriale: 2 m³/m² rapporto di copertura: 0,40 3 altezza massima: 9 m indice di fabbricabilità territoriale: 1,5 m³/m² rapporto di copertura: 0,40 Il RU vigente, invece, non suddivide le zone C, e per esse stabilisce: altezza massima: 13,5 m indice di fabbricabilità territoriale: 1,2 m³/m² rapporto di copertura: 0,40 Per le zone D i piani definiscono un’articolazione abbastanza complessa. Il PRG del 1971 (art. 18) prevede una suddivisione in sette sottozone, di cui quattro (la D3, la D4, la D6 e la D7) introdotte con successive Varianti; le sottozone D1 (di espansione) e D2 (di completamento) presentano stessi parametri e indici e si differenziano per la procedura di intervento stabilitavi: per le D1 intervento urbanistico preventivo, per le D2 intervento urbanistico diretto. D1 e D2 altezza massima: 12 m indice di fabbricabilità fondiaria: 3 m³/m² rapporto di copertura: 0,50 Nelle sottozone D3 (di espansione per servizi e attrezzature annessi all’industria) si opera attraverso intervento urbanistico preventivo. Le sottozone D4 (di completamento per insediamento di depositi di carburanti e combustibili) hanno come procedura di intervento stabilita quella dell’intervento edilizio diretto e presentano i seguenti indici e parametri: D4 altezza massima: 12 m indice di fabbricabilità fondiaria: 1 m³/m² rapporto di copertura: 0,20 Nelle sottozone D5 (di espansione, destinate all’insediamento di industrie insalubri, in particolare per lo stallaggio, la macellazione e la lavorazione delle carni) si interviene con intervento urbanistico preventivo, nel rispetto degli indici e dei parametri: D5 altezza massima: 12 m indice di fabbricabilità fondiaria: 3 m³/m² rapporto di copertura: 0,50
38
Le sottozone D6 (di espansione per attività artigiane e/o industriali di piccola e media dimensione) presentano i seguenti indici e parametri: D6 altezza massima: 12 m indice di fabbricabilità fondiaria: 2,5 m³/m² rapporto di copertura: 0,50 Infine, per le sottozone D7 (di espansione, destinate ad attività produttive all’aperto) si dispone: D7 altezza massima: 6 m indice di fabbricabilità fondiaria: è ammessa la realizzazione di un magazzino di 80 m² e di locali di custodia e uffici a carattere semipermanente di 40 m² per ogni insediamento rapporto di copertura: 0,50 Il PRG del 1985 prevede per le zone D ben otto sottozone (art. 23): D1: di espansione, in cui si interviene attraverso Piano Particolareggiato: altezza massima: 12 m rapporto di copertura: 0,50 D2: di completamento, per le quali si dispone che vi si operi attraverso intervento edilizio diretto, e che le manutenzioni, le modifiche, le ristrutturazioni e gli ampliamenti debbano rispettare un rapporto di copertura pari a 0,50, mentre per le nuove costruzioni i parametri e gli indici sono: altezza massima: 10 m rapporto di copertura: 0,50 D3: per officine ferroviarie, necessitano di Piano Particolareggiato D4: per depositi di carburante; presentano gli stessi valori di altezza massima e di indice di fabbricabilità fondiaria delle zone D4 del piano del 1971, mentre varia il rapporto di copertura (da 0,20 a 0,15): altezza massima: 12 m indice di fabbricabilità fondiaria: 1 m³/m² rapporto di copertura: 0,15 D5: per la coltivazione di cave D6: commerciali e direzionali, vi si interviene attraverso Piano Particolareggiato o progetto edilizio: altezza massima: 21 m indice di fabbricabilità territoriale: 3 m³/m² rapporto di copertura: 0,40
39
D7: per attività produttive all’aperto, sono normate come le sottozone D7 del 1971, ma non si esprime il valore del rapporto di copertura: altezza massima: 6 m indice di fabbricabilità fondiaria: è ammessa la realizzazione di un magazzino di 80 m² e di locali di custodia e uffici a carattere semipermanente di 40 m² per ogni insediamento D8: per depositi all’aperto, vi si può intervenire con Piano Particolareggiato o lottizzazione o progetto edilizio; si ammette la costruzione di locali di servizio fino ad un massimo di 100 m² di superficie coperta per ogni insediamento. Il Regolamento Urbanistico vigente, infine, prevede per le zone D cinque sottozone: D1 (art. 121): aree produttive da consolidare (di completamento); presentano gli stessi indici e parametri delle sottozone D1 e D2 del PRG del 1971: altezza massima: 12 m indice di fabbricabilità fondiaria: 3 m³/m² rapporto di copertura: 0,50 all’interno delle sottozone D1, è inclusa un’ulteriore sottocategoria, chiamata D1a (art. 122), che comprende un’area interclusa tra il fosso Macinante e l’Autostrada A1, a nord di San Donnino, in cui non sono consentite nuove edificazioni D2 (art. 132): aree produttive di nuova definizione (di espansione); presentano gli stessi indici e parametri delle sottozone D1 e D2 del PRG del 1971: altezza massima: 12 m indice di fabbricabilità fondiaria: 3 m³/m² rapporto di copertura: 0,50 D3 (art. 123): aree per industrie a rischio di incidente rilevante (di completamento, per depositi di carburanti e combustibili); dal confronto con i piani precedenti, emerge un aumento del valore del rapporto di copertura; l’indice di fabbricabilità fondiaria non è espresso: altezza massima: 12 m rapporto di copertura: 0,40 D4 (art. 124): aree per depositi di materiali a cielo aperto (di completamento); rispetto alle norme dei piani precedenti, cambiano le superfici ammesse per il manufatto per uffici e custodia (25 m² di superficie utile lorda massima), per il manufatto per il magazzino (superficie coperta
40
non superiore al 10% dell’area); inoltre, sono ammesse tettoie aperte su tre lati. D5 (art. 133): aree a prevalente destinazione terziaria di nuova definizione (di espansione); sono suddivise a seconda del sistema funzionale definito dal Piano Strutturale in cui ricadono:
- delle aree edificate e trasformabili altezza massima: 21,5 m indice di fabbricabilità fondiaria: 3 m³/m² rapporto di copertura: 0,40
- degli ambiti strategici indice di fabbricabilità territoriale: 1,2 m³/m²
- delle aree produttive gli indici e i parametri sono indicati da Piano di Massima Unitario L’ultima prescrizione consente di spendere poche righe circa il Piano di Massima Unitario: tale strumento è stato introdotto dal PS (nell’elaborato 13.0: Relazione sul progetto di Piano Strutturale, impostazione del sistema valutativo e “Marketing” del territorio) e dalla prima stesura del RU, in alternativa al Piano Attuativo - da cui si differenzia solo in termini procedurali – con l’intento di recuperare una certa flessibilità per la definizione degli standard urbanistici; la terza Variante al Regolamento Urbanistico, redatta dopo l’entrata in vigore della legge 1/2005 e in seguito alle problematiche scaturite dai dubbi sulla legittimità del RU originario (finalizzata, pertanto, al riallineamento del RU al PS) ha reintrodotto lo strumento del Piano Attuativo, comprendendo in questa categoria anche il Piano di Massima Unitario. Per quanto riguarda le zone E, il PRG del 1971 dispone una normativa abbastanza concisa (art. 19); le aree agricole sono infatti suddivise in due sottozone che si differenziano per i parametri e gli indici urbanistici; in particolare, le sottozone E2 sono quelle inedificate o a scarsissima edificazione: E1 altezza massima: 8 m indice di fabbricabilità fondiaria: 0,03 m³/m² rapporto di copertura: 0,5 E1 altezza massima: 4 m indice di fabbricabilità fondiaria: 0,01 m³/m² rapporto di copertura: 0,2 Il PRG del 1985 mantiene la suddivisione in due sottozone, raffinando la definizione (art. 25): E1: agricole normali (art. 25a) E2: agricole con valore ambientale (art. 25b)
41
Entrambe sono disciplinate dalla legge 10 del 1979. Per alcuni complessi morfologici delle zone E2 si prevede la redazione, da parte del Comune, di Piani Particolareggiati “ispirati ai principi della conservazione e della valorizzazione dei valori paesistici, agrari, faunistici, architettonici e alla promozione di usi collettivi del territorio”; in questa definizione si percepisce una diversa (rispetto agli anni Settanta) concezione della politica del recupero, che dopo gli anni Ottanta prende in considerazione anche aree extraurbane. Gli ambiti che necessitano di Piano Particolareggiato sono tre:
- porzione del parco centrale metropolitano
- porzione del parco delle Miccine (frazione della zona occidentale del Comune, ai confini con Prato)
- porzione in riva destra di Arno (San Donnino)
Inoltre, per una particolare zona in località Le Prata nella frazione di Sant’Angelo a Lecore è prevista la realizzazione di impianti di servizio all’agricoltura per attività di conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli (art. 25c, introdotto con Variante del ’97), con parametri e indici: altezza massima: 12 m rapporto di copertura: 0,10 Il RU vigente distingue, nelle zone E:
- quelle a carattere di seminativo (art. 154)
- quelle per l’ortoflorovivaismo e per la pastorizia (art. 155) Entrambe sono disciplinate dal Titolo IV, Capo III, della legge regionale toscana 1/2005 e dal Regolamento regionale 5R/2007. Infine, le zone F, nel PRG del 1971, sono suddivise in tre sottozone (art. 20): F1: zona aeroportuale; in quegli anni era infatti previsto, dal Piano Intercomunale Fiorentino, che l’aeroporto di Firenze fosse trasferito nei pressi di Sant’Angelo a Lecore, progetto poi evidentemente non attuato, sia per l’opposizione dei Comuni di Campi Bisenzio e di Prato, sia per l’intenzione di potenziare l’aeroporto di Peretola F2: zona a disposizione del Piano Intercomunale Fiorentino F3: zona per impianti complementari all’autostrada (introdotta con la prima Variante) Il Piano Intercomunale Fiorentino è uno strumento che si propone lo scopo di predisporre il coordinamento dei PRG dei Comuni dell’area Firenze-Prato-
42
Pistoia; nasce nel 1956 con un Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici e si può suddividere in due fasi: la prima (1956-1966), che definisce alcuni punti fermi per l’assetto generale della viabilità e per la dislocazione delle principali attrezzature intercomunali; la seconda (1971-1978) che, sempre nella stessa ottica, cerca però di porre maggiore attenzione agli aspetti qualitativi e sostenibili della trasformazione territoriale, promuovendo interventi di recupero nel patrimonio edilizio esistente per affrontare il fabbisogno residenziale. Il PRG del 1985 non prevede sottozone per le zone F (art. 26): nelle norme elenca alcuni esempi (aree per attrezzature per l’istruzione superiore dell’obbligo, aree per parchi pubblici di livello urbano e territoriale, aree per altri impianti e attrezzature di interesse generale esistenti o di progetto: Palazzetto dello Sport e impianti sportivi all’aperto di via Barberinese, centro culturale di Villa Montalvo, Chiesa, uffici e Motel dell’Autostrada e, introdotti con Variante del ’98, struttura destinata a Canile rifugio e cassa di laminazione idraulica), mentre nella cartografia ogni destinazione d’uso delle zone F è indicata con apposito simbolo. Il RU vigente presenta un articolo (art. 139) di simile struttura, per le zone F, (descrivendole come parti del territorio destinate ad accogliere attrezzature di livello sovracomunale, quali: palazzetti dello sport ed altri impianti sportivi di livello metropolitano, piscine, centri culturali e direzionali di livello sovracomunale, interporto, attrezzature universitarie, canili rifugio, strutture per convegnistica, centri socio-sanitari ed altre analoghe attrezzature di interesse generale a livello metropolitano), specificando che le attrezzature realizzate da privati devono rispettare i seguenti indici e parametri: altezza massima: 15 m indice di fabbricabilità fondiaria: 3 m³/m² rapporto di copertura: 0,40
43
Immagine 1.14: Tavola dell’uso della struttura fisica del territorio del
Regolamento Urbanistico vigente (legenda nella pagina seguente) (unione delle tavole E/a ed E/b del RU; scala originale: 1:5.000)
45
Come già anticipato, parallelamente alla descrizione, appena terminata, della panoramica sull’evoluzione normativa relativa agli indici e ai parametri urbanistici che hanno disciplinato le trasformazioni territoriali, il lavoro si propone di rintracciare, nei precedenti piani, le radici e le origini di alcune significative opzioni strategiche progettuali che tuttora caratterizzano gli strumenti urbanistici vigenti; e inoltre, di sottolineare come, relativamente a tematiche particolarmente rilevanti per il Comune, alcune di queste siano invece radicalmente cambiate nel tempo. Uno degli elementi di continuità che si possono riscontrare è l’individuazione di alcune aree strategiche, all’interno del territorio comunale, che, più di altre, sono state considerate adatte ad ospitare particolari funzioni e ad assolvere il ruolo di nodi di interesse per lo sviluppo urbano e di particolari settori. Nel PRG del 1985, all’interno del Capo IV delle Norme per l’Attuazione del Piano (“Divisione del territorio comunale in zone e sottozone. Vincoli e caratteri da osservare in ciascuna zona e sottozona”) è dedicato un articolo (art. 24) a particolari zone integrate con obbligo di PP; tali aree sono tre: 1) “Barberinese” (art. 24a) 2) “Palagetta” (art. 24b) 3) “Area Nord Produttiva” (art. 24c); quest’ultima è stata introdotta con l’ormai più volte menzionata Variante Produttiva Nord, approvata nel 1993
La prima comprende alcune zone ad est e ad ovest di via Barberinese, importante asse stradale del Comune di Campi Bisenzio, principale infrastruttura di attraversamento nord-sud. Nel piano sono esplicitate le linee guida per la realizzazione di un polo multifunzionale, con caratteristiche da dettagliarsi attraverso due Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica o privata: uno ad est della via, con destinazioni commerciali e direzionali (sottozona D6) per un volume edificabile pari a 34.350 m³, l’altro ad ovest, comprensivo di aree destinate alla residenza (sottozona B2: di completamento e sostituzione edilizia secondo parametri urbanistici) per un volume di 58.500 m³ e a strutture commerciali e direzionali (52.300 m³), con la previsione della collocazione di una scuola media superiore (zona F). E’ facile comprendere come l‘investimento del piano su quest’area sia di notevole importanza, data la rilevante integrazione funzionale (residenza, servizi, esercizi commerciali, studi professionali) e la previsione di una struttura a forte valenza intercomunale come una scuola media superiore. Gli strumenti urbanistici attuali confermano il valore strategico dell’area in questione; dagli anni Ottanta ad oggi lungo via Barberinese sono state realizzate diverse strutture per servizi di interesse collettivo, uffici (anche comunali), attrezzature e impianti sportivi, attività ricettive, esercizi commerciali, nonché cospicue espansioni residenziali; il Piano Strutturale (che inserisce l’asse infrastrutturale nel sottosistema funzionale delle strade urbane generatrici della forma “città”) e il Regolamento Urbanistico vigente continuano a prevedere aree per attrezzature di interesse comune e per l’istruzione. In particolare, una delle più recenti Varianti al RU, presentata al pubblico il 28 ottobre 2011, è finalizzata alla realizzazione di strutture sanitarie e scolastiche in via Barberinese: un ospedale privato convenzionato e un liceo scientifico; la scuola media superiore, prevista già
46
dal piano del 1971 (non esattamente in via Barberinese, ma comunque non distante) e poi da quello del 1985, infatti, è arrivata a Campi, in veste di sede associata del Liceo Scientifico A.M.E. Agnoletti di Sesto Fiorentino, solo nel 2001, ed occupa tuttora alcuni locali sottratti all’adiacente scuola media. Vicende simili spettano anche alla seconda delle zone territoriali integrate così definite dal PRG del 1985: quella di via Palagetta. Anche questo asse infrastrutturale, infatti, svolge una funzione di collegamento nord-sud per la zona orientale del territorio comunale, e nel tempo è stato teatro di previsione di numerose funzioni; il PP del 1985 comprende 91.200 m³ di attrezzature di interesse comune ad uso commerciale e di servizio e 22.800 m³ per la residenza. Gli strumenti urbanistici attuali (che includono anche via Palagetta nel sottosistema funzionale delle strade urbane generatrici della forma “città”) prevedono, in relazione a tale asse, aree per l’istruzione, per attrezzature di interesse comune e aree residenziali di nuova definizione (zona C). L’art. 24b del PRG del 1985 precisa, però, che “La zona integrata “Palagetta” […] potrà essere realizzata solo in condizioni di compatibilità col sistema delle infrastrutture di collegamento, in particolare con la linea ferroviaria “lenta” Firenze-Signa”: questa è un’opzione strategica che dagli anni Ottanta è presente nell’agenda politica e urbanistica locale, ed esiste il progetto di una stazione ferroviaria appunto non lontano dalla strada in questione; è da osservare che sicuramente previsioni di tale entità sono più complesse da realizzare, perché coinvolgono ben più di una amministrazione pubblica o di un ente; tuttavia, ad oggi non si intravedono le condizioni che permettano la concretizzazione della linea lenta né tantomeno della stazione nei pressi di via Palagetta. L’argomento sarà comunque più dettagliatamente trattato in seguito, in merito alle previsioni urbanistiche riguardanti la mobilità. La terza ed ultima zona territoriale integrata citata nel piano del 1985 è quella dell’Area Nord Produttiva. Come si legge all’art. 25c delle NTA, “è una zona destinata prevalentemente ad attività industriali, commerciali, direzionali di livello comprensoriale; denominata “Caposaldo n. 7” nello Schema Strutturale; di quest’ultimo ne attua i contenuti previsionali e le indicazioni normative”. Lo Schema Strutturale per l’area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia è uno strumento di governo territoriale approvato dalla Regione Toscana nel 1990, in seguito alla conferenza per il coordinamento degli interventi di pianificazione territoriale della piana. Tale strumento ha avuto, per l’epoca, un portato innovativo, in quanto ha obbligato le amministrazioni a pensare in un’ottica metropolitana, e ha riabilitato il ruolo della pianura come luogo per ritrovare le risorse adatte a ricucire i tessuti urbani periferici dell’area; uno degli obiettivi dello Schema Strutturale è il riordino delle aree produttive e direzionali: la terza zona territoriale integrata di Campi Bisenzio rientra in questa finalità. I PP (di iniziativa pubblica e/o privata) per quest’area sono tre:
- Per insediamenti industriali e artigianali I parametri urbanistici e la destinazione d’uso sono quelli della sottozona D1 e la superficie coperta edificabile massima è di circa 20.000 m²
47
- Per insediamenti commerciali e direzionali I parametri urbanistici e le destinazioni d’uso sono quelli della sottozona D6; la capacità edificatoria massima è articolata in: 350.000 m³ per attività di dettaglio organizzato e di dettaglio tradizionale, punti vendita e somministrazione di cibi e bevande, magazzini, uffici, direzione; 121.000 m³ per attrezzature alberghiere-residence, servizi culturali e ricreativi, attrezzature sportive al chiuso, centri di attrazione, ristorante, servizi paracommerciali, uffici pubblici e privati, attività espositive, centri di calcolo e di ricerca, centro-auto
- Per insediamenti industriali e artigianali I parametri urbanistici e la destinazione d’uso sono quelli della sottozona D1 e la superficie coperta edificabile massima è di circa 69.000 m², esclusivamente per lo stabilimento FIAT
E’ noto come gli interventi più vistosi scaturiti dalle disposizioni della Variante Nord siano stati l’insediamento del centro commerciale “I Gigli” e dello stabilimento FIAT-GKN; le implicazioni economiche e sociali di tali trasformazioni territoriali sono state descritte nel paragrafo ad esse dedicato. Nella zona in questione, ricadente all’interno del sottosistema funzionale delle aree produttive, gli strumenti urbanistici vigenti prevedono ulteriori espansioni della sottozona D5. C’è da sottolineare una particolarità: il centro commerciale “I Gigli” ricade anche all’interno del sottosistema funzionale delle caratteristiche sensoriali dei contesti urbani (redatto in base ad un’indagine condotta in fase di realizzazione del Piano Strutturale sui giudizi percettivi dei cittadini sulla qualità visiva, sonora, olfattiva e tattile della città: art. 34 delle NTA del PS) e presenta un valore “notevole” (i parametri di giudizio delle caratteristiche sensoriali sono “basso”, “medio”, “alto” e “notevole”), superiore anche a quello del centro storico (“alto”), e pertanto, nelle tavole del Regolamento Urbanistico, l’area è contrassegnata da un simbolo che indica “presenza di caratteristiche sensoriali da preservare”. Per proseguire la ricerca sugli elementi di persistenza progettuali contenuti nel tempo dai vari piani, è interessante e necessario affrontare il tema della mobilità. Sicuramente una rilevante opzione strategica rimasta nell’agenda politica e urbanistica locale è quella di incrementare la mobilità su ferro presente sul territorio (che ancora oggi consiste solo in un tratto della ferrovia Firenze-Pisa, sul quale la frazione di San Donnino beneficia di una stazione). Nella cartografia del PRG del 1971, come ferrovia di progetto è indicato un tratto che attraversa il territorio comunale occidentale da nord a sud: è quello previsto dal Piano Intercomunale Fiorentino del 1965 (raccordo Prato-Signa); il PRG del 1985 contempla invece la realizzazione di ben tre fermate sul territorio campigiano: la prima, posta lungo il tracciato della già citata linea lenta Firenze-Signa, collocata in un’area tra il capoluogo e la frazione di San Piero a Ponti; le altre due, invece, sul tratto Indicatore-Gonfienti (raccordato alla linea Firenze-Signa), una in corrispondenza di via dell’Albero, nella zona La Villa, e l’altra nei pressi di via Fratelli Cervi, a servizio di Capalle e della sua area industriale; il Regolamento Urbanistico
48
vigente ripropone sostanzialmente l’idea del 1985, con la previsione di due tratti ferroviari - uno con orientamento nord-sud e l’altro con orientamento est-ovest – e di tre stazioni: la principale, circa nella stessa localizzazione prospettata dal piano precedente, e altre due, sul tratto nord-sud, una a servizio della zona degli impianti sportivi di via Barberinese, l’altra in località la Villa. Nel Piano Strutturale, il tratto nord-sud è indicato come prosecuzione tranviaria della direttrice est-ovest (Firenze-Aeroporto-Osmannoro-Campi Bisenzio), che si dirige verso Prato sud (a nord) e verso Signa (a sud). Anche per quanto riguarda la mobilità su gomma si possono riscontrare nei piani alcune proposte progettuali perdurate nel tempo. Già nel PRG del 1971, infatti, sono indicati i tracciati della Circonvallazione Nord e di una nuova strada provinciale Firenze-Prato, anch’essa collocata nella parte nord del Comune. Il percorso della Circonvallazione è lo stesso che si trova nel PRG del 1985: la costruzione dell’infrastruttura, infatti, iniziata nel 1979, fu interrotta con Decreto Ministeriale per la tutela paesaggistica della zona di Villa Montalvo; il piano del 1985 conferma l’opera nella stessa posizione planimetrica, rinviando alla progettazione esecutiva la soluzione del rapporto con la villa. La vicenda termina soltanto nel 2001, con l’inaugurazione dell’asse. Anche l’ipotesi di progetto della nuova strada provinciale Firenze-Prato ha spazio nel piano degli anni Ottanta, il quale prevede, per di più, al centro della carreggiata, una tramvia veloce (art. 17 delle Norme per l’Attuazione del Piano). Ma dal confronto tra gli strumenti urbanistici vigenti e il PRG del 1985 emergono altre due ipotesi progettuali persistenti: quelle dei tracciati della Circonvallazione Sud e della Bretella Granatieri-Gonfienti. La prima è stata realizzata nel 1997, non ricalcando fedelmente il tracciato previsto nel piano del 1985; infatti, questa doveva affiancarsi alle due linee ferroviarie, lambendo il centro abitato anche ad ovest, ed invece, ancora oggi, il principale asse di attraversamento della città, in quella zona, è via Barberinese. In effetti, ancora nella strumentazione urbanistica attuale è previsto il prolungamento ad ovest della Circonvallazione. La seconda consiste in un tronco di superstrada che avrebbe dovuto unire Prato alla Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, attraversando il territorio comunale di Campi Bisenzio nella sua parte occidentale; le modalità e l’opportunità di realizzazione di una Bretella Lastra a Signa-Prato sono ancora oggi argomento di discussione all’interno delle amministrazioni locali e nella cartografia attuale si rileva il progetto di tale percorso. Si può osservare che anche nel piano del 1971 era previsto un raccordo stradale in quella direzione, ma con tracciato diverso. Per quanto riguarda le vicende della provinciale Firenze-Prato, l’idea ha preso campo con la realizzazione della Mezzana-Perfetti-Ricasoli, che, ad oggi, non è ancora totalmente terminata.
49
Immagine 1.15: Tavola di progetto del Piano Strutturale vigente (legenda nella pagina seguente)
(elaborato 13.7 b del PS; scala originale: 1:10.000)
51
Una tematica particolarmente delicata, come già ripetuto, per il Comune di Campi, è quella relativa al rischio idraulico; dopo l’alluvione del 1991, uno degli obiettivi prioritari dell’amministrazione comunale è stato quello volto a promuovere degli interventi che potessero risolvere o contenere tale problematica, che da sempre ha afflitto la popolazione campigiana. Può essere significativo, pertanto, ricostruire un’analisi sul modo in cui la normativa di piano si è regolata a riguardo, nel tempo. In realtà, dalla lettura delle norme dei piani del 1971 e del 1985, si rileva che la messa in sicurezza dal rischio idraulico non può essere considerata un’opzione strategica persistente: infatti, nel primo dei piani presi in considerazione, non è mai fatto esplicito riferimento ai problemi legati alla situazione idraulica del Comune, e inoltre vengono ammesse costruzioni sotterranee o seminterrate (art. 7 delle Norme di Attuazione del PRG). Il PRG del 1985 dimostra una debole presa di coscienza dello stato delle cose, introducendo l’indice del rapporto di permeabilità (art. 11, lettera n delle Norme per l’Attuazione del Piano); inoltre, con alcune Varianti sono state previste casse di espansione e laminazione (Variante 17 del ’95, Variante 46 del ’98 per la località Tomerello, Variante 55 del ’99 per San Donnino, Variante 82 del 2004 per Focognano); tuttavia, si ammettono ancora volumi interrati fino al 30% del volume edificabile sul lotto e, in particolari situazioni di traffico e di sosta, possono essere autorizzati volumi interrati anche oltre il 30% del volume edificabile sul lotto, purchè il volume eccedente sia destinato a parcheggio ad uso pubblico (art. 11, lettera h delle Norme per l’Attuazione del Piano); all’art. 28 (Aree per parcheggi pubblici) viene ribadito che i parcheggi possono essere realizzati anche nel sottosuolo e che la loro copertura può essere attrezzata a verde. Negli strumenti urbanistici vigenti, invece, la tematica è affrontata con maggiore consapevolezza: nel RU assume ancora più importanza il contenimento dell’impermeabilizzazione superficiale, a cui è dedicato l’art. 45 delle NTA (che dispone il mantenimento di una quota di superficie permeabile non inferiore al 25% della superficie fondiaria); inoltre (art. 71), in caso di documentata impossibilità di prevedere sufficiente superficie permeabile, è ammessa la realizzazione di vasche di prima pioggia idonee a contenere sufficienti quantità di acqua piovana, per poi rilasciarla in modo controllato; ma è soprattutto l’art. 86 che introduce delle importanti novità: al comma 8 si legge che “relativamente alle aree di autocontenimento (che sono aree di laminazione deputate al contenimento dei volumi di pioggia degli areali che hanno subito un aumento dell’impermeabilizzazione rispetto al 1985) […] ove possibile si prescrive la non realizzazione di nuove unità abitative ad esclusivo sviluppo orizzontale al PT, attuando invece la suddivisione verticale dell’edificio al fine di avere comunque una via di fuga.”; il comma 9 prescrive che “l’impiantistica dovrà essere immergibile o posta a quota di sicurezza idraulica, gli ascensori dovranno avere il comando automatico che in caso di piena impedisca l’arresto dello stesso al piano terra, i bandoni dei garage dovranno aprirsi anche in caso di presenza di un battente d’acqua all’esterno, per permettere la fuga dall’interno.”; infine, al comma 10, che attua l’art. 2 delle NTA del PS, si legge che “in tutto il territorio comunale non possono essere realizzati interrati. In riferimento ai volumi interrati esistenti si prescrive il non ampliamento del volume, della superficie utile, della superficie non residenziale.”. Inoltre, l’art. 142 disciplina le casse di espansione e compensazione idraulica, indicate nella cartografia 1:2.000 ed elencate all’art. 29 delle NTA del PS (“per il Garille a Focognano, per il Gavine a San Donnino, per il Vingone-Lupo in località Le Miccine, per il
52
Crucignano in località Fornello, per lo scolmatore di piena del Bisenzio con cassa di espansione idraulica in località Le Miccine”). Come anticipato all’inizio del paragrafo sulla storia urbanistica di Campi Bisenzio, per una più completa comprensione dell’evoluzione pianificatoria, è necessario fare riferimento alle vicende giudiziarie che in anni recenti hanno coinvolto l’amministrazione comunale. Non si deve dimenticare, infatti, che il Regolamento Urbanistico vigente è frutto di una profonda revisione, operata nel 2007 attraverso la terza Variante: un intervento della Magistratura espresse allora dubbi sulla regolarità dell’atto di governo del territorio, considerato non conforme al Piano Strutturale; il Comune decise di richiedere un parere pro veritate all’Avvocato Alberto Bianchi e all’Architetto Riccardo Bartoloni sulla sopraccitata conformità tra RU e PS; parere che evidenziò incongruenze tali da procedere al riallineamento dei due strumenti, compito affidato allo stesso Arch. Riccardo Bartoloni. Per maggiore chiarezza sulle vicende è utile consultare i documenti relativi alla terza Variante, ed in particolare la relazione generale, completa di Valutazione Integrata, in cui si esplicitano le criticità del Regolamento Urbanistico del 2004. L’analisi condotta nella relazione dell’Arch. Bartoloni riporta, innanzitutto, i dati relativi al dimensionamento del Piano Strutturale: per l’anno 2010 è infatti previsto il raggiungimento di 45.000 abitanti, con il conseguente incremento di volumetria residenziale fino a 456.000 m³; inoltre il PS stabilisce l’aumento di 102 ettari per aree ad uso produttivo e di 15.200 m² per superfici destinate ad attività commerciali. All’elaborato 2 si prevede anche che la soddisfazione del fabbisogno residenziale dovrà avvenire per il 15% con interventi di recupero, per il 20% con interventi di completamento e per il 65% con interventi di espansione. Il fatto che il Piano Strutturale abbia come scadenza temporale il 2010 è considerato come un fattore limitante: si sottolinea, infatti, come tale strumento di pianificazione debba avere invece una valenza a tempo indeterminato. La Variante, a partire dall’obiettivo, contenuto nell’elaborato 1 del PS, di “confermare il trend di crescita degli ultimi anni”, cerca pertanto di ricostruire analiticamente, e quindi numericamente, tale trend di crescita, proiettandolo nel tempo per ottenere dei limiti demografici - e quindi volumetrici – per anni successivi al 2010, ricavando il risultato di 50.000 abitanti previsti al 2020. La relazione evidenzia poi quali siano le principali criticità del Regolamento Urbanistico. La problematica riconosciuta come quella più evidente consiste in una cattiva distribuzione temporale dello sviluppo: le previsioni complessive appaiono compatibili con i limiti determinati per il 2020, ma eccedono nettamente quelli prescritti per il 2010 dallo Statuto dei Luoghi; infatti la relazione alla Variante spiega come il RU di Campi Bisenzio venga sostanzialmente a configurarsi, almeno per gli interventi privati, come un atto a tempo indeterminato per la sua rinuncia al Piano Attuativo e alla sua decadenza quinquennale (art. 28 della legge regionale 5/1995), affermando che la diversa natura del Piano di Massima Unitario (di cui il presente lavoro ha fatto accenno alla fine della trattazione sull’evoluzione normativa riguardante le zone D) lo sottragga a tale decadenza. Il problema sussiste soprattutto nel dimensionamento ad uso residenziale: solo nelle aree di completamento risultano infatti edificabili circa 480.000 m³, pari a 4.800 abitanti, e nelle aree di espansione invece 336.600 m³ (3.366 abitanti), per
53
un totale che supera di 3.666 unità il limite di 4.500 abitanti previsto dal PS per il 2010; si nota come, tuttavia, il dato sarebbe invece coerente con la previsione per il 2020. La relazione evidenzia altresì come il RU permetta espansioni sostanzialmente monofunzionali (art. 37 delle NTA), mentre nel PS (art. 25) si dispone che l’indice massimo ammesso debba essere ripartito tra più destinazioni; inoltre il RU ignora l’indicazione del PS di ripartire lo sviluppo residenziale attraverso il 15% di interventi di recupero, il 20% di interventi di completamento e il 65% di interventi di espansione. Infine, si segnala l’esuberante estensione delle zone omogenee B, che comprendono anche aree solo parzialmente urbanizzate. Le soluzioni scelte dalla Variante per conformare il Regolamento Urbanistico, riallineandolo al Piano Strutturale, sono volte all’eliminazione delle problematiche appena descritte. Prima di tutto, viene definita, come strumento applicativo del RU, una particolare forma di avviso pubblico (secondo l’art. 13 del Regolamento Regionale 3R/2007) che, nella peculiare situazione campigiana, assume la forma di un vero e proprio bando pubblico che possa temporizzare e contingentare i diritti edificatori in funzione della sostenibilità dei progetti e dei benefici pubblici che ne possono conseguire; in sostanza gli interventi ad uso residenziale suscettibili di incidere significativamente sul territorio e quelli ad uso commerciale che prevedono superfici eccedenti i limiti dell’esercizio di vicinato (prescritti dal PS per ogni UTOE) sono sottoposti ad una procedura competitiva e comparativa e quindi ad una valutazione delle proposte (da parte di una commissione la cui composizione e il cui funzionamento sono disciplinati dal RU stesso) attraverso pubblici bandi, di cui si contempla una scansione temporale che prevede una prima procedura bandita nel 2008 (tale da rientrare nei limiti prescritti dal PS per il 2010) e una seconda nel 2013 (anno in cui interverrà la decadenza quinquennale di cui all’art. 55, comma 6, della legge regionale 1/2005). In secondo luogo, la Variante rende obbligatorio il carattere multifunzionale di alcune aree di espansione, e concretizza in termini operativi l’indicazione strategica del Piano Strutturale di dare risposta al fabbisogno residenziale per il 15% con interventi di recupero, per il 20% con interventi di completamento e per il 65% con interventi di espansione; inoltre, reintroduce lo strumento del Piano Attuativo, considerando come tale anche il PMU. Infine, la Variante ha operato una generale revisione della normativa riguardante le zone B, differenziandole, come già osservato, in B, Bc, Br e assegnando ad esse diversi indici e parametri urbanistici: il RU originario prevedeva (art. 35 delle NTA) un’unica zona territoriale B, così disciplinata: altezza massima: 13,5 m indice di fabbricabilità fondiaria: 2,25 m³/m² (nelle aree non
interessate da preesistenti volumi edilizi tale indice fondiario è da intendersi per 2,00 m³/m² a destinazione residenziale e per 0,25 m³/m² a destinazione non residenziale)
rapporto di copertura: 0,50
54
Immagine 1.16: Tavola dell’uso della struttura fisica del territorio del Regolamento Urbanistico originario (legenda nella pagina seguente) (unione delle tavole E/a ed E/b del RU originario; scala originale: 1:5.000)
56
1.3 La necessità del monitoraggio a Campi Bisenzio L’analisi della storia economica, sociale e urbanistica del Comune di Campi Bisenzio permette di condurre una breve riflessione sulle necessità e sull’utilità del monitoraggio urbanistico per le trasformazioni fisiche del territorio. Dalla trattazione, infatti, emerge la complessità della situazione del Comune in questione, che si trova al centro di una dinamica quanto problematica area metropolitana, stretto tra due delle tre più importanti città della Piana (Firenze e Prato), zona di localizzazione di importanti attività produttive, interessata da una crescente evoluzione demografica, con conseguente massiccia espansione edilizia e aumento dei prezzi di mercato; l’accenno alla storia giudiziaria consente inoltre di comprendere, in primo luogo, quanto la tematica urbanistica sia di stringente attualità, e in secondo luogo, quanto gli esiti delle scelte dei piani siano determinanti per un corretto sviluppo della città e del territorio, e quindi, di quanto sia indispensabile condurre un’adeguata analisi di monitoraggio in grado di operare continue verifiche e controlli, che consentano di ottenere una maggiore consapevolezza per le decisioni che produrranno le future trasformazioni territoriali.
57
2. IL MONITORAGGIO: CHE COS’È E A CHE COSA SERVE
2.1 Evoluzione normativa Il quadro normativo di riferimento per la strumentazione urbanistica vigente del Comune di Campi Bisenzio è costituito principalmente dalle due leggi regionali toscane del 16 gennaio 1995, n. 5, e del 3 gennaio 2005, n. 1, entrambe titolate “Norme per il governo del territorio”. Sia il Piano Strutturale che il Regolamento Urbanistico sono infatti stati redatti secondo le disposizioni della l.r. 5/95; in seguito, la terza Variante al RU, finalizzata al suo riallineamento con il PS, ha, per quanto possibile (cioè coerentemente con la struttura del PS), adeguato l’atto di governo del territorio alle innovazioni normative della l.r. 1/05. La Toscana, con la l.r. 5/95, è stata la prima Regione italiana a rinnovare la legislazione in materia urbanistica a partire dalla metà degli anni Novanta. Infatti, di fronte alla stagnazione della normativa nazionale, che dalla fine degli anni Sessanta prospetta una riforma urbanistica mai concretizzata, sono state le leggi regionali che hanno introdotto nuovi concetti e procedure. La l.r. 5/95 infatti contiene importanti elementi di novità. Innanzitutto, il Piano Regolatore Generale è scomposto in: - Piano Strutturale, di natura strutturale e strategica (il PS, cioè, connatura il territorio come “struttura” e contiene l’apparato della previsione, l’idea di progetto) - Regolamento Urbanistico, di natura operativa (il RU contiene il sistema delle norme, conforma e trasforma il suolo) - Programma Integrato di Intervento (è uno strumento facoltativo con il quale l'Amministrazione Comunale individua le trasformazioni del territorio da attuare per il periodo corrispondente al proprio mandato amministrativo). Inoltre, una delle idee-chiave della l.r. 5/95 consiste in un mutamento amministrativo nel gestire la cosa pubblica: infatti, la legge prevede che gli Enti locali possano autoapprovarsi gli strumenti urbanistici, superando il modello gerarchico a favore di quello cooperativo; tale modello implica che le decisioni debbano essere inserite in argomentazioni esplicite, dimostrabili e trasparenti; in questo senso ha un ruolo fondamentale il Quadro Conoscitivo, che comprende un’organica rappresentazione del territorio e dei suoi processi evolutivi, e costituisce lo scenario di riferimento iniziale per la definizione degli obiettivi del piano. La l.r. 5/95 introduce anche il concetto di “invariante strutturale”, di cui non è data una precisa definizione, lasciando al pianificatore l’interpretazione quando si afferma (art. 5, comma 6) che le invarianti strutturali del territorio sono “da sottoporre a tutela, al fine di garantire lo sviluppo sostenibile”. Fondamentalmente esse sono una scelta sostantiva di piano. Anche il sopraccitato concetto di sviluppo sostenibile, oggi generalmente condiviso, è un elemento di novità della l.r. 5/95. La l.r. 1/05 si pone in continuità con quella del 1995, confermando e sviluppando alcuni dei suoi principi basilari, e includendone dei nuovi. Essa elimina definitivamente la nozione di Piano Regolatore Generale, definendo, a livello comunale: - il Piano Strutturale, come strumento della pianificazione territoriale - il Regolamento Urbanistico, come atto di governo del territorio.
58
Il significato di “invarianti strutturali” è più chiaramente descritto, all’art. 4, indicandole come “le risorse, i beni e le regole relative all'uso, […] nonché i livelli di qualità e le relative prestazioni minime, […] del territorio da sottoporre a tutela al fine di garantire lo sviluppo sostenibile”; inoltre, sempre nello stesso articolo, “si definisce prestazione derivante dalla risorsa essenziale il beneficio ricavabile dalla risorsa medesima, nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile”, calando quindi in una logica di mercato (nel senso positivo del termine) le regole non negoziabili del territorio. Inoltre, la legge prevede che gli strumenti della pianificazione territoriale contengano, oltre al Quadro Conoscitivo, lo Statuto del Territorio (dunque la parte statutaria del piano, che include le invarianti strutturali “quali elementi cardine dell’identità dei luoghi”38), e che questo sia distinto dalla parte strategica, che deve essere invece connessa con la programmazione economica nel medio periodo. La l.r. 1/05, inoltre, cerca di stabilire un diverso rapporto tra pubblico e privato, ispirato al principio della sussidiarietà, agevolando forme di contrattazione, e introducendo l’importante strumento della perequazione urbanistica, “finalizzata al perseguimento degli obiettivi individuati dagli strumenti della pianificazione territoriale ed alla equa distribuzione dei diritti edificatori per tutte le proprietà immobiliari ricomprese in ambiti oggetto di trasformazione urbanistica”39. Il principio della perequazione ha una valenza culturale molto elevata, perché concede una giustizia distributiva nei confronti dei proprietari dei suoli destinati ad usi urbani, e permette la formazione, senza spese o espropri, di un patrimonio pubblico di aree per la collettività. Un ulteriore elemento di novità della l.r. 1/05 è la Valutazione Integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana, a cui è dedicato tutto il Capo I del Titolo II. Il processo di Valutazione Integrata, in Italia, esiste solo nella normativa toscana e diventa un momento costitutivo della formazione del piano. Il Regolamento regionale 9 febbraio 2007, n. 4/R è di attuazione dell’art. 11, comma 5, della l.r. 1/05, in materia di Valutazione Integrata.
38 Art. 5, comma 2, della Legge Regionale 1/05.
Più in generale, sul passaggio da Statuto dei Luoghi a Statuto del Territorio rimandiamo a: Francesco Ventura, Statuto dei luoghi e pianificazione, Città Studi, Torino, 2000; Giuseppe Cinà (a cura d i), Descrizione fondativa e statuto dei luoghi, Alinea, Firenze, 2000; Alberto Magnaghi, Il progetto locale, Bollati Boringhieri, Torino, 2010 39 Art. 60 della Legge Regionale 1/05.
Per un approfondimento sullo strumento della perequazione urbanistica, rimandiamo a: Giuseppe De Luca, Marco Gamberini, Toscana. Norme per il governo del territorio, Il Sole-24 Ore Libri, Milano, 2006
59
2.2 Il monitoraggio nella legislazione Al monitoraggio è dedicato l’art. 13 della l.r. 1/05, che fa parte del Capo dedicato alla Valutazione Integrata, di cui si riporta il testo integrale: Art. 13 - Il monitoraggio degli effetti 1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio sono sottoposti, da parte dei soggetti istituzionali competenti di cui all’articolo 7, al monitoraggio degli effetti di cui all’articolo 11, comma 140. 2. Gli atti, di cui al comma 1, individuano, nei casi previsti dalla presente legge, le principali modalità e gli indicatori idonei al monitoraggio medesimo, nel rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento regionale di cui all’articolo 11, comma 541. 3. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull'attività di monitoraggio degli effetti di cui al comma 1. A tal fine, a partire dal secondo anno di entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 11, comma 5, e con cadenza biennale, entro il primo semestre di ogni biennio, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che evidenzi le azioni di monitoraggio compiute sugli strumenti della pianificazione territoriale e sugli atti di governo del territorio e sui risultati conseguiti in termini di controllo e garanzia della sostenibilità ambientale delle attività pubbliche e private che incidano sul territorio medesimo. Per quanto riguarda il Regolamento Urbanistico in particolare, all’art. 55, comma 7, della stessa legge, si legge: “alla scadenza di ogni quinquennio dall'approvazione del regolamento urbanistico, il comune redige una relazione sul monitoraggio degli effetti di cui all’articolo 13”. Nel Regolamento regionale 9 febbraio 2007, n. 4/R il monitoraggio degli effetti è trattato all’art. 4, relativo alla descrizione generale del processo di Valutazione Integrata, e all’art. 10, inerente la relazione di sintesi. In modo indiretto è citato anche all’art. 5, in merito alla valutazione iniziale, poiché questa dovrebbe essere il momento in cui viene definito il programma della valutazione comprensivo dei fondi eventualmente disponibili, ivi compresi quelli per il monitoraggio e per la diffusione dei suoi risultati. L’art. 4 definisce il monitoraggio degli effetti come parte integrante del processo di valutazione, e ne prevede l’attuazione “attraverso l’utilizzo di indicatori predeterminati”.
40 Comma 1 dell’art. 11:
I comuni, le province e la Regione, per quanto di rispettiva competenza, provvedono alla previa effettuazione di una valutazione integrata degli effetti territo riali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana ai fini dell’adozione ed approvazione dei seguenti strumenti ed atti: a) piano di indirizzo territoriale; b) piano territoriale di coordinamento; c) piano strutturale; d) regolamento urbanistico; e) piano complesso di intervento; f) atti di cui all’articolo 10, comma 2, qualora incidano sull’assetto definito dagli strumenti della pianificazione territoriale in vigore, determinando modifiche o variazioni di essi; g) le varianti agli strumenti ed att i di cui al presente comma, ove queste costituiscano quadro di riferimento di progetti ed altre attività, sia in relazione all’ubicazione che alla natura, alle dimensioni e alle condizioni operative di esse, sia con riferimento alla ripartizione di risorse. 41 Il comma 5 dell’art. 11 stabilisce l’emanazione, entro 365 giorni dall’entrata in vigore della l.r. 1/05,
di un regolamento di attuazione che discipl ini le modalità pe r l’effettuazione della Valutazione Integrata, compresi gli indicatori per il monitoraggio degli effetti; tale disposizione si è concretizzata con l’emanazione del Regolamento regionale 4/R del 2007.
60
Nell’art. 10 viene stabilito che il sistema di monitoraggio, “finalizzato alla gestione dello strumento della pianificazione territoriale o dell’atto di governo del territorio e alla valutazione del processo di attuazione e di realizzazione delle azioni programmate”, sia definito all’interno del documento della relazione di sintesi.
61
2.3 Tecniche utilizzate Il modo migliore per approfondire le metodologie con cui le Pubbliche Amministrazioni concretamente realizzino il monitoraggio è sicuramente quello di analizzare alcune relazioni di monitoraggio già redatte dai Comuni. A questo scopo sono stati esaminati dei documenti facilmente accessibili su Internet (poiché consultabili sui siti dei Comuni di riferimento), ed, in particolare:
- La relazione di monitoraggio del Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli (FI), redatta da un gruppo di lavoro coordinato dall’Arch. Mario Lopomo, che peraltro è stata il documento di partenza da cui è scaturita l’idea per il presente lavoro42
- La relazione di monitoraggio del Regolamento Urbanistico del Comune di Buti (PI), redatta da un gruppo di lavoro con l’Arch. Giuseppina di Loreto come Responsabile del Procedimento43
- La relazione di monitoraggio del Regolamento Urbanistico del Comune di Lucca, coordinata dall’Arch. Maurizio Tani44
Inoltre, è stato analizzato il Rapporto sullo stato di avanzamento del RU del Comune di Borgo a Mozzano (LU), redatto dal Geom. Alessandro Brunini45. Nella tabella che segue si sintetizzano le metodologie riscontrate nelle varie relazioni analizzate per le principali tematiche prese in considerazione dal monitoraggio.
42 Titolata “Le trasformazioni del territorio empolese dal Piano Strutturale al primo Regolamento
Urbanistico”, è la relazione di monitoraggio degli effetti alla scadenza del quinquennio dall ’approvazione del RU, risalente al 2005. E’ consultabile all’indirizzo internet: www.comune.empoli.fi.it/newsletter/2011/monitoraggioRU.htm 43 Titolata “Relazione di monitoraggio sullo stato d i attuazione del Regolamento Urbanistico e Avvio del
Procedimento per la redazione della revisione quinquennale del Regolamento Urbanistico”, è redatta in previsione della scadenza quinquennale del RU, approvato nel 2007. E’ consultabile all’indirizzo internet: www.comune.buti.pi.it/files/relazione_di_monitoraggio_RU_completa_784_2827.pdf 44 La relazione, titolata “Direttive e linee giuda – verso una nuova stagione di piani per i l governo della
città e del suo territorio”, è abbastanza complessa, redatta per (come si legge in copertina) la “formazione degli strumenti di monitoraggio e Valutazione Integrata (ambientale e strategica) finalizzati alla redazione della Variante generale al Regolamento Urbanistico e al Piano Strutturale”; il RU di Lucca è stato approvato nel 2004. La relazione si trova facilmente su internet, d igitando, su un qualsiasi motore di ricerca, le parole “direttive e linee guida comune di Lucca” 45 Il documento è un Rapporto annuale di monitoraggio per il RU, approvato nel 2008, e pertanto consta
di sole quattro pagine. E’ consultabile all’ indirizzo internet: www.comune.borgoamozzano.lu.it/upload/file/documenti assetto del territorio/monitoraggio carichi R.U/Allegato alla delibera monitoraggio Rapporto.pdf
62
Empoli Buti Lucca
Verif ica delle trasformazioni a carattere insediativo
Analisi delle pratiche edilizie, attraverso l’organizzazione dei dati in un database; distinzione tra “realizzazioni” e “non realizzazioni”
Tabella di confronto tra interventi previsti e interventi realizzati
Analisi delle pratiche edilizie, attraverso l’organizzazione dei dati in database; individuazione cartografica (sulle tavole del RU) delle tras formazioni urbanistiche attuate
Verif ica dello stato di attuazione degli standard urbanistici
Analisi dello stato di fatto, ottenuto inc rociando le cartografie, contenenti le previsioni, con le ortofoto del 2009 e del 2010
Non viene fatto riferimento agli standard urbanistic i, quanto alle opere di urbanizzazione, di cui quelle realizzate vengono sintetizzate in tabella e individuate su cartografia
Tabella di sintes i e individuazione cartografica (sulle tavole del RU) degli standard urbanistic i realizzati
Analisi dello stato dell’ambiente
Analisi attraverso indicatori ambientali e, per il paesaggio, comparazione di foto aeree del 1998 e del 2009
Nella relazione di monitoraggio non viene fatto riferimento allo stato dell’ambiente
Resoconto del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente di Lucca, che utilizza tabelle e grafic i di sintesi costruiti con l’aiuto di indicatori ambientali, ma che è redatto nel 2006 e non alla data del monitoraggio (2009)
Analisi del quadro socio-economico
Analisi della dinamica demografica recente (con l’aiuto di grafic i e tabelle) e del mercato immobiliare, confrontando i dati di Empoli con quelli di Firenze e di Castelfiorentino
Breve descrizione dell’andamento demografico dall’approvazione del RU , attraverso una sintesi tabellare; elenco delle attività produttive insediate sul territorio comunale
Analisi della dinamica demografica dal 1956 e della domanda sociale di abitazione, con l’aiuto di grafic i e tabelle; ulteriori informazioni sono contenute nel Rapporto sullo Stato dell’Ambiente di Lucca, redatto nel 2006 e s intetizzato nella relazione
Analisi del processo partecipativo
Resoconto delle scelte e delle iniziative promosse dall’Amministrazione
Non è monitorato lo stato di fatto, ma vengono indicate alcune propos te per i processi partecipativi futuri
Dopo un piccolo accenno (discorsivo) alla partecipazione, contenuto nella sintesi del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente di Lucca, si elencano alcune metodologie utili al processo partecipativo sperimentate da altre Amminis trazioni, non monitorando lo s tato di fatto
63
A proposito del Rapporto sullo stato di avanzamento del RU del Comune di Borgo a Mozzano (per quanto non si possa attuare un confronto organico tra questo e le altre tre relazioni, per la differente struttura e funzione dei documenti, nonché per il diverso arco temporale preso in considerazione) si sottolinea che il resoconto consta di un’analisi – discorsiva – sullo stato di attuazione delle opere di urbanizzazione e degli interventi pubblici e privati, e di un aggiornamento della situazione delle abitazioni in relazione al dimensionamento del Piano Strutturale, attraverso l’esame delle D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività) presentate e dei Permessi di costruire rilasciati.
Immagine 2.1: Esempio di elaborazione cartografica tratto dalla relazione di monitoraggio del Comune di Empoli
64
Immagine 2.2: Esempio di elaborazione cartografica tratto dalla relazione di monitoraggio del Comune di Lucca
65
2.4 Problematiche riscontrate Dall’analisi effettuata emerge chiaramente la natura variegata delle tecniche utilizzate, nelle varie realtà amministrative, in risposta alle disposizioni dell’art. 13, secondo comma, della l.r. 1/200546. Forse proprio questa prima constatazione può essere considerata indice di una problematica che nasce a monte di qualsiasi processo di monitoraggio: la vaghezza della disposizione normativa in merito alla sua concreta realizzazione. D’altro canto, ciò consente anche una certa libertà, che si può tradurre, in contesti di Pubbliche Amministrazioni virtuose, in sperimentazioni innovative o nella definizione di tecniche particolarmente efficaci. Nelle relazioni prese in esame, sintetizzando, si riscontrano queste tipologie di tecniche di monitoraggio:
- Analisi e confronto dei dati attraverso database e/o sintesi tabellari e/o grafiche
- Elaborazioni cartografiche, più o meno complesse: mere localizzazioni; perimetrazione degli interventi realizzati sulle cartografie contenenti le previsioni; confronto tra le cartografie e le foto aeree
E’ intuitivo che, quanto più il dato monitorato è localizzabile, quantificabile e visualizzabile sul territorio, tanto più l’analisi e il controllo risultano produttivi. C ’è da dire che la problematica maggiore, a tal proposito, non è solo quella di riuscire ad individuare una particolare tecnica di monitoraggio, ma di applicarla al più ampio spettro di tematiche possibili. Le relazioni analizzate, prese nel loro complesso, offrono una gamma di elaborazione di dati abbastanza composita (in particolare, è specialmente utile la tecnica di confronto tra cartografie e foto aeree a distanze temporali), ma non la sfruttano appieno per tutte le tematiche prese in considerazione. Inoltre, è necessario sottolineare che alcuni argomenti affrontati in una relazione non sono trattati nelle altre, e viceversa. Concludendo, una maggiore integrazione tra tecniche già sperimentate (la quale potrebbe produrre, ad esempio, elaborazioni cartografiche che, nella loro forma digitale, siano costruite sulla base di archivi di dati sempre aggiornabili, e, nello stesso tempo, database che possano avere un continuo riscontro visualizzabile su cartografie) e un approfondimento capillare di ogni tematica che possa influire sulle trasformazioni territoriali, attraverso una più significativa concertazione tra soggetti istituzionali, sono l’obiettivo verso cui tendere per attuare una buona azione di monitoraggio, in modo da realizzare strategie il più possibile condivise e partecipate, che non siano circoscritte solo all’interno di un confine amministrativo.
46 L’articolo prevede, infatti, che siano gli strumenti di pianificazione territoriale e g li atti di governo del
territorio a individuare le principali modalità e gli indicatori idonei al monitoraggio.
66
2.5 Il monitoraggio a Campi Bisenzio Come precedentemente affermato, il Comune di Campi Bisenzio ha redatto la strumentazione urbanistica vigente sulla base della l.r. 5/95; con l’avvento del nuovo quadro di riferimento normativo, è stato necessario un adeguamento alle disposizioni della l.r. 1/05. Infatti, è con la terza Variante al RU (approvata nel 2008 e, come noto, finalizzata al riallineamento del Regolamento Urbanistico con il Piano Strutturale) che viene introdotto il concetto di monitoraggio degli effetti di cui all’art. 13 della sopraccitata legge. Premettendo che la Variante stessa può essere considerata a buon diritto una relazione di monitoraggio (essa, infatti, verifica e controlla le trasformazioni territoriali conseguenti alle disposizioni del RU, evidenziandone problematiche e criticità, e proponendo azioni correttive), è all’interno del rapporto di Valutazione Integrata, contenuto nella Relazione generale, che si definiscono le modalità idonee alla concretizzazione dell’attività di monitoraggio. Infatti, al paragrafo 9.2, si legge: “Il monitoraggio degli effetti, di cui all’art. 13 della L.R. 1/2005, è stato conseguito attraverso l’utilizzo di indicatori predeterminati (come previsto dall’art. 4, comma 4, lettera “b”, del Regolamento 4/R) e più esattamente confermando quelli già previsti dal Piano Strutturale e dal Regolamento Urbanistico vigenti nel contesto dello strumento strategico del Bilancio Ambientale Locale (vedi Allegato A allo Statuto dei Luoghi del Piano Strutturale ed Elaborato “F” del Regolamento Urbanistico)”. In effetti, già il PS ed il RU originario contemplavano l’utilizzo dello strumento del BAL (Bilancio Ambientale Locale, appunto), che “fornisce un quadro per la gestione delle risorse ambientali, analogo a quelli utili per la gestione delle risorse finanziarie”47. L’unità di riferimento per l’applicazione del BAL è l’UTOE (Unità Territoriale Omogenea Elementare); per ognuna di queste (il Comune di Campi Bisenzio è suddiviso in otto UTOE) sono stati studiati sei sistemi ambientali (biodiversità, acqua, aria, energia, rifiuti, sensorialità) attraverso indicatori di “stato”, “pressione” e “sostenibilità”, definiti in base all’art. 32 della l.r. 5/9548.
47 Allegato A allo Statuto dei Luoghi
48 Art. 32 della Legge Regionale 5/95:
(Valutazione degli effetti ambientali) 1. Gli atti di pianificazione territoriale del comune, di cui al presente capo, contengono, anche sulla base del quadro conoscitivo del p.t.c., d i cui all'a rt. 16, quarto comma, la valutazione degli effetti ambientali attraverso: a) la individuazione delle aree e dei beni di rilevanza ambientale; b) l'analisi dello stato delle risorse soggette a modificazione; c) l'indicazione delle finalità degli interventi previsti e dei motivi delle scelte rispetto ad altre alternative; d) la descrizione delle azioni previste e dei loro prevedibili impatti sull'ambiente; e) la individuazione dei livelli di criticità delle aree e delle risorse interessate; f) l'indicazione delle misure idonee ad evitare, ridurre o compensare gli effetti negativi sull'ambiente, individuando la disponibilità delle risorse economiche da impiegare; g) l'accertamento del rispetto delle norme igienico-sanitarie. 2. Le analisi di cui al primo comma, lettere a), b), c), d), e) si avvalgono del sistema informativo di cui all'art. 4 e lo implementano. L'accertamento di cui al primo comma, lettera g), è effettuato, limitatamente alle previsioni di insediamenti industrial i e di attività produttive in genere, avvalendosi del parere preventivo delle strutture competenti per i controlli ambientali. 3. Le valutazioni degli effetti ambientali riguardano in particolare i seguenti fattori e le loro interrelazioni: il suolo, l'acqua, l'aria, le condizioni microclimatiche, il patrimonio culturale, la fauna e la flora, gli insediamenti, i fattori socio-economici, 4. La legge regionale e le istruzioni tecniche di cui al l'art. 13 stabiliscono norme specifiche per garantire l'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
67
Per ogni sistema ambientale, in forma tabellare, è indicato un “grado di giudizio” relativo ad ogni indicatore, per il quale è utilizzata la seguente scala di valutazione49: B/B = Basso/Basso, valore minimo, massimo grado di scadenza. B/M = Basso/Medio, valore basso con elementi di sufficienza. M/M = Medio/Medio, valore sufficiente. M/A = Medio/Alto, valore sufficiente con elementi di eccellenza. A/A = Alto/Alto, valore buono. A/N = Alto/Notevole, valore buono con elementi notevoli N/N = Notevole/Notevole, valore massimo, notevole. Attraverso i risultati ottenuti, le zone possono essere classificate in aree stabili, trasformabili e sensibili, con il criterio esplicato nella seguente tabella, che contiene lo schema per individuare la condizione di uno specifico sistema ambientale all’interno di una UTOE:
Immagine 2.3: Tabella 3 dell’Allegato A allo Statuto dei Luoghi
Nella relazione alla terza Variante si sottolinea come il BAL, “Seppur pensato ed attuato ben prima delle disposizioni della L.R.1/2005 e dei suoi regolamenti attuativi […] anticipa buona parte delle finalità della odierna valutazione integrata e, sicuramente, è in grado di assolvere tuttora a tale compito, consentendo sia di contribuire ad una valutazione continua delle trasformazioni del territorio che al monitoraggio dei conseguenti effetti”50 e si afferma che “la variante conferma il Bilancio Ambientale Locale, nella forma già normata, come lo strumento per il controllo qualitativo delle trasformazioni ammesse dal Regolamento Urbanistico e per la valutazione degli effetti che ne derivano sul piano ambientale, territoriale, economico, sociale e sulla salute umana”51. Riconosciuto il carattere innovativo del BAL, c’è da sottolineare che tale strumento è nato tuttavia in assenza di legislazione relativa a valutazione integrata e conseguente monitoraggio, e che, quindi, presenta dei limiti
5. L'adeguatezza delle indagini previste dall'art. 1 della legge regionale 17 aprile 1984, n. 21, anche in riferimento alle direttive tecniche regionali, è certificata in solido dal tecnico abilitato che le ha effettuate e dal tecnico progettista dello strumento urbanistico. 6. Gli elaborati relativi alle indagini di cui al quinto comma sono depositati prima dell'adozione dello strumento urbanistico presso il competente ufficio del genio civile, il quale provvede, prima dell'approvazione dello strumento stesso, ad esprimere al comune in proprio pare re sull'adeguatezza delle indagini e a dettare ove occorra le necessarie prescrizioni. 49 Allegato A allo Statuto dei Luoghi
50 Paragrafo 9.2 della relazione alla Variante
51 Paragrafo 9.4 della relazione alla Variante
68
nell’adeguamento alla vigente normativa, in primis quello derivante dall’essere circoscritto allo studio dei sistemi ambientali. A tal proposito, nell’ultimo paragrafo della relazione alla Variante, il 9.6, interamente dedicato al monitoraggio degli effetti, dopo la conferma dell’idoneità, a tal fine, dello strumento del BAL, si afferma che “Il sistema di monitoraggio è esteso anche agli interventi di recupero ed ai permessi di costruire rilasciati nelle zone di completamento, al fine di controllare le consistenze complessive dei medesimi. Ciò consentirà di monitorare anche l’andamento della risposta al fabbisogno minuto, evitando che mutamenti nel trend della domanda di edificazione minore, oggi non prevedibili, portino a volumetrie non compatibili con i limiti previsti dalla variante in coerenza con gli indirizzi del Piano Strutturale”.
Immagine 2.4: Suddivisione del territorio comunale in UTOE (fonte: www.comune.campi-
bisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2277)
69
Immagine 2.5: Esempio di scheda di valutazione del BAL del RU vigente (fonte: www.comune.campi-bisenzio.fi.it/flex/sit/utoe1.pdf)
71
3. UNA PROPOSTA
3.1 La tecnica utilizzata Con il presente capitolo si avvia la fase maggiormente operativa e sperimentale del lavoro, che ha lo scopo di proporre ed attuare un sistema di monitoraggio applicato alla strumentazione urbanistica del Comune di Campi Bisenzio. A tal fine, è sembrato particolarmente produttivo (anche dopo l’analisi delle tecniche di monitoraggio condotte da altre amministrazioni comunali, esaminate nel secondo capitolo), un metodo che cercasse un continuo confronto tra le previsioni verbo-disegnate del piano e le fotografie aeree, immediata testimonianza delle trasformazioni territoriali realmente avvenute. La tecnica vuole essere, appunto, una proposta, uno studio testato attraverso il controllo e la verifica stessa degli strumenti urbanistici, in alcune aree campione. Per la scelta di queste, era necessario trovare una metodologia che permettesse una selezione casuale e impersonale. Con questo scopo, la tavola di progetto del Piano Strutturale (scala originale 1:10.000) è stata suddivisa attraverso una griglia rettangolare costituita da celle quadrate di 500 m di lato; per coprire l’intero territorio comunale è occorsa una ripartizione in 18 x 17 celle; il criterio di scelta è stato poi il seguente: spostarsi di 5 caselle in 5 caselle, dall’alto verso il basso e da destra verso sinistra, scartando quelle celle che si venivano a trovare fuori o a cavallo del confine comunale; in tal modo sono state ottenute 20 aree di 500 x 500 m, che rappresentano una porzione ragionevole del territorio, e che contengono situazioni sufficientemente variegate. L’analisi condotta, come già accennato, vuole integrare l’osservazione dell’evoluzione delle previsioni di piano nel tempo, e il controllo dello stato di trasformazione mediante un’indagine diacronica delle foto aeree. Per la particolare situazione del Regolamento Urbanistico campigiano, sostanzialmente modificato dalla terza Variante, e oggetto di altre successive numerose variazioni, è stato deciso di monitorare la sua evoluzione in tre momenti: quello del RU originario, nel 2005, quello della terza Variante, nel 2007, e infine quello del RU vigente, la data del cui aggiornamento varia da zona a zona, a seconda delle Varianti intervenute. Per quanto riguarda le foto aeree, si è deciso di analizzare le immagini storiche del 2003 e del 2007 (reperibili in rete attraverso lo strumento di Google Earth), rispettivamente anno di adozione del PS e della terza Variante, e la situazione al 2011 (attraverso le mappe aggiornate reperibili, anch’esse su internet, mediante il motore di ricerca Bing), per avvicinarsi il più possibile allo stato attuale. Lo schema seguente riassume il lavoro condotto su ogni area:
72
Analisi dello stralcio della tavola di progetto del PS (elaborato 13.7 b)
Ricognizione dei sistemi funzionali presenti
Analisi dello stralcio della/e tavola/e 1:2.000 del RU del 2005 contenente/i l’area
(tavole di definizione dell’uso della struttura fisica del territorio)
Ricognizione delle previsioni di piano
Descrizione generale dell’area
Confronto tra le foto aeree del 2003 e del 2007 e le previsioni di piano
Analisi dello stralcio della/e tavola/e 1:2.000 della Variante al RU del 2007 contenente/i l’area
(tavole di definizione dell’uso della struttura fisica del territorio)
Ricognizione delle previsioni di piano
Analisi dello stralcio della/e tavola/e 1:2.000 del RU vigente contenente/i l’area
(tavole di definizione dell’uso della struttura fisica del territorio)
Ricognizione delle previsioni di piano
Confronto tra le foto aeree del 2007 e del 2011 e le previsioni di piano
73
3.2 Schede di monitoraggio Per ogni area, individuata attraverso la griglia, è realizzata una scheda costruita sulla base dello schema indicato nel paragrafo precedente.
Immagine 3.1: Le aree oggetto di studio individuate sulla Tavola di progetto
del PS (scala originale: 1:10.000)
74
Per una migliore comprensione degli stralci di piano nelle schede di monitoraggio, in questa e nelle pagine seguenti si riportano le legende del PS vigente, del RU del 2005 e del RU conseguente alla terza Variante.
Immagine 3.2: Legenda della Tavola di progetto del PS vigente (elaborato 13.7 b del PS)
75
Immagine 3.3: Legenda della Tavola dell’uso della struttura fisica del territorio del RU originario (tavole E/a ed E/b del RU originario)
76
Immagine 3.4: Legenda della Tavola dell’uso della struttura fisica del territorio del RU vigente (tavole E/a ed E/b del RU)
77
AREA_1 Descrizione generale dell’area: la zona, a destinazione prevalentemente produttiva, si trova in un’area a nord-oves t del C omune, a ridosso dell’Autostrada A11 e del fiume Bisenzio. Il tessuto urbano è quello tipico delle attività produttive, con grandi strutture monoplanari per la produzione indus triale, associato ad aree agricole adibite per lo più a seminativo, o ad aree verdi incolte
Analisi dello stralcio della tavola di progetto del PS: il PS individua, nell’area, i seguenti sottosis temi funzionali (tra parentesi gli articoli relativi delle NTA): - delle aree produttive (che occupa la maggiore superficie) (art. 27); l’art. 4 dello Statuto dei Luoghi considera, per l’area, “risorse essenziali” le attività produttive es istenti - delle aree edificate tras formabili (art. 25) - delle permanenze (art. 22) - degli ambiti strategici (art. 26), cioè di aree in cui si prevede una equilibrata commistione di funzioni, e in cui l’indice territoriale non dovrà superare 15.000 m³/ha e dovrà essere ripartito in modo da ottenere un ottimale tessuto urbano che possa provocare la riqualificazione degli insediamenti es istenti
- idrico: delle acque alte, basse, dei canali, dei pozzi, delle casse di espans ione e di laminazione (art. 29) - dei parchi (art. 30) - delle autostrade e dei relativi caselli (art. 16) - delle strade extraurbane principali di tipo “B” (art. 17)
78
Analisi dello stralcio della tavola 3 1:2.000 del RU del 2005: le principali previsioni di piano sono: - 3 Piani di Massima Unitari: il 4 .1 e il 4 .3 , con previsione di aree produttive D2 (aree produttive di nuova definizione) e parcheggi, e il 4 .2 , che corrisponde alla zona individuata dal PS come “ambito strategico”, con previs ione di un’area di espansione C (tessuto residenziale di nuova definizione) e di un’area di espansione D5 (aree produttive a prevalente destinazione direzionale e commerciale) - nuova viabilità in relazione alla bretella Las tra a Signa-P rato, il cui tracciato di progetto attraversa l’area in questione - corso idrico di progetto parallelo al torrente Vingone
Analisi dello stralcio della tavola 3 1:2.000 della Variante al RU
del 2007: la tavola 3 non ha subito modifiche (cartografiche) con la terza Variante (mentre la normativa è s tata modificata con le variazioni già illustrate nel paragrafo dedicato alla s toria urbanistica)
Analisi dello stralcio della tavola 3 1:2.000 del RU vigente: le modifiche riguardano: - la definizione della nuova viabilità collaterale al progetto definitivo della bretella autos tradale Lastra a Signa-P rato (sesta Variante al RU , 2009); in merito c ’è da sottolineare che il PS indica ancora la bretella come s trada extraurbana principale di tipo “B” e non come autostrada, non aggiornando l’ampiezza della fascia di rispetto, secondo le disposizioni del DM 1404/68 - la ridefinizione di aree edificabili finalizzata alla realizzazione di un complesso alberghiero in via dei Confini (proponente: soc ietà immobiliare Dienne s .r.l., area di circa 4 .900 m² des tinata dal vigente RU in parte a zona B in parte a verde privato vincolato, Piano Attuativo e Variante n. 11 approvati con Del. C .C . n. 80 del 22
Luglio 2010): infatti cambia la perimetrazione delle zone B
79
Confronto tra le foto aeree del 2003 e del 2007 e le previsioni di piano: il confronto fotografico non evidenzia nessuna sos tanziale tras formazione di suolo: i PMU 4 .1 , 4 .2 e 4 .3 non sono stati né adottati né approvati; la mancata realizzazione della bretella Lastra a Signa-P rato ha implicato la non esecuzione della viabilità collaterale; le previs ioni relative al sistema idrico non sono state realizzate Confronto tra le foto aeree del 2007 e del 2011 e le previsioni di piano: il confronto fotografico non evidenzia nessuna sos tanziale tras formazione di suolo: i PMU 4 .1 , 4 .2 e 4 .3 non sono stati né adottati né approvati, mentre la convenzione per il Piano Attuativo per la Dienne s .r.l. è stata s tipulata con Determinazione n. 60 del 12/09/11; la mancata realizzazione della bretella Lastra a Signa-Prato ha implicato la non esecuzione della viabilità collaterale; le previs ioni relative al sistema idrico non sono state realizzate
2003
2007
2011
2003
80
AREA_2 Descrizione generale dell’area: la zona, che si trova in un’area a nord-ovest del Comune, in località Confini, è caratterizzata dalla presenza di un nuc leo insediativo sviluppato lungo la strada s tatale 325 (mis to produttivo-residenziale), inserito tra il corso del fiume Bisenzio ed aree agricole adibite a seminativo
Analisi dello stralcio della tavola di progetto del PS: il PS individua, nell’area, i seguenti sottosistemi funzionali (tra parentesi gli articoli relativi delle NTA): - delle aree produttive (che occupa la maggiore superficie) (art. 27); l’art. 4 dello Statuto dei Luoghi considera, per l’area, “risorse essenziali” le attività produttive es istenti - delle aree edificate tras formabili (art. 25) - delle permanenze (art. 22); in particolare è da sottolineare la presenza dell’opificio di via dei Confini, opera dell’architetto Leonardo Ricci, considerata “risorsa essenziale” dallo Statuto dei Luoghi” (art. 4) - degli ambiti s trategici (art. 26) - idrico: delle acque alte, basse, dei canali, dei pozzi, delle casse di espansione e di laminazione (art.
29) - delle aree agricole (art. 32) - del verde urbano: pubblico attrezzato e privato (art. 33) - delle strade extraurbane principali di tipo “B” (art. 17) - della grande viabilità pedonale e c iclabile (art. 19)
81
Analisi dello stralcio delle tavole 3 e 7 1:2.000 del RU del 2005: le principali previsioni di piano sono: - 3 Piani di Massima Unitari: il 4 .3 e il 4 .6 , con previsione di aree produttive D2 (aree produttive di nuova definizione), verde pubblico, parcheggi e nuova viabilità secondaria, e il 4 .2 , che corrisponde alla zona individuata dal PS come “ambito strategico”, con previs ione di un’area di espansione C (tessuto residenziale di nuova definizione), di un’area di espansione D5 (aree produttive a prevalente des tinazione direzionale e commerc iale) e verde di rispetto - corso idrico di progetto parallelo al torrente Vingone - tracciato di progetto della bretella Las tra a Signa-Prato Analisi dello stralcio delle tavole 3 e 7 1:2.000 della Variante al RU del 2007: la Variante non apporta nessuna modifica cartografica alle previs ioni di piano del RU originario (mentre la normativa è modificata con le variazioni già illustrate nel paragrafo dedicato alla storia urbanistica) Analisi dello stralcio delle tavole 3 e 7 1:2.000 del RU vigente: - le modifiche riguardano la definizione della nuova viabilità collaterale al progetto definitivo della bretella autostradale Lastra a Signa-P rato (sesta Variante al RU , 2009); in merito c ’è da sottolineare che il PS indica ancora la bretella come s trada extraurbana principale di tipo “B” e non come autos trada, non aggiornando l’ampiezza della fascia di rispetto, secondo le disposizioni del DM 1404/68
82
Confronto fra le foto aeree del 2003 e del 2007 e le previsioni di piano: il confronto fotografico non evidenzia nessuna sostanziale tras formazione di suolo: i PMU 4 .2 , 4 .3 e 4 .6 non sono stati né adottati né approvati; la mancata realizzazione della bretella Las tra a Signa-P rato ha implicato la non esecuzione della viabilità collaterale; le previsioni relative al sistema idrico non sono state realizzate
Confronto fra le foto aeree del 2007 e del 2011 e le previsioni di piano: il confronto fotografico non evidenzia nessuna sos tanziale tras formazione di suolo: i PMU 4 .2 , 4 .3 e 4 .6 non sono stati né adottati né approvati; la mancata realizzazione della bretella Lastra a Signa-P rato ha implicato la non esecuzione della viabilità collaterale; le previs ioni relative al sistema idrico non sono state realizzate
2003
2007
2011
2011
83
AREA_3 Descrizione generale dell’area: la zona si trova in un’area posta a nord-est del territorio comunale; è caratterizzata dalla presenza di superfici adibite a seminativo intercluse tra zone di tipo produttivo, con tessuto urbano a grandi strutture monoplanari per la produzione industriale; l’area è attraversata dall’asse stradale di via Salvador Allende e dal corso del torrente Nuovo Garille; da sottolineare, inoltre, la presenza del complesso di Villa Permoli (a sud-est), costruita nel XVII secolo e adibita a orfanotrofio dello Spedale degli Innocenti, poi trasformata in villa signorile e infine abbandonata nel secondo dopoguerra, oggetto di un recente intervento di recupero, che l’ha trasformata in struttura ricettiva; a sud-est, tra via Allende e via Einstein, è presente l’area dell’ex canile comunale, chiuso nel 2008
Analisi dello stralcio della tavola di progetto del PS: il PS individua, nell’area, i seguenti sottosistemi funzionali (tra parentesi gli articoli relativi delle NTA): - delle aree produttive (che occupa la maggiore superficie) (art. 27: questo stabilisce, specificatamente per l’area produttiva tra il Garille Nuovo e via Allende, idonee zone di salvaguardia ambientale, e che le previsioni edificatorie siano subordinate alla definizione di opportuni accordi); gli insediamenti produttivi, per questa zona, sono considerati “risorse essenziali” dallo Statuto dei Luoghi (art. 2) - delle permanenze (art. 22) - idrico: delle acque alte, basse, dei canali, dei pozzi, delle casse di espansione e di laminazione (art. 29) - delle aree agricole (art. 32), che occupa anch’esso una parte consistente dell’area - delle strade extraurbane principali di
tipo “B” (art. 17) - delle strade extraurbane secondarie di tipo “C” (art. 18); la caratterizzazione di via Allende, quale viale principale di accesso alla città dalle infrastrutture territoriali nazionali, è, nello Statuto dei Luoghi, (art. 2) tra le invarianti strutturali - degli uffici e delle attrezzature pubbliche e private di uso pubblico di livello urbano (art. 40) - degli uffici e delle attrezzature pubbliche e private di uso pubblico di livello metropolitano (art. 41)
84
L’area è stata inoltre oggetto di tutte e due le Varianti che hanno modificato il Piano Strutturale: - la prima (2006), per un accordo di pianificazione (vedi art. 27 NTA) per il quale l’area posta tra via Allende e il Nuovo Garille è diventata produttiva anziché agricola - la seconda (2009), relativa al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2009-2011, per cui la zona dell’ex canile, da area per servizi (uffici e attrezzature pubbliche e private di uso pubblico di livello metropolitano) è s tata trasformata in area produttiva
Analisi dello stralcio delle tavole 5 e 9 1:2.000 del RU del 2005: il RU , per tale area, non presenta particolari previsioni progettuali; da notare è la presenza di Villa Permoli, come edificio ed areale inserito negli elenchi della l.r. 59/80, con tipo di intervento ammesso “a” (restauro con risanamento conservativo), e l’area del canile, nell’angolo a sud-oves t, definita come zona F (attrezzature metropolitane) Analisi dello stralcio delle tavole 5 e 9 1:2.000 della Variante al RU del 2007: nessuna delle due tavole è s tata modificata dalla Variante (le NTA sono s tate invece modificate con le variazioni illustrate nel paragrafo relativo alla storia urbanistica)
Analisi dello stralcio delle tavole 5 e 9 1:2.000 del RU vigente: - l’area dell’ex canile è definita come zona D5 (a prevalente destinazione terziaria di nuova definizione) - da notare il non aggiornamento del RU al PS per quanto riguarda l’area produttiva cos ì definita dalla prima Variante al PS (nel RU è ancora indicata come zona E , agricola), con Del C .C. 46/04; esiste infatti, per l’area, un Piano Attuativo del 2010 a destinazione produttiva, presentato dalla Inves tex S.p.A. di Prato assieme alla Valutazione Integrata per la sua realizzazione, che non ha portato ad una Variante al RU
Immagine 3.5: stralcio della Tavola di progetto del PS antecedente alle due Varianti
85
Confronto tra le foto aeree del 2003 e del 2007 e le previsioni di piano: - nel 2003 sono in corso i lavori per l’intervento di recupero a Villa Permoli, terminati nel 2007, con la realizzazione di nuovi edifici, anche se il RU del 2005 (art. 14 NTA) non ammette la realizzazione di nuovi volumi nelle pertinenze degli edifici classificati con tipo di intervento “a”, anche previa demolizione di manufatti esistenti (norma ribadita anche nel RU vigente, art. 104, comma 2 NTA)
Confronto tra le foto aeree del 2007 e del 2011 e le previsioni di piano: il confronto fotografico non evidenzia nessuna sostanziale modifica
2003
2007
2011
86
AREA_4 Descrizione generale dell’area: la zona, prevalentemente agricola, è s ituata a nord-ovest del territorio comunale, ed è attraversata dal torrente Vingone
Analisi dello stralcio della tavola di progetto del PS: il PS individua, nell’area, i seguenti
sottosistemi funzionali (tra parentesi gli articoli relativi delle NTA): - delle aree agricole (art. 32), che occupa la maggiore superficie - idrico: delle acque alte, basse, dei canali, dei pozzi, delle casse di espansione e di laminazione (art. 29), che comprende la cassa di espansione per il torrente Vingone; l’intero reticolo idraulico è considerato “risorsa essenziale” dallo Statuto dei Luoghi (art. 4) - dei parchi (art. 30) - delle permanenze (art. 22) - casello autostradale (art. 16), relativo alla bretella Lastra a Signa-Prato - delle linee ferroviarie-tranviarie e delle s tazioni metropolitane (art. 15) - delle strade extraurbane secondarie di tipo “C ” (art. 18) - della grande viabilità pedonale e ciclabile (art. 19)
87
Analisi dello stralcio della tavola 7 1:2.000 del RU del 2005: le principali previsioni di piano riguardano la mobilità: - nuova strada di tipo C , che si inserisce nello svincolo per la bretella Lastra a Signa-P rato (il cui tracciato di progetto lambisce l’area) e relativo verde di rispetto - tratto del tracciato nord-sud ferroviario di progetto, che nel PS (art. 15 NTA) è indicato come prosecuzione tranviaria del tracciato es t-ovest; è inoltre prevista una cassa di espansione lungo il torrente Vingone Analisi dello stralcio della tavola 7 1:2.000 della Variante al RU del 2007: La Variante non apporta modifiche alle previsioni di piano del RU originario (le NTA sono state invece modificate con le variazioni illustrate nel paragrafo relativo alla storia urbanis tica) Analisi dello stralcio della tavola 7 1:2.000 del RU vigente: - le modifiche riguardano la definizione della nuova viabilità collaterale al progetto definitivo della bretella autos tradale Lastra a Signa-P rato (sesta Variante al RU , 2009); in merito c ’è da sottolineare che il PS indica ancora la bretella come s trada extraurbana principale di tipo “B” e non come autostrada, non aggiornando l’ampiezza della fascia di rispetto, secondo le disposizioni del DM 1404/68 - è inoltre variato il perimetro della cassa di espans ione, estesa anche a nord della strada di progetto
88
Confronto fra le foto aeree del 2003 e del 2007 e le previsioni di piano: il confronto fotografico non evidenzia nessuna sostanziale trasformazione di suolo; la mancata realizzazione della bretella Lastra a Signa-Prato ha implicato la non esecuzione della viabilità collaterale; la ferrovia Osmannoro-Campi Bisenzio (inserita nel Piano Regionale della Mobilità e della Logistica come “intervento prioritario”) e le sue prosecuzioni non sono state realizzate
Confronto fra le foto aeree del 2007 e del 2011 e le previsioni di piano: il confronto fotografico non evidenzia nessuna sostanziale trasformazione di suolo; la mancata realizzazione della bretella Lastra a Signa-Prato ha implicato la non esecuzione della viabilità collaterale; la ferrovia Osmannoro-Campi Bisenzio (inserita nel Piano Regionale della Mobilità e della Logistica come “intervento prioritario”) e le sue prosecuzioni non sono state realizzate; con Variante n. 15 al RU (approvata con Del. C.C. 115/2011) si è imposto il vincolo espropriativo per la realizzazione della cassa di espansione sul fosso Vingone (inserita nel Programma triennale delle opere pubbliche 2010-2012 del Comune di Campi Bisenzio)
2003
2007
2011
89
AREA_5 Descrizione generale dell’area: la zona, situata a nord-es t del territorio comunale, è costituita da un’area prevalentemente produttiva, con grandi strutture monoplanari per la produzione indus triale, e attraversata dal Torrente Garille Nuovo; si nota anche (ad ovest) il corso del torrente Marina; è presente un’area verde, incolta, con una piccola area umida di circa un ettaro; in direzione nord-ovest/sud-est si snodano i tracciati dell’Autostrada A11 e di via E ins tein, mentre in direzione sud-ovest/nord-est si trova via Allende
Analisi dello stralcio della tavola di progetto del PS: il PS individua, nell’area, i seguenti
sottosistemi funzionali (tra parentesi gli articoli relativi delle NTA ): - delle aree produttive (che occupa la maggiore superficie) (art. 27: questo stabilisce, specificatamente per l’area produttiva tra il Garille Nuovo e via Allende, idonee zone di salvaguardia ambientale, e che le previsioni edificatorie s iano subordinate alla definizione di opportuni accordi); gli insediamenti produttivi, per questa zona, sono considerati “risorse essenziali” dallo Statuto dei Luoghi (art. 2) - idrico: delle acque alte, basse, dei canali, dei pozzi, delle casse di espansione e di laminazione (art. 29) - del verde urbano: pubblico attrezzato e privato (art. 33) - dei parchi (art. 30) - delle autostrade e dei relativi caselli (art. 16)
90
Analisi dello stralcio delle tavole 8 e 9 1:2.000 del RU del 2005: - la previsione di maggior rilievo è il Piano di Massima Unitario 2 .5 a destinazione produttiva (zona D2: aree produttive di nuova definizione) che comprende tutta l’area ad est del Garille Nuovo - la piccola area umida a sud della struttura industriale non è indicata nel RU
Analisi dello stralcio delle tavole 8 e 9 1:2.000 della Variante al RU del 2007: la Variante non apporta modifiche (cartografiche) alle previsioni di piano (le NTA sono state invece modificate con le variazioni illustrate nel paragrafo relativo alla storia urbanistica); l’unica modifica è l’assenza del perimetro dei centri e nuclei abitati: il RU 2005 infatti lo individua nella cartografia 1:2 .000 (art. 32 NTA), mentre la Variante is tituisce apposita cartografia 1:10.000 per il perimetro dei centri abitati (art. 40 NTA)
Analisi dello stralcio delle tavole 8 e 9 1:2.000 del RU vigente: per l’area in ques tione, le Varianti successive alla terza non hanno apportato modifiche
91
Confronto fra le foto aeree del 2003 e del 2007 e le previsioni di piano: - nel 2007, rispetto al 2003, è sorto un nuovo edificio industriale ad ovest di quello es istente - inoltre, sono iniziati i lavori per l’area produttiva del PMU 2 .5 , approvato con Del. C .C . 44/06: la convenzione è s tata s tipulata il 28/09/06 (quindi precedentemente alla terza Variante al RU); proponente: Società ATENE S.p.A ., il comparto edificatorio in oggetto interessa una superficie territoriale di 185.995 m²
Confronto fra le foto aeree del 2007 e del 2011 e le previsioni di piano: - nel 2011 si nota un forte avanzamento dei lavori per l’area del PMU 2 .5
2003
2007
2011
92
AREA_6 Descrizione generale dell’area: la zona, posta in posizione centro-settentrionale nel territorio comunale, comprende la frazione de La Villa e l’espansione meridionale della frazione di Capalle (a nord dell’area) lungo la strada s tatale 325 e piazza Togliatti; nella frazione de La Villa si riconosce il nucleo storico, che si sviluppa lungo il percorso matrice di via Colombina, e le espansioni più recenti, costituite in gran parte da edifici in linea; il tessuto urbano che si viene a c reare è di tipo discontinuo
Analisi dello stralcio della tavola di progetto del PS: il PS individua, nell’area, i seguenti sottosistemi funzionali (tra parentesi gli articoli relativi delle NTA): - delle aree edificate trasformabili (art. 25), che occupa la maggiore superficie - delle permanenze (art. 22) - delle aree produttive (art. 27) - degli ambiti s trategici (art. 26) - dei tessuti unitari e delle architetture recenti (art. 23) - idrico: delle acque alte, basse, dei canali, dei pozzi, delle casse di espansione e di laminazione (art. 29) - del verde urbano: pubblico attrezzato e privato (art. 33) - dei parchi (art. 30) - degli uffici e delle attrezzature pubbliche e private di uso pubblico di livello urbano (art. 40)
- delle strade extraurbane secondarie di tipo “C” (art. 18) - della grande viabilità pedonale e c iclabile (art. 19) - delle strade urbane generatrici della “forma città” (art. 20)
93
Analisi dello stralcio delle tavole 7 e 8 1:2.000 del RU del 2005: l’area è in gran parte definita attraverso zone B (aree residenziali da consolidare), Bp (edifici in aree PEEP vigente) e edifici ed areali inseriti negli elenchi della l.r. 59/80, che, in questo caso, costituiscono il nuc leo s torico della frazione de La Villa; le previsioni di rilievo sono: - nuova viabilità secondaria (che va a ricongiungersi con la Circonvallazione Ovest, di progetto, che ricade fuori dall’area) - aree per l’istruzione e per attrezzature di interesse comune (piazza Togliatti e zona a sud del nuc leo s torico) e parcheggi - da notare come alcune zone definite come B siano inedificate, contrastando la definizione delle zone B del DM 1444/68 (“parti del territorio totalmente o parzialmente edificate”, art. 2) Analisi dello stralcio delle tavole 7 e 8 1:2.000 della Variante al RU del 2007: la Variante conferma sostanzialmente le previsioni di piano, ma per l’area a sud del nuc leo s torico interessata dalle tras formazioni prevede Piano Attuativo, e, soprattutto, classifica come Bc (zone residenziali di completamento del tessuto insediativo) le aree inedificate classificate come B dal RU 2005 (questa variazione deriva dalla generale revisione della normativa riguardante le zone B, operata dalla terza Variante, descritta nel paragrafo relativo alla s toria urbanistica del Comune) Analisi dello stralcio delle tavole 7 e 8 1:2.000 del RU vigente: le previsioni di piano sono confermate; l’unica piccola modifica si riscontra nel tracciato della viabilità di progetto
94
Confronto fra le foto aeree del 2003 e del 2007 e le previsioni di piano: - demolizione e ricostruzione di nuovi edifici nella zona B più a nord - demolizione e inizio lavori nella zona B a nord di via Colombina - la nuova viabilità non è stata realizzata
Confronto fra le foto aeree del 2007 e del 2011 e le previsioni di piano: - nuovo edificio nella zona B a nord di via Colombina (quello per cui erano iniziati i lavori nella foto del 2007) - realizzazione piccola rotatoria presso piazza Togliatti - il Piano Attuativo non è stato attuato (come gli altri a destinazione residenziale), perché sottoposto a un bando pubblico (novità introdotta dall’art. 10 delle NTA modificate dalla terza Variante) che il Comune non ha mai fatto - la nuova viabilità non è realizzata ed è inserita nel Programma triennale delle opere pubbliche 2010-2012 del Comune di Campi Bisenzio (non per l’intero tratto di Circonvallazione Ovest, ma solo per quello che costeggia la frazione di Capalle)
2003
2007
2011
95
AREA_7 Descrizione generale dell’area: la zona, posta in un’area centro-occidentale del territorio comunale, è caratterizzata da insediamenti industriali localizzati in modo frammentato all’interno di aree prevalentemente agricole; in particolare, quest’area è particolarmente fragile da un punto di vista ambientale, perché nel tempo ha ospitato lo stabilimento della fornace “Le Piaggiole” (a nord), in cui venivano prodotti laterizi (attività cessata nel 1984); la cava posta a sud dello stabilimento, una volta esaurita, è stata utilizzata come discarica per i rifiuti nel corso degli anni Sessanta; inoltre, la parte a sud dell'area è stata occupata dall'impianto di compostaggio “Bioter”, chiuso nel 2000; la zona è attraversata dal torrente Vingone, fortemente canalizzato
Analisi dello stralcio della tavola di progetto del PS: il PS individua, nell’area, i seguenti sottosistemi funzionali (tra parentesi gli articoli relativi delle NTA): - delle aree produttive (che occupa la maggiore superficie) (art. 27: questo, per l’area produttiva ex Fornaci le Piaggiole e Impianto di Bioter prescrive “che nell’ambito delle soluzioni progettuali del Regolamento Urbanistico siano ricostruiti i valori ambientali e paesistici nonché la continuità biologica dell’habitat lungo il canale Vingone-Lupo. L’intervento edilizio dovrà essere limitato alla ristrutturazione urbanistica delle aree già compromesse e che s iano tenute in considerazione, nella redazione del Regolamento Urbanistico, ai fini dell’utilizzazione dell’intera area, le caratteristiche naturalistiche ed ambientali dell’area stessa. Le strutture edilizie dei depositi di materiali a cielo aperto dovranno essere limitate alle necessità
funzionali ed avere le caratteristiche di amovibilità. Il riuso delle aree già compromesse dovrà risultare compatibile con il territorio agricolo circostante.”); inoltre, lo Statuto dei Luoghi (art. 4) pone l’utilizzazione dei siti industriali dismessi della Bioter e delle Piaggiole (nelle quali aree dovranno trovare sistemazione anche i depositi per le attività edilizie) come “invariante strutturale” - delle permanenze (art. 22) - dei manufatti con valore documentario (art. 24) - idrico: delle acque alte, basse, dei canali, dei pozzi, delle casse di espansione e di laminazione (art. 29) - delle aree agricole (art. 32), che occupa anch’esso una parte consistente dell’area - della grande viabilità pedonale e ciclabile (art. 19)
96
Analisi dello stralcio delle tavole 6, 7, 12 e 13 1:2.000 del RU del 2005: le principali previsioni di piano, oltre al piccolo tratto del corso idrico di progetto che rientra nell’area (nell’angolo a sud-es t), sono i due PMU (4 .15 A e 4 .15 B) relativi all’area da bonificare ex Fornaci ed ex Bioter, che prevedono: - aree produttive di nuova definizione (zona D2) in corrispondenza degli stabilimenti delle ex Fornaci e dell’ex Bioter - aree per depositi di materiali edili a c ielo aperto (zona D4) che occupano approssimativamente l’area dell’ex cava usata come discarica - nuova viabilità secondaria - parcheggi e verde pubblico attrezzato
Analisi dello stralcio delle tavole 6, 7, 12 e 13 1:2.000 della Variante al RU del 2007: la Variante sottopone l’area da bonificare a Piano Complesso di Intervento 4 .15 (art. 133 bis NTA , strumento non previsto nel RU originario), contemplando una diversa s istemazione delle aree produttive, della viabilità secondaria, del verde pubblico e dei parcheggi
Analisi dello stralcio delle tavole 6, 7, 12 e 13 1:2.000 del RU vigente: le tavole sono modificate con Variante approvata con Del C .C . n. 51 del 26/04/2010, relativa al PCI “Le Piaggiole”, che presenta una sistemazione ancora diversa della zona, suddivisa in tre comparti, due a destinazione industriale (zona D2) e uno a des tinazione a depositi di materiali a cielo aperto (zona D4) con un’area molto più estesa di verde pubblico attrezzato e di verde di rispetto, per una superficie complessiva di circa 137.000 m²
97
Confronto fra le foto aeree del 2003 e del 2007 e le previsioni di piano: il confronto fotografico non evidenzia nessuna sostanziale tras formazione di suolo; le previsioni relative al sis tema idrico non sono s tate realizzate
Confronto fra le foto aeree del 2007 e del 2011 e le previsioni di piano: - sono iniziati i lavori per la bonifica dell’area con contestuale progetto in base alle disposizioni del PCI: la convenzione è s tata stipulata nel maggio 2010 - le previs ioni relative al sis tema idrico non sono state realizzate
2003
2007
2011
98
AREA_8 Descrizione generale dell’area: la zona si trova nell’area centro-orientale del territorio comunale, a nord del capoluogo; è caratterizzata dalla presenza del complesso di Villa Montalvo, prevalentemente agricolo, composto dalle strutture di origine trecentesca (oggetto di rifacimenti sei-settecenteschi e di un recente res tauro, sono sede della Biblioteca Comunale, dell'Archivio Storico del Comune e di alcuni uffici municipali), dai giardini storici e da un parco urbano di circa 19 ettari che si estende lungo il corso del torrente Marina; a sud del complesso di Villa Montalvo, e da questo separato dalla Circonvallazione Nord, si nota la parte settentrionale del centro abitato del capoluogo, caratterizzato da tessuto urbano continuo con grandi edifici in linea
Analisi dello stralcio della tavola di progetto del PS: il PS individua, nell’area, i seguenti sottosistemi funzionali (tra parentesi gli articoli relativi delle NTA): - del verde urbano: pubblico attrezzato e privato (art. 33), che occupa la maggiore superficie - idrico: delle acque alte, basse, dei canali, dei pozzi, delle casse di espansione e di laminazione (art. 29) - dei parchi (art. 30) - delle aree agricole (art. 32) - delle permanenze (art. 22) - dei tessuti unitari e delle architetture recenti (art. 23) - una piccolissima area del sottosistema delle aree edificate tras formabili (art. 25) - della grande viabilità pedonale e ciclabile (art. 19) - delle strade extraurbane
secondarie di tipo “C ” (art. 18) Lo Statuto dei Luoghi (art. 3), per l’area, considera “risorse essenziali”: la forte demarcazione tra centro abitato e zona agricola definita dal limite della c irconvallazione Nord e il complesso monumentale di villa Montalvo e del parco omonimo retrostante, e “invarianti strutturali”: la tutela e la valorizzazione dei livelli attuali di “naturalità” dei luoghi del parco […] di V illa Montalvo […]
99
Analisi dello stralcio delle tavole 8 e 14 1:2.000 del RU del 2005: date le caratteristiche dell’area, distinta dalla presenza del complesso di Villa Montalvo, il RU non prevede particolari tras formazioni territoriali; a sud della Circonvallazione, le zone residenziali sono c lassificate come B (aree residenziali da consolidare) e Bp (edifici in aree PEEP vigente: sono le grandi strutture in linea che ben si notano dalla foto area); da notare la previsione della pis ta ciclabile, che dalla Circonvallazione si inserisce in via di Limite (che costeggia il parco urbano), e di un’area ecologica attrezzata
Analisi dello stralcio delle tavole 8 e 14 1:2.000 della Variante al RU del 2007: la Variante non apporta nessuna modifica (cartografica) alle previsioni di piano (le NTA sono state invece modificate con le variazioni illustrate nel paragrafo relativo alla storia urbanistica)
Analisi dello stralcio delle tavole 8 e 14 1:2.000 del RU vigente: il RU vigente conferma le previsioni di piano della Variante del 2007
100
Confronto fra le foto aeree del 2003 e del 2007 e le previsioni di piano: - nella foto del 2007 si nota la realizzazione della pista c iclabile
Confronto fra le foto aeree del 2007 e del 2011 e le previsioni di piano: il confronto fotografico non evidenzia nessuna sostanziale tras formazione di suolo
2003
2007
2011
101
AREA_9 Descrizione generale dell’area: la zona si trova nell’area occidentale del territorio, in località Le Miccine, ai confini con il Comune di Prato; è una zona prevalentemente agricola, caratterizzata dalla presenza di case sparse e di aree umide di interesse naturalistico
Analisi dello stralcio della tavola di progetto del PS: il PS individua, nell’area, i seguenti sottos istemi funzionali (tra parentesi gli articoli relativi delle NTA): - delle aree agricole (art. 32), che occupa la maggiore superficie - idrico: delle acque alte, basse, dei canali, dei pozzi, delle casse di espansione e di laminazione (art. 29) - delle aree di particolare rilevanza naturalistica (art. 31): nell’area ricade parte del Sito di Interesse Comunitario inserito dalla Regione Toscana nella rete ecologica regionale come SIR (Sito di Interesse Regionale) 45 “Stagni della Piana Fiorentina”; l’art. 31 stabilisce che la previsione, in sede di Regolamento U rbanistico, di interventi suscettibili di produrre effetti sui SIR, s ia subordinata alla
redazione della relazione di incidenza, ai sensi dell’art. 15 della legge regionale 56/2000, che dimostri che gli interventi previsti e la loro attuazione non pregiudicano l’integrità del sito - delle permanenze (art. 22) Lo Statuto dei Luoghi (art. 6), per l’area, considera “risorse essenziali”: le aree di interesse naturalistico definite a medio, alto e notevole grado di naturalità, i laghetti palustri s ia per il paesaggio che essi caratterizzano che per la risorsa idrica, che per la fauna migratoria ospitata, e “invarianti strutturali”: la realizzazione della cassa di espansione idraulica delle Miccine e il mantenimento dell’intero paesaggio agrario con le relative strade poderali e fossi campestri esistenti
102
Analisi dello stralcio della tavola 12 1:2.000 del RU del 2005: - gli edifici presenti sono tutti inseriti negli elenchi della l.r. 59/80 - le s trade presenti sono indicate come “s trade vic inali e poderali da tutelare” - la previsione di maggior rilievo è la cassa di espansione, che però occupa dell’area in ques tione solo una piccola parte, a sud-ovest Analisi dello stralcio della tavola 12 1:2.000 della Variante al RU del 2007: la Variante non apporta nessuna modifica (cartografica) alle previsioni di piano (le NTA sono state invece modificate con le variazioni illustrate nel paragrafo relativo alla storia urbanistica) Analisi dello stralcio della tavola 12 1:2.000 del RU vigente: il RU vigente conferma le previs ioni di piano della Variante del 2007
103
Confronto fra le foto aeree del 2003 e del 2007 e le previsioni di piano: il confronto fotografico non evidenzia nessuna sostanziale tras formazione di suolo; le previsioni relative al s istema idrico non sono s tate realizzate Confronto fra le foto aeree del 2007 e del 2011 e le previsioni di piano: il confronto fotografico non evidenzia nessuna sos tanziale tras formazione di suolo; le previsioni relative al sistema idrico non sono s tate realizzate
2003
2007
2011
104
AREA_10 Descrizione generale dell’area: la zona si trova in posizione centrale rispetto al territorio comunale e ricade nel centro abitato del Capoluogo, attraversato da nord a sud dal corso del fiume Bisenzio; la zona comprende parte del centro storico, sviluppatosi lungo la viabilità matrice di via Santo Stefano, in sinis tra Bisenzio, e lungo la sua prosecuzione oltre il ponte, nonché lungo via Santa Maria, in destra Bisenzio; il tessuto urbano è quello della città consolidata: continuo e compatto e con particolari emergenze architettoniche (ad esempio, il complesso della trecentesca Rocca Strozzi, in riva destra nei pressi del ponte, o la P ieve di Santo Stefano) nel centro s torico, continuo ma più rado nelle zone più lontane dal centro
Analisi dello stralcio della tavola di progetto del PS: il PS individua, nell’area, i seguenti sottosistemi funzionali (tra parentesi gli articoli relativi delle NTA): - delle permanenze (art. 22), che occupa la maggiore superficie - delle aree edificate tras formabili (art. 25) - idrico: delle acque alte, basse, dei canali, dei pozzi, delle casse di espansione e di laminazione (art. 29) - del verde urbano: pubblico attrezzato e privato (art. 33) - dei parchi (art. 30) - degli uffic i e delle attrezzature pubbliche e private di uso pubblico di livello urbano (art. 40) - delle strade urbane generatric i della “forma c ittà” (art. 20) - delle caratteristiche sensoriali dei contesti urbani (art. 34): valore alto
in corrispondenza del centro s torico di via Santo Stefano, valore medio in corrispondenza del centro s torico in riva destra (come s i legge nello Statuto dei Luoghi, art. 4: “il fiume […] ha di fatto rappresentato nella s toria dei popoli una frattura tra la riva destra e la sinis tra” Lo Statuto dei Luoghi (art. 4), per l’area, inoltre, pone come “risorsa essenziale” il carattere storico e documentario di Via Tosca Fiesoli (tracciato del decumano della centuriazione romana) a partire dal valore del centro storico di Santa Maria e della Rocca Strozzi e (art. 5) il centro storico di Santo Stefano comprendente la Pieve omonima e gli edifici inseriti negli Elenchi di cui alla L.R. 59/80, e come “invariante s trutturale” (art. 5) la salvaguardia e tutela del Centro Storico, il patrimonio edilizio di cui agli Elenchi della LR. 59/80
105
Analisi dello stralcio della tavola 14 1:2.000 del RU del 2005: - l’area è indicata con “presenza di caratteri sensoriali da preservare”; le previsioni di maggior rilievo sono: - l’insediamento di attrezzature di interesse comune alla Rocca Strozzi - la realizzazione di due parcheggi, uno tra il giardino della Rocca Strozzi e la Chiesa di Santa Maria, e l’altro in via II Settembre Analisi dello stralcio della tavola 14 1:2.000 della Variante al RU del 2007: la Variante non apporta nessuna modifica (cartografica) alle previsioni di piano (le NTA sono state invece modificate con le variazioni illustrate nel paragrafo relativo alla storia urbanistica) Analisi dello stralcio della tavola 14 1:2.000 del RU vigente: il RU vigente conferma le previsioni di piano della Variante del 2007
106
Confronto fra le foto aeree del 2003 e del 2007 e le previsioni di piano: - a partire dal 2003 il centro è s tato oggetto di una riqualificazione e dell’istituzione della Zona a T raffico Limitato, con lo scopo di valorizzare la centrale via Santo Stefano e le strade e le piazze ad essa adiacenti; nella foto aerea si distinguono la nuova pavimentazione e sistemazione delle alberature - nella foto aerea del 2007 si nota la realizzazione del parcheggio tra il giardino della Rocca Strozzi e la Chiesa di Santa Maria
Confronto fra le foto aeree del 2007 e del 2011 e le previsioni di piano: il confronto fotografico non evidenzia nessuna sostanziale tras formazione di suolo
2003
2007
2011
107
AREA_11 Descrizione generale dell’area: la zona, pos ta nell’estremità orientale del territorio comunale, a nord del centro abitato della frazione di Sant’Angelo a Lecore, è prevalentemente agricola e di particolare rilevanza naturalistica, per la presenza di numerosi laghetti palustri
Analisi dello stralcio della tavola di progetto del PS: il PS individua, nell’area, i seguenti sottosistemi funzionali (tra parentesi gli articoli relativi delle NTA): - idrico: delle acque alte, basse, dei canali, dei pozzi, delle casse di espansione e di laminazione (art. 29), che occupa la maggiore superficie - delle aree di particolare rilevanza naturalistica (art. 31): l’area ricade all’interno del Sito di Interesse Comunitario inserito dalla Regione Toscana nella rete ecologica regionale come SIR (Sito di Interesse Regionale) 45 “Stagni della Piana Fiorentina”; l’art. 31 stabilisce che la previsione, in sede di Regolamento Urbanis tico, di interventi suscettibili di produrre effetti sui SIR, sia subordinata alla redazione della relazione di
incidenza, ai sensi dell’art. 15 della legge regionale 56/2000, che dimostri che gli interventi previsti e la loro attuazione non pregiudicano l’integrità del s ito - delle aree agricole (art. 32) - delle permanenze (art. 22) - della grande viabilità pedonale e c iclabile (art. 19)
108
Analisi dello stralcio delle tavole 11 e 17 1:2.000 del RU del 2005: - alla quasi totalità dell’area è affidata la funzione di cassa di espansione - una delle previs ioni più rilevanti è l’is tituzione dell’ANPIL “Crocicchio dell’Oro” (perimetrato nelle tavole): nel quarto P rogramma Regionale delle A ree P rotette tale ANPIL è inserita tra le proposte; nel quinto Programma Regionale delle Aree Protette 2009-2011 l’ANPIL non compare tuttavia negli elenchi Analisi dello stralcio delle tavole 11 e 17 1:2.000 della Variante al RU del 2007: la Variante non apporta nessuna modifica (cartografica) alle previsioni di piano (le NTA sono state invece modificate con le variazioni illustrate nel paragrafo relativo alla storia urbanistica)
Analisi dello stralcio delle tavole 11 e 17 1:2.000 del RU vigente: le tavole 11 e 17 non hanno subito modifiche dopo la terza Variante
109
Confronto fra le foto aeree del 2003 e del 2007 e le previsioni di piano: il confronto fotografico non evidenzia nessuna sostanziale tras formazione di suolo; le previsioni relative al sistema idrico non sono s tate realizzate
Confronto fra le foto aeree del 2007 e del 2011 e le previsioni di piano: - messa a coltura dell’area occupata dal laghetto palus tre (l’art. 142, comma 7 del RU vigente prevede, infatti, che “i laghetti palustri possono essere coltivati e modificati (anche nelle loro arginature) ripristinati e gestiti a condizione che non si c rei alcun danno alla fauna presente nella zona […]” - ampliamento dell’unico edificio presente nell’area - le previsioni relative al sistema idrico non sono state realizzate
2003
2007
2011
110
AREA_12 Descrizione generale dell’area: la zona si trova nell’area occidentale del territorio, in località Le M iccine; è una zona prevalentemente agricola, attraversata dal torrente Vingone e caratterizzata dalla presenza di case sparse e di aree umide di interesse naturalistico
Analisi dello stralcio della tavola di progetto del PS: il PS individua, nell’area, i seguenti sottosistemi funzionali (tra parentesi gli articoli relativi delle NTA): - delle aree di particolare rilevanza naturalistica (art. 31), che occupa la maggior parte della superficie in quanto l’area ricade quasi totalmente all’interno del Sito di Interesse Comunitario inserito dalla Regione Toscana nella rete ecologica regionale come SIR (Sito di Interesse Regionale) 45 “Stagni della P iana Fiorentina”; l’art. 31 stabilisce che la previsione, in sede di Regolamento U rbanistico, di interventi suscettibili di produrre effetti sui SIR, s ia subordinata alla redazione della relazione di incidenza, ai sensi dell’art. 15 della legge regionale 56/2000, che dimostri che gli interventi previsti e
la loro attuazione non pregiudicano l’integrità del s ito - idrico: delle acque alte, basse, dei canali, dei pozzi, delle casse di espans ione e di laminazione (art. 29), che occupa anch’esso la quasi totalità dell’area - delle aree agricole (art. 32) - delle permanenze (art. 22) - della grande viabilità pedonale e c iclabile (art. 19) Lo Statuto dei Luoghi (art. 6), per l’area, considera “risorse essenziali”: le aree di interesse naturalistico definite a medio, alto e notevole grado di naturalità, i laghetti palustri s ia per il paesaggio che essi caratterizzano che per la risorsa idrica, che per la fauna migratoria ospitata, e “invarianti strutturali”: la realizzazione della cassa di espansione idraulica delle Miccine e il mantenimento dell’intero paesaggio agrario con le relative strade poderali e fossi campestri esistenti
111
Analisi dello stralcio delle tavole 12 e 18 1:2.000 del RU del 2005: - gli edifici presenti sono tutti inseriti negli elenchi della l.r. 59/80 - la previs ione di maggior rilievo è la cassa di espansione
Analisi dello stralcio delle tavole 12 e 18 1:2.000 della Variante al RU del 2007: la Variante non apporta nessuna modifica (cartografica) alle previsioni di piano (le NTA sono state invece modificate con le variazioni illustrate nel paragrafo relativo alla storia urbanistica)
Analisi dello stralcio delle tavole 12 e 18 1:2.000 del RU vigente: il RU vigente conferma le previsioni di piano della Variante del 2007
112
Confronto fra le foto aeree del 2003 e del 2007 e le previsioni di piano: - modifica dei confini dell’area occupata dal laghetto palustre (l’art. 54 del RU originario prevede, infatti, che “[…] i laghetti palus tri possono essere coltivati e modificati (anche nelle loro arginature) ripristinati e gestiti a condizione che non si c rei alcun danno alla fauna presente nella zona […]” (norma rimas ta immutata anche nel RU vigente) - le previsioni relative al sistema idrico non sono state realizzate
Confronto fra le foto aeree del 2007 e del 2011 e le previsioni di piano: il confronto fotografico non evidenzia nessuna sostanziale tras formazione di suolo; le previsioni relative al sistema idrico non sono s tate realizzate
2003
2007
2011
113
AREA_13 Descrizione generale dell’area: la zona s i trova in posizione centrale rispetto al territorio comunale e ricade nel centro abitato del Capoluogo, attraversato da nord a sud dal corso del fiume Bisenzio; la zona comprende parte del centro storico, sviluppatosi lungo la viabilità matrice di via Santo Stefano, in sinistra Bisenzio, ed è caratterizzata dalla presenza del complesso della quattrocentesca Villa Rucellai (che oggi ospita alcuni uffici comunali) e del suo giardino; il tessuto urbano è quello della città consolidata, continuo e compatto e con particolari emergenze architettoniche (ad esempio, il Palazzo Comunale) nel centro storico, continuo ma più rado nelle zone più lontane dal centro
Analisi dello stralcio della tavola di progetto del PS: il PS individua, nell’area, i seguenti sottosis temi funzionali (tra parentesi gli articoli relativi delle NTA): - delle permanenze (art. 22) - delle aree edificate tras formabili (art. 25), che, ins ieme a quello delle permanenze, occupa la maggiore superficie - dei tessuti unitari e delle architetture recenti (art. 23) - degli ambiti s trategici (art. 26) - del verde urbano: pubblico attrezzato e privato (art. 33) - dell’istruzione (art. 38) - dei circoli ric reativi e culturali (art. 39) - degli uffic i e delle attrezzature pubbliche e private di uso pubblico di livello urbano (art. 40) - delle strade urbane generatrici della “forma c ittà” (art. 20)
- delle caratteris tiche sensoriali dei contesti urbani (art. 34), con valore “alto”, in corrispondenza del centro storico Lo Statuto dei Luoghi (art. 5), considera, per l’area, “risorse essenziali”: il centro storico di Santo Stefano comprendente la P ieve omonima e gli edific i inseriti negli Elenchi di cui alla L.R. 59/80, tra i quali la Villa Rucellai; le attività commerciali esis tenti della media e piccola distribuzione; le strutture dell’associazionismo e del volontariato presenti nell’area; le attrezzature pubbliche, scolas tiche e gli uffici della Pubblica Amministrazione; pone, invece, come “invarianti s trutturali”: la salvaguardia e tutela del Centro Storico, il patrimonio edilizio di cui agli E lenchi della LR. 59/80 inserito nel quadro conoscitivo e delle architetture moderne (ad esempio la sala consiliare dell’ architetto Marco Dezzi Bardeschi); il recupero di Villa Rucellai con la conseguente formazione del polo delle funzioni pubbliche
114
Analisi dello stralcio delle tavole 14 e 20 1:2.000 del RU del 2005: - la previsione di piano più rilevante è contenuta nel PMU 5 .1 e comprende un’area di espans ione C (tessuto residenziale di nuova definizione) a sud del giardino di Villa Rucellai - l’area di Villa Rucellai è des tinata ad accogliere attrezzature di interesse comune (e infatti, oggi, dopo il restauro avvenuto nel periodo 2002-2003, ospita alcuni uffic i comunali) Analisi dello stralcio delle tavole 14 e 20 1:2.000 della Variante al RU del 2007: - l’area del PMU del 2005 è assoggettata a PCI (Piano Complesso di Intervento: art. 133 bis NTA , strumento non previsto nel RU originario), ed estesa alla Villa Rucellai ed al suo giardino, al Palazzo Comunale e a piazza della Resistenza Analisi dello stralcio delle tavole 14 e 20 1:2.000 del RU vigente: il RU vigente conferma le previs ioni di piano della Variante del 2007
115
Confronto fra le foto aeree del 2003 e del 2007 e le previsioni di piano: - a partire dal 2003 il centro è stato oggetto di una riqualificazione e dell’istituzione della Zona a Traffico Limitato, con lo scopo di valorizzare la centrale via Santo Stefano e le strade e le piazze ad essa adiacenti; nella foto aerea si dis tinguono la nuova pavimentazione e sistemazione delle alberature
Confronto fra le foto aeree del 2007 e del 2011 e le previsioni di piano: il confronto fotografico non evidenzia nessuna sostanziale tras formazione di suolo: il PCI 5 .1 non è s tato né adottato né approvato
2003
2007
2011
116
AREA_14 Descrizione generale dell’area: la zona, pos ta nell’estremità orientale del territorio comunale, a nord del centro abitato della frazione di Sant’Angelo a Lecore e in località Crocicchio dell’Oro, è prevalentemente agricola e di particolare rilevanza naturalistica, per la presenza di numerosi laghetti palustri; la zona comprende un piccolo nuc leo abitato, con tessuto urbano rado
Analisi dello stralcio della tavola di progetto del PS: il PS individua, nell’area, i seguenti sottosistemi funzionali (tra parentesi gli articoli relativi delle NTA): - idrico: delle acque alte, basse, dei canali, dei pozzi, delle casse di espansione e di laminazione (art. 29) - delle aree di particolare rilevanza naturalistica (art. 31): l’area ricade quasi totalmente all’interno del Sito di Interesse Comunitario inserito dalla Regione Toscana nella rete ecologica regionale come SIR (Sito di Interesse Regionale) 45 “Stagni della P iana Fiorentina”; l’art. 31 stabilisce che la previsione, in sede di Regolamento U rbanistico, di interventi suscettibili di produrre effetti sui SIR, s ia subordinata alla redazione della relazione di incidenza, ai sensi dell’art. 15 della
legge regionale 56/2000, che dimostri che gli interventi previsti e la loro attuazione non pregiudicano l’integrità del sito - delle aree agricole (art. 32), che, ins ieme a quello delle aree di particolare rilevanza naturalistica, occupa la maggiore superficie - delle permanenze (art. 22) - delle aree edificate tras formabili (art. 25) - dei manufatti con valore documentario (art. 24) - della grande viabilità pedonale e c iclabile (art. 19)
117
Analisi dello stralcio della tavola 17 1:2.000 del RU del 2005: le previsioni principali sono: - un bacino di compensazione delle celle idrauliche - l’is tituzione dell’ANPIL “Crocicchio dell’Oro” (perimetrato nelle tavole): nel quarto Programma Regionale delle Aree Protette tale ANPIL è inserita tra le proposte; nel quinto Programma Regionale delle Aree Protette 2009-2011 l’ANPIL non compare tuttavia negli elenchi Analisi dello stralcio della tavola 17 1:2.000 della Variante al RU del 2007: la Variante non apporta nessuna modifica (cartografica) alle previsioni di piano (le NTA sono state invece modificate con le variazioni illustrate nel paragrafo relativo alla storia urbanistica); l’unica modifica è l’assenza del perimetro dei centri e nuclei abitati: il RU 2005 infatti lo individua nella cartografia 1:2 .000 (art. 32 NTA), mentre la Variante istituisce apposita cartografia 1:10.000 per il perimetro dei centri abitati (art. 40 NTA )
Analisi dello stralcio della tavola 17 1:2.000 del RU vigente: la tavola 17 non ha subito modifiche dopo la terza Variante
118
Confronto fra le foto aeree del 2003 e del 2007 e le previsioni di piano: - modifica dei confini dell’area occupata dal laghetto palustre (l’art. 54 del RU originario prevede, infatti, che “[…] i laghetti palustri possono essere coltivati e modificati (anche nelle loro arginature) ripristinati e ges titi a condizione che non si c rei alcun danno alla fauna presente nella zona […]” (norma rimas ta immutata anche nel RU vigente) - le previsioni relative al s istema idrico non sono state realizzate
Confronto fra le foto aeree del 2007 e del 2011 e le previsioni di piano: il confronto fotografico non evidenzia nessuna sostanziale tras formazione di suolo; le previsioni relative al s istema idrico non sono s tate realizzate
2003
2007
2011
119
AREA_15 Descrizione generale dell’area: la zona si trova nell’area occidentale del territorio; è una zona prevalentemente agricola, caratterizzata dalla presenza di case sparse e di aree umide di interesse naturalistico
Analisi dello stralcio della tavola di progetto del PS: il PS individua, nell’area, i seguenti sottos istemi funzionali (tra parentesi gli articoli relativi delle NTA): - idrico: delle acque alte, basse, dei canali, dei pozzi, delle casse di espansione e di laminazione (art. 29) - delle aree di particolare rilevanza naturalistica (art. 31), che, insieme a quello idrico, occupa la maggior parte della superficie in quanto l’area ricade all’interno del Sito di Interesse Comunitario inserito dalla Regione Toscana nella rete ecologica regionale come SIR (Sito di Interesse Regionale) 45 “Stagni della Piana Fiorentina”; l’art. 31 stabilisce che la previsione, in sede di Regolamento U rbanistico, di interventi suscettibili di produrre effetti sui SIR, s ia subordinata alla
redazione della relazione di incidenza, ai sensi dell’art. 15 della legge regionale 56/2000, che dimostri che gli interventi previsti e la loro attuazione non pregiudicano l’integrità del sito - delle permanenze (art. 22) - della grande viabilità pedonale e c iclabile (art. 19) Lo Statuto dei Luoghi (art. 6), per l’area, considera “risorse essenziali”: le aree di interesse naturalistico definite a medio, alto e notevole grado di naturalità, i laghetti palustri s ia per il paesaggio che essi caratterizzano che per la risorsa idrica, che per la fauna migratoria ospitata, e “invarianti strutturali”: la realizzazione della cassa di espansione idraulica delle Miccine e il mantenimento dell’intero paesaggio agrario con le relative strade poderali e fossi campestri esistenti
120
Analisi dello stralcio delle tavole 18 e 19 1:2.000 del RU del 2005: le previsioni di maggior rilievo riguardano: - la cassa di espansione, che interessa tutta l’area - grande viabilità di progetto: il tronco di s trada ricadente nell’area è l’“appendice” dello svincolo che si inserisce nel tracciato di progetto della bretella Las tra a Signa-P rato (classificata come strada extraurbana principale di tipo “B”)
Analisi dello stralcio delle tavole 18 e 19 1:2.000 della Variante al RU del 2007: la Variante non apporta nessuna modifica (cartografica) alle previsioni di piano (le NTA sono state invece modificate con le variazioni illustrate nel paragrafo relativo alla storia urbanistica)
Analisi dello stralcio delle tavole 18 e 19 1:2.000 del RU vigente: - la modifica più rilevante riguarda la nuova viabilità, in relazione al progetto definitivo della bretella autostradale Lastra a Signa-P rato (sesta Variante al RU , 2009); in merito c ’è da sottolineare che il PS indica ancora la bretella come strada extraurbana principale di tipo “B” e non come autostrada, non aggiornando l’ampiezza della fascia di rispetto, secondo le disposizioni del DM 1404/68
121
Confronto fra le foto aeree del 2003 e del 2007 e le previsioni di piano: - l’unica modifica è la diversa messa a coltura dell’appezzamento a sud-es t dell’area, che assume un aspetto tipico di “orto urbano”, peraltro non indicato dal RU per quest’area - la mancata realizzazione della bretella Lastra a Signa-Prato ha implicato la non esecuzione della viabilità collaterale - le previsioni relative al s istema idrico non sono state realizzate
Confronto fra le foto aeree del 2007 e del 2011 e le previsioni di piano: il confronto fotografico non evidenzia nessuna sostanziale tras formazione di suolo; la mancata realizzazione della bretella Lastra a Signa-P rato ha implicato la non esecuzione della viabilità collaterale; le previsioni relative al sistema idrico non sono state realizzate
2003
2007
2011
122
AREA_16 Descrizione generale dell’area: la zona si trova nell’area centro-orientale del territorio comunale, e ricade nella parte meridionale del centro abitato del capoluogo; comprende s ia aree con tessuto urbano continuo ma rado, sia superfici agricole adibite per lo più a seminativo, od aree verdi incolte; l’area è caratterizzata dalla presenza dell’asse di via Palagetta, che svolge un’importante funzione di collegamento nord-sud, e dalla piazza Nazioni Unite, dalla forma triangolare, che è s tata l’area adibita al mercato settimanale fino a quando questo è s tato spostato nella centrale via Santo Stefano, nell’ambito del progetto di riqualificazione del centro storico
Analisi dello stralcio della tavola di progetto del PS: il PS individua, nell’area, i seguenti sottosistemi funzionali (tra parentesi gli articoli relativi delle NTA): - delle aree edificate trasformabili (art. 25), che occupa la maggiore superficie - dei tessuti unitari e delle architetture recenti (art. 23) - degli ambiti s trategici (art. 26) - dell’istruzione (art. 38) - degli uffici e delle attrezzature pubbliche e private di uso pubblico di livello urbano (art. 40) - degli uffici e delle attrezzature pubbliche e private di uso pubblico di livello metropolitano (art. 41) - delle strade urbane generatrici della “forma c ittà” (art. 20) Per la zona, lo Statuto dei Luoghi (art. 5) considera “risorse essenziali” le attrezzature pubbliche, scolastiche e gli uffici
della Pubblica Amministrazione, e “invarianti s trutturali” la qualificazione dei due assi urbani prioritari: via Buozzi (che non ricade nell’area) e via Cetino-Palagetta
123
Analisi dello stralcio della tavola 20 1:2.000 del RU del 2005: - la previsione di maggior rilievo è quella che ricade all’interno del PMU 5 .5 e che comporta una generale risis temazione dell’area attorno a piazza Nazioni Unite (nuova viabilità urbana secondaria, parcheggi, verde pubblico, aree residenziali di nuova definizione - zona C - e aree per l’istruzione e per attrezzature di interesse comune) - a sud-est nell’area ricade una piccola porzione del PMU 5.7 , con previsione di aree per l’istruzione di livello metropolitano - inoltre, a es t ricade nell’area anche una parte ancora più ridotta del PMU 5 .2 , con previs ione di parcheggio Analisi dello stralcio della tavola 20 1:2.000 della Variante al RU del 2007: la Variante conferma le previsioni di piano (sempre da cons iderare parallelamente alle modifiche alle NTA illustrate nel paragrafo relativo alla storia urbanistica) Analisi dello stralcio della tavola 20 1:2.000 del RU vigente: il RU vigente conferma le previsioni di piano della Variante del 2007
124
Confronto fra le foto aeree del 2003 e del 2007 e le previsioni di piano: - nel 2007 si nota una nuova sistemazione dell’area a nord di piazza Nazioni Unite, con l’apertura di una nuova strada (prolungamento di via Giordano Bruno) e la costruzione di rotatoria e parcheggi; tali tras formazioni non fanno parte del PMU, e sono avvenute precedentemente all’approvazione del RU del 2005, che infatti indica la strada e la rotatoria come viabilità es istente e non di progetto - i PMU 5 .2 , 5 .5 e 5 .7 non sono stati né adottati né approvati
Confronto fra le foto aeree del 2007 e del 2011 e le previsioni di piano: il confronto fotografico non evidenzia nessuna sostanziale tras formazione di suolo: i PMU 5 .2 , 5 .5 e 5 .7 non sono stati né adottati né approvati
2003
2007
2011
125
AREA_17 Descrizione generale dell’area: la zona si trova a sud-ovest rispetto al territorio comunale, a nord del centro abitato della frazione di Sant’Angelo a Lecore, sviluppatosi lungo la via Pistoiese (con tessuto urbano discontinuo), che costituisce il confine tra il Comune di Campi Bisenzio e quello di Signa; è una zona prevalentemente agricola, attraversata dal torrente Vingone e caratterizzata dalla presenza di aree umide di interesse naturalistico
Analisi dello stralcio della tavola di progetto del PS: il PS individua, nell’area, i seguenti sottosistemi funzionali (tra parentesi gli articoli relativi delle NTA): - idrico: delle acque alte, basse, dei canali, dei pozzi, delle casse di espansione e di laminazione (art. 29) - delle aree di particolare rilevanza naturalistica (art. 31): l’area ricade quasi totalmente all’interno del Sito di Interesse Comunitario inserito dalla Regione Toscana nella rete ecologica regionale come SIR (Sito di Interesse Regionale) 45 “Stagni della P iana Fiorentina”; l’art. 31 stabilisce che la previsione, in sede di Regolamento U rbanistico, di interventi suscettibili di produrre effetti sui SIR, s ia subordinata alla redazione della relazione di incidenza, ai sensi dell’art. 15 della
legge regionale 56/2000, che dimostri che gli interventi previsti e la loro attuazione non pregiudicano l’integrità del sito - delle aree agricole (art. 32), che, ins ieme a quello delle aree di particolare rilevanza naturalistica, occupa la maggiore superficie - delle aree edificate tras formabili (art. 25) - della grande viabilità pedonale e c iclabile (art. 19) - una piccolissima parte di sottosis tema funzionale delle aree produttive (art. 27) Lo Statuto dei Luoghi (art. 6) considera, per la zona, “risorse essenziali” le aree di interesse naturalistico definite a medio, alto e notevole grado di naturalità, l’intero reticolo idraulico di “notevole” valore per il deflusso delle acque piovane, i laghetti palustri sia per il paesaggio che essi caratterizzano che per la risorsa idrica, che per la fauna migratoria ospitata; e pone come “invariante s trutturale” il mantenimento dell’intero paesaggio agrario con le relative strade poderali e fossi campestri esistenti
126
Analisi dello stralcio della tavola 18 1:2.000 del RU del 2005: il RU non prevede particolari tras formazioni territoriali; da sottolineare è la presenza della cassa di espans ione (realizzata antecedentemente al RU), che è in relazione con l’area del sistema idrico delle Miccine Analisi dello stralcio della tavola 18 1:2.000 della Variante al RU del 2007: la Variante non apporta nessuna modifica (cartografica) alle previsioni di piano (le NTA sono state invece modificate con le variazioni illustrate nel paragrafo relativo alla storia urbanistica); l’unica modifica è l’assenza del perimetro dei centri e nuclei abitati: il RU 2005 infatti lo individua nella cartografia 1:2000 (art. 32 NTA), mentre la Variante istituisce apposita cartografia 1:10000 per il perimetro dei centri abitati (art. 40 NTA )
Analisi dello stralcio della tavola 18 1:2.000 del RU vigente: la tavola 18 non ha subito modifiche dopo la terza Variante
127
Confronto fra le foto aeree del 2003 e del 2007 e le previsioni di piano: il confronto fotografico non evidenzia nessuna sostanziale tras formazione di suolo Confronto fra le foto aeree del 2007 e del 2011 e le previsioni di piano: il confronto fotografico non evidenzia nessuna sostanziale tras formazione di suolo
2003
2007
2011
128
AREA_18 Descrizione generale dell’area: la zona si trova in posizione centro-meridionale rispetto al territorio comunale ed è un’area prevalentemente agricola, caratterizzata dalla presenza di case sparse, situata a sud della Circonvallazione, lungo il corso del fiume Bisenzio nei pressi del centro abitato della frazione di San Piero a Ponti, che presenta tessuto urbano continuo e rado
Analisi dello stralcio della tavola di progetto del PS: il PS individua, nell’area, i seguenti sottosistemi funzionali (tra parentesi gli articoli relativi delle NTA): - delle aree agricole (art. 32), che occupa la maggiore superficie - idrico: delle acque alte, basse, dei canali, dei pozzi, delle casse di espansione e di laminazione (art. 29) - del verde urbano: pubblico attrezzato e privato (art. 33) - delle aree edificate trasformabili (art. 25) - delle permanenze (art. 22) - degli ambiti strategic i (art. 26), in piccolissima parte - degli uffici e delle attrezzature pubbliche e private di uso pubblico di livello urbano (art. 40) - della grande viabilità pedonale e ciclabile (art. 19)
- delle strade extraurbane secondarie di tipo “C” (art. 18) - delle linee ferroviarie-tranviarie e delle s tazioni metropolitane (art. 15) Lo Statuto dei Luoghi (art. 6) pone, come “risorse essenziali” del luogo le attrezzature pubbliche, cimiteriali sportive e scolastiche esis tenti, e come “invariante strutturale” il mantenimento dell’intero paesaggio agrario con le relative strade poderali e fossi campestri es istenti
129
Analisi dello stralcio delle tavole 19 e 20 1:2.000 del RU del 2005: le previsioni di piano rilevanti riguardano: - il tracciato della ferrovia di progetto, che s i trova sulla direttrice est-oves t Firenze-
Aeroporto-Osmannoro-Campi Bisenzio - il corso idrico di progetto - nuova viabilità in relazione all’ambito s trategico della zona di Torricella (che ricade fuori dall’area, a ovest), che prevede zone C e nuove aree produttive (PMU 6 .6), ma che è considerato nelle “aree non inserite nel presente RU” (art. 68 NTA ): sono aree le cui previsioni potranno essere attuate solo quando saranno superate le problematiche (es . messa in sicurezza idraulica) che ne impediscono la realizzazione (vedi spiegazione più esaustiva per l’area 20) - area per orti urbani Analisi dello stralcio delle tavole 19 e 20 1:2.000 della Variante al RU del 2007: la Variante conferma sostanzialmente le previsioni di piano, ma classifica come Bc (zone residenziali di completamento del tessuto insediativo) le aree inedificate c lassificate come B dal RU 2005 (questa variazione deriva dalla generale revisione della normativa riguardante le zone B, operata dalla terza Variante, descritta nel paragrafo relativo alla storia urbanis tica del Comune) Analisi dello stralcio delle tavole 19 e 20 1:2.000 del RU vigente: il RU vigente conferma le previsioni di piano della Variante del 2007
130
Confronto fra le foto aeree del 2003 e del 2007 e le previsioni di piano: il confronto fotografico non evidenzia nessuna sostanziale tras formazione di suolo; la nuova viabilità non è s tata realizzata; la ferrovia Osmannoro-Campi Bisenzio (inserita nel Piano Regionale della Mobilità e della Logis tica come “intervento prioritario”) non è s tata realizzata; le previs ioni relative agli orti urbani non sono s tate attuate; quelle relative al sistema idrico non sono s tate realizzate
Confronto fra le foto aeree del 2007 e del 2011 e le previsioni di piano: il confronto fotografico non evidenzia nessuna sostanziale tras formazione di suolo; la nuova viabilità non è s tata realizzata; la ferrovia Osmannoro-Campi Bisenzio (inserita nel Piano Regionale della Mobilità e della Logis tica come “intervento prioritario”) non è s tata realizzata; le previs ioni relative agli orti urbani non sono s tate attuate; quelle relative al sistema idrico non sono s tate realizzate
2003
2007
2011
131
AREA_19 Descrizione generale dell’area: la zona si trova nell’estremità sud-orientale del territorio comunale, nella frazione di San Donnino, ai confini con il Comune di Firenze; l’area è attraversata dalla Variante alla Strada Regionale Pistoiese, a sud della quale, lungo gli assi di via Pis toiese e di via Trento, s i sviluppano il centro storico di San Donnino e alcune espansioni più recenti (il tessuto urbano è quello della c ittà consolidata, continuo e più denso nel centro storico), mentre a nord si trova un’area produttiva, associata a superfici agricole o verdi incolte, e chiusa tra il canale Macinante e l’Autos trada A1
Analisi dello stralcio della tavola di progetto del PS: il PS individua, nell’area, i seguenti sottosis temi funzionali (tra parentesi gli articoli relativi delle NTA): - delle aree produttive (art. 27), che occupa la maggiore superficie: in particolare, per l’area produttiva in questione, l’art. 27 prescrive che “nell’ambito delle soluzioni progettuali del Regolamento Urbanistico s iano ricostruiti i valori ambientali e paesistici lungo le infrastrutture viarie (Autos trada A1 e ex Statale 66), nonché la continuità biologica dell’habitat lungo il canale Macinante. Gli interventi edilizi dovranno essere contenuti all’interno del sedime delle aree già compromesse dall’edificato esistente. Le arterie stradali dovranno essere opportunamente schermate con
l’inserimento di zone filtro per le polveri e le barriere antirumore atte a contenere l’inquinamento atmos ferico ed acustico” - delle permanenze (art. 22) - delle aree edificate tras formabili (art. 25) - delle strade urbane generatrici della “forma città” (art. 20) - delle strade extraurbane secondarie di tipo “C” (art. 18) - delle autos trade e dei relativi caselli (art. 16 , in cui si legge “[…] I l Piano Strutturale recepisce il progetto della 3a corsia dell’A1 […]”) Lo Statuto dei Luoghi (art. 8) pone, per l’area, come “risorse essenziali” il centro storico di San Donnino, le attività industriali e artigianali esistenti, e come “invarianti strutturali” la salvaguardia e tutela degli edifici inseriti nel centro storico e la qualificazione dei due assi urbani prioritari: Via Pistoiese, Via T rento
132
Analisi dello stralcio delle tavole 25 e 27 1:2.000 del RU del 2005: le previsioni di piano di maggior rilievo riguardano: - l’area compresa tra il centro storico e la Variante alla Strada Regionale Pis toiese, in cui s i prefigurano nuovi parcheggi, verde pubblico (da notare come alcune zone definite come B siano inedificate, contras tando la definizione delle zone B del DM 1444/68) - la zona produttiva, che il RU disciplina con un apposito articolo (art. 40), in cui non sono ammesse nuove edificazioni e gli interventi di demolizione e ricostruzione, a pari superficie coperta e volume es istenti potranno essere consentiti nell’ambito di un miglioramento ambientale complessivo dell’area Analisi dello stralcio delle tavole 25 e 27 1:2.000 della Variante al RU del 2007: - la Variante conferma sostanzialmente le previsioni di piano, ma classifica come Bc (zone residenziali di completamento del tessuto insediativo) le aree inedificate c lassificate come B dal RU 2005, sottoponendole a Piano Attuativo (questa variazione deriva dalla generale revisione della normativa riguardante le zone B, operata dalla terza Variante, descritta nel paragrafo relativo alla storia urbanis tica del Comune) - l’area produttiva è disciplinata dall’art. 122 delle NTA , che conferma le disposizioni dell’art. 40 delle NTA del RU originario
Analisi dello stralcio delle tavole 25 e 27 1:2.000 del RU le tavole 25 e 27 non hanno subito modifiche dopo la terza Variante
133
Confronto fra le foto aeree del 2003 e del 2007 e le previsioni di piano: - nel 2007 sono in corso i lavori per la realizzazione della terza cors ia dell’A1
Confronto fra le foto aeree del 2007 e del 2011 e le previsioni di piano: - i lavori per la realizzazione della terza corsia dell’A1 sono terminati - il Piano Attuativo non è stato attuato (come gli altri a destinazione residenziale), perché sottoposto a un bando pubblico (novità introdotta dall’art. 10 delle NTA modificate dalla terza Variante) che il Comune non ha mai fatto
2003
2007
2011
134
AREA_20 Descrizione generale dell’area: la zona si trova nell’estremità sud-orientale del territorio comunale, nella frazione di San Donnino, ed è di variegata composizione: comprende infatti parte del centro storico (sviluppato lungo l’asse stradale di via Trento), aree di più recente espansione (sempre lungo via Trento e oltre il canale Macinante), aree destinate ad attrezzature, in gran parte sportive, aree produttive con strutture industriali e superfici agricole adibite prevalentemente a seminativo; il tessuto urbano che si viene a c reare è di tipo discontinuo
Analisi dello stralcio della tavola di progetto del PS: il PS individua, nell’area, i seguenti sottosistemi funzionali (tra parentesi gli articoli relativi delle NTA): - delle permanenze (art. 22) - dei tessuti unitari e delle architetture recenti (art. 23) - delle aree edificate tras formabili (art. 25) - delle aree produttive (art. 27) - idrico: delle acque alte, basse, dei canali, dei pozzi, delle casse di espansione e di laminazione (art. 29) - del verde urbano: pubblico attrezzato e privato (art. 33) - dei parchi (art. 30) - delle aree di particolare rilevanza naturalistica (art. 31): nell’area ricade parte del Sito di Interesse Comunitario inserito dalla Regione Toscana nella rete ecologica regionale come SIR (Sito di Interesse Regionale) 45 “Stagni della Piana Fiorentina”; l’art. 31 stabilisce che la
previsione, in sede di Regolamento Urbanistico, di interventi suscettibili di produrre effetti sui SIR, sia subordinata alla redazione della relazione di incidenza, ai sensi dell’art. 15 della legge regionale 56/2000, che dimostri che gli interventi previsti e la loro attuazione non pregiudicano l’integrità del sito - dell’istruzione (art. 38) - degli uffici e delle attrezzature pubbliche e private di uso pubblico di livello urbano (art. 40) - degli uffici e delle attrezzature pubbliche e private di uso pubblico di livello metropolitano (art. 41) - della grande viabilità pedonale e ciclabile (art. 19) - delle strade urbane generatrici della “forma città” (art. 20) Lo Statuto dei Luoghi (art. 8) pone, per l’area, come “risorse essenziali” il centro storico di San Donnino, le attività industriali e artigianali esistenti, le attrezzature pubbliche, scuole, impianto sportivo e cimitero, e come “invarianti strutturali” la salvaguardia e tutela degli edifici inseriti nel centro storico, la realizzazione dell’ANPIL dell’Arno e la qualificazione dei due assi urbani prioritari: Via Pistoiese, Via Trento
135
Analisi dello stralcio delle tavole 26 e 27 1:2.000 del RU del 2005: l’area è abbastanza complessa, e comprende: - previs ioni di aree produttive (classificate come D1, cioè “da consolidare”, anche se le aree in cui ricadono sono ancora inedificate) - previsioni di parcheggi, orti urbani - previsione di bacini di compensazione delle celle idrauliche - perimetro di progetto dell’ANPIL dell’Arno (l’ANPIL non compare né tra le proposte né negli elenchi s ia del quarto che del quinto Programma Regionale delle Aree Protette) Analisi dello stralcio delle tavole 26 e 27 1:2.000 della Variante al RU del 2007: la Variante conferma sostanzialmente le previsioni di piano, ma c lassifica come Bc (zone residenziali di completamento del tessuto insediativo) le aree inedificate c lassificate come B dal RU 2005, sottoponendole a Piano Attuativo (questa variazione deriva dalla generale revisione della normativa riguardante le zone B, operata dalla terza Variante, descritta nel paragrafo relativo alla storia urbanistica del Comune); in questo caso, però, tale Piano Attuativo è considerato come “area non inserita nel presente RU” (art. 159 NTA); in tali aree (previs te anche dal RU del 2005: vedi, ad es ., l’area 18), sono ammessi esclusivamente gli interventi
consentiti dalla disciplina delle aree non pianificate (art. 63 l.r. 1/2005), in attesa che vengano meno le ragioni che ne motivano l’esclusione; in tale zona, in particolare, le problematiche derivano dalle disposizioni del comma 15 dell’art. 86 (“Fattibilità geologica ed idraulica delle previs ioni di piano”), il quale stabilisce che: “Le istanze edilizie che prefigurano interventi nelle aree previste in s icurezza idraulica in lunghissimo tempo (colore viola nella tav. 10-19 del piano s trutturale) e comportano una trasformazione morfologica superiore a 500 mq sono da rinviare a successivo Regolamento urbanis tico, ad esclusione dei recuperi urbanistici della “Tintoria di Sant’Angelo” e della “Ausonia” nonché della nuova previsione del centro polifunzionale di San Donnino.” Nell’elaborato 10.19 del PS s i può notare come le aree previste in sicurezza idraulica in lunghissimo tempo coprano quasi la totalità del territorio comunale a sud della Circonvallazione Sud: l’area in questione vi ricade completamente Analisi dello stralcio delle tavole 26 e 27 1:2.000 del RU le tavole 26 e 27 non hanno subito modifiche dopo la terza Variante
136
Confronto fra le foto aeree del 2003 e del 2007 e le previsioni di piano: - costruzione di nuove attrezzature sportive a sud-es t - le previs ioni relative agli orti urbani non sono s tate attuate e quelle relative al sistema idrico non sono s tate realizzate
Confronto fra le foto aeree del 2007 e del 2011 e le previsioni di piano: il confronto fotografico non evidenzia nessuna sostanziale tras formazione di suolo; le previsioni relative agli orti urbani non sono state attuate; quelle relative al sis tema idrico non sono state realizzate
2003
2007
2011
137
3.3 Considerazioni finali A seguito dell’analisi condotta su ognuna delle venti aree campione oggetto di monitoraggio, è opportuno operare un ulteriore approfondimento su alcuni aspetti emersi nel corso dello studio. In primo luogo, è interessante fare alcune considerazioni circa la situazione dei Piani Attuativi: di tutti quelli che ricadono, almeno in parte, nelle aree, risulta che ne siano stati attuati - o che abbiano portato alla sottoscrizione di una convenzione - tre (un Piano Attuativo, nell’area 1, un Piano di Massima Unitario, nell’area 5, e un Piano Complesso di Intervento, nell’area 7); lo stato delle cose è, tuttavia, abbastanza complesso e merita, per una maggiore comprensione, alcune specificazioni. Innanzitutto, bisogna sottolineare che, anche se il Regolamento Urbanistico originario è stato approvato nel 2005, le previsioni contenute nei Piani Attuativi sono ancora valide: come già spiegato nel Capitolo 1 del presente lavoro52, infatti, il RU del 2005 aveva rinunciato allo strumento del Piano Attuativo, sostituendolo con quello del Piano di Massima Unitario, non sottoposto alla decadenza quinquennale; la terza Variante, approvata nel 2008, ha reintrodotto, nella normativa, il Piano Attuativo, considerando come tali anche i PMU già individuati in cartografia, le cui previsioni decadono quindi nel 2013. La situazione è analoga per quei PMU trasformati dalla terza Variante in Piani Complessi di Intervento53. Inoltre, è evidente come nessuno dei Piani Attuativi a destinazione esclusivamente residenziale sia stato attuato: questi sono stati infatti introdotti dalla terza Variante in quelle zone che il RU del 2005 classificava come B, anche se palesemente inedificate e solo parzialmente urbanizzate; gli interventi, in tali aree, sono sottoposti ad una procedura competitiva e comparativa54 attraverso dei pubblici bandi che il Comune non ha in realtà mai emanato. La tavola illustrata nella pagina seguente vuole sintetizzare lo stato di attuazione dei Piani Attuativi presi in esame.
52 Vedi il paragrafo 1.2 (Storia urbanistica)
53 Previsti dall’art. 56 della l.r. 1/05
54 Vedi il paragrafo 1.2 (Storia urbanistica) e artt. 19-27 delle NTA del RU vigente
139
In secondo luogo, è necessario approfondire la situazione relativa alle previsioni sul sistema idrico. Dal monitoraggio emerge infatti che, tra gli interventi contemplati dal Regolamento Urbanistico, l’unico in via di attuazione è quello ricadente nell’area 4 (cassa di espansione sul fosso Vingone); anche nell’area 17 ricade una cassa di espansione realizzata, esistente però già prima della redazione del RU del 2005. Ovviamente questo risultato deriva in parte dal fatto che l’attività di monitoraggio non si è svolta sulla totalità del territorio comunale; tuttavia nelle aree prese in considerazione rientrano alcune previsioni di rilievo, quali l’estesa cassa di espansione delle Miccine e il corso idrico di progetto. Quest’ultimo è lo scolmatore del Bisenzio, che consiste in un’opera idraulica in grado di diminuire la portata di piena del fiume, attraverso un canale, parallelo al torrente Vingone, che convoglia le acque verso la cassa di espansione delle Miccine, bypassando il centro abitato. Tali interventi non sono stati attuati, ma meritano una menzione alcuni atti amministrativi riguardanti il controllo del rischio idraulico nel bacino del torrente Vingone, con una premessa: la porzione del territorio comunale posta in riva destra del fiume Bisenzio (dove sono previsti sia lo scolmatore che la cassa di espansione delle Miccine) ricade sia nel Comprensorio di Bonifica n. 15 Ombrone Pistoiese che nel Comprensorio di Bonifica n. 16 Area Fiorentina. A riguardo sono state recentemente emanate quattro significative Deliberazioni della Giunta Comunale:
- la n. 23 del 15/02/201155 - la n. 232 del 17/11/201156 - la n. 250 del 6/12/201157 - la n. 254 del 13/12/201158
In conseguenza a tali Deliberazioni si è approvata la progettazione preliminare delle opere di autocontenimento previste dal Piano Strutturale (nella Tavola 10-15 del Piano Strutturale ad oggetto “Interventi per la mitigazione del rischio idraulico e di ristagno modificata a seguito dell’accoglimento delle osservazioni”) e, specificatamente per quanto riguarda il torrente Vingone, in particolare, la realizzazione di un canale parallelo alla viabilità di circonvallazione al servizio del centro abitato di Campi con funzione di recapito della rete drenante delle acque meteoriche.
55 Oggetto: “Approvazione schema del protocollo d’intesa da sottoscrivere con il Consorzio di Bonifica Ombrone Pistoiese ed il Consorzio di Bonifica dell’Area Fiorentina per la progettazione preliminare degli interventi di mit igazione del rischio idraulico connessi con le previsioni degli strumenti urbanistici del Comune, nei bacini del torrente Vingone e del Fosso di Piano.” 56 Oggetto: “Studio idrologico e idraulico del sistema idraulico in sponda destra del fiume Bisenzio nel
Comune di Campi Bisenzio presentato dal Consorzio di Bonifica Ombrone Pistoiese ad attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto il 24.2.2011. Approvazione.” 57 Oggetto: “Interventi finalizzati alla realizzazione del collettore orientale di scarico delle acque
meteoriche scolanti provenienti dall’abitato di Campi Bisenzio – Progetto preliminare generale- Presa d'atto. Approvazione.” 58 Oggetto: “Interventi finalizzati alla realizzazione del collettore orientale di scarico delle acque
meteoriche scolanti provenienti dall’abitato di Campi Bisenzio – Lotto funzionale n. 2. Progetto preliminare. Presa d’atto – Approvazione.”
140
Scolmatore e cassa di espansione di progetto
Opere idrauliche oggetto delle Deliberazioni
Immagine 3.7: Stralcio della legenda e della Tavola 10-15 del PS (scala originale: 1:10.000) con individuazione delle opere idrauliche oggetto della
trattazione
141
Esaminando, invece, il quadro delle previsioni riguardanti il sistema della mobilità è evidente coma la maggior parte di quelle relative alla viabilità su gomma e ricadenti nelle aree analizzate sono connesse al tracciato di progetto della bretella Lastra a Signa-Prato, ancora non realizzata. Le complesse vicende legate alla concretizzazione di questa infrastruttura sono state aggravate da problemi di tipo economico-finanziario tra la Regione Toscana e la Società SIT (Società Infrastrutture Toscane S.p.A., costituita il 28 giugno 2006 per la progettazione, realizzazione e gestione della Bretella Lastra a Signa-Prato59), firmatarie di un contratto di concessione per l’esecuzione dell’opera; la Giunta regionale ha pertanto deciso di risolvere il contratto con SIT, rilanciando un nuovo project financing. La mancata realizzazione della bretella ha ovviamente impedito l’attuazione delle previsioni ad essa collaterali. Per quanto riguarda la mobilità su ferro che interessa il territorio comunale, il cui tracciato ricade in parte nelle aree prese in considerazione per il monitoraggio, nel Quadro aggiornato delle previsioni del Quadro Regionale della Mobilità e della Logistica60, elaborato nel luglio del 2007, si legge, per la linea ferroviaria Osmannoro-Campi Bisenzio, che il progetto definitivo è in via di elaborazione con approfondimento delle problematiche idrauliche e conseguente approvazione e finanziamento. E’ interessante, infine, fare un breve riferimento alla situazione delle volumetrie residenziali realizzate nel periodo analizzato, relativamente all’intero territorio comunale. Il PS, infatti, pone61, come limite realizzabile per l’anno 2010, quello di 456.000 m³, e la terza Variante al RU individua62 come volumetria ammissibile realizzabile ad uso residenziale nel periodo 2011-2015 300.000 m³, attribuendo al biennio 2011-2012 una quota che è 2/5 del totale (quindi 120.000 m³). Nella tabella si sintetizzano i dati raccolti nella Relazione Generale alla terza Variante (a partire da aprile 2003) redatta dall’Arch. Bartoloni, aggiornata con i dati degli anni successivi forniti dall’Ufficio Edilizia Privata.
59 Come si legge sul sito internet della Camera di Commercio di Firenze (http://partecipa-
firenze.innrete.net/AnagraficaEnte.asp?IdTipoSocieta=1&IdEnte=69&Denominazione=SOCIETA%27%20INFRASTRUTTURE%20TOSCANE%20S.P.A.) 60 Consultabile all’indirizzo internet:
www.rete.toscana.it/sett/pta/territorio/pit_2005_2010/allegati_al_pit/mobilita/Estratto_interventi_PianoMobilitaAGG16-07-2007.pdf 61 Nello Statuto dei Luoghi
62 Nella Relazione generale
Anno N. Permessi di
costruire Volume in m³
(nuova edificazione) Volume in m³
(sostituzione edilizia)
2003 8 1.475,7 10.081,94
2004 13 8.193,99 8.431
2005 6 2.250,33 3.646
2006 58 105.446,4 27.844,6
2007 8 8.943,85 3.241
2008 13 5.313,54 2.098,82
2009 10 5.603,32 835,69
2010 17 4.675,41 4.458,53
Totale 133 141.902,54 60.637,58
142
Nel corso del 2011, infine, sono stati rilasciati permessi di costruire per un totale di 14.250,18 m³ di nuovi volumi e di 2.071,18 m³ di volumi a sostituzione edilizia, saturando (raggiungendo il limite volumetrico ammissibile63) le UTOE 1, 6 e 7, quindi in particolar modo la fascia meridionale del territorio comunale.
63 Per un quadro dettagliato sui limiti allo sviluppo edilizio ed urbanistico è utile consultare l’a rt. 157
delle NTA del RU vigente, la Determina n. 40 del 13/06/2011 e la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 130 del 26/07/2011, scaricabili dal sito internet del Comune
143
È difficile negare che la città e il territorio urbanizzato abbiano costituito fin dall’antichità una rappresentazione particolarmente efficace della distribuzione spaziale del potere, a cui si deve il carattere simbolico che le strutture insediative tendono ad assumere anche nei confronti dell’osservatore più distratto. A. Filpa, M . Talia, Fondamenti di governo del territorio
CONCLUSIONI
Alla base di un qualsiasi processo di pianificazione vi è la necessità di agire all’interno del delicato rapporto tra interessi pubblici e privati. La prevalenza di quale “potere” emerge dall’attività di monitoraggio compiuta? Pur non dimenticando che il lavoro ha esaminato un campionamento territoriale, e non l’intera superficie comunale, si può tuttavia distinguere, nelle dinamiche di trasformazione, una tendenza: gli interventi che definiscono la città pubblica si concretizzano dopo (e tardi) rispetto a quelli della città privata, determinando un cambiamento che si muove con due diverse velocità. In un contesto come quello di Campi Bisenzio (crescita demografica, processi di rilocalizzazione industriale), stretta tra Firenze e Prato, di fronte alle modifiche prodotte dalla materializzazione di interessi privati (la tabella che riassume l’insieme dei permessi di costruire, inserita nel paragrafo 3.3 del presente lavoro, seppur schematica e riferita alle sole volumetrie residenziali, è a tal proposito esplicativa, soprattutto per il periodo “caldo” dell’urbanistica campigiana, antecedente alla terza Variante), si nota l’assenza di alcuni interventi, previsti e di interesse collettivo, pertinenti alla città pubblica (ad esempio, quelli relativi alla messa in sicurezza idraulica). Questa discrepanza influisce, tuttavia, su molte realtà territoriali e amministrative: la situazione di Campi Bisenzio non è singolare. Perché? E’ chiarificante questa osservazione: da un lato […] la ricerca di una relazione più stretta e trasparente tra i soggetti pubblici e i soggetti privati può favorire effettivamente la nascita di un nuovo riformismo urbanistico, al quale affidare una sostanziale correzione delle esternalità negative prodotte dalle leggi di mercato, e una redistribuzione della ricchezza più efficiente in termini economici e più equa sotto il profilo sociale. Ma dall’altro è comunque possibile che nei contesti in cui le istituzioni sono meno consolidate tendano a prevalere gli interessi forti, con la conseguenza di non permettere il bilanciamento della valorizzazione della rendita con il raggiungimento di interessi collettivi64. Ai fini di concludere adeguatamente il percorso intrapreso dal presente lavoro, è necessario, però, condurre anche una breve riflessione che ponga l’attenzione sulla sola attività di monitoraggio, prescindendo dai risultati ottenuti e dalla situazione territoriale a cui è stata applicata.
64 Andrea Filpa, Michele Talia, Fondamenti di governo del territorio. Dal piano di tradizione alle nuove
pratiche urbanistiche, Carocci, Roma, 2009, p. 142
144
Non si può negare, infatti, l’utilità che questa possa avere in un qualsiasi processo di decisione pubblica, perché, in un sistema dinamico come quello pianificatorio, costituisce un significativo strumento di feedback. Può, tuttavia, presentare alcune criticità: intrinseche, poiché pertinenti alla modalità stessa con cui il monitoraggio è realizzato65, o estrinseche, cioè relative all’uso che può venir fatto dei risultati ottenuti. E’ stato ritenuto utile, quindi, approntare, nella forma di un’analisi SWOT66, un’autovalutazione sull’attività di monitoraggio condotta sugli strumenti urbanistici di Campi Bisenzio.
Punti di forza Punti di debolezza - confronto tra le previsioni del piano e la “testimonianza” delle foto aeree - analisi sincronica (tra piani e fotografie) e diacronica (tra piani nel tempo e tra fotografie nel tempo)
- tecnica di semplice concretizzazione
- assenza di un’esatta localizzazione delle trasformazioni quantitative - monitoraggio delle sole trasformazioni territoriali
Opportunità Minacce - possibilità di integrazione/supporto con SIT (Sistemi Informativi Territoriali) e database
- possibilità di estendere l’analisi all’intero territorio comunale
- costruzione di una mera “fotografia” dello stato di fatto - soluzione di continuità tra i risultati
del monitoraggio e i processi decisionali futuri
Dall’analisi emerge quanto già parzialmente affermato all’inizio del Capitolo 3: il sistema di monitoraggio applicato vuole essere una proposta, uno studio che si concede di suggerire alcuni spunti costruttivi per attivare una funzionale attività di controllo; se calato all’interno di un reale processo di pianificazione, necessita di alcune strategie per potenziare i punti di forza, sfruttare le opportunità, eliminare i punti di debolezza ed evitare le minacce: ad esempio, come già indicato nella tabella, sarebbe opportuno, per renderlo effettivamente utile alla formazione degli strumenti urbanistici successivi a quello monitorato (che è in fondo l’obiettivo principale, in assenza del quale il concetto stesso di monitoraggio perde di senso), predisporre un SIT impostato, e nel tempo aggiornato, attraverso i risultati conseguiti dal lavoro attuato.
65 Un’indagine circa le tecniche utilizzate nelle relazioni di monitoraggio dalle Pubbliche Amministrazioni
è stata condotta nel Capitolo 2 del presente lavoro 66 L’analisi SWOT è una tecnica uti le quando si richiede di valutare progetti, strumenti o attività,
situazioni o contesti, all’interno di un processo decisionale: essa evidenzia infatti i punti di forza (Strengths) e di debolezza (Weakness) – fattori interni all’oggetto di valutazione – e le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) – fattori esterni all’oggetto di valutazione
145
BIBLIOGRAFIA Pubblicazioni
• AA.VV., Tra recupero della propria identità e crescita, il comune diventa città: Campi Bisenzio dal 1990 al 2004, Adriano Chini, Campi Bisenzio, 2004
• Roberto Aiazzi, Sandra Baffetti, Stefano Bettini, Campi Bisenzio profilo di un territorio fiorentino (anni 1950 – anni 2000) Trasformazioni strutturali ed immagine della città, NTE, Firenze, 2009
• Lando Bortolotti, Giuseppe De Luca, Come nasce un’area metropolitana. Firenze Prato Pistoia: 1848-2000, Alinea, Firenze, 2000
• Giuseppe Cinà (a cura di), Descrizione fondativa e statuto dei luoghi, Alinea, Firenze, 2000
• Giuseppe De Luca, Marco Gamberini, Toscana. Norme per il governo del territorio, Il Sole-24 Ore Libri, Milano, 2006
• Andrea Filpa, Michele Talia, Fondamenti di governo del territorio. Dal piano di tradizione alle nuove pratiche urbanistiche, Carocci, Roma, 2009
• Alberto Magnaghi, Il progetto locale, Bollati Boringhieri, Torino, 2010 • Saverio Mariotti, L’urbanizzazione della campagna: il caso di Campi Bisenzio
dal 1865 al 1945, Franco Angeli, Milano, 1993 • Alessandro Monti, La terra sul fiume. Storia di Campi dalle origini al
Medioevo, Campi Bisenzio, Edizioni del Comune di Campi Bisenzio, 2003 • Fabrizio Nucci, Debora Pellegrinotti, La miglior genìa. Storia del Novecento di
una cittadina toscana: Campi Bisenzio, Campi Bisenzio, Edizioni del Comune di Campi Bisenzio, 2002
• Emanuele Repetti, Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana, Firenze, 1833-1846
• Francesco Ventura, Statuto dei luoghi e pianificazione, Città Studi, Torino, 2000
Strumentazione urbanistica
• Comune di Borgo a Mozzano, Rapporto sullo stato di avanzamento del Regolamento Urbanistico, gennaio 2010
• Comune di Buti, Relazione di monitoraggio del Regolamento Urbanistico, settembre 2011
• Comune di Campi Bisenzio, Piano Regolatore Generale adottato nel 1971 e approvato nel 1973, e successive Varianti
• Comune di Campi Bisenzio, Piano Regolatore Generale adottato nel 1985 e approvato nel 1988, e successive Varianti
• Comune di Campi Bisenzio, Piano Strutturale adottato nel 2003 e approvato nel 2004, e successive Varianti
• Comune di Campi Bisenzio, Regolamento Urbanistico adottato nel 2004 e approvato nel 2005, e successive Varianti
• Comune di Empoli, Relazione di monitoraggio del Regolamento Urbanistico, aprile 2011
• Comune di Lucca, Relazione di monitoraggio del Regolamento Urbanistico, ottobre 2009
Legislazione
• Decreto Ministeriale 1 aprile 1968, n. 1404 • Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 • Legge Regionale Toscana 16 gennaio 1995, n. 5
146
• Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 • Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 9 febbraio 2007, n. 4/R
Siti internet
• www.archeogr.unisi.it/repetti • www.campi-bisenzio.eu • www.cbaf.it • www.comune.borgoamozzano.lu.it/upload/file/documenti assetto del territorio/monitoraggio carichi R.U/Allegato alla delibera monitoraggio Rapporto.pdf
• www.comune.buti.pi.it/files/relazione_di_monitoraggio_RU_completa_784_2827.pdf
• www.comune.campi-bisenzio.fi.it • www.comune.empoli.fi.it/newsletter/2011/monitoraggioRU.htm • www.comune.lucca.it • www.comune.prato.it/servizicomunali/prg/nuovops/pianificazione/03 • www.consorzioombronebisenzio.it
• www.fi.camcom.it • www.regione.emilia-romagna.it/temi/territorio/cartografia-regionale/vedi-anche/uso-del-suolo/pubblicazioni/Manuale%20fotointerpretazione%20Agea2008.pdf/view
• www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/trasporti/ferrovie/rubriche/piani_progetti/visualizza_as
set.html_882098817.html • www.rete.toscana.it/sett/pta/territorio/pit_2005_2010/allegati_al_pit/mobilita/Estratto_interventi_PianoMobilitaAGG16-07-2007.pdf
• www.urba.unifi.it/docprog/deluca
ALLEGATI A) Tavola di progetto del Piano Strutturale del Comune di Campi Bisenzio; stampa in scala 1:10.000
B) Tavola dell'uso della struttura fisica del territorio del Regolamento Urbanistico originario del Comune di Campi Bisenzio – Nord; stampa in scala non originale (1:7.200)
C) Tavola dell'uso della struttura fisica del territorio del Regolamento Urbanistico originario del Comune di Campi Bisenzio – Sud; stampa in scala non originale (1:7.200)
D) Legenda della Tavola dell'uso della struttura fisica del territorio del Regolamento Urbanistico originario del Comune di Campi Bisenzio
E) Tavola dell'uso della struttura fisica del territorio del Regolamento Urbanistico vigente del Comune di Campi Bisenzio – Nord; stampa in scala
non originale (1:7.200) F) Tavola dell'uso della struttura fisica del territorio del Regolamento Urbanistico vigente del Comune di Campi Bisenzio – Sud; stampa in scala non originale (1:7.200)
G) Legenda della Tavola dell'uso della struttura fisica del territorio del Regolamento Urbanistico vigente del Comune di Campi Bisenzio
H) Tavola 1 – Stato di attuazione dei Piani Attuativi; stampa in scala 1:15.000
147
Si ringraziano per la preziosa collaborazione:
i T ecnici e i Referenti Amministrativi dell’U fficio Urbanistica del Comune di Campi Bisenzio: in particolare, l’Arch. Antonella Bucciarelli, la Sig.ra Grazia Carfagno, la Dott.ssa Donata Troisi, il Geom. Luigi Maggio, il Geom. Michele Puccioni, l’A rch. Anna Bos i il Geom. Franco Pepi e la Sig.ra Simonetta Cappelli dell’U fficio Edilizia Privata del Comune di Campi Bisenzio