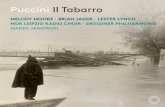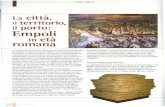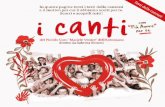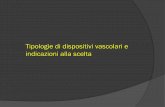Il leone o il serpente: la scelta di Yvain
Transcript of Il leone o il serpente: la scelta di Yvain
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E LETTERARI
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN LETTERE MODERNE
Il leone o il serpente: la scelta di Yvain
Relatore: Prof.ssa Francesca Gambino
Laureanda: Noemi Anna Facchin
Nr. Matr. 1027375
Anno Accademico 2013/2014
Il leone o il serpente: la scelta di Yvain
3
IL LEONE O IL SERPENTE:
LA SCELTA DI YVAIN
A nonna Rosetta
Il leone o il serpente: la scelta di Yvain
5
Indice
1. INTRODUZIONE…………………………………………….. pag. 7
1.1 Chrétien de Troyes e la materia bretone……………………………... pag. 7
1.2 Le opere di Chrétien…………………………………………………...pag. 8
1.2.1 Erec et Enide…………………………………………………………….pag.8
1.2.2 Cligés……………………………………………………………pag. 11
1.2.3 Li chevaliers de la charrete……………………………………...pag. 14
1.2.4 Li contes del graal………………………………………………pag. 15
1.3 Le chevalier au lyeon……………………….………………………....pag. 17
1.3.1 Trama…………………………………………………………....pag.17
1.3.2 Amore e cavalleria………………………………………….........pag.19
1.3.3 Il percorso interiore di Yvain………………………………..…..pag. 19
2. IL LEONE E IL SERPENTE……………………………….. pag. 21
2.1 Il leone………………………………………………………………pag. 21
2.2 Il serpente…………………………………………….……………..pag. 25
2.3 Il Fisiologo e i bestiari del Medioevo……………………………….pag. 28
3. LA SCELTA DI YVAIN……………………………………...pag. 31
4. CONCLUSIONI………………………………...…………….pag. 38
5. BIBLIOGRAFIA……………………………………………...pag. 41
Il leone o il serpente: la scelta di Yvain
7
CAPITOLO PRIMO: INTRODUZIONE
1.1 Chrétien de Troyes e la materia bretone
Se decidessimo di intervistare un gruppo di persone, potremmo rimanere sbalorditi da
quanto, ai giorni nostri, le leggende di Re Artù sono almeno vagamente conosciute.
Probabilmente questo è dovuto alla grande quantità di film e libri che sono stati prodotti
nell’ultimo secolo su queste leggende; ma le storie del ciclo arturiano hanno una
tradizione ben più lunga.
La prima opera che tratta della materia bretone è in prosa latina e si intitola Historia
Regum Britanniae. Scritta da Goffredo di Monmouth, tra il 1135 e il 1137, racconta la
storia del regno britannico dalle origini mitiche al VII secolo. Questo lavoro venne ripreso
da Wace, poeta anglo-normanno, nel Roman de Brut (ovvero Bruto, nipote di Enea e
mitico fondatore del regno dei Bretoni). Il merito proprio di questo autore è di aver
introdotto la materia bretone nella letteratura volgare per la prima volta, riuscendo così a
proporre nel panorama letterario dell’epoca personaggi nuovi rispetto a quelli classici, e
un nuovo canone di valori basato sull’interazione tra amore e cavalleria.
In realtà, l’autore per eccellenza del romanzo cortese arturiano fu il chierico Chrétien de
Troyes. Le poche notizie che si hanno riguardanti questo poeta sono ricavate, soprattutto,
da ciò che lui stesso scrive nei prologhi dei suoi romanzi1. Si può collocare la sua attività
tra gli anni sessanta e la fine degli anni ottanta del XII secolo, e nella corte dei conti di
Troyes, città della Champagne. Questa corte, soprattutto per l’influsso della contessa
Marie de Champagne, ebbe un ruolo primario nella promozione della nascente
produzione letteraria cortese.
Ai fini della prossima lettura dell’Yvain, è utile soffermarsi su due costanti dei romanzi
di Chrétien: l’aventure e il rapporto tra matière e sen.
Il termine aventure deriva da quello latino AD-VENTURA (ʻcose che succederannoʼ),
ma con il passare dei secoli ha assunto il significato di “ciò che bisogna affrontare” fino
ad arrivare ad indicare la serie di prove che un cavaliere deve superare per compiere la
1 Da notare che, nel prologo dell’Erec et Enide, Chrétien de Troyes si presenta come l’autore del romanzo,
distanziando, in questo modo, il suo lavoro da quello dei giullari e dei cantori. Egli stesso, infatti, definisce
la sua operazione “conjointure”, che si può tradurre come ̒ sviluppo e organizzazione organica dei contenuti
del romanzoʼ; diverso, quindi, da una mera riproduzione di leggende conosciute.
Il leone o il serpente: la scelta di Yvain
8
sua missione. Ecco che «Si capisce allora come, da un lato, l’aventure sia il meccanismo
stesso dell’azione narrativa, dall’altro, essa rappresenti il percorso di formazione e
affermazione del protagonista»2.
Il rapporto tra matière e sen, che caratterizza tutte le opere a noi rimaste di Chrétien,
riguarda il valore didascalico che lui stesso conferisce all’opera. La scrittura del romanzo,
perciò, non comporta solamente la creazione di una solida struttura narrativa, ma anche
l’uso del materiale narrativo per trasmettere concetti e ideali prefissati. In particolare, il
fine di Chrétien era dimostrare che le avventure che il cavaliere doveva superare erano
mezzo per raggiungere la perfezione. Ma quand’è che un cavaliere è da considerarsi
perfetto? Nei romanzi di Chrétien questa perfezione viene spesso identificata come il
giusto equilibrio che il cavaliere riesce a mantenere tra amore e cavalleria. Questa
costante è ben evidente nell’Erec et Enide, dove il protagonista si macchia dell’onta di
recreantise (parola glossabile in modo più o meno approssimativo con il termine di
‘vigliaccheria’), in quanto si dedicava molto di più ai doveri verso Amore, rispetto a quelli
verso la cavalleria.
1.2 Le opere di Chrétien
1.2.1 Erec et Enide
Lo schema narrativo di quest’opera è diviso in tre blocchi, caratteristica che consente di
accostarlo a Le chevalier au Lyon. Il primo blocco prevede una felicità provvisoria dovuta
al matrimonio di Erec con Enide. In questa parte del romanzo, infatti, si vede il
protagonista intento a godersi il piacere dell’amore, trascurando, in questo modo, i suoi
doveri di cavaliere. Questa sua negligenza verso la cavalleria gli viene a costare il giudizio
negativo dei suoi compagni. Lo scenario iniziale è la tradizionale caccia al cervo bianco,
nella quale Erec viene offeso dal nano del conte Yder e decide di partecipare alla giostra
dello sparviero bianco, per chiedere riparazione. Lungo la strada che lo portava al suo
risarcimento, conosce Enide, bellissima figlia di un valvassore. Una volta conclusa
vittoriosamente la sfida, decide di sposare la fanciulla di cui si era innamorato. La vita
matrimoniale, però, distoglie il protagonista da quella che era la sua vita di prima, ovvero
2 Brugnolo-Capelli 2011, pag. 67.
Il leone o il serpente: la scelta di Yvain
9
una vita all’insegna di tornei e avventure e, soprattutto, della cavalleria. A causa di questo,
Erec attira su di sé le critiche dei compagni che non condividono la sua scelta di
distaccarsi completamente dalla vita cavalleresca in favore di quella amorosa.
Sono proprio le critiche che segnano l’inizio della seconda parte del romanzo, quella
contraddistinta dalla crisi dell’eroe e dalle avventure di cui si servirà lo stesso per ritornare
ad essere un buon cavaliere. La crisi, però, non coinvolge solamente Erec, ma anche il
rapporto che questo ha con Enide. È lei stessa, infatti, a confidargli le critiche che aveva
sentito dire dagli altri cavalieri contro il suo atteggiamento passivo. Sembra, quindi, quasi
logico che questo cammino per riottenere la perfezione non debba essere percorso
solamente dal protagonista, ma dalla coppia. Le avventure che dovranno affrontare sono
otto: il combattimento prima con tre e poi con cinque cavalieri briganti; lo scontro con il
conte Galoain che si era infatuato di Enide; il duello con re Guivret le Petit (così chiamato
a causa della sua bassa statura); la scaramuccia con Keu, il combattimento contro due
giganti che viene vinto da Erec con un grandissimo dispendio di energie, tanto che l’eroe
perde i sensi e viene creduto morto; il duello con il conte Oringle che vuole condurre
all’altare Enide, credendo morto il protagonista; l’ultima prova vede scontrarsi
nuovamente Erec con Guivret le Petit, duello organizzato all’insaputa dei due.
Una volta che sono state superate tutte le otto prove, inizia la terza, ed ultima, parte del
romanzo, quella che prevede la felicità definitiva con l’incoronazione dell’eroe. Per
approdare a questo lieto fine, però, manca ancora quella prova che, sebbene ultima, è
probabilmente la più significativa: la Joie de la Cort. Erec deve affrontare il possente
cavaliere Maboagrain che è sottomesso agli ordini di una dama non ben identificata di cui
deve custodire il giardino fatato e di cui è ardentemente innamorato. Una volta superata
anche quest’ultima avventura, la coppia viene accolta alla corte di Re Artù trionfalmente
ed Erec succede al padre re Lac, dopo essere stato incoronato da re Artù.
Uno degli aspetti più importanti di questo romanzo, e di cui si è già parlato in precedenza,
è l’innovativo rapporto tra amore e cavalleria. Chrétien, infatti, riesce a far trovare un
accordo tra l’amore totalizzante, che non permette di concentrarsi su nient’altro che non
sia l’oggetto delle proprie attenzioni amorose, e la cavalleria che abbisogna di tutta
l’attenzione del cavaliere su di sé. All’inizio, infatti, Erec riceve le critiche dei suoi
compagni proprio perché si dedica solamente all’amore per Enide. Ciò che può, però,
Il leone o il serpente: la scelta di Yvain
10
realmente sconvolgere il lettore è il fatto che Enide diventi compagna di avventure per
Erec, fatto del tutto eccezionale nel panorama dei romanzi cavallereschi. Questa
eccezione, comunque, testimonia l’importanza della coppia all’interno del testo e mette
in risalto il messaggio che l’autore vuole lasciare a chi lo legge: far comprendere come
amore e cavalleria vadano di pari passo e si completino l’uno con l’altro. Quello che
avviene nell’arco del romanzo è una completa maturazione dell’amore tra i due coniugi.
Infatti, l’amore che i due provano all’inizio del romanzo si potrebbe definire
adolescenziale, ovvero un amore che isola i due amanti in una sorta di locus amoenus e
che li allontana dalla comunità cortese e dalle sue regole. I due protagonisti possono
essere riammessi alla corte di Re Artù dopo aver raggiunto la perfezione, cosa che avviene
raggiunta solamente quando «la coppia è in armonia al suo interno (succederà solo quando
verranno superate le otto prove) e al suo esterno, è cioè equilibrata e organica rispetto alla
società: e questo avviene solo dopo l’ultima e più importante prova, quella della Joie de
la Cort.»3
L’ultima prova, quella della Joie de la Cort, è molto importante per l’organizzazione del
romanzo per molti motivi, tra cui quello di essere l’unica prova volutamente cercata dal
protagonista. L’avversario di Erec è Maboagrain, un cavaliere follemente innamorato
della sua bella che lo ha costretto a custodire il suo giardino fatato, lontano dal mondo,
finché non fosse arrivato un cavaliere capace di sconfiggere il cavaliere stesso e avesse
suonato il corno presente in quel luogo, in modo da sciogliere definitivamente il patto
d’amore tra i due. L’eroe del romanzo riesce a sconfiggere il povero amante e liberarlo
dall’incantesimo che lo sottometteva. Maboagrain riesce, così, a far ritorno alla sua corte,
rendendo tutti gli abitanti di questa molto gioiosi; ecco perché questa avventura si chiama
Joie de la Cort. Si possono notare facilmente le analogie tra il cavaliere soggetto alla
dama fatata e l’Erec della prima parte del romanzo, quello che aveva completamente
dimenticato la cavalleria e trascorreva il suo tempo solamente con la sua amata. È, quindi,
condivisibile quello che hanno scritto Furio Brugnolo e Roberta Capelli nel loro manuale:
«Il cavaliere sconfitto da Erec rappresenta, dunque, una vera e propria personificazione
dell’amore irrazionale, chiuso in un egoistico piacere dei sensi, superato dall’amore
3 Brugnolo-Capelli 2011, pag. 72.
Il leone o il serpente: la scelta di Yvain
11
nobile, aperto al servizio degli altri. Ecco perché il successo di Erec ha una così grande
ricaduta sull’intera corte di Evrain: perché la prova e il suo esito positivo mostrano che
gli effetti dell’agire regolato da sentimento e prodezza dell’eroe hanno un senso non più
solo personale ma collettivo.»4
L’importanza del bene collettivo non è inusuale in Chrétien, tanto che lo si ritroverà anche
ne Le chevalier au lyeon. L’amore è un’arma a doppio taglio: da una parte rischia di
assorbire completamente il cavaliere, distogliendolo dai suoi doveri; dall’altra è fonte di
energia positiva che guida il cavaliere nella sua ricerca di perfezione.
1.2.2 Cligés
Il Cligés inizia con il più classico degli espedienti meta-letterari, ovvero quello di far
credere il lettore che il romanzo sia solamente una trascrittura, o una traduzione, di un
manoscritto trovato per caso. Chrétien decise di fare questo per attribuire una maggiore
autorità alla sua opera, facendo credere che avesse origine da fonti popolari e orali.
Il protagonista della storia è, appunto, Cligés, figlio di Alessandro ed erede al trono
imperiale di Costantinopoli. Nella prima parte del romanzo si trova un flashback nella
quale si spiega la storia di Alessandro e di sua moglie Soredamor, damigella della regina
Ginevra e dove viene spiegato che, a causa della falsa notizia della morte del re, lo zio di
Cligés, Alis, era salito illegalmente al trono. Al ritorno di Alessandro, continuò a rimanere
sul trono Alis, ad un’unica condizione che era quella di non avere alcuna discendenza.
Da qui in poi inizia la storia di Cligés. Alis, lo zio, cede alle insistenze dei baroni e si
sposa con Fenice, bellissima figlia dell’imperatore tedesco. Il cuore di Fenice, però,
apparteneva già ad un altro cavaliere: Cligés. Fenice, quindi, è costretta a sposare lo zio
del suo amato, ma è ben decisa a non concedersi ad un uomo che non ama. Per fare questo,
chiede aiuto alla sua fedele ancella Tessala che le prepara una pozione da far bere al
marito. Questo filtro faceva credere al re Alis di giacere con sua moglie e di godere del
suo amore, cosa che in realtà non avveniva. Non sarà, però, questo l’unica pozione
preparata per i due giovani amanti; anzi, una successiva darà a Fenice una morte apparente
4 Brugnolo-Cappelli 2011, pag. 74.
Il leone o il serpente: la scelta di Yvain
12
e verrà seppellita in una torre fatata dove la raggiungerà Cligés. I due amanti possono,
così, realizzare il loro sogno d’amore. Ma questo non basta per realizzare la loro felicità
perpetua: i due vengono scovati. Grazie, ancora una volta, ad altri stratagemmi di Tessala
riescono a fuggire in Bretagna e a raggiungere la corte di re Artù. La storia dei due
innamorati fa commuovere la corte ed il re fa preparare un esercito per castigare Alis, ma
la morte di quest’ultimo impedisce la realizzazione dei progetti del re. A questo punto
Cligés ed Enide possono far ritorno a Costantinopoli, dove vengono accolti festosamente
e dove il protagonista viene incoronato legittimamente imperatore di Costantinopoli.
Questo romanzo si distingue nettamente dagli altri per la complessità della trama e della
psicologia dei personaggi; ancor di più, viene ampliato lo spazio in cui si svolge l’azione
(dalla Bretagna dove risiede la corte di re Artù, alla Germania dove vivono i grandi
feudatari fino all’ambiente magico e lussuoso dell’Oriente bizantino) e le relazioni tra i
personaggi sono molto più problematiche. Non c’è da stupirsi se con una così maggior
attenzione all’interiorità dell’uomo, vengano trascurate le avventure. Questo non vuol
dire che all’interno del romanzo non siano presenti dei combattimenti, anzi ci sono e
vengono anche vinti valorosamente dal protagonista. Quello che però manca è il fine
morale delle avventure. Si è visto precedentemente nell’Erec et Enide che il protagonista
deve affrontare otto prove per raggiungere la sua perfezione; in realtà le avventure di
Cligés non hanno alcun fine.
Un ruolo fondamentale all’interno del romanzo spetta a Fenice, la bellissima figlia
dell’imperatore tedesco, il cui matrimonio con Alis assomiglia molto a quello di Isotta
con re Marco. È indubbio, infatti, il paragone creato all’interno dell’opera tra la storia di
Tristano e Isotta e quella di Cligés con la sua bella Fenice. Vi sono, infatti, diversi
elementi in comune. Uno di questi può essere che entrambe le coppie non hanno la
possibilità di coronare il loro amore in quanto lei è costretta a sposare lo zio dell’amato.
Un altro esempio è la presenza, in entrambe le storie, di pozioni e filtri magici. Ciò che,
in realtà, distacca nettamente i due romanzi è il comportamento antitetico delle due eroine.
Infatti, se da una parte si trova Isotta che si concede a due uomini, dall’altra si trova Fenice
che si serve di una pozione per non concedersi ad un uomo che non ama. Non si deve
dimenticare, inoltre, che la protagonista decide di donarsi al suo amato solamente dopo
aver bevuto il filtro della morte apparente, ed essere, così, rinata ad una nuova vita. Su
questo Capelli e Brugnolo scrivono:
Il leone o il serpente: la scelta di Yvain
13
«Fenice ricorre al giusto filtro, non d’amore ma di morte (apparente), che la libera dai
vincoli matrimoniali senza averne violate le regole. La ʻrinascitaʼ della protagonista non
può che far pensare all’uccello leggendario che ne porta il nome, la fenice, descritto dai
bestiari medievali come capace di rivivere dalle proprie ceneri; e, se si considera ch’esso
rappresentava, in chiave allegorica, Cristo risorto, non pare del tutto fuori luogo rilevarne
le affinità con il passaggio dell’eroina, vittima di un matrimonio ingiusto, ad una ʻnuova
vitaʼ nella gioia del vero amore.»5
Fenice, quindi, non cede alle lusinghe dell’amore, ma ne rispetta la sacralità. Da una parte,
infatti, non tradisce il compagno impostole finché non trova una soluzione per liberarsi
da quel vincolo, dall’altra continua a rimanere fedele al suo vero amore, non concedendosi
mai al marito. Non si può non pensare che questo parallelismo sottointeso tra le due eroine
sia a favore dell’amata di Cligés, tanto che lei stessa menziona più volte Isotta nel
romanzo, facendo notare come quest’ultima abbia svilito l’amore concedendosi ad un
uomo che non amava. Dalla storia di Cligés, quindi, si può molto ben comprendere quale
fosse il pensiero di Chrétien, tanto che lui stesso, nel prologo del Cligés, si attribuisce
un’opera intitolata ʻre Marco e Isottaʼ: la novità di questa sta nell’incentrare il titolo del
romanzo sulla coppia regale e non su quella fedifraga.
Non si può, quindi, più mettere in dubbio la sacralità che Chrétien attribuisce al
matrimonio. Sempre nel manuale di Brugnolo e Cappelli si trova un’osservazione
interessante riguardo a questo:
«L’amore dei trovatori, così come quello di Tristano e Isotta, è un amore adultero, cui
Chrétien oppone la sacralità e onorabilità del matrimonio, in quanto unione fondata sulla
spontanea reciprocità dei sentimenti, in velata polemica con le politiche dinastiche
dell’epoca, che facevano dei matrimoni un mezzo per acquisire e consolidare
possedimenti territoriali e alleanze militari. Liceità e sincerità dell’unione sono quindi
condizioni necessarie all’amore di Cligés e Fenice per convalidare la gloria futura della
loro discendenza: poiché essi non sono legati da ʻnecessità di Statoʼ (come, invece, è il
5 Brugnolo-Capelli 2011, pag. 77.
Il leone o il serpente: la scelta di Yvain
14
caso di Alis), e non hanno trasgredito il codice della morale e della legge (come Tristano
e Isotta)».6
Non a caso, sia nel romanzo di Erec che in quello di Yvain, opere che dovevano
dimostrare il giusto rapporto tra amore e cavalleria, presentano dei matrimoni liberi da
qualsiasi motivazione legata a terre o domini. Con questo romanzo Chrétien vuole dar
vita ad un nuovo ideale di amore, che «rinnova i fondamenti della fin’amor e rappresenta
una nuova etica amoroso-cortese non più liricamente irrealizzabile come quella
trobadorica, non più illegittimamente realizzata come quella tristaniana, bensì
cavallerescamente praticabile nel rispetto dei valori coniugali, all’interno di un sistema
culturale e morale collettivamente condiviso»7.
1.2.3 Li chevaliers de la charrete
Il romanzo racconta le vicende di due cavalieri, Galvano e Lancillotto, che cercano di
liberare la regina Ginevra. All’inizio del racconto, infatti, si trova il cavaliere Meleagant
che sfida un cavaliere della Tavola Rotonda, che alla fine risulta essere Keu, e la posta in
gioco è la regina stessa. Keu viene sconfitto e Galvano parte alla ricerca di Ginevra.
Durante la sua quête, incontra un cavaliere, il cui nome verrà svelato solo più avanti nel
romanzo. Poco dopo questo incontro, i due trovano lungo il loro cammino una carretta
condotta da un nano. Quest’ultimo è disposto a indicare loro la strada da seguire se fossero
stati disposti a salire sulla carretta; cosa che farà solamente Lancillotto. Da qui in poi
inizia una serie di prove a cui Lancillotto deve sottoporsi come quella prova del letto
interdetto e quella della lancia infiammata. Dopo queste sconfigge un cavaliere,
guardiano di un sentiero; resiste alle offerte amorose della dama del castello del luogo;
interroga le tombe del misterioso cimitero dei cavalieri; libera gli abitanti dal regno di
Gorre fino ad arrivare al Ponte della Spada. Una volta superata quest’ultima prova, riesce
ad accedere al regno del re Baudemagu, padre di Meleagant, e a duellare con quest’ultimo.
Grazie allo sguardo della regina che lo rinvigorisce, Lancillotto riesce a sconfiggere
l’avversario che, però, rinvia il duello. Al contrario di quello che ci si può aspettare,
Ginevra tratta l’eroe con estrema freddezza. A questo punto Lancillotto parte alla ricerca
6 Brugnolo-Capelli 2011, pag. 79. 7 Brugnolo-Capelli 2011, pag. 81.
Il leone o il serpente: la scelta di Yvain
15
di Galvano. Nel frattempo si diffonde la falsa notizia della morte del protagonista, notizia
che fa provare un enorme dolore alla regina; tanto che quando il suo amante fa ritorno gli
consente l’accesso alla sua camera. Poco dopo questo episodio, Meleagant accusa Keu di
aver commesso adulterio con la regina; Lancillotto, quindi, si batte per difendere l’onore
di Ginevra, ma viene catturato e imprigionato, sarà Galvano a condurre Ginevra alla corte
di re Artù. Lancillotto riesce a fuggire per partecipare al torneo di Noauz, ma viene
nuovamente catturato. Solo con l’aiuto della sorella di Meleagant riuscirà a liberarsi e
sconfiggere definitivamente il suo avversario.
L’episodio più famoso e, probabilmente, più importante di tutto il romanzo è quello della
carretta. Nel periodo storico in cui Chrétien scriveva, la carretta era uno degli oggetti più
infamanti, in quanto servivano a trasportare i condannati a morte. Lancillotto sceglie di
salirvi cosciente di perdere la sua fama di cavaliere perfetto, poiché tiene molto di più al
suo amore per Ginevra. Queste decisione, però, permette a Lancillotto l’accesso nel regno
dei morti, ovvero quello del re Baudemagu, e poter, così, salvare Ginevra.
La visione di Chrétien in questo romanzo si sposta tutta a favore dell’amore, la cavalleria
viene completamente superata in importanza dall’amore. L’amore non è edificante come
Nell’Erec et Enide o nell’Yvain, anzi, più Lancillotto evolve dal punto di vista del codice
amoroso, più retrocede nel seguire le regole della perfetta cavalleria. In questo romanzo
Chrétien ha voluto celebrare quell’amore così forte che è pronto a sacrificare tutto per
conquistare l’oggetto del suo desiderio.
1.2.4 Li contes del graal
La trama di quello che si pensa essere l’ultimo romanzo di Chrétien si sviluppa su due
linee: una vede come protagonista Perceval, l’altra si dilunga su Galvano.
Perceval, sebbene faccia parte di un’importante dinastia di cavalieri, cresce nella totale
ignoranza delle arti cavalleresche in quanto la madre lo vuole tenere lontano da questo
mondo; questo perché aveva già perso il marito e due figli. Basta, però, la visione di
cinque cavalieri di Artù nel bosco per far nascere nel protagonista il desiderio di diventare
cavaliere. Presa la decisione, quindi, parte verso la corte di re Artù, lasciando la madre
sofferente che si accascia a terra. Le prime azioni di Perceval sono dettate dall’ingenuità
e dall’ignoranza delle norme cavalleresche. Sarà il nobile Gornemant de Goort ad istruirlo
Il leone o il serpente: la scelta di Yvain
16
su come essere un cavaliere degno del suo Ordine. La prima avventura dopo essere stato
istruito è la liberazione dall’assedio del castello di Beaurepaire, dove si innamora di
Biancofiore, la castellana. La seconda vede il protagonista soggiornare nel maniero del
Re Pescatore, uomo molto ammalato. In questo contesto, assiste alla processione della
lancia stillante sangue e del graal, senza fare alcuna domanda. Incontra, di seguito, una
sua cugina che lo rimprovera per non aver fatto alcuna domanda riguardo la processione;
se avesse domandato informazioni riguardo a ciò che vedeva, sarebbe riuscito a guarire il
Re Pescatore. Rimanendo in silenzio, ha dimostrato la stessa insensibilità di cui aveva
dato prova andandosene da casa senza soccorrere la madre accasciata a terra. Perceval fa
ritorno alla corte di re Artù dove arriva una fanciulla orrenda che, prima, maledice il conte
del graal, poi invita i cavalieri a duellare con i più scelti soldati del Castello Orgoglioso e
liberare la fanciulla rinchiusa a Montesclaire. Mentre gli altri cavalieri accettano la sfida,
Perceval comincia a vagare senza pace alla ricerca della lancia e del graal. Da una parte
si trova Galvano impegnato in continue peripezie, dall’altra Peceval che in cinque anni
compie mirabili imprese. Le imprese di Perceval, però, non vedono in alcun modo la
presenza di Dio nel suo cammino. È così che un venerdì santo incontra un gruppo di
penitenti e prende coscienza della sua misera condotta. Decide quindi di andare a
confessarsi da un eremita, che scopre essere suo zio. L’eremita educa il cavaliere ai
misteri profondi della fede, che da questo momento in poi guideranno il suo cammino.
Da qui il romanzo si sposta verso le peripezie di Galvano. Il romanzo è rimasto
incompleto, alcuni studiosi pensano questo che possa essere dovuto alla morte dell’autore
stesso.
La compresenza di due trame all’interno dello stesso romanzo ha creato diverse
discussioni tra gli studiosi. Alcuni hanno supposto che il lavoro di Chrétien finisca col
sopraggiungere della parte dedicata a Galvano; altri credono che le due parti
appartenessero a due romanzi diversi, unite da una seconda persona solo dopo la morte
di Chrétien. In realtà, diversi aspetti strutturali e narrativi presenti in quest’ultimo
romanzo si trovano già nei precedenti, sebbene in forma embrionale. Inoltre, è piuttosto
evidente che le storie di Galvano fungano in qualche modo «da contraltare a quelle di
Perceval, che delineano invece un progressivo percorso di formazione e di educazione
Il leone o il serpente: la scelta di Yvain
17
spirituale, e rappresentano un modello di cavalleria da superare, un mondo in cui i valori
vengono, sia pure con discrezione, messi in discussione.»8
È doveroso soffermarsi brevemente sul graal, il cui mito ha inizio con questo romanzo.
Proprio da quest’opera, infatti, viene attribuita una misteriosa sacralità al graal (così viene
nominato questo recipiente, il cui nome viene ripreso dal latino GRADALEM che
significa ʻvassoioʼ) senza aver ancora alcuna implicazione religiosa. Saranno le opere
letterarie successive che definiranno per bene del mito, anche perché da questa ne
possiamo trarre davvero poche informazioni, anche solo una descrizione fisica dettagliata
ci è negata. Ciò che è contenuto all’interno del graal è un’ostia che tiene in vita il re
spirituale del Re Pescatore. Questo elemento getta le basi per la trasformazione dal graal,
oggetto magico profano, al Graal, oggetto sacro e vera reliquia da venerare.
1.3. Le chevalier au lyeon
1.3.1 Trama
La trama dell’Yvain può essere scomposta in tre blocchi narrativi. Il primo rappresenta la
felicità provvisoria raggiunta da Yvain, ma che lui stesso non riesce a mantenere. Lo
scenario iniziale di tutta la storia è la corte di re Artù, dove si sono radunati i cavalieri
della Tavola Rotonda per celebrare una ricorrenza molto presente nei romanzi
cavallereschi: la pentecoste. In questa occasione Calogrenant, cavaliere e cugino di
Yvain, decide di raccontare la sua avventura alla fonte miracolosa, dove venne sconfitto
da un cavaliere dall’armatura rossa. Il re, sentita la storia, decise di recarsi con la corte
alla fonte. Il protagonista decise di avviarsi verso la fonte prima del resto della corte, così
da avere la possibilità di battersi prima di tutti. Durante il viaggio incontra un valvassore
molto gentile che lo accoglie in casa insieme alla sua bellissima figlia, e, di seguito, un
essere molto strano, che nella tradizione si identifica con il signore degli animali, e che
indica a Yvain la strada per arrivare alla fonte. Una volta arrivato alla fonte, compie gli
stessi gesti che aveva compiuto la prima volta Carlogrenant, così da scatenare una
tempesta, terminata la quale arriva al galoppo Esclados, il cavaliere dall’armatura rossa.
Tra i due inizia un combattimento molto duro, tanto sono valorosi i due cavalieri, finché
8 Brugnolo-Capelli 2011, pag. 101-102.
Il leone o il serpente: la scelta di Yvain
18
Yvain riesce ad assestare all’avversario un colpo molto violento. Esclados è così costretto
a ritirarsi dal duello e comincia a galoppare verso il suo castello, inseguito dal
protagonista. Yvain riesce ad entrare al castello al seguito dell’avversario, ma dietro di
lui si chiude una porta-ghigliottina che taglia a metà il suo cavallo e gli trancia gli speroni.
In questo modo, Yvain si ritrova chiuso dentro una stanza, senza alcuna possibilità di
scappare. In suo soccorso, però, arriva Lunete, damigella della dama del castello, che si
ricordava delle cortesie che Yvain stesso le aveva rivolto e decide di aiutarlo. Per farlo
gli consegna un anello che conferisce il dono dell’invisibilità a chi lo indossa; così, una
volta che gli abitanti del castello entrano nella stanza per cercare Yvain, non riescono a
trovarlo. L’aiuto di Lunete, però, non si ferma a questo. Dalle finestre della stanza, infatti,
Yvain vede la moglie del cavaliere che aveva ucciso e se ne innamora follemente. La
damigella, quindi, si serve della fiducia che la sua dama pone in lei per far avvicinare
Yvain alla sua amata, Laudine. Questa, dapprima, si oppone a questo amore, ma dopo si
lascia convincere e i due si sposano, con il consenso del resto della corte. Poco dopo il
loro matrimonio, sopraggiunge la corte di re Artù alla fonte. Yvain va loro incontro,
sconfigge Keu e invita loro a dimorare nel suo castello. Dopo vari giorni di
festeggiamenti, Yvain viene invitato da Gauvain a seguirlo per affrontare nuove imprese.
Il cavaliere del leone, per paura di macchiarsi dell’onta di recreantise, decide di partire
alla ricerca di avventure insieme ai suoi compagni una volta ottenuto il permesso della
consorte di stare lontano per il tempo massimo di un anno.
La seconda sezione del romanzo vede la rottura del patto d’amore tra Yvain e Laudine,
in quanto il protagonista non ha fatto ritorno al castello nel tempo promesso alla consorte.
Quando il cavaliere si accorge della sua colpa, non riesce a sopportare il peso della
vergogna e diventa folle9. Dopo questo periodo di incoscienza (che può essere interpretato
come la morte del vecchio Yvain), il protagonista viene fatto rinsavire da un’ancella
mandata dalla dama di Noroison (al contrario, questo episodio può essere inteso come la
rinascita). Da questo momento in poi e, soprattutto, da dopo l’incontro con il leone nella
foresta, inizia la serie di avventure che il cavaliere del leone affronta e che testimoniano
il cammino interiore che egli stesso sta compiendo per essere nuovamente degno
9 La follia di Yvain acquisisce le caratteristiche già conosciute nell’Ercole furioso (come il vagare nudi
per il bosco o il mangiare carne cruda), e che verranno poi riprese in opere successive come l’Orlando
furioso.
Il leone o il serpente: la scelta di Yvain
19
dell’amore della sua amata. L’incontro con il leone è l’evento centrale di tutto il romanzo,
e da questo momento in poi il leone diventa il compagno di avventure di Yvain. Le
avventure che Yvain deve affrontare sono quattro: salva Lunete, condannata al rogo
ingiustamente; vince Arpino della Montagna, un terribile gigante; si batte con Galvano
per risolvere la diatriba tra le sorelle di Nera Spina e sconfigge i due fratelli demoni nel
castello di Mala Ventura per liberare le operaie schiavizzate.
L’ultimo blocco narrativo è costituito dal perdono concesso da Laudine e la conseguente
felicità definitiva, dovuta anche al fatto che ormai Yvain può considerarsi un cavaliere
quasi perfetto. A completare questo quadro di armonia e stabilità troviamo una struttura
narrativa a cerchio, in quanto il romanzo si conclude con il trasferimento dei due coniugi
dalla fonte miracolosa alla corte di Re Artù, luogo da dove tutto ha inizio.
1.3.2 Amore e cavalleria
Come si è già detto in precedenza, osservando lo schema narrativo del Chevalier au lyeon,
e confrontandolo con quello dell’Erec et Enide, possiamo notare che la disposizione delle
sequenze è identica. In entrambi i romanzi, difatti, troviamo il matrimonio all’inizio della
narrazione, la crisi al centro e il ricongiungimento dei due coniugi alla fine. Ciò che
cambia, invece, è il percorso interiore svolto dal cavaliere. Infatti, mentre Erec dopo il
matrimonio rimane legato ai piaceri di amore, e trascura i suoi doveri di cavaliere, Yvain
si allontana dalla moglie proprio per paura di essere accusato di recreantise. La crisi
iniziale dei due romanzi, perciò, sfocia da due atteggiamenti opposti ed estremi all’interno
di quell’equilibrio, di cui abbiamo già accennato prima, tra amore e cavalleria. Chrétien,
quindi, critica entrambi i cavalieri, mettendo così allo stesso livello i valori cavallereschi
e quelli dell’amore. Ecco, allora, che riuscire a riconquistare il favore della propria amata
diventa anche mezzo per diventare un perfetto cavaliere.
1.3.3 Il percorso interiore di Yvain
Una volta rinsavito dalla pazzia, quindi, qual è il modo per riottenere la fiducia di
Laudine? Il cammino di Yvain verso questo nuovo traguardo interiore è segnato da due
fattori: l’umiltà e le donne.
Il primo è caratterizzato dalla perdita del nome: il cavaliere non si fa più chiamare con il
proprio nome, che tutti conoscevano, ma si fa chiamare «Le chevalier au lyeon». La
Il leone o il serpente: la scelta di Yvain
20
perdita del nome è la perdita dell’orgoglio che caratterizzava il protagonista nella prima
parte del romanzo, e che lo rendeva ancora imperfetto10. La scelta di non far conoscere
alla corte di Re Artù le sue imprese, vuol dire escludere ogni secondo fine personale da
quello che si sta facendo e mettere la propria forza veramente al servizio dei più deboli11.
Il secondo fattore può ricordare lontanamente la legge del contrappasso che caratterizza
la Divina Commedia: poiché Yvain ha tradito la fiducia della propria dama, così, per poter
riottenere il suo favore, dovrà andare in soccorso di tutte le fanciulle che ne avranno
bisogno. Si può notare, infatti, l’asimmetria tra le imprese compiute prima della pazzia e
quelle compiute dopo. Le prime non vedono beneficio per alcuno, se non per l’orgoglio
e la fama del cavaliere stesso; le seconde hanno come fine il soccorso di una o più donne
(si pensi alla dama di Noroison, all’avventura nel castello di Mala Ventura o alla
liberazione di Lunete).
10 La perfezione di cui si parla è diversa da quella totale che può raggiungere solamente chi riesce a
conquistare il Santo Graal. 11 Si ricorda che all’inizio del romanzo Yvain parte da solo alla ricerca della fonte miracolosa pur di poter
affrontare quell’avventura ed essere lui stesso a salvare il cugino dall’onta.
Il leone o il serpente: la scelta di Yvain
21
CAPITOLO SECONDO: IL LEONE E IL SERPENTE
2.1 Il leone
«Cominceremo parlando del leone, il re degli animali.»12
Questo è l’incipit con cui si apre la sezione del Fisiologo riguardante il leone. Nell’epoca
attuale non stupisce che il leone sia menzionato come re degli animali, in quanto questa
lunga tradizione è ancora ben presente (si pensi anche solo al film di animazione Il Re
Leone della Disney, o alle Cronache di Narnia di Lewis, dove il leone, addirittura, ha il
ruolo di un dio creatore). Al contrario di quello che si potrebbe pensare, però, la corona
del regno animale non è sempre appartenuta al leone.
Sfogliando la Bibbia si può notare come il leone sia un animale che compare molto
frequentemente, accompagnato da un’aura di potenza e di coraggio, cosa che rende lui un
animale molto difficile da sconfiggere. In generale, però, la figura del leone è considerata
piuttosto negativamente, dall’Antico Testamento fino ai Padri della Chiesa. Nell’Antico
Testamento il leone rappresenta i nemici d’Israele, i malvagi, i tiranni, qualcosa da cui
Dio doveva proteggere l’uomo, come recita il Salmo 22 “Salvami dalla bocca dei leoni”.
La maggior parte dei Padri della Chiesa vedono nelle sue fauci l’orrido dell’inferno e la
lotta contro questo animale corrisponde alla lotta contro Satana.
Contemporaneamente a questo leone cattivo esiste un leone buono, le cui caratteristiche
sono il coraggio, la generosità, la potenza, la regalità e a cui vengono paragonati tutti i re
e gli eroi dotati di forza eccezionale. Vi sono due passi nella Bibbia molto importanti, e
legati tra loro, dove compare il leone come figura positiva. Il primo si trova nel libro della
Genesi, ed è il passo da cui nasce l’immagine del leone della tribù di Giuda13: Giacobbe
benedice Giuda e tutta la sua discendenza, da cui nasceranno re Davide e il Messia. Dio,
infatti, aveva promesso ad Abramo e a Giacobbe che avrebbe fatto nascere un re dalla
loro stirpe, e Giacobbe sancisce che ciò avvenga nella discendenza di Giuda, figlio degno
di questo onore.
12 Zambon 2011, pag. 39. 13Questa immagine, nell’Apocalisse, verrà attribuita a Cristo.
Il leone o il serpente: la scelta di Yvain
22
«Giuda, figlio mio, sei come un giovane leone
che ha ucciso la sua preda e torna nella tana.
Come una leonessa sdraiata e accovacciata:
chi oserà farti alzare?
Lo scettro rimarrà nella casa di Giuda,
il bastone di comando non le sarà mai tolto
finché verrà colui al quale appartiene:
a lui saranno sottoposti tutti i popoli.»14
Il leone, quindi, in questo caso è l’animale scelto a cui paragonare il capostipite della
dinastia a cui apparterà Gesù (questa immagine del leone di Giuda sarà molto presente in
futuro, tanto da essere citata nel Fisiologo stesso).
Il secondo passo, invece, appartiene all’Apocalisse, ed è un richiamo diretto al brano che
abbiamo appena citato: Giovanni ha la visione di un libro chiuso da sette sigilli e di un
angelo che domanda chi sia la persona degna ad aprire il libro. L’apostolo è colto dalla
disperazione, in quanto crede non si sia alcun vivente e non meritevole di aprire il libro.
«Ma uno degli anziani mi disse: “Non piangere. Colui che si chiama “Leone della tribù
di Giuda” e “Germoglio di Davide” ha vinto la sua battaglia e può aprire il libro e i suoi
sette sigilli”.»15
Ecco che il leone ha una valenza ancora maggiore di quella vista prima: viene a
rappresentare lo stesso Gesù. Da questo momento in poi, sebbene il suo cammino sarà
comunque ostacolato, come detto prima, da una parte dai Padri della Chiesa, il leone
comincia la sua ascesa all’interno della gerarchia animale, in quanto simbolo di Cristo. I
bestiari, infatti, sia latini che volgari, che sono stati scritti in questo periodo si dilungano
nella descrizione di questo animale e lo definiscono “rex bestiarum” (re delle bestie
selvatiche), se non già “rex animalium” (re degli animali).
Spostando lo sguardo verso il mondo greco, ci si può soffermare sulle favole di Esopo.
Qui il leone compare quasi sempre come il re degli animali. Questa qualità, però, non gli
14 Genesi, 49, 9-10. 15 Apocalisse, 5, 5.
Il leone o il serpente: la scelta di Yvain
23
garantisce di comparire sempre come figura positiva: i leoni che compaiono nelle favole
possono essere dei buoni re, come nella favola Il leone e il suo regno, oppure figurare
come esseri arroganti e presuntuosi, come ne Il leone e la zanzara. In sostanza, se da una
parte in queste favole il ruolo del leone non è messo in dubbio, dall’altra deve essere il
leone stesso a rendersi degno della sua regalità.
Nonostante questo inizio turbolento, a partire dall’anno Mille circa il leone comincia ad
acquisire una connotazione completamente positiva e a salire definitivamente sul trono
del regno animale, sottraendolo all’orso. Si tenga presente che il leone era un animale
piuttosto conosciuto nel mondo occidentale di quell’epoca, in quanto non erano rari i
serragli di bestie feroci che giravano di fiera in fiera e le sue raffigurazioni erano molto
presenti nelle chiese, negli stemmi, finanche nelle miniature dei libri.
Dal punto di vista letterario, il Roman de Renart può rappresentare molto fedelmente
quale fosse la gerarchia animale nell’Alto Medioevo. In questi poemi, infatti, vengono
raccontate le gesta di un cavaliere d’eccezione, ovvero Renart, una volpe caratterizzata
da una formidabile furbizia. La società animale in cui sono ambientate queste vicende
ricalca quella umana; infatti si trovano: l’orso (castellano e messaggero del re), l’asino
(l’arciprete), la scimmia (il buffone) e via di seguito. A capo di questa società vi è il leone
Noble, re «maestoso, fiero, giusto, generoso ma anche ingenuo»16. Ecco che ancora una
volta il leone compare sul trono e, in questo caso, sebbene sia accusabile di ingenuità,
figura come un giusto e la sua unica debolezza non gli conferisce una patina negativa.
Esiste un’altra situazione dove il leone dimostra la sua supremazia: nelle raffigurazioni
dell’episodio biblico dell’Arca di Noè. Come è ovvio che sia, le rappresentazioni
pittoriche di questa narrazione non possono mostrare tutte le coppie delle specie animali
viventi; proprio per questo motivo è interessante notare la scelta dei pittori attraverso i
secoli e le culture, poiché la preferenza di una specie animale rispetto ad un’altra «è
specchio del sistema di valori, di pensiero, di conoscenze e classificazioni zoologiche che
sono differenti e si diversificano a seconda del tempo, delle regioni e della società»17.
Come osserva bene Pastoreau, nel suo libro Animali celebri: «Nel medioevo, ad esempio,
nelle rappresentazioni dell’arca che galleggia sulle acque del diluvio, gli animali non sono
16 Pastoureau 2014, pag. 90. 17 Pastoureau 2014, pag. 17.
Il leone o il serpente: la scelta di Yvain
24
sempre raffigurati. Ma quando sono presenti – cioè quattro volte su cinque – il leone c’è
sempre»18. Sempre nello stesso libro, l’autore commenta le raffigurazioni dell’ingresso
degli animali nell’arca, o dell’uscita, sottolineando il fatto che molto spesso, se non
sempre, è il leone ad aprire la fila degli animali, come è giusto che sia per il re degli
animali. Anche queste rappresentazioni dell’arca, quindi, ci confermano che il leone,
durante il Medioevo, ha perso completamente la connotazione negativa.
Analizzando il Fisiologo, opera a cui si rifanno tutti i bestiari medievali, si possono notare
tre caratteristiche grazie alle quali il leone viene paragonato a Cristo.
«La sua prima natura è questa: quando vaga e passeggia per la montagna e gli giunge
l’odore dei cacciatori, con la coda cancella le proprie impronte, affinché i cacciatori,
seguendole, non trovino la sua tana e lo catturino. Così anche il Cristo nostro, il leone
spirituale vittorioso, della tribù di Giuda, della radice di Davide, inviato dal Padre
invisibile, ha nascosto le sue impronte spirituali, cioè la sua divinità. […]
Seconda natura del leone. Quando il leone dorme nella tana, i suoi occhi vegliano: infatti
rimangono aperti. […] Così anche il corpo del Signore mio dorme sulla croce, ma la sua
natura divina veglia alla destra del Padre […]
Terza natura del leone. Quando la leonessa genera il suo piccolo, lo genera morto, e
custodisce il figlio, finché il terzo giorno giungerà il padre, gli soffierà sul volto e lo
desterà. Così anche il Dio nostro onnipotente, il Padre di tutte le cose, il terzo giorno ha
risuscitato dai morti il suo Figlio, primogenito di tutte le creature, il Signore nostro Gesù
Cristo, affinché salvasse il genere umano smarrito. Bene quindi ha detto Giacobbe: “Si è
sdraiato e ha dormito come un leone e come un leoncino: chi lo desterà?”»19
In alcuni bestiari medievali il leone compare anche come nemico della scimmia che era
conosciuta come una creatura del male, diabolica. Si è quindi certi che per gli uomini del
Medioevo il leone simboleggiasse Cristo (si pensi anche a tutte la raffigurazioni presenti
nelle chiese). Ciò che ci si potrebbe domandare è come l’uomo medievale abbia gestito il
fatto che nella Bibbia il leone non sempre compaia positivamente, anzi. Tra il secolo XI
e XII nei bestiari vediamo comparire un alter ego del leone positivo, ma che acquisisce
18 Pastoureau 2014, pag 17-18. 19 Zambon 2011, pag. 39-40.
Il leone o il serpente: la scelta di Yvain
25
tutte le caratteristiche negative del leone che compaiono nella Bibbia e negli scritti dei
Padri della Chiesa. Questa sorta di surrogato del leone è il leopardo; è, quindi, certo che
all’epoca in cui Chrétien de Troyes scrisse Le chevalier au lyeon il leone figurasse come
re degli animali e immagine di Cristo.
2.2 Il serpente
«Il serpente era più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio, il Signore, aveva fatto»20
Si è visto prima che il leone ha una storia molto travagliata prima di diventare immagine
di Cristo. Il serpente, invece, è un animale che ha avuto una forte simbologia negativa e
demoniaca dalla Genesi fino ancora ai giorni nostri. La categoria dei serpenti nei bestiari
medievali non è omogenea, ma quasi sempre compaiono sotto questo nome l’aspide, la
vipera e la biscia. Il re dei serpenti è il basilisco, mentre il serpente più forte rimane il
drago. La vipera figura come la più furba e crudele21 e il Fisiologo la paragona ai farisei,
in quanto «allo stesso modo in cui la vipera uccide il padre e la madre, anch’essi hanno
ucciso i loro padri spirituali, i profeti, e il Signor nostro Gesù Cristo e la Chiesa»22.
Nella sezione del Fisiologo dedicata al serpente vengono elencate quattro nature di
quest’ultimo, e da cui si possono trarre degli insegnamenti per l’uomo.
«Seconda natura del serpente. Quando il serpente va alla fonte a ber dell’acqua, non porta
con sé il veleno, ma lo depone nella propria tana.………………………………… Così
anche noi, quando accorriamo all’acqua perenne e pura, che è piena delle parole celesti e
20 Genesi, 3, 1. 21 Probabilmente questa crudeltà le viene attribuita a causa di una credenza che vedeva la femmina
mozzare il capo al compagno durante l’accoppiamento e i cuccioli uccidere la madre non appena venuti al
mondo. 22 Zambon 2011, pag. 49.
Il leone o il serpente: la scelta di Yvain
26
divine, non dobbiamo portare con noi nella Chiesa di Dio il veleno della malvagità, ma
dobbiamo completamente espellerlo da noi stessi e accostarci puri. …
Terza natura del serpente. Quando vede un uomo nudo, ha paura e fugge via; se invece lo
vede vestito, gli balza addosso. …………………………………………………………
Anche noi consideriamo spiritualmente come, quando il nostro padre Adamo era nudo
nel paradiso, il demonio non ha potuto assalirlo. Perciò se anche tu hai l’abito dell’uomo
vecchio, cioè le foglie di fico del piacere, per essere invecchiato nei giorni malvagi, il
demonio ti balza addosso.»23
Si osservi che nella seconda natura sembra che il male attribuito al serpente risieda
soprattutto nel suo veleno, non vi è quindi una condanna totale dell’animale, ma il veleno
che ha in corpo lo rende cattivo. Così anche l’uomo non è un essere malvagio di per sé,
ma è il peccato la sua rovina e ciò da cui si deve tenere ben lontano. La terza, invece,
dimostra proprio come il serpente sia associato a Satana: il serpente non attacca un uomo
nudo, così come Satana non ha attaccato Adamo se non quando si è vestito.
Non si può non tener conto, comunque, che la storia dell’uomo occidentale inizia con la
Genesi biblica e con il peccato originale. In questo episodio il serpente ha il ruolo
fondamentale del corruttore, di colui che grazie alla sua furbizia è riuscito a fare in modo
che Eva e Adamo andassero contro il volere di Dio. Il mandante, o il colpevole reale è
Satana stesso, il serpente è l’animale attraverso il quale si compie il male. Questo compito
costa al serpente la maledizione da parte di Dio:
«Allora Dio, il Signore, disse al serpente: “Per quel che hai fatto tu porterai questa
maledizione fra tutti gli animali e fra tutte le bestie selvatiche: Striscerai sul tuo ventre e
mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. Metterò inimicizia fra te e la donna, fra la
tua e la sua discendenza. Questa discendenza ti colpirà al capo e tu la colpirai al
calcagno”.»24
23 Zambon 2011, pag. 49-50. 24 Genesi, 3, 14-15.
Il leone o il serpente: la scelta di Yvain
27
È Dio stesso a sancire la malvagità di questo animale e a renderlo nemico della donna e
quindi dell’uomo. Si noti che, come la figura del leone di Giuda della Genesi è stata poi
ripresa nell’Apocalisse, anche il serpente viene richiamato con il segno del drago.
«Un altro segno apparve nel cielo: un drago enorme, rosso fuoco con sette teste e dieci
corna. […] Poi scoppiò una guerra nel cielo: da una parte Michele e i suoi angeli, dall’altra
il drago e i suoi angeli. Ma questi furono sconfitti, e non ci fu più posto per loro nel cielo,
e il drago fu scaraventato fuori. Il grande drago, cioè il serpente antico, che si chiama
Diavolo e Satana, ed è il seduttore del mondo, fu gettato sulla terra, e anche i suoi angeli
furono gettati giù.»25
Il serpente antico è Satana, il seduttore. In questo passo dell’Apocalisse compare anche
la figura di una donna che dovrebbe simboleggiare, a seconda delle letture che se ne
fanno, la Vergine Maria o la Chiesa. Comunque sia, l’inimicizia tra la donna e il drago è
quella annunciata nella maledizione di Dio al serpente. Non a caso, molto spesso le
raffigurazioni di “Maria Immacolata” e di alcuni santi prevedono un serpente schiacciato
dai piedi di quest’ultimi: è la sconfitta del male e del peccato.
Tornando nell’ambiente medievale, più precisamente negli scritti di un chierico come
Chrétien de Troyes, non si può non considerare tutto questo bagaglio di simbologie che
questi due animali portano con loro. Quando Chrétien, nel suo romanzo, pone Yvain
davanti alla scelta se salvare un leone o un serpente non lo fa senza tenere conto delle
simbologie. Inoltre, questa decisione diventa molto importante nelle dinamiche del
romanzo, in quanto, in un romanzo cavalleresco, il leone e il serpente possono significare
la forza ferina26 del cavaliere; a lui la scelta se assumere una forza cristologica o una forza
demoniaca.
25 Apocalisse, 12, 1-10. 26 Con “forza ferina” alcuni studiosi intendono quella forza più nascosta e istintiva dei cavalieri che
emerge solo in particolari situazioni, e che è simile alla forza bruta degli animali feroci.
Il leone o il serpente: la scelta di Yvain
28
2.3 Il Fisiologo e i bestiari del Medioevo
Vista l’importanza che ebbe il Fisiologo per i bestiari medievali, è importare dedicare
dello spazio a quest’opera, padre dei bestiari. Purtroppo, di questo non sono certe né il
luogo né la datazione né, soprattutto, l’autore. Nell’introduzione alla sua edizione critica,
Francesco Zambon spiega che le ipotesi sull’origine di quest’opera indicano le località
tra l’Egitto e la Siria, mentre l’epoca oscilla tra il II e il IV secolo. Specifica, inoltre, che,
in base ad alcuni riferimenti storici e dottrinari, è possibile essere più specifici all’interno
di quella supposizione e credere che l’opera sia stata composta tra la fine del II secolo e
la prima metà del III secolo ad Alessandria. L’ipotesi del luogo di origine viene condivisa
anche dall’enciclopedia Treccani, anche se la datazione viene fatta coincidere con il II
secolo. Entrambi, comunque, non riescono a dare alcuna informazione sull’autore.
Come si era già accennato, il Fisiologo ebbe una larghissima diffusione. Infatti, già dal V
secolo d.C. il testo greco venne tradotto in etiopico, in armeno, in siriaco, in latino, e altre
lingue. La prima redazione greca dell’opera subì diverse trasformazioni; ad esempio, la
versione latina vede l’inserimento di altri testi scientifici dell’antichità. Queste evoluzioni
dell’opera vedono due linee guida opposte: quella latina e quella dei bestiari romanzi. La
prima prevede una classificazione degli animali sempre più rigorosa e scientifica che apre
la strada ai moderni studi di zoologia; la seconda, invece, mostra ad una sempre più
ricercata rielaborazione moralistica o letteraria. Basti pensare che «si ebbero ʻbestiariʼ
dedicati ai vizi e alle virtù, alla preparazione spirituale dell’anima, alla Vergine, e così di
seguito: notissimi sono poi i ʻbestiari d’amoreʼ, ove le proprietà degli animali sono
addirittura convocate a illustrare il discorso della seduzione amorosa».27
Nel corso degli studi sul Fisiologo si è posta spesso la domanda se l’impostazione
dell’opera fosse più prettamente scientifica, o più allegorica. La seconda delle due è
l’opinione più condivisa dagli studiosi, in quanto i codici che appartengono alla tradizione
e che sono privi di questi aspetti moralizzanti, sebbene in un primo momento si credette
appartenessero ad una fase più antica, in realtà si è, in seguito, scoperto che si trattavano
di riassunti dell’opera stessa. Non si tiene, poi, conto del significato reale del termine
ʻfisiologiaʼ nei primi secoli dopo Cristo. Nell’ambito laico questo termine disegnava
l’allegoria; mentre in quello Cristiano, come ben definisce Clemente Alessandrino negli
27 Zambon 2011, pag. 19.
Il leone o il serpente: la scelta di Yvain
29
Stromati, è quel processo per il quale dall’osservazione degli elementi del cosmo ci si
innalza alla contemplazione del divino. È quindi indiscutibile l’apporto moralizzante di
quest’opera, più specificamente di una morale cristiana.
Come si è già accennato in precedenza, i bestiari romanzi del Medioevo, che si basano
molto spesso sul Fisiologo stesso, lasciano largo spazio alla classificazione morale degli
animali. Interessante è la definizione che Michel Pastoureau dà di ʻbestiariʼ nel suo libro
Bestiari del Medioevo:
«Quegli strani ʻlibri di animaliʼ che parlano delle diverse specie zoologiche non tanto per
descriverle oggettivamente e ancor meno per studiarle in maniera scientifica, ma piuttosto
per trarne significati morali e religiosi. Non sono trattati di storia naturale, almeno non
nel senso comune del termine, ma opere che parlano degli animali per meglio parlare di
Dio, di Cristo, della Vergine, a volte dei santi, e soprattutto del diavolo, dei demoni e dei
peccatori. Se si soffermano sulle ̒ proprietàʼ delle bestie e sulle meraviglie delle loro varie
ʻnatureʼ, non è per dissetare della loro anatomia, etologia o biologia, ma per celebrare la
Creazione e il Creatore, per trasmettere le verità della fede, per invitare i fedeli a
emendarsi.»28
Più avanti, sempre nello stesso libro, l’autore precisa che nel Medioevo la verità veniva
ricercata molto più nella metafisica che nella fisica. Si può, quindi, intuire che nell’epoca
contemporanea a Chrétien gli animali venivano considerati molto di più per quello che
simboleggiavano che per quello che, in realtà, erano. L’attendibilità scientifica di quello
che veniva scritto nei bestiari non importava, l’importante era che gli animali fossero
mezzo per comunicare le verità della fede.
La presenza del pensiero cristiano, all’interno del Fisiologo, fa sorgere, allo stesso tempo,
delle problematiche, in quanto nel testo si possono riscontrare alcuni elementi che
possono far parte di alcune correnti eretiche, come quelle gnostiche, simoniane o ofite.
Riguardo a questo, Francesco Zambon crede che non sia propriamente corretto credere
28 Pastoureau 2012, pag. 6.
Il leone o il serpente: la scelta di Yvain
30
che l’autore sconosciuto del Fisiologo aderisca a queste eresie in quanto da una parte
questi riferimenti non sono, tutto sommato, numerosi e dall’altra vi si può spesso trovare
esortazioni all’unità all’interno della Chiesa e all’obbedienza verso la stessa.
« Il Fisiologo ha detto del leone che ha tre nature »29
Molti capitoli del Fisiologo presentano questa frase per introdurre l’argomento. In tutto
il libro compare questa figura misteriosa, senza alcun riferimento concreto. In realtà il
fisiologo non è altro che l’alter ego cristiano dei maghi ellenistici; ovvero quelle figure a
cui vengono rivelati i segreti della natura. Francesco Zambon, inoltre, sempre
nell’introduzione alla sua edizione critica del Fisiologo, fa riflettere sul fatto che, in realtà,
il primo fisiologo in assoluto è Adamo, in quanto «nella sua originaria nominazione degli
animali, in cui ciascuno di essi, come dice Filone, ebbe un nome «interamente rivelatore»
delle sue occulte proprietà, offrì una sorta di paragdimma perfetto al ʻbestiarioʼ»30
CAPITOLO TERZO: LA SCELTA DI YVAIN
29 Zambon 2011, pag. 39. 30 Zambon 2011, pag. 25-26.
Il leone o il serpente: la scelta di Yvain
31
«Et li lyons lez lui costoie
Que ja mes ne s’an partira,
Toz jorz mes avoec lui ira
Que servir et garder le vialt»31
Il passo appena citato sancisce l’inizio della relazione di amicizia tra il leone e il cavaliere.
L’importanza di questo episodio è sancita anche dalla posizione di questo avvenimento
all’interno del romanzo: la vicenda si trova sia a metà degli eventi narrati, sia a metà del
numero di versi. Se si tiene conto che il leone compare anche nel titolo, non si può non
pensare che Chrétien conferisse al leone un ruolo decisamente importante e in modo del
tutto consapevole.
Si è accennato, alla fine del secondo capitolo, alla forza ferina del cavaliere; Zimmer
riguardo a questo dice:
«Il leone inarticolato, forza vitale bruta nel suo aspetto più maestoso e generoso,
rappresenta, come il cavallo meraviglioso della storia di Conn-eda, il principio guida
intuitivo che conduce l’eroe alla sfera della potenza soprannaturale, che è a un tempo al
di sopra e al di sotto del piano sociale. La perfetta coscienza umana del cavaliere, unita
all’istinto subumano e sovraumano del re degli animali, si dimostra più forte persino del
titano della foresta, e prevale là dove l’umana cavalleria avrebbe mancato di sagacia e di
forza.»32
Yvain senza il leone non è completo, la sua forza non è alla massima potenza. Il leone
non è un semplice compagno, ma è la guida che lo conduce nel suo percorso alla ricerca
della perfezione, per poter essere riammesso alla corte di Laudine. Non a caso, il
comportamento di Yvain durante la sua pazzia è molto simile a quello del leone:
31Gambino 2011, pag 312 (v. 3414-3417). 32 Zimmer 1983, pag. 142.
Il leone o il serpente: la scelta di Yvain
32
«Tant com il fu an cele rage
Que aucune beste salvage
Ne li aportast a son huis.
Iceste vie mena puis,
Et li boens hom s’antremetoit
De l’escorchier, et si metoit
Asez de la venison cuire;
Et li peins, et l’eve en la buire
Estoit toz jorz a la fenestre
Por l’ome forsené repestre;
S’avoit a mangier et a boivre
Venison sans sel et sanz poivre
Et aigue froide de fontainne.» 33
«In seguito non passarono otto giorni,
per tutto il tempo in cui fu pazzo,
che non portasse al suo uscio
una qualche bestia selvaggia.
Questa era la vita che conduceva,
e il buon uomo si occupava
di scuoiare la pelle, e di mettere
buona parte della cacciagione a
………………………… cuocere;
e il pane e l’acqua nell’orcio
erano ogni giorno alla finestra
per nutrire il forsennato;
aveva così da mangiare e da bere,
cacciagione senza sale e senza pepe
e acqua fresca di fonte.»
«Qant ocis l’ot, si le gita
Sor son dos, et si l’en porta
Tant que devant son seignor vint,
Qui puis an grant chierté le tint
Por la grant amor qu’an lui ot.
Ja fu pres de nuit, se li plot
Qu’ilueques se herbergeroit
Et le chevrel escorcheroit
Tant com il en voldroit mangier.
Lors le comance a escorchier;
Le cuir li fant desus le coste,
De la longe un lardé li oste;
«Dopo averlo ucciso, se lo caricò
sul dorso e andò a portarlo
davanti al suo signore,
che da allora sentì per lui molto affetto
per il grande amore che gli mostrava.
Era già quasi notte, e dunque decise
di sostare in quel posto,
e di scuoiare il capriolo
per mangiarne a sazietà.
Cominciò dunque a scuoiarlo:
gli fendette la pelle sul fianco,
e gli levò un pezzo di carne dal lombo;
33 Gambino 2011, pag. 274 (v. 2871-2883)
Il leone o il serpente: la scelta di Yvain
33
Et tret le feu d’un chaillot bis,
Si l’a de busche sesche espris;
Puis mist en une broche an rost
Son lardé cuire au feu mout tost;
Sel rostist tant que il fu cuiz.
Mes del mangier ne fu deduiz
Qu’il n’i ot pein ne vin ne sel,
Ne nape, ne coutel, ne el»34
fece sprigionare il fuoco da una selce,
lo appicò a della legna secca,
poi mise il suo pezzo di carne
su uno spiedo ad arrostire sul fuoco;
lo fece arrostire finché fu cotto,
ma non ebbe piacere a mangiarlo,
perché non aveva pane, vino, sale,
tovaglia, coltello né null’altro.»
La corrispondenza del comportamento di Yvain da folle con quelle di una bestia selvatica
era già stata accennata, ciò che può, però, stupire di questi due passi è che il folle si
comporta esattamente come il leone si comporterà più tardi con lui. Nel momento in cui
Yvain perde la ragione segue unicamente il suo istinto ferino, che, in questo caso, coincide
completamente con quello del leone. Si noti, anche, che sia il leone che Yvain ringraziano
i propri benefattori portando loro della selvaggina.
Per il protagonista la pazzia ha rappresentato la morte dell’uomo vecchio, ed ora che è
rinsavito ha l’occasione di poter rimediare al suo errore ed elevarsi ad un livello più alto.
Ecco allora che, quando Yvain si trova davanti alla scelta se aiutare un serpente o un
leone, sta in realtà scegliendo tra una forza demoniaca e una cristologica. Non a caso, la
prima avventura che affronta Yvain dopo essere stato aiutato dalla dama di Noroison, e
averla aiutata a sua volta, è proprio questa. Quello che avviene quando trova i due animali
che lottano e sceglie di aiutare il leone, dopo essere rinsavito, è, in realtà, una sorta di rito
di iniziazione, o meglio, di battesimo. Dopo essere rinato Yvain ha deciso di percorrere
un cammino di vita che l’avrebbe riportato dalla sua signora; infatti, quando la dama di
Noroison lo prega, insieme a tutta la sua corte, di rimanere e di sposarla lui rifiuta.
Avrebbe potuto passare il resto della sua vita in quella corte servito e onorato come il
migliore cavaliere del mondo, ma sarebbe stato lo stesso errore che aveva già compiuto
34 Gambino 2011, pag. 314-316 (v. 3451-3470).
Il leone o il serpente: la scelta di Yvain
34
nella prima parte del romanzo. Inoltre, la sua scelta sarebbe stata contraddistinta, ancora
una volta, dall’orgoglio. Probabilmente è proprio grazie al superamento di questa prova
che gli viene concessa la seconda, ovvero quella di trovare il leone e il serpente nella
foresta. Solo un cavaliere valoroso e coraggioso come Yvain poteva decidere di fermarsi
davanti a quella scena e soccorrere l’animale più meritevole, e, soprattutto, simbolo di
Cristo. Da questo momento in poi può cominciare il cammino interiore di Yvain, guidato
dal leone (ovvero, riprendendo Zimmer, l’animale guida), portavoce del Signore.
Si è già visto in precedenza come la storia di Yvain possa essere paragonata a quella di
Erec, in quanto entrambi dovranno compiere un cammino interiore per riuscire a
comprendere il giusto equilibrio tra amore e cavalleria. Vi è, però, nella storia di Yvain
un elemento in più: la presenza di un marito che lo ha preceduto nell’amare Laudine.
Questo personaggio incarna totalmente la figura del guardiano della sorgente, che deve
essere sempre presente per poter proteggere la fonte, e alla cui morte deve essere
prontamente sostituito, così da non lasciare mai la sorgente incustodita. Questo, in realtà,
fa di Laudine una fata, più precisamente la fata della sorgente. Se ci si sofferma, infatti, a
guardare il comportamento di Laudine dopo la morte di Esclados, si può notare quanto
sia diverso da quello che ci aspetterebbe da una donna che ha appena perso il marito.
Zimmer dice:
«Se la contessa, la Dama della Fontana, fosse stata un essere umano, un io, una personalità
che reagisse alle situazioni in quanto individuo, sarebbe stato giusto che si abbandonasse
alla disperazione del lutto personale che le era stato inflitto dalla morte del suo consorte.
Avrebbe potuto rinunciare alla vita e alle gioie della femminilità e dell’amore. Ma, in
quanto fatata signora della Fontana della Vita, essa non è altro che la cieca forza vitale
incarnata; non può ritirarsi. E secondo il costume del Castello della Vita, essa e l’eroe che
ha ucciso il suo precedente marito, il predecessore dell’eroe stesso, si appartengono. Il
legame che li unisce è il defunto Cavaliere Nero. La Signora è stata conquistata dal
Cavaliere Nero, e il Cavaliere Nero da Ivano. […] Il sangue del vecchio sacerdote ucciso,
stillante dalle mani del suo sacro uccisore, era l’unguento iniziatico che consacrava
quest’ultimo nell’ufficio sacro del servitore ritualmente giustiziato.»
Il leone o il serpente: la scelta di Yvain
35
Yvain, quindi, è degno di essere il sacerdote della Fonte, poiché è riuscito a sconfiggere
il guardiano precedente; ma questo non basta. Egli non ha raggiunto ancora la perfetta
cavalleria, tanto da commettere il grave errore di lasciare la sorgente incustodita per più
di un anno. È giusto soffermarci, però, su un passo riguardante il marito precedente di
Laudine:
« Tant i fui que j’oï venir
Chevaliers, ce me fu avis;
Bien cuidai que il fussent dis,
Tel noise et tel bruit demenoit
Uns seus chevaliers qui venoit.
Qant ge la vi tot seul venant,
Mon cheval restraing maintenant,
N’a monter demore ne fis;
Et cil, come mautalentis,
Vint plus tost c’uns alerions,
Fiers par sanblant come lions. »35
« Rimasi assorto finché udii venire,
così mi parve, dei cavalieri;
pensai che fossero dieci,
tanto rumore e fracasso faceva,
sopraggiungendo, un solo cavaliere.
Quando lo vidi arrivare solo,
strinsi subito le cinghie del mio cavallo
e mi affrettai a montare in sella;
lui, con fare minaccioso,
giunse più rapido di un alerione,
feroce come un leone. »
Esclados viene paragonato ad un leone e così anche Yvain, che nel combattimento riesce
a sconfiggere il cavaliere, assume i connotati positivi della metafora con il leone. Già in
questo passaggio viene preannunciato quel rapporto speciale che Yvain avrà con il suo
compagno, ma questa coincidenza può anche, in qualche modo, far pensare ad una sorta
di ciclicità. Si può pensare, infatti, che per essere degni protettori della sorgente è
necessario essere come dei leoni, e, quindi, essere come Cristo. Non si dimentichi che le
avventure che seguono l’incontro del re degli animali e del cavaliere quasi perfetto sono
all’insegna del soccorso alle donne indifese e bisognose del loro aiuto. Questa
caratteristica delle loro imprese segue una logica completamente cristiana che vede un
Dio capace si immolarsi per gli esseri umani e sempre pronto ad aiutare i più deboli. Lo
35 Gambino 2011, pag. 90 (v. 476-486).
Il leone o il serpente: la scelta di Yvain
36
scenario della fonte, poi, richiama totalmente il battesimo cristiano, assicurando, così, la
presenza di Dio nel contesto del mondo fairies.
Un aspetto che non si è ancora visto del rapporto tra il cavaliere e il suo leone è quello
dei duelli. In un primo momento, infatti, quando si vede intervenire il leone, si può
pensare che questo avvantaggi Yvain, rendendo, così, il combattimento scorretto. La
realtà è, invece, ben diversa. L’intervento del leone serve a ristabilire un equilibrio che
prima mancava, portando i duelli ad essere, nuovamente, caratterizzati dalle regole della
cavalleria. Il primo duello, infatti, vede Yvain scontrarsi con il gigante Harpins de la
Montaigne, ovvero un essere che ha in sé la forza di più uomini. È normale, quindi, che
Yvain non possa farcela da solo e l’aiuto del leone, oltre a essere giusto, è anche essenziale
ai fini della vittoria. Il secondo duello è quello con il siniscalco e i suoi due fratelli, che
Yvain combatte per poter liberare Lunete; mentre il terzo è quello al castello di Pessima
Avventura, che ha come fine la liberazione delle trecento giovani operaie e che vede
Yvain scontrarsi contro due demoni. Se il primo può sembrare ancora uno scontro alla
pari, il secondo e il terzo, senza il leone, sono palesemente squilibrati, tanto che la cosa è
commentata da Chrétien stesso. Nello scontro contro il siniscalco, infatti, il leone non
obbedisce all’ordine di Yvain e uccide il siniscalco; fatto questo lo scrittore dice: «Or sont
el chanp tot per a per», ovvero «ora erano pari sul campo». A conferma della correttezza
degli interventi del leone si trova il combattimento tra Yvain e Gauvain. In questo caso
lo scontro è pienamente alla pari, tanto che nessuno dei due viene sconfitto, ma entrambi
dichiarano l’altro vincitore. Questo duello vede scendere in campo due dei più valorosi
cavalieri esistiti al mondo, esempi di una perfetta cavalleria, per cui il leone non aveva
alcun motivo di soccorrere il suo signore. Non a caso, l’animale fa la sua comparsa
maestosa solo quando è stata fatta giustizia nella contesa tra le due sorelle e, in quel
momento, Yvain presenta il leone dicendo che ognuno dei due appartiene all’altro.
Un ultimo aspetto particolare che si vuole far notare, riguardo i duelli, è l’invocazione a
Dio. Come nota bene J. Harris nel suo saggio The rôle of the lion in Chrétien de Troyes’
Yvain, questo è un elemento che non compare in nessun altro romanzo dell’autore.
Questo, probabilmente, può essere giustificato dall’importante tematica della giustizia
che compare nei duelli. Si è visto prima che il leone instaura nuovamente un equilibrio
cavalleresco tra le forze in gioco e che il fine del combattimento non è più la fame e
l’orgoglio personale ma il soccorso degli esseri più deboli. Questo contesto di giustizia,
Il leone o il serpente: la scelta di Yvain
37
quindi, non può che essere sottolineato dall’invocazione a Dio, affinché possa proteggere
il cavaliere che combatte in nome della giustizia:
«Et totes les dames ansanble
Qui la dameisele mout ainment
Damedeu mout sovant reclainment
Et si li prïent de boen cuer
Que sofrir ne vuelle a nul fuer
Que cil i soit morz ne conquis
Qui por li s’est an painne mis.
De priere aïde li font
Les dames, qu’autres bastons n’ont.” 36
«E tutte le nobildonne insieme,
che amavano molto la fanciulla,
continuavano a invocare Dio
e lo pregavano con tutto il cuore
di non permettere a nessun costo
che fosse ucciso o vinto
chi s’era messo in pericolo per lei.
Le dame, che non avevano altre armi,
lo aiutavano con le preghiere.»
Si potrebbe anche dire che l’intervento del leone sia in qualche modo richiesto da queste
preghiere: il leone, simbolo di Cristo, guida del cavaliere e portatore di giustizia interviene
nei duelli come aiuto divino. Questa lettura è confermata dal fatto che ne La Queste del
Saint Graal l’autore dice esplicitamente che il leone è stato mandato a Yvain da Dio.
36 Gambino 2011, pag. 392 (v. 4512-4520)
Il leone o il serpente: la scelta di Yvain
38
CAPITOLO QUARTO: CONCLUSIONI
«Del Chevalier au lyeon fine
Crestïens son romans ensi.
N’onques plus conter n’en oï
Ne ja plus n’en orroiz conter
S’an n’i vialt mançonge ajoster.»37
Nell’Yvain, Chrétien conclude la storia affermando: “Chrétien termina così il suo
romanzo/sul cavaliere del leone”, sfruttando, così, anche questa via per sottolineare la
centralità di questo animale all’interno del romanzo. Già da questo elemento si può capire
che il leone non è un semplice animale da compagnia, come può sembrare dai primi versi
quando porta il cibo o obbedisce ad ogni comando di Yvain, come fosse un fedele cane
da caccia. Il leone è l’animale-guida, è il compagno che aiuterà Yvain a superare molte
prove, ad affrontare tante avventure e, soprattutto, a compiere il suo cammino interiore
verso la perfetta cavalleria.
Per comprendere a fondo le vicende de Il cavaliere del leone, non bisogna trascurare la
simbologia dei due animali che lottano nella foresta: il leone e il serpente. Si è visto nel
secondo capitolo come il leone abbia avuto un’evoluzione positiva nel corso dei secoli,
diventando simbolo di Cristo. Al contrario, il serpente ha mantenuto una connotazione
negativa e demoniaca dalla Genesi sino ancora ai nostri giorni. La valenza cristologica
del re degli animali viene confermata dal comportamento del leone stesso nel romanzo.
Il leone, infatti, è portatore di giustizia negli scontri che Yvain deve affrontare, ed è guida
nel suo cammino. Questa presenza di Dio all’interno del romanzo, simboleggiata dalla
presenza del leone, è supportata dalle invocazioni a Dio prima dei duelli e dal fatto che
nel La Queste del Saint Graal viene esplicitamente detto che il leone è stato mandato a
Yvain da Dio.
Non si dimentichi il rapporto tra matiere e sen che caratterizza le opere di Chrétien. Il
fine dell’autore non si conclude nel presentare bene una storia, ma nel trasmettere un
37 Gambino 2011, pag. 558 (v. 6816-6820).
Il leone o il serpente: la scelta di Yvain
39
insegnamento con questa. Se si tiene conto, poi, che Chrétien era un chierico, si può ben
comprendere come tutta la simbologia cristiana sia presente in questo romanzo. Si può,
quindi, dire che, raccontando ai suoi lettori il cammino interiore di Yvain, l’autore abbia
voluto mostrare un percorso positivo e guidato dal leone, simbolo di Dio.
Si può infine dire che l’incontro di Yvain con il leone e il serpente non sia stata affatto
una casualità, al contrario, è stato un vero e proprio rito di iniziazione. Yvain, appena
rinato, si vede comparire due animali rappresentanti due forze completamente opposte:
uno quella del male e l’altro quella del bene. La sua scelta non si limita a quella di quale
animale salvare, ma quale compagno avere durante il suo percorso, e sceglie l’animale
nobile, generoso contro l’animale forte, furbo ma anche meschino. La sua è stata una
decisione molto importante, in quanto il leone sarebbe diventato il suo compagno per il
resto della sua vita, come guida nel suo cammino. Allo stesso tempo, però, non si può
dimenticare il peso che la simbologia di questi due animali ha su questo rito di iniziazione.
Come si è visto prima, nel secondo capitolo, i due animali nel Medioevo finirono per
simboleggiare, in qualche modo, il bene e il male. Se poniamo questa simbologia su
un’ottica più cristiana, come può ben essere per il chierico Chrétien, allora la scelta fu, in
realtà, tra Dio e Satana. Non può essere, allora, così sbagliato pensare alla scelta di Yvain
come il suo secondo battesimo cristiano. Con la pazzia era morto l’uomo vecchio e
orgoglioso che non vedeva altro fine nella vita che il raggiungimento della fama di buon
cavaliere. Non che fosse una persona meschina come il cavaliere Keu, la sua fama si
fondava, comunque, su ciò che lui effettivamente era. Questo, però, non bastava per fare
di lui un cavaliere realmente degno ad essere il guardiano della fontana. Essere a servizio
degli altri senza alcun fine per sé stesso è ciò che lo ha reso migliore.38 Anche l’impresa
più strabiliante precedente la pazzia, quella contro Esclados, non è affatto positiva come
quelle che verranno dopo. Esclados, che nel romanzo compare come una figura
complessivamente forte coraggiosa e buona, viene sfidato da Yvain per una mera
questione di onore e viene ucciso; è quindi un avventura che vede morire un buon
cavaliere senza portare un reale beneficio per nessuno, solo morte.
38 Si ricordi la diversità dei duelli: quelli precedenti la pazzia sono duelli, gare e all’insegna del successo
personale; quelli successivi, invece, vedevano il cavaliere soccorrere i più deboli.
Il leone o il serpente: la scelta di Yvain
40
Si può, quindi, concludere dicendo che Le chevalier au lyeon è un romanzo cavalleresco
che racconta il percorso formativo del protagonista, guidato dal suo leone. Questo animale
non è un semplice compagno, ma una guida mandata da Dio stesso e scelta da Yvain nella
foresta. Quello che avviene nella foresta è una sorta di battesimo dove Yvain accoglie la
presenza di Dio nella sua vita. Da questo momento inizia il cammino di Yvain per
raggiungere la perfezione e poter essere nuovamente ammesso alla corte della dama della
Fontana. Questo percorso vedrà Yvain diventare un vero cavaliere, difensore dei più
deboli e sarà sotto l’insegna della Cristianità.
Il leone o il serpente: la scelta di Yvain
41
BIBLIOGRAFIA
Esopo
Esopo, Favole di Esopo, introduzione di Giorgio Manganelli e traduzione di
Elena Ceva Valla, Milano, Rizzoli, 1992.
Furio Brugnolo e Roberta Capelli
Furio Brugnolo e Roberta Capelli, Profilo delle letterature romanze
medievali¸ Roma, Carocci editore, 2011.
Francesca Gambino
Chrétien de Troyes, Il cavaliere del leone, a cura di Francesca Gambino, con
un'introduzione di Lucilla Spetia, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2011 ("Gli
orsatti", 33).
Michel Pastoureau
Michel Pastoureau, Animali celebri. Mito e realtà, Firenze, Milano, 2010;
rist. Firenze, Milano, 2014.
Michel Pastoureau, Bestiari del Medioevo, Torino, Giulio Einaudi editore,
2012.
Il leone o il serpente: la scelta di Yvain
42
Nicolò Suffi
Parola del Signore, La Bibbia, traduzione interconfessionale in lingua
corrente con fotografie a colori e note, a cura di Nicolò Suffi con la
collaborazione di Cherubino M. Guzzetti per la traduzione dall’inglese per il
materiale aggiunto, di Bartolino Bartolini e Severino Fabris per la ricerca
delle foto, di Ottavio Davico e Enrico Pollet per l’impaginazione, Torino Elle
Di CI, Roma, Alleanza Biblica Universale, 1985.
Treccani
Treccani.it L’enciclopedia Italiana, consultabile all’indirizzo
www.treccani.it. Data ultima consultazione 29/07/14.
Francesco Zambon
Il Fisiologo, a cura di Francesco Zambon, Milano, Adelphi, sesta edizione:
marzo 2011 (“Piccola Biblioteca”, 22), pag. 39.
Heinrich Zimmer
Heinrich Zimmer, Il re e il cadavere – Storie della vittoria dell’anima sul
male, Milano, 1983; rist. Milano, 2011.