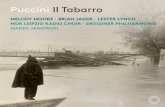«Albinelli? Il grande malato è il centro storico» - La Pressa
Il Gruppodel Cilento
Transcript of Il Gruppodel Cilento
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL SANNIO
Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
Corso di laurea triennale in
“Scienze Geologiche”
A.A. 2010/2011
Esame di
“Geologia Stratigrafica”
“Gruppo del Cilento”
Il Cilento
Il Cilento è una porzione montuosa della Campania che si protende come una
penisola tra i golfi di Salerno e di Policastro, nella zona meridionale della regione,
dichiarato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità.
Il territorio del Cilento è individuato dai paesi delimitati a est dal Fiume Alento,
insieme con buona parte della provincia costiera ed interna meridionale di Salerno.
Si estende precisamente ad Ovest dell’arco appenninico campano-lucano.
Nel Cilento è possibile distinguere due complessi litologici differenti. Il primo è
costituito da terreni prevalentemente argillosi e calcaro-marnosi, deformati e
metamorfosati, che costituiscono la Formazione delle Crete Nere di età Eocene
medio-Burdigaliano ( Unità Liguridi ). Il secondo da una successione silico-clastica,
comprendente la Formazione di Pollica e di San Mauro ( Flysch del Cilento ), di età
mesozoico-terziaria.
Carta geologica in scala 1:100.000
Il Foglio 198 “Vallo della Lucania”(I.S.P.R.A.) mostra tre differenti serie di terreni:
una serie calcarea (Serie carbonatica), costituita dai sedimenti di piattaforma intra-
oceanica; una serie flyschoide (Serie del flysch del Cilento) con sedimenti torbiditici
di eugeosinclinale; una serie di transizione (Serie del M.Bulgheria) tra la piattaforma
carbonatica e il bacino del flysch.
I depositi del flysch del Cilento sono in sovrapposizione tettonica sia sui terreni di
piattaforma, sia su quelli di transizione.
Formazione di Pollica
Giorno 8 Giugno 2011
Ora 12:06
Località Ogliastro Marina (Comune di Castellabate SA)
-Posizione sulla carta topografica: punto P13
-Flysch del Cilento: Formazione di Pollica
1)Membro inferiore
Giacitura degli strati: 300-28 NS
Siamo di fronte al prodotto di un “flusso torbiditico”, che si è depositato formando
una grossa conoide sottomarina.
Si tratta di arenarie siltiti e argilliti siltose. Le arenarie sono per lo più gradate, a
grana molto fine con scarsa matrice e con cemento prevalentemente siliceo,
organizzate in strati alternativamente medi e sottili, con uno spessore che va da 5 a
10 cm. Troviamo anche arenarie a grana media in strati spessi fino a 50 cm.
E’ possibile osservare un’esigua percentuale di argilla nelle rocce del membro
inferiore, da cui si capisce che ci troviamo nella coda della conoide.
Si tratta della parte basale della Formazione di Pollica, che si presenta notevolmente
tettonizzata, con frequenti pieghe a zig-zag (pieghe kink). Si osserva anche
l’intrusione di minerali, quali ad esempio le miche, che provengono da frammenti
litici di altra natura litologica. La potenza del membro inferiore è di circa 200 m.
Le strutture sedimentarie che troviamo nell’affioramento sono diverse:
-laminazione parallela, che ci dice che gli strati si sono deformati dopo la diagenesi
precoce;
-laminazione piegata, che ci dice che gli stati si sono deformati durante la diagenesi
precoce;
-ci sono evidenti segni di fratturazione che è avvenuta dopo la diagenesi precoce:
Clay chips
Flute casts
- ripple marks, che ci
consentono di dedurre la
direzione della corrente NE;
-flute casts, che ci dicono
che la successione è diritta
e non rovesciata;
-clay chips, cioè “fiocchi di
argilla”: sono fori di sabbia
all’interno dei quali si è
litificata una certa quantità
di argilla.
Giorno 8 Giugno 2011
Ora 14:35
Località Ogliastro Marina (Comune di Castellabate SA)
-Posizione: spiaggia
-Formazione Pollica: Membro inferiore
Troviamo strati intercalati da strati e banchi di arenaria a grana fine, gradati e con
scarsa matrice; sono presenti ciottoli di argilla.
Si osserva la presenza di strutture da carico.
Giacitura degli strati 040 NE 30 SW
Giorno 8 Giugno 2011
Ora 16:00
Località Ogliastro Marina (Comune di Castellabate SA)
-Posizione sulla carta topografica: Tempa Rossa (fronte strada)
-Flysch del Cilento: Formazione di Pollica
2)Membro superiore
Si tratta del membro più alto della Formazione di Pollica. La sua potenza è di circa
600m.
Troviamo arenarie a grana grossa e media con scarsa matrice insieme con ciottoli
di argilla siltosa. Gli strati di base sono più sottili (pochi cm) e regolari, mentre gli
strati superiori sono più doppi e arricciati. I banchi più grossi (150cm) hanno molto
spesso una geometria lenticolare: tali strati si chiudono a lente quando il canale si
riempie durante la deposizione.
Nella zona di Ascea e anche in quella di Monte Sacro il membro superiore della
formazione di Pollica è caratterizzato esclusivamente da conglomerati a matrice
arenacea, ben stratificati e con ciottoli di rocce ignee, metamorfiche e sedimentarie.
La Formazione di Pollica è datata al Cenomaniano-Eocene inferiore.
Sono frequenti fenomeni di frane intraformazionali in corrispondenza di grosse
granulometrie (“slumping”).
Col termine slumping si intende un movimento laterale di sedimenti incoerenti che
accade in corrispondenza di deboli scarpate o strati orizzontali su depositi.
I fenomeni di “slumping” sono avvenuti durante la diagenesi precoce: il fatto che gli
strati sono arricciati è una testimonianza di questo evento.
Ci spostiamo dalla parte prossimale a quella distale della conoide : il membro di
base della Formazione di Pollica , più fine, si è depositato nella zona più distante
dall’area di origine della torbida; mentre il membro superiore si è depositato nella
parte più vicina a dove ha avuto inizio la torbida.
Formazione delle Crete Nere
Giorno 08 Giugno 2011
Ora 18:00
Località Ascea marina (SA)
-Posizione: spiaggia
-Formazione Crete Nere
Nell’affioramento si riscontra la presenza di argilloscisti neri abbastanza doppi, a
cui si alternano livelletti calcaro-marnosi caratterizzati da una grana fine, con uno
spessore di 5-10cm e di colore grigiastro.
Le rocce si presentano molto deformate e metamorfosate: si osservano infatti
numerose micropieghe e fratture di vario genere. La mancanza di apporti grossolani
fa supporre che queste rocce si siano depositate in un ambiente di bacino
profondo. La Formazione delle Crete Nere è di età Eocene e precede dunque , nella
sequenza cronostratigrafica, il Flysch del Cilento (Miocene) da cui si separa tramite
“unconformity”.
Formazione di San Mauro
Giorno 09 Giugno 2011
Ora 10:50
Località Tempa Rosalia (Comune di Novi Velia SA)
-Posizione sulla carta topografica: quota 1650m s.l.m.
-Flysch del Cilento: Formazione di San Mauro
La Formazione di San Mauro, come quella di Pollica, è costituita da due differenti
membri: un membro inferiore costituito da una successione arenaceo-marnosa; un
membro superiore costituito da una successione arenaceo-conglomeratica.
Si tratta di un deposito torbiditico.
Abbiamo osservato per primo il membro inferiore contraddistinto dall’alternanza di
marne e marne siltose con arenarie, siltiti e siltiti argillose organizzate in strati e
banchi. Sui livelli marnosi di potenza di 50m si rinvengono conglomerati a matrice
arenaceo-siltosa non stratificati, calcilutiti silicifere, diaspri neri e marne rossastre.
Si rinviene la presenza di selce, indicativa del fatto che si tratta di un deposito che
si è sedimentato in un ambiente di mare profondo. Per ragioni tettoniche il membro
si è poi sollevato.
Si riscontra la presenza di cosiddetti “olistostromi”, cioè megastrati: frane
sottomarine hanno messo in posto strati di arenarie molto sottili e strati di arenarie
più grossolane, che sono del tutto estranei al bacino di sedimentazione del Flysch
del Cilento e che si sono mescolati con gli strati sottostanti, formando megastrati.
Gli olistostromi sono rappresentati da successioni stratificate di calcilutiti con selce
nera, diaspri varicolori, marne e argille rosso-verdi.
E’ possibile osservare nei campioni di rocce laminazioni diverse a seconda dei
processi che si sono verificati:
-le laminazioni parallele indicano che le rocce sono state deformate quando la
diagenesi era ormai conclusa;
-le lamine piegate indicano che le deformazioni sono cominciate quando gli strati si
stavano formando.
Strati arenaceo-marnosi, marne e marne siltose di colore grigiastro della
Formazione di San Mauro.
La Formazione di San Mauro precede nella successione crono-stratigrafica la
Formazione di Monte Sacro più giovane. Le due unità sono separate da una
superficie di discontinuità (Unconformity).
All’interno dei calcari marnosi si sono rinvenuti frammenti di orbulina che fanno
presupporre che ci sia stato un lasso di tempo in cui la sedimentazione e la
diagenesi abbiano avuto un momento di stasi (Serravalliano).
La Formazione di San Mauro è attribuita al Eocene-Miocene inferiore.
Formazione di Monte Sacro
Giorno 09 Giugno 2011
Ora 14:35
Località Monte Sacro o Gelbison (Comune di Novi Velia SA)
-Posizione sulla carta topografica: quota 1706m s.l.m.
-Formazione di Monte Sacro
Si tratta di un deposito torbiditico messo in posto da un “debris flow”.
E’ costituito quasi esclusivamente da materiale arenaceo e conglomeratico.
Troviamo alternanza tra strati spessi e sottili: gli strati sottili sono in prevalenza
composti da arenarie a grana media e fine; gli strati più spessi, che diventano verso
l’alto veri e propri banchi, sono composti per lo più da conglomerati. I clasti di
media e grande dimensione, sono più o meno arrotondati e sono immersi sempre in
una matrice sabbiosa. Si tratta di clasti con diversa natura litologica: rocce ignee,
metamorfiche e sedimentarie.
Questa formazione è situata nella parte più alta del Flysch del Cilento e risale al
Miocene superiore (post Tortoniano-Messiniano). Essa è stata messa in posto da
flussi di alta densità e viscosità come i debris flow in un flusso detritico laminare e
parallelo.
I depositi di arenarie e marne coincidono con la fase prossimale della conoide
sottomarina; mentre i terreni conglomeratici corrispondono alla fase distale, più
vicino all’origine della conoide.
La presenza d brecce testimonia fenomeni di crioclastismo risalenti a circa 2 milioni
di anni fa circa nel Quaternario, quando si sono verificati gli ultimi episodi di
glaciazione.
Durante il “Wurm”, nel Quaternario, si è verificato l’ultimo evento di regressione del
livello del mare ( 20.000 anni fa ): il livello del mare era 100m più basso di quello
attuale. Questo spiega la presenza di valli che sono più profonde del livello del mare
attuale.
Durante il Tirreniano il livello del
mare era più alto di 6-8m
rispetto al livello del mare
attuale. Infatti si può osservare
una superficie di abrasione
antica nel profilo del terrazzo
marino.
Genesi del Cilento
Il Gruppo del Cilento è parte integrante dell’ Appennino meridionale formatosi
nell’ambiente geodinamico di subduzione che ha interessato l’orogenesi
appenninica nel Mio-Pleistocene. Essa va inserita nel più grande contesto
dell’orogenesi alpino-himalayana, cominciata nell’Eocene, quando la zolla africana è
entrata in collisione con quella europea in seguito al progressivo aprirsi
dell’Oceano Atlantico meridionale ( Giurassico ) e alla conseguente chiusura del
bacino ligure-piemontese ( fine Cretaceo), parte di antica Tetide che fino ad allora
aveva separato l’Africa dall’Europa.
La migrazione della zolla africana verso quella eurasiatica è iniziata nel Cretaceo e
perdura tuttora. Lungo la fascia di collisione si sono formate due importanti catene:
quella alpina formatasi nel Paleogene, e quella Appenninica, formatasi, invece, nel
Miocene.
L’Appennino meridionale è una catena montuosa a falde di ricoprimento,
che quando è nata si trovava sul prolungamento delle Alpi che collegava l’Italia alla
Spagna meridionale. Durante il Miocene la catena appenninica, compiendo una
rotazione verso Est ha strappato un tratto della penisola iberica, chiamato
complesso sardo-corso, dal quale si è poi separata. La frattura tra i due blocchi ha
consentito l’apertura del Mar Tirreno.
In seguito al progressivo ed articolato sprofondamento della microzolla Adria al di
sotto della catena alpina ed appenninica, si è aperto un nuovo margine di
subduzione. In questo contesto il gruppo del Cilento si è già deposto.
Il Gruppo del Cilento è un corpo geologico silico-clastico, articolato in due differenti
unità strutturali: “Unità Liguridi”, formate da rocce argillose e calacaro-marnose di
età Eocene medio-Burdigaliana; “Flysch del Cilento”, successione silico-clastica di
età Mesozoico-Terziario.
Si tratta di un complesso nato dalla diagenesi di frammenti di rocce che in origine
affioravano in aree continentali, che sono state col tempo degradate ed erose. I
frammenti che ne sono derivati sono stati poi trasportati fino alla costa ( base delle
scarpate ) da agenti morfogenetici, quali fiumi, vento, ghiacciai.
I frammenti di cui si riscontra la presenza sono molto eterogenei dal punto di vista
della litologia: si tratta di rocce ignee, metamorfiche, sedimentarie. Ad esempio si
riscontra la presenza di frammenti di graniti: i graniti che compongono l’80% della
crosta continentale a grandi profondità, sono stati sottoposti a sollevamento
tettonico durante l’ orogenesi appenninica.
Gli eventi che hanno generato l’assetto geologico-strutturale della Campania sono
strettamente connessi agli eventi che hanno generato il quadro strutturale della
penisola italiana.
Le principali strutture geologiche della penisola italiana sono rappresentate da
quattro elementi strutturali:
1.Area tirrenica, caratterizzata da crosta continentale assottigliata e, in alcune zone
(Tirreno meridionale), da crosta oceanica, formatasi a partire dal Tortoniano
superiore-Messiniano inferiore in seguito a processi di rifting avvenuti all’interno di
una catena preesistente;
2.Catena appenninica, costituita da coltri di ricoprimento, a convergenza adriatica, e
dai depositi di riempimento di bacini che si impostavano sulle coltri di ricoprimento
in avanzamento;
3.Avanfossa appenninica, costituita da sedimenti plio-quaternari in parte sepolti
sotto falde appenniniche;
4.Avampaese, costituito da una potente successione carbonatica mesozoica,
impostata su crosta continentale, in graduale approfondimento verso SW al di sotto
delle coltri appenniniche.
Parco geoarcheologico di Elea-Velia
Elea, denominata in epoca romana Velia, è un'antica città della Magna Grecia. L'area
archeologica è attualmente localizzata nel comune di Ascea in provincia di Salerno,
all'interno del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
La città antica dista dal mare non più di 100m (oggi la linea di costa è di circa 750m);
il promontorio dell’acropoli è una penisola protesa sul mare per circa 400-500m ;
l’Alento ed il Palistro sfociano a mare con due foci differenti. Questa morfologia
costiera tra il V-IV secolo a.C., subisce modificazioni radicali a causa di una
successione di eventi climatici che determinano un accumulo di sabbie marine
grossolane e depositi di sedimenti alluvionali, provenienti dalla conoide alluvionale
del Frittolo, provocando l’allontanamento dalla linea di costa e l’innalzamento del
piano campagna di circa 3-4m. Alla fine del V secolo d.C. la piana di Velia è
interessata da nuove alluvioni che in circa 200 anni portano ad un innalzamento
ulteriore del piano campagna di altri 4-6m ed un corrispondente allontanamento
dalla linea di costa.
Gradazione del piano
campagna, che porta ad una
regressione del mare di
decine di metri, concentrata
dal VI secolo a.C. al IV secolo
d.C.
Terreni: conglomerati di
Centola, sabbie sciolte,
successione di Ascea.
Una volta varcata la porta, la
strada sulla quale camminiamo è
risalente al III secolo a.C.
Eseguendo gli scavi, la città
arcaica del VI-V secolo si trova
interrata di 4metri, costituiti da
depositi alluvionali e
paleosismiti.
Dal IV al III secolo a.C. vi sono
ulteriori 4m di depositi.
Ricostruzione dell’antico piano campagna
L’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. è l’evento
geologico principale verificatosi in epoca
storica. L’eruzione, che ha profondamente
modificato la morfologia del vulcano e dei
territori circostanti, ha provocato la
distruzione delle città di Ercolano e Pompei,
le cui rovine, rimaste sepolte sotto strati di
pomici, sono state riportate alla luce a
partire dal XIX secolo sotto la dinastia dei
Borbone durante il regno delle due Sicilie.
L’eruzione del 79 d.C. ricoprì tutta l’antica
città di Velia, proprio come accadde ai
territori circostanti il Vesuvio. Prodotti vulcanici dell’eruzione del Vesuvio del
79 d.C. (Eruzione di Pompei), che in tutta
l’area archeologica costituiscono un preciso
marker crono-stratigrafico, situato
precisamente nell’antistante area della
necropoli romana.