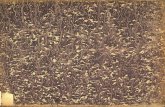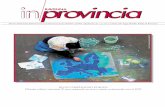Origini dell’architettura greca, in Architettura del mondo antico
Trattati e teorie dell’architettura nel Rinascimento: da Alberti a Palladio
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Trattati e teorie dell’architettura nel Rinascimento: da Alberti a Palladio
Il primato della letteraturaNella Prefazione al VI libro del De Architectura,Vitruvio esprime eterna rico-noscenza nei confronti dei propri genitori per avergli consentito di appren-dere un’arte così nobile da non poter essere manifestata senza l’ausilio dellascrittura e senza la conoscenza delle più disparate scienze.Peraltro il trattatista latino, fin dall’inizio del libro I, argomenta ampiamentesulla necessità che l’architetto sia erudito in numerose discipline e varie co-gnizioni pratiche (“Architecti est scientia pluribus disciplini et variis eruditionibusornata”, De Architectura, I, I, 1), enumerandone almeno tredici, che spazianodall’aritmetica alla giurisprudenza, dalla fisica alla medicina, dalla musica al-l’astronomia. Egli, conscio dell’inattuabilità di un programma formativo cosìvasto, non pretende una cultura enciclopedica o l’eccellenza in tutte le disci-pline dianzi individuate, bensì ne auspica una conoscenza generale, nella mi-sura e per i contenuti che possono concernere l’attività professionale dell’ar-chitetto. Ciononostante appare singolare che, nel richiamato elenco, l’abilitàletteraria preceda la scultura, la geometria, l’ottica, e addirittura il disegnostesso (“Sia perciò egli letterato […]. In appresso abbia disegno”, ivi).Non è per caso, quindi, che la riscoperta dell’unico trattato di architetturapervenutoci dall’antichità abbia un seguito così fecondo nel corso dell’epo-pea umanistico-rinascimentale e nei secoli successivi, e che il maggiore epi-
2 Trattati e teorie dell’architetturanel RinascimentoDa Alberti a Palladio
53
10.02_052_073 29-01-2007 14:50 Pagina 53
gono di Vitruvio, Leon Battista Alberti, sia un letterato prim’ancora che unarchitetto. L’attitudine a esprimere nella forma più completa le teorie e leconoscenze pratiche dell’arte edificatoria si diffonde ampiamente tra gli ar-chitetti: questi, infatti, non si limitano a progettare, ma sentono l’esigenza ditrasmettere in modo sistematico il nuovo bagaglio di idee, conoscenze ed e-sperienze che in quegli anni si va rapidamente sviluppando, anche attraversol’utilizzo del nuovo mezzo della stampa a caratteri mobili, che non solo neconsente un’ampia diffusione, ma soprattutto istituzionalizza, per così dire,testo, immagini e autorità delle opere editate.
Il “Vitruvio” modernoCon il De re aedificatoria (1485), Alberti contribuisce in maniera determinan-te alla fortuna del precedente vitruviano e allo stesso tempo fonda il generedel moderno trattato di architettura. Egli riprende dal trattatista latino lasuddivisione in dieci libri e la maggior parte dei temi affrontati articolandoli,però, secondo un ordine più logico e razionale che, nell’evidente sforzo didare alla materia un’impostazione sistematica, manifesta implicitamente ungiudizio tutt’altro che benevolo nei confronti di Vitruvio.Alberti, infatti, antepone un’unica prefazione a tutto il trattato ed enuncia letre categorie vitruviane di firmitas, utilitas e venustas soltanto nel primo libro,impostando, tuttavia, proprio in base a esse l’ossatura complessiva della suateoria architettonica, che assume, alla fine, la seguente struttura: Libro I: de-finizioni; Libri II e III: firmitas (materiali e costruzione); Libri IV e V: utilitas(funzione e tipologia degli edifici); Libri VI-IX: venustas (decorazione; edificisacri, pubblici e privati; teoria della proporzione); Libro X: conclusioni dicarattere generale e conservazione degli edifici esistenti (restauro).La teoria degli ordini architettonici è integralmente recepita, sia nella pun-tuale individuazione della serie completa degli elementi formali (dal piedi-stallo al cornicione), sia nella definizione del carattere proprio di ogni ordinesulla base del cosiddetto “decor”.
Nonostante il recepimento integrale della teoria degli ordiniarchitettonici, Alberti assume nei confronti di Vitruvio un atteggiamento critico, sottoponendo a concreta verifica le sue affermazioni sull’architettura antica mediante il confronto con gli edifici superstiti.
Leon Battista non fornisce precetti assoluti ma indaga i principi dai quali essihanno origine; riconosce l’autorità degli edifici antichi ma la considera ugua-gliabile se non addirittura superabile; insiste sull’importanza dei modelli in
Il tardo Cinquecento54
10.02_052_073 29-01-2007 14:50 Pagina 54
scala quale modalità di affinamento del percorso progettuale e propone inte-ressanti analogie, per esempio quella secondo cui lo stato è inteso come unagrande casa e la casa come un piccolo stato.Scritto in un latino depurato dalle “oscurità lessicali” vitruviane e privo di il-lustrazioni, il trattato albertiano si rivolge a un pubblico colto, costituito nonda architetti bensì dai loro committenti, ovvero quei principi umanisti (laicio esponenti del clero) che auspicavano un catalogo di criteri pratici ed esteti-ci per progettare e realizzare le proprie opere edilizie. Non a caso il primoesemplare manoscritto viene presentato nel 1452 a Niccolò V, il papa ispira-tore di radicali ristrutturazioni urbanistiche, e lo stesso Leon Battista manife-sta il desiderio (puntualmente soddisfatto nell’editio princeps postuma) di de-dicare l’edizione a stampa a quel Lorenzo de’ Medici che, proprio per la suavocazione riformatrice, è universalmente noto come “il Magnifico”.
Trattati e teorie dell’architettura nel Rinascimento 55
Alla pagina 52:Francesco di GiorgioMartini, Ordini dicolonne, in Trattato di architettura civile e militare, 1480 circa,Firenze, BibliotecaLaurenziana, ms. 282(Codex Ashburnham361), fol. 13v.
Prospettiva di un paesaggio con dighe di ritenutae acquedotti, inL’architecture et l’art debien bastir du seigneurLeon Baptiste Alberti,1553, Parigi.
10.02_052_073 29-01-2007 14:50 Pagina 55
Le teorie postalbertiane Il De re aedificatoria costituisce senza dubbio il più ambi-zioso compendio di riflessioni teoriche sull’architetturaben oltre il Quattrocento, nonostante la sua fortuna siaalquanto limitata mentre Alberti è ancora in vita. Gli ana-loghi esempi contemporanei, invece, si rivolgono a unacerchia di lettori potenzialmente più vasta, adottandol’uso del volgare in luogo del latino e scegliendo forme diesposizione più dilettevoli.Un chiaro esempio di questo atteggiamento sono le pa-role di Antonio Averlino, meglio noto con lo pseudoni-mo da lui stesso coniato di Filarete (“amico della virtù”),il quale preferisce “narrare modi, misure e proporzionidell’edificare” rinviando “quelli che più periti e più inlettere intendenti saranno” alla lettura dei suoi predeces-sori Vitruvio e Alberti.Il suo trattato è noto in due diverse versioni, dedicate ri-spettivamente a Francesco Sforza e Piero de’ Medici, chetradiscono l’intento di procacciarsi commissioni edilizie,peraltro mai ottenute. L’opera è suddivisa in venticinquelibri di lunghezza variabile: i primi ventuno compongo-no il trattato vero e proprio, quelli dal XXII al XXIV so-no dedicati al disegno, alla pittura e alla scultura, mentreil XXV contiene la descrizione di edifici eretti per inca-rico dei Medici a Firenze e Milano. Il testo si presentasotto forma di romanzo scritto in forma dialogica: leconcezioni architettoniche non sono esposte in modo si-stematico ma alquanto episodico e narrativo, prendendospunto dalla descrizione della fondazione di Averliano,città che una volta realizzata si chiamerà, non a caso,Sforzinda. Questa doppia denominazione sottolinea ilvalore autonomo del progetto urbanistico, legato trami-te il nome al suo ideatore, rispetto all’esecuzione con-creta che, al contrario, allude a quello dell’agognatocommittente.Durante lo scavo delle fondamenta del porto di Sforzin-da, poi, gli operai rinvengono un Codex Aureum, nel qua-le si narra della città di Plusiapolis, edificata anticamentein quello stesso luogo da Onitoan Nolivera, nuovo giocodi parole che cela l’anagramma di Antonio Averlino e la
Il tardo Cinquecento
Filarete, L’ospedaledi Sforzinda, inTrattato di architettura,1461-1464, Firenze,Biblioteca NazionaleCentrale, ms. CodexMagliabechianus (M),II, I, 140, fol. 83v.Il disegno mostraevidenti analogie conl’ospedale maggiore di Milano che AntonioAverlino progettò per Francesca Sforza,realizzando solo ilprimo piano del bloccocentrale tra il 1456 e il 1465.
56
10.02_052_073 29-01-2007 14:50 Pagina 56
volontà di fondare sugli esempi antichi il prestigio degli edifici progettati.In uno di questi ultimi, l’allegorica “casa della virtù e del vizio”, Filareteconcepisce anche una nuova forma di rappresentazione grafica la sezioneprospettica. Di grande interesse, infine, è la rielaborazione, alla luce dellatradizione cristiana, del mito vitruviano della capanna primigenia, illustrato
Trattati e teorie dell’architettura nel Rinascimento 57
10.02_052_073 29-01-2007 14:50 Pagina 57
da Filarete per la prima volta in una serie di figure che mostrano Adamo,cacciato dal Paradiso terrestre, nel tentativo di costruirsi un rifugio la cuistruttura rudimentale sarebbe all’origine di tutte le forme architettonichepiù evolute.
Tutte le dimensioni della capanna primigenia, non solo “di Filarete” ma da Filarete in poi, sono riconducibili alle proporzioni umane e fondano un’antropometria intuitivain cui il modulo elementare non può essere desunto che dalla parte più nobile del corpo umano: la testa.
Analoghe allegorie e giochi di parole caratterizzano la pressoché contempo-ranea Hypnerotomachia Poliphili (si veda Dentro il capolavoro alle pagine 60-61)del monaco veneziano Francesco Colonna.
Il tardo Cinquecento
Filarete, Ordini di colonne, in Trattatodi architettura,1461-1464, Firenze,Biblioteca NazionaleCentrale, ms. CodexMagliabechianus (M),II, I, 140.
58
10.02_052_073 29-01-2007 14:50 Pagina 58
I diversi esemplari manoscritti (1470-1500) del trattato di Francesco diGiorgio Martini, più di ogni altro vicino alle teorie vitruviane, dedicano in-vece un’ampia sezione all’architettura militare e alla teoria delle fortifica-zioni, imitato circa un secolo dopo da Pietro Cataneo nel primo de I quattroprimi libri di architettura (1554).La nota illustrazione leonardesca della figura vitruviana, invece, occupa unfoglio sparso che non consente di fare luce su un suo ipotetico abbozzo ditrattato di architettura.
Trattati e teorie dell’architettura nel Rinascimento 59
Filarete,La costruzione dellacapanna primigenia,in Trattato diarchitettura, 1461-1464, Firenze,Biblioteca NazionaleCentrale, ms. CodexMagliabechianus (M),II, I, 140, fol. 5v.
10.02_052_073 29-01-2007 14:50 Pagina 59
Francesco ColonnaHypnerotomachia Poliphili
Piramide a gradoni, tempio di Venere Physizoa, pagina ditesto, elefante porta-obelisco,1499,Venezia.
Polifilo, alla disperata ricercadell’amata Polia, percorre uncomplesso cammino iniziatico in bilico tra i cerimoniali pagani e la liturgia cristiana che lo monda dalle passioni carnali e lo proietta verso l’anelatoequilibrio tra i sensi e la ragione.
Dentro il capolavoro
La Hypnerotomachia Poliphili è considerata uno dei libri più belliin assoluto per l’eccellente integrazione tra il testo, daglieleganti caratteri tipografici, e 172 splendide xilografie.L’impeccabile stampatore veneziano Aldo Manuzio, però,fu costretto a corredarlo di un consistente errata corrige,quasi smarrito nella selva linguistica costruita dall’autoreutilizzando una base toscana sulla quale sono innestatineologismi latineggianti, forme verbali arcaiche ed eruditigrecismi, che già nel titolo denotano i tre temi portanti:il sogno (ipnos) di una battaglia (make) d’amore (eros).
10.02_052_073 29-01-2007 14:50 Pagina 60
Superato il misterioso Polyandron, la statua girevole inottone che corona una poderosa piramide a gradoni,
il tempio cupolato di Venere Physizoa, l’elefante in ossidiana con l’obelisco sulla schiena (tanto simile
a quello di Bernini), i due amanti si ricongiungonofinalmente sull’isola di Citera, a metà strada
tra l’Atlantide platonica, la Sforzinda filaretiana e gli statiutopici analogamente “insulari” di Moro e Campanella.
Il romantico ed emotivoapproccio all’antico diColonna sembracontrapporsi a quelloscientifico e intellettualedi Alberti, costituendo il monumentalecoronamentodell’erudizione antiquariacontemporanea.
La Hyperotomachia Poliphili costituisce una vera battaglialinguistica ed erotica, tanto che, proprio a causa dei temierotici e pagani, l’identità dell’autore viene celatanell’acrostico formato dalle prime lettere dei trentottocapitoli: “poliam frater franciscus columna peramavit”. Polifilosarebbe, quindi, l’alter ego del frate domenicano FrancescoColonna, il cui percorso mistico e sensuale diventa ilpretesto per dettagliatissime descrizioni, ai margini dellateoria dell’architettura, che danno la sensazione disprofondare nella mappa dei cartografi folli di Borges.
10.02_052_073 29-01-2007 14:50 Pagina 61
Le edizioni del De Architectura nel RinascimentoTutti i trattatisti rinascimentali devono inevitabilmente confrontarsi con l’u-nico analogo testo antico, per questo motivo le pubblicazioni vitruviane di-ventano sempre più elaborate, passando dalla semplice edizione latina a tra-duzioni collazionate e commentate criticamente.Sospeso il giudizio sulla leggendaria “scoperta” di un manoscritto a Montecas-sino nel 1414, a opera di Poggio Bracciolini, l’editio princeps del De Architecturaviene pubblicata (intorno al 1486) da Giovanni Sulpicio da Veroli che, pur di-chiarando di aver confrontato diversi codici, lascia filtrare numerosi erroriche ne rendono alquanto oscura l’interpretazione. I curatori delle successive
edizioni (Firenze 1496 e Venezia 1497) non sono noti, mentre quella del1511, pubblicata da fra’ Giocondo da Verona, segna una svolta negli studi vi-truviani per la correttezza del testo e il lussuoso apparato iconografico, costi-tuito da 136 xilografie che, per la prima volta, contribuiscono alla compren-sione dell’opera; esse fanno da modello a gran parte delle edizioni successive,sia per la scelta dei passi da illustrare sia per le caratteristiche figurative. Il te-sto, invece, viene emendato attingendo ad altri brani dello stesso Vitruvio e dialtri autori, attraverso un’attenta considerazione dell’argomento o sulla scor-ta dell’esperienza pratica maturata dal curatore nei suoi lunghi anni di attività
Il tardo Cinquecento62
Homo ad circulum,in Vitruvio,De Architectura,edizione a cura di fra’ Giocondo,1511,Venezia.
Sinossi degliordini architettonici,in Vitruvio,De Architectura,edizione a cura diCesare Cesariano,1521, Como.
10.02_052_073 29-01-2007 14:50 Pagina 62
edilizia. La presenza in appendice di un indice alfabetico, infine, completa isussidi offerti affinché il trattato possa essere letto e capito, come Giocondodichiara fin dal titolo: “[…] cum figuris et tabula ut iam legi et intelligi possit”.Intorno al 1514 l’umanista Fabio Calvo prepara una traduzione che Raffaelloavrebbe dovuto illustrare ma che non verrà mai data alle stampe, cosicché laprima versione italiana, basata sulle edizioni sulpiciana e giocondina, vienepubblicata nel 1521 dal pittore-architetto Cesare Cesariano. Come fra Gio-condo, egli tende a fornire al lettore uno strumento utile per la progettazione,corredando l’ampio commento con 119 incisioni in folio che, pur ricalcando la
Trattati e teorie dell’architettura nel Rinascimento 63
10.02_052_073 29-01-2007 14:50 Pagina 63
scelta dei soggetti del frate veronese e palesando una conoscenza delle archi-tetture antiche limitata all’Italia settentrionale, presentano interessanti propo-ste innovative e una cura nei ai particolari che qualificano l’apparato iconogra-fico come la sede privilegiata da Cesariano per ampliare la comprensione deltesto.Tra queste, notevolissima è la tavola che anticipa la sinossi degli ordini diSebastiano Serlio (fol. LXII/r), affiancando diversi tipi di colonne e capitelli,mentre la rappresentazione della figura vitruviana su uno sfondo quadrettatoevidenzia i rapporti proporzionali tra le membra del corpo umano.Un’altra limpida traduzione del testo vitruviano, ultimata intorno al 1440 daGiovan Battista da Sangallo, è rimasta malauguratamente inedita, mentre glisplendidi disegni, schizzati dallo stesso Sangallo a margine dell’esemplare sul-piciano conservato presso l’Accademia dei Lincei, sono stati pubblicati da Ga-briele Morolli nel 1988, a corredo di una guida illustrata al De Architectura.
Dalla conoscenza al dogmaSebastiano Serlio inizia la pubblicazione dei suoi libri sull’arte di costruire apartire dal Quarto, che ritiene il più importante, ove definisce le Regole ge-nerali sopra le cinque maniere degli edifici (1537), seguito tre anni dopo dal Ter-zo. La pubblicazione dei rimanenti libri prosegue in ordine non sistematico,a intervalli irregolari e in diverse città europee, terminando solo dopo lasua morte.
La grande novità introdotta da Serlio è costituita dalla sinossi che apre il Quarto libro, probabilmente ispirata a Cesariano, in cui porta a maturazione il sistema dei cinqueordini architettonici, disposti per la prima volta in sequenzalogica, aggiungendo l’ordine toscano e quello composito aidue estremi della triade costituita da dorico, ionico e corinzio.
Il sistema serliano dei cinque ordini è completato da altri elementi non con-templati nel trattato latino (i piedistalli, la base e la trabeazione corinzie, trat-te da esempi antichi) e proporzionato aumentando l’altezza delle colonne diun diametro per ogni ordine, da sei a dieci. Per tutte le modanature di ognimembratura Serlio prescrive una precisa proporzione, con lo scopo evidentedi rendere disponibile un metodo pratico in modo che “non solo gli elevati in-gegni l’habbino ad intendere ma ogni mediocre anche ne possa esser capace”(Epistola ai lettori, fol. 5r), segnando così l’inizio della tendenza a “codificare”gli ordini che culminerà dopo la metà del secolo con il trattato di Vignola.Il grande successo editoriale testimonia che Serlio aveva raggiunto il proprioobiettivo, probabilmente grazie all’utilizzo mirato delle illustrazioni (chiare
Il tardo Cinquecento64
10.02_052_073 29-01-2007 14:50 Pagina 64
Vignola,Costruzione di uncapitello corinzio,in Regola delli cinque ordinid’architettura, 1562,Roma.
e in grande formato) come strumento didattico, a corredo di un testo spessoridotto a semplice nota esplicativa, benché autorevole nei contenuti.Jacopo Barozzi da Vignola, sull’esempio del Quarto libro di Serlio, riduce ulte-riormente il testo a didascalie di poche righe per ognuna delle 32 tavole di ra-me. Il suo scopo, infatti, è quello di costruire una “regola” semplice e univer-sale, che definisca una serie di rapporti proporzionali di facile riproduzione,sganciati da qualsiasi giustificazione antiquaria o metafisica. Lo stesso fronte-spizio della Regola delli cinque ordini d’architettura lascia presagire un’inversionenella scala dei valori, testimoniata dalla sostituzione del consueto riferimentoall’autorità dell’architettura romana (vedute di rovine) con il fiero ritrattodell’autore, rappresentato con il compasso tra le mani, che risalta rispetto alleesigue dimensioni dell’edicola in cui è inquadrato e alle personificazioni dellateoria e pratica architettoniche che la affiancano.Poiché l’uso del diametro all’imoscapo come modulo determinava numerosedifficoltà applicative, specialmente per i numeri irrazionali che ne derivava-no, Vignola concepisce una doppia rivoluzione: in primo luogo inverte lemodalità di calcolo delle proporzioni, partendo dalle dimensioni totali e sta-bilendo così una relazione esprimibile col semplice rapporto 4:12:3 tra pie-
10.02_052_073 29-01-2007 14:50 Pagina 65
distallo, colonna e trabeazione: l’altezza totale di un ordine risulta pertantosuddivisa in 19 sezioni (o 15, senza il piedistallo) che possono essere calcola-te tramite cifre chiave che egli stesso fornisce. In secondo luogo,Vignola ele-va il modulo stesso al rango di misura assoluta, svincolandola dai diversi si-stemi di misura regionali, quali braccia, piedi o palmi. La semplificazione el’estremo pragmatismo della Regola vignolesca sono alla base del suo incre-dibile successo, testimoniato dalle oltre 250 edizioni sino ad oggi.
Trattati e teorie dell’architettura nel Rinascimento 67
Sebastiano Serlio,Quarto libro,1537,Venezia.
Vignola,Regola delli cinqueordini d’architettura,Frontespizio,1562, Roma.
Alla paginasuccessiva:Andrea Palladio,I quattro libridell’architettura,frontespizio, 1570,Genova, BibliotecaUniversitaria,Rari R VI 21.
10.02_052_073 29-01-2007 14:50 Pagina 67
L’ambiente venetoIl progetto dei Quattro libri dell’architettura matura nel periodo in cui Andreadi Piero della Gondola, detto Palladio, insieme al suo mecenate Daniele Bar-baro, medita sul testo e disegna le illustrazioni dell’edizione vitruviana del1556, la più scrupolosa del XVI secolo, insuperata almeno fino alla versionesettecentesca di Berardo Galiani. Con molta probabilità Palladio progetta, inanalogia con Vitruvio e Alberti, un trattato in dieci libri, pubblicandone soloquattro ripartiti in due serie (I primi due libri dell’architettura e I due libri del-l’antichità), che riscuotono un grande successo per le straordinarie xilografiee la preziosità della stampa.Ciò che distingue le figure di Palladio da quelle di Serlio è il rigore nell’ap-plicazione del metodo proiettivo ortogonale in pianta, alzato e sezione, in cuila rinuncia quasi assoluta alla prospettiva facilita una lettura precisa delle pro-porzioni e contribuisce a differenziare il linguaggio grafico degli architetti daquello più naturalistico (e quindi prospettico) dei pittori.Nel Libro I Palladio sviluppa un discorso in parallelo tra la tradizione costrutti-va materiale e le regole generali stilistiche del costruire, soffermandosi da unlato sulla teoria dei materiali e sulle strutture morfologiche più comuni (volte,stanze, scale e così via), ma enunciando precetti per gli edifici pubblici e priva-ti, nonché la teoria degli ordini architettonici, palesemente ispirata alla Regolavignolesca sin nella forma delle illustrazioni, senza esprimersi in modo siste-matico sulla proporzione. Nel Libro II Andrea affronta il tema dell’edilizia pri-vata di città e di campagna (ville), utilizzando come esempi quasi esclusiva-mente i propri edifici; una tale fierezza, sottolineata dal rivolgersi al lettore inprima persona, non ha precedenti fra i trattatisti. La sezione dedicata agli e-sempi di architettura antica (che Palladio stesso ha faticosamente misurato,chiamandoli poi “le mie antichità”) illustra basiliche, piazze e ponti nel LibroIII, mentre nel IV, interamente dedicato ai templi, edifici romani e tardoantichisono mescolati senza imbarazzo con il bramantesco San Pietro in Montorio.
“Roma quanta fuit ipsa ruina docet”I trattati della seconda metà del Cinquecento tentano di sistematizzare oltreun secolo di esperienze architettoniche fornendo una base teorica alla prati-ca consolidata che soddisfa la ricerca di regole certe in luogo dell’autorevo-lezza del De Architectura. Le norme semplici e comprensibili, poi, risultanopreziose per diffondere il linguaggio desunto dalle antichità romane in regio-ni dove i rari monumenti antichi non riescono a soddisfare le esigenze degliarchitetti interessati alla nuova (ma antichissima) maniera di costruire.L’istanza pedagogica di Serlio e Vignola, che porta alle estreme conseguenze lefinalità strumentali giocondina e cesariana, si contrappone tuttavia alla mitizza-
Trattati e teorie dell’architettura nel Rinascimento 69
10.02_052_073 29-01-2007 14:50 Pagina 69
Pianta schematica del teatro romano,in I dieci libridell’architettura di Vitruvio, edizione a cura di DanieleBarbaro, 1556,Venezia.
Sebastiano Serlio,Terzo libro,frontespizio, 1540,Venezia.Il Terzo libro di Serliocontiene la dettagliatarappresentazione di 53monumenti antichi,soprattutto romani,insieme ad alcuniprogetti di Bramante,Raffaello e Peruzzi.
zione dell’architettura classica perseguita dalla romana Accademia della Virtùdi Claudio Tolomei, che riecheggia nella versione vitruviana di Filandro, filolo-gicamente autorevolissima. Diversi passi di Serlio e Filandro stesso, infatti, te-stimoniano l’accesa polemica tra i cosiddetti “antiquari”, convinti che la pre-senza di una qualsiasi soluzione dimensionale o decorativa in monumenti anti-chi ne legittimi l’utilizzo, e i “vitruviani”, i quali fanno riferimento assoluto alDe Architectura per selezionare negli esempi superstiti le forme ortodosse dellagrammatica classica.Tutto il Rinascimento è infatti permeato da un’intensa attività di misurazio-ne e riproduzione figurativa degli edifici antichi ancora parzialmente conser-vati, finalizzata al loro confronto con il testo di Vitruvio. Tale diffuso atteg-giamento è descritto in modo assai fedele dal frontespizio delle Antiquarieprospettiche romane, un opuscolo dedicato a Leonardo da un “prospectivo Mela-nese depictore” (probabilmente Bramante) intorno all’anno 1500, in cui è raf-figurato un uomo nudo entro un cerchio, con gli strumenti dell’architettotra le mani, intento a misurare figure geometriche e inginocchiato davanti adantiche rovine. Similmente, nel frontespizio del Terzo libro serliano il lettoreè esortato a osservare analoghe rovine con la dovuta ammirazione poiché,per quanto possano essere decadenti e corrotte, mostrano quanto furonograndi un tempo Roma e la sua architettura.
Il tardo Cinquecento70
10.02_052_073 29-01-2007 14:50 Pagina 70
Il significato dell’architettura manieristica
Lett
ure
Il XVI secolo fu un’epoca in cui l’uomo sentiva come vivamenteproblematici tutti gli aspetti fondamentali della sua esistenza: i rapporti conil prossimo, con la natura, con la cultura, con Dio e persino con se stesso.All’uomo “divino” del Rinascimento, subentrò l’uomo “terribile”, l’essereche dubita e teme, interiormente diviso dal dramma della scelta. La libertàdi scelta introdotta dall’Umanesimo rinascimentale portava naturalmente aquesta situazione, perché partiva dal presupposto che i valori eterni nonerano rivelati direttamente all’uomo, ma dovevano essere conquistatidall’azione creativa. Ma la fiducia nelle capacità morali e intellettualidell’uomo, tipica del Rinascimento, non durò a lungo. Erasmo e Luterorappresentano il dubbio riguardo al fine della libertà e della “dignitàdell’uomo”, per usare l’espressione di Pico; e Copernico (1545) toglie laterra dal centro dell’universo. I fondamenti politici della civiltàrinascimentale si sgretolarono e la divisione della Chiesa confermò ladisintegrazione del mondo unificato e assoluto. Il nuovo stato di cose fusentito soprattutto come problema “psicologico”. L’uomo moderno, chevuole sostituire all’autorità la coscienza e la responsabilità personale, nacquenel XVI secolo. Il suo è un mondo problematico e diviso, e l’uomo è unessere alienato e sofferente. Mai prima d’allora la ricerca di valorisignificativi era stata sentita con tanta intensità.Il problema fu risolto in maniera diversa dal Protestantesimo e dalCattolicesimo. Il protestante dipende interamente dalla grazia divina; le sueazioni non possono essergli di aiuto, e anche la cultura diviene inutile esuperflua. Perciò il Protestantesimo giunse quasi al punto di negare ognivalore all’arte religiosa e ridusse il simbolismo al minimo. Per il protestanteil mondo non ha significato; non manifesta alcuna verità divina, e lo spazio èneutrale e privo di “qualità”. Il Protestantesimo perciò risolse la crisi umananegando significati esistenziali di importanza tradizionale. È evidente che lasocietà “tecnocratica” e l’uomo “secolarizzato” del nostro tempo sono unaderivazione naturale dell’interpretazione protestante della realtà.Per il cattolico, la verità si rivela nel mondo, e la storia è il percorso umanoverso la redenzione. Nel suo cammino, l’uomo è guidato dalla Chiesa.Perciò uno dei primi intenti della Controriforma fu quello di abolire ildiritto dell’individuo a risolvere i problemi personali per mezzo dellaragione. La Controriforma voleva ristabilire l’autorità ecclesiastica,indebolita dall’Umanesimo rinascimentale. Si abbandonarono i concetti di
10.02_052_073 29-01-2007 14:50 Pagina 72
forma perfetta e di bellezza, e l’arte religiosa divenne strumento dipersuasione e di propaganda. Il generale processo di fenomenizzazione delsecolo XVI ben si adattava agli scopi della Chiesa. Abbiamo già discusso ilproblema della persuasione in relazione con la chiesa del Gesù. La metadella persuasione è la “partecipazione”. Perciò, oltre alle riforme introdottedal Concilio di Trento, sorsero delle organizzazioni che cercavano diadattare la fede cattolica alle esigenze del tempo. Ebbero particolareimportanza i Gesuiti, secondo i quali la religione doveva fare appello aisentimenti umani. Si formò così un tipo di religione popolare, anti-intellettuale, che nei due secoli successivi si diffuse in tutto il mondocattolico, e che si manifestò visualmente nell’enorme diffusione di elementireligiosi, come edicole, crocifissi, cappelle e santuari. Il pellegrinaggio tornòad essere una pratica molto diffusa nella vita della chiesa, e i conventiriacquistarono una parte dell’importanza culturale che avevano avuto nelMedio Evo. La ragione essenziale del grande valore attribuito allapropaganda stava nei fatto che la Chiesa Cattolica non era più l’unicosistema di valori per l’uomo occidentale. Da quel momento, la Chiesa fusolo uno dei molti sistemi religiosi, politici e filosofici. Perciò la propagandadivenne essenziale, ed acquistò un carattere dinamico e centrifugo.Le forme inquiete del Manierismo si trasformarono nel rassicurantedinamismo del Barocco. La crisi fu superata con la rinuncia all’idearinascimentale di libertà umana.
Christian Norberg-Schulz(da Significato dell’architettura occidentale, Electa, Milano, 1974)
10.02_052_073 29-01-2007 14:50 Pagina 73