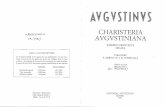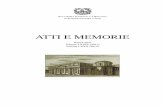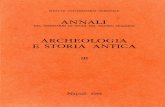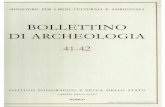Origini dell’architettura greca, in Architettura del mondo antico
Tobi e Ahiqar. Sulle tracce di un racconto antico
Transcript of Tobi e Ahiqar. Sulle tracce di un racconto antico
Il saggio AhiqarFortuna e trasformazioni di uno scritto sapienziale.Il testo più antico e le sue versioni
a cura diRiccardo Contini e Cristiano Grottanelli
Paideia Editrice
Indice del volume
9 Premessa
10 Sigle
Riccardo Contini - Cristiano Grottanelli11 Introduzione
Simo Parpola91 Il retroterra assiro di Ahiqar
Riccardo Contini113 Il testo aramaico di Elefantina
Giancarlo Toloni141 Tobi e Ahiqar
Cristiano Grottanelli - Emanuele Dettori167 La Vita Aesopi
Marilina Betrò177 La tradizione di Ahiqar in Egitto
Fabrizio Pennacchietti193 Il testo siriaco antico di Ahiqar
Paolo Rostagno Giaiero227 Tre recensioni arabe della Storia di ±ayqºr
Gianfrancesco Lusini255 La Storia di Ahiqar in versione etiopica
Cristiano Grottanelli - Emanuele Dettori267 La Storia di Combabo
Riccardo Contini275 Bibliogra#a ahiqariana
9
Premessa
In uno dei più celebri resoconti di viaggio europei nel Medi-terraneo orientale, Robert Curzon racconta di avere saputo,al Cairo nel 1833, da uno dei suoi protagonisti, il mercantearmeno Walmas, di un evento che si sarebbe veri#cato pocodopo il massacro dei Mamelucchi da parte del Pascià MehmetAli (1811). Questi, all'epoca non ancora signore d'Egitto sot-to la nominale autorità ottomana, trovandosi in dif#coltà #-nanziarie, avrebbe chiesto al suo futuro potente primo mini-stro, anch'egli armeno, Boghos Bey, di procurargli a brevissi-mo termine una enorme somma di denaro. Fallito ogni tenta-tivo di raccogliere tale cifra, il Pascià avrebbe condannato ilsuo consulente #nanziario a morire annegato nel Nilo. L'uf#-ciale e le guardie incaricati dell'esecuzione, chiuso Boghos inun sacco e caricatolo su un asino, si avviarono verso il #ume.Lungo la via, incontrarono Walmas, buon amico sia del Pa-scià sia di Boghos, che fece liberare il suo compatriota, incon-trando scarsa opposizione da parte dei gendarmi. Tempo do-po, Mehmet Ali, nuovamente bisognoso di denaro, espresse ildesiderio che Boghos fosse ancora vivo. Walmas, presente aquella scena di disperazione, garantitasi l'incolumità, rivelòdi aver salvato quel presunto morto tanto rimpianto. Il Pascià,rallegrandosi molto, riabilitò completamente Boghos e ricom-pensò Walmas, ma fece mettere a morte le guardie che aveva-no disatteso i suoi ordini.
Chiunque conosca anche solo per sommi capi la vicenda diAhiqar la ravviserà immediatamente in questo racconto del-l'Egitto del primo Ottocento. Ci è sembrato che questa enne-sima variante, che testimonia della lunghissima storia di unracconto vivace e istruttivo, nonché di marcato sapore ”orien-tale', rappresentasse il miglior incoraggiamento per il lettoread affrontare il complesso intreccio testuale e tematico di cuisi è voluto dar conto in questo libro.
141
Giancarlo Toloni
Tobi e AhiqarSulle tracce di un racconto antico
Un raffronto di Tobia con la Storia di Ahiqar si impone #ndalla prima lettura del testo. Nel libro biblico, infatti, oltre al-le innegabili af#nità dell'impianto narrativo con questo scrit-to, si trovano alcune menzioni dello stesso Ahiqar. Così, ilpotente primo ministro di Sennacherib, attraverso varie tra-sposizioni e adattamenti, in Tobia diviene un pio osservanteisraelita della tribù di Neftali, parente dello stesso Tobi, esvolge un ruolo signi#cativo all'interno della sua vicenda, inuna serie di racconti che si raccolgono intorno alle personedi Tobi e del #glio Tobia, ambedue deportati come prigio-nieri in Assiria dal regno del nord, nel 734 a.C., sotto Senna-cherib. Tobi, che era in situazione agiata, cade in disgrazia es'ammala di cecità; ma, dopo un periodo di sofferenza, tornain salute e al benessere, grazie all'intervento di un angelo diYhwh e all'intraprendenza del #glio.
1. il problema letterario
Il tema non è nuovo, ma si attiene allo schema del giusto sof-ferente, come nel libro di Giobbe, e ha un precedente nel poe-ma babilonese del giusto sofferente e nel Libro di Ahiqar. Inquest'ultimo la vicenda narrata ha i connotati dell'esemplari-tà, e sta a metà fra la favola e il romanzo edi#cante di stamposapienziale: delinea la diversa sorte che attende l'uomo giu-sto e pio (Ahiqar), il quale attraversa una serie di vicissitudi-ni dolorose e drammatiche – effetto della calunnia presentataa Sennacherib dal nipote ingrato Nadin (o Nadan), da luiadottato e preparato perché gli subentrasse a corte –, ma lesupera grazie alla fede incrollabile nella giustizia divina. Alla#ne, la mala sorte travolge il malvagio Nadin, a cui da prin-cipio sembravano assicurate l'impunità e il successo, mentreAhiqar viene riabilitato dal re e reintegrato nel suo ruolo.
142
È evidente che il rapporto fra Tobia e Ahiqar, più che daqualche pericope speci#ca, va studiato a partire dalle af#nitàdei rispettivi protagonisti, cosa, del resto, suggerita dallo stes-so agiografo, che fa di Ahiqar un personaggio del libro. Daquesto punto di osservazione si intravedono infatti le traccedel racconto antico che sta alla base delle due opere, anche sela loro prospettiva è molto diversa. Ad esempio, l'ultima par-te della vicenda di Ahiqar – il viaggio in Egitto alla corte delfaraone, per risolvere con la sua saggezza proverbiale l'inci-dente diplomatico creatosi con l'Assiria, il suo ritorno a casae la punizione di Nadin – non ha riscontro in Tobia.
È facile che l'agiografo abbia conosciuto il racconto popo-lare su Ahiqar,1 notissimo nel Vicino Oriente antico, e cheabbia rimodellato liberamente questo precedente letterario;secondo alcuni avrebbe inteso abbozzare la vicenda di Tobisull'archetipo di quella di Ahiqar,2 per altri invece avrebbevoluto solo sfruttare la conoscenza che ne avevano i suoi let-tori, e così accrescere il prestigio del protagonista della suaopera, facendone un suo parente.3 Ma non è da escludere chesi proponga anche di presentare nel mondo giudaico l'inse-gnamento morale della vicenda di Ahiqar.
Nel suo insieme il Libro di Ahiqar costituisce un'opera sa-pienziale unitaria per ispirazione; tuttavia le due parti di cuiconsta – la Storia di Ahiqar [SAh] e i cosiddetti Proverbi diAhiqar [PAh] – sono molto diverse per #nalità e genere let-terario.4 Il confronto con Tobia andrà tentato a partire dal-la SAh, non dai PAh, che appaiono un'aggiunta seriore.5 LaSAh, infatti, richiama più da vicino la vicenda biblica, dato chepresenta anch'essa un racconto autobiogra#co, che inquadra
1 I titoli ricorrenti non inclusi nella bibliogra#a #nale del capitolo sonocompresi nella conclusiva. Cf. Charlesworth 1981: 75-77, spec. 76.2 J.C. Dancy, Tobit, in J.C. Dancy - W.J. Fuerst - R.J. Hammer, The Shor-ter Books of the Apocrypha: Tobit, Judith, Rest of Esther, Baruch, Letter ofJeremiah, Additions to Daniel and Prayer of Manasseh (The CambridgeBible Commentary: New English Bible s. n.), Cambridge 1972, 1-66, spec. 6.3 Green#eld 1981: 329-336, spec. 331.4 Cf. la presentazione di Denis 2000: 993-1036.5 Pennacchietti 1981: 51-95, spec. 56. Cf. anche Grelot 2001: 511-528, spec.515: "Les proverbes viennent après le récit, sans qu'on sache comments'opérait la liaison entre les deux».
143
in un'unica cornice due raccolte di brevi apologhi di caratte-re gnomico, secondo uno schema narrativo molto noto nel Vi-cino Oriente antico, articolato su due temi: disgrazia e riabi-litazione di un cortigiano; ingratitudine di un nipote.
La vicenda di Ahiqar ci è giunta in varie traduzioni anti-che, specialmente in quella siriaca,1 che fra le versioni com-plete è la più importante, ed è attestata in più recensioni.Tuttavia, è più probabile che l'agiografo di Tobia si ispiri auna copia del racconto af#ne a quella del papiro aramaico diElefantina,2 datato al sec. v a.C., i cui undici frammenti re-stituiti negli scavi della missione archeologica tedesca del1907-1908 costituiscono il testimone del testo più antico eautorevole,3 anche se – come precisa Pennacchietti 4 – alcuniammodernamenti linguistici debbono già essere ritenuti unadattamento dell'originale. La conferma viene da alcuni im-portanti rilievi lessicali, principalmente dal valore di "elemo-sina» dato all'aramaico ‡dqh, che nel libro biblico è usato insenso salvi#co, mentre la versione siriaca lo rende con k®n¯-tâ, che è la semplice "rettitudine».5 Nel racconto elefantinola vicenda di Ahiqar doveva essere conforme a quella gene-ralmente diffusa, poiché ambientava la SAh sotto Esarhad-don, non sotto Sennacherib, come nelle versioni successive.Proprio questo spostamento propone un interessante paral-lelo con Tobia e con la celebre lista della tavoletta accadicadi Uruk, datata al 16.5.165 a.C. e ritrovata durante gli scavidel 1959-1960, la quale pone Ahiqar sotto Esarhaddon e inAssiria. Nella lista, infatti, si menziona un dotto (ummºnu),vissuto a Babilonia cinquecento anni prima di Esarhaddon, ese ne dà, oltre al nome sumerico, il corrispondente aramaico,Ahu'aqari, cioè Ahiqar. Con questa "identi#cazione apocri-fa» 6 i dotti di Uruk pongono l'ummºnu Ahiqar sotto Esar-haddon e in Assiria, come fa anche l'agiografo di Tobia, con
1 Edita e tradotta da J.R. Harris, in Conybeare et al. 1913: 34-73. 99-127.2 Edita da Porten e Yardeni 1993: 22-57.3 Sulle antecedenze del testo assiro-aramaico di Elefantina e sulle varie fasidella sua pubblicazione si veda l'importante contributo di Fales 1994: spec.39-47. 4 Pennacchietti 1981: 57.5 Pennacchietti 1981: 57, a proposito dei PAhSir nr.i 2 e 37.6 Fales 1993: spec. 155.
144
l'inserzione nel suo racconto dello stesso Ahiqar: si trattacioè della "promozione per chiara fama» del saggio assiro,che diventa così "protagonista della Storia», non più solo diuna storia.1
Il confronto con Tobia si fa quindi signi#cativo sul pianonarratologico e storico-critico, come su quello linguistico. In-fatti nel primo caso è innegabile che in entrambi gli scritti siha un genere che molto s'avvicina al romanzo, oltre a varieanalogie compositive, e consonanze circa il messaggio tra-smesso; nel secondo, la recente pubblicazione ad opera diJ.A. Fitzmyer dei frammenti 2 di quattro manoscritti aramai-ci di Tobia – 4QTob ara-d (4Q196-199) – e di un quinto ebrai-co – 4QTob hebre (4Q200) –, probabile versione da un origi-nale aramaico, tutti databili paleogra#camente fra l'inizio delsec. i a.C. e la prima metà del sec. i d.C.,3 consente una sin-golare comparazione lessicale.4
Attualmente la critica è incline ad affermare l'esistenza diun originale "semitico, probabilmente aramaico»,5 di Tobia.Ciò impone un attento esame dei cinque manoscritti qumra-nici, oltre che delle due recensioni greche complete (Gi e Gii);a queste ne va aggiunta una terza, frammentaria (Giii), colle-
1 Fales 1993: 155.2 Ritrovati nel 1952 a Qumran nella grotta 4 e af#dati a J.T. Milik per la ca-talogazione e la decifrazione, alla #ne del 1991 i frammenti furono asse-gnati dall'Israel Antiquities Authority a Fitzmyer, che ne curò la pubblica-zione (Fitzmyer 1995b). Una prima edizione era apparsa nel 1994 – Beyer1994: 134-147 –, ma vi si ricomponevano i frammenti secondo l'ordine delracconto nel Gii, mescolando cioè quelli ebraici con quelli aramaici. Del1997 è l'edizione di F. García Martínez - E.J.C. Tigchelaar (edd.), The DeadSea Scrolls Study Edition, i. 1Q1-4Q273, Leiden - New York - Köln 1997,382-399, af#ne a quella di Fitzmyer (l'editio princeps), a cui qui si farà rife-rimento. 3 Fitzmyer 1995a: 655-675, spec. 657.4 Un'eccellente traduzione dei frammenti è proposta in F. García Martínez(ed.), Testi di Qumran. Traduzione italiana dai testi originali con note di C.Martone (Biblica. Testi e studi 4), Brescia 1996, 480-487, la maggiore edi-zione per il numero dei manoscritti su cui si fonda (270 tra testi completi eframmentari). Rispetto all'originale spagnolo, l'autore ha incluso in essa an-che vari scritti qumranici di recente pubblicazione e altri #nora inediti,compresi appunto quelli di Tobia, tradotti da Martone sulla base degli ori-ginali ebraici e aramaici, e confrontati con le varie edizioni uf#ciali, con lefotogra#e e con le micro#ches. 5 Fitzmyer, 1995a: 671.
145
gata per lo più al Gii.1 La prima, nota anche come testo bre-ve, è stata trasmessa dalla maggior parte dei manoscritti gre-ci, seguiti da buona parte delle versioni antiche. Più attendibi-le, ai #ni della restituzione dell'originale, sembra il Gii, il co-siddetto testo lungo, che rende una Vorlage che doveva esse-re aramaica; è tràdito attraverso il codice Sinaitico (= LXXS),cui è connessa la Vetus Latina (= VL).2 Meno signi#cativa èinvece la Vulgata (= Vg),3 sostanzialmente legata al Gi.4 Lascoperta dei frammenti qumranici ha aperto interessanti pro-spettive,5 e impone in ogni caso di confrontare sempre le re-censioni greche, a cui si riconducono per lo più gli altri testi-moni del testo,6 con le corrispondenti attestazioni aramaichenei manoscritti, che sembrano molto vicine all'originale, for-se #no a identi#carsi con esso. Infatti i frammenti ricostruitispesso concordano con il Gii e la VL, cioè la tradizione te-stuale ritenuta migliore ai #ni della restituzione dell'Ur-text.
1 Edita da Hanhart 1985. Quest'edizione propone una lettura sinottica diGi e Gii, ma in alcuni casi riporta anche il Giii, annotandolo nell'apparatocritico del Gii.2 P. Sabatier (ed.), Bibliorum Sacrorum Latinae versiones antiquae seu Ve-tus Italica… i, Remis 1743, rist. anast. Turnhout 1976, 706-743. La VL sitrova in quattro manoscritti – g, b, a, d – e sostiene in forma decisa il Gii, sesi eccettua il ms d, che si accosta in parte al Gi. Cf. F. Vattioni, Studi e notesul libro di Tobia: Augustinianum 10 (1970) 241-284, spec. 271. Sul contri-buto critico della VL si veda J.R. Busto Saiz, Algunas aportaciones de laVetus Latina para una nueva edición crítica del libro de Tobit: Sefarad 38(1978) 53-69.3 Benedettini dell'Abbazia di S. Girolamo (edd.), Biblia Sacra iuxta LatinamVulgatam versionem ad codicum #dem… edita, viii. Libri Ezrae, Tobiae,Iudith ex interpretatione Sancti Hieronymi…, Romae 1950, 163-209.4 Sull'apporto della Vg all'analisi #lologica cf. la monogra#a di V.T.M.Skemp, The Vulgate of Tobit Compared with Other Ancient Witnesses(Society of Biblical Literature - Dissertation Series 180), Atlanta, Ga. 2000.5 Sull'importanza dei frammenti qumranici per la restituzione dell'origina-le di Tobia cf. Fitzmyer 2000, e inoltre Id., Tobit, in L.H. Schiffman - J.C.Vanderkam (edd.), Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls ii, Oxford 2000,948b-950a.6 Le forme testuali del greco sono descritte in Hanhart 1985: 29-36; Id., Textund Textgeschichte des Buches Tobit (Abhandlungen der Akademie derWissenschaften in Göttingen. Philologisch-historische Klasse, Dritte Folge139 = Mitteilungen des Septuaginta-Unternehmens 17), Göttingen 1984, 49-58. Una presentazione generale dei vari testimoni del testo si trova in Moore1996: 53-64.
146
L'originale di Tobia perciò va cercato in una forma testualesimile a quella dei frammenti aramaici ed ebraici di Qumran.Anche se non può semplicemente identi#carsi con questa, èfuor di dubbio che la ricostruzione del testo qumranico, perquanto parziale, consente di descrivere la vicenda di Tobiconforme, nelle linee generali, a quella del Gii e della VL.
La lingua dei manoscritti di Tobia sembra presentare i trat-ti dell'aramaico giudaico (palestinese). Si tratta effettivamen-te di aramaico della fase media e, nella fattispecie, di un dia-letto af#ne a quello dei targumim dell'Antico Testamento edi altri testi parabiblici di Qumran come l'Apocrifo della Ge-nesi (1QapGen), il Targum di Giobbe (11QtgJob [11Q10]) ei Libri di Enoc (4QEna-g [4Q201-202.204-207.212]); 1 inoltreesso presenta molti e signi#cativi contatti con il libro biblicodi Daniele, come spiega anche la datazione bassa delle dueopere. Del resto, la composizione di Tobia non deve prece-dere di molto i manoscritti qumranici, e può anche essere coe-va dei frammenti restituiti. Quindi i frammenti in questionesembrano solo di qualche decennio posteriori alla copia auto-grafa dell'autore, che doveva usare la stessa forma di aramai-co. Perciò essi, dal punto di vista linguistico e testuale, si pre-sentano come il testimone più vicino all'originale.
Da questi presupposti può partire l'analisi delle singolemenzioni di Ahiqar nel libro di Tobia, nel quale Tobi apparecome la rielaborazione della #gura del saggio assiro. Si trat-terà anzitutto di individuare come è ripreso in Tobia il nu-cleo di un racconto primitivo della disgrazia e della successi-va riabilitazione di un illustre cortigiano innocente, che staalla base di Ahiqar ed è presente anche in Giobbe e in altreletterature vicino-orientali, adattato alla speci#ca prospettivadi ogni opera. Si cercherà, perciò, di cogliere il preciso ap-porto fornito all'agiografo da questa vicenda, e come egli sene sia servito per tracciare quella di Tobi.
1 Cf. E.M. Cook, The Aramaic of the Dead Sea Scrolls, in P.W. Flint - J.C.Vanderkam (edd.), The Dead Sea Scrolls after Fifty Years. A Comprehensi-ve Assessment… With the Assistance of A.E. Alvarez i, Leiden-Boston-Köln1998, 359-378, spec. 359. Sulla #sionomia di questo dialetto cf. G. Garbini- O. Durand, Introduzione alle lingue semitiche (Studi sul Vicino Orienteantico 2), Brescia 1994, 52-53.
147
2. le menzioni di ahiqar in tobia
Ahiqar è citato espressamente in quattro passi: Tob. 1,21-22;2,10; 11,18; 14,10, nei quali le vicissitudini del potente primoministro assiro sono ricontestualizzate sullo sfondo di quelledi Tobi.1 La prima e l'ultima sono importanti per la qualitàdelle notizie che forniscono. Esse sono rilevanti anche dalpunto di vista narratologico, dato che appartengono alla cor-nice del libro, dove la critica attualmente tende a rintracciareil racconto originario.
2.1. Ahiqar alla corte assira (Tob. 1,21-22)
Con l'avvento del nuovo re, Esarhaddon (Saxérdonow nelleversioni greche),2 subentrato a Sennacherib, si ha un muta-mento nella politica verso gli Israeliti esuli in Assiria. Tobistesso – deportato sotto Sennacherib per aver violato il di-vieto del re dando sepoltura ai giustiziati – su mediazione diAhiqar, suo parente, ottiene di "ritornare a Ninive» (v. 22), ein un secondo tempo a casa (2,1), con moglie e #glio. Nellesue parole si delinea il ritratto di questo familiare illustre. Cidice che Ahiqar era "#glio di Anael» (v. 21), suo fratello,3 eche ricopriva cariche prestigiose alla corte assira, perciò ave-va forte in@uenza sul re: come sovrintendente generale, glispettava la giurisdizione su "tutte le #nanze del regno» e"autorità su tutta l'amministrazione» (v. 21). Si comprende1 Ad Ahiqar rimandano anche Tob. 4,17 (solo nel Gi) e 14,15 (secondo al-cune versioni). Tuttavia si tratta di menzioni indirette, la prima riferita piùche altro a uno dei PAh, la seconda discutibile dal punto di vista testuale.2 Nella VL si ha Archedonassar (v. 24); nella Vg (v. 25) il termine non #gu-ra. Sulle confuse traslitterazioni del nome di questo re è illuminante 4QTobara (4Q196), fr. 2, r. 8, dove si legge 'sr‹dwn, cioè Esarhaddon. Cf. Fitzmyer2003: 122.3 Con Grelot 1996a: spec. 330, sulla base di 4QTob ara (4Q196), fr. 2, r. 5,si può ritenere che il termine "fratello» per Anael sia usato qui in sensoproprio: "Le sage araméen entre ainsi dans la famille de Tôbî» (ibid., n. 9).La corruzione che ha subito il nome Anael nella tradizione testuale è atte-stata dalle versioni antiche: nel Gi.ii è reso ¦Anaúl, nella VL Annanihel (v.24); nella Vg (v. 25) non #gura. La forma corretta è quella restituita da4QTob ara (4Q196), fr. 2, r. 5, dove si ha ”n'l, "Dio ha risposto». Cf. ancheFitzmyer 2003: 122.
148
perciò che Ahiqar potesse intervenire anche economicamen-te in aiuto di Tobi, la cui situazione rimaneva molto precariaa causa della con#sca di tutti i beni, a seguito della sua fugadalla città.
Sulla #gura di Ahiqar Tobi offre qui tre indicazioni im-portanti, per la cui valutazione si dovrà tener conto delle va-rie forme testuali pervenuteci, compresa la VL1 e, ancor piùin questo caso, del testo qumranico, conservato unicamentenel primo dei cinque manoscritti (4QTob ara [4Q196]). An-zitutto Tobi precisa la tipologia delle cariche di Ahiqar. NelGii si dice che era "capo coppiere e gran cancelliere, capo del-l'amministrazione e sovrintendente della contabilità». Il con-fronto con 4QTob ara (4Q196), fr. 2, rr. 7-8, conferma il nu-mero (quattro) e la qualità di queste funzioni di Ahiqar, conalcune sottolineature signi#cative. Anzitutto precisa che sitratta di un rb šqh, cioè un "capo coppiere», non di un sem-plice "coppiere» (Gi; cf. 1 Re 10,5) o assaggiaveleni, confer-mando così la grande #ducia del re e la forte in@uenza di Ahi-qar su di lui. Il secondo titolo è reso nel testo qumranico conrb ”zqn, "guardasigilli (lett. "capo/custode dei sigilli reali»)»,2
mentre nel Gi.ii #gura al singolare; ciò ribadisce l'autorità diAhiqar, dato che il sigillo era consegnato "solo al funziona-rio più fedele e potente» per l'autentica dei decreti reali (cf.Gen. 41,42; Est. 3,10; 8,2.8). Gli ultimi due titoli, invece, pon-gono un problema linguistico più serio. "Capo dell'ammi-nistrazione» rende fedelmente il senso di dioikhtúw, del Gi.ii,hapax attestato anche nei papiri tolemaici d'epoca romanaper indicare l'amministratore delle #nanze pubbliche,3 e dihmrkl, di 4QTob ara (4Q196), che può derivare dal persianohamarakara, "ministro del tesoro».4 Con "sovrintendente
1 Infatti la VL – come fa notare Wise 1993: 566-570, spec. 567 –, che con iLXXS ha conservato il testo lungo di Tobia (Gii), il più vicino all'originale,"pur tradotta dal greco, deriva da un diverso sottogruppo di questa fami-glia testuale, rispetto a quanto fa il Sinaitico», perciò spesso possiede dellelezioni "uniche», oltre che numerose in comune con il Gi. Un elenco det-tagliato dei manoscritti della VL si trova in Fitzmyer 2003: 8 n. 32.2 Nella versione di Elefantina, nella col. i, r. 3, il titolo è formulato come[w‡]byt ”zqth, "[e gu]ardasigilli».3 Cf. Schüngel-Straumann 2000: 60 e anche Fitzmyer 2003: 123.4 Secondo quanto ha sostenuto J.C. Green#eld, *Hamarakara > 'Amarkal,
149
della contabilità» si traduce Àklogistúw, del Gi.ii, termine tec-nico che in P. Oxy. 1436.23 designa il funzionario dell'Egit-to ellenistico posto a capo di un distretto, incaricato della su-pervisione dei conti e delle entrate; 1 questo senso ha pure ilcorrispettivo qumranico [w]šyzpn, anche se rimane d'origineincerta.
Tobi poi spiega qual era il ruolo uf#ciale di Ahiqar sottoSennacherib. Il Gi informa laconicamente che Saxérdonow gliaveva assegnato quella funzione Àk deutéraw, espressione didif#cile traduzione. Nel Gii è preceduta dall'annotazione cheAhiqar aveva ricoperto tali ruoli già con Sennacherib,2 pri-ma che con Esarhaddon. Il confronto con il testo aramaicodi Elefantina conferma la continuità di questi incarichi sottoentrambi i re;3 perciò la locuzione è stata spesso resa, sullabase delle versioni, con "per la seconda volta», per dire cheEsarhaddon confermò Ahiqar nel suo incarico, o lo rinomi-nò (katésthsen a@tòn. . . Àk deutéraw).4 Tuttavia 4QTob ara
in M. Boyce - I. Gershevitch (edd.), W.B. Henning Memorial Volume (AsiaMajor Library s. n.), London 1970, 180-186. Cf. anche J. Hoftijzer - K.Jongeling, Dictionary of the North-West Semitic Inscriptions with Appen-dices by R.C. Steiner, A. Mosak Moshavi, and B. Porten (Handbuch derOrientalistik. Erste Abteilung. Der Nahe und Mittlere Osten 21) i, Leiden- New York 1995, 284, s.v. hmrkr. 1 Cf. Fitzmyer 2003: 123-124.2 Per sé in 4QTob ara (4Q196), fr. 2, r. 8, si legge 'sr‹ryb, ma, con Wise 1993:570 n. 9, e J.A. Fitzmyer, Preliminary Publication of pap4QToba ar, Frag-ment 2: Biblica 75 (1994) 220-224, spec. 223, lo si può considerare una forma"anomala» del nome Sennacherib – corrispondente all'ebraico san‹®rîb, delT.M. (cf. 2 Re 19,36), e all'aramaico Ðn‹'ryb o sn‹'ryb, dell'Ahiqar di Ele-fantina, col. i, rr. 3.4, e col. iv, r. 55 –, prodottasi per una confusione delloscriba, che per errore iniziò a trascrivere il nome Esarhaddon, ma concluse,inavvertitamente, con le ultime consonanti di Sennacherib. Sulle trascrizioniaramaiche del nome Sennacherib cf. Fitzmyer 2003: 116-117.3 Infatti, nella col. i, rr. 1.3, sotto Sennacherib Ahiqar è de#nito spr ‹kymwmhyr, "scriba saggio ed esperto», e [w‡]byt ”zqth zy Ðn‹'ryb mlk 'tw[r,"[e gu]ardasigilli di Sennacherib, re di Assi[ria]»; ibid., col. i, r. 12, sottoEsarhaddon è detto [s]pr' ‹kym' y”„ 'twr klh, "lo [sc]riba saggio, consiglie-re di tutta l'Assiria». I titoli sono poi ripresi e ampliati nella col. iii, r. 42, enella col. iv, rr. 55-56, designando Ahiqar, rispettivamente, come spr' ‹kym'wb”l ”„t' „bt', "lo scriba saggio e il maestro di buon consiglio», al tempo diquest'ultimo re, e 'bwh zy 'twr kl' zy ”l ”„th sn‹'ryb mlk' w‹yl 'twr [kl]'[00 hw]w, "il padre di tutta l'Assiria, dal cui consiglio il re Sennacherib e[tut]ta la gente di Assiria [er]a (guidata)», all'epoca del precedente.4 Cf. Priero 1963: 54 ("Sacherdonos infatti lo aveva rimesso in quella carica
150
(4Q196) suggerisce una diversa interpretazione, senz'altropreferibile. Qui l'espressione w'šl„h 'sr‹dwn tnyn lh, "edEsarhaddon lo nominò secondo [solo] a se stesso», fa pre-sente che Ahiqar è il primo funzionario, subito dopo il re,1 eche occupa una posizione che lo assimila ad Aman (Est. 3,10), Mardocheo (Est. 8,2.8) e Giuseppe (Gen. 41,42-43). Èevidente, quindi, che nel testo qumranico il ruolo di Ahiqaralla corte assira è descritto con maggior precisione che nelleversioni. Del resto, la stessa denominazione delle sue cari-che, come ha spiegato Contini,2 "riecheggia solo in parte» itermini con cui sono designati i funzionari assiri nei libristorici dell'A.T. e nell'aramaico di Elefantina; invece la tito-latura corrispettiva nel Gi.ii "ri@ette il linguaggio ammini-strativo tolemaico». Questo conferma che nei diversi ramidella tradizione la professione di Ahiqar e i suoi titoli onori-#ci hanno subito un processo di continua interpretazione e at-tualizzazione attraverso il lessico contemporaneo3 nei tenta-tivi di "storicizzarne la #gura».4
In#ne Tobi precisa il suo grado di parentela con Ahiqar,quali#candolo come suo "nipote» (Gi.ii); ma non risulta cheegli avesse veri fratelli o sorelle. Nemmeno l'espressione se-guente, dove Tobi lo designa come uno "della mia parente-la» (Gii), aiuta a risolvere il problema. In 4QTob ara (4Q196),fr. 2, r. 9, si legge br '‹y hwh, "egli era #glio di mio fratello»;ma, con Fitzmyer, le due lettere della prima parola e l'inizia-le della seconda sono da considerarsi di incerta lettura. An-
per la seconda volta»); R. Pautrel, Tobie, in La Sainte Bible de Jérusalem.La Sainte Bible traduite en français sous la direction de l'École Biblique deJérusalem. Nouvelle édition revue et corrigée, Paris 181998, 663-679, spec.664b ("et Assarhaddon l'avait maintenu en fonctions»).1 Così traducono Wise 1993: 569 ("he appointed him second [only] tohimself»); Fitzmyer 1995b, 9 ("Esarhaddon put him in charge as second tohimself»); Moore 1996: 116 ("Esarhaddon appointed him second only tohimself») e Schüngel-Straumann 2000: 59 ("Assarhaddon hatte ihm denzweiten Platz in seinem Reich gegeben»). Quindi, tnyn lh, "secondo a sestesso», è af#ne all'accadico turtºnu/tartºnu, "Mann an 2. Stelle» (W. vonSoden, Akkadisches Handwörterbuch iii, Wiesbaden 1981, 1332a-b, s.v.ta/urtºnu, ta/rtºnnu), come precisa anche Fitzmyer 2003: 124.2 Contini 1998: spec. 92.3 È la tesi di Schmitt 1996: spec. 37-38. 4 Contini 1998: 92.
151
che nel testo qumranico quest'espressione è seguita da altredue, wmn byt 'by wmn m‡p‹ty, "e dalla casa di mio padre edalla mia famiglia», che non consentono di de#nire meglio latipologia della parentela di Ahiqar con Tobi.1
2.2. Ahiqar esempio di rettitudine (14,10)
Tobi, ormai sul letto di morte, rivolge al #glio le ultime rac-comandazioni (14,8-11), richiamando la propria condottamorale, già presentata in 4,3-21. In particolare esorta Tobia ainsegnare ai #gli la pratica della giustizia e dell'elemosina (v.8), a dare onorevole sepoltura a lui e ad Anna, e a non rima-nere più oltre a Ninive, dove regnano l'ingiustizia e la per#-dia (v. 9). A questo precetto fa seguito il richiamo all'esem-pio del retto Ahiqar, a cui si contrappone l'ingratitudine diNadab (Gii; Nadin, o forse Nadan, nel racconto elefantino).Infatti Ahiqar lo "aveva allevato» (Gi.ii), e invece "fu ridottoa scender vivo sotto terra» (Gii); 2 ma "Dio ha ritorto l'infa-mia contro di lui», così "Ahiqar è tornato alla luce e Nadabè sceso nella tenebra eterna, per aver tentato di uccidere Ahi-qar» (Gii). Tobi stesso precisa il senso di questa menzione diAhiqar nell'applicazione moraleggiante con cui si chiude ilv. 10: "per aver praticato l'elemosina egli 3 sfuggì al lacciomortale, tesogli da Nadab; Nadab, invece, cadde in quel lac-cio, ed esso lo fece perire» (Gii). L'esempio, citato a sostegnodelle ammonizioni paterne, non #gura nella Vg e nelle ver-1 Secondo Grelot 1996a: 334, il testo qumranico rivela che nelle recensionigreche si è avuto un adattamento dell'originale: "Mais ce sont là des indi-cations purement sociologiques, alors que le livre tourne autour des rela-tions affectives de la famille».2 Si tratta di un riferimento allusivo a un motivo attestato anche nellaSAhSir, dove si dice che il saggio condannato scese nel nascondiglio prepa-rato per lui sotto la soglia di casa sua dalla moglie e da Nabusemakh. Suquesto aspetto del tema della morte apparente (Scheintod) nella SAh e inaltri racconti biblici e vicino-orientali antichi si veda Grottanelli 1987 (cit.nella rist. in Id. 1999: spec. 157 ss.).3 Nel Gi la pratica dell'elemosina, invece che ad Ahiqar, è attribuita a Ma-nasshw, "Manasse», con la nota confusione dei nomi di persona che carat-terizza questa recensione in 14,10. Certo non è possibile identi#care costuicon il per#do Manasse di 2 Re 21, 1-18, anche perché qui la vittima del tra-dimento è Ahiqar. Cf. anche Fitzmyer 2003: 334.
152
sioni semitiche; la VL vi fa un semplice accenno. Qualcheframmento del passo è riportato solo nel terzo (4QTob arc
[4Q198]) e nel quarto (4QTob ard [4Q199]) dei manoscrittiqumranici; ma in 4QTob arc (4Q198), fr. 2, rr. 1-5, il testo èmal conservato, perciò è pressoché impossibile proporne ilconfronto. Invece in 4QTob ard (4Q199), fr. 2, r. 1, che con-sta di una sola espressione, si trova un'indicazione signi#ca-tiva sul piano narratologico: infatti l'espressione [000 ”]wbdyndn[000 ],
1 "[000 le a]zioni di Nadin[000 ]», sottolinea che ilnarratore non ha voluto speci#care il comportamento di Na-dab, e questo presuppone che i lettori fossero a conoscenzadei fatti a cui egli si è limitato a fare una semplice allusione.Anche in questo particolare si può riconoscere un'ulterioreprova del sottile impianto narrativo che regge tutto il rac-conto. La conclusione di Tobi, che segue nel v. 11a, è gno-mica: "vedete, #glioli, ciò che fa l'elemosina e ciò che fa l'in-giustizia: uccide!».2 Essa ribadisce l'insegnamento di fondodel libro biblico: chi fa bene riceverà bene, chi fa male, male.Inoltre contiene la de#nizione del retto agire, cioè l'esseremisericordiosi con i fratelli. In de#nitiva, in questo passo iltema del giusto riabilitato in virtù della sua rettitudine è pre-sentato con due novità sostanziali rispetto ad Ahiqar: il na-scondiglio sotterraneo, in cui egli si segrega, e l'elemosina,che gli vale la salvezza. Infatti, la presentazione di Ahiqarche si legge in Tobia si avvicina più alla recensione "rielabo-rata e romanzata» 3 delle versioni tarde della Storia, e special-mente a quella della versione siriaca antica, come ha dimo-strato Green#eld.4 Oltretutto, #no al secolo scorso la vicen-
1 Similmente nel Gii: õsa Nadàb Àpoðhsen 'Axikçrƒ, "quanto fece Nadab adAhiqar», e nella VL: quid fecit Achicaro, "ciò che fece Ahiqar», che pre-suppongono quindi la stessa Vorlage. Il frammento non è riportato nelleedizioni di Beyer e di García Martínez - Tigchelaar, né in alcuna fotogra#adel Palestine Archaeological Museum; nel 1994 fu nuovamente fotografato.2 Con il Gii, più pertinente per la presenza anche dell'alternativa al negati-vo, che sintetizza l'intera vicenda di Ahiqar e Nadab; nel Gi, invece, si hakaì nˆn, paidðon, îde tð ÀlehmosÚnh poieø, kaì tð dikaiosÚnh êÚetai, "ed ora, #-glio, considera ciò che fa l'elemosina, e come la rettitudine salva», con cui sifa di dikaiosÚnh un sinonimo di ÀlehmosÚnh. Cf. anche Moore 1996: 293 n.al v. 11. 3 Contini 1998: 93. 4 Green#eld 1981b: 329-336.
153
da di Ahiqar era nota primariamente nella versione siriaca.1
Fu Hoffmann2 a collegare il saggio assiro con l'Ahiqar di To-bia; inoltre la versione aramaica di Elefantina è in diversipunti più laconica della siriaca.3 Contini segnala due ele-menti fondamentali nelle varie af#nità tra il racconto biblicoe il testo siriaco di Ahiqar. Il primo è "la presentazione diTobia come anti-Nadin»: infatti i medesimi insegnamenti emassime della sapienza tradizionale, con cui i due sono egual-mente formati, hanno esiti opposti, il vile tradimento da par-te del #glio adottivo Nadin (Nadab in Tobia), la pietà #lialee devota da parte di Tobia. L'altro è "l'aspirazione a una piasepoltura», uno dei temi centrali del libro, come pure l'elo-gio dell'elemosina, presenti in questo passo, che – com'è sta-to notato sopra – "potrebbe riposare su una diversa inter-pretazione di un originale aramaico (/ebraico postbiblico)‡dqh semanticamente ambiguo soggiacente alla ”rettitudine'(k'nwt') attribuita ad Ahiqar nella recensione siriaca antica».4
Le due menzioni centrali invece sono meno signi#cativesotto il pro#lo narratologico:
2.3. Ahiqar soccorre Tobi (2,10)
Nell'ampio contesto di 2,10, dove si narrano le circostanzeche portano Tobi alla cecità (v. 10a), viene di nuovo intro-dotta la #gura di Ahiqar. Le condizioni economiche di Tobi,già duramente colpito con la con#sca di tutti i beni (1,20),5
si fanno ancor più precarie a causa della malattia: la suben-trata inabilità al lavoro, insieme con le nuove spese per le cu-re mediche, aggravano ulteriormente il suo dissesto #nanzia-rio. Ma Ahiqar viene in soccorso di Tobi (v. 10b), provve-dendogli il necessario (Âtrecén me) "per [almeno] due» deiquattro anni della sua cecità, "prima della sua partenza perl'Elimaide» (Gii), cioè l'Elam, regione della Persia, a sud del-
1 Green#eld 1981b: 330. 2 Hoffmann 1880: 182-183.3 Green#eld 1981b: 333-334. 4 Contini 1998: 93.5 La notizia che si legge in Vg 1,25 – omnisque facultas eius restituta est ei,"gli fu restituito ogni suo avere» –, rimane una testimonianza isolata: si de-ve credere perciò che a Tobi non fu più reso nulla di quanto requisito inprecedenza.
154
la Media, con capitale Susa (cf. Gdt. 1,6). Nel testo qumra-nico il passo (2,10-11) è conservato solo nel primo manoscrit-to (4QTob ara [4Q196]), nel fr. 4, r. 1, di lettura incerta; laricostruzione proposta da Fitzmyer [0 00 l”y]lm b”d[n' dn 0 00 ],"[000 per l'E]lam. In quel tempo000 ]»,1 in linea con il Gii e laVL,2 conferma l'improbabilità dell'interpretazione di Dil-lon, che considera "Elimaide (Elymais)» un'errata interpre-tazione dell'ebraico ”lm, "nascondiglio», e perciò traduce"egli entrò nel nascondiglio (he went into hiding)».3 Nullasi sa, però, del motivo speci#co che induce Ahiqar a partire.
2.4. Ahiqar alle nozze di Tobia (11,18)
Al ritorno dal viaggio in Media, dopo aver riabbracciato i ge-nitori Anna e Tobi, che ormai ha recuperato del tutto la vi-sta, Tobia presenta ai familiari la nuora Sara; i "fratelli», cioègli stretti familiari o i connazionali che avevano partecipatoall'af@izione di Tobi nel giorno della sua malattia (2,10; Gii,VL), ora si associano alla sua festa (11,17). Fra essi accorro-no anche Ahiqar e suo "nipote»4 Nabad (= Nadab), e si con-gratulano con lui (v. 18). Si noti che l'agiografo non ha maimenzionato Nabad per l'innanzi; perciò questa sua compar-
1 Il passo non #gura nelle edizioni di Beyer e di García Martínez - Tigche-laar.2 Achicarus autem pascebat me annis duobus, priusquam iret in Limaidam(v. 15), "Ahiqar mi nutrì per due anni, prima che se ne andasse in Limai-da». 3 Dillon 1898.4 Il Gi legge „Axiçxarow kaì NasbÜw ó Àjçdelfow a@toˆ, "Ahiqar e Nasbas,suo cugino»; il Gii invece ha „Axixàr kaì Nabàd oí Àjçdelfoi a@toˆ, "Ahiqare Nadan, suoi (= di Tobi) nipoti», che pare preferibile. Così anche Moore1996: 261: "Ahiqar and his nephew Nadin», che intravede (ibid., 264 n. alv. 18) qui una chiara allusione all'"ingrato #glio adottivo (faithless adoptedson)» di Ahiqar. Per sé il sostantivo Àjçdelfow ha entrambe le accezioni di"cugino» e di "nipote», ma quest'ultima, che si af#anca a "cugino», è tipicadei LXX e speci#ca di Tob. 1,22 (25). Cf. H.G. Liddell - R. Scott, A Greek-English Lexicon… Revised by H.St. Jones… With a Supplement 1996, Ox-ford 91940, rist. anast. 1996, 581a, s.v. Del resto in J. Lust - E. Eynikel - K.Hauspie, A Greek-English Lexicon of the Septuagint… With the Collabora-tion of C. Chamberlain i, Leuven 1992, 156b, si annota solo il signi#catodi "nephew», assegnandolo a Tob. 1,22; 11,19, e designandolo come un neo-logismo.
155
sa priva di precisazioni sulla sua identità, oltre al legame diparentela con il saggio assiro, è un'ulteriore conferma dellatesi di Green#eld, che cioè il narratore presuppone che i suoidestinatari siano a conoscenza della vicenda del personaggio.I manoscritti di Qumran non aiutano a valutare questa men-zione, poiché non conservano alcun frammento del passo.
Tentiamo ora uno sguardo d'insieme. Si nota subito che ivari testimoni del testo riportano le citazioni di Ahiqar in for-me molto diverse; inoltre non #gurano, nemmeno parzial-mente, in tutte le redazioni. In alcuni manoscritti della VLmanca 1,21-22, ma, per lo più, nel resto essa è conforme algreco, che riporta tutti i quattro passi. Il Gii è il più preciso ericco di informazioni, mentre il Gi è spesso sbrigativo e al-l'oscuro di qualche particolare. Tuttavia, l'integrazione dellequattro menzioni con il rispettivo contesto appare spesso po-co armonizzata. Infatti i riferimenti ad Ahiqar non sembra-no in connessione signi#cativa con l'intreccio della vicendadi Tobi, tanto che potrebbero essere rimossi senza compro-metterne la comprensione. Se ne può pertanto concludere chesi tratta di probabili aggiunte tardive.
In questi quattro passi si intravede un doppio livello reda-zionale con varie strati#cazioni testuali: il primo è lo stratocomune a tutti testi greci, l'altro, secondario, è il risultato diuna lenta sovrapposizione di elementi testuali, aggiunti forsenel tentativo di apporre glosse esplicative ad alcune espres-sioni, che non sempre si riesce a chiarire. La redazione piùpertinente e informata sembra quella del Gii, che si basa suiLXXS ed è spesso ripresa nella VL. Nel testo aramaico diQumran si sono conservati 1,21-22; 2,10; 14,10, e si fornisce– soprattutto in 1,21-22 – un contributo esegetico importan-te, con espressa conferma dell'interpretazione del Gii.
Quanto all'analisi redazionale delle citazioni, risulta so-prattutto che la prima, la più estesa e articolata, in realtà nondà un contributo sostanziale alla narrazione; anzi, vi intro-duce alcuni elementi estranei e fuorvianti. Inutile appare, adesempio, l'inserzione di Ahiqar come mediatore nel perorarela causa di Tobi: già la nuova politica instaurata con l'avven-to di Esarhaddon avrebbe potuto esser garanzia suf#ciente del
156
suo ritorno dall'esilio. Inoltre l'eccessivo rilievo dato alla me-diazione del saggio assiro contraddice alla prospettiva del-l'intero libro, che mira a sottolineare la #ducia nella provvi-denza divina, piuttosto che in un intervento umano, per quan-to autorevole. Si intravedono poi chiaramente i due strati re-dazionali del passo: l'ambientazione storica del ritorno di To-bi a Ninive, poi la successiva aggiunta dei titoli e delle cari-che di Ahiqar. Il Gii, che precisa anche come il saggio assiropossedesse le stesse cariche che già ricopriva con Sennache-rib, per rafforzarne così l'autorità, rivela una piena conoscen-za degli eventi e dei documenti assiri, a differenza della con-cisione del Gi, e dell'anacronismo delle altre versioni, doveAhiqar è detto cancelliere solo di Sennacherib e quest'ultimoè detto #glio di Esarhaddon! La miglior conoscenza dei fattisi ha invece nella versione di Elefantina, ripresa nel Gii. Se neconclude che la seconda recensione greca è venuta a contattoin un secondo tempo con una copia di questo testo aramai-co, integrando esattamente i primitivi cenni del passo comu-ni alle altre versioni, che pure intervennero sul testo ma con-fondendo i dati, poiché ignoravano il racconto elefantino.
In 14,10 l'intervento redazionale è ancor più chiaro, datoche il passo, nelle fonti che lo conservano, sembra inserito po-co opportunamente: Tobi, infatti, ha già prima ammonito To-bia, esortandolo a partire da Ninive. La prima redazione deltesto, con le opposte vicende di Ahiqar e Nadab, doveva es-sere certo eloquente per i destinatari, che ben conoscevano ifatti narrati dall'agiografo; ma per i lettori successivi si im-posero delle integrazioni esplicative del valore esemplare diquell'episodio, intese a porre in rapporto la salvezza di Ahi-qar con la sua elemosina e la rovina di Nadab con la sua ma-lizia. Le aggiunte più importanti sono quelle del Gii e del Gi,oltre a quelle in comune con la VL.
Milik1 ritiene che le menzioni di Ahiqar in Tobia siano diprovenienza persiana, soprattutto a partire da 1,21-22, dovela carriera del saggio assiro è descritta "nei termini dell'am-ministrazione persiana»; sotto Esarhaddon la sua portata au-menta con l'introduzione della più alta carica persiana, quel-
1 Milik 1991-92: spec. 385-387.
157
la di "secondo dopo il re».1 Così in 2,10, dove si può sup-porre che Ahiqar si rechi a Susa, capitale del regno persiano,dal re dell'Elam, a nome del proprio re, accogliendo la s#daper un dibattito sapienziale. Il particolare è irrilevante per lanarrazione; logico concluderne che potrebbe essersi intro-dotto nel testo dalla tradizione orale o da qualche copia per-duta del racconto. Il viaggio ritorna anche nella successivaversione siriaca, ma è ambientato in Egitto. La novità è l'in-troduzione di un terzo interlocutore, il saggio, che sostieneil punto di vista del proprio re. Poiché quest'elemento non#gurava nel racconto elefantino, con Milik si può conclude-re che il tema della disputa fra re, "di origine indiana, piùche egiziana», potrebbe effettivamente essere stato inserito"nel romanzo del saggio assiro in epoca persiana».2
Anche in 11,18 il Gii si conferma come il testimone piùinformato e preciso; infatti parla di Ahiqar e di Nadab comeÀjçdelfoi di Tobi, sia pure di grado diverso. In effetti Ahiqar ènipote di Tobi, in quanto #glio di una sua sorella, e Nadab, è"nipote» di Tobi, essendo nipote a sua volta del saggio assi-ro. Anche in questo caso perciò i LXXS dovevano conoscerecertamente la versione aramaica del racconto, a differenzadelle altre fonti, che si limitano a de#nire Ahiqar "nipote» diTobi.
In de#nitiva, l'analisi redazionale conferma che i quattropassi in questione sono ritenuti come aggiunte esteriori al te-sto primitivo. Inoltre in essi è implicito un rapporto direttocon la versione aramaica di Elefantina: quando tale contat-to venne meno, il testo diventò oscuro. La cosa non si veri#canelle integrazioni esatte del Gii, che perciò deve aver attintoa una copia del racconto vicina o af#ne a quello elefantino.
L'analisi strutturale, invece, ribadisce che la prima e l'ulti-ma menzione, le più importanti, incorniciano la vicenda conil ritorno a casa del protagonista da un viaggio nelle regionifavolose dell'Oriente e con il conseguente comporsi di un or-dine morale di giustizia e tranquillità familiare, infranto da-gli imprevisti incontrati lungo la via. Le due citazioni centra-li, poi, inquadrano la prova di Tobi e la successiva letizia per
1 Milik 1991-92: 385. 2 Milik 1991-92: 386.
158
la guarigione e per il benessere ritrovati. È possibile perciòintravedere nel libro una doppia e concentrica inclusione let-teraria, individuata da tali citazioni, che forse servì a ribadirel'effettivo reimpiego di quelle due tematiche del racconto pri-mitivo, molto diffuso nel Vicino Oriente antico già prima diessere adottato dall'agiografo. In effetti le menzioni di Ahi-qar non aggiungono né tolgono alcunché di sostanziale al rac-conto dell'agiografo, ma piuttosto ne confermano la prospet-tiva. Certo, il nucleo originario dei vari passi e le relative in-tegrazioni risultano incomprensibili se non si ammette unadipendenza diretta dalla Storia di Ahiqar, probabilmente se-condo la versione elefantina. È plausibile infatti che l'autoredi Tobia possa aver conosciuto qualche forma scritta della vi-cenda del saggio assiro; il recensore dei LXXS (su cui si basail Gii), sia pure in tempi e luoghi diversi, può aver consultatoqualche copia af#ne di tale versione aramaica, esaminandolaperciò in una differente forma testuale, con il risultato di uncomplesso esito redazionale. Quindi, sebbene non sia possibi-le dire se per l'agiografo di Tobia il contatto con questo nu-cleo primitivo della vicenda di Ahiqar sia avvenuto già nellafase orale della trasmissione della Storia, o quando già ne eradiffusa una redazione scritta, è ormai assodata una voluta di-pendenza letteraria di Tobia da Ahiqar.
Tutto conferma l'attendibilità della linea interpretativa diGreen#eld, ripresa da altri studiosi di scuola italiana, che han-no privilegiato l'esame della versione aramaica nello studiodel problema critico, dato che la pubblicazione del papiro diElefantina ha permesso di comprendere meglio queste cita-zioni e coglierne il reale contributo alla prospettiva dell'agio-grafo. Vari autori, in un approccio narratologico a Tobia, vihanno rilevato un procedimento tipico di molte letterature,quello cioè di "inglobare personaggi e luoghi appartenentialla cultura generale del periodo».1 Tobia, perciò, farebbe ecoa quella catena di narrazioni sul saggio Ahiqar e il malvagio#glio Nadin, il cui più antico esemplare è il papiro di Elefan-tina. Infatti, poiché molti temi del libro biblico avevano ri-scontro anche nella vicenda di Ahiqar, il protagonista di que-st'ultima fu inserito tout court nella vicenda della famiglia1 Fales 1994: 41.
159
israelitica a Ninive. Quindi si può concludere che "un autoreebreo adattò quest'opera della letteratura (assiro-) aramaicaalla tradizione letteraria giudaica della diaspora in un roman-zo sapienziale di cui divenne protagonista l'ebreo Tobi, pre-sentato come parente di Ahiqar».1
3. l'apporto di ahiqar a tobia
Per cogliere l'entità del contributo fornito all'agiografo, i duescritti esaminati vanno anzitutto confrontati sulla base dell'af-#nità del loro genere letterario. Per Tobia esso sta fra la no-vella e il romanzo didattico-sapienziale, data la compresenzadegli elementi narrativi dell'una e dell'altro, sia pure con lanetta prevalenza del secondo, che con#gura la vicenda di To-bi come racconto del padre che consegna al #glio la propriaeredità morale e religiosa. Qualcosa di simile vale anche perAhiqar, che sarebbe insuf#ciente considerare come un roman-zo. Quanto meno, non può certamente esser considerato taleil racconto elefantino; lo possono, al più, e con qualche cor-rettivo, le versioni successive dello stesso, che appaiono co-me ampie rielaborazioni. In effetti – con Fales2 –, il confron-to della traduzione aramaica, per quanto frammentaria,3 conle altre fornisce "elementi suf#cienti di incongruenza o ri-dondanza» in quelle tardive, e lascia intendere che "il testopiù antico presentava una struttura a un tempo più semplicee lineare». Inoltre, dal punto di vista del messaggio, l'Ahiqardi Elefantina "sembra riprendere topoi consueti e ben assi-milati»: il giusto, caduto in disgrazia a causa degli empi, alla#ne sarà riabilitato a motivo della sua rettitudine, contandosulla benevolenza del re. In questo diverso impianto ideolo-gico la versione aramaica richiama i rapporti epistolari all'in-terno della corte assira, che attestano "vari appelli di sudditie cortigiani alla giustizia e alla benevolenza regia», cioè ri-mandano al "versante della cultura assiro-aramaica» della cor-te di Ninive.
1 Contini 1998: 93. 2 Fales 1994: 59.3 L'analisi del palinsesto eseguita da Ada Yardeni ha appurato che il testo del-la Storia, disposto su nove colonne, è mutilo delle ultime quattro. Dei PAhsi sono conservate nove colonne delle dodici originali (Contini 1998: 87).
160
Contini, nel ribadire1 l'appartenenza della Storia di Ahi-qar alla cultura mesopotamica e delle Massime a quella siria-na, conferma la "originaria indipendenza delle due sezioni».2
Nella linea di studi recenti, egli ritiene che il genere lettera-rio del racconto elefantino sia assimilabile alla leggenda dicorte, ben nota in tutto il Vicino Oriente e diffusa a livellopopolare nell'impero achemenide, come si vede anche nel ce-lebre Insegnamento di Anchsheshonqi, di età persiana. Talegenere è presente pure nella letteratura giudaica, in una seriedi scritti rielaborati in libri biblici d'età ellenistica, come ilCon@itto tra Mardocheo e Aman (nucleo più antico del librodi Ester), in alcune fonti dei primi sei capitoli di Daniele, Su-sanna e Bel e il dragone, e nel cosiddetto Proto-Ester, comepure nella Storia di Giuseppe (Gen. 37,39-50).3 In questeleggende i protagonisti appaiono quali rappresentanti positi-vi di un gruppo etnico presente in un grande impero gover-nato da un sovrano straniero. Tali leggende hanno inoltre latendenza a svilupparsi in forme narrative strutturalmente piùcomplesse, che abbondano in digressioni e inseriscono per-sonaggi minori; perciò per Ester, Daniele e le versioni tardo-antiche di Ahiqar si può parlare di novella o proto-romanzo.4
Alla luce di questi presupposti è chiaro che il libro di To-bia appare propriamente come un'aretalogia, cioè un raccon-to che intende proclamare "il potere di Dio di aiutare i suoidevoti», infatti "la glori#cazione della propria divinità o del-le divinità preferite […] era un tema letterario popolare inOriente».5 La diffusione di un unico linguaggio comune, cioèl'aramaico, e la mescolanza dei popoli sotto i sovrani assiri,neobabilonesi e persiani, contribuirono a favorire questa ten-denza nelle varie rielaborazioni di un motivo comune, che sta
1 Contini 1998: 102. 2 Contini 1998: 82.3 Infatti, secondo A. Catastini (ed.), Storia di Giuseppe (Genesi 37-50). ConIntroduzione di C. Grottanelli (Letteratura universale Marsilio s. n.), Ve-nezia 1994, e Id., L'itinerario di Giuseppe sulla tradizione di Genesi 37-50(Studi semitici N.S. 13), Roma 1995, il racconto andrebbe attribuito a unautore giudeo-egiziano del iv-ii sec. a.C.; P. Sacchi, Il problema della da-tazione della storia di Giuseppe (Genesi 37-50): Henoch 18 (1996) 357-364,propende piuttosto per un'epoca fra il vi e v sec. a.C.4 Contini 1998: 88-89. 5 Bickerman 1991: 92-93.
161
alla base di un racconto esso pure comune della cultura meso-potamica, nell'apparente forma di un romanzo che nascon-de in realtà ben diverse applicazioni a seconda della speci#caprospettiva di ciascuno scritto.
Pertanto il rapporto di dipendenza letteraria che lega To-bia ad Ahiqar dovette riguardare probabilmente una versio-ne aramaica "più tarda del testo di Elefantina, intermedia fraquesto e la recensione più elaborata» che si può collocare "al-l'origine delle due principali #liere della tradizione testualedi Ahiqar, l'orientale e l'occidentale».1 Questo potrebbe spie-gare la #sionomia anomala del genere letterario di Tobia, cheè qualcosa più che una novella, ma che non presenta ancoradistinta la forma del romanzo. Infatti, nonostante la sua ori-gine come #aba, il libro è radicato in un preciso tempo e luo-go, cioè nell'esilio. Inoltre l'agiografo si propone di rimaneg-giare e adattare il racconto alla letteratura sacra d'Israele, ci-tando soprattutto i libri storici,2 ma anche quelli profetici esapienziali. Perciò un racconto antico è ipotizzabile come ba-se: tuttavia è chiaro che la forma #nale del libro dipende piut-tosto dalla sacra Scrittura.
Un secondo problema riguarda il modo con cui l'agiogra-fo di Tobia usa il primitivo racconto mesopotamico di Ahi-qar per dar forma alla sua vicenda. Molto probabilmente eglivenne a contatto con una vicenda di diffusione internaziona-le, anteriore alle rielaborazioni successive. In effetti l'Egittodi età achemenide conobbe una vasta circolazione di scrittiletterari aramaici, di vario tipo e provenienza. È noto che laversione più antica di Ahiqar – il racconto assiro-aramaico ela precedente raccolta di massime di origine siriana – fu ac-colta presso la comunità di Elefantina alla #ne del v sec. a.C.e "probabilmente presso le stesse classi mercantili e ammini-
1 Cf. Contini 1998: 104, #g. 1, dove si riproduce, modi#candolo leggermen-te, lo stemma delle tradizioni diretta e indiretta di Ahiqar proposto da Fa-les 1994: 53, che a sua volta aveva corretto quello stilato da Lindenberger1983: 7, in cui però si tralasciava di indicare la dipendenza di una delle tra-duzioni siriache e di una delle neoaramaiche da una Vorlage araba.2 In particolare, A.A. Di Lella, The Book of Tobit and the Book of Judges:An Intertextual Analysis: Henoch 22 (2000) 197-206, sostiene che la peri-cope di Tob. 12,11-22 è stata modellata su Giud. 13.
162
strative», alle quali pare destinato particolarmente il genereletterario internazionale della leggenda di corte.1 Del resto,le scoperte epigra#che e le analisi comparative con le lettera-ture vicino-orientali e con quella greca attestano un "rappor-to di interdipendenza culturale» delle letteratura ebraica delpostesilio con le culture circonvicine, a partire dalla tradizio-ne aramaica, che anche in Palestina era bene affermata a livel-lo amministrativo, letterario, e come lingua dei rapporti quo-tidiani.2
Scrivendo in questa lingua, un autore si rivolgeva a un udi-torio internazionale, come si evince dalla versione aramaicadella Storia di Ahiqar, che è "libera da ogni tinta nazionali-stica»; così la vicenda del saggio assiro si divulgò un po' intutto il mondo antico.3 Parimenti, "libri giudaici in aramaicodovevano essere capiti alla frontiera dell'Egitto come pure al-l'estremità meridionale del Mar Caspio». Tobia è un esem-pio di questa nuova prospettiva. "Scritto con rara abilità e mo-strando l'eredità di una lunga tradizione letteraria», esso "ac-quistò una tale popolarità che, sebbene l'originale semitico siaandato perduto (eccetto che per frammenti tra i rotoli delMar Morto), tre differenti edizioni greche sono giunte #no anoi».4 Pertanto, la questione dei rapporti fra Ahiqar e Tobianon può più porsi nei termini della priorità dell'uno sull'al-tro.5 Si tratta invece di capire quando l'agiografo sia venutoa conoscenza della Storia di Ahiqar: infatti la presenza dellemenzioni dirette del saggio assiro potrebbe teoricamente spie-
1 Contini 1998: 102. L'autore si è già interessato della letteratura aramaicain prosa rinvenuta in Egitto in copie papiracee nella #ne del v sec. nella bi-blioteca della comunità giudaica di Elefantina in un precedente studio: Id.,I documenti aramaici dall'Egitto persiano e tolemaico: Rivista Biblica 34(1986) 73-109. In quello che si è menzionato, ha privilegiato gli scritti piùimportanti, nelle loro "implicazioni comparative per l'Antico Testamen-to»: il romanzo e i proverbi di Ahiqar, e la collezione di poesia religiosadel papiro Amherst 63 (1998: 81). 2 Contini 1998: 101.3 Bickerman 1991: 85-86. 4 Bickerman 1991: 86.5 Priero 1963: 25 cita le due posizioni dei critici del passato, divisi fra chisosteneva che Ahiqar avesse dato spunto alla composizione di Tobia (Har-ris, Halévy, Simpson), e chi invece (Hoffmann e Vigouroux) riteneva cheun autore, partendo delle citazioni di Ahiqar in Tobia, avesse ideato il ro-manzo del saggio assiro inserendovi le due serie di sentenze sapienziali.
163
garsi anche con la contemporaneità dei due libri, venuti a con-tatto mediante tradizioni orali.1
In de#nitiva, sembra preferibile pensare, con Green#eld,che non avendo Ahiqar bisogno di presentazione per i letto-ri "il riferimento a lui fornì una struttura entro la quale po-tesse essere inserito il racconto di Tobi».2 Ahiqar dunque noncostituì certo un archetipo per l'agiografo del libro di Tobia;ma – secondo un procedimento letterario non lontano dallacontaminatio dei classici –, egli sfruttò la notorietà di questavicenda, riprendendone liberamente vari elementi e adattan-doli alla sua prospettiva, per diffondere autorevolmente ilproprio messaggio, arricchito forse con la parziale riproposi-zione della gnÊmh del racconto assiro-aramaico. Proprio gliinnegabili riferimenti, diretti e allusivi, ad Ahiqar in Tobiaerano eloquenti per il lettore antico; perciò il libro di Tobianon fu solo in@uenzato dal racconto di Ahiqar a livello let-terario, ma quest'ultimo servì anche per la narrativa di Tobiae per le sue #nalità didattiche: infatti non solo i due protago-nisti erano af#ni agli occhi dell'agiografo, ma anche le lorovicende erano in correlazione.3
Un terzo problema riguarda l'individuazione del contribu-to speci#co di Ahiqar all'elaborazione della vicenda di Tobi.L'analisi testuale ha confermato anzitutto che l'apporto del-l'assiro-aramaico a Tobia è maggiore, e più diretto, di quellofornito da altre fonti extra-bibliche, consistente nell'uso delmedesimo schema tematico e impianto narrativo, sia pure congli innegabili e sostanziali correttivi dell'agiografo. In entram-bi i racconti il narratore è il protagonista dell'opera, e la tec-nica adottata è quella del @ash-back, dato che, avanzato neglianni, egli rievoca in prima persona gli avvenimenti che lo ri-guardano, accennando anche al tempo della sua giovinezza(§ 66a4 // Tob. 1,4). Del resto, nella #sionomia dei due pro-tagonisti ritornano tratti molto simili, che danno risalto allaloro saggezza, pietà religiosa, età avanzata e ricchezza, per1 Priero 1963: 25.2 Green#eld 1981b: 331. Cf. Nickelsburg 1996: spec. 343: "The Story ofAhiqar is a speci#c story that our author certainly knew and used».3 Green#eld 1981b: 334.4 La divisione in paragra# è conforme a quella di Pennacchietti 1981: 51-95.
164
Ahiqar, secondo il costume orientale, descritta come posses-so di sessanta mogli e sessanta castelli (§ 66a // Tob. 1,3.14.20). Identico, poi, nelle due vicende sembra il motivo con-duttore: il giusto si salva per la sua rettitudine. Questo è ilpunto di raccordo di varie linee tematiche, fra cui spiccano ledue che risalgono a un celebre racconto popolare dell'anti-chità utilizzato anche in Ahiqar: disgrazia e riabilitazione diun ministro (che in Tobia diventa la storia di un pio osser-vante perseguitato ingiustamente e in#ne salvato); ingrati-tudine di un nipote (che in Tobia è trasposta al positivo nel-l'immagine edi#cante della devozione di un #glio). In Tobia,perciò, esse sono riprese con importanti innovazioni: qui siparte dal fatto che il giusto si salva per la sua rettitudine, equesta trova espressione nell'elemosina, che comprende nonsolo la solidarietà diretta con il prossimo, ma anche la pietàreligiosa verso Dio. Il secondo tema, poi, è capovolto, datoche nel libro biblico si tratta della devozione e obbedienza diun #glio, il che sta a ribadire, non più per antitesi (come inAhiqar), ma per conferma, la stessa tesi di fondo del primotema. In#ne, in entrambe le opere i due temi sono svolti nel-la cornice del libro, e inquadrano allo stesso modo le ri@es-sioni sapienziali che, in forma diversa (parenetica in Tobia,sentenziosa nella prima serie dei Proverbi di Ahiqar), e condifferente rilievo, sono collocate nel corpus del libro.
In Tobia, però, essi sono collocati entro due circostanzefondamentali della vita umana: il matrimonio nella propria fa-miglia o tribù, sia per Tobi che per Tobia, e la degna sepolturadel cadavere, specialmente il m®t mi‡wâ, cioè "il cadavere ab-bandonato» (1,17-18; 2,4-7). Di questo, invece, in Ahiqar nonvi è traccia, se non nell'insistenza sul motivo della propriasepoltura, della quale il protagonista è vivamente preoccupa-to (§ 66b // Tob. 4,3), #no a giungere a pregare Dio che gli con-ceda un #glio, poi ad adottare il #glio della sorella, Nadin, ea crescerlo come suo erede, perché a tempo debito possa occu-parsi della sua sepoltura. Controverso è invece il tema del-l'elemosina, che per entrambi consiste nella rettitudine e giu-stizia di fronte a Dio, ma anche nella pietà e misericordia peri deboli (§ 76a: massima 2; § 77b // Tob. 1,3.8; 14,10). Al pro-posito, giova osservare che questo termine ha subito qui una
165
rilettura semantica, dato che nell'esempio portato da Tobi aTobia (14,10) Ahiqar è presentato come persona salvata dal-l'elemosina. Tuttavia Ahiqar non fu mai prodigo di elemosi-ne, ma esemplare per la sua rettitudine. Ciò conferma quantogià si anticipava, cioè che il siriaco k®n¯ƒâ traduce un origi-nale aramaico ‡idqâ/‡edaqtâ, usato in Tobia nel senso di "ele-mosina», più che di "rettitudine».
Quindi, in Tobia buona parte degli elementi narrativi attin-ge al mondo della sapienza, oltre che al Pentateuco e ai Pro-feti. Proprio il richiamo esplicito e allusivo ad Ahiqar potreb-be esser suggerito all'agiografo dal tentativo di rilanciare, at-traverso il motivo del giusto salvato grazie alla sua rettitudi-ne, la concezione tradizionale della sapienza – in forte crisi intutto il Vicino Oriente antico dalla #ne del iv sec. a.C. –, neisuoi legami fra mondo ebraico e internazionale.
Bibliogra#a ricorrente
Bickerman, Elias J.1991 Gli Ebrei in età greca. Con introduzione di L. Troiani, Bolo-
gna.Hanhart, R. (ed.)1985 Septuaginta. Vetus Testamentum Graecum Auctoritate Acade-
miae Scientiarum Gottingensis editum viii/5. Tobit, Göttin-gen, 2a edizione.
Schüngel-Straumann, Helen2000 Tobit. Übersetzt und ausgelegt (Herders Theologischer Kom-
mentar zum Alten Testament 19), Freiburg i.Br. - Basel - Wien.