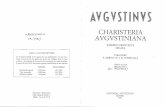Porro_Sinceritas veritatis. Sulle tracce di un sintagma agostiniano
Tracce di arcaismo greco nella scultura egizia di epoca tolemaica, in “Rendiconti della Pontificia...
Transcript of Tracce di arcaismo greco nella scultura egizia di epoca tolemaica, in “Rendiconti della Pontificia...
Estratto dai RENDICONTI
della Pontificia Accademia Romana di Archeologia, volume LXXIII 2000,2001 (fuori commercio) - --- ------
Traeee di areaismo greeo nella seultura egizia di epoca tolemaiea
DI
G. CAPRIOTTI VITTOZZI
Tipografia Vaticana
TRACCE DI ARCAISMO GRECO NELLA SCULTURA EGIZIA DI EPOCA TOLEMAICA *
Dr
GIUSEPPINA CAPRIOTTI VITTOZZI
1. P REMESSA
II campo di rice rca di questo lavoro e l'espressione artistica del periodo
tolemaico, quello che potremmo definire un territorio di confine: nella ter
ra d 'Egitto, da tempo immemorabile meta di gruppi culturalmente eteroge
nei, l' impiantarsi della cultura greca produce frutti di grande valore. COSl, se
da un lato nasce la grande arte alessandlina di espressione eUenistica, dal
l'altra Ie officine indigene, particolarmente queUe che possiamo chiamare fa
raoniche, continuano a realizzare progetti di tipo tradizionale. Tra questi
due poli culturali e artistici, nasce, e diventa sempre piu produttiva, un tipo
di arte, quella «greco-egizia ", che doveva essere particolarmente efficace e
compresa in un orizzonte culturale vario e «bilingue " come l'Egitto tole
maico, un 'arte tuttavia che per noi presenta spesso vere difficolta esegetiche.
el XX sec., comunque, grazie soprattutto all'attivita p ionieristica di Ber
nard von Bothmer e della sua scuola americana, I 10 studio deU'arte tolemai
ca ha compiu to dei poderosi passi in avanti rive lando iI grande fascino di
quest' espressione multiculturale.2
* Letta nell 'Adunanza pubbJica del 26 aprile 200l. 1 Ringrazio la dott. Laura Fabbrini che mi ha incoraggiato a svi luppare in questo studio
a1cune idee e osservazioni, mettendo generosamente a disposizione conoscenze e riflessioni nel corso di numerose quanto memorabili conversazioni. Ringrazio la dott. Dorothea Arnold, Direttrice della sezione egizia del Metropolitan Museum of Art di New York, e il dott. France co Buranelli, Dire ttore dei Musei Vaticani, per aver concesso rispettivamente Ie foto 0. 2 e 3, 1 e 6. Un grazie di cuore, infine, al dott. P.E. Stanwick per l'amichevole aiuto.
! Esemplifican do, ci cita solo la prima grande opera nel settore, il catalogo ESLP, e il pili recente volume in corso di starnpa di P. E. Stanwick, fr utta della dissertazione di dotlOralO ( r.-\." \1CK 1999). el presente lavoro non viene citato nelle note ESLP, aI quale si li
sale daIIa bibliografia successiva qui riportata per Ie varie sculture.
178 REI D. DELLA PO IT. ACCAD. ROM. D'ARCH. - VOL. LXXIII
2. aTE SU ALCUNI ASPEITI DELL' ICOI OGRAFIA Dr REGINE TOLEMAICHE
La presente indagine prende in esame particolarmente a1cuni sviluppi
nell 'ambito della statuaria regale femminile: 3 in epoca tolemaica sopravvivo
no antichissime tendenze iconografiche e, spesso, il ricorso a modi tipici di
un glorio 0 passato svela precisi intenti propagandistici.4 In altri casi, ad una
impo tazione tradizionalmente egizia della figura femminile, si aggiungono
elementi di provenienza diversa come Ia cornucopia.5
n modo di considerare e rappresentare Ia figura femminile, paiesemente
rno trata nella sua anatomia, resta nell 'arte egizia di epoca ellenistica e ro
mana anche quando si progredisce in una degenerazione del can one tradi
zionale. come si puo osservare in una regina conservata a Yale 6 0 in un 'alu'a
figura non regale al Museo Gregoriano egizio 7 (fig. 1), nelle quali Ie linee al
lungare del bu to, Ia rotondita delle spaUe, Ie proporzioni dei seni e dei fian
chi no ormai Iontane dalle figure u·adizionali. Tornando al genere di regi
na con cornucopia, ci meraviglia dunque, in una statuetta al Metropolitan _fuseum di _ -ew Yorks (fig. 2), il rapporto totalmente diverso, che qui tro
viamo. tra il corpo femminile e la veste che nulla las cia u'apelare, quasi fosse
modeUata un cilindro: l'abito e di ascendenza egizia, annodato suI petto,
pur rispondendo al !!USto ellenistico per i panneggi; esso e dello stesso tipo
di quello della tama ,-aticana (fig. 1) rna produce un effetto totalmente di
,·erso nelle due f!Ure. modellandosi completamente suI nudo femrninile in
un caso. nelralrro na.scondendolo del tutto. Puo essere utile, dunque, porre
a confronro i due tipi sculrorei 0 servando come nella statua vaticana l'abito
perde importanza rispeno al corpo rnentre ne acquista nella scultura di New
York: nella prima il panneggio dell'abito e appena disegnato, nell'altra esso
e meglio ,. ·bile. descrino da pieghe geomeu'iche e calligrafiche, quasi rne
talliche. n tipo rappresentato dalla tatua vatican a e piu evidentemente lega-
3 E pro imo alia pubblicazione un mlume di . Albersmeier su questo argo mento, derivante anch'esso da una tesi di donorato.
< CAPRIOlTl VrrroZZl199 . 5 Si consideri La bella tama delrErmi cre (n. 3936) 0 quell a frarnmentaria di Torino
(Cat. 1385): CAPRIOlTl VrrroZZl 1995: 1:.-\.'"" 1999. cal. F3, pp. 498-499, tav. 122 (statua di Torino) ; STAN\\~CK 1999, cat. F6, pp. 502-504 SIatua di San Pietroburgo); Cleopatra Tegina d'Egitto, p . 119 cat. n. 11.4, pp. 122-123 cat. n. 11.9.
6 Yale University Art Gal lery, YAG 1931.106: 1 6. p. 169 cat. n .95; STANWICK 1999, cat. D12, pp. 464-465 , tav. 98.
7 Museo Gregoriano Egizio n . 22800, alt. COL 143: Born - Ro~-\"'ELLl 1951 , pp. 99-100 n. 148, tav. LXIX.
8 Metropolitan Museum of Art n. 20.2.21: Cleopairns EgJpt. pp. 170-172 cat. n. 66; CA. PRIOTT! VITTOZZI 1995; STAN\I'ICK 1999, cat. C25, pp. 445-447. ta,-. 7.
G. CAPRIOTTI vrrrOZZI - TRACCE Dl ARCAISMO GRECO NELlA SCULTURA EGIZlA... 179
Fig. 1. Statua femmin ile nel Museo Gregoriano
Egizio, inv. n. 22800 (foto gentilmente concessa
dall 'archivio fotografico dei Musei Vaticani)
Fig. 2. Statua di Arsinoe II aI Metropolitan Mu
sewn of Art di New York, inv. n . 20.2.21; Rogers
Fund, 1920 (foto gentilmente concessa dal
Metropolitan Museum)
180 REND. DEllA POI T. ACCAD. RO~l O'ARCH- - \'OL L\Q(JII
to alIa tradizione autoctona anche nel ,iso e nelracconciatura; n ell 'altra fi
gura, il volto, di un gusto massicciamente geometrico poco 0 nulla deve alIa
tradizione egizia sui visi femminili. L'acconciatura e composta da boccoli,
che scendono ordinatamente sulla fronte, incorn.iciano il viso, raggiungono
Ie spalle; il coronamento, che e andato perduto per la frattu ra, doveva esse
re tipicamente egizio. L'iscrizione geroglifica, dietro il pilastrino dorsale del
la statua del Metropolitan, ci dice che la regina e Arsinoe II Filadelfo divi
nizzata. Sicuramente nella stesso ambito artistico va collocata anche un 'altra
tatuetta al Metropolitan Museum (fig. 3) ,9 una Cleopatra: l'abito e dello stes
so tipo, COS! come il totale disinteresse per il corpo sottostante; anche qui ab
biamo un'acconciatura di boccoli, in questo caso, pera, piccole trecce ritor
te coprono la fronte. Un'altra testa al Museo di Brooklyn 10 apparteneva ad
un tipo simile. L'attestazione pill antica in Egitto, di un'acconciatura a sin
goli boccoli, allo stato attuale delle nostre conoscenze, si trova nella tomba di
Peto iri a Tlma el-Gebel, datata al IV sec. a.c. La tomba, 0 meglio il tempio
funerario di que to santo sacerdote, e un monumento famoso per la coesi-
tenza di rilievi tipicamente egizi con altri che propongono grandi novira ico
nografiche Ie quali farebbero pensare ad una provenienza dall'arte grecaY
n tipo di capigliarura, spesso definita «libica », fu in epoca tolemaica e ro
mana diffusa dall'iconografia delle regine tolemaiche e da quella isiaca: tale
acconciatura embrerebbe piuttosto diversa da quelle a piccoli riccioli com
patti proprie della tradizione egizia. ell 'ultimo scritto di B. von Bothmer,
stampato postumo, 10 studioso accennava ad una possibile derivazione di
questa capigliatura dalla scultura greca. 12 Alcune statue di komi ad Atene mi
sembrano particolarmente significative, per i lunghi boccoli che scendono
sulle spalle e anche per Ie ciocche, intrecciate e ritorte sulla fronte , che ab
biamo visto n ella Cleopatra del Metropolitan e nella testa a Brooklyn : si os
servi in particolare la kore n . 682 del Museo dell'Acropoli 13 (fig. 4). Tornan
do ora a considerare l'anomalia, dal punto di vista egizio , dell 'abito nelle due
statuette a New York, possiamo notare che anche qui Ie piegh e calligrafiche,
che scendono simmetriche sull 'asse della figura a sottolineare il mazzo di
stoffa che sembra una trave, hanno un preciso riscontro nelle figure femmi-
9 Metropolitan Museum of Art, n. 89.2.660: CAPRIOTTI VITTOZZI 1995 (vi si propon e
un 'amibuzione a Cleopatra I); CleO'patra regina d'Egitto, p. 121 cat. n. II. 6 (vi si propon e
un 'attribuzione a Cleopatra VII) ; STANWICK 1999, cat. F2, pp. 497-498. 10 Brooklyn Museum of Art, n. 71.12: STAI'IWICK 1999, cat. Fl, pp. 495-496, tav. 120; Cleo-
palm regina d'Egitto, p. 122 cat. n. II.7. 11 LEFEBVRE 1923-24, III, taw. XXXV e XLVI. 12 BOTl-L\1ER 1996, p. 225. 13 RiCl-ITER 1968, pp. 73-75 n. 116, fig. 362-367.
G. CAPRIOTII VlTIOZZI- TRACCE OJ ARCAISMO CRECO ELlA SC LTURA EGIZLA .. 181
Fig. 3. Statln d i regina tolemaica (Cleopau'a) al Metropolitan Museum of
An di New yo,'k, in\'. n. 89.2.660; Gift of Joseph W. Drexel, 1889 (foto genti lmente concessa dal Meu'opoli tan Museum)
182 REND. DELLA PONT. ACCAD. ROM. D'MCH. - VOL. LXXllI
Fig. 4. Statua di kore ne! Museo dell 'Acropoli di Atene, inv. n. 682 (foto ri
prodotta da RICHTER 1968, fig. 366)
C. CAPRlOTTl VrnOZZl - TRACCE Dl ARCAlSMO CRECO NEllA SCULTURA ECIZIA... 183
nili arcaiche della scultura greca. La trabea e Ie pieghe che da essa divergono
diventano poi uno dei motivi p ortanti dell 'arte arcaizzante. Infine, il drap
peggiarsi dell 'abito non direttamente sulle forme femminili, come ancora
nelle figure tolemaiche di tradizione autoctona (fig. 1) , ma su una sorta di
solido geometrico, che Ie lascia solo in parte intravedere, non ha alcun ri-
contro n elJa millen aria tradizione egizia bensi e tipica espressione della pill
antica scultura greca. E inevitabile supporre l'esistenza di un modelIo im
portante cui queste statuette fanno riferimento.
3. BREVI CENNI AI PRODROMI Dl UN RAPPORTO FECONDO: AUCRATI E ME FI
La cul tura figurativa egizia incontro molto presto quelJa greca di epoca
arcaica, e anzi illustri studiosi hanno, negli u ltimi decenni, ampiamente di
mostrato che la scultura greca arcaica monumentale, quelIa dei kouroi, mol
to deve alIa tradizione egizia. 14 E utile richiamare l'attenzione su due centri
che particolarmente dovettero essere veri laboratori culturali nei quali Egit
[0 e Grecia si incontrarono in epoca piuttosto antica, quando la Grecia era in
uno dei maggiori momenti creativi, il periodo arcaico, mentre in Egitto l'ar
te guardava al glorioso passato producendo raffinati arcaismi. el periodo
aitico, tra VII e VI sec. a.c., molti Greci giunsero in Egitto: mercenari al ser
vizio del faraone , che si stanziarono numerosi anche a Menfi; commercianti
che ebbero a Naucrati un emporio di grande importanza; ma anche uomini
di cultura e d'arte che giungevano in Egitto in una sorta di pelIegrinaggio at
rratti dalla sua milIenaria civilta.
Naucrati , sono venute alIa luce piccole sculture di tipo greco, come
piccoli kouroi in pietra egiziana, Alcuni studiosi hanno messo in rilievo la
pre enza di Ciprioti a Naucrati. e il ruolo di Cipro nel porre in contatto l'E-'tto e il mondo greco: 15 Ateneo 16 ci narra che durante la 23° Olimpiade
(nella prima meta de l VII sec.) , Erostrato di laucrati, un commerciante,
ayeya acquistato a Pafo una statuetta di Afrodite; avvicinandosi all 'Egitto, la
nave ulla quale era imbarcato era stata coinvolta in una terribile tempesta
dalla quale benevolmente la dea di Pafo, invocata, 10 aveva salvato. Tornato
a ::\aucrati, Erosu'ato aveva dedicato la statua, ornata di mirto , n el locale
tempio dando inizio alla tradizione delle corone di Naucrati , della quale
speci.ficamente Ateneo si vuole occupare in questo capitolo. Nel porre in
]. Gt.,'RAI..l 1CK 1978, p. 470; K YRJELEIS 1996, pp. 68-86, 108-120, 121-127; CHINERY 1996. 1> i \'eda in particolare DAVIS 1979 e DAVIS 1980, come pure DE SALVIA 1989; D E SALVIA
1993: JE.'.1ill1S 2001. Ateneo XV, 676 c-d.
184 REND. DELLA PONT. ACCAD. ROM. D'ARCH. - VOL. UOmI
circolazione idee e irnmagini egizie , la Grecia insulare, oltre a Cipro, ebbe
un ruolo importante e particolarmente Sarno con il suo santuario, dove so
no stati anche trovati molti oggetti egiziY Dall 'ambiente samio, proviene an
che un 'interessante figurina femminile in bronz~, testimonianza degli scam
bi tra Ionia e Vicino Oriente e particolarmente dei rapporti tra Sarno e I'E
gitto: 18 il viso tondo e sorridente e incorniciato da un 'acconciatura liscia
molto simile, n ella forma, alIa parrucca tripartita egizia; l' abito, dal quale
spuntano grandi piedi geom etrici, fascia la figura affusolata conferendole
quasi l'aspetto di un ushabti.
Menfi , grande capitale e centro religioso, attiro gli stranieri fin da un 'e
poca molta antica: in torno al grande tempio di Ptah si stabilirono genti di
origine vicino-orientale, poi Cari, Ioni e, genericamente, persone di cultu
ra greca. Si noti una figura femminile trovata a Menfi 19 (fig. 5), nell 'area di
Mit Rahina, e attribuita all 'arte greca del VI sec. a .C. Gli studiosi hanno ri
levato, nella kore di Menfi, delle anomalie che rivelano una contaminazio
ne con l'arte egizia e sono davvero notevoli n el trattamento della testa: non
solo gli occhi e Ie sopracciglia erano incastonati, ma anche la capigliatura
e il coronamento circolare, un modio 0 un polos, erano aggiunti in diverso
mate riale. I solehi che ospitavano i riccioli sparsi sulle spalle conservano
tracce di pasta blu e que to particolare allude forse ad una contaminazio
ne iconografica oltre che stilistica: in Egitto la chioma blu 0 azzurra e tipi
ca di divin ici e in particolare di Hathor, dea della bellezza e dell 'amore poi
assirnilata ad Mrodite, oltre che ad lsi; azzurra e dunque la chioma d i don
ne descritte nella loro bellezza, come la celebre principessa ramesside al
Museo del Cairo .20 Una lirica d 'amore datata al Nuovo Regn o,21 tramanda
ta dal papiro Ch ester Beatty I, lodando la be llezza della donna, ne canta 10
splendore aureo della pelle e la chioma azzurra come lap islazzuli, in una
d escrizione ch e la assimila ad Hathor, la Dorata, o ltre ch e alla stella Sothis
che annuncia la buona annata. 22 La statuetta di Mit Rahina, dunque, appa
re com e l'eccezionale creazio ne dell 'ambiente multiculturale menfita do-
j7 SCl-L\UDT 1968, pp. 113-119;J ANTzEN 1972; DAVIS 1981.
18 E conser vata nel museD eli Sarno . BlANCH] BAN DI NELU - PARlJlENI 1976, n. 159. Devo que
sta indicazione alIa cortesia de lla dott. Laura Fabbl-ini.
19 EDGAR GGG, p . 3 n. 27431, tav. I; RICHTER 1968, p. 94 n. 170, fig. 540. Si noti l' attinenza
di questa figura con quella al Museo dell 'AcropoJi, n. 681 (RICHTER 1968, pp. 69-70 n. 110,
fig. 340).
20 BORCHARDT GGG, II, p. 152 cat. n. 600, tav. 108; DONADONI 1981, p. 200 .
21 MATI-liEU 1996, p . 22: si tipona la tradizion e egittologica che data approssimativa
mente il papiro alia XX dinastia.
ti BRESC!ANI 1969, p. 428; MATHI EU 1996, pp. 26-27. Su\l'associazione tra la chioma di la
pislazzu li e la divinitii , si veda MATHlE:u 1996, p. 36 n ota 34.
G. CAPRIOTTI VITTOZZI - TRACCE Dl ARCAlSMO GRECO ELLA SCULTURA EGIZIA... 185
Fig. 5. Slatua di kare aI Museo del Cairo, Cal. Gen. n. 27431
(foLO riprodotta da RICHTER 1 968~ fig. 540)
186 REND. DELLA PONT. ACCAD. ROM. D'ARCH. - VOL. LXXIII
ve, al culto di Hathor, si sovrappose in epoca molto antica Astarte, I'Mro
dite degli stranieri citata da Erodoto 23 e, forse molto presto, anche l'Mro
dite greca.24 Quando in epoca tolemaica, dunque, emergono nella scultura
egizia stilemi de ll 'arcaismo greco, questo trova in Egitto degli archetipi
precisi e significativi. Cercheremo ora di formulare delle ipotesi per la com
prensione di questo fenomeno.
4. ELEMENTI Dr ARCAISMO GRECO IN AMBIENTE TOLEMAICO
Un certo gusto per l'arcaismo impronta la propaganda tolemaica fin dal
Ie monete battute da Tolemeo Soter prima dell'ascesa al trono d 'Egitto, n elle
quali si vede I'Atena Promachos arcaizzante, del tipo che continuava ad essere
riprodotto nelle anfore panatenaiche del IV sec.: tale figura doveva promuo
vere l'immagine del Macedone presso i Greci rifacendosi ad una tradizione
venerabile.25
4.1. ate sull'immagine di Arsinoe II
na figura da prendere in considerazione e quell'Arsinoe II Filadelfo cui
e dedicata la statuetta del Metropolitan Museum gia presa in esame 26 (fig. 2).
Arsinoe, figlia del Soter, ormai vedova, torna in Egitto e sposa il fratello re
gnante Tolemeo IF? Arsinoe II e un personaggio chiave nella elaborazione
del culto dinastico dei Tolemei e la sua immagine viene formulata in riferi
m ento a grandi modelli della storia egizia; intorno alIa sua figura si coagula
no gli sforzi degli ambiente di corte e di que1li templari.28 La regina porta ti
toli sacerdotali di grande prestigio nella tradizione indigena: e «Sposa del
dio » e «figlia di Amon »; 29 divinizzata dopo la morte, e spesso definita lsi: 30
nel colosso, rispondente all 'iconografia egizia pili. tradizionale , conservato ai
Musei Vaticani insieme a quello di Tolemeo II, trovati negli Horti Sallustiani
e provenienti probabilmente da Eliopoli, Arsinoe e «Figlia di Geb » e «im-
23 Erodoto II, 112. 2. CRAWFORD 1983, p. 18.
25 ZAGDOUN 1989, pp. 53-54. 26 Cfr. nota 8.
27 HOLBL 1994, pp. 32-33.
28 WRIOITI VrrroZZl 1998, pp. 58:5.9 ~'on bibliografia precedente . 29 Q UAEGEBEUR 1971b, pp. 207-209.
30 Si deve aJ. Quaegebeur 10 studio ampio e approfondito della figura e del protocol-10 di Arsinoe II: in tale ambito si fa dunql\e riferimento alia sua bibliografia, a partire da Q UAEGEBEUR 1971a e 1971 b fino a ,quella pili recente, citata nei volumi in sua memoria: Egyptian Religion, I, pp. xv.XXIV. Si veda anche MAlAISE 1994, p . 359.
G. CAPRIOTTI VTlTOZZI - TRACCE DI ARCAISMO GRECO 'ElLA SC LTURA EGIZIA... 1 7
. e di Isi ».31 Da un lata, dunque, abbiamo l'impegno della regina sui
e interno ed egizio, ehe la porta probabilmente a gratifieare gli am
ri templari al punto di essere eonsiderata come una nuova Ahmose-Ne-
·.la regina che all'inizio del Nuovo Regno aveva avuto un ruolo fonda
male nei confronti del eulto fino alIa divinizzazione post-mortem; 32 dall'al
Arsinoe conduce un'importante attivita suI fronte della diplomazia tole
'ca nel Mediterraneo, fino a divenire, dopo la morte, Arsinoe-Mrodite, Ar
oe Cypria, cioe l'Arsinoe del Capo Zefirio, tempio fondato dal grande na-
'4rca di Tolemeo II, Callicrate di Samo. 33 Nell 'eterogeneo ambiente di Men
-. inoltre, tanto importante per l'elaborazione del culto dinastico, Arsinoe fu
molto presto accolta come paredra del dio Ptah.34 Si tratta dunque di una fi
gura complessa, che focalizza in se aspetti di due culture diverse e coesisten
ti. La documentazione della sua divinizzazione e piuttosto varia sui due fron
ti e ei limitiamo qui a citare alcune fonti: una stele geroglifica trovata a Men
des ci testimonia la volonta di Tolemeo Filadelfo di far collocare in ogni tem
pio un 'immagine di Arsinoe in compagnia di queIle degli altri dei d 'Egitto.35
Una fonte greca invece, <U1cora Ateneo di Naucrati , ci racconta che 10 stesso
Tolemeo volle per Arsinoe l'attributo del dikeras carico di frutti, la doppia
cornucopia 36 che abbiamo visto nella statua di San Pietroburgo e in queIla
del Metropolitan (fig. 2). Sempre Ateneo ci ha conservato il ricordo di epi
grammi di CaIlimaco e Posidippo suI tempio del Capo Zefirio, dedicato ad
Arsinoe Mrodite, 0 Arsinoe Cypria, «amante del vento deIl'ovest », patrona
dei naviganti. 37 In questo tempio Berenice II, alIa vigilia della partenza della
sposo per la guerra di Siria, dedi co una ciocca di capelli.38 Lo stesso Ateneo
ricorda, con un epigramma di Edilo, un meraviglioso congegno meccanico
dedicato nello stesso tempio da Ctesibio, un Thy ton, un corno appunto, che si
apriva a suon di music a per versare vino. 39 Cio che sembra veramente inte
ressan te di questo mirabolante congegno e la caratteristica forma di Bes, di
vinita egizia a forma di nano parzialmente teriomorfo, tradizionalmente rap
presentato nell'atto di suonare e danzare mentre accompagna Hathor; il
31 Bom . R OMANELU 1951 , pp. 22·23, taw. XXII·XXIV; Q UAEGEBWR 1988, p . 47; STANWICK
1999, cat. A3, pp. 334-336, tav. l ; STANWICK 1999, cat. A4, pp. 336-337, tav. 2; MAL-\1SE 1994, p . 359.
32 Cfr. nota 28. 33 HAUBEN 1983, pp. 111·114. M Q UAEGEBEUR 1971a, pp. 262·263; THOMPSON 1988, pp. 127·13l. 35 D E M EUL ENAERE · MACKAY 1976, pp. 174-177,205. 36 Ateneo XI, 497; RICE 1983, pp. 202·208; STANI\~CK 1999, pp. 122·123. 37 Aleneo VII, 31 8. 38 H OLBL 1994, pp. 98-99. 39 Ateneo XI, 497.
188 REND. DELLA PONT. ACCAD. ROM. D'ARCH. - VOL. LXXIIl
poeta ci descrive la musica prodotta da Bes come la melodia ancestrale delle
divine acque del Nilo che portano la piena e dunque i frutti . 11 componi
mento, con il tono leggero di una lirica di corte, sembra alludere ad una
complessa stratificazione mitologica: Arsinoe e Afrodite CypTia, Afrodite Eu
ploia; a lei si dedica un simbolo dell 'abbondanza accompagnato da Bes,40 per
sonaggio legato ad Hathor, la Dea Lontana 41 che, al suo ritorno in Egitto, si
assimila alIa piena portatrice di fecondita: si intuisce, dunque, la sovrapposi
zione tra Afrodite-Arsinoe e H athor. La figura di Arsinoe si arricchisce di
sempre nuove sfumaulre: I'attributo della cornucopia la avvicina a Tyche, e il
suo nome e giustapposto a quello di Agathe T)IChe 42 sulle oinochoai in faience,
utilizzate secondo la Thompson in occasione di grandi feste tolemaiche, for
se Ie Arsinoeia.' 3 Per l' elaborazione dell'immagine di Arsinoe in arnbiente gre
CO, il navarca Callicrate di Sarno dovette avere un ruolo fondamentale :44 que-
to per onaggio, politicamente fedelissimo al Filadelfo, fu il primo sacerdote
eponimo di Arsinoe II e si adopero per propagandare il culto della regina.
Oltre aHa fondazione del tempio del Capo Zefirio ,45 conosciamo una sua de
diea per Arsinoe e Tolemeo in un tempio di lsi e Arlubi a Canopo.46 Molto. in
tere ante e la riflessione di M. Malaise su lsi di Canopo: 10 studioso suppo
ne che, grazie al navarca e per il tramite di Arsinoe la quale e lsi rna anche
Afrodite Euploia, lsi di Canopo abbia acquisito il ruolo di protettrice dei na
viganti. 47 Callicrate e conosciuto an che da documenti che ne testimoniano
l'attiyiti in vari siti del Mediterraneo, dana patria Sarno, a Delo, a Cipro.48
4.2. Ipotesi su un simulacro arcaizzante di Afrodite-Arsinoe
on sappiamo come fosse il simulacro di Arsinoe al Capo Zefirio: 49 sem
bra improbabile che si trattasse di un 'Afrodite nuda; e forse possibile che fos
se stato creato till mode no che riproponesse un tipo arcaico e percio parti-
.0 Su Bes: M-\L\ISE 1990 (con ampia bibliografia preceden te); H. ALTENMOLLER in LA I , coll. 720 SS. , s. v. Bes, V. T RAN TAN T lNH in LIMCIII,l , p. 98 55. , s. v. Bes; BRESCIANI 1992; DASEN 1993, p. 55-83; VOLOKHlNE 1994.
41 Sulla Dea Lontana: F. DAUMAS in LA IT, 1024-1033, S.Y. H athoT.
42 THOMPSON 1973, pp. 51-59 . • 3 Ibid. , pp. 117-122.
0\4 HAUBEN 1970, particolarmente pp. 6~67.
'5 Ibid., p. 43-44. 46 Ibid. , p. 40-41; M ALAISE 1994, pp. 353-354 . • 7 MALAISE 1994, particolarmente p. 364. SuI SilO di Canopo, si e in attesa de i risultati
delle ricerche subacquee del gruppo eli F. Godelio. 48 HAUSEN 1970, p. 64 .
• 9 Da Canopo, invece, conosciamo immagini femmin ili portau;ci eli cornucopia (MAL-\lSE 1994, pp. 368-369).
G. CAPRlOrrI VIrrOZZI - TRACCE Dr ARCAlSMO GRECO NELLA SCULTURA EGIZlA... 189
colarmente venerabile? La scelta del genere iconografico fu sicuramente
condizionata da Callicrate: forse peso, sulla sua scelta, la formazione samia,
e nell'isola erano an cora visibili immagini arcaiche; 50 d'altro canto, anche nel
resto dell'ambiente mediterraneo insulare, nel quale Callicrate si muoveva,
sana ben conosciuti degli attardamenti 0 il riafforare del gusto arcaico: e
dobbiamo guardare a Cipro, Rodi, Delo.
Sembra interessante fermare l'attenzione su dei coni monetali battuti a
ea Paphos da Tolemeo III: vi si vede una figura femminile dall'alto poZos,
Afrodite, Ie cui caratteristiche sono tipicamente arcaiche. B. Lichocka,51 che
ha studiato queste monete, nota anche la probabile presenza di una trave as-
iale nell 'abito e osserva che tale figura doveva rappresentare una statua im
portante eben conosciuta: si trattava di un antico simulacro, del tipo ripro
dotto da quello portato da Erostrato a Naucrati,52 oppure era un 'immagine
arcaizzan te creata in epoca ellenistica? La Lichocka ricorda, a proposito, che
a Cipro eben attestato il culto di Arsinoe II e conclude che queste monete
pon-ebbero rappresentare un ' immagine di Afrodite, e insieme di Arsinoe
Afrodite, dedicata come ringraziamento per il ritorno del re dalla guerra di
iria. Monete analoghe furono battute anche a Rodi.
4.3. Aspetti dell'arcais1no nella Qrecia insulare
Merker, nel suo studio sulla scultura ellenistica in quest'isola,53 si soffer
rna a sottolineare i legami tra Rodi e Alessandria ricordando tra l' altro la pre
senza di ritratti di dinasti tolemaici e di sculture egizie importate. Riguardo
alia produzione arcaizzante, che a Rodi e particolarmente importante,
~ferker suppone che la scultura greco-egizia possa aver influenzato 10 stile
dei tipi femminili arcaizzanti locali.54 Da notare l'uso, frequente a Rodi, del
p iegone centrale [ormato dalle vesti, una sorta di trave in cui la ricaduta e di
segnata in pieghe piatte, a zig-zag 0 a losanghe.55
Anche Delo offre spunti interessanti alIa nostra riflessione. Marcade, nel
suo studio sulla scultura delia, nota che sono rare Ie sculture arcaizzanti, tra
que te ci presenta un frammento dal Serapeo C dell'isola e un altro molto si
mile dei quali sottolinea 10 stile rigido: 56 la figura e addossata al manto, che
50 Apuleio, Flmi.de XV . • 1 UCHOCKA 1986. 5!! Cfr. nota 16. 55 ~1£RKER 1973 . .... Ibid., pp. 13-l4. -- Ibid., p. 33 n. 136. ;0 ~1ARC:o\DE 1969, p. 431 , nn. A5369-A5370, tav. LVII.
190 REND. DEliA PONT. ACCAD. ROM. O'ARCH. - VOL. LXXI II
costituisce quasi un pilastro dorsale; il piegone centrale fo rma una trave as
siale alIa cui sommita si intravede parte del cosiddetto no do isiaco; la mana
sinistra sui fian co sembra alludere alia presenza di una cornucopia. Secondo
Marcade, il grafismo delle pieghe e la rigidita della figura stabiliscono un rap
porto tra Ie sculture egittizzanti e quelle arcaizzanti dell 'isola. Lo studioso os
serva che si esita a definire certe sculture egittizzanti 0 arcaizzanti; e proba
bile che Ie due correnti si rafforzino a vicenda.57 Tale riflessione di Marcade
sembra calzante anche di fronte alle statuette del Metropolitan Museum: 10
stile egizio, nella sua predilezione per Ie form e geometriche, ben si fonde
con l'arcaismo greco; d 'altra parte si puo notare la vicinanza del frammento
di Delo (n. A5370) alle sculture del Metropolitan. A Delo sono ben cono
sciuti culti egizi e dediche dei dinasti tolemaici: qui esisteva un tempio di cul
to di Arsinoe II, de tto Philadelpheion; un altro alto funzionario di Tolemeo II ,
il nesiarca Ermia, due anni dopo la morte di Arsinoe, vi fondo Ie feste dette
Philadelpheia.58 Tali iniziative creano un corrispettivo a quelle gia citate di Cal
licrate ill Sarno e corroborano Ie testimonianze sull ' importanza del culto di
Ar inoe II nel Mediterraneo orientale, attestato nella gia citata Cipro, a Le-
bo, Paro, Thera, Milet0 59 ecc. Restando a Delo, sembra molto interessante
I'os ervazione fatta da Vallois molti anni or sono su un sovrapporsi della
figura ill Agathe Tyche a quella della Filadelfo; 60 oltre che sulla corrisponden
za tra I'iconografia de lla dea e quella della regina con cornucopia e sullega
me ben attestato tra Arsinoe e Agathe Tyche, Vallois appoggia Ia sua ipotesi su
gli oggetti di un inventario fatto alia meta del II sec. a .C. secondo il quale, nel
tempio delio di Agathe Tyche, sono presenti, tra I'altro, conchiglie marine, co
m e quelle care ad Mrodite Cypna e dedicate anche al Capo Zefirio; vi si tro
va inoltre una statuetta di can efora, e sappiamo che la sacerdotessa di Arsi
noe ad Alessandria e Tolemaide era tale; infine abbiamo due piloi stellati ed
una testa di ariete ch e Vallois vede in corrispondenza con i misteri di Samo
tracia, rna, possiamo ricordare, 1'ariete e particolarmente legato ad Arsinoe
in ambiente egizio dove la regina era detta «figlia di Amon » 61 e veniva
rappresentata, ad esempio sul1e monete, con il corno di montone die tro 1'0-
recchio.
Come si puo osservare , e difficile definire il n esso di causalita tra gli
aspetti arcaizzanti dell 'iconografia di Arsinoe in Egitto e Ie forme di arcaismo
57 Ibid., pp. 431-432. 58 B RUNEAU 1970, p. 544. 59 Ibid.
60 VALLOIS 1929. In BRUN EAU 1970, p. 540, si ritiene una semplice ipotesi l' identificazione fatta da Vallois de l Philadelpheion nel tempio di Agathe Tyche.
61 efr. nota 29.
G. CAPRIOTII VJITOZZI - TRACCE Dl ARCAlS 10 GRECO NELLA SCULTURA EGIZIA. .. 191
riscontrate a Rodi 0 a Delo, stabilendo una priorita cronologica; tuttavia, at
tenendosi aIle osservazioni di Marcade e di Merker, sembra possibile che una
certa iconografia di Arsinoe possa aver stimolato alcune produzioni locali.
Un tentativo di ricostruzione del fenomeno potrebbe dunque partire dalle
osservazioni della Lichocka: un'iconografia arcaica 0 arcaizzante di Afrodite
Cypria avrebbe condizionato quella di Arsinoe-Mrodite per il tramite, forse,
di Calli crate di Sarno, in osservanza ad una tradizione venerabile in ambito
greco che tuttavia ben si sposava con il gusto egizio; tale iconografia avrebbe
improntato alcune forme di arcaismo nell 'arnbiente mediterraneo pili lega
to all'Egitto tolemaico. Una bella scultura in Vaticano,62 uscita da un'officina
greco-egizia, propone una bella sintesi degli aspetti fin qui delineati (fig. 6):
in questo caso la pietra e nera, tipicamente egizia; la posizione flessa della
gamba sinistra e I' himation che awolge la figura si riferiscono esplicitamente
all'arte ellenistica; il trattamento duro e calligrafico delle pieghe dell'abito ri
cavate dalla pietra piuttosto ostica, Ie proporzioni piccole e la forma rigida
della cornucopia ricordano precisarnente Ie sculture del Metropolitan 63
(figg. 2-3). Queste ultime, nel coniugare modi egizi e greci arcaici, potreb
bero testimoniare l'esistenza di un simulacra di Arsinoe, cui si sarebbero ispi
rate anche regine successive come, appunto, una Cleopatra.
5. CONCLUSION I
A conclusione di queste osservazioni, bisogna ricordare quanta notato da
Zagdoun nel suo studio sulla scultura arcaizzante: alcuni tipi iconografici im
prontati alIo stile arcaizzante dell'Asia Minore rappresentano molto spesso
divinita di origine orientale come Tyche, Agathodaimon, Isi-Tyche, Eirene, Sera
pi,64 filone iconografico che si irradia fino all' epoca romana. Si ricordano qui
alcuni oggetti esemplificativi: un bronzetto di pregevole fattura mostra una
figura femminile che reggeva un sistro, ora mutilo; la capigliatura a boccoli
e ordinata sulIa fronte in modo non dissimile da quello delI'Arsinoe del Me
tropolitan (fig. 2) .65 Un'acconciatura piuttosto simile si ritrova anche in una
bella statuetta di Isi-Demetra a Berlin0 66 fino a immagini arcaistiche di 'T-/che
62 Museo Gregoriano Egizio, n. iny. 22799, alt. em. 129. Bom - R OMANELU 1951 , pp. 97-9 n. 147, tay. LXVIII; lside, p. 160 cat. n . IV.I.
63 Si noti l'analogo U'attanlento di questo attributo in immagini di Tyche di diyersa pro,enienza, ad es. in una scultura al Louvre (MA 2571) : ZAGDOUN 1989, p. 245 n. 325, tav. 54 litT, 196 .
... Z AGDOUN 1989, p. 178, 65 D E RIDDER 1895; Z~GDOUN 1989, p. 228 n. 66, tav. 49 fig. 180. 66 Berlino, Agyptisehes Museum, n. inv. 12440: lside, p. 108 cat. n. I1I.22.
192 REND. DELLA PONT. ACCAD. ROM. D'ARe H. - VOL. LXXIII
Fig. 6. Statua di Isi-Tye" e 0 regina al Museo Gregoriano
Egizio, inv. n . 22799 (fotc genti lmente concessa dall 'ar
chi\~o fotografico dei Musei Vatican i)
C. CAPRJOTTI VIrrOZZJ - TRACCE DJ ARCAlSMO CRECO NELLA SCULTURA ECJZlA. .. 193
di epoca romana.67 Ii caso pili. evidente di arcaismo greco nella scultura di
ambiente isiaco e la bella statua di lsi dall'iseo di Pompei: 68 qui assisriamo.
pen'>, ad una sorta di rovesciamento, rispetto alle statuette del Metropolitan.
per quanto riguarda il rapporto veste-corpo femminile: l'abito, infatri, sveia
completamente Ie forme come nella pili. antica tradizione egizia; la figura
brandiva un sistro come il bronzetto gia citato. M.-A. Zagdoun commenta la
scultura osservando che il genere egittizzante, al servizio di una divinita
orientale, si serve dello stile arcaizzante per meglio suscitare la pieta popola
re .59 Una chiara impronta arcaistica si puo trovare ancora, ad esempio, :in una
tatua isiaca al Museo azionale Romano. 70 E difficile, allo stato attuale delle
nostre conoscenze, supporre con chiarezza l' esistenza di un Urbild, un mo
dello cui tale filone iconografico si sarebbe ispirato, tuttavia, gia nel 1927, nella presentazione di una testa identificata come lsi nella collezione von Sie
o-lin,71 sottolineando la fusione di aspetti egizi e tratti di arcaismo greco, si for
mulava l'ipotesi dell'esistenza di un importante simulacra di culto che aves
se queste caratteristiche.
In un ambiente cuIturalmente poIiedrico come I'Egitto tolemaico, Ie esi
o-enze del culto e della propaganda fecero ricorso a modelli autorevoli del
passato, siano essi egizi che greci e cio forse non awenne solo nell 'ambito
dell ' iconografia femminile che pure presenta il fenomeno pili. vistoso: una
insolita testa trovata dagli scavi Vogliano a Medinet Madi nel Fayum in un cu
mulo di rottami nel tempio locale (fig. 7) , identificata come un principe to
lemaico, e pili. precisamente da A. Leone 72 come Tolemeo VIII, mostra delle
caratteristiche che la rendono del tutto inusuale. La studiosa, che l'ha ana
lizzata di recente, la ritiene frutto di un genere iconografico idealizzato di
ambiente egizio, tuttavia, aIle studioso di antichita egizie, la testa appare co
me p rofondamente estranea. Vorrei fermare l'attenzione sulla struttura del
- e della mandibola, sulla forma della piccola bocca di tipo figuIino awi
cinata al naso, rna soprattutto sugli occhi, delineati da un taglio netto e si
uosa ulla superficie leggerrnente modulata e priva di pieghe corrispon
deme ai globi oculari , e infine Ie sopracciglia definite da un sernplice cordo
piuITO to sfumato. La testa, in calcare bianco, rnostra una consonanza con
opere di tradizione tardo-arcaica cipriota, dai tratti del visa alIa lavorazione
es. una statua all'A1bertinulU di Dresda: Z AGDOUN 1989, p. 235 n. 173, tav. 51
Xapoli. ~fuseo Archeologico Nazionale, in\!. n. 976: [side, p. 428 ca t. n. V.46 . z:aa.x." 1989, p. 199.
n.. 126074: [side, p. 406 cat. n . V.24. 1927, pp. 83-85.
- 1996: TAN'\~CK 1999, cat. D5, pp. 455-456.
194 REND. DELLA PONT. ACCAD. ROM. D'ARCI-!. - VOL. LXXIII
Fig. 7. Sculmra n e lle Civiche Rac
colte Archeologiche Numismati
ch e di Milano, inv. n. EO.9.4075
(foto riprodotta da L EONE 1996,
fig. 3)
della chioma a piccole ciocche calligrafiche: gii A. Vogliano, notando l' e
straneiti dell'opera alIa tradizione egizia, vi aveva riconosciuto d elle analogie
rispetto alIa scultura di Cipro.73 Perc he in un tempio del Fayum di lunga
tradizione egizia si trovi una scultura simile, idealizzata S1, rna non nella
tradizione egizia, e un interrogativo aperto: e si tratta davvero di un dinasta
tolemaico? Ma qui si apre un nuovo problema che potra essere affrontato in
futuro.
73 VOGLIANO 1938, pp. 30-31 n.7: «L'opera e estranea all 'arte egizia e non si spiega can Ie sale influenze dell' arte greeD arcaica (si conn-anti la testa dell 'auriga di Delfi). Difficilmente ci si sotu'ae all'impressione ch e il vicino orien te n on abbia esercitato il suo influsso. Le analogie piu vicine sono con I'arte cipriota, dove queste correnti si sono incontrate ".
G. CAPRlOTTI VlTroZZI - TRACCE DI ARCAISMO GRECO NELLA SCULTURA EGIZIA. .. 195
BIANCHI BAt'lDINELLI -
PARIBENI 1976
BORCHARDT CGC
BOTHMER 1996
ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE
R. BIANCHI BANDINELLI - E. PARIBENJ, L'arte dell'antichitli classi
ca. Greeia. I, Torino 1976.
L. BORCHARDT, Statuen und Statuetten von Kiinigen und Priva
tleuten, II, Berlin 1925.
B. VON BOTHMER, Hellenistic Elements in Egyptian Sculpture of
the Ptolemaic Period (pubblicato postumo a cura di P. E.
Stanwick), in Alexandria and Alexandrianism. Symposium
(J Paul Getty Museum, 1993), Malibu 1996, pp. 215-230.
BOTTI-ROMANELLI 1951 G. BOTTI - P. ROl.-lANELLI, Le sculture del Museo Gregoriano Egi
zio, Citta del Vaticano 1951-
BRESCIANI 1969 E. BRESCIANI, Letteratum e poesia dell ' antiro Egitto, Torino 1969.
BRESCIANI 1992 E. BRESCIANI, Un nuovo documento della devozione a Bes, protet
tore della maternitd, in U. LUFT (ed.), The Intellectual Heritage
of Egypt, Studies presented to L. Kakosy (Sc Aeg., 14), Budape
st 1992, pp. 81-84.
BRUNEAU 1970 PH. BRUNEAU, Recherches sur les cultes de Delos Ii l'epoque hellini
stique et Ii l 'epoque imperiale (Bibl. Ec. Fmn. Athens Rome, 217),
Paris 1970.
CAPRIOTTI VITTOZZI 1995 G. CAPRIOTTI VITTOZZI, Un busto di regina tolemaica al Museo di
Torino. Note sull 'iconografia di Berenice II e di Cleopatm 1, in
Rend. Lincei seL IX vol. VI fase. II 1995, ppA09-438.
CAPRIOTTI VITTOZZI 1998 G. CAPRIOTTI VITTOZZI, Una statua di sovmna al Museo di Tori
no: la tmdizione del Nuovo Regno nell'ironografia delle regine to
lemaiche, in Vic. Or: XI 1998, pp. 53-66.
Cleopatra regina d'lc-'gitto Cleopatra regina d 'Egitto. Catalogo della mostra a cum di
S. Walker e P Higgs (Rama Palazzo RU5poli, 12 ottobre 2000 -
25 febbraio 2001), Milano 2000.
Cleopatra's Egypt Cleopatm '5 Egypt: Age of the Ptolemies. Exhibition Catalogue
(Brooklyn Museum, October 7, 1988 - January 2, 1989),
Brooklyn 1988.
CHINERY 1996 L. M. ClliNERY, The Influence of Egypt on the Development of Ar
chaic Kouroi and Kourai in Eastern Greece (late seventh - early
sixth centuries B. C.). Dissertation, University of Alberta 1996.
CRAWFORD 1983 D.]. CRAWFORD, Hellenistic Memphis: City and Necropolis, in
N. BONACASA - A. Dr VITA (ed.) , Alessandria e it mondo elleni
stico-romano. Studi in onore di Achille Adriani, I, Roma 1983,
pp. 16-24.
196 REND. DELLA PONT. ACCAD. ROM. D'ARCH. - VOL. LXXlIl
D ASEl 1993 V. D ASEN, Dwarfs in Ancient Egypt and Greece, Oxford 1993.
D AVIS 1979 W. M. D AVIS, Ancient Naukratis and the CYP110tes in Egypt, in
Gott. Misz. XXXV 1979, pp. 13-23.
D AVIS 1980 W. M. D AVIS, The Cypriotes at Naukratis, in Gott. Mm. XLI
1980, pp. 7-19.
D AVIS 1981 W. M. D AVIS, Egypt, Samos, and the Archaic Style in Greek Sculp
ture, in Joum. Eg. Arch. LXVII 1981, pp. 61-81-
D E MEULENAERE - H . DE MEuLE AERE - P. lYfACKAY, Mendes, II, Warminster 1976.
MACKAY 1976
DE RIDDER 1895
DE SALVIA 1989
DE SAL\1A 1993
D ONADo.!I 1981
EDGAR CGC
Egyptian Religion
ESIP
G URALt'lrCK 1978
HAUBE 1970
H AUBE. 1983
H OLBL 1994
Iside
A. D E RIDDER, Statuette de bronze, in M on. PiotII 1895, pp. 145-
156.
F. DE SALVIA, The Cypriots in the Saite Nile Delta: the Cypro-EgyjJ
tian Religious Syncretism, in The Archaeology, Geography and H i
story of the Egyptian Delta in Pharaonic Times. Proceedings of Col
loquium (Wadham College, 29 - 31. 8. 1988), Oxford 1989,
pp.81-1I8.
F. DE SALVIA, Cipro, Grecia e l '« Egitlizzante cip110ta » , in St. Egit
toL Ant. Pun. xn 1993, pp. 65-75.
S. D o 'ADONl, L'Egitlo, Torino 198!.
C. C. EDGAR, Greek Sculpture, Le Caire 1903.
W. CLARYSSE - A. SCHOORS - H. WIlLEMS (ed .), Egyptian Religion.
The last Tlwusand Years. Studies Dedicated to the Memory of Jan
Quaegebeur ( Orient. Lovan. Analecta, 84), Leuven 1998.
B. VON B OTHMER e t aI. , Egyptian Sculpture of the L ate Period,
700 B. C. to A.D. 100. Exhibition Catalogue, Brooklyn 1960.
E. GURALNICK, The Proportions of Kouroi, in Amer. Journ. Arch.
LXXXII 1978, pp. 461-472.
H. H'\UBEN, Calli crates of Samos. A conl',ibution to the study of the
Ptolemaic admiralty (Stud. H ellenistica, 18), Leuven 1970.
H. H AUBEN, Arsinoe II e La politique extirieure de lEgypte, in
E. VAN 'T D ACK et aL (ed.), EgyjJt and the Ellenistic World. Pro
ceedings of the International Colloquium (Leuven, 24-26. May
1982) (Stud. H ellen·istica, 27), Leuven 1983, pp. 99-1 27.
G. H OLBL, Geschichte des Ptolemaerreiches, Darmstadt 1994.
Iside. Il mito, il mistero, La magia. Catalogo mostra a cura di
E. ArsLan et al. (Milano Palazzo Reale, 22 febbmio-1 giugno
1997), Milano 1997.
G. CAPRIOTTI VITTOZZI - TRACCE or ARCAISMO GRECO NELLA SCUITL'RA EGIZl.-\..
JANTZEN 1972
JENKINS 2001
KYruELEIS 1996
LEFEBVRE 1923-1924
LEO fE 1996
LICHOCKA 1986
LIMC
MAulSE 1990
MAL~SE 1994
lvlARCADf. 1969
MATHIEU 1996
MERKER 1973
QUAEGEBEUR 1971a
QUAEGEBEUR 1971 b
U . JANTZEN, Agyptische und orientalische Bnmzen aus
raion von Samos (Samos, 8) , Bonn 1972.
J. JE KINS, Archaic Kouroi in Naucratis: The Case for CyprWt On
gin, in A mer. J ourn. ATch. CV 2001, pp. 163-179.
H . KYruELEIS, Der grosse KOUTOS von Samos (Samos, 10) Bonn
1996.
W. HELCK-E. OTTo-W. WESTENDORF (ed.), Lexikon der AgYPloiD
gie, Wiesbaden 1975-1992.
G. LEFEBVRE, Le tombeau de Petosi1is, I-III, Le Caire 1923-1924.
A. L EONE, Nuove aequisizioni sul tempio di Medinet Madi: un ri
traUo « idealizzato " di principe tardo tolemaico, in R iv. 1st. Naz.
Mch. St. Arte XVIII 1995, Roma 1996.
B. LICHOCKA, La statue d'Aph1'odite sur les monnais de Pto
lemie III. in l conographie classique et identitis TegiOnales.
Actes du Colloque international du G.N.R.S. n. 619 (Paris 26-
27 mai 1983), in Bull. Corr. Hell. Suppl. XIV 1986, pp. 311-
330.
Lexicon Iconographicum Mythologiae Classieae, Zurich-Dussel
dorf 1981-1997.
M. MALAISE, Bes et les croyances SOlaiTes, in S. IsRAELlT-GROLL
(ed.), Studies in Egyptology presented to M. Licktkeim, J erusa
lem 1990, II, pp.680-729.
M. MALAISE, Le culte d'Isis a CanO'pe au ill' siecle avant notre ere,
in M.-O. JENTEL - G. DESCHENES-WAGNER (ed.), Tranquillitas.
Melanges en l'}wnnel.LT de Tran Tam Tinh, Quebec 1994,
pp. 353-370.
J. MAACADE, Au Musie de Delos (Bibl. Ee. Fran. AtMnes Rome,
215), Paris 1969.
B. MATHIEU, La poesie amoy,rmse de l'Egypte ancienne. Reckerches
sur un genre litteraire au Nouvel Empire (Bibliotheque d'etude
I.EA.a., 115), Le Caire 1996.
G. S. MERKER, The Hellenistic Sculpture of Rhodes (Stud. Medit.
Mch. , 40) ,Goteborg 1973.
J. QUAEGEBEUR, Documents concernig a Cult of Arsinoe Phi
ladelplws at Memphis, in Jouro. Near East. St. XXX 1971,
pp. 239-270.
J. QUAEGEBEUR, Ptolemee II en adoration devant Arsinoe II divini
see, in Bull. Inst. Arch. Or. LXIX 1971 , pp. 191-217.
198 REND. DELLA PONT ACCAD. ROM. D'ARCH. - VOL. LXXIII
Q UAEGEBEUR 1988 ]. Q UAEGEBEUR, Cleopatra VII and the Cults of the Ptolemaic
Queens, in Cleopatra 's Egypt, pp. 41-54.
RICE 1983 E. E. RICE, The Grand Procession of Ptolemy Philadelphus,
Oxford 1983.
RICHTER 1968 C. M. RICHTER, Korai. Archaic Greek Maidens, London 1968.
SCHMIDT 1968 C. SCHMIDT, Kyprische Bildwerke aus dem Heraion von Samos
(Samos, 7) , Bonn 1968.
SCOTT 1986 C. D. SCOTT III , Ancient Egyptian Art at Yale, New Haven
1986.
STANWICK 1999 P. E. STANWICK, Egyptian Royal Sculpture of the Ptolemaic Period
(A dissertation submitted in pm·tial fulfillment of the requi'rements
for the degree of Doctor of PhilosffjJhy, Institute of Fine Arts, New
York University, September 1999), UMI Dissertation Services,
Ann Arbor 1999.
T HOMPSON 1973
THOMPSO 1988
V ALLO IS 1929
V OGUANO 1938
VOLOKHINE 1994
W ATZINGER 1927
ZAGDOUN 1989
D.B. THOMPSON, Ptolemaic Oinochoai and Portraits in Faience.
Aspects of the Ruler-Cult, Oxford 1973.
D.]. THOMPSON, Memphis under the Ptole1nies, Princeton 1988.
R. V ALLOIS, Le temple de/ien d'A1'Sinoe Philadelphe au d'Agathi
Tychi, in Comptes Rendues A cad. Inscr. 1929, pp. 32-40.
A. VOGLIANO, Catalogo della mostra delle antichitd rinvenute nel
la campagna d 'Egitto condotta dalla missione della Regia Univer
sitd di Milano 1934-37 (XII-XV) , Milano 1938.
Y V OLOKHlL'JE, Dieux, masques et hommes: d propos de la forma
tion de l 'iconograpie de Bes, in Bull. Soc. Egypt. Geneve XVIII
1994, pp. 81-95.
Die griechisch-iigyptische Sammlung Ernst von Sieglin, herausge
geben von E. von Sieglin. 1. Malerei und Plastik. Zweiler Teil (B)
bearbeitet von C. Watzinger, Leipzig 1927.
M.-A. Z AGDOUN, La sculpture archaisdnte dans ['art hellenistique
et dans l'art romain du haut-empire (Bib/. E c. Fran. Athenes Ro
me, 269), Atene 1989.