TRACCE DI STORIA DEL COSTRUIRE NEI CONTI DI FABBRICA
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of TRACCE DI STORIA DEL COSTRUIRE NEI CONTI DI FABBRICA
9
5 Cfr. anche F. BONORA, Il palazzo Durazzo Bombrini in Corniglia-no, un’architettura francese a Genova, Genova 1991, pp. 65-66.
6 Con l’esclusione dei falegnami che hanno liste a parte, (in quelle dei muratori sono presenti invece dei bancalari, si individua così una differenza di compiti tra le due categorie?) o di qualche opera particolare di pittori.
7 1756 à 17 aprile Conto di pitture diverse (1755 primo dicembre) Lavori dati a Fregolia in Cornigliano a scarso. Conclude con: tutti sudetti lavori sono per la sola fatura avendoci dato a spese nostre tutti i colori, olio, colla et altro.
Durazzo, quinto marchese di Gabiano, costruita nella prima fase per una decina di anni a partire dal 1752 a Cornigliano.
L’esame puntuale delle carte, la loro regestazione e parziale trascrizione ha consentito di ricavare infor-mazioni sui più diversi aspetti del cantiere dell’epoca e sui cambiamenti tra l’inizio e la metà del secolo, che qui si presenta.
1. MAESTRANZE, MESTIERI E ARNESI DA CANTIERE
I nomi di maestri e lavoranti citati nei conti esa-minati, specialmente in quelli di Cornigliano, sono dell’ordine delle centinaia; una ricerca di tipo attribu-tivo o sui fenomeni della centenaria emigrazione dalle valli dei laghi lombardi potrebbe utilmente giovarsi di tali dati, qui invece non si può mancare di delineare le diverse figure che operano nella fabbrica, per poter constatare la complessità del meccanismo che conduce all’opera finita.
Persino nel caso della manutenzione successiva al cantiere di costruzione la varietà di maestranze impie-gate resta notevole come si evince ad esempio nella nota di spese fatte negl’anni 1726 e 1727 per il mantenimento dell’anno 1726 de miei stabili di Genova e del Palazzo di S. Filippo Neri, in cui sono citati: ottoniere, falegname, vetraio, ponteggiatore, ferraro, calderaro.
1.1 IL CAPO D’OPERA
Non è possibile cogliere con precisione dai docu-menti esaminati il ruolo del capo d’opera, si avverte però la sua presenza costante, documentata dalla periodicità della ricognizione, somma riconosciuta per l’assistenza che fa alla fabrica, o dal fatto che, come si vede chiaramente nei conti Durazzo, fa parte delle sue incombenze redigere le liste per il pagamento5, anche quindicinale, delle maestranze di volta in volta coinvolte, con l’accurata contabilità delle giornate da ciascuno lavorate6.
Difficilmente invece il capo d’opera di Cornigliano provvede a qualche fornitura di materiali, perché in que-sto cantiere è presente una figura a parte, il reverendo Angelo Aronio, che si occupa di tutti i conti e che tiene una sorta di magazzino del materiale non utilizzato, così da poterlo usare in caso di bisogno7.
INTRODUZIONE
È già stata presentata, su questa rivista, la possibilità di ricavare da uno studio sistematico delle fonti scritte una chiave di lettura delle fonti materiali e di ottenere un aumento reciprocamente alimentato, nell’incrocio delle informazioni tra documenti scritti e oggetti, della conoscenza del costruito storico1.
Nella stessa linea di ricerca si colloca questo ap-porto che si configura come un tentativo di esplorare un diverso genere di fonte scritta rispetto a quelle già presentate, che sono soprattutto i capitolati contenuti nelle filze notarili.
Si tratta dei conti di fabbrica, che, almeno in area genovese, si reperiscono più facilmente in archivi pri-vati che in quelli pubblici, già esplorati in queste altre occasioni.
Le potenzialità di questa fonte si rafforzano dal partecipare dei risultati raggiunti in diversi anni di ricerca, che hanno prodotto diversi contributi sugli aspetti costruttivi della casa genovese tra medievo ed età moderna, murature, impianti, pavimenti, intonaci e così via2.
Tra le fonti scritte stesse esistono notevoli differenze e potenzialità, il presente contributo vuole presentare alcune delle informazioni specifiche che si possono trarre da dettagliati conti di fabbrica.
L’occasione propizia3 è la documentazione prodotta nel corso di due importanti cantieri genovesi del Sette-cento, tutta conservata in un archivio di famiglia4, dove è più probabile incontrare simili fonti.
Si tratta dei conti per tutti i pagamenti effettuati durante due fabbriche, la prima in ordine temporale è l’ampliamento di un palazzo di città, il palazzo di “strada Lomellina” di Paolo Gerolamo Pallavicino III, realizzato tra primo giugno 1718 e il 6 marzo 1724, la seconda è una villa vicino al mare, ritenuta uno degli ingressi dell’influenza francese nell’architettura sette-centesca a Genova, di proprietà Giacomo Filippo II
1 A. BOATO, Fonti indirette e archeologia dell’architettura: una pro-posta di metodo, «Archeologia dell’Architettura», III, 1998, pp. 61-74. Cfr. anche «Notiziario di Archeologia Medioevale», n° 72, 2000.
2 Insieme ad Anna Boato abbiamo raccolto ed inserito in una banca dati centinaia di documenti provenienti dalle filze notarili del-l’Archivio di Stato di Genova nel corso delle seguenti ricerche: Fonti scritte e fonti materiali per l’edilizia dell’età moderna, Storia dell’uso dei materiali edili a Genova, Tecniche costruttive, manutenzione, ma-teriali, restauri: il caso ligure, 1988 - 1996 Facoltà di Architettura di Genova (coordinatore prof. L. Grossi Bianchi). In tale ambito abbiamo scritto diversi contributi su riviste e atti di convegni.
3 Il lavoro è stato svolto nel corso della mia tesi di dottorato di ricerca in Conservazione dei beni architettonici, presso il Politecnico di Milano, 2002, Conoscere l’architettura, manufatti nel settecento genovese.
4 Si tratta degli Archivi Pallavicini n. II 43, Conti della Fabrica del Palazzo di strata Lomellina variato e ampliato di Paolo Gerolamo Pallavicino da san Filippo Neri, e dell’Archivio Durazzo marchesi di Gabiano, filze 475-480, Conti di Cornigliano.
TRACCE DI STORIA DEL COSTRUIRE NEI CONTI DI FABBRICA
10
Mentre un particolare interessante riguarda il capo d’opera di via Lomellini, che l’anno seguente la fine del cantiere ancora è in credito di materiali che evidente-mente aveva fornito lui:
n° 501 6 marzo 1724 pagamento a Giacomo Viano di dieci picciole antenne poste nella volta della sala et altri luoghi dell’appartamento superiore e nel guardarobbe, e becciarie poste nelle volte delli salotti del detto appartamento.
La sua influenza sulla fabbrica continua anche a cantiere concluso, se – nel caso Durazzo – ancora nel 1766 si ricorre a lui per lavori piccoli ma significativi dal punto di vista della riuscita generale dell’opera, pagando al capo d’opera Andrea Orsolino per sua assistenza al lavoro della terassa di Cornigliano, e scalini di marmo nel boschetto di merangoli £106.2.
La fiducia dei committenti perdura se – nel caso Pallavicini – il rapporto con Viano continua e si estende al mantenimento dei miei stabili di Genova.
1.2 LO SCALPELLINO
È colui che lavora la pietra, ma è anche colui che la fornisce; nel caso di via Lomellini troviamo Francesco Marini vendere ogni genere di materiale o manufatto lapideo che occorre in cantiere, mentre il fornitore di Cornigliano, Stefano De Lucchi scalpellino, provvede anche qualche materiale ceramico (trombette, cannoni, persino mattoni), nonché diversi rubbi di porcellana8, gesso e polvere di marmo.
Una specializzazione faticosa dev’essere quella dello scalpellino da scoglio, che deve aprire varchi per condutture in muri esistenti o rompere la roccia in un ampliamento, a lui servono ad esempio scalpelli da scoglio per far più grandi li buchi ove si pongono le colonne di legno nella strada.
Alcune finiture da fare in opera rendono necessario il lavoro dello scalpellino: attestare palmi 712 cordone di pietra longo la strada davanti al palazzo, cioè adattare i profili dei cordoli l’uno all’altro e alla loro posizione lungo il bordo della rampa inclinata che dà accesso alla villa, oppure inserire le persiane.
Come anche:fattura di scalpelino di far sagrime £ 0:12:=
fattura di scalpelino di incastrare dadi £ 1:=:=
fattura di scalpelino di inpiobare ferri £ 0:16:=
fattura di scalpelino di inpiobare puzi £ 1:=:=
fattura di scalpelino di inpiobare ferri e incastrare puzi £ 1:4:=
Tocca ancora ad uno scalpellino l’operazione di rifinitura dei laterizi da pavimento: Antonio Calimano scalpellino per quadratura di n° 2800 quadretti a soldi 18 il centinaio; oppure il riattamento delle guide di pietra di lavagna vecchie che erano nel pavimento del portico per porle al nuovo pavimento del medemo, vanno raddrizzate, cioè rifilate e sistemate per la nuova posizione. Il reimpiego è una costante nota del cantie-re preindustriale, che ritorna nell’operato di tutte le maestranze.
8 Così veniva chiamato il caolino, additivo idraulicizzante per malte usato a Genova prima della pozzolana che viene introdotta all’inizio del XVII secolo, in seguito il termine può indicare entrambe le cose.
1.3 IL MARMARAIO
Detto anche marmararo. Si potrebbe dire uno scal-pellino dedito solo al marmo. Il nome compare solo nei conti di inizio secolo ed è attribuito a Gio Battista Torre e Gio Battista Porri q Gio Maria, fornitori di colonne e pilastretti per le scale, porte, piane, piedi-stalli, poggioli con balaustri e così via, a Francesco Gaggino, pagato per fare gli incavi alle porte o sia porta di marmo per gorni di ferri per reggere le porte di noce, a Francesco Saporito il quale, nel corso di una giornata, ha dovuto impiombare li ferri alla colonna di marmo per sostenere il rastello9 o l’ha consumata in fare gli incastri alle due piane di marmo delle due finestre in strada lomelina del portico per potervi porre le arve di legno.
Anche lui fornisce, accomoda, completa, specialmen-te nel caso di reimpieghi: un marmararo ha ricomodato la colonna vecchia nelle mezarie, si spende per giornate di marmarari che travagliano con il mio marmo vec-chio ascendenti a lire 43.17, ovvero rifatte n° 4 piane di marmo alli balconi e fatto due capitelli per la porta e il batiporta della medema. Usa uno stucco speciale (robba per lo stucco de marmarari), probabilmente anche dell’olio, e si serve di una raspa per le finiture e di agoglie e scopelli.
1.4 I LUSTRATORI
Una figura spesso citata nei conti Pallavicini, quasi da sembrare una maestranza a se stante, è quella del lustra-tore, o lustradore, che interviene per lustrare li quadretti di terra, gli ottangoli e quadretti per i pavimenti venuti da Biserta, molto probabilmente usando una barcata di arenino, sicuramente alcune raspe.
Interviene anche su marmi nuovi o vecchi, come i marmi antichi della cappella, mediante l’uso di apposite raspe per lustrare i marmi, non possiamo essere certi che siano diverse da quelle citate per uso del marmararo, ma qui sembrano specifiche, sembra evidente invece l’uso per la lustratura di una cornice antica, di stucco e olio.
Da un cenno nei conti di Cornigliano, in cui i lustratori non sono mai citati, apprendiamo che chi esegue le operazioni di lustratura di ferri da finestra, è un lavorante, ovvero non possiede ancora (o non avrà mai) la qualifica di maestro.
1.5 I FALEGNAMI
I maestri che lavorano il legno sono chiamati nei conti con due diversi nomi: bancalari e falegnami, il primo termine è molto più usato tra Cinque e Seicento e compare nella denominazione ufficiale dell’arte, in generale osservando il contenuto dei documenti sembra che il loro uso sia indifferente.
Ma si trovano i primi pagati dal capo d’opera insieme ad altre maestranze e gli altri invece hanno una loro lista separata: sembra ipotizzabile, almeno per questo caso, che i bancalari svolgano un ruolo più attinente allo svolgersi della fabbrica in senso stretto, mentre i falegnami siano forse impegnati nell’arredo.
9 Cancello, in questo caso può essere di legno traforato, posto a metà scala.
11
Tutti si occupano comunque anche di strumenti o manufatti da cantiere come nel caso del falegname Rol-lero che interviene per agiustare tre volte la tavola dello designo della rebaggia della scala maestra do palaszio e acomodare lo caro.
Hanno ferri che necessitano continua manutenzione ed oliatura: arrivano in cantiere n° 7 quarteroni di oglio che serve per ongere li ferri de bancallari a soldi 10; usano un’erba particolare, finemente abrasiva10, per la superficie dei loro manufatti (erba per i bancalari). Sem-bra poi siano ospitati in casa durante il lavoro: bugata fatta a lenzuoli de bancallari e lavorano anche di sera se devono essere accomodati 24 lumi per li bancalari, dopotutto il loro lavoro si svolge in gran parte al chiuso e quindi possono facilmente trovarsi in condizioni di luce ridotta.
1.6 IL FABBRO
Il fabbro, oltre a produrre, come fa maestro Gio Pietro Bonvino ferraro che fornisce a Paolo Gerolamo Pallavicino, ferri chiodi e manifatture dalla sua ferriera di Trigasta, o riadattare tutti i manufatti metallici oc-correnti, ha una parte importantissima nel mantenere in efficenza gli strumenti di tutti gli altri operatori11, per queste operazioni può essere utile altra attrezzatura come una mola per rotare li ferri de falegnami.
Così vediamo ad esempio un maestro ferraro che accomoda li ferri à maestri scalpellini che squadrano gli ottangoli e quadretti venuti da Biserta, oppure le grate d’ottone con cui si ripassa l’arena e fornisce una cazza per fondere il piombo in peso libbre 3.4 per uso della fabbrica nel cantiere Pallavicini e i ferrari Bartolomeo Bruno e Domenico Zanata che, a Cornigliano, in di-verse volte eseguono operazioni di bollitura, azzalitura, appontatura, agiontatura…
Con accomodare si intende in generale la manu-tenzione che ogni strumento necessita per mantenere
la perfetta funzionalità: può essersi rotta una parte, aver perso la forma giusta (come nel caso dei denti), o persino essere necessario fare due interventi diversi sullo stesso attrezzo: azzalito un martello dalla penna e agiontato ferro dall’altra (parte).
Appontare o pontare e refilare sono termini più spe-cifici, che indicano l’intervento sulla punta o sul filo dell’attrezzo, così come azzalire, che si potrebbe italia-nizzare in acciaiare, irrobustire tramite la carburazione del ferro (battitura della superficie a caldo con polvere di carbone), procedimento che rende il manufatto più duro in superficie lasciandogli una certa elasticità:
aver posto l’acciaio ad un piccone.
Il carbone usato è probabilmente di castagno se il fabbro ne vende di quello avanzato:
carbone lasciato di castagnia.
Inoltre produce strumenti per altri maestri: un pistello per il giesso, due lumi da mano per uso della fabbrica, un rastello di ferro per uso della fabbrica per la calcina, punte da piantare per le lenze, una lastra per il vedraro da metere il stucho a vetri.
Durante la costruzione interviene spesso per met-tere in opera o adeguare se già presenti i suoi stessi manufatti che hanno funzione strutturale: le chiavi12; lo troviamo così a:
ritagliare una chiave con lima e scaldata e rivoltarla £ 3
scaldare altra chiave in opera doppiata per carbone e fattura £ 4
havere adrizato una chiave da tré a fascio e dato tré bolliture e fatta in misura £ 7.10
tagliare una chiave con lima et archetto in cucina £ 2.10
avere tagliato due chiavi da quattro a fascio in opera con lima £ 4
avere tagliato altra chiave in due luoghi con lima in opera £ 2.10
per avere tagliato con lima una chiave grossa in opera per li poggioli £ - 10
10 Comunicazione orale del prof. Mannoni, acquisita presso un laboratorio di falegnameria in cui ancora viene utilizzata.
11 Sul ruolo del fabbro in cantiere cfr. BOATO, DECRI, Il ferro nel-l’architettura storica genovese: impieghi strutturali e finiture, in part. 1. Chiavi, vele e stanghette. Sugli oggetti metallici forniti dal ferraro cfr. il capitolo sul ferro e altri metalli.
Fig. 1 – 35 Seggia, secchia; 36 Seggia de legno, secchia di legno. Poco dissimile dalla secchia di legno è il bugliuolo o bogliolo (buggeu), che è una specie dipiccolo bigonciuolo con una doga sporgente; 39 Buggeu, secchio di legno, ha talora un manico semicircolare terminante in due doghe; talora un manico di ferro, o un pezzo di fune che si raccomanda agli occhi delle due
doghe sporgenti.; 40 Buggeu, bugliolo, vaso di legno simile al bogonciolo (v. sebbro) ma un poco minore (PAGANINI 1857).
12 Cfr. BOATO, DECRI, Il ferro nell’architettura storica genovese, cit.
12
13 Arembaggia: bracciuolo, appoggiatoio lungo il muro delle scale ad uso di tenervisi con la mano. A. PAGANINI, Vocabolario domestico genovese-italiano, Genova 1857.
dove bollire significa saldare a caldo; nonché deve intervenire sulle stanghette, i paletti capochiave,
fattura d’havere adrizzato una stanghetta grossa scaldata £ -.16
tagliare una stanghetta grossa in opera con lima £ 1.10
tagliare una stanghetta di chiave grossa in opera £ 3
tagliare una stanghetta in due luoghi in opera £ 3
tagliare una stanghetta grossa e scaldata £ - 14
ed inoltre prepara:
una branca con due occhi e due inginocchiature per un pilastro in peso rubbi 5.1 £16.0.8una chiavetta per la pilastrata della porta maestra di palmi 1 1/2 £ - 12
1.7 IL BOTTAIO
Fra le maestranze richieste in cantiere compare il bot-taio, evidentemente specializzato nello foggiare il legno per ottenere forme curve, è lui che produce la sesta del contorno della rembaggia13 della scala, ma anche che realizza oggetti utili al cantiere, i buglioli da calce e le secchie sempre da calce, nonché i secchielli con maniglia (3 segelli novi da manegia), e utili alla casa come uno bogiollo novo da posso sercatto de ferro, uno tapo grosso per la siterna; inoltre li aggiusta, magari aggiungendo uno serco a uno bogiollo da carcina, o intervenendo ben due volte sullo segione da pasta da carcina, che dovrebbe essere un mastello che contiene il grassello.
Ne troviamo citati due, a Cornigliano nel 1762, Giuseppe Rollero e Benedetto Daste.
1.8 IL VETRAIO
Si usa il termine di vetraio (verero, vedraro, vetriaro) per riferirsi sia a colui che realizza finestre a vetri (a Cornigliano Antonio Maria Bruno, Sebastiano Bruno, Pietro Assereto, Nicolò Bruno, sia a colui che fornisce conche, corbe, giare, bottiglie, trombette… ovvero vari recipienti di vetro e manufatti di cotto invetriati. Così succede in via Lomellini con Gio Battista Campi, mentre Rocco Paganino vien pagato per manifattura di vetri.
1.9 I SEGATORI
Sia la pietra, specialmente il marmo, sia il legno, ad esempio tavole, squere e giene, richiedono operazioni di riduzione mediante segatura in cantiere, queste vengono svolte in cantiere dai segatori a volte su materiali nuovi altre volte per il reimpiego:
n° 287 segano una colonna vecchia che serva per bati-porta p 23, olio d’oliva
n° 360 segatura tavole di noce per l’appartamento nob sup 19/4/1721
n° 126 segatura di due schiappe di legno e un cantero
1755 @ 19 luglio Conto di segatura di marmi
di tre tagli per fare i battenti della porta £ 10.8 (li paga al palmetto)
Nel taglio del marmo viene usata, di solito, una sega a lama liscia con sabbia a far da abrasivo, infatti vengono fornite
arena quarte 18 per segatori a soldi 10
questo strumento necessita di manutenzione là dove si consuma:
comodato una sera per il seratore de marmari adrizzata a caldo per essere frusta al mezo e tagliato al mezzo altra e di nuovo gionta
anzi, viene pagato proprio il consumo14:frazattura di sega et arena in più volte: palmi 142In particolare i legnami possono essere divisi longi-
tudinalmente15 facendo leva con cunei: comodato n° 2 conij dal taglio per schiapare li legniami.
2. MATERIALI
Su alcuni materiali i documenti offrono indicazioni tali per cui è possibile fornire alcune note, da ritenersi soltanto il primo passo di ulteriori approfondimenti.
2.1 CALCE E SABBIA
La calce usata a Genova per secoli è quella, dalle ottime prestazioni, che si cava dal monte Gazzo presso Sestri Ponente ed infatti nel cantiere Pallavicini la for-nisce Antonio Rossi di Sestri Ponente.
La calce che arriva in cantiere viene misurata, per il pagamento, dopo lo spegnimento (sciorare),
n° 248 misure della fossa di calcina
I contenitori più adatti per svolgere questa opera-zione sono apposite fosse ricavate in luoghi strategici in cantiere come le cantine o l’atrio, ma troviamo calcina cioratta nelli troggi e due troggiette di calcina cioratta fuori della fossa, nonché una cassetta, probabilmente di legno fissata con 8 angolari di ferro, che potrebbe contenere calce spenta ma anche costituire la prima vasca dello spegnimento.
Per tale operazione occorre fornire acqua nella quantità necessaria e così, nel palazzo Pallavicini, l’ottoniere Gio Andrea Pescio viene pagato per stagno consumato in aggiongere li canali nel vicolo delle Me-rini, ad effetto di fare venire l’acqua per stemperare la calcina nella fossa.
Un rastello di ferro per uso della fabbrica per la cal-cina in peso libbre 8 (circa due chili e mezzo) serve con tutta probabilità come griglia per setacciare i crudi.
Per preparare le malte la sabbia viene fornita in consumo di calcina, si parla infatti di servitù di arena, a seconda della granulometria desiderata va passata al setaccio:
acomodato la ramata per pasare l’arena per essere rotta, con filo di ottone.
14 Frazzà scemare, disperdere, calare, diminuire, mancare in parte, consumare, in G. CASACCIA, Vocabolario genovese-italiano, Genova 1851.
15 Scciappa: schiappa e stiappa; comunemente intendesi da noi la metà o parte d’una cosa schiappata, o spaccata per lo lungo, in G. CASACCIA, Vocabolario, cit.
13
Per conservare la calce viene costruita una apposita cassetta:
fatto n° 8 canti de suoi pezzi vechij per la casetta per la calcina.
Infine, per chiudere il cantiere, occorre anche eli-minarne le tracce:
savora portata per il pavimento della sera et per li fondi del palazzo ove vi erano le fosse della calcina.
2.2 LATERIZI
2.2.1 I mattoniNel cantiere di inizio secolo vengono forniti (ad
esempio da G.B. Lanza) mattoni di tre tipi: da carogio, ferrioli e neri chiari; con i seguenti prezzi:
mattoni neri e chiari £ 13. 15 il migliaio;
ferioli £ 15.10 il m.
chiapelle feriole £ 15
Sono presenti altresì le squole, dette anche spuole16, che non compaiono nei secoli precedenti, nei quali, però, i tipi di mattoni nei cantieri erano anche cinque17 per cui, in prima ipotesi, si potrebbe supporre che esse corrispondano alla qualità di mattoni meno cotti, quelli rossi o quelli negrisoli.
Nell’ottocento invece i prezzi variano in funzione della misura (ve ne sono diverse contemporaneamente) più che della cottura
18.
Vediamo che nel cantiere di metà secolo la fornitura di mattoni non varia nei tipi, con qualche differenza nel calcolo del prezzo e persistono quelle che ora son chiamate spole, risultano in numero molto minore ri-spetto agli altri e costano come i mattoni neri e chiari, mentre invece, per il trasporto, vengono considerate come le chiappelle, ne consegue che sono più leggere dei mattoni?
Per i gruppi di costo è eloquente il seguente conto:1756 al primo luglio Conto di prezzo di mattoni
N° 30000 mattoni ferrioli
8640 chiapelle come sopra
38640 a £ 11.10 £ 444.8
N° 37850 da caroggio a £ 13
3000 detti scarti a £ 11
40850 £ 525.11
N° 8000 negri e chiari a £ 9.10
3000 spole a £ 9.10
11000 £ 104.10
N° 10000 ferrioli e da caroggio
rotti per battumi a £ 8 £ 80
È interessante notare questa fornitura di mattoni rotti per i pavimenti battuti, che non sono quindi un residuo del cantiere ma provengono direttamente dalla fornace già in frantumi, verranno ridotti a pezzi più piccoli a seconda dell’uso.
In quest’altro conto, in cui collimano i prezzi di cui sopra, si introduce un nuovo elemento: le monelle di prezzo molto più alto e di spessore maggiore.
1754 a 22 ottobre Conto di Casciano Salamone per mattoni et altro come da 10 contente
mattoni ferrioli N° 43550 a £ 11.10£ 500.16.
detti negri e chiari N° 18000 a £ 9.10 £ 171.
detti da caroggio N° 28600 a £ 13 £ 375.16.
monelle osia mattoni doppi N° 3589 a £ 18.10 £ 65.12.
chiapelle feriole N° 12300 a £ 11.10 £ 141.10
spole N° 1000 a £ 9.10 £ 9.10
quadrelle grandi per pavimenti N° 4970 a £ 24.10 £ 121.16
Il totale dei mattoni arrivati a Cornigliano dal 1752 al 1757 è 1.156.189; le chiapelle ferriole sono 59.530, le spore 10.000 e i quadretti della forma grande 41.130.
2.2.2 Materiali per pavimenti Per i pavimenti troviamo diversi generi di manufatti,
innanzitutto le chiappelle che nei secoli precedenti era-no mattonelle rettangolari da pavimentazione interna, facilmente confondibili con i mattoni.
Ma in un conto di prezzo di mattoni ferrioli di Casciano Salamone n° 102900 e chiappelle ferriole n° 2000, per Cornigliano, si specifica che le chiappelle sono quadre; in un altro conto di porto alla spiaggia di quadrelle n° 5000, ciapelle ferriole n° 1000 e spole n° 1000, solo le prime sono indicate per pavimenti; infine troviamo un conto di porto dalla spiaggia alla fabbrica di quadrelle 12000 e chiappelle ferriole 5000; si specifica che i quadretti di oncie 6 in quadro sono di matteria ordinaria di mattone e che il trasporto costa meno rispetto ai mattoni perché sono più piccole.
A fronte di questi dati si può ipotizzare che le chiap-pelle continuino ad essere rettangolari come nei secoli precedenti e che quello del documento suindicato sia il modo di indicare un manufatto particolare, non esisten-do la dizione quadretti ferrioli, infatti, da un controllo sulla filza 476 dei conti Durazzo, apprendiamo che arrivano in cantiere i quadretti di pasta ordinaria e le chiappelle ferriole quadre.
Inoltre si potrebbe pensare alle spole come ad un materiale per pavimenti, essendo accomunate in una stessa fornitura con quadretti e chiappelle, oppure si potrebbe identificarle con i mattonini citati soltanto nella prima filza di conti.
Esistono ancora altri elementi da pavimentazione: le quadrelle grandi, chiamate in un conto anche quadretti doppi, nel trasporto da Savona di quadrelle n° 6000 il nolo di dette quadrelle che per essere quasi il doppio delle solite a £ 5 per migliaio se le paga £ 30.
Molto particolare infine è una fornitura, per il cantiere Pallavicini, di ottangoli 21mila e quadretti 13 mila da fabricare, prodotti a Tunisi, le cui avventure di viaggio sono narrate al capitolo “provenienze e trasporti”.
16 Il termine potrebbe suggerire anche l’idea di un elemento cavo, si può trattare dei primi mattoni forati o forse di cilindri ritrovati in riempimenti di volte?
17 Cfr. A. BOATO, A. DECRI, Il cotto nelle pavimentazioni genovesi dei secoli XVI e XVII, in Superfici dell’Architettura: il cotto. Caratte-rizzazione e trattamenti, Atti del convegno, Padova 1992.
18 Città di Genova, Ufficio dei lavori pubblici, Capitolato speciale per l’appalto della manutenzione ordinaria quinquennale degli stabili di proprietà o di uso del Municipio di Genova o per cui incombe al Municipio di Genova di sopportare o di anticipare in tutto od in parte la spesa, Genova Pagano 1882.
14
Anche fra le trombette di Pisa alcune sono «un poco assentite», in un altro documento sono «astronate», si può immaginare il suono “stonato” che fanno quando hanno qualche piccola lesione che ne rende sconsiglia-bile l’utilizzo22.
Fanno parte ancora delle forniture dei ceramisti tre campanelle e una campanella grossa; eppoi:
18 conche per pittori
3 conche grande
1 conca delle più grande
Infine sono materiali ceramici i coppi, rifiniti con vernice (probabilmente una vetrina), che devono essere posti a completamento dei vertici del tetto. Sono forniti anche 12 coppi di Pisa.
2.3 LEGNO
Per quanto riguarda il legname è da segnalare la quantità di diverse forme e, naturalmente, di diverse essenze e provenienze con cui si presenta al cantiere:
2.3.1 BaioO bailo23 di Fiandra, lungo palmi 22 può essere
grosso o mezzano (oltre sette metri, spesso o sottile), è citato solo nel palazzo Pallavicini.
2.3.2 BecciarieLunghe dai nove ai dodici metri e più, compaiono
solo nel cantiere genovese e sono paragonabili alle sucinte di rovere di p 50 once 6, o alle
insente di rovere n° 4 di p 52 l’una a £ 7 l’una che servono per incatenare il solaro del guardarobbe.
2.3.3 BordonariQuesto termine si riferisce a elementi forniti sin-
golarmente o in pochissime unità, lunghi dagli otto ai sedici metri, vengono impiegati nei solai o come costana al tetto, in questo caso si precisa che si tratta di un bordonaro di cipresso lungo quasi dieci metri.
Un capitolato ottocentesco li traduce con travi24.Sono oggetto di reimpiego in altro ruolo:tre bordonari antichi della casa per servire da canteri delle cantine dell’appartamento superiore.
2.3.4 CanteriDi solito sono di castagno (specialmente di Corsica)
ma a Cornigliano si trovano anche di cipresso, sono lunghi dai due metri e mezzo ai tre e una misura di spessore ritrovata è di circa 12 cm; si usano in vario modo, soprattutto per solai e balconi, ma anche per il pavimento del miradore, o per realizzare la gropia nella stalla.
Ad aggiungere un po’ di complessità a questa fornitu-ra è che 5000 ottangoli di terra di Tunis per li pavimenti nobili sono venduti a Paolo Gerolamo a Genova, dal padre Alessandro Mainero della Compagnia di Gesù, per cui si può pensare che questa lontana fonte fosse usata da più persone.
A Cornigliano sono impiegate anche1000 quadrette di oncie 15 in quadro fondo bianco con fiori di diversi colori fatte venire da Napoli per il pavimento del bagno e luogo all’inglese e 2050 pianelloni osia chiapelle più larghe e longhe delle nostre e di pasta più fina venute da Pisa (pagate a Gio Maria Cavanna £ 60).
2.2.3 FinitureI materiali da pavimento necessitano ancora di lavo-
razione in cantiere per una perfetta messa in opera, con i giunti veramente sottili, ineseguibile prima se si vuole evitare di rovinare i bordi nel trasporto: si tratta della squadratura e fregatura di quadretti; è impressionante leggere i numeri di questo lavoro di precisione:
n° 1550 £ 38.14
per scuadrare n° 9600 quadretti solo di quadratura per essere statti fregati in gta a conto de suddetto ill.mo signore a ragione di soldi 30 il centinaio £ 144
per n° 27300 sudetti quadretti scuadrati e fregati a scarso a soldi 52 il centinaio £ 709:16
per scuadrare n° 900 quadretti vechij a soldi 16 il centinaio £ 7:4
Mentre per la squadratura si rimanda al capitolo “lo scalpellino”, per la fregatura, con cui si rendeva liscia la superficie scagliata dal frappo19 si può ipotizzare che venissero usate delle raspe:
2 raspe per quadrelle venute da Napoli.
Probabilmente dopo la messa in opera l’ultima lavorazione è lustrare li quadretti di terra, operazione effettuabile con la cospicua quantità di arenino, usato come abrasivo, che viene citata nello stesso conto:
n° 370 raspe per lustrare ottangoli e quadretti venuti da Biserta
n° 280 lustrare li quadretti (282 e ottangoli) venuti da Biserta; una barcata di arenino.
2.2.4 Elementi per impianti ed altro Trombette e cannoni20, le prime più smilze i secondi
più larghi sono gli elementi delle tubature, posti in opera in sequenza e innestati l’uno dentro l’altro, che sono in grado anche di effettuare cambi di pendenza e curve; ne esistono versioni speciali: 4 cannoni straor-dinari, 4 canoni da lavello, 12 canoni grossi, 2 goelli da trombetta, 4 trombe grosse.
A Cornigliano fanno la loro comparsa anche le trombette di Pisa, nell’ordine delle centinaia, perciò prevalenti su quelle locali, sono anch’esse finite con vernice, alcune sono doppie21, ma un’altra voce più ingente è quella delle trombette per canali
Canali con vernice di Empoli tot 1383, se ne deducono per essere stronati 59.
19 Oppure la parte superiore?20 Cfr. A. BOATO, A. DECRI, Gli impianti delle case genovesi tra
Cinque e Seicento, «Tema», n° 1, 1995.21 Potrebbero essere più spesse o forse il termine è da riferire al
raddoppio del diametro riscontrato in diversi casi reali.
22 Assentiö allentato, rotto. Astrûnnôu intronato, fesso, smosso. Dicesi di un vaso incrinato o di campana che battendovi sopra manda un suono cattivo. In G. CASACCIA, Vocabolario, cit.
23 Baglio: grosso trave di legno o di ferro, in D.E.I. 1975: C. BATTISTI, G. ALESSIO, Dizionario etimologico italiano, Firenze 1975.
24 Archivio di S. Maria della Castagna, Genova, Filza A, inserto 7 plico 1, Condizioni relative all’appalto dei lavori per l’alzamento di un braccio del Monastero dei R.R. Padri Benedettini di S. Giuliano.
15
Fig. 2 – Camino al pianterreno di villa Durazzo di marmo di Serravezza.
2.3.5 GeneSono presenti soltanto nel cantiere più antico dovedue giene (p 34 e p 38) sono poste alli due salotti verso strada lomellina.
2.3.6 SquereSembrano essere sempre di legno di Fiandra, cioè
una conifera del nord Europa, ne arrivano in cantiere centinaia, lunghe dai tre ai quattro metri.
Sono poi dette panconi nell’ottocento25.
2.3.7 Tavole e tavoloniIl significato è evidente, le essenze usate sono moltis-
sime, nel cantiere genovese: castagno, noce (comprate nel contado di tortone), arbora di Pisa, Amburgo; a Cor-nigliano ancora arbola, castagno di Corsica e cipresso proveniente da Savona; messe in opera nei solari e in molti altri posti:
tavole di castagnia di corchica per le rige della gropia e le sprange della porta della stalla e per li telari da vedro e per li seti del loco comune e per li orli deli telari da bar-coni in tuto parmi n° 9 a sordi 28 il parmo £ 12:12
Misurano dai 7 ai 32 palmi. Sono forniti anche dei tavoloni di cipresso venuti da Pisa e venduti dal cavalier Agliata sono varie quantità di diverse lunghezze (da 9 a 14 palmi) provengono anche da Lucca.
2.3.8 Trapellotti, palati, riondi, radiciIl cantiere più antico ci fornisce ancora altri nomi di
elementi, come le radici, decine di trapellotti di palmi 10-12,
4 mezzi palati
tre legni di rovere di p 15; e 2 di p 10
un legno di sapino l p 38 comprato per appuntelare poi servirà per il tetto
uno riondo di rovere di p 18.
2.4 MARMO
Anche se il marmo non può essere considerato uno dei materiali percentualmente più presenti il suo ruolo nell’architettura è essenziale per realizzare l’effetto di sobrietà e lusso che caratterizza i palazzi genovesi già nei secoli precedenti.
Sono infatti di marmo manufatti come colonne e pilastretti per le scale, porte, piane, piedistalli, poggioli con balaustri, dieci dadi per le scale maestre, due pomel-li, ecc. che sono forniti in via Lomellini da Gio Battista Porri q Gio Maria marmararo.
Naturalmente viene considerato un materiale prezioso (se non altro perché è un materiale pesante che viene da lontano, proveniendo il tutto da Carrara come da conto del signor Moretti) e quindi, ancora più attentamente che al solito, ne viene recuperato e reimpiegato ogni pezzo, così Paolo Gerolamo paga marmari e lustradori che hanno lavorato attorno ai meii marmi vecchi. Nei pianerottoli delle scale vengono lavorati marmi nuovi ma anche 86 quadretti riciclati e rilavorati, nonché bisogna fare con li marmi antichi della fabbrica il cordone di marmo della porta situata in strada Lomellina, utilizzare una colonna vecchia che serva per batiporta, vanno rifatte n° 4 piane di marmo alli balconi e fatto due capitelli per la porta e il batiporta della medema e piede di stallo con mio marmo al putto di marmo della fontana della terrazza.
Nei bordi dei pianerottoli e dello spazio antisala, vengono messi mezzanini, elementi che nella pietra di Lavagna sono lunghi e stretti e posti come alzata nelle
25 Città di Genova, Ufficio dei lavori pubblici, Capitolato spe-ciale, cit.
16
scale, perciò questi di marmo risultano molto adatti per costituire la finitura di un piccolo pavimento.
Una novità che si nota nel cantiere Durazzo è l’im-piego del marmo per gli scalini della scala, cosa che non avviene in casa Pallavicini e neanche nei secoli precedenti (l’unico esempio che mi risulti documentato – oltre alle chiese – è un edificio molto particolare quale l’Albergo dei Poveri, costruito nella seconda metà del seicento).
Infatti arrivano diverse casse di scalini, oltre a pezzi vari: 3 pezzi di marmo grigio per la scala, pezzi marmo per la scala 4, la scala maestra ha ben 54 scalini di longhezza palmi 12 (che costano l’ingente somma di 2786 lire) l’arco della scala maestra (che costa da solo ben 760 lire), la sponda con il girone della suddetta scala secondo il disegno, altri n°6 pezzi di cornice per cordone della suddetta in longhezza fra tutti palmi 47.
Una fornitura di pezzi tutti diversi serve per la scaletta della parte verso ponente nel giardino, in cui vengono impiegati
scalini n° 1 di longhezza palmi 9 larghezza palmi 3; n° 1 di longhezza palmi 8.2, n° 1 di longhezza palmi 7.6 e n° 6 di longhezza palmi 7, in tutto sono palmi 46.8 a £ 4.6 £ 286.12
Gli scalini possono essere corniciati e pieni, a volte sono pagati a palmetto, che indica il palmo quadrato:
scalino di palmi 6 1/2 largo palmi 2 palmetti 13 riqua-drati a £ 2 il parmetto.
Come complemento della facciata vengono impiegati 263 balaustri, 54 poggioli e 5 piedistalli per pogoletti; mentre le terrazze sono fornite di
n° 16 pilastri per le terrazze compreso n° 4 mezzi pilastri a £ 45 l’uno £ 720
n° 4 pilastri per li canti a £ 70 l’uno £ 280
per cornice alle suddette due terrazze in giro di palmi 245.4 a £ 4.6 il palmo £ 1054.18
per lastre poste sotto li balaustri in giro di palmi 253 larghe 0/16 che devono essere palmi 2 a £ 2.10 £ 632.10
balaustri per le medeme n° 228 a £ 4 £ 912.-
3 casse lastre per terrazza
6 lastre senza cassa per terrazza
17 casse cornici per terrazza
11 piedistalli per terrazza.
A Cornigliano si riscontra un utilizzo notevole del marmo anche nei pavimenti, quando vengono provvisti da Giambatta Viani 1650 quadretti di marmo bianco di once 7 (circa 14 cm di lato) e 366 quadrelle di marmo compre in Genova, da 12 once (circa 28 cm di lato), 1497 quadrette di marmo rottate e fornite di palmo 1 in quadro e altre 714 in un’altra fornitura (circa 24 cm di lato). Molto belle le 16 amandole di bianco e nero servite nel squarsato della porta nella capella a soldi 36 cadauna; altre 16 a minor costo (soldi 22) sono impiegate altrove.
Una voce molto ripetuta nei conti è la polvere di marmo, venduta in centinaia di quarte (circa 14 kg e mezzo) da Antonio Capelano e da un certo Schiaffino a Cornigliano, mentre in città viene fornita da maestro Francesco Marino scalpellino, insieme a diversi mate-riali lapidei.
Marmo bardiglio, marmo avenato, due camini di salvaressa26 e pietre di marmo venute da Roma sono impiegate per arredi.
Infine il marmo trova largo impiego negli impianti come troglio, lavello, bocca di pozzo, luogo all’inglese e n° 1 bagno tutto in pezzo e lavorato a £ 420.
2.5 METALLI E LEGHE
La quantità di manufatti metallici che circola in cantiere è cospicua e molto varia. Si va dalle catene, fondamentali per la struttura, ai cardini e sistemi di chiusura dei serramenti (meglio visti nel capitolo ad essi dedicato) agli attrezzi per la costruzione, come l’interminabile serie di picche, pichette, marapiche, piconi, martelli, frapine, ecc. che ricorrono nei conti, specialmente nella prima fase del cantiere.
2.5.1 FerroVediamo arrivare a Cornigliano cantara 1.24 ferro
ponentino comprato in Genova (circa sessanta chili). L’aggettivo parrebbe alludere alla provenienza, tuttavia molto ferro proviene da Savona (molte le ferriere del-l’entroterra) senza essere chiamato ponentino;
1753 @ 5 dicembre Conto di porto alla spiaggia di ferro cantara n° 34
arriva da Savona ed è provvisto da Garbarino
1753 @ 4 dicembre Conto di porto alla spiaggia di ferro cantara n° 9.67
arriva da Savona col padron Sebastiano Guasco ed è provvisto da Garbarino
si tratta di 2 fasci ferro quadrato da 6 a fascio
e 6 fasci di ferro simile da 5 a fascio
in tutto pesa cantara 9:67
non è da escludersi allora un significato che riguarda la forma: oltre ad esso, infatti, sono presenti ferro grosso, ferro piatto e piatto da 7, ferro quadro e bi-squadro da 10 e da 12, ferro rotondo e staza sotile; in particolare si trova una citazione di fasci di ferro ponentino e rottondo: può essere le due cose insieme (forma e provenienza) oppure il primo è sicuramente non tondo?
prezzo a £ 23 al cantaro di cantario 1.25 peso di fasso uno ferro tondo da 14 consegnato a maestro Bartolo-meo Bruno, compreso il facchino £ 29.4
fasci di ferro da 8 in quadro n°10
fasci di ferro da 12 in quadro n° 3
A complicare la questione è anche la seguente for-nitura:
1756 à 22 febbraio Conto di ferro di Moscovia
lastre 30 ferro di Moscovia
il cui prezzo per peso, trasporto, dogana, scelta, am-monta a £ 232.12 pagate ad Antonio Maria Weber (il quale fornisce anche verderame). Lo stesso compare come trasportatore (insieme a Rouvier, sono pagati in ragione del 10%) del ferro per i cancelli della villa di Cornigliano, ben 219 cantara di ferro in verghe (grosso onze 2 1/2 in quadro) fornito da Causa e Raffo.
26 Serravezza, in Versilia, vi si cavava la breccia medicea, roccia policroma oggi esaurita.
17
È noto come il ferro sia indicato nei documenti dei secoli precedenti usando come unità di misura il fascio:
Negli edifici di abitazione le catene previste dai contratti di costruzione erano in genere di trappe (barre) da 4 o da 6 a fascio, mentre nelle grandi volte degli edifici religiosi si potevano mettere in opera anche catene da 1, da 2 o da 3 a fascio. A numero maggiore corrisponde evidentemente diametro inferiore, secondo una relazio-ne che dipende forse dal processo di produzione oppure da una particolare unità di misura in uso nel commercio di tali elementi.Possiamo osservare le forniture per Cornigliano:Fasci n° 2 da 6 a fascio ferro piatto in peso cantara 2:59
fascio 1 da 12 cantara 1:23
fasci n° 2 da 6 a fascio ferro quadro Cantara 2:45
fasci n° 2 da 10 a fascio ferro rotondo cantara 2:81
e notare che i vari fasci hanno solo piccole differenze di peso (circa cantara 1:10 ~ 1.20 al fascio, kg 52-57), per cui dato che al diminuire della sezione dell’elemento in un certo peso ci stanno più elementi, sembra confermata la lettura soprariportata: una chiave da uno a fascio potrebbe così avere diametro otto volte più grande di una da otto a fascio.
Restano da citare la ghisa27, due lastre grandi di ferro d’Olanda per camini e il filo di ferro: per tendine 3 mazzi fili di ferro, filferro tirato alla trafila.
2.5.1.1 ChiaviCome sistemi di contrasto delle spinte orizzontali
delle volte oppure come legature degli orizzontamenti e dei muri sono messe in opera le chiavi, e messe in tiro con la stanghetta, il bolzone, incuneata nell’occhio,
un pezzo di chiave con due occhi da una parte e gancio e altro occhio con gancio
ma anche con i tiranti provvisti di occhio e gancio. Allo spesso scopo servivano probabilmente i cunei tal-volta citati per sequadrare, mettere in tiro.
due cunij serviti per le chiave
fatto n° 6 conij per sequadrare le chiave inbraghate.
La funzione di legatura tra murature e solai poteva essere svolta anche dai travi maestri attraverso altri elementi di ferro le vere, o vele:
lunghe staffe di ferro che da un lato sono dotate di fori per alloggiare tre o più chiodi e di un gancio lungo e acu-minato tramite cui vengono fissate alla parte terminale del trave, dall’altro lato terminano invece in un occhio in cui viene inserito un bolzone di ferro (la stanghetta), simile a quello adottato nelle catene delle volte28.
L’elemento acuminato viene detto rampone:fatto il rampone novo a una veria
boglito nel mezzo n° 13 sue verie giontato ferro e fatto il rampone e agiustate nel ochio
e si trova, oltre che nelle vele, anche come parte ter-minale di un tirante
tiranti per regiere la capa di un camino da inchiodare e con ramponi
o a sé stante: ramponi da una parte tiratti sotili con buchi da inchio-dare e dalaltra con ranpone.
A volte le chiavi sono dotate di bracci29 ovvero di diramazioni rispetto alla linea orizzontale della catena principale, sistema utilizzato per non ingombrare l’in-tradosso dell’arco , detto anche imbragatura:
una chiave senza stanghetta con gancio bollito per il braccio
chiavi con ganci bolliti per li bracci e 4 stanghette
due bracci senza stanghette
un braccio con occhio e ganco
fatto n° 2 chiave nove da 4 inbraghate a n° 4 brazzi e con sue stanghette in peso cantara 626.
Ma esistono anche chiavette, messe in opera nella facciata, probabilmente come armatura delle decorazio-ni, altre servono per assicurare i contenitori della terra, altre ancora legano i manufatti di marmo o di pietra:
chiavette da impiombare e murare per la facciata, altre lunghe once 8, altre da palmi 1 1/2
chiavette da hortigiolo anche inginocchiate
chiavette a coda di rondine per li balaustri di marmo sopra la terrazza
chiavette per i poggioli di marmo
chiavette fatte a Te da murare per tenire le chiappe del parapetto di una terrazza
chiavette tenere uno stanterolo da una parte da murare e dalaltra d a inchiodare
in modo simile a quanto accade per gli elementi di sostegno dei corrimano delle scale:
per uno arembatore di scala in peso libbre 64 a soldi 4.5 circa la libbra £ 13.17.4
per 5 chiavette da impiobare per dettoed altri manufatti diversi come
una branca con due occhi con piegature et una chia-vetta per detta per tenere un pilastro fatte con molte fatture
Fig. 3 – Saliera di Campomorone. Sezione sul portico: schema delle catene e dei “brazzi” (CEVINI 1996).
27 Il ferro non viene commerciato in lastre e sul fondo dei camini viene usata la ghisa, riflette il calore verso la stanza ed è possibile decorarla molto finemente mediante stampi.
28 BOATO, DECRI, Il ferro nell’architettura storica genovese, cit., in part. 1. Chiavi, vele e stanghette.
29 Figura tratta dalla tesi di laurea di P. CEVINI, La torre D’Amico a Campomorone e il commercio del sale nel seicento, rel. T. Mannoni, facoltà di Architettura di Genova, a.a. 1996/97.
18
ganci nuovi incrociati per le colonne
ferri inginocchiati per scale
ferri per reggere li mezzanini.
Restano da citare le stazze, verghe di ferro30, che nell’ottocento sono indicate come le parti di una rin-ghiera (cfr infra), ma compaiono nei nostri cantieri anche con funzioni diverse: per reggere le righe, come tirante di stazza con buchi e persino come chiavi di stazza e stanghette.
2.5.1.2 ChiodiQuesto argomento necessita di un approfondimento
particolare per la difficoltà di riconoscimento dei molti manufatti diversi che si possono raggruppare sotto il nome di chiodi, il primo passo, affrontabile già in que-sta sede, è quello di elencare i termini riscontrati nei documenti, aggiungendo le sporadiche informazioni che vi si possono riferire:
chiodi da banco, chiodi da basto semplice, chiodi da basto doppio, chiodi da basto doppio siaccati, chiodi da bessaro (besale), chiodi da canna, chiodi da can-telaro (incantalaro), chiodi da gelosia, lorpe, lorpe sciaccati, chiodi da palmo, chiodi da riga, chiodi da riga con bolla, chiodi sciaccati, chiodi da seitro (sentro, celtro) semplici, chiodi da seitro (sentro, sutro) doppi, chiodi da soccalo (zoccolo), chiodi da solaro, chiodi da solaro con bolla, chiodi da solaro lorpe, chiodi da solaro siaccati, chiodi da sprangare (sprangaro), chiodi da sprangaro con bolla, chiodi da sprangaro sciacati, chiodi da sprangaro sciacati grossi, stachette da solaro, stachette da 10, stachette da 12, stachette da canna, stachette da riga scacciate, stachette da riga stagnate, stachette da solaro, stachette da splangare, chiodi da veria, stachette da zoccolo.
Ed inoltre si trovano chiodi da denari 4 l’uno per la facciata, chiodi per li ponteli.
Sono provvisti in balle (pagati a peso) o a numero (migliaia o centinaia) dai fabbri oppure dalla bottega dei fratelli Riviera (da cui arrivano anche uno barile tonina stipa grossa e mezzo barile stipa [stepa?] piccola) per Genova e Bartolomeo Piccardo per Cornigliano.
Un confronto fra i prezzi può aiutare a capire, a se-conda dell’ordine di costo, quale rapporto dimensionale vi sia tra i vari chiodi:
soldi al migliaio soldi alla libbra62 sprangaro siacati 86 incantalaro44 solaro 30 bessaro34 riga 20 sentro doppio32 solaro siaccati 14 basto doppio24 stachette da 12 8 lorpe14 gelosia 6,8 sprangaro8 lorpe 6 cantelaro6 sprangaro 4 riga con bollaCirca 5 riga con bolla
Si possono ancora aggiungere alcune definizioni31:cante’ o travërsi, correnti, piane, travicelli quadran-
golari, lunghi e sottili che servono a diversi usi, especial-mente per far palchi e coprture di edifizj addattandoli fra trave etrave
riga, regolino,liste di legno che coprono inferiormente le commessure delle assi de’ palchi. I regolini lisci son riquadrati solamente, i regolini bozzolati (Righe co’ o cordonetto), hanno una modanatura per ornamento
e annotare come le stachette da riga stagnate ven-gono usate dai vetrai, mentre stachette semplici vanno in 6 telaretti di legno per l’uccelliera.
Nelle gelosie di Cornigliano vengono impiegati centinaia di chiodi da solaro, di cui alcuni sciaccati, oltre a pochi chiodi da celtro doppij, da sprangaro e un centinaio da basto sempij, per le mappe sono specificati chiodi da basto doppij, per i ferogiari chiodi generici.
In cantiere vengono svolte diverse finiture, come la limatura, applicata alla testa di diversi tipi di chiodi, specialmente a quelli da basto, semplici o doppi; la sciacatura della testa, eseguita su chiodi grossi, per dare una forma particolare:
sciacato la testa fatta a marteletto a n°100 chiodi da? per li legnami delle grepie
sciacato la testa a n° 40 chiodi da besaro
sciacato la testa a marteletto a n° 88 chiodi da veria e besaroed inoltre:ariondato nella gamba e imbotiti nella testa n° 88 chiodi grossi da cantero
tirato sotile n° 24 chiodi da veria e di novo fatto la testa
tagliato la testa a n°200 chiodi e fatto la ponta
All’inizio del Seicento le stachette probabilmente si dicono
aguti per vedri, aguti da riga, aguti sciacati32,ed inoltre si può redigere una casistica meno ampia:chiodi da basto e da sentro sia dopij che sempij, chiodi da banco, chiodi grossi, chiodi da splangare.
Fig. 4 – 1a) ago, chiodo a testa, 1b) punta; 2) punte de pariggi, bullette spille; 3) stachetta o brochetta (corruz, di borchietta), nome di varie sorte di chiodi piccoli e corti e particolarmente di quelli che h anno un gran cappello. Stachetta a cado, bul-letta a caldo quella che si fa con vergetta di ferro arroventata, ed ha quadrangolare il fusto e la capocchia proporzionalmente
più grossa (PAGANINI 1857).
30 Stazza, verga graduata che serve a stazzare, misurare la capacità interna di una nave; F. CERRUTI, L.A. RESTAGNO, Vocabolario della lingua italiana, Torino 1939. da cui Figg. 7 e 8
31 A. PAGANINI, Vocabolario domestico genovese italiano, Genova 1857, da cui anche Fig. 4. 32 BOATO, DECRI, Il ferro nell’architettura storica genovese, cit.
19
Fig. 5 – Badile (PAGANINI 1857).
Fig. 6 – Frappo (SAVIOLI 1988).
Infine si segnalano anche i dadi:dadi con testa quadra ribattuti in opera.
2.5.1.3 AttrezziAnche per gli attrezzi usati in cantiere la ricerca
risulta solo all’inizio, ma sembra opportuno proporre almeno un primo elenco, corredato dalle note che si possono desumere dai conti esaminati.
Aghoglie e ponteSono entrambe punte, forse le punte sono più gros-
se delle agoglie, ma più probabilmente i termini sono sinonimi; troviamo infatti le agoglie da scoglio per i muratori, quelle con cui rompere la roccia così come con le ponte da pietra, entrambe vengono azzalite o appuntate nella punta e gli viene bolito la testa, si usa
una agoglia di azzale per fare le incave li muratorij per la stanghetta della chiave
e una punta pesa circa kg 2,860 e oltre:1 ponta da pietre nova assalita in peso libbre 9
2 ponte novae assalite in peso libbre 19 1/2
mentre esistono anche agiogie minute
Oltre ai muratori anche gli scalpellini usano le ago-glie e le punte:
fato un agoglia e uno scopeletto per Serisola
apontature di agoglie e scopelli de marmarari
pontato n° 3 ponte da scopelino
Esistono anche ponte per stucchi o per i cornicioni, da intendersi come grossi chiodi che costituiscono un’armatura per elementi aggettanti piuttosto che attrezzi per scolpire
ponte da piantare per il cornicione in sala a piano del portico.
BadiliI badili si usano per la calce, e posseggono una doglia,
che si consuma, probabilmente con questo termine si identifica la parte di ferro.
acomodato n° 8 badili per la calcina mesoli le doglie de altri suoi vechi rotti
fatto la doglia nuova a un badile da calcina.
CuneiAbbiamo visto i cunei come manufatti da mettere in
opera per mettere in tiro le chiavi, ma possono anche essere usati per schiappare il legname, segnaliamo qui 2 cunii novi in peso libbre 6, circa kg 1,8.
Frapine e frappi Sono due strumenti simili, evidentemente l’una più
piccola dell’altro, nell’ottocento vengono descritti così: frappo: “uno studioso ottocentesco lo ha definito martel-lo a due tagli, in quanto è provvisto di due lame simili a quelle da pialla, contrapposte, in posizione perpendicolare rispetto all’asse del manico. Lungo almeno 1 palmo (circa 25 centimetri), pesante 10 libbre (quasi 3,2 chilogrammi), è provvisto di manico sfilabile che può essere fissato in due maniere differenti” come un picco, usato per rifilare i bordi, o come una pialla, per lisciare la superficie33.
33 SAVIOLI, Tecniche di produzione e lavorazione, in T. MANNONI (a cura di), Ardesia, materia, cultura, futuro, Genova 1995, p. 63.
20
34 PAGANINI, Vocabolario, cit.
anche una frappa reghasasti e che si possono usare3 frapine fatte grosse per scalcinare li mattoni.
MarapicheManutenzione caratteristica della marapica è la
ricalzatura:1 marapicha mezza ricalsata
1 marapicha ricalsata
1 marapicha agionta nella testa assalita la ponta
MartelliI martelli citati dai conti sono del tipo a scure, ven-
gono infatti aggiustati nel taglio della penna.acomodato n° 81 martelli dal taglio
azalito in più volte n° 17 martelli dal taglio
azzalito un martello dalla penna e agiontato ferro dall’altra (parte)
MazzoliI mazzuoli devono essere più frequenti di quanto
non appaia nei documenti, perché quelli di solo legno non venendo aggiustati dal fabbro non risultano dai conti, mentre compaiono i mazzuoli “ripieni”, quelli in cui viene rinforzato con ferro il punto di contatto con la testa dello strumento che si usa insieme, un peso possibile è di circa kg 2.2:
comodato il mazzolo per il scopelino inpito da tutte e due le parte e boglito e alarghato nel ochio pesa libbre 7
PichetteProbabilemnte si tratta di piccoli picconi (con il a
mnico corto?) ai quali viene sovente rifatta la punta e acciaiata:
azalito n° 16 pichette
pontato n° 4 pichette in più volt.e
PiconiNe esistono alcune varietà, picconi grossi forniti in-
sieme alle agoglie da scoglio, picconi da piano che sono assaliti nella testa, oppure uno viene agionto appontato, in generale le punte vengono assalite e appontate, come al solito, ed inoltre:
1 piccone da ponta e taglio accomodato
1 piccone da piano bolito la testa assalito la ponta
2 picconi da piano ricalsati.
PicozziCome suggerisce il Paganini (cfr figura 9), si tratta
di una scure:comodato un picozzo boglito nel taglio e di nuovo temperato
ScopelliDi scalpelli si trovano quelli per li astreghi , quelli da
scopelino, uno scopeletto per Serisola e varieapontature di agoglie e scopelli de marmarariVengono anche usati per lavori particolari:fattura di tagliare un pane di piombo con scopelli
tre ferri a modo di scopello inazzaliti per dare leva alli scalini della nova scala
per aver pontato in più volte n° 8 ponte a un scopello per lavori de campanini.
Fig. 8 – Martelli: 66. martello; 67. bocca; 68. penna; 71. martello a punta; 72. piccone (CERRUTI, RESTAGNO 1939).
Fig. 7 – Martellina (CERRUTI, RESTAGNO 1939).
Martelinha o frapinha martellina, è senza bocca e con due penne taglienti34.
Dai documenti di cantiere apprendiamo che le frapi-ne invece hanno i denti da entrambe le parti , e che esiste
21
TenaglieUno paro di tenaglie vengono fornite per rancare li chio-
di dali canteri vechi, oltre a un paio di tenaglie grosse.
TrapaniPer forare una verga di ferro si impiega un trapano:
fato n° 3 buchi con trapano a una rembata di scala per porli li pomi.
Zappe Le più citate sono le zappe da calce,Sappa da cashina, marra è poco dissimile dalla marra or-dinaria, ma ha il collo molto piegato verso il manico: sene serve il calcinaio per istemperare e rimestar la calcina35
una di esse, definita grossa, pesa circa kg 1,9una sappa da calcina grossa in peso libbre 6come per i badili, la parte di ferro viene chiamata
doglia o sgoglia e va spesso rifatta o saldata:fatura di una sgoglia a una sappa da calcina
boglito nel collo una sappa da calcina per essere rotta
fatto la doglia a una sappa da calcina e boglita
Ma troviamo anche:2 sapette per uso del giardino
2 sappe da getto agionte nel ochio.
2.5.1.4 Inferriate, ringhiere e altroNell’ambito delle inferriate e sopratutto delle ringhie-
re il fabbro può esprimersi anche da un punto di vista figurativo, anche se guidato dal progettista, come succede a Cornigliano, dove si sperimenta qualcosa di nuovo.
Tuttavia possiamo notare che già nel cantiere Palla-vicini si realizzano con il ferro due pogioli a arebeschi e balaustri per le mezzarie e un poggiolo con balaustri e tre pomi in peso rubbi 6.10, (circa 50 kg) che sembrano proprio quelli di seguito descritti36:
Un secondo tipo di ringhiera è costituito da una succes-sione di balaustrini a tutto tondo, con profilo simile ai coevi balaustri in marmo bianco, ma in forme molto più affusolate. Nonostante che a prima vista tali balau-strini possano sembrare torniti, tanto grande è la loro precisione e il loro grado di rifinitura, essi erano invece ottenuti per battitura entro appositi stampi.Una forma che appare essere la semplificazione della precedente, e che forse entra in uso un pò più tardi come imitazione di più facile realizzazione (probabilmente nel XVIII secolo), è quella a balaustrini piatti, costituiti da una lamina di ferro, che viene sagomata tramite batti-tura a partire da un semilavorato a forma di verga. In relazione al procedimento di lavorazione tale lamina ha spessore differenziato: più consistente nelle strozzature, più sottile in corrispondenza delle “pance”.
Infine le ringhiere forse più decorative sono quelle costi-tuite da un insieme di elementi in ferro battuto, a sezione in genere quadrangolare, curvati a formare disegni più o meno elaborati, e inquadrati tra le due traverse.
L’aletta descritta nella seguente voce di conto po-trebbe essere quella parte di parapetto che è posta in opera in orizzontale sul bordo superiore della ringhiera stessa e che è formata da ferri piatti a formare disegni, che compare già nel cantiere Pallavicini:
per un poggiolo fatto con arabeschi e sua aletta et uno arembatore di scala attaccato al detto poggiolo et uno rastello per serare con mappe pesa rubbi 17 £ 142.13
Anche nelle inferriate si evidenzia un cambiamento, ne vengono fatte due alla lombarda, che pesano ben kg 754, e sono come quelle in voga per tutto il secolo precedente, e molte a quadretto; ma anche una ferrata di ferro quadro fatta con arebeschi in peso rubbi 6.20; dello stesso genere sono queste piccole inferriate per finestrine ovali o per una mezzaluna:
un ovato fatto ad alboretto per la scala in peso rubbi 6.4 £ 51.6.8
un ovato con arabeschi per la scala in peso rubbi 6.6 £ 52
per un ovato fatto ad arebesco per una finestra nella scala maestra in peso libbre 66 £ 20.18
una mezzaluna fatta ad arebeschi.
Nel finestrino ovale sta molto bene anche una tessi-tura dei ferri ad incrocio in diagonale:
una ferrata ovata fatta ad amandoletta per balcone a piano del portico £ 29
Quelle poste nei sovraporta sono inferriate otte-nute con un procedimento piuttosto complesso, la rifollatura che37
consiste nel riscaldare la barra di ferro nella zona in cui si vuole realizzare il rigonfiamento stesso e nel comprimerla verticalmente, battendola all’estremità con la mazza. Al rigonfiamento viene poi data la forma voluta tramite battitura,
Fig. 9 – 14) picosso, scure; 15) picossìn, accetta, piccola scure da maneggiare con una sola mano (PAGANINI 1857).
37 BOATO, Archeografia del costruito, tecniche e materiali della Genova pre-industriale (secoli XI-XIX), Genova.
35 PAGANINI, Vocabolario, cit.36 BOATO, DECRI, Il ferro nell’architettura storica genovese, cit.
22
nel caso dei balaustrini il procedimento viene aiutato da appositi stampi.
n° 7 balaustri per sopraporte con pomo nel mezzo in peso libbre 25 £ 5.16.8
n° 18 balaustri per sopraporte nel caroggio con pomo in peso rubbi 5.4 £ 27.19Dello stesso genere possono essere i montanti di rin-
ghiere di scale o poggioli, per i quali si nota una differenza tra i due cantieri , sembra infatti tra il primo e il secondo si passi dal balaustrino a tutto tondo a quello sottile, ricavato da un ferro piatto, come nelle alette sudescritte.
per uno arembatore di scala con balaustri a colonetta
in peso libbre 88 a soldi 8 la libbra £ 35.4
per un pomo d’ottone per detto £ 1.10
un arembatore di scala di balaustri a colonnetta in peso libbre 66 £ 33
per contati spesi in un pomo d’ottone per detto £1.16
In generale il corrimano della ringhiera viene sor-retto da chiavette impiombate o da:
una colonna et un dado che serve per attaccare li rembatori di scala in peso libbre 41 a soli 8.6 circa £ 7.4-
Nel cantiere Durazzo tutti questi elementi subiscono ancora un rinnovamento, vi si introduce una tecnica di lavorazione esplicitamente alla francesa:
1755 a’ 24 novembre Conto di 8 balconi di ferro
Lavori fatti da maestro Giovà Battista Balatti
Per n° 8 poggiolli cioè 20 longhi palmi 7, alti palmi 3 con giro e ghaibo con staza e cornice fatti di fero quadro tirato sotille fatti alla francessa con diversi inchastri e ben tiratti con lima in tutto pessano rubbi 15:16
20 altri 4 longhi palmi 6 alti palmi 4 fatti con telari quadro e con staza tiratta a cornice fatti di ferro qua-dro sotille tirato a patta e fatti con diversi rebeschi e siggi e con diversi inchastri fatti alla francessa e ben tirati con lima in peso rubbi 22.20 che in tuto pesano rubbi 40:8 a soldi 22 la lira con fero e fatura e spesa e ogni cosa £ 1105:10
spessa di porto de fachini £ -:18 £ 1106:8
(ma poi si accontenta di £ 900)
Nelle ringhiere di scale minori si usa la stazza38:una delle due sbarre parallele che formano una ringhiera insieme a bacchette di ferro verticali,
che è un termine non ancora riscontrato nei documenti dei secoli precedenti, anche se probabilmente il manu-fatto aveva già fatto la sua comparsa,
per n° 2 arembatori di scala di palmi 16 circa con li suoi caragoli e sua stazza sotto e d’alto con sue vide nel suo ferro et al primo caragolo messovi la stazza cornigiata di sopra in peso rubbi 17:13 a soldi 3/4 la lira di fattura £ 87:12:=
per n° 5 pezzi di arembature di scala con sua stazza limata e sua cartella in peso rubbi 7:10 a soldi 5/6 la lira ferro e fatura £ 55:10:=
sulle ringhiere vengono effettuati anche adattamenti per modifiche avvenute nella fabbrica, anche pochi anni dopo :
per avere acomodato uno delli suoi pugioli vechij della scala e trapanato a lavoro e atacato con la detta scala e messoli giornate n° 3 a soldi 40 il giorno £ 6:=:=
Come già anticipato, a Cornigliano viene realizzata, ad alto costo, una ringhiera per la scala maestra, di gusto squisitamente francese che sembra uscire dalle pagine dell’Ènciclopedie39 uno dei primi tentativi a Genova, se non il primo:
1757 à 16 maggio Conto della rampa della scala grande
per avere fatto la rampa della scala di marmaro cioè n° 6 pezzi con suoi recanti tutto a rebeschi con molta fatica più de altre £ 1270.7
deduzione £ 188.4
pagate a Bartolomeo Bruno £ 1082.3
Le altre ringhiere sono più semplici ma comunque elaborate:
1756 à 4 settembre Conto di 3 pezzi di rampe
per aver fatto n° 3 pezzi di rembate di scala per la scala verso Sestri per andare nelle mezzarie di cima fati con driti di ferro con pedino da tutte e due le parti e con la cadenza ribatuti sotto con stazza e sopra ferro quadro ritondato dauna parte in peso cantara 529 a £ 22.10 il c. £ 118.10
fatto una cantonata a rebescho simile de altra £ 22
detta rampa per essere con troppo ferrose le paga in ragione di £ 13 circa il cantaro £ 70
Bartolomeo Bruno riceve £ 92
1756 à 10 luglio Conto della rampe della scaletta a ponente (realizzate a arebeschi da B. Bruno)
Tutte le ringhiere sono finite dal pittore Lupi con due mani di olio.
Anche il cancello principale della villa viene realiz-zato con decori arabescati:
1756 à 20 agosto Conto di fattura del rastello del cortile grande
fatto con arebeschi alla cima da B. Bruno per £ 311.12
Manufatti particolari come i lumi e gli anelli per appenderli sono curati con aggiunta di elementi de-corativi:
due lumi di Pistoia doppi recamati per la fabbrica £ 2
un anello da volta con sua rosetta e fiorami £ 5
4 anelli da volta con sue rosette e fiorami con gamba di p 2 £ 20
per due annelli da volta per li salotti con sue rosette fiorami e gambe di palmi 2 £ 12.10
Restano da segnalare alcuni altri manufatti del fabbro Bruno, diversi telai di ferro tessuti per le uccelliere, le cantine, la cucina, 6 telaretti di legno per l’uccelliera, fissati mediante stachette, ed inoltre 8 occhi quadri fatti a T con occhio per mettere una chiavetta per il
38 PAGANINI, Vocabolario, cit.
39 Cfr. F. BONORA, Il palazzo Durazzo Bombrini in Cornigliano, un’architettura francese a Genova, Genova 1991.
23
palco in sala, occhietti, occhi per le cortine di sala fatti a balaustro, ferri per il lampione e tutto il necessario per i campanelli:
per n° 6 grilette da campanino a soldi 1£ l’uno £ 5:8:=
per n° 19 ochij da piantare per detti campanini
in peso lire due e onze 4 a soldi 30 la lira £ 3:10:=
per havere acomodato sei delli suoi griletti usati e messo li perni nuovi
e a qualcuno datoli giunta £ 0:16:=
n° 2 molle di azzale con ochio e da levare e metere per campanini.
2.5.2 Altri metalli e legheIl piombo è presente in alcune condutture, canali,
usati per la peschiera e per una tromba (pompa). L’altro ruolo importante di questo metallo è quello visto nei serramenti, per i quali viene detto piombo da vetro; per lavorarlo può essere necessario tagliare un pane di piombo con scopelli, lavoro svolto dal fabbro.
Lastre di rame compaiono in entrambi i cantieri, dove sono impiegate per un balcone, per una canaletta, e si usano 100 stopparoli servono per inchiodare una lastra di ramo.
In particolare: 1754 @ 31 dicembre (5 settembre) Conto di lastre di rame e stagno
per lastra d’Allemagna posta sopra il tetto del pa-lazzo in Cornigliano libbre 84 senza ferro e stagno £ 113.8.-
e per stagno per detta libbre 31.3 £ 19.1.-
per altro stagno per la fabbrica libbre 17.6 a soldi 12 10.10.-
per fattura di collocare detta lastra con altre e tirarle compresevi giornate 3 di due uomini £ 20.-.-
si deducono avanzi e ritagli.Vi sono inoltre alcuni particolari pezzi di impianti,
come un canone nuovo di rame con due gomiti di p 8 portione saldato in peso netto l 40, oppure una caldara grande nuova da far scaldare l’acqua per il bagno di rame senza ferro p libbre 46.
Di ottone troviamo benn° 270 otto pomi nuovi e nettatura di altri 10 vecchi di casa per le ferrate.
Lavorano il rame e l’ottone i calderari Antonio Per-pinto e Antonio Maria Zermucca.
Nel cantiere di Cornigliano arrivano anche alcuni manufatti di ottone, forniti sia dal fabbro Bruno sia da un tal Brignone
2 anelli con sue rosette due mappe e un anello con bottone per il luogo all’inglese £ 4
filo d’ottone per li giochi da campanini mandato da Genova
13 grilletti simili de altri per detti giochi
per mettere in detto (palazzo) 5 giochi di canpanili n° 4 canpanili novi £ 8
in detto 5 mole di acale con sua ganba £ 17.10
in detto 25 grileti per detti giochi a soldi 22 l’uno £ 17.10
ocheti et ponte per negare il filo di lotone £ 3.16
filo di lotone ricoto £ 5.10
maestro Antonio Suanasino fatura di deto lavoro £ 16
filo di ottone in tutto libbre 50 di filo mezzano
pomi grossi 164, mezani 16 e picoli 12
rozete 106
bochete 96 (ad esempio per i secretaire)
stachete dongene 72.
È tessendo il filo di ottone che si realizzano i telai di ramina, grandi, ad esempio, sei palmi in quadro.
Infine troviamo documentato anche il bronzo in alcune forme particolari:
Conto di due anitre di bronzo dorato per il bagno
Conto del costo di un pomo di bronzo dorato per la rampa della scala grande pagato in £ 36
per un pomo di bronzo dorato a vernice per la rampa della scala grande fatto da Brignone.
2.6 PIETRA DI LAVAGNA
Non si può trascurare quanto viene indicato dai conti consultati riguardo all’ardesia, poiché, oltre a giocare una parte importante nelle finiture, lo fa con una straordinaria varietà di elementi diversi.
Non è sempre evidente, però, l’impiego di tali ele-menti, anche perché alcuni possono giocare più ruoli, per cui occorre analizzarli uno per uno e tentare di individuarne i principali utilizzi.
Ci vengono in aiuto documenti della metà del sei-cento40, il primo redatto in seguito ad una lunga ver-tenza tra i cavatori e produttori di pietra di Lavagna e i maestri muratori per ottenere una standardizzazione degli elementi che cautelasse questi ultimi da imprevisti negli acquisti e che garantisse una ottimale qualità delle forniture: alla fine viene redatta una “Dichiarazione delle robbe che si devono fabbricare in ogni bontà e perfettione nelle rocche di Lavagna e condursi alla città”41, da cui, schematizzando, rileviamo:
– abbaini palmi 2 e once 2 fino a 4
– chiappe da gronda palmi 3 per 2 (spessore propor-zionale)
– scalini lunghi palmi 3.4.5.6 larghi p 1 1/4 spessi (grossi) once 1 e 1/2 (ql larghi un solo palmo vanno pagati mezzo)
– scalini lunghi palmi 7.8.9.10.11.12 devono essere larghi p 1 1/2 spessi once 2 (anche qui quelli più sottili o meno larghi vanno pagati meno)
– scalini bastardi lunghi palmi 7.8.9.10.11.12 devono essere larghi p 1 3/4 spessi once 1/2
– scalini grossi (nel senso di spessi) p 1/4 lunghi palmi da 3 a 12 devono essere palmi 1 1/2, (valgono due scalini ordinari)
– chiappe da lavello lunghe palmi 3 larghe palmi 2 grosse un’onza in circa
– lavelli ordinari incavati lunghi palmi 3 larghi palmi 2 (brutto e netti senza diffetti, ne schiapati) grossi onze 5
40 Trascritto in S. SCHIAFFINO, Regestazione e valorizzazione delle filze dei Padri del Comune relative alle arti, degli anni 1641-50, rel. A. Roccatagliata, Tesi di laurea, a.a. 1994/95.
41 Esiste un’altra dichiarazione del 1603, che sarebbe utile raf-frontare.
24
– tetti ordinari lunghi palmi 3 larghi palmi 2 massicci grossi palmi 1/3
– chiappami da palmi 2 pagati come uno scalino e mezzo
– chiappami da palmi 2 1/2 fino a 3 pagati come due scalini
– chiappassoli squadrati di misura giusta di palmi 1 e once 10 in quadro
– quadretti giusti di palmi 1 e 1/4 quelli di un palmo dritti e grossi e 3/4 di oncia42
– pilastrate grosse p 1/3 larghe di netto un palmo
– queironi grossi 1/4 di palmo e larghi 3/4 di palmo
in quanto alla qualità li abbaini siano fatti nella più perfetta pietra e siano nè troppo grossi
li chiappami tutti si faccino senza bianche, nè file per traverso, senza diffetti e grosse per tutto uguali e dritte
le pilastrate siano di grossezza giusta tutte senza bianche nè file per il mezzo nè schiappate
il secondo documento, poco più tardo, fa parte del gruppo delle normative che la Magistratura dei Cen-sori erogava regolarmente al fine di regolamentare le produzionie i commerci della Repubblica43:
abbaini palmi due e onze due in quadro et altri chiamati gronde che siano longhi palmi due e onze sette e larghi palmi uno e onze nove a quali abbaini detti gronde della suddetta misura è statuita la meta a lire dieci il cento condotti in città e si vendano separatamente et agl’altri di giusta misura lire otto il cento pure condotti in città sotto pena…
Una norma simile, ma della metà del Settecento, stabilisce anche una misura di spessore di circa sei mil-limetri, corrispondente a molti casi reali44:
abbaini palmi due e onze due in quadro, abbaini doppi di p 2 e mezzo in quadro della dovuta bontà e grossessa cioè trentasei per ogni palmo si dell’una che dell’altra qualità
Portando le misure in centimetri è possibile con-frontarle con quanto emerge, nell’Ottocento, da un Capitolato speciale per l’appalto della manutenzione ordinaria quinquennale degli stabili di proprietà o di uso del Municipio di Genova o per cui incombe al Municipio di Genova di sopportare o di anticipare in tutto od in parte la spesa45, che, per quanto riguarda l’ardesia prevede:
– intelaiature per porta composte di stipiti, archi-trave e soglia dette alla cappuccina di spessore mm 25÷34×larghezza 10÷15
– intelaiature per porta composte di stipiti, architrave e soglia dette quairone di spessore mm 35÷44×lar-ghezza 13÷15
– intelaiature per porta composte di stipiti, architrave e soglia dette a pilastrate di spessore mm 60÷70×lar-ghezza 18÷22
– scaglioni per gronde spessi cm 3÷4×larghezza 10÷12
– gradini detti schiavoni cm 2,5÷3,5×28 ÷ 30
– gradini detti da quarto vuoto m 005 ÷ 07 larghi m 030÷035Nella Tabella 1 sono messe a confronto le fonti, in
nero quella più antica, in grassetto quella seicentesca dei Censori, in corsivo quella settecentesca dei Censori in sottolineato quella ottocentesca.
Risulta quindi una sensibile variazione nelle dimen-sioni degli elementi, perlatro già nota nel caso degli abbadini46 che suggerisce come, nel caso in cui fosse possibile riconoscere e misurare gli elementi in opera, potrebbe essere pensabile una mensiocronologia della pietra di Lavagna? Proviamo intanto a verificare l’ipo-tesi con le misure settecentesche, come risultano dai conti di fabbrica esaminati.
2.6.1 AbbainiCosì si chiamano, almeno tra cinque e seicento47 gli
elementi da copertura quadrati, sottili, messi in opera per terzo; il termine oggi usato per indicarli è abbadini e questo cambiamento si può osservare proprio tra il primo e il secondo dei cantieri studiati.
Nel caso più antico troviamo una precisazione di-mensionale: il lato della lastra dev’essere di palmi 2 1/2 (circa 62 centimetri), ovvero più grande dell’intervallo previsto dalla Dichiarazione seicentesca ma perfetta-mente corrispondente alla norma di metà settecento proprio per gli abbadini doppi, come infatti sono sem-pre indicati in tutte le citazioni:
Nel secondo caso, invece, si pagano sempre abba-dini detti grandi, probabilmente non varia la misura ma solo il modo di chiamarli, se ne possono contare 10600 e oltre, di cui un migliaio sono doppi (sinonimo o variazione di spessore?), che costano lo stesso prezzo degli altri.
2.6.2 BattiportaQuesto termine compare solo nel cantiere Pallavici-
ni, in poche citazioni, mentre nei secoli precedenti era molto usato ad indicare un elemento lavorato di pietra di Lavagna, usato in orizzontale, messo in opera sotto e sopra ai balconi dalla parte di fuori48.
Può essere rifinito a bastone oppure semplicemente refilato49, misura circa 16 cm di larghezza, ovvero è più piccolo di un querone (cfr.).
2.6.3 ChiappeVoce con cui si designa l’elemento generico di pietra
di Lavagna, la lastra, o, ancor più in generale tutti gli elementi di tale materia50; ma ha un uso specifico per
42 L’aggettivo “giusti” viene chiarito con il documento di cui alla nota seguente, in cui si dice: e se si trovassero francischiati con li ab-baini giusti i suddetti chiamati grondette e fossero venduti inssieme…, va quindi inteso “di misura corretta”.
43 Archivio Storico del Comune di Genova, Censori, 428, 18 maggio 1668.
44 Archivio Storico del Comune di Genova, Censori, 428, 12 febbraio 1751.
45 Città di Genova, Ufficio dei lavori pubblici, Capitolato spe-ciale… cit.
46 A. BOATO, Costruire a Genova tra medioevo ed età moderna, tesi di dottorato in Conservazione dei beni architettonici, VI ciclo, Politecnico di Milano, p. 64.
47 Cfr. A. DECRI, Per un glossario sull’uso della pietra per le finiture nell’edilizia genovese dei secoli XVI–XVII, in Atti del VII convegno di Studi “Scienza e beni culturali – Le pietre nell’archi-tettura: struttura e superfici”, Libreria Progetto, Padova 1991, pp. 57-66, voce “abaini”.
48 DECRI, Per un glossario, cit. voce “battiporta”.49 La figura riguarda l’ipotesi sulla forma di tali profili avanzata
da BOATO, Costruire a Genova, cit., p. 115.50 In un documento che riassume gli “avanzi”, vengono detti
chiappe anche gli scalini, i queloni, le pilastrate.
25
indicare gli elementi di forma bidimensionale come le lastre (rispetto a quelli in cui prevale nettamente la lunghezza); un caso particolare è dato dal chiappasolo, elemento attestato nel Seicento per i pavimenti e pre-sente nel cantiere Durazzo: n° 130 chiappasoli di p 2 in quadro lavorati £ 32.10, misurano circa mezzo metro di lato, quindi di tratta di manufatti più piccoli della normale chiappa, ma leggermente più grandi di quelli del secolo precedente.
Dal punto di vista dimensionale, comunque, esiste una varietà notevole: si va dalla chiappa quadrata di un metro di lato o a quella rettangolare di due per mezzo metro, fino alle più grandi, di 175 cm per un metro, neanche previste dalla Dichiarazione seicentesca.
Esistono lastre specializzate come quelle da lavello (cfr lavello), quelle da gronda e quelle bastarde usate per la gronda; nell’Ottocento sono chiamate scaglioni per gronde e misurano mm 30÷40×100÷12051, ma sono note già nei secoli precedenti, la loro dimensione maggiore rispetto alle altre lastre da copertura e la loro forma rettangolare serve per mettere in opera il corso (chiappata o gronda) in modo da coprire il termine della muratura con un’unica lastra, per meglio proteggerla dall’acqua piovana52.
I conti settecenteschi del cantiere genovese aggiungo-no dei dati sulle dimensioni: una cinquantina di chiappe da gronda misurano palmi 5×2 (circa 125×50 cm) ben più grandi di quelle indicate nei documenti ufficiali; sempre larghe cinque palmi sono fornite anche 124 chiappe bastarde per gronda, forse più corte delle altre. Come finitura si impiegano due quatteroni d’oglio per la chiapata del tetto, forse steso con pietra pomice.
Ancor più specializzate sono due chiappe di p 5 in quadro squadrate atorno e tagliate da canto a filo de canti del tetto, nel palazzo Pallavicini, mentre in quel-lo Durazzo, ancora negli angoli, troviamo chiappe da gronda a civetta tagliate a cartabuone per canti di p 8 e p 3 n° 4 e simile di p 7 e 3 n° 4, da cui si evince che il taglio a cartabono è il taglio a 45° in pianta.
Sempre come finiture della copertura troviamo, a Cornigliano, dei coppi di querione di p 4 e 8 coppi di palmi 5 di pilastrata doppia incavati: si tratta di quegli elementi che sono posti sopra il giunto delle due falde nella parte terminale del tetto. (cfr. quaroni e pilastrate).
Come lavorazione del bordo, spesso applicata a lastre tra le più grandi (palmi 8 1/4×3 o 7×3) e usata special-mente per l’impiego in coperture particolari, come il tetto del miradore, il lucernaio, il cornicione oppure un trogolo, è il becco di civetta, il cui profilo corrisponde bene a quello ottenuto con lo smusso di un solo spigolo di una lastra. A Cornigliano viene fornita una chiappa così rifinita come copertura di un trogolo:
51 Città di Genova, Ufficio dei lavori pubblici, Capitolato spe-ciale, cit.
52 DECRI, Per un glossario, cit. voce “chiappata o gronda”.
palmo onciacm 24.8 2.067
abbaini palmi 2 e onze 2 fino a 4 (once?) da 53.7 a 57.8 latoabbaini palmi 2 e onze 2 53.7 latoabbaini doppi palmi 2 e mezzo 62 latochiappe da gronda palmi 3 per 2 74.4 lato 49.6 lato(spessore proporzionale)gronde longhe palmi 2 e onze 7, lar. palmi 1 onze 9 64,1 lato 43,4 latoscaglioni per gronde 100÷120 lato 3÷4 spessorescalini lunghi palmi 3.4.5.6 da 74.4 a 148.8 lunghezzalarghi p 1 1/4 spessi (grossi) once 1 e 1/2 31 larghezza 3.1 spessorescalini lunghi palmi 7.8.9.10.11.12 da 173.6 a 297.6 lunghezzalarghi p 1 1/2 spessi once 2 37.2 larghezza 4.1 spessorescalini bastardi lunghi palmi 7.8.9.10.11.12 da 173.6 a 297.6 lunghezzalarghi p 1 3/4 spessi once 1/2 43.4 larghezza 1.0 spessorescalini “grossi” lunghi palmi da 3 a 12 da 74.4 a 297.6 lunghezzapalmi 1 1/2 grossi p 1/4 37.2 larghezza 6.2 spessorechiappe da lavello lunghe palmi 3 74.4 latolarghe palmi 2 grosse un’onza in circa 49.6 lato 2.1 spessorelavelli ordinari incavati lunghi palmi 3 74.4 lunghezzalarghi palmi 2 grossi onze 5 49.6 larghezza 10.3 spessoretetti ordinari lunghi palmi 3 74.4 lunghezzalarghi palmi 2 massicci grossi palmi 1/3 49.6 larghezza 8.3 spessorechiappami (nel senso di chiappe) da palmi 2 49.6 latochiappami da palmi 2 1/2 fino a 3 da 62 a 74.4 latochiappassoli squadrati di palmi 1 e once 10 in q. 45.47 latoquadretti di palmi 1 e 1/4 quelli di un palmo e 31 poi 24.8 latogrossi 3/4 di oncia 1.6 spessorepilastrate grosse p 1/3 larghe di netto un palmo 24.8 larghezza 8.3 spessorepilastrate di spessore mm 60÷70×larghezza 18÷22 18÷22 6÷7 queironi grossi 1/4 di palmo e larghi 3/4 di palmo 18.6 larghezza 6.2 spessorequairone di spessore mm 35÷44×larghezza 13÷15 13÷15 larghezza 3.5÷4.4 spessore
Tabella 1.
26
chiappa 6×5 e una di p 3 lavorata a bastone e lavorata a becco di civetta tagliata a carta bone sopra il troglio.e troviamo anche la finitura a civetona, applicata a
tre lati di tre chiappe di palmi 4 e palmi 2, forse usate come mensole?
Nello stesso modo vengono trattate le chiappe per il dado, che è la fascia marcapiano che interrompe il corso dell’acqua piovana e che, per questo, gioca un ruolo molto importante nella prevenzione del degrado da dilavamento53, sembra utile rilevare, perciò, che il bordo di tale fascia, protetto dalla lavagna, è anche ac-curatamente sistemato per un corretto gocciolamento: chiappe per il dado lavorate a becco di civetta et attestate con sue gocciole larghe o 10, col che probabilmente si intende il piccolo scavo nella parte inferiore della lastra, qui utile perché messa in opera molto meno inclinata di quelle del tetto.
Il termine attestate potrebbe indicare la sistemazione precisa delle lastre l’una nei confronti dell’altra per ridurre il giunto.
chiappe di p 7 e p 3 lavorate a becco di civetta et atte-state per tetto miradore
chiappe per gronda lavorate a becco di civetta et atte-state p 8 e p 2 1/2 due chiappe per pilastri di p.mi 4 in quadro a civeta a torno taliato li canti per desene £ 4.8
Come finiture troviamo ancora la squadratura, realizzata su chiappe per balconi (si tratta di lastre di circa 174×16,5 probabilmente usate per l’imbotte), per un bordo da incastrare oppure per il pavimento di un ballatoio: si differenzia dal bastone che é un bordo tondeggiante54, per cui la squadratura sembra la finitura a 90°.
E allora le chiappe a bastone squadrate oppure quelle a bastone e refillate si possono interpretare come lastre con finiture diverse sui diversi bordi.
Perché la superficie di alcuni elementi sia veramente liscia e piana occorre che sia aspianata in straguardo.
Tra gli usi è da segnalare il vasto impiego negli impianti, come nei gaggioli (condotti verticali), nei trogoli, nelle bocche di pozzo, e così via, per cui pos-sono servire chiappe con fossetta, chiappe con bucci per acqua.
Nelle pavimentazioni la lavagna ha un ruolo im-portante nei vani delle finestre, dove realizza una finitura impermeabile all’acqua piovana non trattenuta dal serramento e poi convogliata fuori da apposito pertugio:
(…) due chiappe di p 6 large 0/14 rifilate da squarcio £ 1.12
Per riassumere, infine, la straordinaria varietà e quantità di chiappe usate in cantiere, per i più diversi impieghi, si è compilata la Tabella 2 contenente esempi di quantità e misure e della loro relazione con i prezzi unitari, qualora presenti o ricavabili.
Resta da segnalare come coesistano, seppur rari, i termini lastra e piana:
piane alla romana e lisciate di p 6 larghe oncie 10
lastre servite di Francesco Rondanina per lastricare li fondi del palazzo.
2.6.4 CoperteSi tratta di un elemento posto a copertura dei vani di
porte e finestre, oggi detto imbotte; può essere realizza-to con uno o più quaroni ed avere una sezione scavata per permettere l’incastro dei telai fissi oppure la battuta di quelli mobili. La finitura alla romana e l’aggettivo finte risultano per ora poco spiegabili.
una coperta con l’incastro, di p 3 per porta di com-modità
una coperta di quaroni con faccia liscia con due incastri da vetro e arva
una coperta alla romana
n° 6 coperte di palmi 4 doppie finte £ 6.12.-
2.6.5 Lavelli
Citato come pezzo solo nel primo cantiere (in cui peraltro compare anche la chiappa da lavello, un paio sono messe come piede di stallo di colonna), è inte-ressante notare che non vengono usati per costruire lavelli, appunto, bensì sono messi in opera sopra o sotto le colonne e sotto i bordonari, cioè le travi maestre, a fungere da appoggio piano, nonché come zoccoli (lavelli pieni per fare soccari).
Nel secondo cantiere invece vengono fornite le chiappe da lavello, presumibilmente lo stesso pezzo, in totale sono 2760, numero che sembra confermare l’uso come piano di appoggio.
Possiamo quindi descriverle come lastre di parti-colare spessore, mentre l’aggettivo pieno potrebbe riferirsi al fatto che non è stato praticato lo scavo per contenere l’acqua.
Dalle misure della Dichiarazione seicentesca si rileva che lavelli e chiappe da lavello hanno identiche lunghez-za e larghezza (75×50 cm circa) ma i primi sono spessi ben 10 cm mentre le seconde solo 2. Inoltre i lavelli ordinari sono definiti incavati, proprio il contrario di quelli pieni qui visti.
2.6.6 MezzaniniTrentacinque mezzanini, alcuni lunghi cinque palmi
(circa 125 cm) lavorati alla Romana oppure solo refilati, altri lunghi circa un metro e larghi circa 16 cm, sono forniti per Cornigliano; il termine già nei secoli prece-denti si usa per indicare l’alzata dello scalino quando è fatta di lavagna55.
2.6.7 OttangoliManufatti da pavimentazione, così quelli usati a
Cornigliano:n° 3 ottangoli doppij di palmi 2 1/2 in quadro squadrati e lisciati per la terrazza £ 4.10
n° 183 ottangoli di palmi 2 1/2 doppij aspianati e lustrati £ 137.5.-
(…) otangoli di polteli dopi di p.mi 2 1/2squadrati e lisati forniti n° 4 £ 6
53 Poiché interrompe il corso della lama d’acqua sulla facciata ed i suoi effetti.
54 Cfr. alla voce battiporta. 55 DECRI, Per un glossario, cit. voce “mezzanini”.
27
2.6.8 PilastrateLa pilastrata è l’elemento verticale della cornice di
una porta o di una finestra, quando questa è realizzata con pietra, mentre la parola stipite, praticamente un sinonimo56, potrebbe indicarne la larghezza;
n° 26 scalini di palmi 5 grossi 1/4 larghi onze 6 di stipito addietro a soldi 34 £ 44.4.-
Spesso con un unico pezzo si copre il muro dov’è la bucatura e si decora la superficie della parete ad esso perpendicolare, a volte infatti questo lato della pilastrata è modanato, anche da entrambi i lati stretti, quando sono a vista;
porte di pilastrata doppie corniciate da due parti p 9 e p 4.4;a volte la battuta viene scavata nell’elemento:
un quadro di pilastrata con l’incastro da vedro di p 3 1/2 in quadro di luce;
Le finiture possibili: alla fratesca, a faccia quadra, corniciata, corrispondono evidentemente ai vari modi di realizzare i profili delle aperture, possono inoltre avere l’incastro per il telaio e il batiporta, la battuta:
pilastrata corniciata con l’incastro di dietro
quattro quadri di pilastrata con faccia liscia con l’inca-stro da vedro di p 5 e p 4 di luce con il batti porta greso oncie 3 e con sue canellette dentro per il miradore;
Possono essere rifinite anche sulle due facce opposte: pilastrate doppie di p 7 n 2 e di p 6 n 2 con faccia quadra da due parte per longhezza sopra un arcola stessa faccia può essere liscia oppure lustra.due coperte di pilastrata con faccia liscia di p 7 e due p 4 simili per fare un quadro;
n° 2 pilastrate di palmi 10 larghe onze 9 lavorate con faccia lustra £ 5.18.-
Quanto alle dimensioni le pilastrate, sempre di lunghezza variabile, risultano nel Seicento larghe 25
chiappequantità lato palmi lato palmi spessore finitura prezzo unitario
12 3 4 soldi 264 4 3 doppie aspianate 7 4 3 grossa onze 2 doppie aspianate 3 4 3 grossa onze 2 aspianate 6 4 3
15 4 4 23 soldi4 4 4 doppie
14 4 4 grossa onze 2 doppie £ 4.1621 4 4 aspianate £ 4.1616 4 4 aspianate in straguardo scielte 30 soldi1 4 4 grossa onze 2 aspianata £ 4
82 5 3 soldi 229 5 3 doppie £ 41 5 3 doppia aspianata £ 46 5 3 aspianata £ 44 5 3 doppie £ 113 5 3 grossa onze 2 aspianata £ 4
29 5 4 circa 1 lira e 1/23 5 4 £ 51 5 4 doppia £ 5
15 5 4 £ 1.69 6 2 1/2 doppie £ 3.4
29 6 38 6 3 grossa onze 2 doppie aspianata £ 4.14
13 6 3 doppie £ 4.1414 6 4 £ 215 7 2 ordinarie6 7 2 1/2 £ 2
12 7 3 doppie aspianata £ 650 7 3 soldi 502 7 3 £ 63 7 3 grossa onze 2 aspianata £ 64 7 4 doppie £ 7.81 8 1 1/2 doppia £ 2.10
34 8 2 grosse onze 2 1/2 doppie £ 825 8 2 ordinarie £ 21 8 2 doppia £ 4
45 8 2 1/2 £ 2.105 8 2 1/2 doppie £ 4.16
128 8 3 £ 311 9 2 1/2 £ 3.43 9 3 £ 83 9 4 £ 7.16
Tabella 2.
56 Pilastrâ stipite e stipito, chiamasi i due membri della porta, che posano in sulla soglia e reggono l’architrave, G. CASACCIA, Vocabolario genovese-italiano, Genova 1851.
28
cm circa e spesse circa 8, nel Settecento i documenti di solito indicano la lunghezza o la luce del vano del-la bucatura, e nell’Ottocento si hanno spessore mm 60÷70×larghezza 18÷22.
Possono ancora essere usate ad esempio per un’imbot-te oppure per il colmo del tetto: due coppi di pilastrata doppia, n° 8 coppi di palmi 5 di pilastrata doppia incavati, nel qual caso si può praticare un solco per rendere il pezzo più stabile sullo spigolo su cui appoggia.
Una certa confusione nasce quando viene usato il termine pilastrata riferito all’elemento costruttivo ma non al pezzo di lavagna:
pilastrate di schiavone con faccia squadra da una parte di palmi 6 large 0/7 N° 8 atestate insieme £ 9:12
una pilastrata di quarone con faccia liscia di p 8 dal fumarolo
n° 2 pilastrate di qualone di palmi 8 lavorate con faccia lustra £ 4.8.-
n° 12 pilastrate di palmi 8 di qualone aspianate a £ 2 £ 24.-.-
Esistono anche pilastrate finte, forse nel senso, già ipotizzato per le coperte, di un uso non strutturale, ma solo di rivestimento:
n° 12 pilastrate doppie di palmi 8 finte £ 26.8.-
n° 7 pilastrate di palmi 8 lavorate finte £ 15.8.-
2.6.9 PortelliIl portello è una lastra da pavimento57, può essere
quadrato e di dimensione maggiore rispetto al chiap-pasolo sopracitato, oppure ottagonale (cfr ottangoli); viene rifinito con molta attenzione: portelli di palmi 3 in quadro doppij aspianati in straguardo, cioè con la superificie resa dritta così regolarmente da reggere alla traguardatura, come visto per le chiappe.
A Cornigliano ne arrivano in tutto 855.
2.6.10 QuaroniIl quarone è simile alla pilastrata ma più piccolo58,
come risulta anche dai documenti ufficiali già citati, in cui si precisa che siano, nel Seicento, grossi 1/4 di pal-mo (circa 8 cm, due centimetri meno delle pilastrate) e larghi 3/4 di palmo (sei centimetri meno delle pilastrate) mentre nell’Ottocento si riducono drasticamente:
intelaiature per porta composte di stipiti, architrave e soglia dette quairone di spessore mm 35÷44×larghezza 13÷15
anch’essi possono essere lavorati a faccia squadra da due parti; ma sono richiesti spesso con faccia liscia (anche quando messi in opera come coperte), nelle porte (in entrambi i cantieri):
n° 6 qualoni lavorati con faccia liscia di palmi 8 con sue coperte di palmi 5 simile £ 17.5.-
con o senza predisposizioni per il serramento:n° 1 porta di palmi 8 larga palmi 5 di qualone lavorata in faccia lustra senza battente £ 5.15.-
n° 1 porta di palmi 8 larga palmi 5 di qualone senza battente £ 5.15.-
una porta di quarone corniciata di p 9 e p 4 e o 3 di luce con l’incastro di dietro astretta ad oncie 6
o nelle finestre, con l’apposito incastro per il telaio:un quadro di quarone con faccia liscia e con l’incastro da vetro di p 2 e p 1/2 di luce e uno simile di p 3 o 1
oppure ancora soltanto resi piani, anche se più spessi:n° 6 qualoni di palmi 7 doppij aspianati £ 10.10.-
n° 3 qualoni di palmi 8 doppij aspianati a £ 2 £ 6.-.-
n° 7 detti di palmi 7 simili £ 12.5.-Quanto agli impieghi, oltre a quelli già visti per le
pilastrate, escluso però quello di coppo, è interessante ritrovarli come riscontri del paletto capochiave a fini-tura della superficie muraria:
quaroni di p 4 n 4 con suo incavo per le stanghettealtri sono usati, nel cantiere del primo Settecento
per il cornicione, si tratta di molti quaroni doppi di p 4 n 60 di p 3 n 56 e di p 5 n 2; li troviamo ancora a fungere da cordone per la rampa di accesso:
due pagioli di quarone lavorati di palmi 2 £ 1:
oppure preparati per qualche uso non ancora chiaro:uno quarone doppio di palmi 4 fatto la fossa a squadra £ 1:
due quaroni di palmi 2 fatto la fossa a squadro e uno scalino incrastato nelli detti quaroni.
2.6.11 ScaliniNell’ottocento vien detto59:Scalìn o scaìn o schën, scalino, (…) scaglione è scalino di pietra o di marmo più grosso degli ordinarij; gradino è voce nobilitata dall’uso, che lasciando scalino per una scala qualunque ella sia, riserba gradino per le scale più nobili.
A questa funzione corrisponde l’elemento di Lava-gna: per esso, nei documenti, spesso è indicato lo spes-sore, 6 cm in entrambi i cantieri, ovvero paragonabile a quelli indicati “grossi” nella Dichiarazione seicentesca, e la larghezza varia tra il metro e venticinque e il metro e settancinque circa.
2.6.12 SchiavoniGli schiavoni compaiono soltanto nel cantiere Du-
razzo, a quanto risulta ad oggi si tratta si un termine mai usato prima, sono da porre in relazione agli scalini:
scallini sciavoni di palmi 7 attestati insieme, uno da 5 con la canale in mezzo,
di cui sembra costituiscano una versione più spessa e un po’ più costosa, forse si tratta del nuovo nome dei seicenteschi scalini grossi, dei quali però si scostano in parte le larghezze (che rileviamo da 32, 34, 36 cm):
– scalini lunghi palmi 3.4.5.6 larghi p 1 1/4 spessi (grossi) once 1 e 1/2 (ql larghi un solo palmo vanno pagati mezzo)
57 In un certo senso il significato permane nell’ottocento: Portello, cateratta, botola, (…) buca per lo più quadra fatta nel palco per cui si passa da un piano dicasa all’altro – ribalta, sportello orizzontale che chiude la botola, PAGANINI, Vocabolario, cit.
58 Misure diverse da quelle standard sono sempre possibili e varia il prezzo in conseguenza: n° 2 qualoni di palmi 7 doppij larghi onze 8 £ 3.10.-. 59 PAGANINI, Vocabolario, cit.
29
– scalini lunghi palmi 7.8.9.10.11.12 devono essere larghi p 1 1/2 spessi once 2 (anche qui quelli più sottili o meno larghi vanno pagati meno)
– scalini bastardi lunghi palmi 7.8.9.10.11.12 devono essere larghi p 1 3/4 spessi once 1/2
– scalini grossi p 1/4 lunghi palmi da 3 a 12 devono essere palmi 1 1/2, (valgono due scalini ordinari).
Invece, nel capitolato ottocentesco60 sono citati dalla frase gradini detti schiavoni mm 25÷35 280 ÷300, che conferma la loro parentela con gli scalini ma qui però sono i più sottili quasi che il significato sia ribaltato.
Quanto alla lavorazione troviamo il classico bastone ma si trovano anche lasciati sgrezi, forse per una finitura in opera.
In fine possono, come in ogni manufatto visto, avere un uso diverso:
canale di palmi 6 di schiavone n° 26 a soldi 1:6 l’una larghe £ 33:16:
n° 1 battente di palmi 6 refillato di schiavone £ 1.4.-
3. LAVORI PARTICOLARI
3.1 LA NOTTE
In caso di freddo intenso, con il rischio di gelate, a Cornigliano occorre proteggere le piante del raffinato giardino, perciò vi è chi deve vegliare dei fuochi accesi per scaldare l’aria attorno agli alberi più delicati.
111 – spese per il giardino di Cornigliano nel 1763
varie notti impiegate a far fuoco alli cedrati per ripararli dal gelo.
Ma di notte si veglia anche, probabilmente per evi-tare furti, ad un materiale:
1754 a 12 giugno Lista del Reverendo Angelo Aronio per diverse
(in cui) speso per fare la guardia di notte alla pozzolana £ 1:4
o per ragioni tecniche ai pavimenti battuti, con consumo d’olio (nei lumi o nelle finiture?)
n° 17 quarteroni oglio a soldi 9.4 servito per ongere i ferri de bancalari e per la veglia de battumi
dati al figlio di Cantone muratore che lavorava col Barello per la veglia di mesi 2 incirca £14
qui veglia, per due mesi, il figlio del capo d’opera.Nel cantiere di città, forse al fine di avere la strada
sgombra di giorno o per evitare incidenti, si trova il conto per aver levato il gettito di notte nelli ponti delle facciate; infine si pagano due persone che hanno lavo-rato due notti per sciorare la calcina.
3.2 ATTREZZI SPECIALI
Oltre agli esempi già inclusi in altri capitoli, troviamo ancora attrezzature di vario genere che vengono fornite all’occorrenza, come serre, scalpelli, verrine e persino un compasso di ferro di palmi 2 e che serve anche per squadra e deve servire a monsieur Decotte per la scala £ 23.12.
Molto utile in un cantiere è la corda, troviamo noti-zia di un certo Gaetano Vernengo che fornisce corda fina per le tende e spago nostrale, quindi più per le finiture che per i lavori strutturali ma questi sono compresi nelle filze non trascritte.
Si trovano anche varie scope, di palma o di brugo (…), un pignatino per la colla, una bussola per Giolfi (un pittore).
Tra le forniture speciali, infine, segnalerei i ma-teriali per i fiori finti per la cappella di Cornigliano, apprestati alla fine degli anni ‘60, vengono prodotti in cantiere con Carta colore di Rosa, Cartine per verde n° 11, Safrano, Gomma, Reffe verde e filo di ferro, in tutto per nove once di peso, ma forse ispirandosi a quelli comprati a Milano per le spalliere (?) della stessa cappella nel 1762.
E il conto per due mesi di carne che ha servito per governo dell’avoltoio, che non sono certo attinenti al cantiere ma dicono molto sul tenore di vita dei com-mittenti.
4. PROVENIENZE E TRASPORTI
I materiali che sono forniti in cantiere provengono da una varietà di luoghi, alcuni sono i più vicini alla fabbrica, altri sono quelli di produzione del materiale, oppure quelli che, pur non essendo i più vicini, lo di-ventano per motivi politici; altre forniture sembrano dipendere da mode o da relazioni personali; infine vi sono quelli inesplicabili: perché Paolo Gerolamo com-pra ottangoli e quadretti a Tunisi, in Africa?
E non senza alcune difficoltà: alcuni facchini li por-tano alla marina, poi van per nave fino a Biserta dove sostano in magazzino, una volta devono essere sbarcati perché la barca non poté uscire dalla fiumara per essersi esseccato dalla bocca; così troviamo un pagamento a mori (per l’assistenza) e sandalli (per l’imbarco) per operazioni di trasporto, arrivano nel 1719 a Genova, per il cantiere Pallavicini.
Da un altro documento, il Conto del costo e spese di 14400 ottangoli di Tunisi di quali però se ne sono ricevuti soli 12955 e di 8760 quadretti di Tunisi mandatomi dal sig. Gio Angelo Bopo di Biserta con sua lettera in data 12/12/1720 apprendiamo che i facchini li portarono alla marina, cinque sandalli li portarono da Tunisi a Biserta, ove giacquero in magazzinaggio, i sandalli li portarono poi a bordo per imbarcarli, dei mori li portarono dal magazzino ai sandalli, per contarli si pagò 0.26, “per portione che spetta a detti ottangoli e quadretti di p.zi 70, cioè p.zi 60 casa del Bastia, p.zi 5 ochilargi, e p.zi 5 torcimano soliti pagarsi per ogni bastimento che più carrica qualsiasi robba.”
Alcuni materiali o manufatti riutilizzabili sono com-prati presso altri utilizzatori, sia privati sia pubblici.
Per il palazzo di via Lomellini sono i gesuiti del collegio dei santi Geronimo e Saverio, nella persona di padre Agostino Balbi, il rettore, che forniscono 13 scalini grandi di pietra di lavagna per le scale maestre, e otto quadretti di marmo; ma ancor più particolare è la rivendita, da parte del padre Alessandro Mainero sj, di 5000 ottangoli di terra di Tunis, che evidente-mente non erano un’esclusiva di Paolo Gerolamo e gli servono per i pavimenti nobili, dopo opportuna lustratura.
60 Città di Genova, Ufficio dei lavori pubblici, Capitolato spe-ciale, cit.
30
Nel palazzo di Cornigliano, invece, per la fabbrica di rimesse con stalla e altri appartamenti sopra d’esse nel cortile vicino alla torre, siamo nel 1763, viene fatto un acquisto di mattoni vecchi, e alcuni vengono dal Lazareto per mezzo di maestro Giacomo Scaniglia. I mattoni nuovi invece vengono da Savona ai seguenti prezzi, al migliaio, di nolo (a cui occorrerà aggiungere la gabella):
1753 @ 3 novembre Conto di nolo da Savona alla spiaggia di mattoni
36000 mattoni negri e chiari a £ 3.5
12800 mattoni ferrioli a £ 3.5
2000 spole a £ 3
10000 mattoni da caruggio a £ 3.5
5000 chiappelle a £ 3Tra altro arrivano invece da Genova: una soma di pi-
lastrate di legno; tromba e canali; ferri, telari e gelosie.Normalmente la pozzolana (a volte detta porcel-
lana), per centinaia di cantara, arriva via mare da Civitavecchia o dal napolitano, ma troviamo che può essere fornita direttamente dall’ufficio che si occupa del territorio e nel 1766 si paga un conto di pozzolana avuta per riparto dal magistrato illustrissimo dei Padri del Comune; questa forma di approvvigionamento tra-mite le scorte pubbliche era stata usata anche nel 1755 se si predispone un conto di porcellana restituita alla Camera dei Padri del Comune; ciò che restava, quindi poteva, o doveva, essere reso. In effetti abbiamo già notato come a questo materiale si facesse una partico-lare attenzione con l’accortezza di sorvegliarlo anche di notte. Comunque in quel periodo arrivano in cantiere oltre 36 tonnellate di pozzolana.
Anche nel palazzo di via Lomellini è presente.A volte i materiali sono forniti per più cantieri dello
stesso committente:n° 464 paga calcina anche per la casa grande di Luccoli e per una a S GenesioCapita anche di incontrare dei manufatti molto “mo-
bili”, come il caso di una vasca di marmo e un paio di colonne che, dopo essere state prelevate dal ponte della Mercanzia (nel porto di Genova) e portate in strada Balbi sono state riportate a Cornigliano, nel novembre 1763.
Il legno è il materiale che arriva dai luoghi più di-sparati, ad esempio a Cornigliano arrivano tavole di cipresso provenienti da Savona, tra l’altro passano dal ponte della Mercanzia a quello Spinola per essere po-ste sul carro. O anche tavoloni di cipresso da Pisa e da Lucca (venduti da un certo cavalier Agliata), sono varie quantità di diverse lunghezze (da 9 a 14 palmi).
Vari tagli di castagno arrivano dalla Corsica nei due cantieri, essendo stati caricati a Bastia. Ma legnami vari provengono anche da Pentema, da Tortona, da Nizza, dalla Fiandra, da Amburgo…
Un recente studio sulla produzione e commercializ-zazione del legname indica proprio Genova come uno dei porti di arrivo per il Pino di Riga (una conifera di eccezionali qualità) che quindi non proveniva dalla Fiandra bensì da ancora più lontano61.
Un caso particolare é dato dalla misteriosa sabbia di Spagna (quale poteva essere l’utilizzo?) che viene comprata da una nave:
1754 a 2 luglio Conto di sabia di Spagna e nolo di detta dal porto a Cornigliano
Per some n° 140 sabia di Spagna bianca essendo ogni soma cantara 3 circa presa a bordo di un bastimento £ 20
e per nolo a minolli62 portata in due volte a Cornigliano et ivi sbarcata £ 20I mattoni nuovi per Cornigliano vengono da Savona
e da lì arrivano anche, in un caso, quadretti 3000 e chiappelle ferriole 3000, che sono però trasportate da un padrone (di barca) di Lavagna.
La canna d’India, usata per 24 sedie di canna alla francese, viene da Livorno.
Mentre uno stesso fornitore procura sia le canne per le volte finte, sia quelle utili nella coltivazione, da giardino, che costano 14 soldi:
1754 a 16 novembre Conto di canne per sofitte
Dato ad Agostino Mascardi per n° 12 fasci cane a soldi 16 il fascio servite per uso della fabbrica £ 9.12Per la messa in opera occorre anche la fornitura di
balle di appositi chiodi da canne, che arrivano insieme agli altri chiodi.
I trasporti avvengono quanto più possibile per via d’acqua, mentre si ricorre al mulo, sulla media distanza, per le zone a ridosso dei valichi appenninici, come ad esempio è per l’olio di noce che arriva dal Piemonte a Cornigliano per mezzo di Lorenzo Canone mulatiere di Novi, mentre l’acquisto é regolato attraverso un droghiere di Sottoripa, a Genova.
Una certa quantità di quarte di polvere di marmo vengono imbarcate a san Marcho con il mulatiere: prodotte dai marmarai in città63 sono trasferite dalla bottega alla barca con il mulo?
Alcuni mattoni del cantiere Pallavicini sono stati presi al ponte della legna e in dogana, evidentemente usati come luogo di compravendita degli stessi.
I vetri di Venezia arrivano via mare a Genova in en-trambi i cantieri; eccetto nel caso di lastre 2000 di vetro arrivate il 11/1/1721 (in via Lomellini) dai sigg Cambiag-gio e Piuma di Venetia con il burchio del padron Giacomo Pinelli, dirigendoli per via del fiume Po a Piacenza.
Se la provenienza è molto distante il materiale fa scalo nel porto di Genova e poi vi sarà un tratto (da Genova a Cornigliano) da percorrere, ancora via mare, con una barca da piccolo cabotaggio, così troviamo i conti per farla scaricare:
spaccio barchetta per quadrelle di Napolima il tratto può essere percorso non senza qualche
inconveniente:1754 @ 31 dicembre (1 luglio)Conto di nolo per donzene 14 tavole (di Corsica) prese in portotavole di palmi 16 prese in porto a bordo e portate da Genova a Cornigliano
62 I minolli e i camalli sono coloro che trasportano a braccia i materiali.
63 Nel XVII secolo i laboratori dei marmarari in città non erano molto vicini, Cfr. L. GROSSI BIANCHI, E. POLEGGI, Una città portuale del Medioevo, Genova nei secoli X-XVI, Genova 1979, p. 304.
61 M. ZUNDE, Timber export from old Riga an its impact on den-drochronological dating in Europe, «Dendrochronologia», 16-17, 1998-1999, da cui anche la figura.
31
per averle bagnate (d’acqua salata in mare) non se le paga che £ 7 (invece che 14).In città si usa il mulo sia per l’apporto come per
l’asporto di materiali dal cantiere, a titolo di esempio troviamo a Genova un mulattiere per calce e mattoni e a Cornigliano si paga
n° 485 30/6/1722: saldo al mulattiere Tomaso Croce per trasporti materiali.n° 474 15/5/1722: per asporto di some 123 gettito a To-maso Croce mulattiere, £ 24.12 Ma in caso di materiali troppo pesanti bisogna ri-
correre ai buoi:n° 243 per una carata di tavole di noce tirata alla fabricha con li bovi £ 2.Per il trasporto (ben 39 viaggi) di diverse cose da
Genova a Cornigliano i Durazzo ricorrono alla bestia dei manenti, molto probabilmente si tratta del mulo, sia perché i buoi sarebbero almeno in coppia, perciò si userebbe il plurale, sia perché così ad esso ci si riferisce tradizionalmente.
Per condurre una statua di marmo rappresentante Ercole, arrivata per mare da Carrara nel 1766, dalla spiaggia al sito destinato nel viale della villa a Corni-
gliano, sono occorse alcune giornate per muoverla, ricorrendo a legnami imprestati (antenne) e tre buoi.
Tenendo conto delle difficoltà nei trasporti, spe-cialmente se confrontate con la situazione odierna, si avverte un paradosso: allora il cantiere non si fermava mai per mancanza di materiali!
Tutto doveva essere previsto e predisposto per il bisogno della fabbrica in modo che, paradossal-mente, un corretto affrontare la complicazione nelle forniture rendeva molto più ristretto il campo degli imprevisti.
Anna Decri
REFERENZE ICONOGRAFICHE
PAGANINI A., 1857, Vcabolario domestico genovese italiano, Geno-va.
CERRUTI F., RESTAGNO L.A., 1939, Vocabolario della lingua italiana, Torino.
SAVIOLI L., 1988, Ardesia: materia e cultura, Genova.CEVINI P., 1996-97, La torre D’Amico a Campomorone e il commercio
del sale nel seicento, Tesi di Laurea, Università di Genova, a.a. 1996-97.

































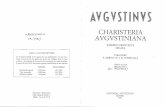
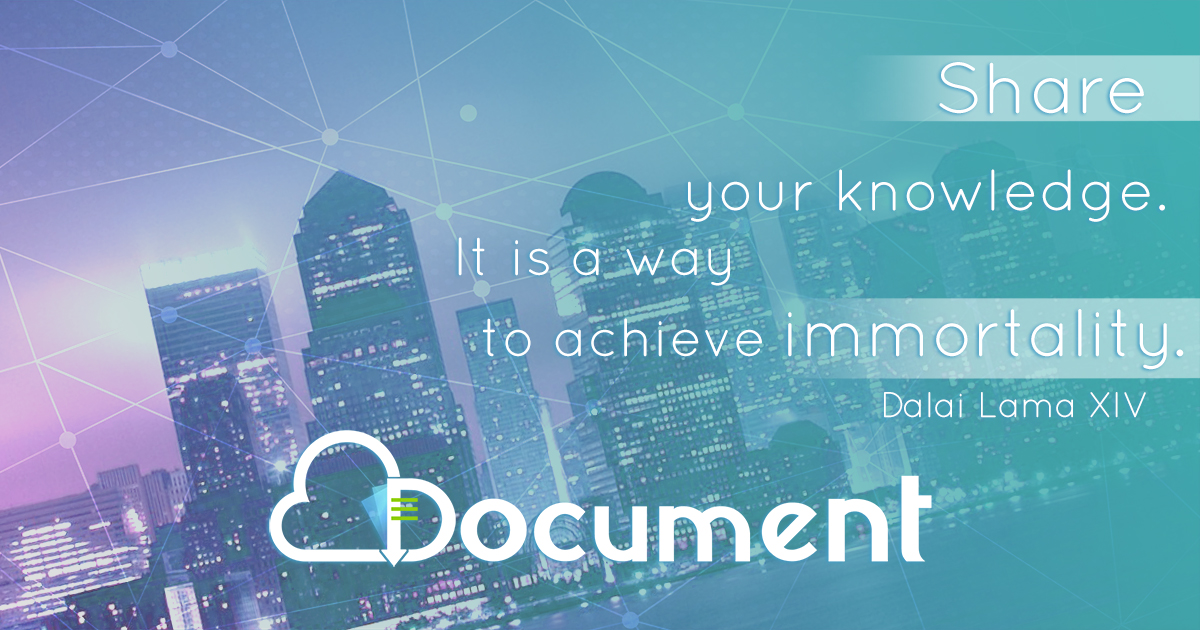




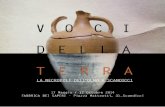

![[2008] Agricoltori per l’agricoltura. La Fabbrica Cooperativa Perfosfati Cerea (1908-2008); a cura di A. FERRARESE [ISBN 978-88-96930-16-8]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6313ae0ffc260b71020f33fe/2008-agricoltori-per-lagricoltura-la-fabbrica-cooperativa-perfosfati-cerea.jpg)

