Bolli figurati impressi su tegole di V e IV secolo a.C. da Kroton: sulle tracce di Apollo...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Bolli figurati impressi su tegole di V e IV secolo a.C. da Kroton: sulle tracce di Apollo...
35
Bolli figurati impressi su tegole di V e iV secolo a.c. da Kroton: sulle tracce di apollo ‘delfiniere’.di Margherita Corrado
1. Temi iconografici e distribuzione dei reperti. 2. Ipotesi interpretative. 3. Inquadramento cronologico dei laterizi krotoniati con bollo.4. Valenza apollinea delle immagini del delfino e del ‘delfiniere’. 4.1 Presupposti e pluralità di significato. 4.2 Sicilia e Magna Grecia: ambiti e modi d’uso. 4.3 Un donario tarantino con Apollo ‘delfiniere’ a Rossano di Vaglio (PZ)? 4.4 Tegole bollate nell‘edilizia funeraria di Kroton e Kaulonia.
Non mi sorprenderebbe che la mia narrazione della leggenda fosseleggendaria, fatta di verità sostanzialee di errori accidentali.J.L. Borges, Altre Inquisizioni.
Bolli figurati su tegole piane, con «rappresentazioni che sembrano de-rivare da tipi monetali molto ingranditi»1, sono stati trovati in contesti di V, IV e III secolo a.C. sia nell’area urbana di Kroton e nelle relative necropoli (fig. 1) sia nella chora, apposti sempre a ridosso o a breve distanza dal li-stello rettilineo con cui terminano i lati brevi di ciascun laterizio.
Un piccolo nucleo di reperti da scavo pubblicati nel 2005, e la possi-bilità di accedere alla documentazione inerente ai pezzi analoghi presenti nelle raccolte di privati e associazioni locali2, rendono ragione del tentativo di affrontare diffusamente l’argomento in questa sede3, a dispetto dell’entità non trascurabile dei dati inediti. Appena sfiorato nella corrente letteratura archeologica, il tema merita attenzione anche per certe implicazioni d’ordi-ne ideologico-religioso fin qui insospettate.
1. Temi iconografici e disTriBuzione dei reperTi.
Nella maggior parte dei casi le stampiglie in esame raffigurano un lebete a collo molto alto, privo di coperchio e di anelli, sorretto da tre poderose zam-pe leonine collegate internamente da un cerchio fissato a mezza altezza. Due elementi accessori più minuti – un kantharos sulla sinistra ed un fallo sulla destra – anch’essi a rilievo bassissimo, sono racchiusi nel medesimo cartiglio circolare scontornato (diam. cm 4,5) che centralmente ospita il tripode4 (figg. 2.1-3). Più esemplari del bollo in questione sono stati restituiti da tombe di IV secolo a.C. del sepolcreto pluristratificato di contrada Carrara, contiguo al quartiere meridionale della polis ed indagato (parzialmente) in due tempi, nel 1974 e nel 1984-55. Altri, identici,
1 saBBione 1984, p. 299.2 Per la disponibilità allo studio ed alla pubblicazione di molti dei reperti qui presentati, è d’obbligo ringraziare la dott.ssa M.G. Aisa, il Gruppo Archeo-
logico Krotoniate – da qui in poi G.A.K. – i signori Pasquale Attianese di Crotone ed Ernesto Palopoli di Torretta di Crucoli. Per i preziosi suggerimenti ed i proficui scambi d’idee sono invece debitrice ai colleghi A. Ruga e G. Aversa.
3 Brevi sintesi sono state proposte in marino – corrado 2009, p. 25-29 e corrado c.d.s.4 Il tripode con collo campeggia per la prima volta sulle emissioni krotoniati nella seconda fase della monetazione d’argento a doppio rilievo, iniziata verso
il 420 a.C., e presto compare anche sul bronzo: cfr. TaLiercio mensiTieri 1993a, p. 111-114, 121-122, con relativa bibliografia.5 Cfr. giudice 1998, p. 61-63.
Fig. 1
36
Margherita corrado
provengono invece dalla necropoli di Tufo-lo-S.Francesco, cui sembra facesse capo il quartiere centrale di Kroton6. Ritrovamenti analoghi7 sono abbastanza frequenti anche nelle aree urbane indagate dalla Soprin-tendenza nell’ultimo trentennio ma solo di alcuni è stata data notizia ufficiale: quelli del distretto artigianale di Campitello, ad esempio, e degli edifici messi in luce nei pressi dello stadio “Ezio Scida” (IV-III se-colo a.C.)8.
Diversamente dai precedenti, man-cano della cornice circolare sia i bolli con delfino stilizzato volto a destra9 (fig. 3.1) sia una parte di quelli con figura ma-schile in nudità eroica seduta in groppa al delfino10. Gli esemplari rinvenuti di re-cente nella chora Sud, ad Isola di Capo Rizzuto (KR)-Ronzino, nello scavo di due fattorie e della necropoli relativa alla seconda, consentono di riferire al V a.C.
sia la serie con ‘delfiniere’ in negativo volto a sinistra11 (figg. 4.1-2), e per comparazione quelle con delfino ‘incuso’12, sia le figure con opposto orientamento aggettanti ma inserite in un contorno incavato13 (fig. 5). Queste precedono le più minute ver-sioni a rilievo modestissimo e racchiuse entro un cartiglio circolare caratteristiche del IV secolo (fig. 6), attestate nei cantieri urbani di via XXV Aprile (Palazzo Foti), B. Telesio (proprietà Zito-Candigliota) e G. Di Vittorio (proprietà Romano) nonché, ancora una volta, alla Carrara.
Fig. 2.1
Fig. 2.3 Fig. 3.1
Fig. 2.2
Fig. 3.2
6 Ibidem, p. 63.7 Il presunto frammento di kalypter hegemon pubblicato in spadea 1992, p. 106 è lo stesso spezzone di tegola piana riproposto in Kroton 1998, p. 9.8 Cfr. spadea 1992, fig. a p. 106 (Campo Sportivo); aversa 2005, tav. XXX, fig. 3. Un esemplare proviene dal santuario di Vigna Nuova, situato subito al di
fuori della cinta urbica: informazione del dott. A. Ruga.9 In merito al delfino, si veda il classico raBinoviTsch 1947. 10 Una stampiglia di questo tipo ma di variante incerta, trovata alla Carrara, è segnalata in FoTi 1975, p. 308, e di nuovo in saBBione 1984, p. 299-300.11 ruga – rescigno – rouBis – fioriLLo 2005, p. 151, nota n. 11, tav. LXI, figg. 12 in alto, 13 in basso (fattoria del sito 1); 202, tavv. XC, fig. 104/46-47 e
LXI, fig. 13 in alto (necropoli del sito 17). Un esemplare sporadico da Ronzino di Isola di Capo Rizzuto (KR) è nella collezione Attianese.12 Il profilo delle tegole in questione è del tutto simile a quello dei manufatti analoghi con ‘delfiniere’, altro bollo di grandi dimensioni e ottenuto con la
stessa tecnica. Oltre al laterizio trovato durante una survey nel sito della necropoli già ricordata (ruga – rescigno – rouBis – fioriLLo 2005, p. 202, tavv. LXI, fig. 13 in alto e XC, fig. 105), segnalo un esemplare sporadico anch’esso da Isola di Capo Rizzuto-Ronzino (fig. 3.1) ed uno dalla Carrara presso il G.A.K., decontestualizzati.
13 Un soggetto dalla Carrara ed uno da ricognizioni di superficie condotte sul versante sud del promontorio di Capo Colonna sono conservati presso il G.A.K.
37
Bolli figurati iMpressi su tegole di V e iV secolo a.c. da Kroton: sulle tracce di apollo ‘delfiniere’
Sui laterizi delle tombe a cassa e a cappuccina di questa necropoli, rimasta in uso nell’intero arco di vita di Kroton, figura pure il bollo con testa di Atena segnalato dal Sabbione nel 198314 (fig. 7). Sono invece del tutto inediti e privi di riscontro altrove sia i marchi con swastika (fig. 8), con clava (figg. 9.1-2) e con presunta epsilon (?) (fig. 10), anch’essi in cornice circolare, sia una variante del delfino ‘incuso’ già ricordato (fig. 3.2) ed un bollo in cartiglio rettangolare con tripode privo di coperchio ma dotato di tre grossi anelli fissati al bordo del lebete (fig. 11). Nello spazio pubblico indagato all’interno dello stadio “Ezio Scida”, poi, un esemplare con swa-
Fig. 9.1 Fig. 10Fig. 9.2
14 saBBione 1984, p. 300.
Fig. 4.2
Fig. 6
Fig. 4.1
Fig. 8Fig. 7
5 cm
Fig. 5
7
11 12 13 14
8 9 10
5 cm
1
3
5
2
4
6
Tavola I
Tavola II
I numeri progressivi da 1 a 14 nelle Tavole I-II si riferiscono alle tabelle dei Simboli in cornice e in cornice circolare, rappresen-tate a pagina 40.
38
Margherita corrado
stika proviene dallo stesso scarico di materiale architettonico che ha restituito la stampiglia con stella a 16 raggi (fig. 12.1), associazione che si ripete nei crolli delle coperture degli edifici della medesima area, l’uno e gli altri risalenti al tra-monto del IV secolo a.C.15. Il diametro dell’astro a 16 raggi è metà di quello ad 8 rinvenuto in via B. Telesio (proprietà Zito-Candigliota) in un li-vello grossomodo coevo (fig. 12.2). Inediti sono pure il tipo con ruota, attestato da un unico bollo trovato in territorio di Isola di Capo Rizzuto (fig. 13)16, ed il tipo con polpo. Di quest’ultimo, un esemplare è noto con certezza dal Vallone San Giorgio, poco lontano da Crotone in direzione nord-ovest, in una sepoltura femminile a cappuc-cina di IV secolo inoltrato17; un altro, con gene-rica provenienza dal territorio krotoniate, figura nella collezione del sig. Ernesto Palopoli a Tor-retta di Crucoli (KR) (figg. 14.1-2).
2. ipoTesi inTerpreTaTive.
Stante la quasi perfetta corrispondenza di gran parte delle figure stampigliate sui lateri-zi con emblemi monetali in uso alle zecche di Magna Grecia e Sicilia fin dall’età arcaica, e la rarità delle tegole bollate rispetto alla grande maggioranza priva di qualsiasi contrassegno18, quanti in passato si sono occupati dell’argomen-to hanno generalmente dato credito all’ipotesi che si tratti in toto di bolli pubblici19. Per alcuni è pubblica la commissione, affidata dalla po-lis ad officine private che avrebbero marchiato esclusivamente le partite da non immettere sul libero mercato20; altri reputano pubbliche sia la
fabbrica sia la destinazione dei manufatti21. Una tesi recente, basata sull’errato presupposto che quasi tutti i bolli risalgano ai primi del IV secolo a.C., li riserva agli edifici di rappresentanza delle città della lega italiota del 393/222, cui aderirono Crotoniati, Cauloniati, Turini, Regini, Hipponiati e forse anche gli abitanti di Velia e Pandosia23. Il nesso colto dal Sabbione non può essere invocato, in realtà, come testimonianza sicura di una scelta programmatica di riproduzione del materiale numismatico dettata dalla
15 Informazioni del dott. A. Ruga. 16 Una tegola da Segesta con bollo circolare a rilievo che raffigura una ruota a 4 raggi, soggetto tra i più attestati sull’instrumentum domesticum, di stile
tuttavia diverso, è in garozzo 1995, 1200-1201, n. 24, tav. CCLXXIII, n. 6. Per altri esempi dalla Grecia propria, cfr. feLsch 1994, p. 304-305, 319, tav. 54.17 Cfr. archivio fotografico Pasquale Attianese. Il laterizio con bollo di diametro inferiore a cm 3 (cfr. tabella) è conservato nel Museo Nazionale di Crotone,
senza indicazione di provenienza (fig. 14.3).18 Il fenomeno, comune a tutta la produzione laterizia di età greca e romana, fa supporre che la prassi, nell’ambito dell’attività delle officine, prevedesse di
apporre il bollo su un solo manufatto per ogni partita: cfr. saBBione 1984, p. 300. 19 Tra i pochi a negarlo, vd. saBBione 1984, p. 299.20 guzzo 1988, p. 471.21 In generale, sul problema della destinazione spesso non solo pubblica dei prodotti delle officine statali, vd. Lazzarini 1982, p. 156-157.22 spadea 1993, p. 25; idem 1998, p. 41. Circa la fondazione della lega italiota nel 393/2 (diod. XIV 91, 1; 101, 1) e i suoi rapporti con la precedente alleanza
delle città achee, nonché a proposito delle complesse vicende di Crotone nel corso del IV secolo a.C., si rimanda a meLe 1993, p. 235 ss.23 meLe 1992, p. 30. Ne deriva che Kroton si sarebbe fatta carico di commissionare partite di tegole diversificate da quelle comuni e tra di loro mediante bolli
invisibili una volta messe in opera, e avrebbe adottato questa procedura anche per sé. L’obbligo implicito di fissare in coincidenza con l’estinzione della citata
Fig. 11 Fig. 14.1
Fig. 12.1
Fig. 12.2
Fig. 14.2
Fig. 14.3Fig. 13
39
Bolli figurati iMpressi su tegole di V e iV secolo a.c. da Kroton: sulle tracce di apollo ‘delfiniere’
volontà di attribuire e vedere riconosciuto ai bolli laterizi lo stesso carattere ufficiale degli emblemi monetali. Dir-li «ridotti al mero valore di simbolo decorativo»24, quasi deplorando che abbiano sofferto una grave diminuzione della loro dignità, è tuttavia altrettanto improprio che sup-porre un’iniziativa pubblica dietro ogni manufatto bollato con un’immagine attestata anche sulle monete.
La forma circolare del cartiglio, ove presente, riman-da effettivamente al tondello metallico coniato, ma alcu-ne stampiglie ne fanno a meno e tutte quelle che l’hanno non recano traccia di perlinato o di linea d’esergo, né si accompagnano a legende di sorta25. Il cerchio sembra infatti costituire, di norma, una semplice delimitazione fisica dello spazio decorato. Quanto alle immagini pro-poste, esse s’ispirano alla vita e alla cultura del tempo ma innegabilmente preferiscono attingere alla sfera del sacro (divinità, elementi di arredo liturgico, simboli reli-giosi) più che a quella del quotidiano, proprio come ac-cade d’abitudine per le monete e meno di frequente per l’instrumentum domesticum.
A prescindere dalle scelte iconografiche, ma con più forza proprio in ragione di quelle, credo che le stampi-glie krotoniati su tegola siano innanzi tutto veri e propri marchi di garanzia mediante i quali lo Stato assicurava il rispetto dei canoni metrologici e ponderali vigenti, la bontà della materia prima impiegata, il corretto procedi-mento di essiccazione e successiva cottura dei manufatti. Tutti questi fattori influiscono sulla qualità, in termini di solidità, integrità e durata26, di un prodotto che il recupe-ro in contesti residenziali urbani e rurali, nonché in ambi-to necropolare, assicura essere stato immesso sul mercato senza restrizioni di sorta.
Nel paragrafo 4 si tenterà di dimostrare che, per ragioni diverse da quelle addotte in passato, carattere ufficiale va riconosciuto senz’altro alle serie con il tripode, «simbolo per antonomasia del cosmo pitico»27, può essere esteso a quelle anteriori con delfino e con ‘delfiniere’ a patto di rivendicare anche per questi una matrice ideologica krotoniate invece che tarantina, di probabile ispira-zione delfica, ma è lecito attribuirlo pure ad alcune tra le piccole stampiglie di fine IV perché allusive ad Apollo e a Delfi almeno in senso lato. Ciò che accomuna i bolli laterizi alle monete è infatti soprattutto la forza del messaggio simbolico affidato loro, in entrambi i casi ricavato direttamente dal patrimonio religioso e cultuale della polis.
In particolare nelle prime serie, tale messaggio non sembra estraneo ad un simbolismo zodiacale di antichissima origine al quale prestarono molta attenzione i Pitagorici, grandi fautori dell’apollinismo delfico, e che rende decisamente remota, vedremo, l’idea di scelte casuali.
symmachia, nel 389 a.C., il terminus ante quem per la fabbricazione dei laterizi con marchi riconducibili alle poleis coinvolte nell’alleanza, ci costringerebbe a crederli contemporanei e adoperati per almeno cent’anni dopo quella data solo come materiale di spoglio, sia in ambito urbano sia nella chora. Né si saprebbe a chi riferire i molti simboli non distintivi di una città federata.
24 spadea 1984, p. 155.25 Le presunte «tracce di una legenda desunta dagli analoghi tipi monetali di Thurii» (saBBione 1984, p. 300) si riducono, nel solo esemplare nitido dei tre
con testa di Atena rinvenuti alla Carrara, ad un paio di cerchietti con punto centrale – altri sono forse illeggibili – posti a ds. del collo come semplice riempitivo richiesto dalla mancata centratura dell’immagine nella cornice.
26 Altrettanto richiederà Vitruvio in fatto di mattoni crudi: viTr. II, 8, 19.27 giangiuLio 1989, p. 84.
Tavola III. Sezioni delle spalle degli embrici e relativi simboli dei bolli.
Tavola III
40
Margherita corrado
3. inquadramenTo cronoLogico dei LaTerizi kroToniaTi con BoLLo.
Le informazioni oggi disponibili attestano che gli archetipi della produzione laterizia bollata di Kroton sono le due serie ‘incuse’ con delfino e con ‘delfiniere’, finora rinvenute soltanto in ambito funerario nell’immediato suburbio e nella chora Sud28. Entrambi i bolli hanno dimensioni ragguardevoli, mancano del cartiglio e ignorano la cura dei particolari interni a vantaggio del risalto dato alla silhouette29. L’opposto orientamento delle figure e certe lievi differenze nella resa dei delfini, del tipo corto e poco slanciato che il confronto con monete di Kroton e Kaulonia rivela tipico della prima metà del V a.C., potrebbero segnalare una certa discrepanza cronologica tra le due serie. Nella successiva e più sapiente versione della seconda – la prima, attestata in due varianti, non ha avuto seguito – questi bolli apposti su tegole adoperate senz’altro nell’edilizia residenziale urbana30 e rurale, come pure in quella funeraria, premiano, invece, la plasticità delle masse muscolari31. Essi sono oggettivamente assai prossimi alle emissioni tarantine coeve, dove figura il tipo monetale sempre chiamato in causa quale modello dei ‘delfinieri’ krotoniati insieme ad un’antefissa di tardo V dagli scavi di Monasterace Marina (Rc)-Kaulonia32.
N° Simboli CorniCe miSure
1 Delfino ‘incuso’ a ds. no 5 x 32 Delfino ‘incuso’ a ds. no 5 x 33 Delfiniere ‘incuso’ a sn. no 7 x 64 Delfiniere a rilievo a ds. sì 7 x 65 Tripode a rilievo sì 3 x 2/2,5
Usciti verosimilmente da opifici pubblici, i soli esistenti, a mio avviso, nella Kroton arcaica e classica, vi furono adottati con l’assenso e forse la regia di un regime pitagorico che nel caso del ‘delfiniere’ in contorno incavato potrebbe essere quello restau-rato per impulso degli Achei e del santuario di Delfi dopo la sanguinosa parentesi democratica di metà V33. La variante più tarda, impressa su tegole utilizzate sia nelle coperture degli edifici sia in ambito funerario, si caratterizza per le dimensioni più contenute dell’immagine34 (cm 5,5 x 5), l’aggetto modestissimo e la cornice circolare che, se pure molto ampia, l’accomuna alle stampiglie krotoniati datate con certezza al IV secolo a.C. La varietà delle dimensioni attestate non sembra riconducibile ad una pluralità di fabbriche in funzione contemporaneamente o di squadre attive nel medesimo atelier che adoperassero punzoni diversi: in nessun contesto affidabile è infatti documentata la coesistenza di stampiglie con simboli differenti35. Nella riduzione progressiva del dia-metro del marchio sembra potersi riconoscere, al contrario, un valido criterio di seriazione cronologica relativamente al IV secolo (tavv. I-II), confortato dai dati stratigrafici acquisiti finora.
N° Simboli in CorniCe CirColare Ø6 Delfiniere a rilievo a ds. 67 Ruota 58 Tripode con kantharos e fallo 4,59 Stella a 8 raggi 410 Swastika 3,511 Polpo 3,211b Polpo 2,712 Testa di Atena 313 Stella a 16 raggi 214 Clava 1,5
28 Ciò potrebbe dipendere dal fatto che le opportunità di indagare livelli di V secolo all’interno dell’area urbana di Kroton sono state fin qui piuttosto scarse.29 La testa di profilo con i capelli raccolti dietro la nuca, il busto di tre quarti, il ‘delfiniere’, ha il baricentro leggermente spostato all’indietro, il braccio sini-
stro arretrato, con la mano posata sulla parte finale del dorso del cetaceo, ed il destro avanzato, piegato ad angolo retto subito sopra l’apice della pinna dorsale, che sfiora il gomito; la mano è chiusa a pugno.
30 Un esemplare inedito da Crotone - via B. Telesio (proprietà Zito-Candigliota) è ricordato in ruga – rescigno – rouBis – fioriLLo 2005, p. 151, nota n. 11 e p. 163. Un altro proviene dagli scavi per il Nuovo Teatro Comunale (ex inf. dott. A. Ruga).
31 In questa prima versione a rilievo, la schiena leggermente piegata in avanti e la testa dritta del ‘delfiniere’, seduto in posizione più avanzata che nel caso precedente, contrastano efficacemente la spinta in senso opposto prodotta dal guizzo del delfino. Ulteriore stabilità è garantita dalla mano sinistra nella posa consueta, mentre la destra, apparentemente vuota, sembra limitarsi a prolungare la linea tracciata da avambraccio e braccio, avanzati e leggermente piegati verso il basso.
32 Il laterizio proviene dallo sbancamento per l’impianto di un vigneto effettuato nel 1890 alla base del versante meridionale della collina del Faro: cfr. BareLLo 1995, p. 19, 2-28, con bibliografia precedente. Da ultimo, vd. ianneLLi 2007, p. 137, fig. a p. 143.
33 Sulle vicende di Crotone nel V secolo a.C. si vedano meLe 1984; idem 1992, p. 25-30.34 La seconda versione a rilievo del ‘delfiniere’ si differenzia dalle precedenti per la più accentuata stilizzazione della figura e per la posizione dell’avam-
braccio destro, quasi perpendicolare al busto, con braccio teso verso l’alto e mano aperta (vuota?) a palmo rivolto in su.
41
Bolli figurati iMpressi su tegole di V e iV secolo a.c. da Kroton: sulle tracce di apollo ‘delfiniere’
Se è così, le dimensioni ancora considerevoli e la notevole somi-glianza con le figure del secondo suggeriscono che il terzo ‘delfiniere’ possa situarsi sullo scorcio del V secolo o nei primissimi anni del IV, anteriormente a quella conquista dionigiana della pόlis che è un credibile terminus ante quem anche per la stampiglia con ruota36.
Il piccolo tripode isolato sembra invece fungere da trait d’union con le serie di pieno IV, poiché ignora il cartiglio circolare già adottato dall’ultimo ‘delfiniere’.
Con quello condivide, altresì, il rilievo modestissimo, ma risolve il contorno che tradizionalmente asseconda il profilo della figura in un ret-tangolo quasi perfetto, appena allargato alla base per seguire la convessità delle caratteristiche zampe leonine.
Quanto ai bolli con tripode e simboli minori, le travagliate vicende storiche di Kroton adombrano due scenari di produzione possibili. Il pri-mo li colloca anch’essi in data anteriore alla sconfitta subita dai Kroto-niati presso l’Elleporo nel 389, dando nuova forza all’ipotesi che guarda al periodo di floridezza economica e ricchezza demografica compreso tra l’ultimo quarto del V e l’avvio del IV secolo a.C. Il secondo orienta inve-ce verso la metà del IV, nella generale ristrutturazione del tessuto urbano seguita alla fine dell’egemonia siracusana, tramontata al più tardi in coin-cidenza con la caduta di Dionisio II nel 35637.
Nel primo caso, i gravi danni subiti dagli edifici pubblici di Kro-ton durante i circa vent’anni di occupazione dionigiana e testimoniati dall’ampio riuso delle loro membrature nel corso del suddetto riatta-mento38 potrebbero aver reso accessibili ai privati, tra i manufatti di-smessi di origine pubblica risalenti a fine V – inizi IV, grandi quantità di prodotti laterizi integri e frammentari, alcuni dei quali bollati, pronti per una seconda vita. Ciò aiuterebbe a spiegare la capillare distribuzione dei loro resti nei tre quartieri in cui si articolava la polis e nelle necro-poli più prossime alla sua cinta muraria, giustificandone ad un tempo l’assenza dalla chora in quanto materiale di spoglio escluso dai normali canali di vendita. Nel secondo caso, ipotesi forse più convincente, pro-prio la rovina di tanta parte delle sedi istituzionali avrebbe imposto alla città, infine tornata libera, un intervento capillare di restauro o, a seconda dei casi, di riedificazione delle fabbriche distrutte. In tale contesto una manifattura pubblica fu attivata o rimessa in moto, se preesistendo le era toccata la stessa sorte della zecca39, perché provvedesse all’esecuzione delle centinaia di partite di tegole necessarie ai cantieri edili messi in funzione, parte delle quali vendute liberamente anche ai privati40.
35 Nelle coperture degli edifici dell’area pubblica parzialmente esplorata all’interno dello stadio “E. Scida”, come nello scarico di materiale architet-tonico ivi scoperto (cfr. supra, p. 36-37), le tegole contrassegnate dalla stella a 16 raggi appartengono con ogni probabilità all’ultima ristrutturazione, quella che mantenne in opera solo i più integri tra i laterizi dei precedenti tetti con swastika, il che spiega il recupero contestuale delle due serie nei crolli dei tetti come nel butto.
36 La coincidenza con il R/ di certi stateri krotoniati emessi intorno a metà del V a.C. (infra, nota n. 104) adombra la possibilità che tale bollo possa essere anteriore al IV secolo ma la lunga durata della memoria di certe scelte è testimoniata anche dalla comparsa di tripode e kantharos sulle stampiglie a distanza di decenni dall’emissione di monete con la stessa associazione: vd. infra, nota n. 44.
37 Cfr. meLe 1993, p. 254-263.38 Cfr. spadea 1993, p. 22; meLe 1992, p. 35-36. 39 Un vuoto di documentazione numismatica si riscontra, a Crotone, dopo l’avvio del IV e fin verso la metà del secolo, a causa dell’esito infelice dello
scontro con Dionisio I di Siracusa: cfr. meLe 1992, p. 36; idem 1993, p. 260.40 Un serio esame comparativo dei profili delle alette e degli spessori delle piastre è al momento impossibile per il numero limitato e le dimensioni ridotte
della maggior parte dei frr. di tegole bollate rinvenuti. Il confronto tra gli esemplari datati con certezza a fine V (relativi ai tipi con delfino e con delfiniere ‘incusi’) e alla seconda metà del IV (astro ad 8 raggi) suggerisce, però, un progressivo ispessimento e accorciamento dell’aletta, unito ad un’inclinazione più accentuata rispetto alla piastra, leggibile anche sulla faccia inferiore nei casi in cui si conserva l’incasso utile alla parziale sovrapposizione delle tegole (tav. III). Se ne ricava una conferma della cronologia che colloca i soggetti marchiati con tripode, kantharos e fallo dopo la metà del IV, mentre per quanto concerne quelli con testa di Atena, il profilo del solo fr. superstite dotato di aletta sembra contraddire la datazione ancora più bassa suggerita, invece, dalle dimensioni ridotte del bollo.
Fig. 15.1
Fig. 15.2
42
Margherita corrado
A differenza che nel V secolo a.C., fuori della cinta urbica esse conobbero una distribuzione molto limitata a causa della presenza brettia che nel pieno e tardo IV arrivava ormai a lambire la città41. In questa situazione, l’avvio o la ripresa dell’attività della figlina statale poco dopo la metà del IV secolo richiese la fabbricazione ex novo di stampi che la riduzione delle dimensioni unita al ricorso sistematico al cartiglio circolare dicono più maneggevoli e perciò facili da usare rispetto al passato42. Le innova-zioni citate sembrano riflettere e marcare una cesura temporale misurabile in diversi decenni rispetto alle stagioni produttive cui spettano le serie ‘incuse’ con delfino e ‘delfiniere’ e quelle successive con ‘delfiniere’ rispettivamente in contorno incavato ed in cornice circolare. Rafforza quest’impressione la palese volontà di porsi al passo coi tempi anche sui piani stilistico e ideologico che indusse ad accantonare il tipo del tripode isolato a favore di quello con kantharos e fallo. In effetti, dopo che la zecca ne aveva fatto l’emblema unico di Kroton fin dai primi decenni della sua attività, solo una figlina pubblica avrebbe potuto adottare come contrassegno un simbolo altrimenti riservato espressamente, a Crotone, alle scene del mito e alla monetazione43. Lo stile dell’im-magine su terracotta risponde sempre ai canoni artistici dell’epoca di produzione dei rivestimenti e la somiglianza con il tripode che campeggia sulle emissioni coeve – nel secondo caso quelle krotoniati, peteline e catanesi della seconda metà del IV a.C.44 – si spiega anche con il fatto che le monete offrivano realmente un modello all’incisore dello stampo utilizzato per la marchiatura dei laterizi45, forse da ricercarsi anch’egli nell’ambiente della zecca46. Sui bolli in questione, però, la ripetizione dell’episema monetale non è calligrafica, poiché negli spazi laterali trovano posto simboli o totalmente estranei alla monetazione krotoniate47 o esclusi, di norma, dal novero dei soggetti principali48. Entrambi sembrano alludere al mondo di Dioniso49, scelta che, ben più delle omis-sioni dell’etnico, del perlinato e della linea d’esergo, rende palese il carattere non vincolante del rapporto tra stampiglia e tondello metallico coniato. Essa potrebbe aver premiato la divinità cui si votavano gli artigiani della zecca, o i figuli, oppure il settore della città dov’era ubicata la manifattura pubblica. In alternativa all’ipotesi di un’iniziativa assunta dall’incisore a titolo personale o nata in seno alla bottega che gli commissionò lo stampo, nei simboli minori dovremo forse cogliere un’esplicita volontà di sotto-lineare l’associazione dell’elemento dionisiaco a quello apollineo50. Potrebbero essere, in tal caso, parte integrante di un diretto richiamo al santuario di Delfi, e segnatamente alla Delfi di IV secolo. Anche la prima apparizione di marchi sui laterizi di Kroton, del resto, datata ai decenni iniziali del V, fu affidata ad un’iconografia di probabile matrice delfica piuttosto e prima che tarantina. In ambiente acheo-krotoniate, in età tardo-arcaica e classica, l’immagine del delfino/’delfiniere’ non poteva infatti che rinviare al celebre Apollonion della Focide51 ed allo stretto vincolo che almeno dalla seconda metà del VI a.C. lo unisce a Kroton. Plausibile risultato di uno «sviluppo progressivo, connesso alla crescita dell’importanza panellenica della nuova Delfi anfizionica nel corso
41 Cfr. spadea 1993, p. 25. Un bollo con fulmine a rilievo in cornice circolare (diam. cm 1,7), è impresso, però, su una tegola piana rinvenuta nell’abitato brettio di Serre d’Altilia, a nord-ovest di Crotone, unitamente a vasellame ceramico di tardo IV-II sec. a.C.: aTTianese 1981, p. 13, fig. 30, ora riproposto in Lopez 2007, p. 16, fig. 10.
42 In generale, l’idea che fossero adoperati punzoni di legno è resa improbabile dalla considerazione che sarebbe stato necessario lavarli e ripulirli dopo ogni impressione. Non così nel caso di stampi metallici o, meglio ancora, fittili.
43 Proprio nel IV secolo a.C. esso è relegato per la prima volta sul rovescio delle emissioni d’argento a doppio rilievo per lasciare il posto d’onore, sul diritto, ad altri soggetti: vd. sTazio 1993, p. 103.
44 Anche il tipo del kantharos e la resa di scorcio del fallo appartengono a quel periodo.45 Se ne congettura uno solo poiché, diversamente dal caso del ‘delfiniere’, attestato in tre versioni tecnicamente e stilisticamente differenti, con diverso
valore semantico in rapporto alla cronologia dei pezzi, per la serie con tripode e simboli accessori lo stile delle immagini è univoco, tale da farli supporre opera della medesima mano, commissionati e realizzati in un’unica soluzione ed in numero sufficiente a dotarne tutte le squadre di operai impegnate nell’attività manifatturiera.
46 Nell’ormai accertato valore cronologico del passaggio dalla figura stampigliata in incavo a quella aggettante ma dai contorni incavati, preludio al bas-sorilievo vero e proprio, s’intuisce una stretta parentela con la dinamica che in ambito numismatico determina l’abbandono della tecnica incusa a favore del doppio rilievo.
47 Una tessera circolare (diam. mm 10; gr 1,23) in bronzo rinvenuta nell’abitato e connessa ad attività ginniche presenta anch’essa, al D/, un fallo visto di scorcio, mentre al R/ reca un aryballos metallico ed uno strigile: arsLan 2005, p. 108, 141, n. 422, tav. LIII.
48 Il kantharos compare nel campo a sn. del tripode al D/ di uno statere coniato intorno alla metà del V secolo a.C.; è invece il tipo principale, con l’aggiunta di due serpenti, al R/ di un raro diobolo in bronzo: aTTianese 1992, p. 77, n. 68 e 91, n. 92.
49 A Taranto, ad esempio, il ricorrere del kantharos su emissioni in oro, argento e bronzo di V – III a.C. è messo direttamente in relazione con il radicato culto di Dioniso: cfr. garraffo 1995, p. 134, 141-142.
50 Com’è noto, Dioniso, nuovo arrivato nel consesso degli olimpî, ebbe il riconoscimento ufficiale dell’oracolo delfico e fu bene accolto nel santuario situato alle falde del Parnaso, monte che le Tiadi, sorta di Baccanti a lui votate, dividevano con le Muse, rimanendo signore unico di Delfi nei tre mesi di permanenza annuale del padrone di casa nel paese degli Iperborei. I due deî sono uniti da una «matrice comune» soprattutto sull’autorità di Plutarco (Plut., De E ap. Delph. 389 c), ma anche dall’avere, ciascuno, un «nesso radicale» con Creta: coLLi 1992, p. 265. Una tradizione vuole che sia stato proprio il figlio di Latona a rac-cogliere i resti di Dioniso bambino sgozzato e divorato dai Titani: OF 35 Kern.
51 La prima esplicita rivendicazione in tal senso è tuttavia molto recente: vd. marino 2003, p. 107. L’ipotesi che fa dei laterizi con ‘delfiniere’ trovati a Crotone un’importazione tarantina benché Taranto non conosca manufatti simili stenta, tuttora, ad essere accantonata: vd. giudice 1998, p. 63; contra saBBione 1984, p. 300.
43
Bolli figurati iMpressi su tegole di V e iV secolo a.c. da Kroton: sulle tracce di apollo ‘delfiniere’
del secolo ed all’organizzazione dei rapporti di Crotone con essa», detto legame non originario52 si accentuò senz’altro nella sta-gione pitagorica, impregnata di apollinismo delfico53. Non saremo lontani dal vero, allora, ascrivendo ad un governo d’impronta pitagorica, desideroso di ribadire il legame della città con Apollo e con il suo santuario più famoso54, l’iniziativa di apporre sui laterizi delle figlinae statali marchi di garanzia con valore di piena ufficialità così esplicitamente connotati55.
La continuità di questa pratica nel tempo a dispetto delle complesse vicende socio-politiche di Kroton tra V e IV secolo a.C. impone all’attenzione l’equivalenza dei due simboli più ricorrenti e la possibilità concreta che essi condividessero, soprattutto nel mondo coloniale d’Occidente, quel carattere di «rappresentazione compendiaria del santuario oracolare delfico» finora ricono-sciuto solo al tripode56.
Ne deriva la necessità d’indagare brevemente l’origine dell’iconografia del delfino/’delfiniere’ per poi gettare un rapido sguar-do d’insieme ai documenti magno-greci e sicelioti che ne testimoniano la declinante fortuna tra la fine del VI e la prima metà del IV secolo a.C., data oltre la quale sembra persistere solo sulle emissioni tarantine e di area apula57.
Le stampiglie in cartiglio circolare con diametro inferiore a cm 4 sono invece ascrivibili alla seconda metà del IV a.C., ed in particolare all’ultimo venticinquennio del secolo58: probabilmente la stagione finale di funzionamento su vasta scala delle mani-fatture pubbliche di Kroton. Nella scelta dei simboli queste serie tarde rivelano una minore autonomia dalle emissioni cittadine rispetto al passato.
Ad eccezione dello swastika, infatti, trovano riscontro in piccoli bronzi di secondo periodo (405 ca. – 350 a.C.) destinati alla circolazione locale tanto l’astro radiato ad 8 e a 16 raggi59, quanto il polpo60, la testa di Atena61 e la clava62. In nessun caso, però, la stampiglia è stata ricavata direttamente dalla moneta o la imita con meditata puntualità63.
Non può vantare legami con la monetazione cittadina, invece, forse allo scopo di rimarcarne la distanza da stampiglie pregne di contenuto ideologico, l’unico bollo non figurato presente nella produzione laterizia di Kroton: quello che consiste in una E im-pressa in profondità all’interno del cerchio, con accentuato rilievo degli spazi di risulta.
A tale anomalia di ordine tecnico se ne aggiunge un’altra: in un soggetto del Deposito Comunale di Cirò Marina proveniente anch’esso dalla Carrara il marchio è impresso sulla faccia posteriore della piastra, tutti elementi che sollecitano a tenere distinta dalle altre questa stampiglia le cui dimensioni molto contenute (diam. cm 1,8) potrebbero riportare al tramonto del IV secolo a.C.64.
52 Esclusa una matrice metropolitana, M. Giangiulio avanza con prudenza l’ipotesi che l’Apollo Pizio krotoniate della prima ora possa essere connesso al Pythaeus dell’Argolide: giangiuLio 2002, p. 299.
53 Circa l’equiparazione di Pitagora, salutato esplicitamente come theios aner, ad Apollo Pizio e Iperboreo, nonché sul carattere pitico e iperboreo della cultura pitagorica, si leggano giangiuLio 1989, p. 86-89, 148-153; idem 1994, p. 22-23.
54 Apollo Pizio, titolare di un santuario urbano anteriore all’arrivo di Pitagora, era oggetto di un rituale civico forse altrettanto antico, di periodica circumam-bulazione degli altari, sul cui senso vd. deTienne 2002, p. 303. Anteriore al soggiorno in città del Samio è forse anche la dedica di un thesauros dei Krotoniati a Delfi: vd. giangiuLio 1989, p. 85-86, 158-159, con bibliografia sull’argomento. Ai ‘documenti apollinei’ di area krotoniate elencati in parra 2001, p. 231 si aggiunge un altro piccolo serpente in bronzo da scavi recenti nell’Heraion del Lacinio: vd. spadea 2005.
55 Manifestando interesse nei confronti delle attività artigianali e commerciali, i Pitagorici seguivano l’esempio del loro maestro che, figlio di un mercante e dunque ferrato in materia, è ricordato dalla tradizione anche come colui che diede ai Greci pesi e misure: vd. meLe 2005, p. 14 ss., con relativa bibliografia.
56 giangiuLio 1994, p. 11.57 Cfr. garraffo 1995, p. 149.58 La loro sporadica presenza in stratigrafie di III va ragionevolmente interpretata come residuale.59 La sola zecca di Kroton, in Magna Grecia, adotta l’astro radiato a 16 raggi come tipo principale: esso compare al D/ su trikalkoi(?) bronzei presumibil-
mente post-dionigiani che al R/ incrociano clava ed arco: aTTianese 2005, p. 279-283, nn. 75-77. Ha 8 o 16 raggi la stella che su monete divisionarie d’argento con D/ tripode e foglia è associata, al R/, al fulmine e all’aquila su colonna ionica: Ibidem, p. 284.
60 Kroton è l’unica polis magnogreca che abbia fatto ricorso al polpo sia come simbolo accessorio – stateri incusi di ‘alleanza’ con Laos datati al 510-500 a.C. ed altri leggermente posteriori che lo associano al tripode rispettivamente al D/ e al R/ (pugLisi 2004, p. 160, fig. 15 e infra, p. 16, nota n. 98) – sia, più tardi, come tipo principale: trioboli d’argento a doppio rilievo e piccoli bronzi di valore incerto che al D/ recano il tripode o la conchiglia (eadem, p. 159, fig. 2; aTTianese – sanTeLLi 2007, p. 18, fig. 2a). Quanto alle altre zecche italiote che adottano l’octopus, guarda caso tutte appartenenti a fondazioni achee, Kaulonia lo accosta al tipo della cerva al R/ in una serie di stateri d’argento a doppio rilievo datati al 480-450 a.C., mentre a Poseidonia, dopo essere stato un attributo di Poseidone su alcuni stateri incusi, esso ricorre su oboli d’argento come tipo principale, ovviamente al R/: cfr. eadem, p. 159, 161, figg. 16-17.
61 Il tipo della testa elmata di Atena di profilo a ds., già adottato per emioboli(?) bronzei di tardo V a.C. con gallo al R/, compare anche su nominali del secondo periodo: trioboli(?) con al R/ aquila stante su testa di cervo, trikalkoi(?) con al R/ civetta e ramo d’olivo, nonché dikalkoi(?) con al R/ due crescenti: aTTianese 2005, p. 125-127, nn. 10-11; 139-141, nn. 13-14; 273-275, nn. 73-74; 287-289, nn. 78-79.
62 La clava è simbolo principale al D/ su alcuni dioboli(?) con arco sulla faccia opposta e al R/ su kalkoi(?) con testa di Herakles al D/: aTTianese 2005, p. 157-161, nn. 21-23 e p. 395-397, nn. 128-129.
63 Il polpo delle monete di Kroton è piuttosto diverso da quello del bollo in uso per la marchiatura delle tegole, e così pure la clava; la testa di Atena, benché prossima a quella dei presunti trikalkoi e trioboli, non trova riscontro preciso in alcuna di tali emissioni.
64 In generale, l’interpretazione corrente delle stampiglie ad unica lettera le vuole allusive a dinamiche interne dell’officina, facendone contrassegni di sin-gole partite o identificativi della squadra di operai responsabile della produzione. In alternativa, si pensa anche a numerali utili all’assemblaggio dei manufatti al momento della messa in opera: cfr. simoneTTi 2001, p. 422.
44
Margherita corrado
4. vaLenza apoLLinea deLLe immagini deL deLfino e deL ‘deLfiniere’.
4.1 Presupposti e pluralità di significato.All’origine dell’iconografia apollinea del delfino con e senza cavaliere sta un culto arcaico a carattere oracolare: quello tri-
butato ad Apollo Delfinio. Enfatizzando il legame del dio con l’elemento marino, esso gli attribuiva la signoria sul mare e sui naviganti (marinai, armatori, commercianti, viaggiatori in genere) e ne celebrava soprattutto la sapienza mantica unita al potere di giustizia65. Nelle tracce superstiti, tale culto sostanzialmente aniconico, legato in primis al mondo greco-orientale insulare e peninsulare66, appare quasi sempre insidiato dalla fama montante della devozione delfica, già presente ad Omero67. Questa ne ha lentamente assorbito i caratteri68 e vi si richiama in modo esplicito anche nel nome, nonostante il fraintendimento dell’eziologia dell’epiclesi69 testimoniato fin dall’Inno pseudo-omerico ad Apollo70.
Nella c.d. Suite pitica, in particolare, composta in ambiente delfico sul finire del VII secolo a.C.71, l’ignoto autore canta che Apollo, subentrando a Gaia ed alle figlie di questa72 nel possesso del sito del santuario e dell’oracolo primitivi mediante l’uccisione della dracena/Pitone, prese l’aspetto di un enorme delfino per salire sulla nave dei mercanti cretesi ai quali volle affidare il suo sacerdozio e condurla senza opposizioni nel golfo di Crisa. Egli stesso impose al nuovo clero di adorarlo con l’epiclesi di Delfinio perché in forma di delfino si era manifestato loro per la prima volta e preconizzò l’eterna fama dell’omonimo altare costruito in riva al mare (Hom. Hymn. 3, 390-496). Dalla ‘sovrapposizione’ testimoniata anche nell’Inno deriva che a Mileto, ad esempio, Talete avrebbe dedicato ad Apollo Delfinio73, dio poliade titolare del superstite temenos rotondo di IV secolo a.C., quel tripode as-segnatogli due volte perché eccellente in sapienza tra i Greci che altre versioni del racconto dicono consacrato da Solone di Atene all’Apollo di Delfi74. Ad Atene, appunto, città dai forti interessi marittimi, dove in età storica il delfinio era un magistrato com-petente per alcuni casi di omicidio75 ed a primavera si celebravano feste propiziatorie della buona navigazione in nome di Apollo Delfinio, Teseo gli avrebbe sacrificato il toro di Maratona catturato una prima volta da Eracle, secondo altri offerto ad Apollo Delfico. La costruzione del tempio dedicato al Delfinio, situato nella valle dell’Ilisso non distante dal Pythion e dall’Olympieion, rimonterebbe proprio all’epoca dell’arrivo in città di Teseo76. Il padre Egeo, fondatore del santuario in questione77 ed abitante nei pressi, avrebbe anche introdotto in città, su indicazione dell’oracolo delfico, il culto di quell’Afrodite Ouranía che, protettrice del-la navigazione a somiglianza della levantina Astarte, altrove è ‘delfiniere’ anch’essa78. Orbene, le spiegazioni a posteriori proposte nell’Inno pseudo-omerico e richiamate sopra adombrano un’origine cretese del Delfinio ed un’anteriorità del culto a lui tributato sul litorale di Crisa rispetto a quello pitico stabilito alle falde del Parnaso79. Al tempo stesso, però, proponendosi di conciliare
65 La complementarietà di giustizia e mantica aiuta a comprendere perché Apollo fosse considerato l’inventore della seconda ed Aletheia la sua nutrice (Plut., Quaest. conviv., III, 9, 2): cfr. vernanT 1987, p. 17 ss.
66 L’Anatolia, sede di alcuni dei maggiori Apollonia dell’antichità – Grinio, Claro, Patara, Didima – è indiziata di essere se non la patria del dio, la regione nella quale il culto gli fu tributato prima che si diffondesse presso i Greci. Quanto al mare che bagna le sue coste e le isole circostanti, esso è anche il mezzo di una giustizia a carattere ordalico trasmessa loro in epoca remota dalle regioni mesopotamiche, altra presunta patria di Apollo, dove tale funzione era invece affidata alle acque dei fiumi: cfr. rispettivamente guThrie 1987, p. 105 ss., 245-246, e deTienne 1983, p. 20-21.
67 Iliade, IX, 401-405.68 Guardando al tema della competenza in fatto di viaggi per mare, può essere utile ricordare che a Gortina spettava ad Apollo Pizio la decima dei relitti e
dei beni di qualsiasi genere portati a riva dalle onde: cfr. deTienne 2002, p. 285, nota n. 4, con relativa bibliografia.69 Delphínios e Delphídios sono invece allusivi a consessi umani in BurkerT 2003, p. 291. Al riguardo, si veda anche deTienne 2002, p. 166 ss.70 Hom. Hymn. 3, 388-546. Circa la data di elaborazione, compresa, pare, tra il VII e l’inizio del VI secolo a.C. – per altri esegeti l’inno sarebbe stato codi-
ficato e a fine VI – vd. fränkeL 1969, p. 283.71 Cfr. anToneLLi 1994, in part. p. 41.72 Circa i rapporti di Apollo e dello zio Poseidone con Gaia, Temi e Febe si rimanda a deTienne 2002, p. 210 ss.73 Cfr. niLsson 1967, p. 554-555; deTienne 2002, p. 47. 74 Diogenes Laertius I, 64-133.75 Circa la giurisdizione di Apollo sui casi di omicidio vd. guThrie 1987, p. 228 ss. e deTienne 2002, p. 231 ss., con relativa bibliografia.76 Paus., I, 19, 1.77 Polluce, VIII, 119.78 Il culto di Afrodite dea del mare e protettrice dei naviganti – designata con le epiclesi Euploia, Pontia, Nauarchis e Acraia – è documentato nelle isole
egee di Thasos e Chio, mentre in Magna Grecia è accertato a Neapolis. A Sparta, secondo la convincente ricostruzione di Massimo Osanna, spettava ad Afrodite Areia, divinità poliade di sicura origine orientale, l’epiclesi Basilis attestata epigraficamente anche per l’Afrodite tarantina che divideva con Gaia (e forse con Satyria) il santuario arcaico ai piedi dell’acropoli di Saturo (osanna 1992, p. 4-9) e che la critica ravvisa nelle statuette di IV a.C. con dea seduta in groppa al delfino (masieLLo 2005a). A proposito del culto cretese di Afrodite e di quelli analoghi attestati nel Peloponneso grazie alla fortuna incontrata nell’Egeo, cfr. cordano 1993, con bibliografia precedente.
79 Cfr. cassoLa 2006, p. 508. In merito al legame di Apollo con Creta, e Cnosso in particolare, cfr. niLsson 1967, p. 554-555 e coLLi 1992, p. 264-265. Circa il nesso Delfi-Creta, in particolare, vd. giuman 2008, p. 220-221. Una delle tradizioni riguardanti la purificazione di Apollo e Artemide dopo l’uccisione di Pitone, quella riferita da Pausania (II, 7, 7), vuole che i due fratelli si siano recati a Creta per ottenere l’aiuto di Carmanore.
45
Bolli figurati iMpressi su tegole di V e iV secolo a.c. da Kroton: sulle tracce di apollo ‘delfiniere’
tradizioni diverse per cronologia e matrice ideologica, le legittimano e le accolgono tutte nel patrimonio ufficiale del santuario delfico, rafforzandone la vocazione panellenica. L’iconografia apollinea attestata in Magna Grecia e Sicilia a partire dal tramonto del VI secolo a.C. e qui presa in esame può ben essere considerata, in questo senso, di matrice delfica. I pochi documenti superstiti in Occidente consentono di mettere a fuoco sia il tema centrale da essa svolto – l’attraversamento delle acque, considerate in tutto il loro campo semantico – sia di identificare quelli che in età tardo-arcaica e classica sono i due ambiti di applicazione privilegiata, con le loro diverse sfumature di significato, lasciando intendere chiaramente che il ‘delfiniere’ costituisce un’aggiunta al modello archetipico del delfino scosso.
Il surplus di valore ideologico conferito all’immagine del delfino dal riconoscimento ufficiale come simbolo apollineo, e delfico in specie, potrebbe avere ispirato e reso possibile la creazione della versione evoluta, con ‘delfiniere’, avvenuta forse direttamente in ambito coloniale.
Procedendo per ordine, è necessario ricordare che per la civiltà minoica, in presenza di una radicata concezione extra-oceanica dell’aldilà, il delfino ed il polpo sono metafore dell’oltretomba e come tali ricorrono spesso nei contesti sepolcrali80. Il ruolo del ceta-ceo travalica, però, la sfera funeraria. Per la potenza conferitagli dalle sue qualità predatorie – velocità, agilità, intelligenza – infatti, esso figura tra gli animali reali e fantastici ai quali a Creta era riconosciuto il compito di intermediari o rappresentanti della divinità, che in molte raffigurazioni vediamo affiancare allo scopo di assicurarne la difesa e/o l’assistenza. A Thera ed in tutte le Cicladi, quelle stesse virtù furono credute trasmettersi magicamente agli scafi decorati con immagini di questi animali o che adottassero il delfino come emblema a prua81. Forte di tali premesse, il profondo valore simbolico già attribuito in area egea alle due creature acquatiche citate non viene meno in età storica ed anzi, esteso a tutto il mondo ellenico, di nuovo si manifesta soprattutto in ambito funerario e nel settore della navigazione marittima:
1) Il delfino è simbolo del Capricorno, la porta solstiziale detta ‘degli dei’ attraverso la quale un’antichissima tradizione vuole che le anime sottratte alla ruota delle rinascite possano raggiungere lo spazio extra-cosmico e i numi accedere al mondo degli esseri umani82; all’opposto il Cancro, che ha il suo emblema nel polpo, è la porta ‘degli uomini’.
Apollo in persona e lui solo può essere rappresentato in groppa al delfino. Lo consentono la sua innegabile dimensione ctonia, che tramite il delfino l’avvicina ad Afrodite Ouranía83, la «primogenita
delle cosiddette Moire»84, ed il dominio su Delfi: il centro/asse del mondo in rapporto al quale si compie il moto solare. Facendo di Apollo un ‘delfiniere’ si vuole alludere, perciò, alla sua signoria sul mare inteso come forma dell’aldilà e quindi «giustizia per tutti85», nonché sfruttare il potere profilattico che ne deriva. Esso spetta di diritto al delfino ma per estensione passa anche a tutti gli altri simboli apollinei, non esclusi quelli delfici meno legati alla sfera funeraria (tripode86, astro radiato, swastika, ecc.).
2) Il delfino è Apollo (o un suo sema) celebrato in quanto promotore, artefice e garante del buon esito di un movimento co-loniale diretto verso le terre del Sole calante che si compie interamente mediante viaggi per mare, imprese sulle quali gravava ben saldo, fino in età classica, «il convincimento che una buona traversata è una presunzione d’innocenza»87. La figura efebica in nudità eroica che talvolta cavalca il cetaceo e tende in avanti un braccio, priva di ali e di qualsiasi attributo, non può essere che il dio stesso, già guida privilegiata del viaggio ultraterreno in direzione dell’estremo Occidente. Essa rende più esplicito il significato dell’immagine e ripete l’associazione descritta sopra, forse preesistente.
80 Cfr. voLorio 2004, p. 69-70, con relativa bibliografia. In tempi molto più vicini a noi, il delfino è fra gli animali che per la «rapidità dei movimenti, presentano analogie con la levità e la sfuggevolezza che si ritiene caratterizzino le anime dei defunti», dunque sede di momentanee reincarnazioni: LomBardi saTriani – meLagrana 1982, p. 98.
81 Ibidem, p. 67-69, con relativa bibliografia. Sembra conservarne memoria, ad esempio, il kantharos plastico del Pittore di Boston 01.8110, fabbricato in Beozia verso il 570-560 a.C., che di fatto riproduce una nave con prua configurata a testa di cinghiale e, sulle murate, immagini dipinte di delfini associati da un lato a Tritone e dall’altro ad una coppia di sirene barbute: cfr. denoyeLLe 2003, p. 2-3, n. 47. Circa il simbolismo astrale del cinghiale, espressione del calore invernale e notturno del Sole, vd. caccamo caLTaBiano 2005, p. 115. Quanto al nesso di Tritone con Apollo, che sia Apollonio Rodio sia Erodoto, nelle rispettive versioni del viaggio degli Argonauti, basano sul tripode e sulla mantica, cfr. deTienne 2002, p. 181, 183-184, 193-194.
82 guénon 1992, p. 121, 203-211.83 Il nesso del cetaceo con questi due deî, del resto, giocando forse sull’assonanza del nome con una credibile etimologia dell’epiclesi Delfinio e del topo-
nimo Delfi – “nelle viscere/utero” – sottolinea caratteristiche che essi condividono soprattutto in età arcaica e che li mettono entrambi in relazione con Gaia. Una forte connotazione oracolare di natura ctonia sembra infatti accomunare i due ‘delfinieri’ in luoghi di remota frequentazione cultuale, e confortare l’idea che al delfino fosse attribuito un significato peculiare, allusivo al mare come distesa d’acqua navigabile solo per l’inevitabile banalizzazione del riferimento prioritario a più oscure profondità, terrestri e celesti, ed alle forze che le governano. In questo senso i delfini sono l’equivalente dei cavalli sulla terraferma, legati a Poseidone e ad altre figure mitologiche che a vario titolo hanno a che vedere con la dimensione ctonia (Dioscuri, Gorgoni, ecc.). Le stesse Muse, del resto, tanto care ad Apollo, sono figlie di Gaia in una tradizione anteriore a quella che le considera prole di Mnemosine: cfr. deTienne 2002, p. 155-156.
84 Paus. I, 14, 7 e 19, 2. 85 Solone, fr. 11 Diehl. 86 Circa il valore amuletico del tripode in rapporto all’incolumità di una città di nuova fondazione, vd. Apollonio Rodio, Argonautiche, 529-534.87 deTienne 1983, p. 22.
46
Margherita corrado
Se la breve fortuna di questa seconda variante iconografica si deve allo stret-to rapporto con un fenomeno di grande importanza storica ma circoscritto nel tempo, sulla prima pesa il progressivo affievolirsi dell’aspetto oscuro/notturno che soprattutto in età arcaica convive, in Apollo, con quello luminoso/diurno88. Il declino fu favorito senz’altro dal diffondersi di credenze relative al viaggio dell’anima che, tramontando l’originaria visione extra-oceanica dell’aldilà, ne affidavano la tutela ad altri dei – Afrodite conserva parte del suo ruolo grazie al sincretismo con Persefone, diffuso soprattutto in Occidente (Locri, Morgantina, ecc.) – e le associavano altri animali con funzione di psychopompoi89, compito invece estraneo al delfino. Il cetaceo, infatti, assiste al viaggio ultraterreno senza svolgere un ruolo attivo nei confronti delle anime dei trapassati, e tuttavia, come il polpo, ha valenza positiva90. Poiché il mare è simbolicamente «il luogo di confine della terra»91, alcuni animali marini, ed in particolare quello che evoca il supera-mento dell’ultimo confine ed il più agognato ma anche il più arduo dei passaggi da un mondo all’altro, si avvicinavano molto, in effetti, sul piano metaforico, ad esseri che tradizionalmente presidiano i pericolosi territori liminari più che accompagnare i defunti. Esseri potenti quanto temibili per questa loro familia-rità con il regno dei morti e alle cui immagini era riconosciuto un grande valore profilattico proprio a motivo di tale dimestichezza92, come dimostra la frequenza con cui le Sirene, le Gorgoni, la Sfinge e l’orrida Scilla ricorrono nella glittica dal geometrico a tutto il periodo arcaico come e più di delfini e polpi, mentre la tarda età classica segnerà, per tutti, un inesorabile declino93. Pur negando al delfino la qualifica di accompagnatore delle anime in senso stretto, trae origine dal secondo nucleo semantico dell’iconografia in esame, probabilmente, quella variante ri-corrente nelle arti figurative a partire da una data piuttosto bassa in cui il cetaceo è strumento del soccorso accordato da Apollo a chi s’imbatte in una delle molte incognite di un viaggio trans-marino, come attestano i diversi miti inerenti ad eroi in groppa a delfini94. Innegabilmente, il loro viaggio deve essere considerato pure in senso metaforico ed ai mostri che li insidiano da vicino va riconosciuto anche il valore di minaccia spirituale, cui si oppone efficacemente la rinascita che soprat-tutto i Pitagorici connettono all’opera salvifica di Apollo95 e che farà la fortuna del simbolismo del delfino riletto in chiave cristiana. Trascurando tuttavia questo aspetto, già ampiamente dibattuto in altre sedi e considerato da molti un tema autonomo96, in ogni caso relativo ad un orizzonte temporale più avanzato di quello che qui interessa, mi soffermerò ora sui primi due, ripartendo dai bolli krotoniati su tegola.
88 A causa della graduale attenuazione del suo primitivo legame con il mare, Apollo si servirà del delfino sempre meno e sarà Dioniso a vantare un nesso particolare con l’elemento acqueo, al punto da giustificarne l’assimilazione plutarchea ad Osiride: vd. coLLi 1977, p. 16. Gli stessi delfini finiranno per appar-tenere all’universo dionisiaco, più che al mondo apollineo e a quello del loro signore Poseidone (Aristofane, Equ., 560), in memoria della punizione inflitta ai pirati tirreni.
89 Cfr. cosTaBiLe – meirano 2006, con relativa bibliografia. A proposito della dimensione infera della dea, si rammentino anche Sofocle fr. 941 Pearson, 1-3 ed il fatto che Plutarco (Quaestiones Romanae 269b) menziona una festa di Afrodite Epitymbia, a Delfi, durante la quale erano evocate le anime dei defunti.
90 È stato correttamente osservato che l’antica relazione del polpo con l’idea del passaggio, e del viaggio ultraterreno in particolare, «sembra però essersi, se non perduta, quanto meno affievolita nel tempo» (pugLisi 2004, p. 164), proprio come progressivamente viene meno la significativa associazione/sostituzione del polpo al gorgoneion.
91 BregLia 2005, p. 271. 92 Le stesse considerazioni valgono per i numi insediati nei territori di confine, non escluse le rive del mare. Si vedano le osservazioni proposte in gargini
2001, p. 20 sulla scelta logistica inerente al presunto Apollonion kauloniate di Punta Stilo (infra, p. 51) e duplicata dal santuario extra-muraneo locrese dedicato invece ad Afrodite, l’altro nume ‘delfiniere’ e con spiccata vocazione marittima.
93 Cfr. Boardman 2001, nn. 288, 289, 378, 406, 407, 458, 602, (Gorgoni); n. 731 (Gorgone e delfino); nn. 317, 318, 406, 615, 721, 1040 (Sirene); n. 453 (Scilla) nn. 353, 454, 487, 580, 603, 657 (Sfinge); nn. 227, 239, 256, 258, 261, 262, 506, 755, 1018 (delfini).
94 Il più noto è senz’altro quello di Arione che, scampato all’annegamento grazie all’intervento di un delfino, fu condotto all’Apollonion di Tenaro dallo stesso cetaceo, evidentemente segno e strumento di una volontà superiore che è appunto quella di Apollo.
95 Cfr. russo 2006, p. 137-138.96 Vd. nafissi 1995, p. 293.
Fig. 16.1
47
Bolli figurati iMpressi su tegole di V e iV secolo a.c. da Kroton: sulle tracce di apollo ‘delfiniere’
4.2 Sicilia e Magna Grecia: ambiti e modi d’uso.
Per spiegare l’adozione dello stesso modello iconografico a Taranto e Crotone non occorre chiamare in causa il «legame privilegiato con il mondo lacedemone» che la città di Miscello vanterebbe fin da epo-ca pre-coloniale97. È alquanto probabile, infatti, che in età tardo-arcaica un’allusio-ne ad Apollo mediante il delfino sarebbe riuscita facilmente comprensibile in tutto il mondo coloniale, evocativa del ruolo di promozione e tutela svolto dal santua-rio di Delfi nella nascita di molte apoikiai e celebrativa di esso. Già nell’Iliade il fi-glio di Zeus e Latona è il dio che autorizza la partenza (Aphétor)98, colui che da altre fonti sappiamo presiedere ai momenti topi-ci dell’imbarco (Embásios) e dello sbarco (Ekbásios)99, separati dai pericoli insiti in ogni traversata. Quella fase delicatissima e di capitale importanza per l’esito di ogni impresa che è il suo inizio100 sta dunque tut-ta nelle mani del dio archegeta per eccellen-za101. A questa luce, con il tipo del presunto Phalanthos che attraversa il mare a dorso di delfino i Tarantini cercarono di far passare il concetto che Apollo avesse non solo indi-cato all’ecista mediante il responso oraco-lare il sito assegnato loro ma, fattosi delfino, condotto lui stesso a buon fine la spedizione dei Parteni come in passato l’imbarcazione dei cretesi102 (fig. 16.1). Analogo significato si attribuisce al delfino guizzante davanti al profilo falcato del porto di Zancle103 (fig. 17) che compare fin dal 525 a.C. ca. sulle emissioni della colonia calcidese sulla spon-da siciliana dello Stretto, promossa anch’essa dall’oracolo delfico104. Al R/ queste monete presentano la stessa conchiglia che gli stateri tarantini collocano invece nel campo sotto il delfino105, simbolo del concetto di rigenerazione spirituale tanto caro alla tradi-zione orfico-pitagorica ed utile a riconoscere nel dio che assume le sembianze del delfino o cavalca il delfino «la somma guida di un viaggio non esclusivamente terreno»106. Nelle serie monetali tarantine posteriori, la stessa spregiudicatezza generatrice del sup-
97 Braccesi 1998, p. 14. Il nesso è testimoniato dalle tradizioni inerenti ad Elena e Menelao ma anche dal periodico rituale con cui le donne krotoniati radu-nate al Lacinio piangevano la morte di Achille figlio di Teti: l’antica e potente dea dell’immensità salata celebrata dal poeta spartano Alcmane intorno al 610 a.C. (cfr. voeLke 1981).
98 Iliade, IX, 404-405; cfr. deTienne 2002, p. 179-181.99 deTienne 2002, p. 181, 185.100 Cfr. Platone, Leggi, V, 753e; Ibidem, VI, 765e; idem, Repubblica, II, 377a 12.101 Si veda, al riguardo, deTienne 2002, p. 122, nota n. 6.102 L’incarnazione del dio nel sema da lui stesso inviato non è sconosciuta alla tradizione delle apoikiai: è un Apollo-corvo, ad esempio, a guidare Batto,
l’ecista di Cirene cantato da Callimaco: cfr. ibidem, p. 115, 122, con relativa bibliografia.103 Cfr. caccamo caLTaBiano 2005, p. 113. 104 Inizialmente molto legata alla monetazione magno-greca, Zancle adotta al D/ tale emblema fino al 488 a.C., e in una serie lo ripropone al rovescio, incuso
(sTazio 1985, p. 88-89). Scacciati i figli di Anassila, nel breve periodo in cui gli Zanclei ripresero il controllo della città furono coniati tetradrammi che di nuovo recavano, al R/, il delfino e la conchiglia. Cinture di delfini ricorrono spesso, invece, sulle emissioni di Siracusa.
105 La presenza della conchiglia, che nelle società tradizionali euro-asiatiche è custode del suono primordiale e legata alle Acque intese come ricettacolo dei germi del mondo manifestato (guénon 1992, p. 125-126, 138), in questo senso cara ad Afrodite, ha fatto pensare alla volontà di rapportarsi con l’Oriente in genere ma in particolare con i porti ed il commercio fenici: cfr. caccamo caLTaBiano 2005, p. 113-114.
106 caccamo caLTaBiano 2005, p. 113.
Fig. 16.2
Fig. 17
Fig. 18
48
Margherita corrado
posto Phalanthos ‘delfiniere’ avrebbe con-sentito di sostituire allo spartiate legato ad Apollo e a Delfi l’eponimo della comunità, Taras, figlio di Poseidone e di una ninfa, e dotarlo dei più varî attributi, mentre il suo predecessore non ne possedeva alcuno (fig. 16.2). Sembra che sulla sponda occidentale del Golfo gli scrupoli a servirsi del delfino con pari ‘irriverenza’ siano stati più forti: la centralità del ruolo politico riconosciu-to ad Apollo Pizio dai circoli pitagorici107 deve avere contribuito a scongiurare una rapida desacralizzazione del tema quale si vorrebbe documentata precocemente solo a Taranto e mediante l’ascesa di un uomo, sia pure l’ecista, a quel rango di ‘delfiniere’ altrimenti riservato ai numi. Sta di fatto che i ‘delfinieri’ di V e IV secolo a.C. ricorrenti in ambiente acheo-coloniale108 non sembra-no essere ecisti, ignoti eroi o divinità mari-ne di basso rango, né alludere a Taranto o provenire materialmente da questa: si trat-ta, se mai, di personificazioni del signore di Delfi giustificate da certe sue specifiche at-titudini e competenze. I delfini possono af-fiancarlo, come al D/ degli stateri kaulonia-ti di emissione più recente109 (fig. 18), ma rimandano inequivocabilmente ad Apollo delfico anche cetacei isolati o in posizione subalterna al tripode110. A Crotone, in parti-colare, un significato apollineo fu senz’al-tro riconosciuto al delfino stampigliato sui laterizi d’inizio V a.C. già prima che ai più espliciti ‘delfinieri’, ed altrettanto accadde, probabilmente, ai suoi omologhi kauloniati di cronologia più bassa, ascritti di recente in toto ad una data posteriore alla conquista
Fig. 19
107 Essa è pari solo a quella accordata al Delfinio a Drero nell’VIII-VII a.C. ed a Mileto un secolo più tar-di: cfr. deTienne 2002, p. 168-169.
108 Si allude, per quanto attiene a Kaulonia, esclusi-vamente al tipo documentato dall’antefissa dalla collina del Faro, poiché del bollo con figura maschile su delfi-
no menzionato in guzzo 1988, p. 471 non c’è riscontro nelle rassegne complete edite di recente. L’anomalia potrebbe dipendere da una sfortunata contamina-zione con i dati relativi a Kroton.
109 noe 1958, p. 14 ss., 50 ss., tav. XIV, gruppo J. I cetacei fanno corona ed aiutano ad identificare un Apollo che avanza recando un ramo di quell’alloro di Tempe con cui, purificato dall’assassinio di Pitone grazie al periodo di servitù impostigli da Zeus (Plutarco, De defectu oraculorum, 21, 421 C; Eliano, Storie varie, III, 1), secondo Pausania fu intrecciato il primo tempio di Delfi (Pausania, X, 5, 9). Sull’argomento, vd. deTienne 2002, p. 44, nota n. 4, e p. 259-262, nonché il recente suggestivo contributo proposto in adornaTo 2007. Circa l’appartenenza dell’alloro di Delfi alle tradizioni riguardanti gli alberi sacri diffuse presso tutte le società tradizionali, cfr. de sanTiLLana – von dechend 2006, p. 578. Circa la successione dei templi nel santuario delfico, vd. giuman 2008, p. 199 ss., con bibliografia precedente.
110 È il caso del delfino che compare nel campo a destra al R/ di certi stateri krotoniati incusi databili sullo scorcio del VI secolo, associato talvolta al polpo (fig. 19) (aTTianese 1992, p. 47-48, nn. 34-37; SNG Brutttium, p. 78, tav. XXXI, n. 380). Ritorna, il cetaceo, sempre a destra ma rivolto verso il basso, anche al D/ di stateri coniati intorno alla metà del V secolo, con ruota a quattro raggi sulla faccia opposta (guzzeTTa 1983, tav. 24, n. 53).
Fig. 20.1 Fig. 20.2
49
Bolli figurati iMpressi su tegole di V e iV secolo a.c. da Kroton: sulle tracce di apollo ‘delfiniere’
siracusana del 389 a.C.111 (figg. 20.1-2). Tale significato potrebbe avere influito, peraltro, sulla scelta degli import models attici nella città di Miscello112, orientan-dola anche in direzione delle teorie di cetacei113, mentre a Kaulonia il sospetto di un’importazione ‘mirata’ riguarda un’arula di presunta fabbrica tarantina con coppia di delfini saltanti rinvenuta a nord della collina del Faro114 (fig. 21). È soprattutto la precoce fondazione del santuario che nel tardo V riceverà antefisse con ‘delfiniere’115, però, a testimoniare l’antica devozione locale nei confronti di un nume protettore dei naviganti in cui sarei tentata di riconoscere lo stesso Apol-lo che ai cretesi appena approdati nella Focide aveva innanzi tutto ordinato, prima di ascendere il monte alla volta del santuario, di costruire un altare sulla riva del mare116 e compiervi un sacrificio in suo nome (Hom. Hymn. 3, 490-492). Se a tale comportamento era attribuito valore esemplare, tant’è che l’autore dell’Inno lo riconduce ad un ordine esplicito del dio, si potrebbe supporre che sia la piccola area sacra in cima alla collina del Faro sia quella sita a sud-est delle sue pendici meridionali, prossima dalla battigia, fossero dedicate ad Apollo117, e lo fossero per avere accolto gli altari innalzati in suo onore come gesto fondante della nuova comunità118. Nel temenos inferiore si potrebbe allora identificare il luogo fisico dell’approdo dei coloni119. La presa di possesso della collinetta retrostante, impor-tante per la sua posizione ed altimetria, s’immaginerà contestuale e sancita con i medesimi strumenti120.
111 Un’ampia analisi delle interpretazioni finora proposte per i piccoli bolli in rilievo di Kaulonia con delfino (rivolto a sn., in cartiglio circolare) e con presunte abbreviazioni demotiche locresi associate al delfino (rivolto a sn. o a ds., in cartiglio quadrangolare) è reperibile in simoneTTi 2001b, p. 430-432, n. 31; 439-440, n. 49. Respinta la tesi che ne faceva l’emblema di una magistratura locale forse di carat-tere sacro (de franciscis 1960, p. 417-418), la studiosa ha suggerito di pensare ad un culto collegato al delfino. Ha inoltre ipotizzato che il proprietario di un’officina dedita alla produzione di manufatti per il santuario presso il Faro marchiasse i suoi prodotti con l’immagine del delfino associata all’abbreviazio-ne (ΠΟΛ) del proprio nome: simoneTTi 2001b, p. 427, 439, con bibliografia precedente.
112 giudice – giudice – giudice 2005, p. 87-90.113 Informazione ed ipotesi del dottor A. Ruga, formulata sulla base di dati inediti. Al contrario,
argomentando però ex silentio, l’assenza di qualsiasi elemento materiale e iconografico riconduci-bile al delfino in uno dei maggiori Apollonia della Crotoniatide, quello di Punta Alice a Cirò Marina, potrebbe dipendere dall’origine non delfica dell’Apollo Aleo, affine a quello anatolico di Patara. Non escluderei che l’oracolo di fondazione della polis menzioni la ‘sacra Krimisa’ in luogo del vicino santuario, importante caposaldo geografico-religioso, non tanto per sottolineare l’anteriorità a quello dell’abitato – una delle città fondate da Filottete – ma espressamente per non citare un Apollo più antico e di risaputa origine non delfica, anzi geograficamente e culturalmente più prossimo agli avversari dell’eroe tessalo. Circa l’estraneità dell’ambiente culturale acheo alla fondazione del culto, cfr. giangiuLio 1996, p. 255.
114 simoneTTi 2001a, p. 385-386, n. 103, figg. 396-397, con bibliografia precedente. Tra le altre testimonianze iconografiche si segnala la piccola lamina bronzea dagli scavi dell’abitato (fig. 22) proposta, ad esempio, in agosTino 2002, p. 12.
115 Paolo Orsi definisce il manufatto ora «testa, fronte rettangolare di καλυπτήρ» ora «cippo terminale»: orsi 1891, p. 61 ss., idem 1914, col. 779, fig. 45.116 Anche l’altare di Apollo citato in Apollonio Rodio, Argonautiche, I, 359, 403-404; II, 689, 927 è «sulla riva» (epáktios).117 Già formulata dall’Orsi, ma in seguito accantonata a favore di altre interpretazioni (cfr. BareLLo 1995, p. 109-110, con bibliografia precedente), l’ipo-
tesi è stata riproposta recentemente, sia pure con estrema cautela: cfr. parra 2001. Il piccolo luogo di culto ellenistico indagato negli ultimi anni poco a sud dell’area del tempio dorico, in località Casa Matta, per la vicinanza a quest’ultimo, la posizione altrettanto liminare e la probabile pertinenza ad Asclepio (ianneLLi c.d.s.), il semi-dio medico che spesso condivide lo spazio riservato al padre, può a sua volta costituire un indizio a favore dell’idea dell’Apollonion. Un’iscrizione di fine VII o inizio VI a.C. rinvenuta nel santuario, che sembrava menzionare i venti (parra 2001, p. 235, con bibliografia precedente), poteva essere messa in relazione con il controllo esercitato su di essi da Apollo allo scopo di dirigere a suo piacimento la nave cretese lungo una rotta innaturale (Hom. Hymn. 3, 420-421). Apollo è del resto invocato perché susciti un vento propizio all’imbarcazione anche da Apollonio Rodio (Argonautiche, I, 423-424). L’iscrizione kauloniate ha tuttavia ricevuto, di recente, un’interpretazione del tutto nuova, proprio mentre alcune tracce rituali venivano accentuando il peso della componente femminile, legata soprattutto ad Afrodite: cfr. parra 2007, in part. p. 12.
118 Manufatti di fine VIII – inizio VII secolo attestano la precoce frequentazione dell’area costiera: parra 2001, p. 221.119 Il paragone con la consacrazione dell’altare di Apollo Archegeta sul litorale in prossimità della nascente Naxos (Tucidide, VI, 3, 1) s’impone: cfr. deTien-
ne 2002, p. 132-133, con relativa bibliografia. Quanto al Capo Cocinto della tradizione, vd. faceLLa 2001; fioravanTi 2001, p. 39-40, con relativa bibliografia; de sensi sesTiTo 2007, p. 320-321.
120 Saremmo di fronte, se così fosse, ad un unico grande spazio sacro pianificato fin dalla nascita dell’apoikia nella misura in cui la costruzione, subito dopo lo sbarco, di altari ove sacrificare al dio che aveva presieduto all’impresa della traversata e si accingeva a sovrintendere con pieno diritto a quella della fonda-zione ex novo della città, era considerato presupposto irrinunciabile per il completamento di un rituale codificato in ogni dettaglio allo scopo di assicurarsi una nascita legittima e «armoniosa» (deTienne 2002, p. 124).
Fig. 21
Fig. 22
Fig. 23
50
Margherita corrado
I due temenoi rinnoverebbero, se così fosse, lo sdoppiamento proprio del santuario madre, salvo invertire il rapporto gerarchico alto-basso per il condizionamento esercitato dalla morfologia dei luoghi. Il secondo, infatti, grazie alla maggiore ampiezza e regolarità della superficie, nel terzo quarto del V secolo fu oggetto di una monumentalizzazione im-pensabile, invece, per il sacello sulla collina. Quest’ultimo, pur costretto a mantenere di-mensioni modeste ed una fisionomia di stampo tradizionale, sembra essere stato dotato di un sistema di rivestimento sostitutivo del vecchio tetto ‘a corna’ di prima metà VI a.C.121 guarda caso nello stesso periodo. Gli appartiene, probabilmente, la piccola antefissa pen-tagonale (20x12 cm ca.) di cui conosciamo un solo esemplare, con decorazione plastica figurata di altissimo valore semantico (fig. 23). L’oggettiva somiglianza con l’immagine del ‘delfiniere’ nota dalle monete di Taranto e dalle statuette di IV a.C. provenienti da Sa-turo122 ci mette infatti di fronte ad un’antefissa che, se fosse di matrice tarantina, rappresen-terebbe senz’altro l’eroe eponimo della città dorica. In tal caso, sarebbe difficile credere ad un fraintendimento del significato da parte dei Kauloniati, come pure alla volontà di ono-rare un personaggio estraneo alla tradizione locale. Nel mondo delle colonie italiote e si-celiote poste lungo la rotta di attraversamento dello Ionio, capisaldi dell’intero movimento coloniale promosso e diretto dal santuario di Delfi, qualsiasi figura efebica in nudità eroica
cavalcasse un delfino, tranne che dotata di ali, doveva tuttavia rimandare ad Apollo ed alla sua antica competenza in fatto di viaggi per mare123. A riprova di ciò, nei secoli VI e V a.C. la connotazione tarantina non fu capace di prevalere sul consolidato carattere sopranazionale ed intimamente apollineo dell’immagine o di distorcerlo. Se l’antefissa kauloniate fosse invece un prodotto dei co-roplasti di ambiente acheo124, lo scarso peso dato da costoro all’inevitabile confusione con l’emblema di Taranto parla anch’esso a favore di una notevole antichità e di un significato panellenico dell’iconografia in esame. L’ipotesi non è nuova, del resto, nell’an-noso dibattito sui delfinieri tarantini125, ma acquista nuovo credito alla luce dall’inedita documentazione di Kroton e dal ripensamen-to di quella di Kaulonia. L’identità del ‘delfiniere’ apparso per la prima volta a Taranto sul R/ della seconda emissione di stateri in-cusi126 va dunque rimessa in discussione. Solo l’abitudine ad una lettura a senso unico delle fonti, infatti, peraltro tutte tarde127, ci dice che il personaggio poi sostituito da Taras è Phalanthos. Solo Taranto, inoltre, tra le apoikiai di Magna Grecia e Sicilia, avrebbe accolto il proprio ecista storico sulle monete in epoca così precoce, consentendogli di disarcionare il nume archegeta e ‘delfiniere’ per antonomasia sì da fare del cetaceo la propria cavalcatura128. Il cambio di rotta per cui, dopo circa vent’anni dall’apertura della
Fig. 24
121 Cfr. BareLLo 1995, p. 19 ss.; idem 2005.122 masieLLo 2005b.123 “Salvatore di navi” lo appella Apollonio Rodio in Argonautiche, II, 927. L’idea di un Apollo delle sponde del mare ventilata in deTienne 2002, p.
308, preesistente e indipendente dal nume delfico della colonizzazione, trova un riscontro preciso, lungo la costa ionica calabrese centro-meridionale, nel sito dell’Apollonion di Punta Alice presso Cirò Marina (KR), ed uno più evanescente nel temenos di Apollo che alcuni reperti segnalano a Capo Colonna in relazione con l’insenatura posta subito ad sud-ovest del celebre Heraion, in località Quote Cimino. Ancora più ad ovest, sul terrazzo di Punta Scifo, la scala esterna della torre d’avvistamento seicentesca (proprietà dei Lucifero dal 1864) è adorna di reperti di età greca e provenienza ignota ma in gran parte subacquea. Tra le eccezioni, spiccano un’antefissa arcaica a protome gorgonica (fig. 24) e vari esempi di vasellame miniaturistico che potrebbero suggerire l’esistenza di uno spazio sacro anche su questa punta ‘minore’ un tempo più prominente di quanto sia oggi. Circa sei miglia marine a sud del Lacinio, poi, a Capo Cimiti, tenui indizi fanno collocare il santuario di Zeus Meilíchiios: di nuovo una divinità dalla duplice natura, celeste e ctonia, anch’essa protettrice, tra l’altro, dei viaggi e della navigazione (Senofonte, Anab. VII, 4-5). Qui il famoso atleta Faillo, più volte vincitore dei giochi pitici, consacrò il noto ceppo d’ancora appartenente forse alla trireme con cui aveva preso parte alla battaglia di Salamina del 480 (vd. Lazzarini 2005). In merito, poi, al presunto culto dei Dioscuri sul poco più meridionale promontorio di Capo Rizzuto, presidiato da entità sovrumane come tutti gli altri terrazzi del litorale crotonese a causa della loro indubbia importanza per la navigazione ma anche dell’oggettivo pericolo da essi rappresentato in condizioni meteo-marine avverse – il Lacinio segnava il limite nord del navifragum Scylaceum (Verg., Aen. III, 552), chiuso a sud dal Capo Cocinto – cfr. infra, nota 139. Non va dimenticato, in fine, che collocando l’isola di Ogigia nelle acque antistanti il Lacinio, alcuni geografi antichi accolgono l’avita tradizione che riconosceva proprio nella costa orientale calabrese l’estremo Occidente, tradizione anteriore alla stabilizzazione della presenza greca lungo il versante tirrenico della Penisola: cfr. Braccesi 1993, p. 17-18, con relativa bibliografia.
124 Circa la lastra pentagonale come forma standard dell’antefissa krotoniate fin dall’età arcaica, cfr. aversa 2005, p. 73, 76, e da ultimo idem c.d.s., che inoltre respinge l’ipotesi di un prodotto di bottega locrese avanzata in merTens horn 1994, p. 242-252.
125 Cfr. garraffo 1995, p. 148-149 e nafissi 1995, p. 291-299. 126 Cfr. garraffo 1995, p. 147-149.127 L’apparizione niente affatto precoce, nelle fonti, dei naufragi di Phalanthos nel golfo di Crisa (Paus. X, 13,10) e di Taras durante il viaggio da Sparta in
Italia (Prob., Verg. Georg. II, 197 ss.) potrebbe indicare una nascita tardiva di queste tradizioni. 128 A favore dell’idea di un fraintendimento moderno potrebbe giocare anche il famoso donario di Onatas offerto dai Tarantini a Delfi per celebrare la vit-
toria sugli Iapigi. Il Lacroix, fra i pochi a tentare di confutare la tesi corrente, riconosceva nel solo delfino raffigurato accanto a Phalanthos e Taras, appiedati, il simbolo della città: cfr. garraffo 1995, p. 148, nota n. 22, con bibliografia precedente; altri lo credono piuttosto un attributo di Phalanthos: nafissi 1995, p. 255, 308-311.
51
Bolli figurati iMpressi su tegole di V e iV secolo a.c. da Kroton: sulle tracce di apollo ‘delfiniere’
zecca, i Tarantini rinunciarono all’uso esclusivo della loro prima scelta – lo Hyakinthos di Amicle129 – a favore di un parasemon apollineo di respiro più ampio, presto trasferito dal rovescio al diritto e destinato a diventare «la costante tipologica della moneta-zione tarantina in argento di taglio più grosso»130, verosimilmente li vide muovere dal desiderio di assicurarsi il prestigio garantito dall’atto di instaurare o ribadire un rapporto privilegiato con il santuario delfico. È significativo che per farlo abbiano adottato quel-la che in ambito numismatico, sul finire del VI secolo, altre apoikiai del versante ionico di Magna Grecia percepivano come un’op-zione secondaria o disconoscevano del tutto. Crotone le aveva infatti preferito il tripode131 e Caulonia la riproduzione, forse, di un agalma di Apollo Pizio132, mentre Sibari e Metaponto, nel valorizzare i presupposti sacrali delle loro città, diedero spazio al sostra-to preellenico, legato soprattutto al problema dell’approvvigionamento idrico, invece di scegliere simboli con implicazioni delfi-che133. La scelta del delfino, compiuta prima dagli Zanclei e poi dai Tarantini, che per differenziarsi vi aggiunsero il ‘delfiniere’, ha forse origine dalla volontà di sottolineare la vocazione marittima ed emporica delle due città, dotate di ottimi porti ed impegnate principalmente in attività economiche legate al mare e alla navigazione. Non doveva dispiacere loro la scelta di Apollo, richiamata dall’immagine in questione, di assumere dei mercanti cretesi, marinai provetti per eccellenza134, come officianti del suo santuario più celebre. L’implicita promozione, però, di una categoria che in patria godeva dello scarso prestigio sociale riconosciuto indistin-tamente a quanti praticavano arti e mestieri, non sfuggì agli italioti e probabilmente condizionò le scelte delle altre apoikiai. Anche Kroton e Kaulonia disponevano infatti di approdi, sia pure stagionali e non altrettanto capaci di quelli tarantini, anzi la prima aveva costruito su di essi la propria fortuna135. Il regime oligarchico che all’epoca dell’attivazione della zecca (530 a.C. ca.) governava una città in cui, senza essere esclusive, fervevano le attività commerciali a lungo e lunghissimo raggio, le stesse che in quegli anni vi condussero Pitagora136 e che testimoniano di un precoce dinamismo sociale, decise perciò di assumere per le proprie monete un ri-chiamo alla sfera pitica più tradizionale, consono al proprio orizzonte di classe e privo del carattere potenzialmente ‘eversivo’ im-plicito nel delfino/’delfiniere’. Per Kaulonia è ragionevole postulare una situazione politica e socio-economica analoga, tale da giustificare scelte simili a quelle di Kroton137. A distanza di qualche decennio appena, in un quadro politico e sociale in rapida evo-luzione, la stessa iconografia trova tuttavia posto nei rivestimenti fittili delle due città. Ciò consente di cogliere ed apprezzare altri elementi di quella pluralità di significati che è peculiare dei simboli. L’antefissa kauloniate, per cominciare, se pensata espressamen-te per l’area sacra dove si venerava il nume delfico regista della spedizione coloniale, comprensibilmente non evoca il dio che s’impadronisce del santuario e dell’oracolo preesistenti mediante l’uccisione di Pitone ma quello che, appena toccata terra e smesse le spoglie del delfino, invita ad erigere un altare e dà disposizioni precise per il sacrificio, gesti intrinseci all’atto di fondare ab ovo, sia che si tratti di un santuario sia di una città138. Non il tripode, perciò, ma il ‘delfiniere’. Quest’ultimo è altresì più adatto a ribadi-re l’antica responsabilità di Apollo nei confronti dei viaggiatori per mare, coloni compresi, ruolo che a Delfi spetta anche ai Dioscu-ri139 ed anzi giustifica il favore incontrato in Occidente dai due cavalieri divini, sovente riprodotti negli acroteri dei templi in omag-gio alla convinzione che apparissero sugli alberi delle navi e sui tetti delle costruzioni che intendevano proteggere140. Se in età sto-rica Apollo delfico condivideva con i figli di Leda la funzione profilattica nei confronti dei vascelli in navigazione, perché la capa-
129 Cfr. garraffo 1995, p. 147.130 Ibidem, p. 149.131 Sia la scelta del tripode, strumento per far mostra di uno speciale legame ideologico-religioso col santuario, sia l’elaborazione della tradizione relativa
alla ktísis, entrambe preesistenti a Pitagora, vanno lette «in relazione alla strutturazione di un’identità comunitaria in un contesto di potenziamento del rilievo di Crotone nell’ambiente acheo»: giangiuLio 1994, p. 25.
132 La connotazione pitica della figura è stata di recente evidenziata in parra 2001, p. 238-239.133 Potrebbe doversi interpretare come una ‘contromisura’ il prezioso donario metapontino a Delfi che gli storici assegnano a fine VI – inizio V sec. a.C.:
giangiuLio 1994, p. 10, con relativa bibliografia.134 Sul significato dell’origine acheo/cretese dell’ecista Miscello, vd. marino 2005.135 Polyb. X, 1. 136 Cfr. meLe 1992, p. 26; idem 2005. La precoce apparizione del polpo come tipo principale e come simbolo accessorio sulle monete di Kroton, scelta per
nulla comune in Magna Grecia e Sicilia nello stesso periodo (cfr. supra, nota 39), trova invece riscontro proprio nel mondo greco ed orientale coevo: vd. pugLisi 2004, p. 160-161.
137 Come ha mostrato di recente Alfonso Mele, la tradizione pitagorica che imputa la proverbiale dissolutezza dei Sibariti alla mancanza di porti con cui convogliare all’esterno parte dei beni prodotti invece di destinarli all’autoconsumo è un sintomo del superamento precoce, in ambiente krotoniate, del tradi-zionale disprezzo della maggior parte dei Greci per il lavoro manuale, e dunque per le attività artigianali e commerciali, preconcetto accantonato con maggiore facilità nelle città a totale o parziale vocazione emporica, ma che la legittimazione datane da Platone in aperta polemica col pitagorismo dimostra essere stato assai tenace: meLe 2005, p. 15-18.
138 Cfr. deTienne 2002, p. 131 ss. 139 Anch’essi sono deî della partenza: cfr. deTienne 2002, p. 180, nota 3.140 Cfr. merTens horn 1999; parra 2001, p. 230; eadem 2005a, p. 35-36; eadem 2005b, p. 278. A proposito del toponimo Dioskouriás conservatoci in
Diodoro 13, 3, 4 e attribuito dalla critica all’odierno promontorio di Capo Rizzuto (KR), presunta sede dei Dioscuri nella loro qualità di protettori di navi (Hom. Hymn. 33, 7 ss.) in quanto riconosciuto limite fisico tra il Golfo di Taranto ed il mare Siculo, vd. Braccesi 1996, p. 63 ss., con relativa bibliografia.
52
Margherita corrado
cità apotropaica ereditata dal Delfinio lo metteva in grado di allontanare l’impurità e con essa il male che ad un tempo la provoca e ne deriva141, è probabile che fosse parimenti in condizione di tutelare gli edifici su terraferma, come richiesto dal suo ruolo di dōmatîtes con specifica competenza sulle soglie e, forse, sulle coperture142. Senza voler mettere in discussione la prioritaria finalità pratica della marchiatura delle tegole143, la scelta di as-sociare l’immagine del delfino/‘delfiniere’ ad elementi di rivestimento dei tetti potrebbe trovare spiegazione nel fatto che, per l’ambiguità naturalmente connaturata al divino in ogni società politeista, tale che Apollo è lo Splendente e il Diritto ma anche l’Oscuro e l’Obliquo144, a quest’immagine, benché appartenesse ad un olimpio, si attribuiva un pote-re in qualche modo affine a quello del gorgoneion145. Prefigurare con un simile espediente l’agognata sollecitudine del dio architetto dalle parole efficaci146 nei confronti dell’edificio così rivestito significava, dunque, evocarla con forza ed in certa misura potere già contare su di essa. Palesarla o meno all’osservatore, a seconda che pensiamo alle antefisse o ai piccoli bolli su tegola, ovviamente invisibili da terra, faceva invece poca differenza.
4.3 Un donario tarantino con Apollo ‘delfiniere’ a Rossano di Vaglio (PZ)?Il significato apollineo attribuito al delfino/‘delfiniere’ in età
tardo-arcaica e classica in alcune città italiote del versante ionico fu probabilmente condiviso nell’intera area del Golfo di Taran-to, entroterra compreso, anche grazie alla precoce diffusione dei circoli pitagorici147. Questi ultimi dovevano avere una particola-re familiarità con simili raffigurazioni di sperimentato carattere delfico. Un tenue indizio in tale direzione si rinviene lasciando il settore dei prodotti laterizi per guardare ad esperienze artistiche più alte. È recente il ritrovamento, lungo la via sacra fiancheg-giata da donari che corre all’esterno del vano porticato ovest (il c.d. ambiente IV) del santuario di Mefitis a Rossano di Vaglio (PZ)148, nella Lucania interna, di una lamina in bronzo lavorata a sbalzo, con rifiniture a cesello, fissata mediante ribattini ad un perduto supporto in materiale deperibile, forse un carro o una cista149 (fig. 25). L’ampia lacuna centrale del manufatto, datato entro i tre decenni iniziali del IV secolo a.C., giustifica i dubbi circa l’identità di genere, prima che personale, del ‘delfiniere’ raffigurato. Accantonata l’ipotesi preliminare che vi riconosceva Anfitrite, sono stati portati argomenti sia a favore dell’identificazione con una Nereide sia con Taras150. La posizione (a caval-cioni) e la completa nudità, come pure la morfologia delle porzioni superstiti del corpo, che ha tratti adolescenziali di necessità piuttosto ambigui, non lasciano dubbi sul fatto che si tratti di un personaggio maschile. Nella piccola plastica di IV sec. a.C.,
Fig. 25
Fig. 26.1 Fig. 26.2
141 Cfr. cassoLa 2006, p. 79-81. Tale è a Cirene, nel IV sec. a.C., l’Apollo «davanti alle porte», e l’omologia tra le porte urbiche e quelle delle abitazioni non sfuggiva agli antichi: cfr. deTienne 2002, p. 165 e p. 166, nota n. 1.
142 Il fatto che Apollo sia stato spesso onorato con l’offerta ai suoi templi di intelaiature e coperture di particolare complessità e monumentalità, dato di cui fa fede Omero per primo (Iliade, I, 14) e che nel dono degli Alcmeonidi al tempio di Delfi ha l’esempio più celebre (Pindaro, Pitiche, V, 42-46), sembra essere la spia non solo del suo «gusto innato per le costruzioni monumentali» (deTienne 2002, p. 48) ma di una riconosciuta competenza del dio in materia di tetti. È dal tetto, perciò, che egli esercita la propria tutela sull’intero edificio.
143 Cfr. supra, p. 38-39.144 deTienne 1983, p. 54. Una eco di tale ambivalenza si coglie, ancora una volta, in ambito numismatico: cfr. caccamo caLTaBiano 2005, p. 119-120.145 Si veda vernanT 1987, p. 39 ss. 146 Cfr. deTienne 1983, p. 38-39.147 A proposito della relazione tanto stretta quanto precoce dei Lucani, in particolare Ocello e Aresa, con il pitagorismo krotoniate, vd. meLe
1991, p. 65 ss.148 Circa l’uso dei vani circostanti il sagrato come luoghi di deposito ed esposizione delle offerte più pregevoli si vedano de paoLa – sarToris 2001, p. 26-
28, fig. 20; nava – cracoLici 2005, p. 112.149 russo 2006, p. 143.150 Cfr. nava 1999, p. 706 , eadem 2003, p. 93; nava – cracoLici 2005, p. 107, fig. 8 (Anfitrite); russo 2006, p. 143-146 (Nereide/Taras).
53
Bolli figurati iMpressi su tegole di V e iV secolo a.c. da Kroton: sulle tracce di apollo ‘delfiniere’
che annovera figure femminili e maschili su delfino, le prime, qua-si sempre abbigliate e velate, siedono invariabilmente sulla schiena dell’animale151 mentre le seconde, nude, lo cavalcano (figg. 26.1-2). Nella pittura vascolare italiota, invece, qualsiasi figura muliebre, sia essa Afrodite o una Nereide, costantemente panneggiata – solo la Pandemos indossa un himation che lascia anteriormente scoperto il busto152 – piuttosto che cavalcare si aggrappa alla pinna dorsale del cetaceo (fig. 28.1) o, più di rado, gli siede in groppa153 (fig. 28.2). Se il reperto da Rossano di Vaglio non è frutto di una razzia154, l’identi-ficazione del ‘delfiniere’ con Taras, e l’interessante ipotesi che vede nel manufatto un ex voto dedicato nel santuario federale delle gentes lucane dalla Taranto di Archita, desiderosa di sottolineare le comuni origini di Tarantini e Lucani grazie alla genealogia che ne faceva il padre di Italo155, non escludono che si sia scientemente voluta offrire una duplice possibilità di lettura dell’immagine anche in relazione al grado di dimestichezza dello spettatore con la tradizione tarantina e con il pitagorismo, al quale lo stesso Archita è notoriamente legato. Nel ‘delfiniere’ si potrebbe infatti continuare a riconoscere Apollo invece di Taras, o quantomeno percepire un’ambiguità premeditata. La capigliatura del personaggio ha del resto carattere apollineo – efebo alle soglie dell’età adulta, Apollo è di norma akersekomas156 – e sovrumana è la sobrietà con cui porta in avanti il braccio destro nell’atto di reggere una phiale mesonfalica baccellata, attributo di norma estraneo all’eroe eponimo tarantino e strumento privilegiato di libagione157. Alla congerie di divinità già attestate a Rossano di Vaglio grazie ai
Fig. 27 Fig. 28.1
Fig. 28.2
151 A lungo assegnate alla ninfa madre dell’eponimo Taras nella convinzione che la peculiare cavalcatura fosse una prerogativa di famiglia, le statuette da Saturo con dea su delfino sono oggi più correttamente paragonate a certe terrecotte locresi raffiguranti Afrodite (fig. 27): cfr. arena 1997, p. 279-280, figg. 5-6 (Taranto), 8 (Locri), con relativa bibliografia.
152 TrendaLL – camBiTogLou 1982, p. 919, tav. 356, nn. 1-2.153 Esempi del primo caso sono reperibili, fra gli altri, in TrendaLL – camBiTogLou 1982, p. 418, tav. 152, n. 4 e p. 607, tav. 233, n. 5, nonché TrendaLL 1989,
p. 88, fig. 198; di paLo 1993, fig. a p. 33; russo 2006, fig. a p. 145. Esempi del secondo sono illustrati in TrendaL – camBiTogLou 1961, p. 13, tav. III, n. 14 e TrendaLL – camBiTogLou 1982, p. 919, tav. 356, nn. 1-2. Un Eros ‘delfiniere’ nudo, a cavalcioni, armato di tridente, è in TrendaLL – camBiTogLou 1982, p. 977, tav. 382, nn. 5-6.
154 Una simile eventualità risolverebbe la discrepanza tra l’idea che il manufatto, assegnato dalla Russo al primo trentennio del IV sec. a.C., sia stato realizzato appositamente per il santuario e la convinzione che monumentalizzazione e lo sviluppo di quell’importante luogo di culto sorto «in un’area non abitata e non destinata a qualche altro monumento in precedenza» non siano anteriori alla metà del IV: adamasTeanu – diLThey 1992, p. 78-81; adamasTeanu 1998, p. 51.
155 russo 2006, p. 145-146. 156 Ibidem, p. 143. Anche gli “anelli di Venere”, presenti sul collo del ‘delfiniere’ di Rossano di Vaglio, sottolineano spesso la bellezza femminea del giovane
dio, come dimostra ad esempio la testa marmorea di Apollo dell’acrolito del santuario di Punta Alice a Cirò Marina (KR): cfr. giusTozzi 2005, p. 262.157 Circa la dedica tarantina di una phiale in argento con ‘delfiniere’ al santuario di Apollo a Delo, vd. nafissi 1995, p. 295, 304-305. In generale, la patera
umbilicata è attributo comune di molte divinità maschili e femminili, sia celesti sia ctonie. Nella coroplastica tarantina, soprattutto in età tardo-classica ed ellenistica, essa ricorre nelle raffigurazione dei Dioscuri e del presunto Hyakinthos. Circa la phiale come attributo costante dell’Apollo Alaios di Punta Alice (KR), si rimanda da ultimo a giusTozzi 2005, p. 261, con bibliografia precedente.
54
Margherita corrado
documenti epigrafici158, alcuni doni votivi di pregio come il ramo d’alloro in bronzo e le cinture in argento chiuse da un fermaglio anguiforme trovate negli ambienti III e IV159, una delle quali arricchita da lamine auree con teste di Helios radiato, potrebbero suggerire l’opportunità di aggiungere le Muse o Apollo in persona160, preferendo forse l’Apollo ‘delfiniere’ perché più consono al carattere ctonio di Mefitis e del suo santuario.
4.4 Tegole bollate nell’edilizia funeraria di Kroton e Kaulonia.L’idea di un dio partecipe dei due mondi, celeste ed infero161, creduto anzi «l’unico ponte» tra loro162, rende possibile un altro
interessante fenomeno che, coinvolgendo i laterizi bollati di Kroton e forse di Kaulonia oggetto di questa ricerca, conferma il valore amuletico riconosciuto innanzi tutto alle stampiglie con delfino/’delfiniere’163.
Poiché le tegole piane erano destinate principalmente a rivestire i tetti degli edifici a scopo di copertura e abbellimento in-sieme164, la protezione divina era invocata principalmente per i vivi. Parte dei laterizi, però, entra nella costruzione di strutture funerarie, che perciò possono restituire anch’esse tegole bollate. A Crotone, dove quasi non esistono tombe in materiale diverso165, la percentuale di quelle che contano almeno un esemplare con bollo è senz’altro piuttosto bassa. I pochi dati disponibili adombra-no, tuttavia, l’abitudine ad una selezione dei manufatti messi in opera nelle architetture funerarie dettata da ragioni ideologico-religiose invece che di ordine meramente pratico.
Se la singola tegola non suscita particolari sospetti, non altrettanto agevolmente si può rendere ragione della presenza di due laterizi bollati nello stesso sepolcro. Così accade per le stampiglie in negativo con Apollo ‘delfiniere’ di una tomba della chora Sud di Kroton: la n. 2 del sito 17 di Isola di Capo Rizzuto - Ronzino, risalente forse alla prima metà del V a.C.166, o per quelli con swastika o con tripode di alcune tombe della Carrara dove pare che i laterizi bollati fossero talvolta tre167. Caso limite è la tomba C della stessa necropoli, situata nel settore indagato nel 1984, dove ben sei tegole con identiche caratteristiche del corpo ceramico recavano il piccolo marchio raffigurante la clava.
Da Kaulonia non sono finora segnalati casi simili ma la presenza di tre tegole con bollo di sicura origine kauloniate nella tom-ba n. 432 di Lipari, oggetto di ampio dibattito168, s’inquadra forse nello stesso fenomeno e dimostra meglio di ogni altro argomento quanto tale pratica, pur se episodica, fosse radicata presso le genti achee della Calabria greca. Merita, allora, indagare brevemente la ragione che spinge a selezionare i laterizi bollati ed il senso di tali presenze, singoli o reiterati, all’interno delle sepolture.
Nella loro dimensione ctonia, Apollo e Afrodite sono le guide privilegiate del cammino dell’anima verso la sua destinazione al di là dell’Oceano: ancora una volta, le guide di un viaggio per mare non privo d’incognite. In questo contesto il delfino ricorre con pieno diritto: è il simbolo, come accennato in precedenza, di una delle due porte del cielo, il Capricorno, detto la ‘porta degli deî’, attraverso la quale le anime liberate grazie all’affinamento spirituale escono definitivamente dal mondo della manifestazione
158 Mefitis, Mamerte, i Dioscuri, Iuppiter e Domina Giovia, Venere: cfr. nava – cracoLici 2005, p. 106.159 Cfr. adamasTeanu – diLThey 1992, fig. 20 e tav. LIV; guzzo 1992, p. 82-83, figg. 130-131; adamasTeanu 1998, p. 56, nn. 33-34; nava 2003, figg. alle
p. 84, 87.160 La rilavorazione che a Metaponto, forse in concomitanza con il soggiorno di Alessandro il Molosso (334-332 a.C.) o con quello successivo di Pirro,
trasforma la testa marmorea raffigurante Apollo kitharodos, originale greco di metà IV a.C., in quella di un Elio o Apollo-Elio, attesta il progressivo aumento d’importanza di questa divinità in ambiente metapontino, confermato anche dal materiale numismatico: merTens horn 2001, p. 83-85.
161 L’aspetto oscuro/notturno del dio, ‘riscattato’ però dal concetto sotteso di rinascita, presente in tutta la gamma dei suoi significati, sembra essere stato particolarmente sentito sulle due sponde dello Stretto. Esso giustifica, ad esempio, l’accostamento di Apollo, nella pittura vascolare e nella piccola plastica magno-greche, ad un animale di altissimo valore simbolico nei contesti funerari qual è la lepre, che la straordinaria prolificità pone nella sfera di Afrodite (cfr. deTienne 2007, p. 79-81). Rende ragione, inoltre, dell’associazione del dio, per il tramite della foglia d’alloro – quello delfico portato da Tempe ma anche quello del bosco sacro connesso all’Apollonion reggino fondato da Oreste – alla biga trainata da una coppia di mule: l’apene tipica dei cortei nuziali e funebri, oltre che dei riti magici della fertilità, raffigurata sulle monete del Regno creato dagli Anassilaidi unificando Rhegion e Messene (480-461 a.C.) che al R/ recano proprio la lepre e sotto di essa il delfino: cfr. caccamo caLTaBiano 2005, p. 119-120, con bibliografia sull’argomento. A proposito del ruolo centrale di Apollo nel pantheon reggino, vd. cosTaBiLe 1979; una sintesi aggiornata della relativa documentazione archeologica è ora in peTroLino 2007, p. 28-29.
162 Cfr. guThrie 1987, p. 110, 245.163 Dette stampiglie sono protagoniste anche di azioni rituali compiute in ambito domestico che dimostrano come un’aura di religiosità le circondasse a
dispetto della oggettiva povertà del supporto: il frammento con bollo di IV secolo a.C. dal cantiere Foti, infatti, è stato rinvenuto in uno dei livelli connessi alla chiusura intenzionale di un pozzo, unitamente ad altri manufatti legati in modo più palese all’esplicazione della pietas domestica: vd. ruga c.d.s.
164 Cfr. Apollonio Rodio, Argonautiche, II, 1073-1074.165 Cfr. spadea 1993, p. 25.166 In assenza di corredo, l’attribuzione delle tegole bollate al terzo quarto del V a.C. fatta da D. Roubis trascina con sé quella della sepoltura ma C. Rescigno
correttamente segnala come la tipologia a cassa parli a favore di una data alta, compatibile con la prima generazione di inumati e perciò risalente ai decenni iniziali del V secolo: ruga – rescigno – rouBis – fioriLLo 2005, rispettivamente p. 202 e 178.
167 Informazione del personale dell’Ufficio Scavi di Crotone, che si ringrazia.168 Cfr. nota 171 a p. 55.
55
Bolli figurati iMpressi su tegole di V e iV secolo a.c. da Kroton: sulle tracce di apollo ‘delfiniere’
individuale per accedere al mondo extra-cosmico, mentre gli deî possono servirsene per ‘scendere’ tra gli uomini. Il cetaceo è perciò caro ad entrambi i numi e ne precisa l’identità. La sua presenza nelle sepolture d’età arcaica e classica ha dunque una fun-zione propiziatoria, peraltro niente affatto nuova169. Associarlo al defunto sotto forma di monili d’uso non solo funerario ma la cui valenza amuletica è indubbia170, oppure incorporare nella struttura della tomba le effigi del cetaceo o del ‘delfiniere’, al quale era consentito di oltrepassare liberamente la porta suddetta, significava augurare all’anima l’esito più felice che la traversata potesse avere, ed in certa misura contribuire a garantirlo. Più tardi, cavalcatura esclusiva di Afrodite e di Eros, il delfino sembra connotare la dea, precisando e ribadendo la sua dimensione ctonia, nelle rare occasioni in cui ella interviene ancora in contesti funerari, so-stituendosi alla «Afrodite dell’Ade»171.
Casi simili a quelli delle sepolture krotoniati e della citata tomba liparese, ricorrenti nella Penisola anche in età repubblicana ed imperiale, fanno fede del potere amuletico riconosciuto alle stampiglie inizialmente per il significato pregnante dei loro emble-mi172 ma poi, sempre più spesso, per estensione del valore apotropaico attribuito a qualunque simbolo dall’autorità centrale, che nelle società pre-industriali è sempre politica ma anche religiosa, anzi prima di tutto religiosa. Un ulteriore slittamento investe ben presto dello stesso significato qualsiasi impressione (figurata o meno), in quanto essa presuppone l’esistenza di un potere capace di esercitare, per suo tramite, un controllo ‘a distanza’. Avremo allora esempi episodici, fino in età imperiale, di tombe con laterizi bollati prodotti in tempi diversi: decenni, a volte secoli di differenza173. Più tardi, in età altomedievale, bolli epigrafici di sicuro carattere funerario o più semplici graffiti, come pure monete emesse da autorità diverse e distanti tra loro nel tempo e nello spa-zio174, attestano come il radicamento di queste convinzioni le abbia fatte passare agevolmente dal mondo pagano a quello cristiano e persistere a lungo ben oltre i limiti dell’Antichità.
Esemplare al riguardo, anche perché molto precoce, è il caso citato della tomba n. 432 di Lipari, dove per rafforzare l’effetto atteso dall’utilizzo di tegole bollate, oltre a quella con delfino compaiono sia la stampiglia che gli associa la sigla ΠΥΡ, allusiva al carattere pubblico dei laterizi o ad un demo locrese, sia il bollo esclusivamente epigrafico che riduce a due le lettere del prece-dente. Tale varietà, finora spiegata pensando le tre tegole uscite dalla stessa officina e sostanzialmente coeve, potrebbe essere vista sotto un’altra luce e, trattandosi con ogni probabilità di manufatti selezionati, riaprire la prospettiva di uno scarto cronologico tra i marchî con solo delfino in cornice circolare e quelli con lettere in cartiglio quadrangolare, altrimenti riferiti tutti alla fine del V (Cavalier) piuttosto che alla metà del IV a.C. (Simonetti) per l’ampia forchetta cronologica del corredo175. In merito ai primi, di cui sono attestate almeno due serie e che non escluderei possano segnalare l’appartenenza della manifattura ad un santuario di Apollo, occorrerà forse riprendere in considerazione la possibilità di una produzione anteriore al 389 a.C.
169 Cfr. infra, p. 12, nota n. 70.170 Piccole fibule con arco in osso/avorio sagomato a delfino oppure a colomba, talvolta dotati di occhi in corallo applicati a parte, compaiono in corredi
funerari d’età arcaica e classica, in Magna Grecia, soprattutto entro tombe femminili e infantili: cfr. Bianco 2006, p. 126-132.171 Piccola plastica funeraria in forma di delfino si rinviene entro tombe di III e II sec. a.C. ad Herakleia, Taranto e nel Foggiano (Bianco 2006, p. 124, 127;
S.Severo 1996, p. 48-50, n. 11; p. 243, con ulteriore bibliografia; LippoLis 1996, n. 397). La sua presenza rinvia ad Afrodite – sulla colomba come attributo della dea, vd. BeLL 1981, p. 85 – come pure quella di conchiglie di molluschi marini bivalvi, non sempre giustificata dal loro uso pratico come pissidi, e di gastero-podi (Bianco 2006, p. 113-126). Altrettanto si potrebbe supporre per la stampiglia con tartaruga che compare su una tegola piana della collezione Palopoli (fig. 15.1-2) a Torretta di Crucoli (KR), proveniente da una tomba a cappuccina di tardo IV sec. a.C. messa in luce in località Castello Sabbatini di Cirò Marina, circa 35 chilometri a Nord di Crotone.
172 Se ruota e swastika sono rappresentazioni dinamiche del Mondo manifestato, in continua rotazione intorno all’invisibile asse centrale fisso, ma in maniera più semplicistica possono essere considerati emblemi solari poiché il Sole è il cuore del mondo fisico e al tempo stesso simbolo indiscusso «del vero ‘Centro del Mondo’, che è il Principio divino», il riferimento a Febo e a Delfi non appare del tutto fuori luogo: vd. guénon 1992, p. 63-66, 74-75, 139-140; idem 2006, p. 83-86. L’astro radiato può a sua volta alludere al Sole ma anche richiamare la trasformazione di Apollo da delfino in stella luminosissima descritta in Hom. Hymn. 3, 440-443.
173 A Crotone, ad esempio, una sepoltura infantile d’età imperiale, la n. 1 di via XXV Aprile (palazzo Foti), annovera nella copertura fittile due frammenti di tegole bollate FISCCROT (spadea – ruga 2007, p. 197, nota n. 53), mentre a Torretta di Crucoli, una quarantina di chilometri più a Nord, una tomba a cappuccina contava due esemplari di tegole fabbricate in una figlina di proprietà della gens Lusia che si crede localizzata nell’alto Crotonese (aisa – corrado – de vingo 2001, p. 310-312).
174 Per restare nel Crotonese, una tomba polisoma del cimitero di fine IX - metà XI legato alla chiesetta bizantina scoperta all’interno del mastio del castello di S.Severina, del tipo a fossa, scavata nel banco roccioso naturale, restituisce una moneta siracusana del periodo agatocleo: vd. cuTeri 1998, p. 71.
175 Cfr. simoneTTi 2001b, p. 432, con bibliografia precedente.
56
Margherita corrado
adamasTeanu 1998 = d. adamasTeanu, Il santuario di Rossano di Va-glio, in AA.VV., Il sacro e l’acqua. Culti indigeni in Basilicata, Catalogo della mostra, Roma 1998, p. 51-57.adamasTeanu – diLThey 1992 = D. adamasTeanu – h. diLThey, Mac-chia di Rossano. Il santuario della Mefitis. Rapporto preliminare, Gala-tina 1992.adornaTo 2007 = G. adornaTo, ΧΑΡΑΚΤΗΡ. Note iconografiche sugli stateri di Kaulonia, «ASNP», Serie IV, Quaderni, 17, 2007, p. 333-349.agosTino 2002 = R. agosTino (a cura di), L’uomo e gli animali: un rap-porto senza tempo, Reggio Calabria 2002.aisa – corrado – de vingo 2001 = m.g. aisa – m. corrado – p. de vingo, Una fornace per la produzione di anfore Dressel 1 sulla costa centro-orientale del Bruttium, Atti XXXIII Convegno Internazionale della Ceramica (Albisola 26-28 maggio 2000), Firenze 2001, p. 301-312.anToneLLi 1994 = L. anToneLLi, Cadmo ed Eracle al cospetto di Apollo. Echi di propaganda intorno a Delfi arcaica, «Hesperìa» 4 (1994), p. 13-48.arena 1997 = E. arena, Σατύριόν τοι δωκα: Il problema storico-topo-grafico di Satyrion nella tradizione degli oracoli delfici relativi alla fon-dazione di Taranto, «Studi di Antichità» 10 (1997), p. 255-289.arsLan 2005 = E. arsLan, Archeologia urbana e moneta: il caso di Cro-tone, in Kroton 2005, p. 91-142.arsLan c.d.s = E. arsLan c.d.s., Il quadro numismatico, in Enotri e Bret-tii in Magna Grecia. Modi e forme di interazione culturale, Atti del Con-vegno di Studi (Cosenza 11-12 giugno 2007), corso di stampa.aTTianese 1981 = P. aTTianese, Altilia di S.Severina. Indagine sulla pe-netrazione ellenica nel retroterra crotoniate, «Il Punto» 8 (1980) 7, p. 12-15.aTTianese 1992 = P. aTTianese, Kroton. Ex nummis historia, Settingiano 1992.aTTianese 2005 = P. aTTianese, Kroton. Le monete in bronzo, Soveria Mannelli 2005.aTTianese – sanTeLLi 2007 = P. aTTianese – g. sanTeLLi, Le contromar-che del Bruttium, («Nummus et Historia» XII), Cassino 2007.aversa 2005 = G. aversa, Le terrecotte architettoniche di Crotone. Nuo-ve acquisizioni e considerazioni tipologiche, in Kroton 2005, p. 67-79.aversa c.d.s. = G. aversa c.d.s., Produzioni di coroplastica architettoni-ca tra Crotone e Kaulonia: elementi di raffronto e spunti di riflessione, in Caulonia tra Crotone e Locri, Atti del Convegno, (Firenze, 30 maggio - 1 giugno 2007), corso di stampa.BareLLo 1995 = F. BareLLo, Architettura greca a Caulonia. Edilizia mo-numentale e decorazione architettonica in una città della Magna Grecia, Sesto Fiorentino 1995.BareLLo 2005 = F. BareLLo, Intervento, in Kroton 2005, p. 287-288.BeLL 1981 = M. BeLL, The Terracottas. Morgantina Studies, I, Princeton, New Jersey 1981.Bianco 2006 = S. Bianco, Conchiglie e corallo nella Basilicata antica, in AA.VV., Coralli segreti. Immagini e miti dal mare in Oriente e in Occi-dente, Potenza 2006, p. 99-133.Boardman 2001 = J. Boardman, Greek Gems and Finger Rings. Ear-ly Bronze Age to Late Classical, London 2001 (II edizione Thames and Hudson).Braccesi 1993 = L. Braccesi, Gli Eubei e la geografia dell’Odissea, «He-sperìa» 3 (1993), p. 11-23.Braccesi 1996 = L. Braccesi, ΕΠΙ ΠΟΝΤΟΝ ΣΙΚΕΛΟΝ (Euripide e i Dioscuri), «Hesperìa» 7 (1996), p. 63-66.
Braccesi 1998 = L. Braccesi, Cronologia e fondazioni coloniarie, 2 (Mi-scello e le tre spedizioni a Crotone), «Hesperìa» 9 (1998), p. 9-17.BregLia 2005 = L. BregLia, Hera e le Sirene al Capo Lacinio, in Kroton 2005, p. 267-278.BurkerT 2003 = W. BurkerT, La religione greca di epoca arcaica e clas-sica, Milano 2003 (II edizione Jaca Book).caccamo caLTaBiano 2005 = M. caccamo caLTaBiano, Le monete ‘gre-che’ di Messana e Rhegion, in F. ghedini et Alii (a cura di), Lo Stretto di Messina nell’Antichità, Roma 2005, p. 113-128.carroccio 1996 = B. carroccio, Il ΠΟΤΑΜΙΟΣ / ΛΙΜΝΑΙΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ nelle monete della Brettia ellenizzata, «NAC» 25 (1996), p. 11-4.carroccio 2005 = B. carroccio, I bronzi Zeus Hellanios/Aquila e l’or-ganizzazione dell’attività monetaria siracusana tra officine parallele e concentrazioni cronologiche,in XIII Congreso Internacional de Numi-smática, Madrid 2003, Actas-Proceedings-Actes, Editado por c. aLfaro – c. marcos – p. oTero, Madrid 2005, p. 331-337cassoLa 2006 = F. cassoLa, Inni omerici, Milano 2006 (VIII edizione Fondazione Lorenzo Valla).coLLi 1977 = G. coLLi, La sapienza greca. I, Milano 1977.coLLi 1992 = G. coLLi, La sapienza greca. II, Milano 1992 (I edizione gli Adelphi).coLLi 1993 = G. coLLi, La sapienza greca. III, Milano 1993 (I edizione gli Adelphi).cordano 1993 = F. cordano, Due note adriatiche, «Hesperìa» 3 (1993), p. 145-153.corrado c.d.s = m. corrado c.d.s., Immagini di delfini e ‘delfinieri’ da Caulonia e Crotone, Comunicazione, Atti del Convegno “Caulonia tra Crotone e Locri” (Firenze, 30 maggio - 1 giugno 2007), corso di stampa.cosTaBiLe 1979 = F. cosTaBiLe, Il culto di Apollo quale testimonianza della tradizione corale e religiosa di Reggio e Messana, «MEFRA» 91 (1979) 2, p. 525-545.cosTaBiLe – meirano 2006 = F. cosTaBiLe – V. meirano, Il viaggio dell’anima e le aparchai degli eidola alati nei riti funebri del mondo lo-crese (Locri, Kaulonia e Medma), «Polis» 2 (2006), p. 73-82. Culti greci = E. LippoLis – S. garraffo – M. nafissi (a cura di), Culti greci in Occidente I. Taranto, Taranto 1995.cuTeri 1998 = F.A. cuTeri, L’insediamento tra VIII e IX secolo. Strutture, oggetti, culture, in R. spadea (a cura di), Il castello di Santa Severina, Soveria Mannelli 1998, p. 49-91.denoyeLLe 2003 =M. denoyeLLe, in AA.VV., Tanagra, Mythe et Archéo-logie, Paris 2003, p. 92-103.deTienne 1983 = M. deTienne, I maestri di verità nella Grecia arcaica, Roma-Bari 1983 (I edizione «Universale Laterza»).deTienne 2002 = M. deTienne, Apollo con il coltello in mano. Un ap-proccio sperimentale al politeismo greco, Milano 2002 (I edizione Gli Adelphi).deTienne 2007 = M. deTienne, Dioniso e la pantera profumata, Bari 2007 (I edizione «Economica Laterza»).de Lucia BroLLi 2000 = M.A. de Lucia BroLLi, Dinos a figure nere, in A.M. moreTTi sguBini (a cura di), La Collezione Augusto Castellani, Roma 2000, p. 44.de paoLa – sarToris 2001 = A. de paoLa – a. sarToris, Rapporto preli-minare delle campagne di scavo a Serra e Rossano di Vaglio (anni 1997-1999), «BBasil» 17 (2001), p. 15-28.
BiBliografia ed aBBreviazioni
57
Bolli figurati iMpressi su tegole di V e iV secolo a.c. da Kroton: sulle tracce di apollo ‘delfiniere’
de sanTiLLana g. – von dechend h. 2006 = G. de sanTiLLana – h. von dechend, Il mulino di Amleto. Saggio sul mito e sulla struttura del tempo, Milano 2006 (III edizione gli Adelphi).de sensi sesTiTo 2007 = G. de sensi sesTiTo, Il paesaggio di Caulonia tra mito, storia e culti, «ASNP», Serie IV, Quaderni, 17, 2007, p. 317-332.di paLo 1993 = F. di paLo, Museo Archeologico Jatta, Ruvo di Puglia 1993. faceLLa 2001 = A. faceLLa, Capo Cocinto (Punta Stilo) nella geografia della Calabria antica, «ASNP», Serie IV, Quaderni, 11, 2001, p. 103-116.feLsch 1994 = R.C.S. feLsch, Further Stamped Roof Tiles from Central Greece, Attica, and the Peloponnese, in N.A. WinTer (ed.), First Interna-tional Conference on Archaic Greek Architectural Terracottas, (Athens, december 2-4 1988), («Hesperìa» 1994), p. 301-323.fioravanTi 2001 = C. fioravanTi, Note su alcuni problemi storico-topografici relativi al territorio di Kaulonia in età arcaica e classica, «ASNP», Serie IV, Quaderni, 11, 2001, p. 27-57.foTi 1975 = G. foTi, L’attività archeologica in Calabria, Atti del XIV Convegno di Studi sulla Magna Grecia, (Taranto 1974), Napoli 1975, p. 291-323.fränkeL 1969 = H. fränkeL, Dichtung und Philosophie des frühen Grie-chentums, München 1969 (1962).gargini 2001 = G. gargini, Kaulonia nel contesto delle tipologie inse-diativa arcaiche in Magna Grecia e Sicilia, «ASNP», Serie IV, Quaderni, 11, 2001, p. 13-25.garozzo 1995 = B. garozzo, Bolli su coppi ed embrici, in AA.VV., Sege-sta. Parco archeologico e relazioni preliminari delle campagne di scavo 1991-1993, «ASNP», s. III, 25 (1995), p. 1187-1204.garraffo 1995 = S. garaffo, La documentazione numismatica, in Culti greci, p. 133-151.giangiuLio 1989 = M. giangiuLio, Ricerche su Crotone arcaica, Pisa 1989.giangiuLio 1994 = M. giangiuLio,Sapienza pitagorica e religiosità apollinea. Tra cultura della città e orizzonti panellenici, «AIONFil» 16 (1994), p. 9-27.giangiuLio 1996 = M. giangiuLio, Tra terra e mare. L’orizzonte religioso del paesaggio costiero, F. pronTera (a cura di), La Magna Grecia e il mare. Studi di storia marittima, Taranto 1996, p. 252-271.giangiuLio 2002 = M. giangiuLio, I culti delle colonie achee d’Occidente. Strutture religiose e matrici metropolitane, in E. greco (a cura di), Gli Achei e l’identità etnica degli Achei d’Occidente, Atti del Convegno In-ternazionale di Studi, (Paestum 23-25 febbraio 2001), Paestum – Atene 2002, p. 283-313.giudice 1998 = F. giudice, Le necropoli, in Kroton, p. 61-63.giudice – giudice – giudice 2005 = e. giudice – f. giudice – G. giudice, I vasi attici della necropoli della “Carrara” di Crotone: analisi distribu-tiva e iconografica, in Kroton 2005, p. 81-90.giuman 2008 = M. giuman, Melissa. Archeologia delle api e del miele nella Grecia antica, Roma 2008.giusTozzi 2005 = N. giusTozzi, Acrolito di Apollo, in S. seTTis – M.C. parra (a cura di), Magna Graecia. Archeologia di un sapere, Catalogo della mostra di Catanzaro, Milano 2005, p. 259-263. guénon 1992 = R. guénon, Simboli della Scienza sacra, Milano 1992 (II edizione gli Adelphi).guénon 2006 = R. guénon, Il Simbolismo della Croce, Firenze 2006 (III edizione Luni Edritrice).guThrie 1987 = W.K.C. guThrie, I Greci e i loro dei, Bologna 1987 (I edizione il Mulino).guzzeTTa 1983 = G. guzzeTTa, Tesoretto monetale di età classica da Ru-tigliano (BA), «Taras» 3 (1983) 1-2.guzzo 1988 = P. guzzo, I documenti per lo studio della produzione ar-tigianale, in S. seTTis (a cura di), Storia della Calabria antica, Roma-Reggio Calabria 1988, p. 429-474.
guzzo 1992 = P. guzzo, Oggetti preziosi dalla stipe, in AA.VV., Da Leu-kania a Lucania. La Lucania centro-orientale fra Pirro e i Giulio-Clau-dii, Roma 1992, p. 82-86.ianneLi 1992 = M.T. ianneLLi, s.v. Monasterace Marina, «BTCGI» 10 (Pisa-Roma 1992), p. 190-217.ianneLi 2007 = M.T. ianneLLi, Kaulonia, in E. LaTTanzi (a cura di), Il Museo Nazionale di Reggio Calabria, Roma 2007, p. 134-145.ianneLi c.d.s. = M.T. ianneLLi, “Casa Matta”: la residenza, le terme, i culti , in Caulonia tra Crotone e Locri, Atti del Convegno, (Firenze 30 maggio - 1 giugno 2007), corso di stampa.Kroton 1998 = R. spadea (a cura di), Kroton. Scavi e ricerche a Crotone dal 1985 al 1998, Milano 1998.Kroton 2005 = R. BeLLi pasqua – R. spadea (a cura di), Kroton e il suo territorio tra VI e V secolo a.C. Aggiornamenti e nuove ricerche, Atti del Convegno di Studi (Crotone 2000), 2005.Lazzarini 1982 = M.L. Lazzarini, I «veri reggini», «Klearchos» 93-96 (1982), p. 145-157. Lazzarini 2005 = M.L. Lazzarini, Ceppo di ancora iscritto, in S. seT-Tis – M.C. parra (a cura di), Magna Grecia. Archeologia di un sapere, Catalogo della mostra di Catanzaro, Milano 2005, p. 269, II.114. LippoLis 1996 = E. LippoLis, La ceramica policroma e plastica tarantina, in E. LippoLis (a cura di), Arte e artigianato in Magna Grecia, Napoli 1996, p. 471-474. LomBardi saTriani – meLigrana 1982 = L.M. LomBardi saTriani – M. meLigrana, Il ponte di San Giacomo. L’ideologia della morte nella socie-tà contadina del Sud, Milano 1982.Lopez 2004 = F. Lopez, Profilo storico di Altilia. Il monastero di Calabro-maria, S.Giovanni in Fiore 2004.marino 2003 = D. marino, Boschi sacri e giardini nell’antico Lacinio, in Il ritorno di Pitagora, Atti del Convegno di Crotone, «Quaderni di Pi-tagora» 3 (2003), p. 101-113.marino – corrado 2009 = D. marino – M. corrado (a cura di), O deî di Kroton! Luoghi e testimonianze del sacro dentro le mura. Catalogo della mostra (Crotone 20 maggio – 31 dicembre 2009), ivi 2009.masieLLo 2005a = L. masieLLo, Satyria su delfino, in S. seTTis – M.C. parra (a cura di), Magna Grecia. Archeologia di un sapere, Catalogo della mostra di Catanzaro, Milano 2005, p. 441.masieLLo 2005b = L. masieLLo, Taras su delfino, in S. seTTis – M.C. par-ra (a cura di), Magna Grecia. Archeologia di un sapere, Catalogo della mostra di Catanzaro, Milano 2005, p. 441.meLe 1981 = A. meLe, Il Pitagorismo e le popolazioni anelleniche d’Ita-lia, «Aion. Archeologia e Storia Antica» 3 (1981), p. 61-96.meLe 1984 = A. meLe, Crotone e la sua storia, Atti del XXIII Convegno di Studi sulla Magna Grecia, (Taranto 1983), Napoli 1984, p. 9-87.meLe 1993 = A. meLe, Crotone greca negli ultimi due secoli della sua storia, in AA.VV., Crotone e la sua storia tra IV e III secolo a.C., Napoli 1993, p. 235-291.meLe 2005 = A. meLe, Pitagorismo e attività produttive, in Kroton 2005, p. 11-18.merTens horn 1994 = M. merTens horn, s.v. Antefissa, in «EAA», II Suppl. 1971-1994, Roma 1994, p. 242-252.merTens horn 1999 = M. merTens horn, Il ricordo delle apoikiai nelle immagini della scultura architettonica arcaica in Sicilia e Magna Grecia, in Le mythe grec dans l’Italie antique. Fonction et image, Actes du col-loque international organisé par l’École française de Rome, Rome 1996, Roma 1999, p. 136-141.merTens horn 2001 = M. merTens horn, La scultura di marmo, in A. de siena (a cura di), Metaponto. Archeologia di una colonia greca, Taranto 2001, p. 71-88.
58
Margherita corrado
nafissi 1995 = M. nafissi, La documentazione letteraria ed epigrafica, in Culti greci, p. 155-334.nava 1999 = M.L. nava, L’attività archeologica in Basilicata nel 1999, Atti del XXXIX Convegno di Studi sulla Magna Grecia, (Taranto 1999), Napoli 2000, p. 677-726.nava 2003 = M.L. nava, Il santuario di Rossano di Vaglio, in AA.VV., Le sacre acque. Sorgenti e luoghi del rito nella Basilicata antica, Catalo-go della mostra, Lavello 2003, p. 85-100.nava – cracoLici 2005 = M.L. nava – V. cracoLici, Il santuario lucano di Rossano di Vaglio, in M.L. nava – M. osanna (a cura di), Lo spazio del rito. Santuari e culti in Italia meridionale tra indigeni e greci, Atti delle giornate di studio (Matera 2002), Bari 2005, p. 103-113.niLsson 1967 = M.P. niLsson, Geschichte der griechischen Religion, vol. I, München 1967 (3° edizione).noe 1958 = S.P. noe, The Coinage of Caulonia, New York 1958. orsi 1891 = P. orsi, Stilo. Di alcuni avanzi riferibili forse all’antica Cau-lonia, «NSA», 1891, p. 61-72. orsi 1914 = P. orsi, Caulonia. Campagne archeologiche del 1912, 1913, 1915, «MonAL» 23 (1914), 2° puntata 1916, coll. 685-947.osanna 1992 = M. osanna, Chorai coloniali da Taranto a Locri, Roma 1992.parra 2001 = M.C. parra, Con Paolo Orsi, ed altri, nel santuario di Punta Stilo. Campagne di scavo 1999-2001, «ASNP», Serie IV, Quader-ni, 11, 2001, p. 219-248.parra 2005a = M.C. parra, Riflessioni e novità intorno al santuario di Punta Stilo (Kaulonia). Campagne di scavo 1999-2001, in M.L. nava – M. osanna (a cura di), Lo spazio del rito. Santuari e culti in Italia meridionale tra indigeni e greci, Atti delle giornate di studio (Matera 2002), Bari 2005, p. 27-42. parra 2005b = M.C. parra, Paolo Orsi a Caulonia: Lungi da Castelve-tere, intorno a Capo Stilo, in S. seTTis – M.C. parra (a cura di), Magna Graecia. Archeologia di un sapere, Catalogo della mostra di Catanzaro, Milano 2005, p. 273-284.parra 2007 = M.C. parra, Ancora dal santuario di Punta Stilo, con Pa-olo Orsi, e altri dopo le campagne di scavo 2000-2005, «ASNP», Serie IV, Quaderni, 17, 2007, p. 3-42.peTroLino 2007 = I. peTroLino, I culti reggini attraverso gli altri rinveni-menti archeologici, in AA.VV., Reggio Calabria. Memorie dal sottosuo-lo. Le principali scoperte archeologiche nella città di Reggio tra XIX e XXI secolo, Reggio Calabria 2007, p. 28-31.pugLisi 2004 = M. pugLisi, Il simbolismo del polpo, in M. caccamo caLTaBiano – D. casTrizio – M. pugLisi (a cura di), La tradizione ico-nografica come fonte storica. Il ruolo della numismatica negli studi di iconografia, Atti del I Incontro di Studio del Lexicon Iconographicum Numismaticae, Messina 2003, (Semata e Signa 1), Reggio Calabria 2004, p. 159-172.raBinoviTsch 1947 = M. raBinoviTsch, Der Delphin in Sage und Mithos der Griechen, Basel 1947. ruga – rouBis – rescigno – fioriLLo 2005 = a. ruga – d. rpouBis – c. rescigno – r. fioriLLo, Ricerche nella chora meridionale di Crotone: prospezioni e scavi (1990-1991), in Kroton 2005, p. 149-206.ruga a. c.d.s.russo 2006 = A. russo, Nereo, Scilla e le Sirene. Miti e viaggi per mare oltre l’Oceano, in AA.VV., Coralli segreti. Immagini e miti dal mare in Oriente e in Occidente, Potenza 2006, p. 135-147.saBBione 1984 = C. saBBione, L’artigianato artistico, Atti del XXIII Convegno di Studi sulla Magna Grecia, (Taranto 1983), Napoli 1984, p. 243-301.
S. Severo 1996 = M. de JuLiis (a cura di), San Severo. La necropoli di masseria Casone, Bari 1996. simoneTTi 2001a = m. simoneTTi, Le arulae da Caulonia, «ASNP», Serie IV, Quaderni, 11, 2001, p. 337-415.simoneTTi 2001b = m. simoneTTi, I bolli di Caulonia, «ASNP», Serie IV, Quaderni, 12, 2001, p. 417-463.SNG Bruttium = E. arsLan 1999, Sylloge Nummorum Graecorum, Italia, Museo Provinciale di Catanzaro, II, Bruttium, Catanzaro 1999.spadea 1984 = R. spadea, La topografia, in AA.VV., Crotone, Atti del XXIII Convegno di Studi sulla Magna Grecia, (Taranto 1983), Napoli 1984, p. 119-166.spadea 1992 = R. spadea, Note topografiche sulla polis, in F. mazza (a cura di), Crotone. Storia Cultura Economia, Soveria Mannelli 1992, p. 91-109.spadea 1993 = R. spadea, Crotone tra IV e III secolo a.C.: precisazioni topografiche, in AA.VV., Crotone e la sua storia tra IV e III secolo a.C., (Napoli 1987), 1993, p. 19-34.spadea 1998 = R. spadea, Le aree di produzione, in Kroton, p. 41-44.spadea 2005 = R. spadea, Serpente, in S. seTTis – M.C. parra (a cura di), Magna Graecia. Archeologia di un sapere, Catalogo della mostra di Catanzaro, Milano 2005, p. 271.spadea – ruga 1996 = R. spadea – a. ruga, Il territorio archeologico, in R. spadea (a cura di), Tiriolo. Ricerche su storia e tradizioni, Milano 1996, p. 33-52.spadea – ruga 2007 = R. spadea – a. ruga, Vetri di età romana da Crotone e da Strongoli-Petelia, in A. coscareLLa (a cura di), La cono-scenza del vetro in Calabria attraverso le ricerche archeologiche, Atti della Giornata di Studio (Cosenza, 12 marzo 2004), Soneria Mannelli 2007, p. 185-212. sTazio 1985 = A. sTazio, Monetazione ed economia monetaria, in G. pu-gLiese carraTeLLi (a cura di), Sikanie. Storia e civiltà della Sicilia greca, Milano 1985, p. 79-122.sTazio 1993 = A. sTazio, La monetazione argentea di Crotone nel IV-III sec. a.C., in AA.VV., Crotone e la sua storia tra IV e III secolo a.C., (Na-poli 1987), ivi 1993, p. 103-109.TaLiercio mensiTieri 1993a = M. TaLiercio mensiTieri, Problemi della monetazione in bronzo di Crotone, in AA.VV., Crotone e la sua storia tra IV e III secolo a.C., (Napoli 1987), 1993, p. 111-129.TaLiercio mensiTieri 1993b = M. TaLiercio mensiTieri, Problemi moneta-ri di Hipponion e delle città della Brettia tra IV e III sec. a.C., in AA.VV., Crotone e la sua storia tra IV e III secolo a.C., (Napoli 1987), 1993, p. 131-186.TrendaLL 1989 = A.D. TrendaLL, Red Figure Vases of South Italy and Sicily, London 1989.TrendaLL – camBiTogLou 1961 = A.D. TrendaLL – a. camBiTogLou, Apu-lian Red-figured Vase-Painters of the Plain Style, Rutland-Tokyo 1961. TrendaLL – camBiTogLou 1982 = A.D. TrendaLL – a. camBiTogLou, The Red-figured Vases of Apulia, I-II, Oxford 1982vernanT 1987 = J. vernanT, La morte negli occhi. Figure dell’Altro nell’antica Grecia, Bologna 1987.voeLke 1981 = A.J. voeLke, Aux origines de la philosophie grecque: la cosmogonie d’Alcman, in Melanges F. Brunner, Neuchâtel 1981, p. 13-24.voLorio 2004 = S. voLorio, Il delfino nell’arte egea: considerazioni ico-nografiche e interpretazioni simboliche, «AΓΩΓΗ» 1 (2004), p. 53-92.




























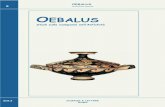
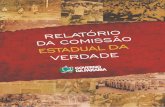












![[Newspapers and Post] "Giornali in Posta" - prima parte - L'epoca dei bolli (1814-1849)](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6323953e5f71497ea9046660/newspapers-and-post-giornali-in-posta-prima-parte-lepoca-dei-bolli-1814-1849.jpg)

