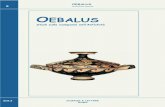Bolli laterizi da Taormina, in «La Parola del Passato», 67/6, fasc. 387, 2012, pp. 414-467
-
Upload
beniculturali -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Bolli laterizi da Taormina, in «La Parola del Passato», 67/6, fasc. 387, 2012, pp. 414-467
LA PAROLA DEL PASSATO
RI V I S TA DI S TUDI A N T ICH I
FA S C I C O L O C C C L X X X V I I
[ESTRATTO]
NA POL I
M A C C H I A R O L I E D I T O R E
2 01 2
LA PAROLA DEL PASSATO . RIVISTA DI STUDI ANTICHIFONDATA DA
GIOVANNI PUGLIESE CARRATELLI E GAETANO MACCHIAROLI
Direzione: Pia de Fidio - Gianfranco Fiaccadori - Valeria Gigante LanzaraResponsabile: Gisella Macchiaroli
Consiglio direttivo: Luigi Beschi - John K. Davies - Sergio DonadoniHans Joachim Gehrke - Michel Gras - Johannes Kramer
Gianfranco Maddoli - Dirk Obbink - Raffaella Pierobon BenoitMirjo Salvini - Salvatore Settis - Marisa Tortorelli Ghidini
Gernot Wilhelm - Fausto ZeviRedazione: Marco Di Branco - Agostino Soldati
Coordinatore: Luigi Vecchio
in collaborazione con l'istituto italiano per gli studi filosofici
pubblicazione realizzata con il sostegno di
VOLUME LXVII/2012 - FASCICOLO VI (CCCLXXXVII DELLA SERIE)
Valeria Gigante Lanzara, Ancora sull'ontano di Filita 401
n o t e c r i t i c h e e f i l o l o g i c h e
Agostino Soldati, <Aki*aqvo| vs. Ke*aqvo| (Erodoto, IV 160, 4) 407
t e s t i e m o n u m e n t i
Francesco Muscolino, Bolli laterizi di Taormina 414
r a s s e g n e
Luigi Vecchio, Michela Nocita, Italiotai e Italikoi. Le testimonianzenel Mediterraneo orientale, Roma, L'Erma di Bretschneider,2012 468
Pubblicazioni ricevute 476
I collaboratori del volume LXVII/2012 477
Indice del volume LXVII/2012 478
Printed in Italy . Arte Tipografica - Via San Biagio dei Librai, 39 - 80138 Napoli
TESTI E MONUMENTI
BOLLI LATERIZI DI TAORMINA*
al piccolo William
Introduzione
GiaÁ nel XVIII secolo gli studiosi che si occupano delle antichitaÁ diTaormina mostrano interesse per i bolli laterizi. EÁ il caso, *in particolare,
414 testi e monumenti
* Per le riviste si usano le abbreviazioni dell'ArchaÈologische Bibliographie. Siindica come Vecchio inventario un manoscritto intitolato R. Soprintendenza ai mo-numenti in Palermo. AntichitaÁ di Taormina. Elenco del materiale esistente presso il postodi servizio del Teatro antico, con sommaria descrizione, dimensioni e numero di matri-cola per ogni singolo oggetto di proprietaÁ dello Stato, databile entro i primi decenni delNovecento. A questo elenco seguono, con diversa grafia, una Nota degli oggettirinvenuti durante gli scavi del Teatro greco di Taormina dal 21 luglio al ... e varieannotazioni su rinvenimenti nel 1932 (quest'ultima parte saraÁ indicata come Anno-tazioni); si indica, invece, come Inventario BernaboÁ Brea l'Inventario dell'Antiquariumdel Teatro romano di Taormina, compilato nel 1945 da Luigi BernaboÁ Brea. Su varireperti sono tracciati due numeri: in rosso il numero del Vecchio inventario (comeindicato anche all'inizio dell'elenco: `Oggetti inventariati e portanti il numero dimatricola in color rosso'), in nero quello dell'Inventario BernaboÁ Brea. Abbreviazioniusate: ASMP (Palermo, Archivio storico del Museo archeologico regionale `A.Salinas'), BAV (CittaÁ del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana), BCP (Palermo,Biblioteca Comunale), BEUMo, AM (Modena, Biblioteca Estense Universitaria,Archivio Muratoriano), CIG (Corpus inscriptionum Graecarum), CIL (Corpus inscrip-tionum Latinarum), IG (Inscriptiones Graecae), alt. (altezza), appr. (approssimativa-mente), c.ans. (cartiglio ansato), circ. (circolare), cons. (conservata/o), diam. (diame-tro), g.e. (Giornale di entrata), inv. (Inventario BernaboÁ Brea), inv.provv. (inventarioprovvisorio), largh. (larghezza), lungh. (lunghezza), m. (mattone), nau. (`Nauma-chia'), q. (quadrangolare), spess. (spessore), tab.ans. (tabella ansata), t.p. (tegolapiana), v.inv. (Vecchio inventario), vis. (dimensione visibile, nel caso dei mattonidella `Naumachia' con concrezioni). ± Ringrazio la dott.ssa Maria Costanza Lentini,direttore del Servizio Parco archeologico di Naxos e delle aree archeologiche di
di Giovanni di Giovanni, che nel 1739 invia la trascrizione di due bolli edi altre epigrafi a Lodovico Antonio Muratori, 1 e di Ignazio Cartella, chein una lettera del 1756 a Domenico Schiavo sostiene, contro i detrattori,l'utilitaÁ di simili studi, affermando: `Perche questi suggelli sono impressiin tegole, o in vasi di creta, e per lo piuÁ sono brevi, si dovranno porre inoblio? Dunque dovremo deridere que' dotti Antiquarj, che di questetegole letterate fecero particolare ricerca, e ne riempirono, ed adorna-rono i loro lodevolissimi, e pregevoli volumi'. 2 Nonostante questa pre-coce attenzione, i bolli laterizi di Taormina non sono stati finora oggettodi uno studio complessivo; si presenta quindi un corpus comprendente,oltre ai pochi giaÁ noti, i numerosi bolli inediti o insufficientementeconosciuti, senza tralasciare gli esemplari non piuÁ rintracciabili.
Il bollo Satqolemisa& m
L'etnico al genitivo plurale dorico Satqolemisa& m, 3 che ricorre anche
415testi e monumenti
Giardini Naxos, Taormina, Francavilla e dei Comuni limitrofi, per aver autorizzatoe costantemente incoraggiato le mie ricerche, il dott. Marco Buonocore, ScriptorLatinus e direttore della Sezione archivi della Biblioteca Apostolica Vaticana, pre-sidente della Pontificia Accademia Romana di Archeologia, per aver agevolato lemie ricerche sul Vat. lat. 10574, la prof.ssa Paola Pelagatti (Accademia Nazionaledei Lincei), per l'indicazione di cui alla n. 48, la prof.ssa Marie FrancËoise Billot(Centre national de la recherche scientifique), per le informazioni sul bollo di Argoalla n. 17, la prof.ssa Olga Tribulato (UniversitaÁ `Ca' Foscari' di Venezia), ladott.ssa Susana Mimbrera Olarte (Consejo Superior de Investigaciones CientõÂficas)e il prof. Kalle Korhonen (UniversitaÁ di Helsinki ± Kone Foundation) per precisa-zioni sulla koina dorica siciliana e sull'uso del greco nella Sicilia imperiale, la dott.ssaDomenica Russotti, per avermi indicato i laterizi g.iii.1.1 e g.iii.4.1, il dott. DarioBarbera (perfezionando presso la Scuola Normale Superiore di Pisa), per la segna-lazione del passo di Riedesel citato alla n. 37 e per aver attirato la mia attenzione sulriuso di mattoni antichi a Castelmola e nel suo territorio.
1 F. Muscolino, in «ZPE», CLXVII, 2008, pp. 119-134.2 Lettera del 15 aprile 1756, in «Memorie per servire alla storia letteraria di
Sicilia», I/5, 1756, pp. 8-12. Sul carteggio tra Cartella e Schiavo vd. F. Muscolino,in «Mediterranea. Ricerche storiche», IV, 2007, pp. 583-584 e 592-596.
3 Tra i possibili confronti si citano i bolli lateriziAi\cie* xm (tarda etaÁ ellenistica/prima etaÁ romana, SEG LII, 495); \Ajaqma* mxm (SEG XLVI, 601); \Ajqeiasa& m (SEGLV, 433); \Aktfei* xm (etaÁ ellenistica, SEG LVI, 611); \Aqrimoe* xm (IG IX/1, 133);Comme* xm (A. Tziaphialias, in «ADelt», XXXII/B, 1977, p. 137); Dilakkisa& m (SEGXLV, 692); \Eqesqie* xm (SEG XXXII, 860); Hgbai* xm (IG VII, 2528 e 3595);Htqqei* xm (IG IX/2, 366); Jakkipokisa& m (SEG XLVIII, 602); Jmxri* xm (M. Guar-ducci, Inscriptiones Creticae, III, Roma, 1950, p. 17, nrr. 3-4); Joqimhi* xm (O. Bro-neer, The South Stoa and its Roman Successors, Princeton, 1954: Corinth, I/4, p. 88,tav. 22, fig. 3); Ledixmi* xm (sec. IV-III a.C., E. Mastrokostas, in «AM», LXXX,
nella monetazione della polis, 4 eÁ attestato su mattoni della `Naumachia'(figg. 1.1-2) segnalati da Biagio Pace 5 e da altri studiosi. 6 Saverio Landolinacita `i mattoni di Taormina con le lettereS.A.T.Q.', 7 senza peroÁ precisarne ilcontesto di appartenenza. L'esame autoptico ha permesso di individuaredue tipi diversi: un bollo quadrangolare che tende ad allargarsi verso ilcentro (g.i.1.1-2, fig. 2.1), 8 e un cartiglio ansato (g.i.2.1-6, figg. 2.2-4).
416 testi e monumenti
1965, p. 159, nr. 17, beil. 64/3); Lgsqopokisx& m (sec. III-II a.C., SEG LII, 563);Matpajsi* xm (SEG XLVII, 554); Oi\miadx& m (SEG XLVI, 601); \Oqhie* xm (etaÁ elleni-stica, SEG LII, 565);Pisamasa& m (sec. III a.C., IG V/1, 917);Rsqasi* xm (SEG XLVII,570); dalori* a |Samacqg* xm (R.C.S. Felsch, in «AM», XCIV, 1979, p. 31, cat. e3b);Sqivxmi* xm (IG IX/1, 125);Uicake* xmdalo* rio| (SEG LII, 459) e da& lo|Uiake* xm [sic](SEG XLVII, 443); Vakjide* xm (IG XII/9, 1168). Per bolli con etnico osco espressoin lettere greche al genitivo plurale vd. laleqsimotl (IG XIV, 2394/2 e 2400/7; A.Zumbo, Fonti epigrafiche, in M. Intrieri & A. Zumbo (edd.), I Brettii, II. Fontiletterarie ed epigrafiche, Soveria Mannelli, 1995, pp. 255-256, cat. a5; I. Bitto, Leiscrizioni greche e latine di Messina, Messina, 2001: Pelorias, 7, pp. 126-127, nrr. 49-50; Ead., Manufatti inscritti del Museo regionale di Messina, in M. Mayer i Olive , G.Baratta & A. GuzmaÂn Almagro (edd.), XII Congressus internationalis epigraphiaeGraecae et Latinae. Acta, Barcelona, 2007, p. 172; K. Korhonen, Le iscrizioni delMuseo civico di Catania. Storia delle collezioni, cultura epigrafica, edizione, Helsinki,2004: Commentationes humanarum litterarum, 121, p. 144; M.C. Lentini, in«NSc», 2008-09, pp. 368 e 371, fig. 13, M.G. Vanaria, P. Mazzoleni & G. Barone,ivi, pp. 417-420) e satqiamotl (Zumbo, Fonti epigrafiche, cit., p. 255, cat. a4).
4 Vd. almeno S. Consolo Langher, Ricerche di numismatica (Messina, 1967:Biblioteca di «Helikon». Testi e studi, 5), pp. 61-165; R. Calciati, Corpus nummo-rum Siculorum. La monetazione di bronzo, III (Milano, 1987), pp. 207-226; A. MinõÁ,Monete di bronzo della Sicilia antica (Palermo, 1979), pp. 412-430; A. CarbeÁ , Notasulla monetazione di Tauromenion nel III secolo a.C., in M. Caccamo Caltabiano(ed.), La Sicilia tra l'Egitto e Roma. La monetazione siracusana dell'etaÁ di Ierone II, Attidel seminario di studi, Messina, 1993 (Messina, 1995: Atti Accademia peloritanadei Pericolanti, suppl. 1), pp. 303-318; B. Carroccio, Dal basileus Agatocle a Roma.Le monetazioni siciliane d'etaÁ ellenistica (cronologia, iconografia, metrologia) (Messina,2004: Pelorias, 10), pp. 90-92 e passim; O.D. Hoover, Handbook of Coins of Sicily(including Lipara). Civic, Royal, Siculo-Punic, and Romano-Sicilian Issues. Sixth toFirst Centuries BC (Lancaster-London, 2012: The Handbook of Greek CoinageSeries, 2), pp. 407-417.
5 B. Pace, in «BdA», s. ii, IX, 1929-30, p. 380, cita `alcuni timbri deimattoni della fabbrica, segnalati in vario tempo, i quali recano l'iscrizione Satqo-lemisa& m che per la forma delle lettere richiama molto da vicino la leggenda dellamonetazione taorminese del periodo immediatamente anteriore al 210 av. Cr.'.
6 M. Santangelo, Taormina e dintorni (Roma, 1950), p. 79; G.F. La Torre, in«Sicilia antiqua»,V,2008,p. 142;M.I.Gulletta, in «BTCGI»,XX,2011, pp.66, 79.
7 Lettera ad Andrea Gallo, 4 agosto 1807, Siracusa, Biblioteca arcivescovileAlagoniana, Registro d'ordini, e lettere per le antichitaÁ delle due Valli Noto e Demone,p. 412.
8 Forse anche nau.4.2, nau.vi.1*, nau.14.1.
Il bollo dalori*a
Un mattone (g.ii.1.1, figg.3.1-2) presenta, al centro di duefacce laterali contigue, un carti-glio ansato con la parola doricadalori* a che, sul lato intera-mente conservato, ha, a sinistrae a destra, due bolli quadrango-lari di minori dimensioni conmonogrammi leggibili, rispetti-vamente, come LAR e AIR (oAR). Sul lato parzialmente con-servato, a destra del cartiglio an-sato con [da]lori* a si conservaun bollo quadrangolare con mo-nogramma AIR (o AR) identico aquello sull'altro lato. Il bolloprincipale, derivante dalla stessamatrice, appartiene a quella cate-
417testi e monumenti
Fig. 1.1 - Taormina, la `Naumachia' vistada Sud.
Fig. 1.2 - Taormina, la `Naumachia' vista da Nord.
goria di bolli, ampiamente noti, che denotano una fabbricazione e/o unadestinazione pubblica del laterizio.9 Un mattone con bollo analogo eÁrinvenuto nella prima metaÁ del XVIII 9secolo da Giovanni di Giovanni
418 testi e monumenti
Fig. 2.1 - Bollo g.i.1.1 (immagine ruotata di 180o rispetto alla realtaÁ).
Fig. 2.2 - Bollo g.i.2.1.
Fig. 2.3 - Bollo g.i.2.2 (immagine ruotata di 180o rispetto alla realtaÁ).
9 Sui bolli di questo tipo vd., in generale, M. Guarducci, Epigrafia greca,II. Epigrafi di carattere pubblico (Roma, 1969), pp. 486-502; Ead., L'epigrafiagreca dalle origini al tardo impero (Roma, 1987), pp. 240-241; M.F. Billot,Centres de production et diffusion des tuiles dans le monde grec, in F. Blonde &A. MuÈ ller (edd.), L'artisanat en GreÁce ancienne, les productions, les diffusions,Actes du colloque, Lyon, 1998 (Lille, 2000), p. 205; vd. anche P. Mingazzini, in
419testi e monumenti
Fig. 2.4 - Bollo g.i.2.5.
«AttiMemMagnaGr», n.s., I, 1954, pp. 55-60, e in «RendLinc», s. viii, XXV,1970, pp. 403-429; A. Orlandos, Les mateÂriaux de construction et la techniquearchitecturale des anciens Grecs, I (Paris, 1966: EÂ cole francËaise d'AtheÁnes. Tra-vaux et meÂmoires, 16), pp. 93-95; V. Morizio, in M. Chelotti, V. Morizio &M. Silvestrini (edd.), Le epigrafi romane di Canosa, II (Bari, 1990: Documenti estudi, 7**), pp. 45-46; D. Manacorda, I diversi significati dei bolli laterizi.Appunti e riflessioni, in P. Boucheron, H. Broise & Y. TheÂbert (edd.), Labrique antique et meÂdieÂvale. Production et commercialisation d'un materiau, Actesdu colloque international, Saint-Cloud, 1995 (Rome, 2000: Collection de l'EÂ -cole francËaise de Rome, 272), pp. 127-159; B. Garozzo, Bolli su anfore e lateriziin Sicilia (Agrigento, Palermo, Trapani) (Pisa, 2011: Pubblicazioni della classe dilettere e filosofia, Scuola normale superiore, 36), pp. 630-632; L. Vecchio, in«MinEpigrP», XII-XV/14-17, 2009-12, pp. 63-114. Per limitarsi solo a qualcheconfronto in cui l'aggettivo appare al femminile singolare vd. i bolli dalori* a edglori* a (B.G. Intzesiloglou, <Jakki*hgqa\. \Aqvaiokocijo+ | jai+ i<rsoqijo+ | o< dgco+ |lia& | a\qvai*a| po* kg| rso+ Jakki*hgqo (Re*jkifa) Jaqdi*sra|, Kallithiro, 1997, p. 26,fig. 29, sec. III a.C.); da[lor]i* a (N. Ceka, in «Iliria», XII, 1982, p. 104, nr. 7,sec. III-II a.C.); [d]alo[r]i* a (SEG XXXIV, 588a, Ambracia, c. 200 a.C.); da-lori* a (SEG XLII, 1093, Ilio); dalori* a | Samacqg* xm (R.C.S. Felsch, in «AM»,XCIV, 1979, p. 31, cat. e3b). Per bolli laterizi di Segesta con DA in nesso,interpretati come da(lo* riom) o da(lori* a jeqali* |) vd. Garozzo, Bolli, cit., pp.630-632; un caso dubbio eÁ su una tegola di Akrai che G. Pugliese Carratelli,in «PdP», XVI, 1951, p. 73 e Id., in L. BernaboÁ Brea, Akrai (Catania, 1956),p. 159, nr. 16 trascrive: [dalori* ]a (vel [i< eq]a* , scil. jeqali* |) hea& m a< cm[a& m]. G.Manganaro, Sikelika. Studi di antichitaÁ e di epigrafia della Sicilia greca (Pisa-Roma, 1999: Biblioteca di «QuadUrbin», 8), p. 47, nr. 36, fig. 111, legge[?D]alo* |riom su un mattone di Aidone.
(g.ii.a); un'iscrizione dalori* a eÁ trascritta nel 1727 da Jacques PhilippeD'Orville presso Giovanni Battista La Camiola. 10 Un'altra probabile at-testazione del bollo dalori* a ± o comunque di questo aggettivo ± eÁ su unmattone rinvenuto nel riempimento della cisterna scoperta nel 2001presso l'HoÃtel Timeo, a poca distanza dal Teatro antico (g.ii.2.1).
Il bollo i<eqa*
L'aggettivo i< eqo* | eÁ ampiamente attestato, nelle sue varie forme, perindicare laterizi destinati a edifici sacri e/o prodotti dai santuari. 11 ATaormina, i< eqa* compare:
420 testi e monumenti
Fig. 3.1±2 - Bolli g.ii.1.1.
10 DKLORIA, cioeÁ d<a>lori* a, vd. J.-P. D'Orville, Sicula (Amstelae-dami, 1764), p. 575, nr. 5 (`Tauromenii, in domo Joh. Bapt. la Caniola[sic], in lapide instar sigilli facto'), da cui I. Franz, in CIG III, 5646. Inter-pretando alla lettera l'indicazione di D'Orville, si tratterebbe di un'iscrizionesu pietra (matrice di bollo?), tranne che non si voglia ipotizzare che `in lapide'sia una svista per `in latere'; sembra questo l'orientamento di Kaibel, cheinserisce questa iscrizione tra i bolli laterizi (IG XIV, 2396/1b); vd. ancheF. Muscolino, in «BdA», s. vii, XIV, 2012, p. 31 e n. 10.
11 In generale, oltre a Orlandos, Les mateÂriaux, cit., e Manacorda, Idiversi significati, cit., vd. M. Guarducci, Epigrafia greca, IV. Epigrafi sacrepagane e cristiane (Roma, 1977), pp. 284-290, Billot, Centres, cit., pp. 204-205, e R.J.A. Wilson, Brick and Tiles in Roman Sicily, in A. McWhirr (ed.),Roman Brick and Tile. Studies in Manufacture, Distribution and Use in theWestern Empire (Oxford, 1979: BAR-IS, 68), p. 23, con particolare riferi-
± in un bollo quadrangolare (g.iii.1.1, fig. 4.1); 12
± in un cartiglio ansato di due tipi diversi, uno di dimensioni maggiori(g.iii.2.1-2, figg. 4.2-3), 13 l'altro di dimensioni minori (g.iii.3.1, fig. 4.4);
± preceduto da un monogramma 14 e seguito da pi, in un cartiglioansato (g.iii.4.1-2, figg. 4.5-6). 15
421testi e monumenti
mento alla Sicilia, come poi Id., Iscrizioni su manufatti siciliani in etaÁ ellenistico-romana, in M.I. Gulletta (ed.), Sicilia epigraphica, Atti del convegno inter-nazionale, Erice, 1998 (Pisa, 1999: «ASNP», s. iv, Quaderni, 2), p. 539. Per laSicilia si citano i seguenti esemplari:
± Entella e Monte Iato, bollo i< eqai* su tegole: Garozzo, Bolli, cit., pp.647-649;
± Alesa, bollo i< eqx& m su mattoni: G. Carettoni, in «NSc», 1959, pp. 324 e334, fig. 30b; Guarducci, Epigrafia, II, cit., p. 499 (legge i< eqx& m); P. Mingaz-zini, in «RendLinc», s. viii, XXV, 1970, p. 417 (considera < Ie* qxm come nomedel re di Siracusa);
± Lipari, bollo i< eqx& m su tegola: M. Cavalier & A. Brugnone, in «Koka-los», XXXII, 1986, pp. 206, 229, nr. 45, tav. 36e (Brugnone legge i< eqx& m, purnon escludendo la lettura <Ie* qxm, nome proprio di un fabbricante);
± Messina, bolli i< eqa* su mattone (anche in associazione con \Apo* kkxmo|):A. Salinas, in «NSc», 1886, pp. 460-462; IG XIV, 2394/1; P. Orsi, in «Mo-nAnt», XXIV, 1916, coll. 193 e 196; P. Mingazzini, in «RendLinc», s. viii,XXV, 1970, p. 406, nr. 3; M.T. Manni Piraino, in «Kokalos», XVIII-XIX,1972-73, p. 347; Bitto, Le iscrizioni, cit., pp. 120-121; Ead., Manufatti, cit., p.172; un bollo i< eqa* \Apo* kkxmo| eÁ attestato anche a Reggio Calabria (G. Cami-niti, in «NSc», 1890, pp. 195-196).
Per un esemplare di Centuripe con IEQ[- - -], G. Biondi, Per una cartaarcheologica del territorio di Centuripe, in G. Rizza (ed.), Scavi e ricerche a Cen-turipe (Catania, 2002: Studi e materiali di archeologia mediterranea, 1), pp. 54-56, nr. 12/3, fig. 19, preferisce l'integrazione < Ie* q[ajo|] sulla base del confrontocon bolli laterizi editi da F. Ansaldi, Memorie storiche di Centuripe (Catania,1871), riedizione a cura di A. Cacia (Catania, 1981), p. 313, nr. 7, p. 316, nr.20; IG XIV, 2397/3. Per esemplari con i< eqai* /i< eqo* | preceduti da uno o piuÁmonogrammi vd. infra, n. 15. Fuori dalla Sicilia, limitandosi ai casi in cuil'aggettivo appare al femminile singolare, si citano, ad esempio: i< aqa* (A. JardeÂ& M. Laurent, in «BCH», XXVI, 1902, p. 336, nr. 6, Delfi); [\Ahama& ]| (?) i< aqa*(SEG XXXI, 405, Cheronea, sec. IV a.C.); [i< a]qa* (SEG XXXIII, 477, Dodona,sec. II a.C.); i< eq[a* ] (SEG XLIII, 166, Messene, etaÁ ellenistica?); i< eqa* (R. Trum-mer, in «Klio», LXVIII, 1986, p. 61, cat. f, fig. 96, Aigeira).
12 Forse anche nau.xiii.3* e nau.14.4*.13 Forse anche nau.13.5*, nau.13.7*, nau.xiii.4*.14 Alpha a barra spezzata legato a sigma (?) e forse anche ad altre lettere
difficilmente leggibili.15 Limitandosi alla Sicilia, si citano i seguenti confronti:± i< eqo* | preceduto da due monogrammi: IG XIV, 2395/7, trascritto da
Mommsen `Cephaloedii apud baronissam Mandralisca' (delta e alpha in nesso,kappa e alpha in nesso, IE[- - -] integrabile come i< e[qo* |] o i< e[qa* ]; bolli analoghi
422 testi e monumenti
Fig. 4.1 - Bollo g.iii.1.1 (immagine ruotata di 180o rispetto alla realtaÁ).
Fig. 4.2 - Bollo g.iii.2.1.
sono pubblicati da P. Fiore, in «SicA», IV/14, 1971, pp. 37-39, in «SicA»,VII/26, 1974, p. 45, fig. 1, in «SicA», IX/31, 1976, pp. 43-48, con letturaDa* lasqo| i< eqo* |; P. Mingazzini, in «SicA», V/17, 1972, pp. 7-8, con letturada(lo* rio|) ja(i+ ) i< eqo* | (rxkg& m); G. Scibona, in «Kokalos», XVII, 1971, pp.21-25, con lettura (je* qalo|) da(lo* rio|) Jakajsi* (mxm) i< eqo* |. Un mattone conbollo simile, sporadico ma da livelli di etaÁ ellenistica, eÁ edito da C. Bonanno,in C. Bonanno (ed.), KaleÁ AkteÂ. Scavi in contrada Pantano di Caronia Marina,Messina, 2003-2005 (Roma, 2009), pp. 44-45, tav. 19, fig. 30, con i nessi scioltiin DA e JAS e con l'osservazione: `si tratta di materiale edilizio messo adisposizione dallo Stato per costruzioni di carattere sacro'; eÁ forse lo stessoesemplare menzionato da A. Lindhagen, Caleacte. Production and Exchange ina North Sicilian Town c. 500 BC-AD 500, tesi di dottorato (UniversitaÁ di Lund,2006), p. 99, come proveniente dagli scavi del 2003-2004. Per i bolli editi daFiore e Scibona, G. Manganaro, in «ANRW», II/11/1, 1988, p. 31 n. 134 eId., Bollatura fiscale dei laterizi per la vendita, in M.G. Angeli Bertinelli & A.Donati (edd.), Usi e abusi epigrafici, Atti del colloquio internazionale di epi-grafia latina, Genova, 2001 (Roma, 2003: Serta antiqua et mediaevalia, 6/Storia antica, 3), p. 382 n. 25, propone la lettura Da* (lot) Jakajs(i* mxm)i< eqo+ | (je* qalo|)
± i< eqai* preceduto da un monogramma, a Monte Iato ed Entella, Ga-rozzo, Bolli, cit., pp. 623-626.
423testi e monumenti
Fig. 4.3 - Bollo g.iii.2.2.
Fig. 4.4 - Bollo g.iii.3.1 (immagine ruotata di 180o rispetto alla realtaÁ).
Fig. 4.5 - Bollo g.iii.4.1.
Il bollo <Eqla& , <Gqajke*o|
Il bollo EQLAGQAJKEOR, interpretato come <Eqla& , <Gqajke* o|
(`di Hermes, di Herakles') eÁ giaÁ stato oggetto di uno studio specificoriguardante otto attestazioni attribuibili a due differenti tipi (g.iv.1.1-2 e g.iv.2.1-6) e due esemplari dispersi (g.iv.a-b) 16; successivamente,sono stati individuati un esemplare frammentario (g.iv.2.7, fig. 5.1) euno poco leggibile (g.iv.2.8, fig. 5.2), entrambi forse riferibili al secondotipo. Agli argomenti giaÁ esposti a sostegno di un collegamento tra questibolli e il ginnasio, si aggiunge l'iscrizione <Eqla& mo| ei\li* Jtkaqabisa& m
(`sono di Hermes dei Kylarabitai') su una tegola di Argo, cosõÁ spiegata
424 testi e monumenti
Fig. 4.6 - Bolli m.iii.1.4 (in basso a destra), m.v.1.1 (verso il centro), g.iii.4.2 (inalto a sinistra).
16 F. Muscolino, in «ZPE», CLXXXII, 2012, pp. 223-242: p. 227 per ladefinizione dei due tipi, il primo lungo almeno cm 10-11, alto circa cm 2, conlettere dal tratto piuttosto sottile alte circa cm 1; il secondo lungo circa cm 20,alto circa cm 2, con lettere dal tratto piuÁ spesso alte circa cm 1,5.
da Marie FrancËoise Billot: `les Cylarabites d'Argos, usagers du GymnaseCylarabis ou habitants du quartier, ont fait couvrir aÁ leurs frais le templeou la chapelle d'HermeÁs; ils partagent donc la proprieÂte des tuiles avec cedieu des gymnases'. 17
I bolli greci con nomi propri
Altri bolli presentano, al genitivo o al nominativo, nomi propri. Traquesti, uno (g.v.1.1, fig. 6), conservato `apud custodem theatri', e ogginell'Antiquarium del Teatro antico, eÁ trascritto da Theodor Mommsen e
425testi e monumenti
Fig. 5.1 - Bollo g.iv.2.7.
Fig. 5.2 - Bollo g.iv.2.8 (immagine ruotata di 180o rispetto alla realtaÁ).
17 Billot, Centres, cit., p. 205; vd. anche R. GinouveÁs, in «BCH»,LXXX, 1956, p. 399, che, tra le `tuiles inscrites' rinvenute ad Argo nel1955, cita un esemplare `mentionnant HermeÁs ( < Eqla& mo|)'.
da Georg Kaibel; quest'ultimo lo pubblica 18 con lettura Diomtri* ot b\,mostrando di interpretare Diomt* rio| come nome proprio 19 e b\ comenumerale. Daniele Manacorda formula l'ipotesi che il bollo sia da ricol-legare a Dionisio II di Siracusa, affermando che `si tratterebbe in tal casodi uno dei bolli piuÁ antichi con nomi di dinasti noti in area greca'. 20
L'autopsia del bollo edito da Kaibel e di un frammento inedito(g.v.1.2) rende peroÁ un po' scettici sull'ultima lettera, che presenta trai due occhielli un tratto orizzontale difficilmente spiegabile in un nor-male beta. In mancanza di spiegazioni valide per questa particolaritaÁ, eÁpreferibile limitarsi a considerare Diomt* rio|, che compare anche in unaltro bollo laterizio forse riconducibile a questo stesso tipo (g.v.1.3),come un semplice nome proprio, peraltro ben attestato nell'epigrafiatauromenitana. Nomi propri sono anche in due bolli circolari (Et> dxqo|o [H]et* dxqo|, g.vi.1.1, fig. 7; < Gqajkei* ot, g.vii.1.1, fig. 8), 21 e in uncartiglio ansato (Mijorsqa* sot, g.viii.1.1-2). Su due esemplari si legge\Ammi* ot (g.ix.1.1-2, fig. 9), come su tre matrici fittili rinvenute a Naxosnella cosiddetta `bottega del figulo', impianto produttivo datato da Ma-ria Costanza Lentini tra I secolo a.C. e I secolo d.C. 22 Oltre che di argilla,e verisimilmente di metallo, le matrici potevano essere di altro materiale:l'impressione di fessure nel bollo dalori* a (g.ii.1.1, figg. 3.1-2) farebbepensare a una matrice lignea, mentre l'iscrizione dalori* a attestata da
426 testi e monumenti
Fig. 6 - Bollo g.v.1.1.
18 IG XIV, 2396/2.19 Diomt* rio| b' (i.e. Diomtri* ot) eÁ elencato tra i Nomina et cognomina (IG
XIV, p. 716).20 Manacorda, I diversi significati, cit., p. 134 n. 44.21 Il nome < Gqajkei* ot, compare, al nominativo, in bolli su tegole di
Lipari (A. Brugnone, in «Kokalos», XXXII, 1986, pp. 226-228, nrr. 34-39,tavv. 33a-e, 37a).
22 Le matrici rinvenute nella `bottega del figulo', con lettere a rilievo,sono peroÁ concepite per realizzare impronte che, a differenza di g.ix.1.1, sonoa lettere cave. Su queste matrici vd. la bibliografia alle nn. 57-58.
D'Orville `in lapide instar sigilli facto' potrebbe essere interpretata comeuna matrice di pietra. 23
427testi e monumenti
Fig. 7 - Bollo g.vi.1.1. Fig. 8 - Bollo g.vii.1.1.
Fig. 9 - Bollo g.ix.1.1.
Fig. 10 - Bollo l.i.1.1.Fig. 11 - Bollo l.ii.1.1.
23 Vd. supra, n. 10.
I bolli latini
Pochi sono i bolli latini finora noti a Taormina. Theodor Mommsen(CIL X, 8045/39) registra un solo esemplare (l.i.1.1, fig. 10), con laparola Petri seguita da almeno un'altra lettera, in un bollo curvilineo sutegola piana o mattone. Per un altro bollo (l.ii.1.1, fig. 11), su tegolapiana o mattone, Antonino Salinas 24 propone il confronto con un esem-plare di Monteleone (oggi Vibo Valentia), che Mommsen (CIL X, 8041/34) legge Spha(erus?) Non(i?) s(ervus?), con il dubbio, confutato dall'esem-plare taorminese, che `initio potest aliquid deesse'; 25 il bollo eÁ attestatoanche a Reggio Calabria. 26 Sembra preferibile la lettura, giaÁ ipotizzata daLuigi BernaboÁ Brea, come Sphanionis, genitivo da un nome proprio*Sphanio. Altri bolli latini sono Iul(ii) Secu(ndi), su un mattone(l.iii.1.1, fig. 12), e C. Iuli(i) Veri, su una tegola piana (l.iv.1.1, fig. 13).
I bolli con monogrammi
Un frammento di tegola piana o mattone con un monogramma(m.i.1.1, fig. 14) in tabella ansata trova un buon confronto, per la parte
428 testi e monumenti
Fig. 12 - Bollo l.iii.1.1.
24 Vd. App. iii, infra, p. 466.25 V. Capialbi, in «Memorie dell'Instituto di corrispondenza archeolo-
gica», I, 1832, p. 186, nr. 33 (ora in Vito Capialbi. Scritti, a cura di M.Paoletti, Vibo Valentia, 2003: Collana di edizioni regionali sulla civiltaÁ cala-brese, 6, p. 31, nr. 33); Th. Mommsen, Inscriptiones Regni Neapolitani Latinae(Lipsiae, 1852), 6306/180; CIL X, 8041/34.
26 A.M. De Lorenzo, in «NSc», 1883, pp. 353, 521; G. Caminiti, in«NSc», 1892, p. 487.
sinistra del monogramma, le dimensioni della tabella e lo spessore dellaterizio, in due bolli su tegole piane di Lipari, per i quali AntoniettaBrugnone propone un collegamento con esemplari simili di Reggio Cala-bria 27 che, secondo la studiosa, potrebbe esserne il centro di produzione. 28
Attestato in tre esemplari eÁ un monogramma (m.ii.1.1-3, fig. 15)interpretato da Luigi BernaboÁ Brea come alpha a barra spezzata inscrittoin un pi,29 da Giacomo Manganaro come alpha a 29barra spezzata sormon-tato da un tratto orizzontale, `da sciogliere verosimilmente Sa(tqolemi-
429testi e monumenti
Fig. 13 - Bollo l.iv.1.1.
27 A.M. De Lorenzo, in «NSc», 1886, p. 62 e in «NSc», 1888, p. 593,nr. 10 (`monogramma ... entro cartello ansato di m. 0,07 � 0,04'); quest'ul-timo esemplare eÁ in IG XIV, 2400/15a (addenda), con lettura `Rseuam ... ?'.
28 A. Brugnone, in «Kokalos», XXXII, 1986, p. 240, nrr. 74-75, tav.53e; nr. 74: `Integra: alt. 85; largh. 56,5, spess. 2,5; bordo 5,5. Bollo in tabellaansata: 9 � 5,7. Monogramma: alt. 4,5. S, A, U, M, I in nesso; sul tratto destrodel ny OLEM con my ed epsilon in nesso. sa+ uaim[o* ]lema?'; nr. 75: `Fram-mento: alt. 48; largh. 42-30, spess. 3; bordo 6. Bollo in tabella ansata: 9,2 � 6.Monogramma: alt. 4,5. sa+ uaimo* lema'. Data la provenienza sporadica di en-trambi gli esemplari, non vi sono elementi per una loro datazione (M. Cava-lier, in «Kokalos», XXXII, 1986, p. 214). La lettura sa+ uaimo* lema ipotizzatada Brugnone (`il bollo, se la lettura eÁ esatta, potrebbe fare riferimento al fattoche esso era impresso nella faccia della tegola che sarebbe rimasta visibile nellacostruzione del tetto') eÁ respinta da L. D'Amore, in «ZPE», CXXIII, 1998, p.292 n. 4. Per laterizi con monogrammi costruiti avendo come base una o duelettere (`box monograms'), in genere entro quadrati, rettangoli o circonferenzevd., ad esempio, C. Mango, in «AJA», LIV, 1950, p. 21, fig. 3; S.J. Hill, TheBrickstamps, in Excavations at SaracËhane in Istanbul (Princeton, 1986-92), I, p.215, cat. c13-c15; J. Bardill, Brickstamps of Constantinople (Oxford, 2004),pp. 362-365, nrr. 1342-60 e pp. 368-371, nrr. 1377-93.
29 Come, ad esempio, in un mattone di Alesa, vd. G. Carettoni, in«NSc», 1959, p. 324, fig. 30a. A Monte Iato il monogramma formato da alphaa barra spezzata inscritto entro pi eÁ su un sigillo di piombo (H.P. Isler, in«SicA», XXX/93-95, 1997, p. 23, fig. 2) e su un blocco del teatro (H.P. Isler,in «SicA», XIX/62, 1986, p. 30, fig. 3).
sa& m)', cioeÁ `come etnico di Tauro-menion'. 30 In entrambi i casi siavrebbe un'interessante somiglianza con monogrammi su monete. 31
430 testi e monumenti
Fig. 14 - Bollo m.i.1.1.
Fig. 15 - Bollo m.ii.1.
30 G. Manganaro, in «ZPE», CXXXIII, 2000, p. 130, tav. 12, fig. 28.Tale scioglimento eÁ proposto sulla base del confronto con il monogrammaentro corona di ulivo su monete che sarebbero state emesse da mercenaricampani nel periodo in cui controllavano Taormina, vd. G. Manganaro, in«Chiron», XII, 1982, p. 241, tav. 6, figg. 7-8 (scioglie come Sa(tqolemisa& m)anche il monogramma composto da alpha sormontato da tratto orizzontale suuna ghianda missile) e in «Gnomon», LX, 1988, p. 456. Anche D. Castrizio,La monetazione mercenariale in Sicilia. Strategie economiche e territoriali fraDione e Timoleonte (Soveria Mannelli, 2000: Antiqua et nova, 5), pp. 53,115, tav. 17, propone di riferire a Tauromenion sia la serie con al D/ elmofrigio e al R/ tau e alpha in monogramma entro corona sia quella con al D/ tau ealpha in monogramma e toro cozzante a sinistra e al R/ astro a sedici raggi; vd.anche M. Puglisi, La Sicilia da Dionisio I a Sesto Pompeo. Circolazione efruizione della moneta (Messina, 2009: Pelorias, 16), p. 336, nr. 369 e Hoover,Handbook of Coins of Sicily, cit., p. 417, nrr. 1606, 1608-1609.
31 Se si accetta la lettura di BernaboÁ Brea, il monogramma sarebbe iden-tico a quello su monete sicuramente tauromenitane (vd., ad esempio, BMC,Sicily, p. 230, nr. 6); se si accetta quella di Manganaro, invece, si avrebbe unlegame con monete ipoteticamente riferite a Taormina (vd. n. precedente). Perun altro esempio di somiglianza tra monogrammi su mattoni e su monete, aCorcira, vd. B. Kindt, Les tuiles inscrites de Corcyre (Louvain-La-Neuve, 1997:Publication d'histoire de l'art et d'archeÂologie de l'Universite Catholique deLouvain, 95), pp. 30 e 108-109, nrr. 314-315. Un monogramma JAS, leggi-
L'autopsia fa propendere per la lettura di BernaboÁ Brea, poiche i trattiverticali del pi sono ben evidenti. Non dissimili dovevano essere, sumattoni rinvenuti in una sepoltura di Naxos, i bolli che, secondo PaoloOrsi, erano composti da alpha a barra spezzata entro quadrato. 32
431testi e monumenti
Fig. 16 - Bollo m.iii.1.1.
Fig. 17.1 - Bollo m.iv.1.1.
bile come Jas(amai* xm), su blocchi di una struttura in opera quadrata sotto ilteatro romano di Catania, trova confronto su monete mercenariali attribuite aKatane, con al D/ civetta e al R/ monogramma entro corona di ulivo (E.Tortorici, in «Atlante tematico di topografia antica», XVII, 2008, pp. 110-113, figg. 24-26; per le monete vd. Calciati, Corpus, cit., p. 94, cat. 2c eHoover, Handbook of Coins of Sicily, cit., p. 174, nr. 631).
32 Secondo P. Orsi, in «NSc», 1903, pp. 69-70, la copertura di unatomba `era formata da quattordici lastre di terracotta (m. 0,50 � 0,34 �
Sui mattoni della `Naumachia' sono presenti monogrammi ricondu-cibili a tre tipi, ciascuno attestato da diversi esemplari. Un monogramma(m.iii.1.1-4, figg. 4.6, 16) eÁ costruito intorno alla lettera my o sigma. Altrimonogrammi (m.iv.1.1-10, figg. 17.1-3, 20), di lettura non sempliceanche per il cattivo stato di conservazione, sembrano ricorrere accop-piati, almeno a giudicare dagli esemplari piuÁ completi: 33 in un bollo siriconosce omega, forse tra kappa e lambda, in un altro my, tau, epsilon eforse zeta. Un bollo (m.v.1.1-3, figg. 4.6, 18), anch'esso non ben leggi-
432 testi e monumenti
Fig. 17.2 - Bollo m.iv.1.5 (immagine ruotata di 180o rispetto alla realtaÁ).
0,15 spessore), disposte a doppio piovente', alcune con il bollo sopra descritto.Un altro mattone con alpha inscritto in pi eÁ stato ritrovato nel 1932 `nei pressidel giardino pubblico', secondo le Annotazioni allegate al Vecchio inventario(vd. anche F. Muscolino, in «ZPE», CLXXXII, 2012, p. 231 n. 59). Non eÁda escludere che i mattoni con i bolli m.ii.1.1-3 provengano da questi duerinvenimenti, o da uno di essi.
33 Forse anche nau.13.1 e nau.xvi.5*.
bile, presenta a sinistra un kappa e, a destra, un alpha a barra spezzata oun lambda combinato con altre lettere. 34
Provenienze
Presso Porta Messina eÁ stato trovato un laterizio con \Ammi* ot
(g.ix.1.1, fig. 9); dal parco dell'HoÃtel Timeo, sulla collina del Teatroantico, proviene un probabile esemplare di dalori* a (g.ii.2.1); il lateriziocon Sphanionis (l.ii.1.1, fig. 11) eÁ stato rinvenuto nel 1899 vicino allachiesa di San Pancrazio. 35 Dei mattoni con i< eqa* , due sono reimpiegati inetaÁ imprecisabile, ma certamente post-antica, forse addirittura post-me-dievale, nel muro di cinta Nord della cittaÁ, presso Porta Messina(g.iii.1.1, fig. 4.1; g.iii.4.1, fig. 4.5), uno (g.iii.2.1, fig. 4.2) eÁ stato
433testi e monumenti
Fig. 17.3 - Bollo m.iv.1.8 (immagine ruotata di 180o rispetto alla realtaÁ).
34 Forse anche nau.xvi.5*.35 Vd., App. iii, infra, p. 466.
rinvenuto nel 1932 presso la chiesa di Santa Caterina, che si sovrapponeparzialmente a un edificio templare, 36 e almeno un altro esemplare(g.iii.4.2, fig. 4.6) si trova tra i mattoni della `Naumachia', che presen-tano numerosi bolli, giaÁ notati nel Settecento. 37 Giuseppe Lugli, 38 ancheper la presenza (esclusiva, come si vedraÁ nel catalogo) di bolli greci, oltreche per l'eterogeneitaÁ delle dimensioni, considera di reimpiego i mattoniutilizzati nell'opera laterizia della `Naumachia', peculiare rispetto aquella degli altri monumenti taorminesi. 39
Per i mattoni con < Eqla& , < Gqajke* o| le provenienze note si adden-sano nelle aree di Bagnoli e di Santa Maria di GesuÁ dove, tra l'altro, bensette esemplari sono reimpiegati nelle `tombe saracene'. 40 Nei pressi delgiardino pubblico, quindi nell'area di Bagnoli, eÁ rinvenuto anche unmattone con monogramma accostabile a m.ii.1. 41 Il mattone con proba-bile bollo < Eqla& , < Gqajke* o| (g.iv.2.8, fig. 5.2), ancora in situ nella porti-cus di summa cavea del Teatro antico, eÁ in una parte dell'edificio gene-ralmente datata ad etaÁ traianea o adrianea; 42 se l'integrazione proposta eÁ
434 testi e monumenti
36 P. Pelagatti, in «Kokalos», XXII-XXIII, 1976-77, pp. 545-548.37 J.H. von Riedesel, Reise durch Sicilien und Groûgriechenland (ZuÈ rich,
1771), p. 150: `Das ganze Werk ist von Mattoni oder Backsteinen, von welchenviele in denen Bogen und Nischen mit RoÈmischen Buchstaben bezeichnet sind;welches anzeiget, dass dieses kein Griechisches Denkmal sein koÈnne' (M.J. deBorch, Lettres sur la Sicile et sur l'Ile de Malthe, Turin, 1782, I, p. 163, invece,scrive: `J'ai cherche les lettres romaines, dont parle Mr. de Riedesel, mais je n'aipu le deÂcouvrir'); J.-M. Roland de la PlatieÁre, Lettres eÂcrites de Suisse, d'Italie,de Sicile et de Malthe (Amsterdam, 1780), III, p. 270: `J'ai en effet eÂte frappe dela grandeur de quelques-unes de ces briques. Les caracteÁres Romains qu'on voitsur plusieurs, n'indiquent point que la Naumachie soit de construction Ro-maine, comme l'ont cru certains auteurs: il est vraisemblable qu'ils ne tiennentqu'aÁ des parties restaureÂes; & les inscriptions Grecques qu'on a trouveÂes d'ail-leurs, leur eÂtoient de beaucoup anteÂrieures'; D.V. Denon, Voyage en Sicile(Paris, 1778), p. 21: `Je trouvai sur les briques les empreintes ordinaires, avecdes caracteÁres que je crus grecs; mais ils eÂtoient si effaceÂs, qu'il ne me fut paspossible de les transcrire' (vd. anche Voyage pittoresque ou description des ro-yaumes de Naples et de Sicile, IV/1, Paris, 1785, p. 44); J. HoueÈl, Voyage pitto-resque des isles de Sicile, de Malte et de Lipari, II (Paris, 1784), p. 51: `J'airemarque sur plusieurs de ces briques des empreintes de petits caracteÁres grecs,qui vraisemblablement sont la marque du fabriquant'.
38 G. Lugli, Studi minori di topografia antica (Roma, 1965), pp. 210-212.39 Lugli, Studi, cit., p. 211; R.J.A. Wilson, Sicily under the Roman Empire.
The Archaeology of a Roman Province, 36 BC-AD 535 (Warminster, 1990), pp.97, 370 n. 252 e G.F. La Torre, in «Sicilia antiqua», V, 2008, p. 142.
40 F. Muscolino, in «ZPE», CLXXXII, 2012, pp. 223-242.41 Vd. supra, n. 32.42 Sulle fasi costruttive del Teatro antico vd. Wilson, Sicily, cit., pp. 70-
corretta, eÁ difficile pensare che nella piena etaÁ imperiale si realizzasseroancora mattoni con bolli in dorico, quando in Sicilia, accanto al latino, siutilizzava un greco di koineÂ. Questo esemplare, giaÁ frammentario quandoeÁ stato posto in opera, e ± se davvero provengono dal Teatro antico ±anche l'altro esemplare con < Eqla& , < Gqajke* o| (g.iv.b) e i mattoni condalori* a e monogrammi (g.ii.1.1, figg. 3.1-2) e con Diomtri* ot B (g.v.1.1,fig. 6), 43 sono probabilmente in condizione di reimpiego. Il paramentolaterizio della porticus e dell'ambulacrum, 44 e anche delle altre parti del
435testi e monumenti
Fig. 18 - Bollo m.v.1.2 (immagine ruotata di 180o rispetto alla realtaÁ).
78; F. Sear, in «BSR», LXIV, 1996, pp. 41-79; C. Rizzo & A. Mirabile,Taotea. Studi sul Teatro antico di Taormina (Gravina di Catania, 2006).
43 G. Lugli, La tecnica edilizia romana con particolare riguardo a Roma eLazio (Roma, 1957), I, p. 629, menziona, con trascrizioni approssimative esenza darne l'esatta collocazione, cinque bolli da lui visti su mattoni delTeatro antico (in situ o nei depositi?): GQAJKEIOI (g.iv? g.vii?), LORIA(g.ii?), DIOTISIOTR (g.v?), L . VESI, un bollo composto da V in un qua-drato, con un lato di cm 4 (m.ii?).
44 Sulla scorta di F. Sear, in «BSR», LXIV, 1996, pp. 64-65, si deno-mina porticus il portico interno, ambulacrum quello esterno. Altri mattoni conbolli, non leggibili a causa dell'altezza, sono nello stesso tratto del paramentointerno della porticus (due mattoni, rispettivamente nel quarto e nel sestofilare sotto la cornice che separa la parete dalla volta) (fig. 19), all'internodell'arco di scarico sulla terza porta da Est dell'ambulacrum (quarto filaredall'arco ribassato, primo mattone da destra). Un mattone con bollo illeggibilee di forma imprecisabile eÁ nel paramento interno del muro tra porticus eambulacrum, nel tratto tra terza e quarta porta da Est, quarto filare sopra la
Teatro antico, sembra presentare un numero di laterizi bollati percen-tualmente inferiore a quello della `Naumachia'. Si deve peroÁ tenere pre-sente che i paramenti laterizi del Teatro hanno subito nei secoli unaspoliazione ingente, forse superiore a quella della `Naumachia'. Nonsembra casuale che i mattoni con bolli si concentrino nel muro internodella porticus che, secondo Luigi BernaboÁ Brea, sotto la cui direzione sisvolsero importanti restauri, 45 era meglio conservato degli altri. 46 Gliesemplari individuati, inoltre, sono o su mattoni collocati in basso(g.iv.2.8, fig. 5.2), in punti verisimilmente un tempo coperti dai crollidelle volte, o troppo in alto per essere raggiunti (fig. 19).
Laterizi bollati provengono da zone che, in passato, erano parte
436 testi e monumenti
Fig. 19 - Mattoni con bollo nella porticus di summa cavea del Teatro antico.
risega di fondazione, quinto mattone da sinistra (primo non di restauro),lungh. cm 25 (cons.), spess. cm 8; bollo di cm 11 (cons.) per cm 2. Un mattonedi cm 18,5 (cons.), spess. cm 10, con bollo quadrangolare illeggibile di cm 3(cons.) per cm 3, eÁ utilizzato come caementum nell'opus caementicium nelprimo tratto del muro che separa la porticus dall'ambulacrum, in corrispon-denza del tempietto. Oltre all'altezza, anche la consunzione delle superficirende difficile individuare eventuali altri mattoni con bollo.
45 Sui restauri del Teatro nel 1949-1956 vd. L. BernaboÁ Brea, in«QuadMess», I, 2000, pp. 59-106; M.C. Lentini, in «BdA», 2004, volumespeciale, pp. 69-74.
46 L. BernaboÁ Brea, in «QuadMess», I, 2000, p. 72.
integrante del territorio di Taormina: l'antica Naxos, non piuÁ esistentecome polis dopo la sua distruzione nel 403 a.C., e Castelmola. Per Naxos,oltre ai mattoni con monogramma accostabile a m.ii.1 menzionati daOrsi, 47 si segnalano i rinvenimenti in contesti archeologici indagati daMaria Costanza Lentini (g.viii.1-2 e an.iii.1-2). Nel 1882, durante lavoriagricoli in una `proprietaÁ denominata la Portella dei Saraceni vicino ilCastello di Mola', sono rinvenuti mattoni bollati acquistati dal Museo diPalermo (g.ix.1.2, m.iv.1.10 e forse un bollo confrontabile con m.ii.1). 48
A poca distanza dalla `Portella dei Saraceni' eÁ stato possibile individuareun mattone con bollo reimpiegato in un casolare abbandonato (g.iii.3.1,fig. 4.4); numerosi sono i mattoni antichi riutilizzati negli edifici diCastelmola e delle sue campagne. In mancanza di altri elementi, non eÁpossibile precisare se questi mattoni provengano da un insediamento inloco ± quasi nulla si conosce, finora, dell'archeologia del territorio diCastelmola ± o dagli edifici antichi di Taormina.
Considerazioni generali
Sono prevalenti i bolli in greco, su mattoni, con una netta prefe-renza per i cartigli ansati e i bolli quadrangolari; piuÁ rari i bolli circolari;
437testi e monumenti
Fig. 20 - Taormina, `Naumachia', piattabanda della tredicesima nicchia (con ibolli nau.13.5*-9* e m.iv.1.9).
47 Vd. supra, n. 32.48 La relazione della `Guardia delle AntichitaÁ' Francesco Strazzeri al Regio
Commissariato dei musei e degli scavi di Sicilia a Palermo (8 dicembre 1882), conallegati ricalchi e disegni dei bolli, e i documenti sull'acquisto sono in ASMP,busta 678. I tre mattoni con bollo, acquistati per lire 2,50, sono registrati al nr. 20del Giornale di entrata del Museo, in data 20 febbraio 1883 (quest'ultima indi-cazione mi eÁ stata cortesemente fornita dalla prof.ssa Paola Pelagatti).
solo in un caso, un bollo (g.ii.2.1) eÁ su un mattone quadrato di notevolidimensioni ma con uno spessore pari a circa metaÁ di quello usuale. Dalpunto di vista paleografico e morfologico, i bolli greci presentano quasitutti una notevole somiglianza, che depone a favore di una loro vicinanzacronologica. Gli esemplari latini, in genere entro bolli quadrangolari osenza cornice, sono di solito su laterizi meno spessi: in un caso si trattacon certezza di una tegola piana (l.iv.1.1, fig. 13), in altri lo stato diconservazione impedisce di precisare se si tratti di tegole piane o mat-toni. Tra i mattoni con bolli greci, sembrano predominanti gli esemplaricon un lato di cm 32-34 per uno spessore di cm 8-11; sono attestati ancheesemplari di cm 50-52 per cm 34. 49 Anche se non eÁ facile individuare
438 testi e monumenti
Fig. 21 - Taormina, `Naumachia', particolare della sedicesima abside (con i bollinau.xvi.4*-5*).
49 Vd. App. ii, infra, p. 461. Il notevole spessore dei mattoni eÁ tipico in
l'unitaÁ di misura, 50 sembrerebbe trattarsi, in ogni caso, di una tradizionenon basata sul piede romano e attestata fino all'etaÁ imperiale.
Il criterio metrologico, per le osservazioni appena esposte, eÁ dunque dipoco aiuto ai fini cronologici; mancano, inoltre, i dati di contesto, se siesclude un esemplare (g.ii.2.1) proveniente da un riempimento non succes-sivo al II secolo a.C. 51 La costruzione della `Naumachia', collocabile traprima e media etaÁ imperiale, 52 eÁ un generico terminus ante quem per i mattoniche vi sono (ri?)utilizzati e per quelli che vi si possono accostare. Stessodiscorso per il mattone del Teatro antico (re?)impiegato in una parte del-l'edificio datata ad etaÁ traianea o adrianea. Per i mattoni con dalori* a, conSatqolemisa& m e con < Eqla& , < Gqajke* o| (se si accetta il collegamento con ilginnasio), e probabilmente anche per quelli con i< eqa* , eÁ verisimile una data-zione anteriore alla deduzione della colonia nel 36 o 21 a.C., perche i bolli
439testi e monumenti
Sicilia; oltre alle misure degli esemplari editi in questo contributo (Cat. e App.ii) vd. almeno, in generale, Lugli, Studi, cit., pp. 205, 210; Id., La tecnica,cit., p. 629; Wilson, Brick, cit., p. 15; Id., Sicily, cit., p. 268.
50 Tra gli esemplari con almeno uno dei lati conservato per intero, lemisure piuÁ frequenti sono comprese tra cm 32 e cm 34, con una media pari acirca cm 32,8, accostabile al cosiddetto piede `dorico' di circa cm 32,6-32,8, diproblematica definizione, su cui vd. A. Stazio, Metrologia greca (Torino, 1959:Enciclopedia classica, I/iii.6), pp. 550-552; H. Bankel, in «AM», XCVIII,1983, pp. 65-99; D. Mertens, CittaÁ e monumenti dei Greci d'Occidente. Dallacolonizzazione alla crisi di fine V secolo a.C. (Roma, 2006), p. 441 e passim. Sitenga presente, peroÁ , quanto osserva J.A.K.E. De Waele, I grandi templi, inL. Braccesi & E. De Miro (edd.), Agrigento e la Sicilia greca, Atti dellasettimana di studio, Agrigento, 1988 (Roma, 1992), pp. 157-205, sull'impos-sibilitaÁ di individuare un piede fisso usato in vaste aree, poiche le unitaÁ dimisura possono cambiare addirittura nella stessa cittaÁ, da un edificio all'altro.Per uno status quaestionis vd. F. Tomasello, Metrologia e proporzionamento.Per una individuazione dei sistemi sicelioti, in P. MinaÁ (ed.), Urbanistica earchitettura nella Sicilia greca (Palermo, 2005), pp. 201-204.
51 In attesa di una pubblicazione complessiva, vd. F. Muscolino, in«ArchEspA», LXXIX, 2006, p. 220.
52 Per una discussione sulla cronologia dell'edificio, con riferimento allealtre datazioni ipotizzate, vd. G.F. La Torre, in «Sicilia antiqua», V, 2008, pp.140-143, che colloca il monumento tra la deduzione della colonia e l'etaÁ flavia;datazioni piuÁ tarde sono proposte da Wilson, Brick, cit., p. 15 (`probably of thesecond half of the second century A.D.') e Lugli, Studi, cit., p. 211 (tra la finedel II sec. d.C. e l'etaÁ severiana). Non puoÁ essere accolta, invece, la datazione alIII-II sec. a.C. proposta da Pace (vd. supra, n. 5) per le somiglianze nella formadelle lettere tra la legenda Satqolemisa& m su monete datate tra III e II sec. a.C. ela stessa parola nei bolli di alcuni mattoni della `Naumachia'; questa somi-glianza paleografica, semmai, corrobora la datazione al III/II-I sec. a.C. propo-sta per gli esemplari con Satqolemisa& m e altre forme doriche.
sembrano presupporre quell'organizzazione politica che, per Tauromenion,eÁ ben testimoniata dal corpus delle iscrizioni pubbliche greche. Anche l'usodi forme doriche nei primi tre bolli citati depone a favore di una datazionenon molto avanzata, 53 che difficilmente puoÁ superare le soglie dell'etaÁ im-periale. 54 L'uso della forma ionico-attica di koineÁ i< eqa* invece del dorico i< aqa*non implica una posterioritaÁ rispetto ai mattoni con forme doriche: nella`koinaÁ dorica', che caratterizza il greco di Sicilia in etaÁ ellenistica, i< eq- eÁcomunemente attestato. 55 Si potrebbe quindi ipotizzare, come giaÁ per gliesemplari con < Eqla& , < Gqajke* o|, 56 una datazione tra III/II e I secolo a.C.Per gli esemplari latini, in assenza di altri elementi, ci si limita a proporre unagenerica datazione all'etaÁ romana, forse a partire dal I secolo a.C. 57
EÁ verisimile che i laterizi siano stati in gran parte prodotti in loco, epiuÁ precisamente nel territorio dell'antica Naxos che, grazie all'affioraredi banchi di argilla, eÁ stato un importante centro di produzione per tutta
440 testi e monumenti
53 La koinaÁ dorica siciliana, cioeÁ quella varietaÁ dialettale nata dall'intera-zione tra dorico siciliano e koineÁ ionico-attica, eÁ ben attestata fino al I sec. a.C.circa; a Tauromenion eÁ utilizzata nei rendiconti finanziari, ad eccezione dei piuÁrecenti (vd. almeno Guarducci, Epigrafia, cit., II, p. 290), e in iscrizioni databilitra III e prima metaÁ del I sec. a.C. (IG XIV, 432, 433, 434, 437; SEG XXXII, 936e 937); sulla koinaÁ dorica siciliana vd. S. Mimbrera Olarte, FoneÂtica y morfologõÂadel dorio de Sicilia (siglos VII-I a.C.) (Madrid, 2012: Manuales y anejos de «Eme-rita», 52); Ead., The Sicilian Doric Koina, in O. Tribulato (ed.), Language andLinguistic Contact in Ancient Sicily (Cambridge, 2012), pp. 223-250.
54 Le iscrizionigrechesiciliane,dal I sec.a.C. inpoi,usanoquasiesclusivamentela koineÁ ionico-attica; vd. C. Consani, I dialetti greci in etaÁ ellenistica e romana: ladocumentazione epigrafica della Magna Grecia e di Sicilia, in P. Cuzzolin (ed.), Studidi linguistica greca (Milano, 1995), pp. 73-89; K. Korhonen, Language and Identity inthe Roman Colonies of Sicily, in R.J. Sweetman (ed.), Roman Colonies in the FirstCentury of their Foundation (Oxford, 2011), p. 20; Id., Sicily in the Roman ImperialPeriod. Language and Society, in Tribulato (ed.), Language, cit., p. 365. Non vi sono,inoltre, elementi per ipotizzare a Taormina un `revival' dialettale come quello atte-stato, con limitati esempi, in altre aree (vd.C.D.Buck, The Greek Dialects. Grammar,Selected Inscriptions, Glossary, Chicago, 1955, p. 180): le iscrizioni greche tauromeni-tane di etaÁ imperiale, soprattutto di carattere funerario (vd. F. Muscolino, in«RACr», LXXXVII-LXXXVIII, 2011-12, pp. 209-249), non hannoelementi dorici.
55 Dal IVsec. a.C. i< eq- eÁ piuÁ comunedi i< aq-nelle iscrizionidorichesiciliane;vd.MimbreraOlarte, FoneÂtica, cit., pp. 117-118;Ead.,The SicilianDoric koina, cit., p.246. Nelle iscrizioni doriche di Tauromenion (vd. supra, n. 53), eÁ attestato solo i< eq-.
56 F. Muscolino, in «ZPE», CLXXXII, 2012, pp. 227-228.57 M.C. Lentini & F. Muscolino, Fornaci e produzioni di anfore e laterizi
tra Naxos e Taormina (III-I secolo a.C.) e rapporti con le aree tirreniche, in G.Olcese (ed.), Immensa aequora. Ricerche archeologiche, archeometriche e infor-matiche per la ricostruzione dell'economia e dei commerci nel bacino occidentaledel Mediterraneo, Atti del workshop, Roma, 2011, c.d.s.
l'antichitaÁ e sino alla metaÁ circa del XX secolo. 58 Solo per alcuni laterizisi puoÁ ipotizzare una provenienza non locale, forse calabrese: eÁ il casodegli esemplari con Sphanionis (l.ii.1.1, fig. 11) e con monogramma entrotabella ansata (m.i.1.1, fig. 14). 59
Catalogo 60
g.i.1.1 (fig. 2.1). Taormina, `Naumachia', sotto l'undicesima nic-chia rettangolare, settimo filare, terzo mattone da sinistra, posto in operacapovolto (nau.11.1), cm 32, spess. cm 10; sullo spessore, bollo quadran-
441testi e monumenti
58 M.C. Lentini, Naxos di Sicilia dall'etaÁ ellenistica all'etaÁ bizantina e B.Garozzo, Alcuni bolli ellenistici da Naxos di Sicilia, in M.C. Lentini (ed.),Naxos romana e bizantina: Naxos di Sicilia in etaÁ romana e bizantina ed evidenzedai Peloritani (Bari, 2001), pp. 13-39 e 41-46; C.M. Coletti & M.C. Lentini,in G. Olcese (ed.), Atlante dei siti di produzione ceramica (Toscana, Lazio,Campania e Sicilia), con le tabelle dei principali relitti del Mediterraneo occiden-tale con carichi dall'Italia centro meridionale, IV secolo a.C.-I secolo d.C. (Roma,2012: Immensa aequora, 2), pp. 464-465; Lentini & Muscolino, Fornaci, cit.
59 Bolli con mattoni sicuramente reggini sono, tra l'altro, attestati aMessina: vd., in particolare, M.L. Lazzarini, in «Klearchos», XXIV, 1982,pp. 145-157 e L. D'Amore, in «ZPE», CXXIII, 1998, pp. 291-296; vd. ancheLentini & Muscolino, Fornaci, cit.
60 Nella compilazione di questo catalogo si usano:± g., l., m., an., rispettivamente per i bolli greci, i bolli latini, i mono-
grammi e i bolli anepigrafi;± i numeri romani per distinguere le parole, i monogrammi o i motivi
ornamentali;± il primo numero arabo per indicare i diversi tipi, derivanti in genere
dalla stessa matrice;± il secondo numero arabo per indicare gli esemplari di ciascun tipo;± una lettera minuscola dopo il numero romano per indicare i bolli non
piuÁ rintracciabili;± l'asterisco (*) per i mattoni della `Naumachia' che non sono stati
schedati a causa dell'elevata altezza alla quale sono collocati;± il segno di approssimazione (�) per i mattoni della `Naumachia' dei
quali non eÁ possibile indicare la posizione esatta, all'interno del filare, a causadelle concrezioni.
Per le altre abbreviazioni vd. supra, n. *. Il 17 luglio 2012 eÁ statoriaperto al pubblico l'Antiquarium del Teatro antico, con una nuova esposi-zione non comprendente i mattoni con bollo, da me schedati presso l'Anti-quarium nel settembre-novembre 2010. L'indicazione `Antiquarium del Tea-tro antico', che si eÁ scelto di mantenere, si riferisce dunque piuÁ che al luogoreale di conservazione ± i depositi adiacenti all'Antiquarium ± alla collezionestorica cui la maggior parte dei mattoni appartiene, in alcuni casi dalla secondametaÁ dell'Ottocento.
golare che tende ad allargarsi verso il centro, alto cm 0,7/0,9 alle dueestremitaÁ e cm 1,2 al centro, lungo cm 8,6; alt. lettere cm 0,4.
SATQOLEMISAM Satqolemisa& m
Per la bibliografia vd. supra, nn. 5-6.
g.i.1.2. Taormina, `Naumachia', terza abside, undicesimo filare,sesto mattone da destra (nau.iii.3), cm 19 (cons.), spess. cm 10,5; sullospessore, bollo quadrangolare che tende ad allargarsi verso il centro, altocm 0,8 all'estremitaÁ conservata e cm 1,2 al centro, lungo cm 6,3 (cons.);alt. lettera cm 0,4.
[- - -]E[- - -] [Satqol]e[misa& m]
Per la bibliografia vd. supra, nn. 5-6.
g.i.2.1 (fig. 2.2). Taormina, `Naumachia', a sinistra della diciasset-tesima nicchia rettangolare, ventesimo filare, primo mattone da destra(nau.17.4), cm 32 per cm 31 (cons.), spess. cm 10; sullo spessore del latointeramente conservato, cartiglio ansato di cm 12,2 per cm 1,8; alt.lettere cm 1.
SATQ . LEM . SAM Satq[o]lem[i]sa& m
Per la bibliografia vd. supra, nn. 5-6.
g.i.2.2 (fig. 2.3). Taormina, `Naumachia', dodicesima abside, di-ciannovesimo filare, settimo mattone da destra, posto in opera capovolto(nau.xii.4), cm 23 (cons.), spess. cm 10,5; sullo spessore, cartiglio ansatodi cm 10 per cm 2; alt. lettere cm 1.
SATQOLEMISA . 61 Satqolemisa& [m]
Per la bibliografia vd. supra, nn. 5-6.
g.i.2.3*. Taormina, `Naumachia', sedicesima abside, trentottesimofilare, terzo mattone da sinistra (nau.xvi.3*); sullo spessore, cartiglioansato.
SATQOL[- - -] Satqol[emisa& m]
Per la bibliografia vd. supra, nn. 5-6.
g.i.2.4. Taormina, `Naumachia', lato destro della quattordicesimanicchia rettangolare, ventitreesimo filare, primo mattone da destra, po-sto in opera capovolto (nau.14.2), cm 29 (cons.) per cm 17 (cons.), spess.
442 testi e monumenti
61 Parola non molto visibile in fotografia, ma ben leggibile con il ricalcosu carta velina.
cm 11; sullo spessore del lato maggiormente conservato, cartiglio ansatodi cm 9,8 (cons.) per cm 2; alt. lettere cm 1.
[. .]TQO[. .]MISA[ . ] [Sa]tqo[le]misa& [m]
Per la bibliografia vd. supra, nn. 5-6.
g.i.2.5 (fig. 2.4). Taormina, `Naumachia', lato destro della tredice-sima nicchia rettangolare, ventinovesimo filare, primo mattone da destra(nau.13.4), cm 22 (cons.?) per cm 12 (cons.), spess. cm 11,5; sullo spes-sore del lato maggiormente conservato, cartiglio ansato di cm 8,6 (cons.)per cm 2; alt. lettere cm 1.
[- - -]OLEMI[. .]M [Satq]olemi[sa& ]m
Per la bibliografia vd. supra, nn. 5-6.
g.i.2.6 Taormina, `Naumachia', sotto la prima nicchia rettango-lare, quarto filare, quarto mattone da destra (nau.1.2), cm 32,5, spess.cm 11; sullo spessore, cartiglio ansato di cm 12,2 per cm 1,8; alt. letterecm 0,9.
SA . . . LE[- - -] Sa[tqo]le[misa& m]
Per la bibliografia vd. supra, nn. 5-6.
g.ii.1.1 (figg. 3.1-2). Taormina, Antiquarium del Teatro antico,inv. 41. 62 Mattone di cm 34 per cm 31 (cons.), spess. cm 10,5. Sullospessore del lato interamente conservato, al centro cartiglio ansato dicm 12,5 per cm 2,2, alt. lettere cm 1,4, con dalori* a; a sinistra, bolloquadrangolare di cm 3 per cm 2,5, con monogramma composto dallelettere LAR; 63 a destra, capovolto, bollo quadrangolare di cm 3 per cm2,5, con monogramma AR o AIR (il R non ben leggibile). 64 Sullo spes-sore del lato a sinistra di quello interamente conservato, cartiglio an-sato, mutilo a sinistra, di cm 8,5 (cons.) per cm 2,2, con [da]lori* a; adestra, bollo quadrangolare di cm 3 per cm 2,5, con monogramma AR oAIR. Su una delle facce, tracce di materiale cementizio, forse dovuteanche al fatto che, come testimonia Rizzo (vd. infra), il mattone inpassato era esposto `nel museo locale, murato sopra un tronco di co-lonna' con g.v.1.1.
443testi e monumenti
62 Il numero eÁ tracciato sullo spessore.63 My al centro, alpha all'interno della parte destra triangolare del my,
sigma tangente alla parte alta esterna del my. Anche Stevenson propone questoscioglimento del monogramma.
64 Alpha a sinistra, sigma a destra; tra le due lettere sembra esserci iota;BernaboÁ Brea scioglie il monogramma come AIR.
Sul lato interamente conservatoa sinistra: LAR LAR
al centro: DALORIA dalori* a
a destra: AR vel AIR AR vel AIR
Sull'altro latoal centro: [- - -]LORIA [da]lori* aa destra: AR vel AIR AR vel AIR
G. Kaibel, in IG XIV, 2396/1a (`descripsi'), da cui G. Rizzo, in «Ar-chivio storico messinese», IV, 1904, p. 118 (`scavato nel teatro'), P.Mingazzini, in «AttiMemMagnaGr», n.s., I, 1954, p. 56, nr. 4 e in«RendLinc», s. viii, XXV, 1970, p. 406, nr. 2.
BAV, Vat. lat. 10574, f. 182r, ricalco su carta velina dei bolli LAR
e dalori* a, del bollo [da]lori* a e del solo bollo LAR, a cura di E. Ste-venson iunior.
g.ii.2.1. Giardini Naxos, depositi presso il Parco archeologico; daTaormina, cisterna rinvenuta nel 2001 nel parco dell'HoÃtel Timeo. Mat-tone di cm 37,8 per cm 37,8, spess. cm 4. La superficie del mattone eÁlisciata sullo spessore e su una delle facce che presenta, verso il centro, unbollo quadrangolare del quale solo la parte sinistra eÁ stata ben impressa,alto cm 1,5 e lungo, nella parte impressa, cm 4.
D . LOR[- - -] d[a]lor[i* a] vel sim.
Inedito.
g.ii.a. Collocazione attuale sconosciuta.DALORIA dalori* a
G. di Giovanni, in BCP, ms. Qq h 129, ff. 165r (`In alio coctili latereTaurome|nij per nos reperto'), 167r (`In coctili quoque latere, Tauro-menij per nos reperto') e BEUMo, AM, filza 36, fasc. 8, c. 186r (`In aliococtili latere Taurome|nij per nos reperto'). 65
g.iii.1.1 (fig. 4.1). Taormina, paramento interno del muro di cintaNord, a Est di Porta Messina, in Vicolo della Zecca. Mattone, posto inopera capovolto, di cm 22,5 (cons.), spess. cm 9; sullo spessore, bolloquadrangolare di cm 6 per cm 3; alt. lettere cm 1,4.
IEQA i< eqa*
Inedito.
444 testi e monumenti
65 Vd. anche F. Muscolino, in «ZPE», CLXVII, 2008, pp. 130 e 134,fig. 3, e in «BdA», s. vii, XIV, 2012, p. 31 e n. 15.
g.iii.2.1 (fig. 4.2). Taormina, Antiquarium del Teatro antico, inv.46. 66 Mattone di cm 27 (cons.) per cm 16 (cons.), spess. cm 8,1. Su unadelle facce maggiori, cartiglio ansato di cm 9,6 per cm 2,3; alt. lettere cm1,5. EÁ probabilmente il mattone rinvenuto nel 1932 presso la chiesa diSanta Caterina. 67
IEQA i< eqa*
Inedito.
g.iii.2.2 (fig. 4.3). Taormina, Antiquarium del Teatro antico, inv.provv. 5. 68 Mattone di cm 18 (cons.) per cm 18 (cons.), spess. cm 7,1;sullo spessore, cartiglio ansato di cm 10,6 per cm 2,5; alt. lettere cm 1,5.
IEQA i< eqa*
Inedito.
g.iii.3.1 (fig. 4.4). Castelmola, nella vera della cisterna di un caso-lare abbandonato a Sud-Ovest del `Piano delle Ficare', tra le contradeSifone a Ovest e Decima a Est. Mattone, posto in opera capovolto, di cm20 (cons.), spess. cm 9; sullo spessore, cartiglio ansato di cm 4 (cons.) percm 2; alt. lettere cm 1.
IE[QA] i< e[qa* ]Inedito.
g.iii.4.1 (fig. 4.5). Taormina, paramento interno del muro di cintaNord, a Est di Porta Messina, in Vicolo della Zecca. Mattone di cm 19(cons.), spess. cm 9; sullo spessore, cartiglio ansato di cm 10,5 per cm 2;alt. lettere cm 1,3.
AR (?) IEQAP AR (?) i< eqa* PInedito.
g.iii.4.2 (fig. 4.6). Taormina, `Naumachia', dodicesima abside,quinto filare, mattone verso il centro (�), posto in opera capovolto(nau.xii.3), cm 23 (cons.), spess. cm 10; sullo spessore, cartiglio ansatodi cm 6,8 (cons.) per cm 1,8; alt. alpha cm 1,3.
[- - -]AP [- - - i< eq]a* PInedito.
445testi e monumenti
66 Il numero eÁ tracciato su una delle facce maggiori.67 Nelle Annotazioni allegate al Vecchio inventario si legge: `un frammento di
mattone romano con la sigla IEQA rinvenuto davanti la porta di S. Caterina' e, inun'altra pagina, `il 15 maggio 1932 davanti la porta di S. Caterina si eÁ rinvenutoun frammento di mattone romano con il bollo di fabbrica IEQA'.
68 Il numero eÁ scritto a destra del bollo e su un cartellino attaccato almattone.
g.iv.1.1. Taormina, Antiquarium del Teatro antico, inv. 45. Mat-tone di cm 17,5 (cons.) per cm 13,5 (cons.), spess. cm 8,4; sullo spessoredel lato maggiormente conservato, cartiglio ansato di cm 11 (cons.) percm 1,7/1,9; alt. lettere cm 0,9.
EQLAGQAJKEOR < Eqla& , < Gqajke* o|
F. Muscolino, in «ZPE», CLXXXII, 2012, p. 231, nr. 3, figg. 4.1-2.
g.iv.1.2. Taormina, `tombe saracene'. Mattone di cm 23 (cons.) percm 21 (cons.), spess. cm 8; sullo spessore del lato maggiormente conser-vato, cartiglio ansato di cm 10,2 (cons.) per cm 1,9; alt. lettere cm 1.
EQLAGQAJKE[- - -] < Eqla& , < Gqajke* [o|]F. Muscolino, in «ZPE», CLXXXII, 2012, p. 231, nr. 5, figg. 6.1-2.
g.iv.2.1. Taormina, `tombe saracene'. Mattone di cm 14,5 (cons.)per cm 16 (cons.), spess. cm 8; sullo spessore del lato meno conservato,cartiglio ansato di cm 10 (cons.) per cm 1,8; alt. lettere cm 1,3.
EQLAG[- - -] < Eqla& , < G[qajke* o|]F. Muscolino, in «ZPE», CLXXXII, 2012, p. 231, nr. 4, figg. 5.1-2.
g.iv.2.2. Taormina, `tombe saracene'. Mattone di cm 22 (cons.) percm 16 (cons.), spess. cm 8,5; sullo spessore del lato maggiormente con-servato, cartiglio ansato di cm 14 (cons.) per cm 1,9; alt. lettere cm 1,5.
GQAJKEOR o, piuÁ probabilmente, [- - -]GQAJKEOR
<Gqajke* o| o, piuÁ probabilmente, [ < Eqla& ], < Gqajke* o|
F. Muscolino, in «ZPE», CLXXXII, 2012, pp. 231-232, nr. 6, figg. 7.1-2.
g.iv.2.3. Taormina, `tombe saracene'. Mattone di cm 32 per cm 25(cons.), spess. cm 8,2; sullo spessore del lato interamente conservato,cartiglio ansato di cm 19 (circa) per cm 2,1; alt. lettere cm 1,5; la metaÁsinistra eÁ illeggibile, forse anche perche impressa solo parzialmente; laparte leggibile misura cm 9,5.
[- - -]AJKEOR
[ < Gq]ajke* o| o, piuÁ probabilmente, [ < Eqla& , < Gq]ajke* o|F. Muscolino, in «ZPE», CLXXXII, 2012, p. 232, nr. 7, figg. 8.1-2.
g.iv.2.4. Taormina, `tombe saracene'. Mattone di cm 16 (cons.) percm 15 (cons.), spess. cm 8,3; sullo spessore, cartiglio ansato di cm 9,8(cons.) per cm 2; alt. lettere cm 1,4.
[- - -]AJKEOR
[ < Gq]ajke* o| o, piuÁ probabilmente, [ < Eqla& , < Gq]ajke* o|F. Muscolino, in «ZPE», CLXXXII, 2012, p. 232, nr. 8, figg. 9.1-2.
446 testi e monumenti
g.iv.2.5. Taormina, `tombe saracene'. Mattone di cm 26 (cons.) percm 23 (cons.), spess. cm 8,8; sullo spessore del lato maggiormente conser-vato, cartiglio ansato di cm 12 (cons.) per cm 2,3 (circa); alt. lettere cm 1,1.
E . . A[- - -] < E[ql]a& , [ < Gqajke* o|] (?)
F. Muscolino, in «ZPE», CLXXXII, 2012, p. 232, nr. 9, figg. 8.1, 10.
g.iv.2.6. Taormina, `tombe saracene'. Mattone di cm 30 (cons.) percm 16 (cons.), spess. cm 8,8; sullo spessore del lato meno conservato,cartiglio ansato di cm 6,4 (cons.) per cm 2,1; alt. lettere cm 1,5.
[- - -]KEOR [ < Gqaj]ke* o| (?) o [ < Eqla& , < Gqajk]e* o| (?)
F. Muscolino, in «ZPE», CLXXXII, 2012, p. 232, nr. 10, figg. 11.1-2.
g.iv.2.7 (fig. 5.1). Taormina, Antiquarium del Teatro antico, s.inv.Mattone di cm 15 (cons.) per cm 20 (cons.), spess. cm 8; sullo spessore dellato meno conservato, cartiglio ansato di cm 7,1 (cons.) per cm 1,9; alt.lettere cm 1,3.
[- - -]\EOR [ < Gqaj]ke* o| (?) o [ < Eqla& , < Gqaj]ke* o| (?)
Inedito.
g.iv.2.8 (fig. 5.2). Taormina, Teatro antico, porticus di summa ca-vea, paramento interno del muro tra porticus e ambulacrum, 69 nel trattotra la seconda e la terza porta da Est, terzo filare sopra la risega difondazione, quindicesimo mattone da sinistra, posto in opera capovolto,cm 25,6 (cons.), spess. cm 9; sullo spessore, cartiglio ansato di cm 18,5per cm 2,4; alt. epsilon cm 1,2; alt. omikron cm 0,7.
[- - -]EOR 70 [ < Gqajk]e* o| (?) o [ < Eqla& , < Gqajk]e* o| (?)
Inedito.
g.iv.a. Collocazione attuale sconosciuta.EQLAGQAJKEOR < Eqla& , < Gqajke* o|
F. Muscolino, in «ZPE», CLXXXII, 2012, p. 230, nr. 1, e in «BdA», s.vii, XIV, 2012, p. 32 e n. 54, fig. 3.
g.iv.b. Collocazione attuale sconosciuta. Dal Teatro antico (?).EQLAGQAJ/[- - -] < Eqla& , < Gqajk[e* o|]
F. Muscolino, in «ZPE», CLXXXII, 2012, p. 231, nr. 2.
447testi e monumenti
69 Per questa distinzione terminologica e per altri mattoni con bollo vd.supra, n. 44.
70 Il sigma eÁ appena rilevabile con il ricalco, mentre epsilon e omikronsono visibili anche a occhio nudo; tutta la restante parte del bollo eÁ abrasa.
g.v.1.1 (fig. 6). Taormina, Antiquarium del Teatro antico, inv.40. 71 Mattone di cm 31,5 (cons.) per cm 26,5 (cons.), spess. cm 8,9; sullospessore del lato maggiormente conservato, cartiglio ansato di cm 13,8per cm 1,9; alt. lettere cm 1.
DIOMTRIOT B Diomtri* ot B
G. Kaibel, in IG XIV, 2396/2 (`descripsimus Mommsen et ego'), da cuiG. Rizzo, La tavola degli strategi [sic] a Tauromenio. Contributi alla storiadell'elemento dorico in Sicilia (Catania, 1893), p. 41 n. 2 e in «Archiviostorico messinese», IV, 1904, p. 119 (con provenienza dal Teatro an-tico). 72
BAV, Vat. lat. 10574, f. 179v, ricalco su carta velina a cura di E.Stevenson iunior (`Bollo di mattone | Museo').
g.v.1.2. Taormina, Antiquarium del Teatro antico, inv. 56. 73 Mat-tone di cm 9,8 (cons.) per cm 9,8 (cons.), spess. cm 8,1 (cons.); sullospessore, cartiglio ansato di cm 6,9 (cons.) per cm 1,8; alt. lettere cm 1.Incrostazioni cementizie.
[- - -]OT B [Diomtri* ]ot B
Inedito.
g.v.1.3. Taormina, Antiquarium del Teatro antico, inv. 44. 74 Mat-tone di cm 20 (cons.) per cm 16,5 (cons.), spess. cm 9; sullo spessore dellato maggiormente conservato, cartiglio ansato di cm 10 (cons.) per cm1,9; alt. lettere cm 1,2.
DIOMTRIOT [- - -] (?) 75 Diomtri* ot [B] (?)
Inedito.
g.vi.1.1 (fig. 7). Taormina, Antiquarium del Teatro antico, inv. 54(v.inv. 73). 76 Tegola piana o mattone di cm 13,5 (cons.) per cm 10,5
448 testi e monumenti
71 Il numero eÁ tracciato su una delle facce maggiori.72 Secondo Rizzo, il mattone sarebbe stato trovato nel Teatro antico
verso il 1880 e, ai suoi tempi, era esposto `nel museo locale, murato sopraun tronco di colonna' con g.ii.1.1.
73 Il numero eÁ tracciato sullo spessore.74 Il numero, poco leggibile, eÁ tracciato in rosso su una delle facce mag-
giori, ed eÁ indicato in un cartellino attaccato al pezzo.75 Il bollo presenta notevoli somiglianze morfologiche e paleografiche
con g.v.1.1-2, anche se, in questo caso, la frattura pochi millimetri dopol'ultima lettera impedisce di avere la certezza dell'identitaÁ con i due esemplariprecedenti.
76 Entrambi i numeri sono tracciati sulla faccia opposta a quella con ilbollo, il 54 in nero, il 73 in rosso.
(cons.), spess. cm 3. Su una delle facce maggiori, bollo circolare, lieve-mente concavo, diam. cm 3,8; alt. lettere cm 0,8.
ETDXQOR Et> dxqo| 77
Inedito.
g.vii.1.1 (fig. 8). Taormina, Antiquarium del Teatro antico, inv.47. 78 Mattone di cm 23 (cons.) per cm 21 (cons.), spess. cm 8,6. Suuna delle facce maggiori, bollo circolare, diam. cm 5,5; alt. lettere cm1,3. Accanto, un bollo (?) circolare, anepigrafo, diam. cm 2,5.
GQAJKEIOT <Gqajkei* ot
Inedito.
g.viii.1.1. Giardini Naxos, Museo archeologico, inv. 2663, da Na-xos. Tegola piana o mattone di cm 25 (cons.) per cm 17 (cons.); spess. cm3. Su una delle facce maggiori, cartiglio ansato di cm 12,4 per cm 2,8.
MIJORSQASOT Mijorsqa* sot
F. Muscolino, in M.C. Lentini & F. Muscolino, Fornaci e produzionidi anfore e laterizi tra Naxos e Taormina (III-I secolo a.C.) e rapporti con learee tirreniche, in G. Olcese (ed.), Immensa aequora. Ricerche archeolo-giche, archeometriche e informatiche per la ricostruzione dell'economia e deicommerci nel bacino occidentale del Mediterraneo, Atti del workshop,Roma, 2011, c.d.s., n. 25, fig. 7.
g.viii.1.2. Giardini Naxos, Museo archeologico, inv. 2666, da Naxos.Tegola piana o mattone di cm 20 (cons.) per cm 14 (cons.); spess. cm 5,4. Suuna delle facce maggiori, cartiglio ansato di cm 7,4 (cons.) per cm 2,4.
[- - -]ORSQASOT [Mij]orsqa* sot
F. Muscolino, in Lentini & Muscolino, Fornaci, cit., n. 24, fig. 6.
g.ix.1.1 (fig. 9). Taormina, Antiquarium del Teatro antico, inv.43. 79 Mattone di cm 18 (cons.) per cm 18 (cons.), spess. cm 8,5. Ricom-posto parzialmente da vari frammenti. Su una delle facce maggiori, bollodi cm 10,3 per cm 3,3; alt. lettere cm 1,7/2. Forse eÁ l'esemplare `rinve-nuto presso Porta Messina' (Annotazioni allegate al Vecchio inventario).
AMMIOT \Ammi* ot
Inedito.
449testi e monumenti
77 A causa dello stato di conservazione, non eÁ possibile escludere lapresenza di un'altra lettera, prima della epsilon: in tal caso, si potrebbe leggere[H]et* dxqo|.
78 Il numero eÁ tracciato sullo spessore.79 Il numero eÁ tracciato sullo spessore.
g.ix.1.2 (non vidi). Palermo, Museo archeologico regionale `A. Sa-linas', g.e. 20 (20 febbraio 1883). Da Castelmola, presso la `Portella deiSaraceni'.
AMMIOT \Ammi* ot
Ricalco e disegno in ASMP, busta 678. Inedito.
l.i.1.1 (fig. 10). Taormina, Antiquarium del Teatro antico, inv. 55(v.inv. 74). 80 Tegola piana o mattone di cm 11,1 (cons.) per cm 6,5(cons.), spess. cm 2,9. Su una delle facce maggiori, bollo a lettere cave;alt. lettere cm 3. PE, TR in nesso. Sotto il nesso PE, traccia della ma-trice.
PETRI A (?) 81 Petri A (?)
Th. Mommsen, in CIL X, 8045/30 (`Taorminae [in museo] ... descripsi'),da cui G. Rizzo, in «Archivio storico messinese», IV, 1904, p. 120.
l.ii.1.1 (fig. 11). Taormina, Antiquarium del Teatro antico, inv. 50(v.inv. 81). 82 Tegola piana o mattone di cm 26 (cons.) per cm 28,5,(cons.), spess. cm 3,3. Su una delle facce maggiori, bollo a lettere cave;lungh. parola cm 10,5, alt. lettere cm 2,5/2,8. PH e AN in nesso. Asinistra della prima S, e a destra dell'ultima S, due lievi incavi verticali,verisimilmente traccia della matrice. Presso il bordo, due impronte ca-nine. Forse eÁ l'esemplare rinvenuto nel 1899 vicino alla chiesa di SanPancrazio. 83
SPHANONS Spha(erus?)Non(i?) s(ervus?) (Mommsen)Sphanionis (?) (BernaboÁ Brea)
Inedito.
l.iii.1.1 (fig. 12). Taormina, Antiquarium del Teatro antico, inv.42. 84 Mattone di cm 34 per cm 36 (cons.), spess. cm 8,2. Su una dellefacce maggiori, bollo quadrangolare di cm 9,1 per cm 3,2; alt. lettere cm2,5.
IVLSECV Iul(ii) Secu(ndi)
Inedito.
450 testi e monumenti
80 Entrambi i numeri sono tracciati sulla faccia opposta a quella con ilbollo, il 55 in nero, il 74 in rosso.
81 Dopo la I si vede l'inizio di una lettera parzialmente conservata,indicato anche da Mommsen nel suo apografo.
82 Il 50 eÁ tracciato in nero sullo spessore, l'81 in rosso sulla faccia con ilbollo.
83 Vd. App. iii, infra, p. 466.84 Il numero eÁ tracciato sullo spessore; a matita, indicazione `Tao 87'.
l.iv.1.1 (fig. 13). Taormina, Antiquarium del Teatro antico, inv.48. 85 Due frammenti combacianti di tegola piana, con parte di uno deimargini laterali rialzati. Dimensioni complessive: cm 48 (cons.) per cm24,5 (cons.), spess. cm 2,5. Dimensioni del bordo conservato: lungh. cm19, largh. cm 3,3, spess. cm 4,9. Su una delle facce maggiori, bolloquadrangolare di cm 10,5 per cm 2,1; alt. lettere cm 1,6. VE in nesso.
CIVLIVERI C. Iulii Veri
Inedito.
m.i.1.1 (fig. 14). Taormina, Antiquarium del Teatro antico, inv. 51. 86
Tegolapianaomattonedi cm16 (cons.) per cm14 (cons.), spess. cm3.Suunadelle facce maggiori, tabella ansata di cm 5,7 per cm 5,7 (cm 7,5 includendole anse). Incrostazioni cementizie sulla faccia opposta a quella con il bollo.
Il monogramma eÁ costruito intorno a ny che, a sinistra, termina in altocon un tratto perpendicolare che forma un tau; sotto il tau, una circon-ferenza tagliata dall'asta sinistra del ny, interpretabile come phi o, menoprobabilmente, omikron; nel triangolo inferiore del ny, un trattinoorizzontale forma un alpha. Alla destra del ny, segni poco leggibilianche per il cattivo stato di conservazione.
Inedito.
m.ii.1.1 (fig. 15). Taormina, Antiquarium del Teatro antico, inv.37. 87 Mattone di cm 51 per cm 34,5, spess. cm 10. Su una delle faccemaggiori, bollo di cm 5 per cm 5.
Alpha a barra spezzata inscritto in un pi.
Inedito
m.ii.1.2. Taormina, Antiquarium del Teatro antico, inv. 38. 88 Mat-tone di cm 50,5 per cm 34,5, spess. cm 10. Su una delle facce maggiori,bollo di cm 5 per cm 5. Per la descrizione vd. m.ii.1.1. Inedito.
m.ii.1.3. Taormina, Antiquarium del Teatro antico, inv. 39. 89 Mat-tone di cm 35 (cons.) per cm 34,5, spess. cm 9,5. Su una delle faccemaggiori, bollo di cm 5 per cm 5. Per la descrizione vd. m.iii.1.1.G. Manganaro, in «ZPE», CXXXIII, 2000, p. 130, tav. 12, fig. 28.
451testi e monumenti
85 Il 48 eÁ ripetuto sullo spessore di ciascun frammento; su una delle faccemaggiori di entrambi, numeri in vernice rossa di difficile lettura.
86 Il numero eÁ tracciato sullo spessore; sulla faccia con bollo, numero invernice rossa di difficile lettura.
87 Il numero eÁ tracciato sullo spessore.88 Il numero eÁ tracciato sullo spessore.89 Il numero eÁ tracciato sullo spessore.
m.iii.1.1 (fig. 16). Taormina, `Naumachia', settima abside, diciot-tesimo filare, terzo mattone da sinistra (nau.vii.1), cm 19 (cons.), spess.cm 9,5; sullo spessore, bollo quadrangolare di cm 4,6 per cm 4,5. Letteramy/sigma: cm 3,1 per cm 3,3.
La lettera al centro del monogramma eÁ my o, leggendo in un altro senso,sigma. Un'asta (iota?) interseca il vertice centrale del my/sigma e ter-mina con omikron. Leggendo la lettera centrale come sigma, il rombocon tratto orizzontale che si forma al centro potrebbe essere interpretatocome theta.
Inedito.
m.iii.1.2. Taormina, `Naumachia', sul fondo della diciottesima nic-chia rettangolare, ventiduesimo filare, primo (?) mattone da destra(nau.18.1), cm 23 (cons.), spess. cm 10,5; sullo spessore, bollo quadran-golare di cm 4,4 per cm 5. Lettera my/sigma: cm 3,1 per cm 3,3. Per ladescrizione vd. m.iii.1.1. Inedito.
m.iii.1.3*. Taormina, `Naumachia', a destra della sesta nicchia ret-tangolare, ventinovesimo filare, primo mattone da destra, posto in operacapovolto (nau.6.2*). Per la descrizione vd. m.iii.1.1. Inedito.
m.iii.1.4 (fig. 4.6). Taormina, `Naumachia', dodicesima abside, se-condo filare, mattone verso il centro (�) (nau.xii.1), cm 28 (vis.), spess.cm 10,5. Bollo quadrangolare di cm 4 (cons.) per cm 4 (cons.). Per ladescrizione vd. m.iii.1.1. Inedito.
m.iv.1.1 (fig. 17.1). Taormina, `Naumachia', quarta abside, quartofilare, quarto mattone da sinistra (nau.iv.2), cm 32, spess. cm 10; sullospessore, a sinistra, bollo quadrangolare di cm 3,8 per cm 2,8; alt. mono-gramma non misurabile; a destra, bollo quadrangolare di cm 4,4 per cm2,8; alt. monogramma cm 1,8.
Nel monogramma a sinistra (bollo a) si riconosce, al centro, omega,forse con kappa a sinistra e lambda a destra. Il monogramma a destra(bollo b) sembra composto da my con l'asta destra in comune conepsilon; il prolungamento del tratto superiore di epsilon sopra my fa-rebbe ipotizzare che, al centro, sia inserito anche tau, mentre il trattoobliquo che unisce il primo e il secondo tratto orizzontale dell'epsilon apartire dall'alto farebbe pensare a zeta.
Inedito.
m.iv.1.2. Taormina, `Naumachia', sotto la quarta nicchia rettango-lare, terzo filare, primo mattone da sinistra, posto in opera capovolto(nau.4.1), cm 26 (cons.) per cm 16 (cons.), spess. cm 11; sullo spessore
452 testi e monumenti
del lato maggiormente conservato, a sinistra, bollo quadrangolare di cm4,7 per cm 3; alt. monogramma cm 2,1; a destra, bollo quadrangolare dicm 3,7 (cons.) per cm 2,9; alt. monogramma non misurabile. Per ladescrizione vd. m.iv.1.1. Inedito.
m.iv.1.3. Taormina, `Naumachia', sedicesima abside, quattordice-simo filare, quarto mattone da destra, posto in opera capovolto(nau.xvi.2), cm 32,5, spess. cm 10,5; sullo spessore, a sinistra, bolloquadrangolare di cm 5 per cm 3,2; alt. monogramma cm 1,5 (cons.); adestra, bollo quadrangolare di cm 3,8 per cm 2,9; alt. monogramma nonmisurabile. Per la descrizione vd. m.iv.1.1 (bollo a illeggibile, bollo bparzialmente leggibile). Inedito.
m.iv.1.4. Taormina, `Naumachia', quarta abside, terzo filare, set-timo mattone da destra (nau.iv.1), cm 14 (cons.), spess. cm 10,5; sullospessore, bollo quadrangolare di cm 3,8 (cons.) per cm 3; alt. monogrammacm 1,9. Per la descrizione vd. m.iv.1.1 (parte del bollo b). Inedito.
m.iv.1.5* (fig. 17.2). Taormina, `Naumachia', sesta abside, quaran-tacinquesimo filare, mattone verso sinistra (�), posto in opera capovolto(nau.vi.2*); sullo spessore, bollo quadrangolare. Per la descrizione vd.m.iv.1.1 (bollo b). Inedito.
m.iv.1.6. Taormina, `Naumachia', sedicesima nicchia rettangolare,ventisettesimo filare, lato destro della nicchia, secondo mattone da de-stra (nau.16.1), cm 34, spess. cm 9,5. A sinistra, bollo quadrangolare dicm 3,7 per cm 3,1; a destra, bollo quadrangolare di cm 4,4 per cm 2,9.Per la descrizione vd. m.iv.1.1 (bollo a illeggibile, bollo b parzialmenteleggibile). Inedito.
m.iv.1.7. Taormina, `Naumachia', dodicesima abside, ventitree-simo filare, mattone verso sinistra (�) (nau.xii.5), cm 13 (cons.), spess.cm 10; sullo spessore, a sinistra, bollo quadrangolare di cm 4 (cons.) percm 2 (cons.); a destra, bollo quadrangolare di cm 4,5 per cm 3. Per ladescrizione vd. m.iv.1.1 (bollo a illeggibile, bollo b parzialmente leggi-bile). Inedito.
m.iv.1.8 (fig. 17.3). Taormina, `Naumachia', a destra della sestanicchia rettangolare, venticinquesimo filare, primo mattone da destra(nau.6.1), posto in opera capovolto, cm 25 (cons.) per cm 12 (cons.),spess. cm 11; sullo spessore del lato meno conservato, bollo quadrango-lare di cm 3,2 per cm 3,7. Per la descrizione vd. m.iv.1.1 (bollo a par-zialmente leggibile). Inedito.
453testi e monumenti
m.iv.1.9* (fig. 20). Taormina, `Naumachia', primo filare sopra lapiattabanda della tredicesima nicchia, quarto mattone da sinistra(nau.13.10*); sullo spessore, bollo quadrangolare. Per la descrizionevd. m.iv.1.1 (bollo a). Inedito.
m.iv.1.10 (non vidi). Palermo, Museo archeologico regionale `A.Salinas', g.e. 20 (20 febbraio 1883). Da Castelmola, presso la `Portelladei Saraceni'. Per la descrizione vd. m.iv.1.1. Ricalco e disegno inASMP, busta 678. Inedito.
m.v.1.1 (fig. 4.6). Taormina, `Naumachia', dodicesima abside,quarto filare, mattone verso il centro (�) (nau.xii.2), cm 29 (cons.), spess.cm 10; sullo spessore, bollo quadrangolare di cm 4,5 (cons.) per cm 2,4.
A sinistra, kappa; a destra, alpha a barra spezzata o lambda combinatocon altre lettere (?).
Inedito.
m.v.1.2 (fig. 18). Taormina, `Naumachia', settima abside, venticin-quesimo filare, primo mattone da sinistra, posto in opera capovolto(nau.vii.4), cm 25 (cons.) per cm 14 (cons.), spess. cm 10; sullo spessoredel lato maggiormente conservato, bollo quadrangolare di cm 4,5 per cm2,8. Per la descrizione vd. m.v.1.1. Inedito.
m.v.1.3. Taormina, `Naumachia', nona abside, settimo filare,quarto mattone da destra, posto in opera capovolto (nau.ix.1), cm 17(cons.), spess. cm 9,5; sullo spessore, bollo quadrangolare di cm 4,5 percm 2,8. Per la descrizione vd. m.v.1.1. Inedito.
an.i.1.1. Taormina, Antiquarium del Teatro antico, inv. 49. Dueframmenti combacianti di tegola piana. Dimensioni complessive: cm55,5 (cons.) per cm 50 (cons.). Su una delle facce maggiori, due bolliquadrangolari di cm 2,8 per cm 4.
Doppio motivo a spina di pesce.
Inedito.
an.ii.1.1. Taormina, Antiquarium del Teatro antico, inv.provv. 7. 90
Mattone di cm 19,5 (cons.) per cm 13,5 (cons.), spess. cm 8,8. Su unadelle facce maggiori, bollo circolare, diam. cm 4.
Stella a cinque (?) punte.
Inedito.
454 testi e monumenti
90 Il numero eÁ scritto sulla faccia con il bollo.
an.iii.1.1. Giardini Naxos, Museo archeologico, inv. 2667, da Na-xos. Tegola piana o mattone di cm 21 (cons.) per cm 15 (cons.); spess. cm3,3. Su una delle facce maggiori, bollo circolare (diam. cm 5,1).
Triskeles.F. Muscolino, in Lentini & Muscolino, Fornaci, cit., n. 22, fig. 4.
an.iii.1.2. Giardini Naxos, Museo archeologico, da Naxos. Mat-tone di cm 27 (cons.) per cm 21 (cons.); spess. cm 7,8. Su una delle faccemaggiori, bollo circolare (diam. cm 5,1).
Triskeles.F. Muscolino, in Lentini & Muscolino, Fornaci, cit., n. 23, fig. 5.
Francesco [email protected]
Abstract. ± Taormina and its territory offer a wide range of brickstampsdatable from the 3rd/2nd century b.c. to the Roman period and mainly inscribedwith Greek words and monograms as well as, to a much lesser extent, Latinnames. This study aims at giving a corpus of brickstamps comprising both thefew already known and the far more numerous unpublished or insufficientlyknown items; their catalogue is integrated with topographical, metrologicaland linguistic remarks. This study deals not only with the bricks from archae-ological excavations or casual discoveries, but also with the exemplars used and,more often, reused in the masonry of such monuments as the Roman Theatre, the`tombe saracene', the urban walls and especially the `Naumachia', a Romanbuilding the brickwork of which shows a considerable number of Greek stamps.
455testi e monumenti
Appendice i
Collocazione dei mattoni con bolli nella `Naumachia'91
± nau.1.1. Sotto la prima nicchia rettangolare, secondo filare, quarto mat-tone da sinistra, cm 34, spess. cm 10,5; sullo spessore, cartiglio ansato dicm 12 per cm 2,2, illeggibile.
± nau.1.2. Sotto la prima nicchia rettangolare, quarto filare, quarto mat-tone da destra: g.i.2.6.
± nau.i.1. Prima abside, quinto filare, decimo mattone da sinistra, cm 25,5(cons.), spess. cm 10,5; sullo spessore, bollo quadrangolare di cm 8 per cm2, illeggibile.
± nau.i.2*. Prima abside, quinto mattone della ghiera, da destra; sullospessore, cartiglio ansato (?).
± nau.ii.1. Seconda abside, primo filare, sesto mattone da destra, cm 16(cons.), spess. cm 10 (cons.); sullo spessore, cartiglio ansato di cm 9,8(cons.) per cm 1,8, illeggibile.
± nau.3.1. A destra della terza nicchia rettangolare, ventunesimo filare,primo mattone da destra, cm 27 (vis.) per cm 10 (vis.), spess. cm 11; sullospessore del lato maggiormente conservato, cartiglio ansato di cm 12,3per cm 2, illeggibile.
± nau.iii.1. Terza abside, primo filare, primo mattone da sinistra, cm 21(vis.) per cm 14 (cons.), spess. cm 10,5; sullo spessore del lato maggior-mente conservato, cartiglio ansato (?) di cm 5,5 (cons.) per cm 2, illeggibile.
± nau.iii.2. Terza abside, decimo filare, primo mattone da sinistra, cm 31(cons.) per cm 18 (cons.), spess. cm 11; sullo spessore del lato maggior-mente conservato, cartiglio ansato di cm 11 (cons.) per cm 1,8, illeggibile.
± nau.iii.3. Terza abside, undicesimo filare, sesto mattone da destra: g.i.1.2.± nau.iii.4. Terza abside, ventesimo filare, quarto mattone da sinistra, cm
25,5 (cons.), spess. cm 10; sullo spessore, cartiglio ansato di cm 6,3 (cons.)per cm 1,8, illeggibile.
± nau.4.1. Sotto la quarta nicchia rettangolare, terzo filare, primo mattoneda sinistra: m.iv.1.2.
± nau.4.2. Sotto la quarta nicchia rettangolare, quarto filare, terzo mattone dasinistra, cm 32,5, spess. cm 10,5; sullo spessore, bollo alto cm 0,7 alle dueestremitaÁ e cm 1,2 al centro, lungo cm 8,7, illeggibile, confrontabile con g.i.1.
456 testi e monumenti
91 Poiche la `Naumachia' (figg. 1.1-2) presenta diciotto absidi interval-late da diciannove nicchie rettangolari, si usano le absidi e le nicchie comepunti di riferimento, numerandole da Sud, cioeÁ dall'ingresso su via Nauma-chia. Si indicano con numeri romani le absidi, con numeri arabi le nicchie;l'ultimo numero distingue i vari esemplari presso ciascuna abside o nicchia. Ilcatalogo di seÂguito presentato eÁ probabilmente incompleto, perche vegeta-zione, concrezioni di vario tipo, intonacature post-antiche e l'altezza stessadel muro rendono di difficile lettura alcuni tratti del paramento che, inoltre,presenta ampi risarcimenti moderni.
± nau.iv.1. Quarta abside, terzo filare, settimo mattone da destra: m.iv.1.4.± nau.iv.2. Quarta abside, quarto filare, quarto mattone da sinistra: m.iv.1.1.± nau.iv.3. Quarta abside, decimo filare, tredicesimo mattone da destra,
cm 20,5 (cons.), spess. cm 9; sullo spessore, cartiglio ansato di cm 11,5 percm 2, illeggibile.
± nau.iv.4. Quarta abside, quattordicesimo filare, quinto mattone da de-stra, cm 21 (cons.), spess. cm 9,5; sullo spessore, bollo quadrangolare dicm 7,4 per cm 1,4, illeggibile.
± nau.iv.5*. Quarta abside, trentunesimo filare, secondo mattone da sini-stra; sullo spessore, bollo quadrangolare.
± nau.iv.6*. Quarta abside, trentatreesimo filare, mattone verso il centro(�); sullo spessore, cartiglio ansato.
± nau.6.1. A destra della sesta nicchia rettangolare, venticinquesimo filare,primo mattone da destra: m.iv.1.8.
± nau.6.2*. A destra della sesta nicchia rettangolare, ventinovesimo filare,primo mattone da destra: m.iii.1.3*.
± nau.vi.1*. Sesta abside, ventinovesimo filare, terzo mattone da destra;sullo spessore, bollo confrontabile con g.i.1.
± nau.vi.2*. Sesta abside, quarantacinquesimo filare, verso sinistra (�):m.iv.1.5*.
± nau.vii.1. Settima abside, diciottesimo filare, terzo mattone da sinistra:m.iii.1.1.
± nau.vii.2. Settima abside, diciottesimo filare, ottavo mattone da destra,cm 16 (cons.), spess. cm 11; sullo spessore, cartiglio ansato di cm 6,5(cons.) per cm 1,7, illeggibile.
± nau.vii.3. Settima abside, diciannovesimo filare, settimo mattone da de-stra, cm 16 (cons.), spess. cm 11; sullo spessore, bollo quadrangolare di cm6 (cons.) per cm 2, illeggibile.
± nau.vii.4. Settima abside, venticinquesimo filare, primo mattone da sini-stra: m.v.1.2.
± nau.vii.5. Settima abside, ventottesimo filare, terzo mattone da sinistra,cm 27 (vis.), spess. cm 9,5; sullo spessore, bollo quadrangolare di cm 4,5per cm 2,8, illeggibile.
± nau.8.1*. Ottava nicchia rettangolare, quarto mattone della piattabanda,da destra; sullo spessore, cartiglio ansato (?).
± nau.viii.1. Ottava abside, sedicesimo filare, sesto mattone da sinistra, cm19 (cons.), spess. cm 10; sullo spessore, bollo quadrangolare di cm 4 percm 4; si tratta forse di un monogramma (con omikron?).
± nau.viii.2*. Ottava abside, terzo mattone della ghiera, da sinistra; sullospessore, bollo quadrangolare.
± nau.ix.1. Nona abside, settimo filare, quarto mattone da destra, posto inopera capovolto: m.v.1.3.
± nau.11.1. Sotto l'undicesima nicchia rettangolare, settimo filare, terzomattone da sinistra: g.i.1.1.
± nau.xi.1. Undicesima abside, sedicesimo filare, nono mattone da destra,
457testi e monumenti
cm 31,8, spess. cm 10; sullo spessore, bollo quadrangolare di cm 4,7 percm 3, illeggibile.
± nau.xi.2. Undicesima abside, ventiduesimo filare, mattone verso il centro(�), cm 17,5 (cons.), spess. cm 9,5; sullo spessore, bollo quadrangolare dicm 4,7 per cm 3,3, illeggibile.
± nau.xi.3*. Undicesima abside, ventisettesimo filare, mattone verso de-stra (�); sullo spessore, bollo quadrangolare (?).
± nau.xi.4*. Undicesima abside, quarantesimo filare, mattone verso sini-stra (�); sullo spessore, cartiglio ansato.
± nau.12.1. A destra della dodicesima nicchia rettangolare, diciottesimofilare, primo mattone da sinistra, cm 20 (cons.) per cm 24,5 (cons.), spess.cm 10,5; sullo spessore del lato maggiormente conservato, cartiglio ansatodi cm 11,5 per cm 2, illeggibile.
± nau.xii.1. Dodicesima abside, secondo filare, mattone verso il centro (�):m.iii.1.4.
± nau.xii.2. Dodicesima abside, quarto filare, mattone verso il centro (�):m.v.1.1.
± nau.xii.3. Dodicesima abside, quinto filare, mattone verso il centro (�):g.iii.4.2.
± nau.xii.4. Dodicesima abside, diciannovesimo filare, settimo mattone dadestra: g.i.2.2.
± nau.xii.5. Dodicesima abside, ventitreesimo filare, mattone verso sinistra(�): m.iv.1.7.
± nau.xii.6*. Dodicesima abside, ventottesimo filare, terzo mattone dadestra; sullo spessore, bollo (?) di forma imprecisabile.
± nau.13.1. Sotto la tredicesima nicchia rettangolare, undicesimo filare,primo mattone da sinistra, cm 34 per cm 10 (cons.), spess. cm 10; sullospessore del lato maggiormente conservato, due bolli quadrangolari, ilprimo da sinistra di cm 4,5 per altezza non misurabile, il secondo dicm 4 per cm 2,9, con monogrammi illeggibili, confrontabili con m.iv.1.
± nau.13.2. A sinistra della tredicesima nicchia rettangolare, ventisette-simo filare, secondo mattone da sinistra, cm 16 (cons.) per cm 26(cons.), spess. cm 11; sullo spessore del lato meno conservato, cartiglioansato di cm 8,7 (cons.) per cm 2,3, illeggibile.
± nau.13.3. Lato destro della tredicesima nicchia rettangolare, ventesimofilare, primo mattone da destra, cm 32 (cons.?) per cm 23 (cons.), spess.cm 11; sullo spessore del lato meno conservato, cartiglio ansato di cm 7,3(cons.) per cm 2,3, illeggibile.
± nau.13.4. Lato destro della tredicesima nicchia rettangolare, ventinove-simo filare, primo mattone da destra: g.i.2.5.
± nau.13.5* (fig. 20). Tredicesima nicchia rettangolare, secondo mattonedella piattabanda, da sinistra; sullo spessore, cartiglio ansato, confronta-bile con g.iii.2.
± nau.13.6* (fig. 20). Tredicesima nicchia rettangolare, terzo mattone dellapiattabanda, da sinistra; sullo spessore, bollo quadrangolare.
458 testi e monumenti
± nau.13.7* (fig. 20). Tredicesima nicchia rettangolare, quarto mattonedella piattabanda, da sinistra; sullo spessore, cartiglio ansato, confronta-bile con g.iii.2.
± nau.13.8* (fig. 20). Tredicesima nicchia rettangolare, primo mattonedella piattabanda, da destra; sullo spessore, bollo quadrangolare.
± nau.13.9* (fig. 20). Primo filare sopra la piattabanda della tredicesimanicchia, terzo mattone da sinistra; sullo spessore, cartiglio ansato (?).
± nau.13.10* (fig. 20). Primo filare sopra la piattabanda della tredicesimanicchia, quarto mattone da sinistra: m.iv.1.9.
± nau.xiii.1. Tredicesima abside, ventitreesimo filare, secondo mattone dasinistra, cm 18 (cons.), spess. cm 11; sullo spessore, bollo illeggibile, 92 diforma non identificabile, di cm 6 (cons.) per almeno cm 1,5 (vis.).
± nau.xiii.2. Tredicesima abside, ventiquattresimo filare, sesto mattone dasinistra, cm 20 (cons.), spess. cm 10,5; sullo spessore, bollo quadrangolaredi cm 7,5 (cons.) per cm 1,8, illeggibile.
± nau.xiii.3*. Tredicesima abside, trentatreesimo filare, secondo mattoneda destra; sullo spessore, bollo quadrangolare, confrontabile con g.iii.1.
± nau.xiii.4*. Tredicesima abside, quarto mattone della ghiera, da destra;sullo spessore, cartiglio ansato, confrontabile con g.iii.2.
± nau.14.1. A sinistra della quattordicesima nicchia rettangolare, ventino-vesimo filare, terzo mattone da sinistra, cm 24,5 (cons.) per cm 21,5(cons.), spess. cm 9,5; sullo spessore del lato maggiormente conservato,bollo lungo cm 8,6, alto cm 0,7/0,9 alle due estremitaÁ, e cm 1,3 al centro,illeggibile, confrontabile con g.i.1.
± nau.14.2. Lato destro della quattordicesima nicchia rettangolare, venti-treesimo filare, primo mattone da destra: g.i.2.4.
± nau.14.3*. Quattordicesima nicchia rettangolare, quarto mattone dellapiattabanda, da sinistra; sullo spessore, cartiglio ansato.
± nau.14.4*. Quattordicesima nicchia rettangolare, sesto mattone della piatta-banda,dasinistra;sullospessore,bolloquadrangolare,confrontabilecong.iii.1.
± nau.xiv.1. Quattordicesima abside, settimo filare, primo mattone da sini-stra, cm 32 per cm 21 (cons.), spess. cm 10; sullo spessore del lato mag-giormente conservato, cartiglio ansato di cm 12,8 per cm 1,8, illeggibile.
± nau.xiv.2. Quattordicesima abside, ventunesimo filare, nono mattone dasinistra, cm 23 (cons.), spess. cm 10; sullo spessore, bollo quadrangolaredi cm 3,5 (cons.) per 1,5, illeggibile.
± nau.xiv.3*. Quattordicesima abside, secondo mattone della ghiera, dasinistra; sullo spessore, bollo quadrangolare (?).
± nau.xiv.4*. Quattordicesima abside, ottavo mattone della ghiera, da si-nistra; sullo spessore, bollo quadrangolare.
± nau.16.1. Sedicesima nicchia rettangolare, ventisettesimo filare, lato de-stro della nicchia, secondo mattone da destra: m.iv.1.6.
459testi e monumenti
92 Vi si puoÁ forse leggere [- - -]E[- - -].
± nau.16.2*. Sedicesima nicchia rettangolare, decimo mattone della piatta-banda, da sinistra; sullo spessore, cartiglio ansato.
± nau.16.3*. Sedicesima nicchia rettangolare, undicesimo mattone dellapiattabanda, da sinistra; sullo spessore, bollo quadrangolare.
± nau.xvi.1. Sedicesima abside, ottavo filare, primo mattone da sinistra,cm 32 per cm 15 (cons.), spess. cm 10; sullo spessore del lato maggior-mente conservato, bollo quadrangolare di cm 7,5 per cm 1,5, illeggibile.
± nau.xvi.2. Sedicesima abside, quattordicesimo filare, quarto mattone dadestra: m.iv.1.3.
± nau.xvi.3*. Sedicesima abside, trentottesimo filare, terzo mattone dasinistra; sullo spessore, cartiglio ansato: g.i.2.3*.
± nau.xvi.4* (fig. 21). Sedicesima abside, quinto mattone della ghiera, dasinistra; sullo spessore, bollo quadrangolare.
± nau.xvi.5* (fig. 21). Sedicesima abside, sesto mattone della ghiera, dasinistra; sullo spessore, bollo quadrangolare, confrontabile con m.iv.1(bollo a) o m.v.1.
± nau.17.1. Sotto la diciassettesima nicchia rettangolare, quarto filare, primomattone da sinistra, cm 52 per cm 16 (vis.), spess. cm 11; sullo spessore,cartiglio ansato, ben visibile per cm 3,5 ma forse lungo cm 11,5, per cm 2.
± nau.17.2. Sotto la diciassettesima nicchia rettangolare, quinto filare, se-condo mattone da sinistra, cm 34, spess. cm 9,5; sullo spessore, bollo diforma non precisabile, di cm 8 per cm 1,5.
± nau.17.3. A sinistra della diciassettesima nicchia rettangolare, tredice-simo filare, primo mattone da sinistra, cm 32 per cm 22 (cons.), spess. cm11; sullo spessore del lato maggiormente conservato, cartiglio ansato dicm 11,8 (cons.) per cm 1,8, illeggibile.
± nau.17.4. A sinistra della diciassettesima nicchia rettangolare, ventesimofilare, primo mattone da destra: g.i.2.1.
± nau.17.5. A destra della diciassettesima nicchia rettangolare, quindice-simo filare, primo mattone da destra, cm 28 (cons.) per cm 10 (cons.),spess. cm 9,5; sullo spessore del lato maggiormente conservato, cartiglioansato (?) di cm 7,2 per cm 2,2, illeggibile.
± nau.17.6*. A destra della diciassettesima nicchia rettangolare, trentadue-simo filare, primo mattone da sinistra; sullo spessore, cartiglio ansato.
± nau.17.7*. Diciassettesima nicchia rettangolare, decimo mattone dellapiattabanda, da sinistra; sullo spessore, bollo quadrangolare (?).
± nau.17.8*. Diciassettesima nicchia rettangolare, primo mattone dellapiattabanda, da destra; sullo spessore, cartiglio ansato (?).
± nau.17.9*. Terzo filare sopra la piattabanda della diciassettesima nicchia,secondo mattone da destra; sullo spessore, cartiglio ansato.
± nau.xvii.1. Diciassettesima abside, decimo filare, primo mattone da sini-stra, cm 32 (cons.?) per cm 8 (cons.), spess. cm 11; sullo spessore del latomaggiormente conservato, cartiglio ansato di cm 11,5 per cm 2, illeggibile.
± nau.18.1. Sul fondo della diciottesima nicchia rettangolare, ventiduesimofilare di mattoni, primo mattone da destra: m.iii.1.2.
460 testi e monumenti
Appendice ii
Prospetto riassuntivo
catalogo supporto misure dei lati spess.formabollo
lungh.bollo
alt.bollo
g.i.1.1 (nau.11.1) m. 32 /// 10 appr.q. 8,6 0,7/1,2g.i.1.2 (nau.iii.3) m. 19 (cons.) /// 10,5 appr.q. 6,3
(cons.)0,8/1,2
g.i.2.1 (nau.17.4) m. 32 31 (cons.) 10 c.ans. 12,2 1,8g.i.2.2 (nau.xii.4) m. 23 (cons.) /// 10,5 c.ans. 10 2g.i.2.3*(nau.xvi.3*)
m. * * * c.ans. * *
g.i.2.4 (nau.14.2) m. 29 (cons.) 17 (cons.) 11 c.ans. 9,8(cons.)
2
g.i.2.5 (nau.13.4) m. 22 (cons.?) 12 (cons.) 11,5 c.ans. 8,6(cons.)
2
g.i.2.6 (nau.1.2) m. 32,5 /// 11 c.ans. 12,2 1,8g.ii.1.1 m. 34 31 (cons.) 10,5 c.ans. 12,5 2,2
c.ans. 8,5(cons.)
2,2
q. 3 2,5q. 3 2,5q. 3 2,5
g.ii.2.1 m. 37,8 37,8 4 q. 4 (cons.) 1,5g.iii.1.1 m. 22,5
(cons.)/// 9 q. 6 3
g.iii.2.1 m. 27 (cons.) 16 (cons.) 8,1 c.ans. 9,6 2,3g.iii.2.2 m. 18 (cons.) 18 (cons.) 7,1 c.ans. 10,6 2,5g.iii.3.1 m. 20 (cons.) /// 9 c.ans. 4 (cons.) 2g.iii.4.1 m. 19 (cons.) /// 9 c.ans. 10,5 2g.iii.4.2 (nau.xii.3) m. 23 (cons.) /// 10 c.ans. 6,8
(cons.)1,8
g.iv.1.1 m. 17,5(cons.)
13,5(cons.)
8,4 c.ans. 11(cons.)
1,7/1,9
g.iv.1.2 m. 23 (cons.) 21 (cons.) 8 c.ans. 10,2(cons.)
1,9
g.iv.2.1 m. 14,5(cons.)
16 (cons.) 8 c.ans. 10(cons.)
1,8
g.iv.2.2 m. 22 (cons.) 16 (cons.) 8,5 c.ans. 14(cons.)
1,9
g.iv.2.3 m. 32 25 (cons.) 8,2 c.ans. 19(circa)
2,1
g.iv.2.4 m. 16 (cons.) 15 (cons.) 8,3 c.ans. 9,8(cons.)
2
461testi e monumenti
catalogo supporto misure dei lati spess.formabollo
lungh.bollo
alt.bollo
g.iv.2.5 m. 26 (cons.) 23 (cons.) 8,8 c.ans. 12(cons.)
2,3(circa)
g.iv.2.6 m. 30 (cons.) 16 (cons.) 8,8 c.ans. 6,4(cons.)
2,1
g.iv.2.7 m. 15 (cons.) 20 (cons.) 8 c.ans. 7,1(cons.)
1,9
g.iv.2.8 m. 25,6(cons.)
/// 9 c.ans. 18,5 2,4
g.v.1.1 m. 31,5(cons.)
26,5(cons.)
8,9 c.ans. 13,8 1,9
g.v.1.2 m. 9,8 (cons.) 9,8 (cons.) 8,1(cons.)
c.ans. 6,9(cons.)
1,8
g.v.1.3 m. 20 (cons.) 16,5(cons.)
9 c.ans. 10(cons.)
1,9
g.vi.1.1 m. o t.p. 13,5(cons.)
10,5(cons.)
3 circ. diam. cm 3,8
g.vii.1.1 m. 23 (cons.) 21 (cons.) 8,6 circ. diam. cm 5,5g.viii.1.1 m. o t.p. 25 (cons.) 17 (cons.) 3 c.ans. 12,4 2,8g.viii.1.2 m. o t.p. 20 (cons.) 14 (cons.) 5,4 c.ans. 7,4
(cons.)2,4
g.ix.1.1 m. 18 (cons.) 18 (cons.) 8,5 q. 10,3 3,3g.ix.1.2 m. ? ? ? q. ? ?l.i.1.1 m. o t.p. 11,1
(cons.)6,5 (cons.) 2,9 alt. lettere cm 3
l.ii.1.1 m. o t.p. 26 (cons.) 28,5(cons.)
3,3 lungh. parola cm 10,5;alt. lettere cm 2,5/2,8
l.iii.1.1 m. 34 36 (cons.) 8,2 q. 9,1 3,2
l.iv.1.1 t.p. 48 (cons.) 24,5(cons.)
2,5 q. 10,5 2,1
m.i.1.1 m. o t.p. 16 (cons.) 14 (cons.) 3 tab.ans. 5,7 5,7/7,5m.ii.1.1 m. 51 34,5 10 q. 5 5m.ii.1.2 m. 50,5 34,5 10 q. 5 5m.ii.1.3 m. 35 (cons.) 34,5 9,5 q. 5 5m.iii.1.1(nau.vii.1)
m. 19 (cons.) /// 9,5 q. 4,6 4,5
m.iii.1.2(nau.18.1)
m. 23 (cons.) /// 10,5 q. 4,4 5
m.iii.1.3*(nau.6.2*)
m. * * * q. * *
m.iii.1.4(nau.xii.1)
m. 28 (vis.) /// 10,5 q. 4 (cons.) 4 (cons.
462 testi e monumenti
catalogo supporto misure dei lati spess.formabollo
lungh.bollo
alt.bollo
m.iv.1.1(nau.iv.2)
m. 32 /// 10 q. 3,8 2,8q. 4,4 2,8
m.iv.1.2 (nau.4.1) m. 26 (cons.) 16 (cons.) 11 q. 4,7 3q. 3,7
(cons.)2,9
m.iv.1.3(nau.xvi.2)
m. 32,5 /// 10,5 q. 5 3,2q. 3,8 2,9
m.iv.1.4(nau.iv.1)
m. 14 (cons.) /// 10,5 q. 3,8(cons.)
3
m.iv.1.5*(nau.vi.2*)
m. * * * q. * *
m.iv.1.6(nau.16.1)
m. 34 /// 9,5 q. 3,7 3,14,4 2,9
m.iv.1.7(nau.xii.5)
m. 13 (cons.) /// 10 q. 4 (cons.) 2 (cons.)q. 4,5 3
m.iv.1.8 (nau.6.1) m. 25 (cons.) 12 (cons.) 11 q. 3,2 3,7m.iv.1.9*(nau.13.10*)
m. * * * q. * *
m.iv.1.10 m. ? ? ? q. ? ?q. ? ?
m.v.1.1 (nau.xii.2) m. 29 (cons.) /// 10 q. 4,5(cons.)
2,4
m.v.1.2 (nau.vii.4) m. 25 (cons.) 14 (cons.) 10 q. 4,5 2,8m.v.1.3 (nau.ix.1) m. 17 (cons.) /// 9,5 q. 4,5 2,8an.i.1.1 t.p. 55,5 (cons.) 50 (cons.) q. 2,8 4an.ii.1.1 m. 19,5 (cons.) 13,5 (cons.) 8,8 circ. diam. cm 4an.iii.1.1 m. o t.p. 21 (cons.) 15 (cons.) 3,3 circ. diam. cm 5,1an.i.1.2 m. 27 (cons.) 21 (cons.) 7,8 circ. diam. cm 5,1nau.1.1 m. 34 /// 10,5 c.ans. 12 2,2nau.1.2 = g.i.2.6nau.i.1 m. 25,5 (cons.) /// 10,5 q. 8 2nau.i.2* m. * * * c.ans.? * *nau.ii.1 m. 16 (cons.) /// 10
(cons.)c.ans. 9,8
(cons.)1,8
nau.3.1 m. 27 (vis.) 10 (vis.) 11 c.ans. 12,3 2nau.iii.1 m. 21 (vis.) 14 (cons.) 10,5 c.ans.? 5,5
(cons.)2
nau.iii.2 m. 31 (cons.) 18 (cons.) 11 c.ans. 11(cons.)
1,8
nau.iii.3 = g.i.1.2nau.iii.4 m. 25,5 (cons.) /// 10 c.ans. 6,3
(cons.)1,8
463testi e monumenti
catalogo supporto misure dei lati spess.formabollo
lungh.bollo
alt.bollo
nau.4.1 = m.iv.1.2nau.4.2 m. 32,5 /// 10,5 appr.q. 8,7 0,7/1,2nau.iv.1 = m.iv.1.4nau.iv.2 = m.iv.1.1nau.iv.3 m. 20,5 (cons.) /// 9 c.ans. 11,5 2nau.iv.4 m. 21 (cons.) /// 9,5 q. 7,4 1,4nau.iv.5* m. * * * q. * *nau.iv.6* m. * * * c.ans. * *nau.6.1 = m.iv.1.8nau.6.2* = m.iii.1.3*nau.vi.1* m. * * * appr.q. * *nau.vi.2* = m.iv.1.5*nau.vii.1 = m.iii.1.1nau.vii.2 m. 16 (cons.) /// 11 c.ans. 6,5
(cons.)1,7
nau.vii.3 m. 16 (cons.) /// 11 q. 6 (cons.) 2nau.vii.4 = m.v.1.2nau.vii.5 m. 27 (vis.) /// 9,5 q. 4,5 2,8nau.8.1* m. * * * c.ans.? * *nau.viii.1 m. 19 (cons.) /// 10 q. 4 4nau.viii.2* m. * * * q. * *nau.ix.1 = m.v.1.3nau.11.1 = g.i.1.1nau.xi.1 m. 31,8 /// 10 q. 4,7 3nau.xi.2 m. 17,5 (cons.) /// 9,5 q. 4,7 3,3nau.xi.3* m. * * * q.? * *nau.xi.4* m. * * * c.ans. * *nau.12.1 m. 20 (cons.) 24,5 (cons.) 10,5 c.ans. 11,5 2nau.xii.1 = m.iii.1.4nau.xii.2 = m.v.1.1nau.xii.3 = g.iii.4.2nau.xii.4 = g.i.2.2nau.xii.5 = m.iv.1.7nau.xii.6* m. * * * ? * *nau.13.1 m. 34 10 (cons.) 10 q. 4,5 ///
q. 4 2,9nau.13.2 m. 16 (cons.) 26 (cons.) 11 c.ans. 8,7
(cons.)2,3
nau.13.3 m. 32 (cons.?) 23 (cons.) 11 c.ans. 7,3(cons.)
2,3
nau.13.4 = g.i.2.5
464 testi e monumenti
catalogo supporto misure dei lati spess.formabollo
lungh.bollo
alt.bollo
nau.13.5* m. * * * c.ans. * *nau.13.6* m. * * * q. * *nau.13.7* m. * * * c.ans. * *nau.13.8* m. * * * q. * *nau.13.9* m. * * * c.ans.? * *nau.13.10* = m.iv.1.9*nau.xiii.1 m. 18 (cons.) /// 11 ? 6 (cons.) 1,5
(vis.)nau.xiii.2 m. 20 (cons.) /// 10,5 q. 7,5
(cons.)1,8
nau.xiii.3* m. * * * q. * *nau.xiii.4* m. * * * c.ans. * *nau.14.1 m. 24,5
(cons.)21,5(cons.)
9,5 appr.q. 8,6 0,7/1,3
nau.14.2 = g.i.2.4nau.14.3* m. * * * c.ans. * *nau.14.4* m. * * * q. * *nau.xiv.1 m. 32 21 (cons.) 10 c.ans. 12,8 1,8nau.xiv.2 m. 23 (cons.) /// 10 q. 3,5
(cons.)1,5
nau.xiv.3* m. * * * q.? * *nau.xiv.4* m. * * * q. * *nau.16.1 = m.iv.1.6nau.16.2* m. * * * c.ans. * *nau.16.3* m. * * * q. * *nau.xvi.1 m. 32 15 (cons.) 10 q. 7,5 1,5nau.xvi.2 = m.iv.1.3nau.xvi.3* = g.i.2.3*nau.xvi.4* m. * * * q. * *nau.xvi.5* m. * * * q. * *nau.17.1 m. 52 16 (vis.) 11 c.ans. 11,5? 2nau.17.2 m. 34 /// 9,5 ? 8 1,5nau.17.3 m. 32 22 (cons.) 11 c.ans. 11,8
(cons.)1,8
nau.17.4 = g.i.2.1nau.17.5 m. 28 (cons.) 10 (cons.) 9,5 c.ans.? 7,2 2,2nau.17.6* m. * * * c.ans. * *nau.17.7* m. * * * q.? * *nau.17.8* m. * * * c.ans.? * *nau.17.9* m. * * * c.ans. * *nau.xvii.1 m. 32 (cons.?) 8 (cons.) 11 c.ans. 11,5 2nau.18.1 = m.iii.1.2
465testi e monumenti
Appendice iii
Notizie sulla scoperta del laterizio con bollo Sphanionis (l.ii.1.1)93
Regio Ispettoratodegli
Scavi e Monumentiin Taormina
n. 18 di Protocollo 94 Taormina 16 Settembre 1899
Oggetto: Rinvenimento d'un'iscrizione greca e di lastroni di creta, in Taormina
IllustrissimoSig(no)r Direttore del Museo Nazio(na)le 95
Palermo
Essendomi stato riferito che nel fondo in questa contrada S(an) Pan-crazio degli eredi Cacopardo si facevano degli scavi al fine di cavarne pietreper la costruzione d'una casetta, essendo un locale archeologico, mi recai avedere cioÁ che erasi rinvenuto, e trovai in fatti alcuni scavi quaÁ e laÁ edavanzi rinvenuti dei grandi lastroni di creta uno di cm 73 � cm 69 � cm09. e gli altri di cm 66 � cm 66 � cm 08. ed una breve iscrizione greca(timbro della fabbrica) di cui rimetto un fac-simile 96 alla S(ignoria) V(ostra)Ill(ustrissi)ma, desiderando conoscerne l'interpretazione.
I sudetti oggetti sono conservati presso i Cacopardo.Con perfetta osservanza L'Ispettore
Giovanni Bonadonna
Salinas annota, a matita, C.I.L. Monteleone 8041.34 e, a penna, Ringraziare± e al tempo stesso chiedere un'impronta in carta bagnata (premendo con una(parola incomprensibile) molle o con una spugna) dell'iscrizione, la quale eÁ latina.
466 testi e monumenti
93 ASMP, busta 678. Su questo rinvenimento vd. anche G. Rizzo, Taor-mina e i suoi dintorni. Storia, architettura, paesaggio (Catania, 1902), p. 81:`Oltre i molti rottami fittili, avanzi di fabbriche, grandissimi mattoni grecilisci e bordati scoperti da recente nel settembre del 1899, i contadini locataridei piani dietro S. Pancrazio ci hanno mostrato un piccolo mattone, rotto inuno degli angoli, non visto ancora da alcuno, che conteneva impresse sullasuperficie alcune lettere latine grandi. [...] Sappiamo che la tegola si conservanel museo locale o almeno abbiamo pregato che fosse raccolta e conservatainsieme con gli splendidi mattoni. Ma questi ultimi non furono comprati equindi furono perduti per sempre, come al solito'.
94 Protocollo di arrivo al Museo nazionale di Palermo n. 435 del 23settembre 1899.
95 Antonino Salinas.96 Ancora allegato al documento.
IndiceBolli greci e latini
Bollo Catalogo\Ammi* ot g.ixdalori* a g.iiDiomtri* ot g.v< Eqla& , < Gqajke* o| g.ivEt> dxqo|(o [H]et* dxqo|)
g.vi
< Gqajkei* ot g.viii< eqa* g.iiiMijorsqa* sot g.viiiSatqolemisa& m g.iIul(ii) Secu(ndi) l.iiiC. Iulii Veri l.ivPetri l.iSphanionis l.ii
Monogrammi e bolli anepigrafi
Monogrammi m.i, ii, iii, iv, vSpina di pesce an.iStella an.iiTriskeles an.iii
467testi e monumenti
LA PAROLA DEL PASSATO - RIVISTA DI STUDI ANTICHI
la parola del passato eÁ sempre simile a una sentenzad'oracolo e voi non la intenderete se non in quanto saretegli intenditori del presente i costruttori dell'avvenire
nietzsche
LA PAROLA DEL PASSATO (PdP) fondata nel 1946, pubblica articoli,note critiche e filologiche, testi e monumenti, rassegne di studi antichi.
Norme di collaborazione. I testi vanno inviati in forma definitiva per la stampa, dat-tiloscritta e con versione elettronica, alla redazione: `La Parola del Passato', MacchiaroliEditore, e-mail [email protected]. Indicare nome e indirizzo dell'Autore, nu-mero di telefono, fax, e-mail, titolo corrente. Allegare un elenco delle eventuali figure,che devono essere ad alta risoluzione 300 dpi, con relative didascalie. Testi, disegni efotografie, anche se non pubblicati, non si restituiscono. Gli Autori riceveranno le bozzerelative. Trascorso un mese dalle spedizioni delle bozze all'Autore senza che questi abbiaprovveduto a restituirle corrette o a dare altra comunicazione, la rivista si riserva distampare l'articolo conforme al testo originale. Citazioni tra apici (` '), citazioni nellecitazioni tra `caporali' (« »). Nomi degli autori moderni in nota in maiuscoletto coniniziale puntata. Nomi e opere di autori antichi in latino secondo le rispettive abbrevia-zioni del LSJ e del Thes. l. Lat. Singole parole in latino e lingue straniere in corsivo.Citazioni in latino e in lingue straniere in tondo tra apici. Abbreviazioni e termini latinidi uso corrente in tondo: Id., Ead., ibid., ap., ad loc., scil., op. cit., supra, infra, passim.Usare cf., non cfr. Evitare il doppio spazio dopo il segno d'interpunzione. Nel testoil riferimento alla nota va messo dopo il segno d'interpunzione. Va rispettato uno spaziodopo i punti sospensivi. Le note bibliografiche vanno riportate nella lingua originaledella pubblicazione. Es. libro: G. Pugliese Carratelli, Scritti sul mondo antico (Napoli,1976). Es. contributo in vol. miscellaneo: A. Grilli, Cicerone, in I. Lana - E.V. Mal-tese (a cura di), Storia della civiltaÁ letteraria greca e latina (Torino, 1988), II, pp. 507-538.Es. articolo in periodico: M. Gigante, Simonide e Leopardi, «PdP», LIII, 1998, pp. 161-200. I testi accettati per la pubblicazione che non seguono le norme di collaborazionesaranno rispediti agli Autori per l'adeguamento allo stile della rivista. I collaboratoririceveranno gratuitamente, via e-mail, un estratto in formato pdf e, su richiesta e apagamento, trenta estratti cartacei dei loro scritti.Peer-review. Articoli e note inviati alla rivista per la pubblicazione sono sottoposti,nella forma del doppio anonimato, a peer-review di due esperti, dei quali almeno unoesterno alla Direzione e al Consiglio direttivo. Ogni due anni saraÁ pubblicato l'elencodei revisori.Prezzi. I fascicoli arretrati disponibili vengono venduti al prezzo di A 22,00 (Italia),EuropaA 27,00, extra EuropaA 30,00. L'abbonamento all'annata LXVIII/2013 (numeri388-393 della serie) costa A 93,00, Europa A 115,00, extra Europa A 130,00. L'editorerinnova l'invio dei fascicoli eventualmente dispersi solo agli abbonati che autorizzano laspedizione in piego raccomandato. Essi dovranno in tal caso aggiungere all'importo del-l'abbonamento A 10,33 ± estero A 18,33.Pagamenti: bonifico bancario sul conto corrente në 3797 Unipol Banca, Agenzia 089,Napoli - codice IBAN në IT12 D031 2703 4110 0000 0003 797 - BIC: BAECIT2Bintestato a Macchiaroli Editore s.a.s., 80127 Napoli - Italia. I clienti che invianoassegni in moneta diversa dall'euro devono aggiungere il controvalore di 20 euro perspese di incasso. Citare sempre la fattura a cui si riferisce il pagamento.
Macchiaroli Editore 11 via Michetti 80127 Napolitelefono +39 081 5783129 - fax +39 081 5780568
e-mail [email protected].
Reg. Trib. Napoli n. 267 del 12.9.1949. Gisella Macchiaroli, responsabile




























































![[Newspapers and Post] "Giornali in Posta" - prima parte - L'epoca dei bolli (1814-1849)](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6323953e5f71497ea9046660/newspapers-and-post-giornali-in-posta-prima-parte-lepoca-dei-bolli-1814-1849.jpg)