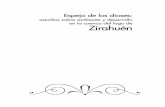Nuovi bolli oschi su tegola dall’area del lago del Matese
Transcript of Nuovi bolli oschi su tegola dall’area del lago del Matese
Studi sulla Campania nell’Antichità
OEBALUS
SCIENZE E LETTEREROMA
8
2013
OEBALUS Associazione Culturale
OEBALUSStudi sulla Campania nell'Antichità
8, 2013
Pubblicazione annuale. Registrazione del Tribunale di Napoli, n. 68 del 22 settembre 2006.
DIRETTORE RESPONSABILE
Felice Senatore
COMITATO DI REDAZIONE
Maurizio Bugno - Domenico Camardo - Eduardo Federico - Alessandro PagliaraCarlo Rescigno - Mario Russo - Eliodoro Savino - Gianluca Soricelli
COMITATO SCIENTIFICO
Claude Albore Livadie - Rosalba Antonini - Dominique Briquel - Giuseppe Camodeca Renata Cantilena - Luca Cerchiai - Michael Crawford - Francesco De Angelis -
Natalie de Haan - Jens-Arne Dickmann - Massimo PoettoHenrik Mouritsen - Fabrizio Pesando - Felix Pirson - Paolo Poccetti
Giovanna Rocca - Heikki Solin - Timo Sironen - Gianluca Tagliamonte
OEBALUS - Associazione Culturale e Casa EditriceVia S. Costanzo, 8 - 80073 Capri (NA)
Grafica e impaginazione: Felice Senatore
© 2014 SCIENZE E LETTERE DAL 1919 S.r.l. UNIPERSONALE già Bardi Editore, Via Piave, 7 - 00187 Roma - Tel. 064817656 - Fax 0648912574.www.scienzeelettere.it - email: [email protected]
ISSN 1970-6421ISBN 9788866870531
INDICE
CARLO DE SIMONE,
ALASTAIR SMALL, David Ridgway
GABRIELLA COLUCCI PESCATORI, VINCENZO DI GIOVANNI,
GIUSEPPE CAMODECA,
MARIA RISPOLI,
SERGIO CASCELLA,
GIANLUCA SORICELLI,
LOREDANA MANCINI,
MARIA CRISTINA NAPOLITANO,
TERESA LAUDONIA,
DOMENICO CAMARDO, ALDO CINQUE, GIOLINDA IROLLO E MARIO NOTOMISTA,
Abstracts
Heiner Eichner: etimologie «etrusco-tirseniche» (et alia)
Compsa, gli Antistii e l’iscrizione plateale del foro
Nuove iscrizioni paleocristiane con date consolari dal complesso basilicale di Cimitile
Una tomba a ricettacolo dalla necropoli di Trinità a Piano di Sorrento
Matidia Minore, la Bibliotheca Matidiana e il Foro di Suessa (Sessa Aurunca - Ce): considerazioni preliminari sullo scavo del cosiddetto Aerarium
Nuovi bolli oschi su tegola dall’area del lago del Matese
«Le Sirene danzeranno in Babilonia». Metamorfosi di un mito tra l’antichità e le Sacre Scritture
La persuasione di Elena. I rilievi marmorei dalle collezioni museali (Napoli, Vaticano, New York)
Materiali dalle necropoli preromane della Penisola Sorrentina nelle collezioni del Museo Correale di Terranova: alcune note preliminari
Prima ipotesi sul limite orientale dell’abitato dell’antica Ercolano
53
7p.
121
147
219
109
245
271
301
325
69
345
Gianluca Soricelli
Nuovi bolli oschi su tegola dall’area del lago del Matese
La prosecuzione dei lavori di scavo sul sito sannitico-romano di località Capo di 1
Campo, nei pressi del lago del Matese (Castello del Matese, CE) ha permesso il
rinvenimento di un ulteriore gruppo di bolli in osco su tegole e coppi da aggiungere 2
a quelli rinvenuti nella campagna di scavo del 2011 e già presentati in questa sede .
Essi sono pertinenti ad un edificio pubblico databile al più tardi nel corso del II
secolo a.C., a carattere verosimilmente cultuale, del quale gli interventi di scavo
hanno al momento restituito un breve setto murario - riutilizzato dal complesso
edilizio che in età augustea vi si impianta sopra - realizzato con grossi blocchi 3
squadrati, di forma più o meno regolare, di calcare fossilifero (figg. 1.a; 2) . I
blocchi, larghi m. 0,43/0,44 sono lunghi m.1,00 e alti tra m. 0,39 e 0,46, per una
lunghezza complessiva di m. 2,90 (il blocco centrale risulta essere stato scalzato
dalla posizione originaria da un intervento di scavo moderno). All’estremità
settentrionale il muro si lega ad una porta (tamponata nel riutilizzo di età augustea),
larga m. 1,04 e profonda m. 0,40 (fig. 1.b). I blocchi poggiano su di una fondazione
(fig. 1.c) realizzata con scheggioni di calcare legati da una malta di calce piuttosto
dura. Le relazioni stratigrafiche assicurano che questo muro rappresenta
l’elemento strutturale più antico al momento portato alla luce e, del resto, tutte le
altre strutture murarie, pertinenti all’edificio di età augustea, risultano realizzate
con pietrame calcareo di piccole e medie dimensioni e con blocchi squadrati di
conglomerato calcareo posti in opera negli stipiti delle porte. Altri blocchi nel
medesimo calcare fossilifero, talora ridotti nelle dimensioni originarie e caratteriz-
1 Desidero ringraziare la Soprintendente Archeologa di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta, dott.ssa Adele Campanelli, per aver concesso le necessarie autorizzazioni, ed il funzionario archeologo di zona, dott. Antonio Salerno, per il continuo sostegno fornito alla ricerca; quest’ultima è stata avviata nel 2010 nel quadro delle attività svolte in convenzione dall’Università del Molise con la Soprintendenza Archeologica ed il Comune di Castello del Matese (CE). Un sentito ringraziamento è dovuto al sindaco, dott. Antonio Montone, e all’Amministrazione Comunale di Castello del Matese per aver fortemente voluto e sostenuto l’indagine a Capo di Campo. L’inquadramento topografico ed il rilievo strumentale delle strutture sono stati realizzati dal dott. Luigi Lombardi (Ares s.r.l.) che ringrazio.
2 Soricelli 2011.3 Per una prima sintesi sullo scavo vd. Soricelli 2013.
zati dalla presenza di incassi a coda di rondine o da una accurata sagomatura delle
superfici di contatto, risultano essere stati ugualmente reimpiegati nelle strutture
posteriori. Sul lato orientale si appoggia al setto murario, e riveste il passo della
porta, un piano pavimentale in battuto di terra e calce che risulta tagliato dalle fosse
di fondazione dell’edificio di età augustea; oltre a frammenti di ceramica a vernice
nera e ceramica a pareti sottili, questo piano pavimentale ha restituito un asse in 4
bronzo databile tra il 169 ed il 158 a.C. Un sottile strato di cenere e carboni, che
copre il piano pavimentale ed il passo del vano della porta e che ha pure restituito
due assi in bronzo anonimi, risulta ugualmente tagliato dalle fosse di fondazione
dell’edificio di età augustea; esso potrebbe essere indizio di una fine violenta di
questo complesso, forse in relazione con gli avvenimenti della guerra sociale che 5
investirono pesantemente Bovianum ed il suo territorio . È da sottolineare, a questo
riguardo, che le monete repubblicane fin qui rinvenute negli strati d’uso
dell’edificio sannitico o residue negli strati posteriori sono tutte anteriori al 90 a.C.
(la moneta più tarda sicuramente databile è rappresentata da un denario suberato di 6
C. Claudius Pulcher databile al 110/109 a.C. ) e che la sequenza monetale si riapre 7
con un quadrante di C. Asinius Gallus del 16 a.C. ed un asse di C. Plotius Rufus del 8
15 a.C. , quest’ultimo proveniente dalla fossa di fondazione dell’edificio che in età
augustea si impianta sulle strutture sannitiche.
Anche questi nuovi bolli provengono dagli strati di disfacimento e obliterazione
dell’edificio di età augustea per la cui realizzazione le tegole di copertura
dell’edificio sannitico erano state riusate ritagliandole e ponendole in opera sia
nelle strutture murarie (ad esempio i nn. 14-15 e 18) che nei pavimenti in opus
4 Crawford 1974, 243, n. 196, pl. XXXI, 9.5 Secondo Appiano (Civ. I 51, 223-225), nell’89 a.C. Silla, dopo aver sottomesso gli Irpini, avrebbe
marciato contro i Pentri seguendo però non la strada diretta, controllata da Mutilo, bensì una strada che imponeva un lungo giro ma che per tale motivo non era controllata dai Sanniti, cfr. Gabba 1976, p. 153 secondo cui la strada seguita da Silla lo avrebbe portato tra Capua e Teano; ciò avrebbe permesso a Silla di sorprendere e sconfiggere Mutilo, costretto a rifugiarsi ad Aesernia, e di continuare la sua azione attaccando ed espugnando Bovianum nonostante fosse difesa da un complesso sistema difensivo costituito da tre fortezze, due delle quali identificate rispettivamente con la cinta fortificata che racchiude Civita di Bojano e con la piccola fortificazione sulla sommità di monte Crocella, cfr. Oakley 1995, pp. 107-109 (la città, tuttavia, sarebbe stata riconquistata l’anno successivo da Poppedio Silone, cfr. Obseq. 56).
6 Crawford 1974, p. 313, n. 300/1: Ø 16 mm; peso 1,99 gr.; D/ Testa di Roma con elmo verso ds. R/ Vittoria su biga in corsa verso ds.; in esergo C. PVLCHER.
7Sutherland 1984, p. 71, n. 373: Ø mm. 26; peso gr. 8,96; D/ CAESARAVGVST[VS TRIBVNICPOTEST]; testa volta verso ds. R/[CASINIVS]GALLVSIIVIR[AAAFF]); al centro SC.
8 Sutherland 1984, p. 71, n. 389: Ø 25 mm; peso 8,62 gr; D/CAESAR [AVGVSTVS TRIBVNIC POT]EST; testa volta verso ds. R/ [C.]PLOT[IVS RVF]VS III[VIR AAAFF]; al centro SC.
GIANLUCA SORICELLI220
NUOVI BOLLI OSCHI SU TEGOLA DALL’AEREA DEL LAGO DEL MATESE
Fig. 1. Capo di Campo (Castello del Matese, Ce): le strutture della fase sannitica.
221
Fig. 2. Capo di Campo (Castello del Matese, Ce): il muro in grossi blocchi di calcare.
figlinum (certamente il n. 12, come mostra la malta di cocciopesto in cui era
allettato - resa in retino grigio alla fig. 3.6 - ancora aderente alle superfici).
L’argilla, pressoché identica a quella degli altri esemplari già editi (e ciò
legittima l’ipotesi, da verificare in ogni caso mediante analisi archeometriche, della
loro provenienza se non dalla medesima officina quanto meno dalla medesima area
di produzione), risulta molto omogenea, mediamente dura, con buona macro-
porosità; gli inclusi più minuti (inferiori a mm 1) sono rappresentati da quarzi e
feldspati; gli inclusi più grossolani (superiori a mm 1) sono invece rappresentati da
chamotte (abbondante, arrotondata, fino a mm 5), pomici e scorie vulcaniche
(frequenti, sub-arrotondate), pirosseni (frequenti), ed ancora quarzi e feldspati
(sporadici).
Come nel precedente contributo, per non appesantire le singole schede sono
stati sintetizzati nella tabella che segue le dimensioni (espresse in centimetri) dei 9
frammenti bollati, il colore delle argille , le letture proposte per ciascun bollo ed il 10
riferimento alle Imagines Italicae . I bolli sono tutti di forma rettangolare e
sinistrorsi, ad eccezione del n. 14, destrorso, e sono apposti su tegola i nn. 7-8, 12-
18, su coppo i nn. 9-11. La numerazione dei bolli (nn. 7-18) prosegue quella degli
esemplari già editi (nn. 1-6):
9 Secondo le Munsell Soil Color Charts.10 Crawford 2011.
GIANLUCA SORICELLI222
7) (figg. 3.1; 6.1) bollo rettangolare, visibile l’angolo superiore sinistro del
cartiglio; lettere incavate, impresse poco profondamente nella parte centrale, alte
ca. cm 1,1/1,2; linea di scrittura lunga cm 8.
m·t·bn·bet·mt
L’esemplare matesino permette di completare, restituendo anche il patronimi-11
co, un esemplare rinvenuto nel santuario di Ercole a Campochiaro . La lettura 12
integrale è, dunque, la seguente: m(eddíss) t(úvtiks) b(a)n(ttis) bet(itis) 13
m(i)t(ileís) . Un b(a)n(ttis) bet(itis) b(a)n(ttieís), ricordato in qualità di meddíss in
un’iscrizione dedicatoria da Molise (Cb), in territorio di Bovianum, potrebbe essere 14
familiarmente legato a costui ; il gentilizio ricorre ancora su di una laminetta 15
plumbea da Monte Vairano associato al prenome statis .
n. lungh. largh. spess. Mus Im. It. 7 13,1 8,2 3,9 2.5Y 8/4 m(eddíss) t(úvtiks) b(a)n(ttis) bet(itis) m(i)t(ileís) Bovianum 6 8 5,2 3,9 0,9 5YR 8/3 [m(eddíss)] t(úvtiks) l(úvkis) kl[í(ppiis) l(úvkieís)] Bovianum 10 9 5,3 4,4 1,7 7.5YR 8/3 m(eddíss) t(úvtiks) p(a)k(is) la[í( ) p(a)k(ieís)] Bovianum 11 10 13,2 8,9 2 7.5YR 6/2 g(aavis) papi(ís) m(i)t(eleís) m(eddíss) t(úvtiks) x Bovianum 27 11 13,1 7,3 1,6 5YR 7/4 [n(iumsis) staa(tiís) o ni(umsieís) staa(tieís)
m(eddíss) t(úvtiks) g(aavis) p]aap(iís) mit(ileís) Bovianum 3
12 12,8 9,8 3,8 2.5YR 8/4 n(iumsis) pap(iís) m[(a)r( ) nu(mnud) t(outas)] Bovianum 26 13 14,4 7,6 3,2 2.5Y 7/3 p(a)k(is) o p(a)k(ieís) m(eddíss) t(úvtiks) h( )r( )
paapi(ís) h[...] /
14 19,4 13,8 3,2 7.5YR 8/3 m(eddíss) t(úvtiks) s(te)n(is) staí(ís) m[it(i)l(eís) k( )] Bovianum 24 15 22,8 8,9 3,3 2.5YR 7/6 [g(aavis) o g(aavieís) ka]m( ) m(eddíss) t(úvtiks)
l(úvkis) sta(íís) m[(a)r(aheís)]
16 7,5 5 3,8 10YR 5/3 [...]paa[p(iís) o pi(ís)][...] ? 17 3,5 3,2 3,1 2.5Y 7/3 [...]paa[pi(ís)][...] ? 18 13,8 9,0 3,0 2.5Y 8/4 [...] ú(vieís) o [... n]ú(vieís) tr(ebieís) oppure ú(vis) o
[n]ú(vis) tr(ebiis) /
11 Sull’esemplare di Campochiaro del patronimico sopravvive solo una barra verticale diversa-mente intesa: Capini 1985, pp. 248-251, n. 25, tav. XLVII, suggerisce tr(ebieís); La Regina 1989, p. 329 osserva che per ciò che sopravvive della prima lettera, il patronimico deve iniziare con m, n, p o t; Crawford 2011, p. 994, Bovianum 6, riprende, sia pure dubitativamente, il tr(ebieís) suggerito dalla Capini.
12 Lo scioglimento in banttis (= lat. Bantius) per l’abbreviazione pronominale bn è generalmente accettato, cfr. Salomies 2008, p. 21. Capini 1985, p. 251 avanza la possibilità che abbrevi banna (= latino Bennius), cfr. anche Vetter 1953, p. 112, n.156.
13 L’abbreviazione prenominale mt ricorre anche sul bollo g·pa^pi·mt·m·t·x da Campochiaro, loc. Civitella, documentato anche a Capo di Campo, vd. infra, ma risulta usata più comunemente la forma mit, vd. Capini 1985, p. 246; Salomies 2008, pp. 27-28.
14 Capini 1985, p. 251; La Regina 1989, p. 329; Letta 1994, p. 390 (che, invece, dubita che possa trattarsi di esponenti della stessa famiglia); Marchese - Poli 2006; Crawford 2011, pp. 1095-1096, Bovianum 97.
15 De Benedittis 1980, pp. 419-420. Crawford 2011, pp. 1097-1098, Bovianum 98. Sul prenome statis vd. Salomies 2008, pp. 34-35.
NUOVI BOLLI OSCHI SU TEGOLA DALL’AEREA DEL LAGO DEL MATESE 223
8) (figg. 3.2; 6.2) bollo rettangolare a lettere incavate conservate per una altezza
di ca. cm 1,3; linea di scrittura conservata per cm 3,7.
[…]t·l·kl[…]
Si tratta di un nuovo esemplare del bollo m·t·l·klí·l, ovvero m(eddíss) t(úvtiks) 16
l(úvkis) klí(ppiis) l(úvkieís), già documentato a Capo di Campo dall’esemplare n. 1 17
e attestato anche a Campochiaro, Colle d’Anchise, Sepino e San Pietro di Cantoni .
9) (figg. 3.3; 6.3) bollo rettangolare; la linea di scrittura è conservata per una
lunghezza di cm 4,10; lettere incavate alte cm 1,2.
m·t·pk·la[…]
Del bollo, oltre al titolo di funzione, restano il prenome p(a)k(is) e la prima
sillaba del gentilizio la[…], ma la formula onomastica può essere integrata grazie ai
diversi esemplari, integri o frammentari, già noti da Bojano, Campochiaro e Colle 18
d’Anchise . La lettura completa è, dunque, la seguente: m(eddíss) t(úvtiks) 19 20
p(a)k(is) laí( ) p(a)k(ieís) .
10) (figg. 3.4; 6.4) bollo rettangolare a lettere incavate alte ca. cm 1,4; linea di
scrittura conservata per cm 7,5.
g·pa^pi·mt·[…]
Sebbene mutilo, l’esemplare matesino sembra restituire un nuovo esempio del
bollo g·pa^pi·mt·m·t·x, documentato da più esemplari nel santuario di Ercole a 21
Campochiaro e in loc. S. Michele Arcangelo a Civita di Bojano .
16 Soricelli 2011, p. 56, n. 1. 17 Crawford 2011, pp. 998-999, Bovianum 10.18 Crawford 2011, pp. 1000-1001, Bovianum 11. Bojano, collezione Chiovitti: Mommsen 1850, p.
175, IX, Taf. VIII. Campochiaro, santuario di Ercole: Capini 1978, p. 421, n. 29, G 1, 430, tav. LXXVIII; Campochiaro, territorio: De Benedittis 2005, p. 65, n. 173, 67. Colle d’Anchise: De Benedittis 1978, p. 116, n. 23, D 3, 417.
19 Sul prenome pakis e la sua diffusione Antonini 2004, pp. 286-289 e note 55-56, 59; Salomies 2008, pp. 30-31. Risulta in genere abbreviato tanto nella forma pk quanto nella forma pak e con le lettere sia sciolte che legate; nella forma pk, con lettere sciolte, non è altrimenti attestato, mentre è comunemente impiegato nella forma p^k, cfr. infra, nt. 32.
20 La Regina 1989, pp. 331-332; Crawford 2011, pp. 1000-1001. Per il gentilizio, La Regina 1989, p. 332 suggerisce la possibilità di scioglierlo in Laenius (= osco laínis), documentato a Brindisi (CIL IX 117), Taranto (CIL IX 244), Amiternum (CIL IX 4204, nella forma Lainio); Crawford 2011, pp. 1000-1001 propone, invece, lo scioglimento laí(is) = lat. Laius; Mommsen 1850, p. 175, Laesius.
21 Capini 1985, pp. 246-248, 249, n. 23, tav. XLVII, 23; Crawford 2011, p. 1021, Bovianum 27.
GIANLUCA SORICELLI224
Fig. 3. Capo di Campo (Castello del Matese, Ce): i bolli nn. 7-13 (scala 1:2).
NUOVI BOLLI OSCHI SU TEGOLA DALL’AEREA DEL LAGO DEL MATESE 225
11) (figg. 3.5; 6.5) bollo rettangolare; la linea di scrittura si conserva per una
lunghezza di cm 4,7; lettere incavate alte fino a cm 1,8.
[...]a^a^p·mit
Per quanto rovinato, le lettere superstiti sembrano restituire il gentilizio
[p]aap(iís) seguito dal patronimico mit(eleís). Potrebbe dunque trattarsi di un 22
nuovo esempio del bollo ni·sta^a·m·t·g·p^a^a^p·mit, documentato a Campochiaro 23
e nell’area di Bojano da diversi esemplari, ora dispersi, della collezione Chiovitti .
12) (figg. 3.6; 6.6) bollo rettangolare; la linea di scrittura si conserva per una
lunghezza di cm 5,3; lettere incavate alte cm 1,1/1,2.
n·pap·m[...]
Si tratta del secondo esemplare di un bollo già documentato a Capo di Campo
(n. 5, fig. 4.2) e, nel territorio di Bojano, a Colle d’Anchise. La loro derivazione dal
medesimo punzone sembra assicurata sia dalla grafia delle lettere che dalla
peculiare forma stretta e allungata dei segni di interpunzione, in particolare di 24
quello che separa il gentilizio dal patronimico . L’esemplare più completo 25
permette di leggere n·pap·mr·nu[…] ma è forse possibile riempire la lacuna finale
sulla base di un esemplare mutilo da Campochiaro (fig. 4.1, non in scala), dalla
superficie parzialmente abrasa, letto [...]mr·m·t, ovvero […]m(a)r(aheis) 26
m(eddíss) t(úvtiks) ma del quale sembra preferibile la lettura[...]mr·nu·t. L’esame 27
autoptico dei due bolli permette, infatti, di rilevare la piena coincidenza grafica
dei patronimici mr e tra il gruppo nu del primo e la m di m(eddíss) del secondo, tale
da fugare ogni incertezza sulla derivazione dei due bolli dal medesimo punzone.
22 Capini 1978, pp. 421-422, n. 30, G 2, 430, tav. LXXVIII; cfr. anche Antonini 1981, p. 320; De Benedittis 1983, p. 313, n. 8.
23 Maiuri 1913, pp. 480-482, fig. 1; Crawford 2011, p. 991, Bovianum 3. Sui materiali laterizi oschi della collezione Chiovitti vd. anche De Benedittis 1978, pp. 410, 413-414, nn. 9-13, A9-A13, 417.
24 Rispettivamente Soricelli 2011, pp. 61-62, n. 5, figg. 2-4; De Benedittis 1978, pp. 416-417, n. 21, D1, tav. LXXVI.
25 Soricelli 2011, pp. 61-62, n. 5, figg. 2-4. 26 Sul bollo di Campochiaro (Crawford 2011, p. 1020, Bovianum 26) vd. Capini 1978, pp. 429, n.
48, G20, 430 (riproduzione grafica imprecisa); la relazione tra questo e l’esemplare di Colle d’Anchise è stata avanzata da De Benedittis 1983, p. 312, n. 5, tav. XLV, 1 (con foto di dettaglio del bollo) con lettura complessiva n·pap·mr·m·t, cfr. anche Soricelli 2011, pp. 61-62 (ove era però esclusa la possibilità di una lettura unitaria dei due bolli).
27 Desidero ringraziare la dott.ssa Stefania Capini (Soprintendenza per i Beni Archeologici del Molise) per avermi permesso di esaminare il bollo da Campochiaro.
GIANLUCA SORICELLI226
Resta, piuttosto, il dubbio circa la corretta lettura della parte terminale, se nu oppure
m. A riguardo, l’ottimo stato di conservazione della superficie e l’eccellente
leggibilità del bollo di Capo di Campo (fig. 4.2) rende preferibile la lettura nu
piuttosto che m, tenuto conto della netta separazione delle ultime due barrette dal
resto del corpo della presunta m e, rispetto a quest’ultima, della grafia del tutto
diversa della m del patronimico che precede. La lettura completa che si propone è
dunque la seguente: n·pap·mr·nu·t, con la prima parte del bollo evidentemente da sciogliere n(iumsis) pap(iís) m(a)r( ). Per quanto riguarda la seconda parte del
28bollo, non è da escludere la possibilità che nu e t siano elementi onomastici , anche
29se nu( ) per nu(vieís) risulterebbe con la u non diacriticata; di contro è da osservare
che non risultano al momento documentati nella serie “pubblica” bolli ove la
Fig. 4. 4.1: bollo da Campochiaro (da De Benedittis 1983, fuori scala); 4.2: bollo da Capo di Campo (da Soricelli 2011, scala 1:1).
28 Per t( ) come abbreviazione prenominale in area pentra vd. Crawford 2011, pp. 1050-1051, Terventum 4: t( ) staiis t( ), Pietrabbondante, iscrizione del tempio A.
29 Intendendo nu come abbreviazione prenominale, núvis risulterebbe la soluzione più plausibile, cfr. Soricelli 2011, p. 61.
NUOVI BOLLI OSCHI SU TEGOLA DALL’AEREA DEL LAGO DEL MATESE 227
formula onomastica comprenda avo e proavo e che, ancora, verrebbe a mancare il
titolo di funzione, di norma presente. In alternativa nu( ) t( ), piuttosto che alla formula onomastica di n(iumsis) pap(iís), potrebbe riferirsi alla natura del suo
ufficio e sciogliersi, semmai, nu(mnud) t(outas), ovvero “a nome / per incarico
della comunità”. Un possibile termine di confronto per questa formula, che
risultando complementare a m( ) t( ) permetterebbe di assegnare anche questo bollo
alla serie “pubblica”, potrebbe essere offerto da una iovile capuana, di lettura però 30
controversa, ove è stato suggerito di leggere num(nud) verehias .
13) (figg. 3.7; 7.1) bollo rettangolare, impresso più profondamente verso destra;
linea di scrittura conservata per una lunghezza di cm 10,4; lettere incavate alte cm
1,4/1,6.
p^k·m·t·h^r·paapih[...]
Questo nuovo esemplare, integrando la prima parte del testo - p^k·m· -, consente 31
di confermare e migliorare la lettura del bollo n. 3 . Il monogramma p^k è da
intendere come prenome, p(a)k(is), considerato che tale sembra essere il suo uso 32
normale in area pentra , mentre la m che segue conferma che il nome di hr( )
paapi(ís) era preceduto dal titolo di funzione. La lettura completa è, dunque, la
seguente: p(a)k(is) [o p(a)k(ieís)] m(eddíss) t(úvtiks) h( )r( ) paapi(ís) h[…] e
consente di aggiungere il nostro esemplare a quel piccolo gruppo di bolli ove il
titolo di funzione è interposto tra i nomi di due personaggi.
14) (figg. 5.1; 7.2) bollo rettangolare orientato da sinistra verso destra, impresso
con maggior forza sul lato sinistro e molto debolmente sul lato destro ove le lettere
risultano assai poco evidenti; la linea di scrittura è conservata per una lunghezza di
cm 8; lettere incavate alte cm 1,4.
mtsn·staí[...]
30 Vetter 1953, pp. 79-80, n. 87; Rix 2000, pp. 214-215; 2002, p. 100, Cp 32; leggono invece íním Franchi de Bellis 1981, pp. 156-171, n. 21, tav. 15; Crawford 2011, pp. 417-418, Capua 32. Il genitivo numneís ritorna nell’iscrizione da Castel di Sangro Crawford 2011, pp. 1235-1236, Aufidena 1. Sul termine vd. anche Untermann 2000, pp. 500-501.
31 Soricelli 2011, pp. 58-60, n. 3, figg. 2-4.32 Sul prenome cfr. Salomies 2008, pp. 30-31 e supra alla nt. 19. Sull’impiego di p^k come
abbreviazione prenominale si vedano, ad esempio, le due iscrizioni lapidee da Castel di Sangro e Forlì del Sannio / Rionero Sannitico (Crawford 2011, pp. 1236-1238, Aufidena 1 e 2) ed i graffiti da Campochiaro, loc. Civitella (Crawford 2011, p. 1076, Bovianum 80), Monte Vairano (De Benedittis 1979, p. 354, n. 2; Crawford 2011, p. 1104, Bovianum 104.1) e S. Giovanni in Galdo (Di Niro 1978, pp. 454, n. 118, M 28, 457; Crawford 2011, p. 1226, Fagifulae 5.16).
GIANLUCA SORICELLI228
Fig. 5. Capo di Campo (Castello del Matese, Ce): i bolli nn. 14, 16-18 (scala 1:2), n. 15 (scala 1:3).
NUOVI BOLLI OSCHI SU TEGOLA DALL’AEREA DEL LAGO DEL MATESE 229
Del bollo sono leggibili le prime due lettere che restituiscono il titolo di funzio-
ne e l’orientamento della linea di scrittura, seguiti da sn ed un possibile segno di
interpunzione; di seguito sembra possibile leggere, sia pure con difficoltà, staí. 33
Tenuto anche conto dell’orientamento destrorso del bollo , la sola lettura possibile
sembra essere mtsn·staí[mitl·k] ovvero m(eddíss) t(úvtiks) s(te)n(is) staí(ís)
m[it(i)l(eís) k( )]. A giudicare, anzi, dalla grafia delle lettere ancora percepibili, il
bollo potrebbe essere stato impresso con il medesimo punzone utilizzato per un 34
esemplare dal santuario di Ercole a Campochiaro . Il bollo risulta già documentato 35
a Capo di Campo con un esemplare (il n. 2) impresso da differente punzone .
15) (figg. 5.2; 7.3) bollo rettangolare, impresso con maggiore forza sul lato
destro; la linea di scrittura è conservata per una lunghezza di cm 9,6; lettere incavate
alte cm 2.
[…]mt·l·sta[·]m[…]
Del bollo sono leggibili, nonostante la frattura, il prenome ed il gentilizio del
personaggio, l(úvkis), stl o sta; a destra del prenome si conserva la parte inferiore di
un tratto verticale, verosimilmente una t, preceduto da una lettera di cui si conserva
solo la base ma che sembra interpretabile come m e da un’ulteriore lettera, forse
ugualmente m o n; tra la t ed il prenome è forse presente, lungo la linea di frattura, un
segno di interpunzione. Per quanto riguarda il gentilizio, la terza lettera potrebbe
essere tanto l, seguita da un segno verticale da interpretare come segno di interpun-
zione, quanto a, tenuto conto della diversa grafia della presunta l rispetto alla l del
prenome (l’angolo tra la barretta verticale e quella obliqua risulta in questo caso
sensibilmente più aperto), che nella linea di frattura potrebbe cogliersi il margine
inferiore della barra orizzontale della a, e che, infine, il segno verticale a sinistra
sembra avere la stessa altezza della barra sinistra della a di un bollo da
Campochiaro che potrebbe costituire un confronto puntuale per il nostro esempla-36
re . Il gentilizio è seguito una lettera male impressa, forse ancora una m; una larga
scoppiatura sulla superficie non permette di notare la presenza di altre eventuali
lettere. La lettura che si suggerisce è la seguente: [...]m( ) m(eddíss) t(úvtiks)
33 Nei bolli dell’officina “pubblica” di Bojano l’orientamento della linea di scrittura da sinistra verso destra si riscontra, al momento, solo nei seguenti esemplari: a) mtnipúmt[…] = m(eddíss) t(úvtiks) ni(umsis) púm(púniis) t[…], La Regina 1989, p. 334; Crawford 2011, p. 1006, Bovianum 14 con diversa lettura: m(eddíss) t(úvtiks) ni(umsis) púm(tiis) tr(ebieis); b) mtsn·stai·mitl·k = m(eddíss) t(úvtiks) s(te)n(is) staí(ís) mit(i)l(eís) k( ), Crawford 2011, pp. 1017-1018, Bovianum 24.
34 Capini 1978, pp. 424, n. 36, G8b, 430.35 Soricelli 2011, p. 58, n. 2, figg. 2-4.36 Crawford 2011, p. 988, n. 4 (con foto a p. 987, in alto a sinistra).
GIANLUCA SORICELLI230
Fig. 6. Capo di Campo (Castello del Matese, Ce): i bolli nn. 6-12 (scala 1:1).
NUOVI BOLLI OSCHI SU TEGOLA DALL’AEREA DEL LAGO DEL MATESE 231
Fig. 7. Capo di Campo (Castello del Matese, Ce): i bolli nn. 13-18 (scala 1:1).
GIANLUCA SORICELLI232
l(úvkis) sta(íís) m[...]. Se corretta, si potrebbe trattare di un ulteriore esemplare del
bollo g(aavis) [o g(aavieís)] kam( ) m(eddíss) t(úvtiks) l(úvkis) sta(íís) 37
m(a)r(aheís), ben documentato nel territorio di Bojano e a Campochiaro .
16) (figg. 5.3; 7.4) bollo rettangolare, la linea di scrittura è conservata per una
lunghezza di cm 4; lettere incavate alte cm 1,3.
[…]paa[…]
Del bollo, dalla superficie fortemente consunta ed erosa, si conservano solo tre
lettere che sembrano restituire il gentilizio paa[piís]. Un possibile confronto
potrebbe essere offerto dal bollo n. 13, di hr( ) paapiís, ove anche compaiono due a
sciolte; tuttavia queste ultime sono retrograde e ciò esclude che i due bolli possano
provenire da uno stesso punzone, pur non potendosi scartare la possibilità di
punzoni diversi per il medesimo bollo. Nell’altro caso noto in cui ricorre il gentili-
zio paapiís, le a sono in legatura così come sembrerebbero legate in un bollo dal 38
santuario di Campochiaro di incerta lettura .
17) (figg. 5.4; 7.5) bollo rettangolare; la linea di scrittura si conserva per una
lunghezza di cm 3; lettere incavate conservate per un’altezza massima di cm 0,9.
[...]pa^a[...]
Ciò che resta del bollo sembra restituire la parte inferiore di due a in legatura,
precedute dai tratti inferiori di due barrette verticali. Le due a in legatura caratteriz-
zano entrambi i gentilizi dell’esemplare n. 11, ni·sta^a·m·t·g·p^a^a^p·mit, ma 39
potrebbero ritornare in un altro bollo da Campochiaro di incerta lettura . Le due
barrette verticali che precedono a^a inducono comunque ad escludere la possibilità 40
che si tratti di un ulteriore esemplare del bollo n. 11 mentre potrebbero ben
corrispondere ad una p. La lettura che si propone è dunque [...]pa^a[p(iís)][...] con
la possibilità che possa trattarsi di un ulteriore esempio del succitato bollo da 41
Campochiaro .
37 Capini 1978, pp. 422, n. 31, G3, 430, tav. LXXVIII;1985, p. 252, n. 29, tav. XLVIII; Crawford 2011, pp. 987-988.
38 Vedi, rispettivamente, il n. 11 supra con le relative note e Crawford 2011, p. 1025, Bovianum 29.39 Crawford 2011, p. 1025, Bovianum 29, con proposta di lettura: [m]t l paap(iis)[-?-].40 Se la prima barretta verticale si dovesse intendere come t (= ta^a) dovrebbe essere preceduta
dalla s ma la seconda barretta verticale conservata lo esclude; in modo analogo, se la prima barretta verticale fosse intesa come p (= p^a^a) si ci dovrebbe aspettare una g ma ciò è ugualmente fatto escludere dalla seconda barretta verticale.
41 Vd. supra, nt. 36.
NUOVI BOLLI OSCHI SU TEGOLA DALL’AEREA DEL LAGO DEL MATESE 233
18) (figg. 5.5; 7.6) bollo rettangolare; ben marcati sui tre lati i margini del
cartiglio, largo cm 3,4; la linea di scrittura è conservata per una lunghezza di cm 4,3;
lettere incavate alte cm 2/2,2.
[…]ú·tr
Per le dimensioni e la forma del cartiglio questo bollo può essere accostato 42
all’esemplare n. 6 , che a sua volta era stato avvicinato ad un gruppo di altri bolli da
Campochiaro e Selva del Campo non attribuibili alla serie “pubblica” ma intesi
come contrassegni o marchi di fabbrica. Questi ultimi, tuttavia, si caratterizzano
per la presenza di sigle con lettere in legatura (Campochiaro: m^h^k; Campochiaro 43
e Selva del Campo: p^v) , mentre più vicino ai nostri esemplari potrebbe eventual-
mente risultare, almeno nella formulazione, un altro bollo da Campochiaro, ove 44
compaiono tre lettere separate da segni di interpunzione .
Qualora anche questo bollo fosse riferibile alla serie “pubblica”, tr potrebbe 45
essere abbreviazione del prenome tr(ebis), da sciogliere in tr(ebieís) , mentre per 46
la ú che precede si potrebbe pensare ai prenomi ú(vis) o [n]ú(vis) , ugualmente da
sciogliere al genitivo - ú(vieís) o [n]ú(vieís) - con la successione patronimico -
avonimico che caratterizza alcuni dei bolli della serie “pubblica” o, diversamente,
intenderla come pertinente ad un gentilizio ed in questo caso potrebbe trattarsi di
ú(viis), ben documentato in area pentra e nei territori vicini (Schiavi d’Abruzzo, 47
Castel di Sangro, territorio frentano) oppure di [n]ú(viis), documentato a 48
Pompei . Se invece non vi è relazione con la serie “pubblica”, si potrebbe anche
pensare ad una formula onomastica bimembre, con il prenome ú(vis) o [n]ú(vis)
seguito dal gentilizio tr(ebiis), quest’ultimo documentato in area pentra a
42 Soricelli 2011, pp. 54, 62, n. 6, figg. 2-4.43 Campochiaro, santuario di Ercole: Capini 1978, pp. 432, n. 59, G31, 440, tav. LXXXI; 1981, pp.
296, n. 4, 298, fig. 6; loc. Selva del Campo: De Benedittis 1978, pp. 416-418, n. 24, E1a-e, 430, tav. LXXVII.
44 Capini 1981, pp. 295, n. 1, 298, fig. 2 (con lettere di dimensioni inferiori - cm 1,6 - rispetto ai bolli precedenti).
45 Per trebis cfr. Salomies 2008, p. 36. In area pentra l’abbreviazione prenominale tr ricorre con relativa frequenza, cfr. il bollo Crawford 2011, p. 1008, Bovianum 16, da Civita di Bojano (De Benedittis 1978, pp. 411-412, n. 3, A3, 417, tav. LXXVI) e Campochiaro (Capini 1978 p. 423, n. 34, G6); il graffito da Monte Vairano Crawford 2011, pp. 1111-1112, Bovianum 107 (De Benedittis 1981, pp. 291-292, 293, fig. 1, tav. XLII a-b) e l’iscrizione da Pietrabbondante Crawford 2011, pp. 1174-1175, Terventum 18.
46 Soricelli 2011, pp. 61-62, note 26 e 33.47 Rispettivamente Crawford 2011, pp. 1208-1209, Terventum 36; 1239-1240, Aufidena 3; 1250,
Frentani 1.48 Crawford 2011, p. 679, Pompei 41 [iscrizione lapidea: m(a)r(as)·nú(viis)] e 825, Pompei 135
[bollo doliare: ú(vis)·núv(iis)·III)].
GIANLUCA SORICELLI234
49 50Campochiaro e a Pompei . È da notare, in ogni caso, la grafia della ú che, per
quanto danneggiata, sembra essere resa in forma di “y” e identica alla ú presente sul 51
già edito esemplare (n. 6) da Capo di Campo .
Questo nuovo gruppo di bolli, oltre a migliorare alcune letture precedentemen-
te proposte, offre la possibilità di qualche ulteriore notazione. Come è noto, ai bolli
dell’officina “pubblica” di Bojano, caratterizzati dalla presenza della sigla m·t·, 52
concordemente sciolta m(eddíss) t(úvtiks), si assegna un significato eponimo ed
in base alla posizione che essa assume nel testo, se anteposta o posposta al nome del
magistrato, oppure interposta tra i nomi di due personaggi, tali bolli sono stati 53
suddivisi in tre gruppi . Il titolo di funzione preposto al nome del magistrato
costituisce la norma mentre rari sarebbero i casi in cui la sigla m·t· è posposta; si 54 55
tratterebbe, in particolare dei seguenti bolli: […]mr·m·t , n·pap·mr·nu[…] ,
49 Capini 1986, pp. 248-249, n. 2, tav. LXIV, b; Crawford 2011, p. 1041, Bovianum 45.50 Crawford 2011, pp. 634, Pompei 11, 766-767, Pompei 99, 810-811, Pompei 125.51 Soricelli 2011, p. 62, n. 6, figg. 2-4; poiché il verso di scrittura è certamente sinistrorso, nel caso
in cui il bollo dovesse appartenere alla serie “pubblica” la ú sarebbe da sciogliere in ú(vieís), mentre per la f che precede si potrebbe pensare al genitivo del prenome úpfals, che ricorre abbreviato sia nella forma úpf(alleís) a Pompei (Crawford 2011, p. 647, Pompei 19), che nella forma úf(alleís) a Cuma (Crawford 2011, p. 497, Cuma 4 bis), con la successione patronimico - avonimico, oppure ad un gentilizio, da sciogliere al nominativo, cfr. ad es. il bollo m. af( ) da Atripalda, località Civita (Crawford 2011, p. 952, Abellinum 6). Non è da escludere, in ogni caso, la possibilità di una formula prenome + gentilizio, ed in questo caso ú starebbe per il gentilizio ú(viis).
52 Sul valore eponimo dei bolli della serie “pubblica”, Vetter 1953, p. 112 e più di recente, tra gli altri, Prosdocimi 1980, pp. 212-213; La Regina 1989, p. 327; Rix 2000, p. 223; Marchese 2002; Crawford 2011, p. 43. Circa la necessità di datare le tegole per comprovarne un congruo periodo di stagionatura prima della loro messa in opera, è da sottolineare che dei passi vitruviani in genere citati a sostegno di ciò - Vitr. II, 3, 2 e II, 8, 19 - il primo si riferisce ai mattoni crudi (e dunque ad una diversa tipologia di materiali) mentre il secondo, dove prescriverebbe l’uso di tegole stagionate per i tetti (quare maxime ex veteribus tegulis tecta structa parietes firmitatem potuerunt habere), potrebbe presentare un problema testuale perché se è vero che i codici sono pressoché concordi nel riportare tecta structa, è anche vero che il contesto è quello della costruzione di muri con mattoni cotti e ciò ha indotto diversi editori del testo vitruviano a correggere (cfr. ad es., Callebat - Gros 2003, p. 34, ove si sceglie la lezione testa structi, traducendo il passo «ce sont donc essentiellement les murs maçoneés de brique cuite, faites de vieilles tuiles, qui pourront avoir de solidité», e p. 149 per il commento) o ad integrare il testo; se si segue Callebat - Gros 2003, il senso complessivo sarebbe diverso e farebbe solo riferimento al fenomeno, ampiamente documentato archeologicamente, del riutilizzo delle tegole per porle in opera nelle cortine murarie.
53 Per quanto riguarda, invece, l’ambito territoriale in cui il m(eddíss) t(úvtiks) dei bolli avrebbe esercitato le sue funzioni, La Regina 1989, pp. 304, 327-340, ritiene che si tratti del magistrato supremo dei Pentri mentre Letta 1994, pp. 388-390 pensa a magistrati di Bovianum, cfr. anche Soricelli 2011, pp. 51-52, nt. 3 con altra bibliografia e Crawford 2011, pp. 41-43 che ugualmente pensa a magistrati di Bovianum.
54 Capini 1978, pp. 429, n. 48, G20, 430; De Benedittis 1983, p. 312, n. 5, tav. XLV, 1; Crawford 2011, p. 1020, Bovianum 26; vd. supra, il bollo n. 12.
55 De Benedittis 1978, pp. 416-417, n. 21, D1, tav. LXXVI; Soricelli 2011, pp. 61-62, n. 5, figg. 2-4; Crawford 2011, p. 1020, Bovianum 26; vd. supra, il bollo n. 12.
NUOVI BOLLI OSCHI SU TEGOLA DALL’AEREA DEL LAGO DEL MATESE 235
56 57g·pa^pi·mt·m·t·x , s(?) stai·úmt . Per spiegare tale anomalia si è ipotizzato che la
posposizione del titolo di funzione rimarcherebbe, in questi pochi casi, il ruolo del 58
magistrato esecutore piuttosto che del magistrato eponimo . Tuttavia, per quanto
riguarda il bollo s(?) stai·úmt è da osservare che esso risulta ricostruito dalla
collazione di cinque esemplari molto frammentari dei quali il solo che ne restituisce
la parte iniziale potrebbe conservare, a destra del residuo del prenome e prima della
linea di frattura, la traccia (almeno a giudicare dalla fotografia) della barretta 59
orizzontale di una t . In ogni caso, tra i bolli di Campochiaro è documentato anche 60
il bollo mtlsta·úmit e, poichè mitel può essere abbreviato sia mit che mt, potrebbe
non essere da escludere la possibilità che anche nel caso di s(?) stai·úmt, piuttosto
che come titolo di funzione mt sia da intendere come avonimico e che il titolo di
funzione abbia preceduto il nome del personaggio. Dal novero dei bolli con il titolo
di funzione posposto, giusta l’integrazione dell’esemplare n. 12, sono da espungere
anche […]mr·m·t e n·pap·mr·nu[…] e, di conseguenza, il gruppo si ridurrebbe al 61
solo bollo n. 10, ovvero al bollo g·pa^pi·mt·m·t·x . Di questo bollo, ed in particolare
del grafema x posto a seguire il titolo di funzione, sono state offerte differenti
interpretazioni: secondo la Capini, esso potrebbe indicare una magistratura
decennale, mentre il La Regina propende per una carica rivestita “per la decima
volta”, soluzione questa scartata dall’equipé di Imagines Italicae che preferisce
immaginare una sua relazione con un aspetto, al momento non definibile, del 62
processo di produzione . Poiché la formula usualmente impiegata prevede il titolo
di funzione anteposto al nome del magistrato, la posposizione della funzione si
spiega solo nell’ipotesi di uno stretto collegamento tra m·t· e x, nel senso che x
serve a precisare il titolo di funzione e ciò induce a scartare l’ipotesi che il grafema x
sia da porre in una qualche relazione con il processo di produzione. D’altra parte, la
spostamento in coda di m·t·x deve essere stato reputato necessario per evitare
possibili fraintendimenti del testo e ciò porterebbe ad escludere anche l’ipotesi di
una magistratura decennale che, se prevista dall’ordinamento locale, non avrebbe
posto particolari problemi di decodificazione. Appare, dunque, maggiormente
56 Capini 1985, pp. 246-248, 249, n. 23, tav. XLVII, 23; Crawford 2011, pp. 1021-1022, Bovianum 27; vd. supra il bollo n. 10.
57 Crawford 2011, pp. 1023-1024, Bovianum 28.58 Prosdocimi 1980, pp. 212-213; Marchese 2002, p. 254. Vd. le obiezioni di Capini 1985, pp. 247-
248 e Crawford 2011, p. 43.59 Crawford 2011, pp. 1023-1024, Bovianum 28, n. 5 e foto in alto a ds.; ciò che resta del prenome
potrebbe, peraltro, essere compatibile anche con una g, e non sarebbe quindi a escludere una sua relazione con il bollo Crawford 2011, p. 1009, Bovianum 17 (che però sembra presentare lettere di dimensioni inferiori).
60 Crawford 2011, pp. 1011-1012, Bovianum 19.61 Come già osservato in La Regina 1989, p. 328.62 Capini 1985, p. 248; La Regina 1989, p. 332; Crawford 2011, p. 1022.
GIANLUCA SORICELLI236
plausibile che m·t·x, come suggerito da A. La Regina, stia ad indicare la carica
rivestita per la decima volta.
Discussa risulta anche l’interpretazione dei bolli ove il titolo di funzione è
interposto tra i nomi di due personaggi. La struttura di questi bolli, presenti a Capo
di Campo con i nn. 11, 3/13 e 15, è stata diversamente interpretata intendendo il 63
primo personaggio come il produttore ed il secondo come il magistrato tutico
oppure ritenendo che siano entrambi meddices e che al primo nel corso del mandato 64
sia succeduto il secondo in qualità di magistrato suffetto . Tuttavia, a differenza di
quanto si osserva sugli altri esemplari noti, ove il primo personaggio è sempre
indicato con prenome e gentilizio separati da un segno di interpunzione,
sull’esemplare n. 13 il personaggio che precede risulta indicato mediante il solo 65
prenome p(a)k(is) . Pur non potendosi escludere la possibilità che il gentilizio sia
stato omesso perché p(a)k(is) era un paapiís come h( )r( ), sembra preferibile
ritenere che, in questo caso, il titolo di funzione si riferisca esclusivamente al
secondo personaggio menzionato nel testo, h( )r( ) paapiís, e non anche al primo, e 66che ciò possa valere anche per gli altri bolli .
Infine, per quanto riguarda i bolli nn. 6 e 18, se la loro pertinenza alla serie
“pubblica” rimane incerta, è forse possibile aggiungere qualcosa circa la
cronologia: la ú in forma di “y” ricorre in area pentra in un ristretto numero di casi e,
in particolare, a Pietrabbondante nell’iscrizione del Tempio A, datata intorno al 175 67a.C. Nei bolli della serie “pubblica” la ú è sempre resa come “v” e viene pertanto
63 Cfr. Maiuri 1913, pp. 483-484 (che nel primo personaggio vedeva però il meddíss); Vetter 1953, p. 112; Capini 1978, p. 433; Marchese 2002, p. 254; Crawford 2011, p. 43.
64 La Regina 1989, p. 328 ove anche si spiega la diversa formula onomastica utilizzata per i due personaggi - il primo indicato solo con prenome e gentilizio, il secondo anche con il patronimico - con una “esigenza di brevità” per cui il patronimico del magistrato non più in carica sarebbe stato taciuto; circa i motivi di questa “sostituzione”, il La Regina, pur non escludendo altro, sembra insistere soprattutto sulle cause naturali. Vd. le obiezioni di Crawford 2011, p. 43 all’ipotesi di La Regina.
65 A meno di non dover supporre che nel monogramma p^k siano da leggere prenome e gentilizio o, diversamente, il solo gentilizio con ricadute, però, sulla comprensibilità del testo.
66 Del resto, accettando l’ipotesi del La Regina, la sostituzione del meddíss nel corso del suo mandato sarebbe sopravvenuta nel 15% dei casi. Per quanto possa valere il confronto con Roma, nel periodo 199-100 a.C. la presenza di consules suffecti si registra nell’Urbe solo in cinque occasioni (180, 162, 154, 130, 108 a.C., cfr. Broughton 1951, pp. 387, 441-442, 449, 501-502, 548) con 6 nuovi magistrati (nel 162 a.C. entrambi i consoli furono sostituiti per motivi procedurali), solo la metà dei quali subentrati a consoli defunti nel corso del mandato, con un valore percentuale pari al 5% (se si considera solo un componente della coppia consolare, il 3% se li si considera entrambi); un tale scarto percentuale, soprattutto se determinato da cause naturali, potrebbe anche giustificarsi immaginando che si diventasse meddíss nel Sannio Pentro in età più avanzata che a Roma e/o che vi fosse una più severa attenzione agli aspetti giuridico-procedurali ma resterebbe, in ogni caso, che per un meddíss il rischio di non concludere regolarmente il suo mandato sarebbe stato sensibilmente più alto che per un console a Roma.
67 Crawford 2011, 24. Per l’iscrizione del tempio A, vd. Crawford 2011, pp. 1050-1051, Terventum 4 (ca. 175 a.C.) e cfr. La Regina 1989, p. 335, n. 4 (intorno al 180 a.C.). La ú in forma di “y” ritorna ancora nell’iscrizione di Molise del meddíss b(a)n(ttis) bet(itis) b(a)n(ttieís), Crawford 2011, pp. 1095-1096, Bovianum 97, con più generica datazione al II secolo a.C.
NUOVI BOLLI OSCHI SU TEGOLA DALL’AEREA DEL LAGO DEL MATESE 237
da chiedersi se la diversa grafia non marchi anche una differenza temporale e che,
appartenenti o meno alla serie “pubblica”, questi due bolli non possano essere
collocati cronologicamente in alto, entro la prima metà del II secolo a.C.
È da sottolineare, ancora, il consistente numero complessivo di esemplari
bollati rinvenuti fino a questo momento, 18, ripartibili tra almeno 10 differenti
bolli, la gran parte dei quali documentati anche nel santuario di Ercole a
Campochiaro ad eccezione del n. 3/13 e dei nn. 6 e 18 (dei quali è però incerta
l’appartenenza alla serie “pubblica”) attestati, al momento, solo a Capo di Campo.
A riguardo, appare di un certo interesse il bollo n. 5/12 che, giuste la ricostruzione e l’interpretazione proposte, documenterebbe l’attività che n(iumsis) pap(iís)
esercita non in qualità di m(eddíss) t(úvtiks) bensì “a nome / per incarico della
comunità”. Così inteso, il bollo, almeno in questo caso specifico, avrebbe 68 documentato l’incarico svolto da n(iumsis) pap(iís) e la sua natura pubblica . Se
tale è stata la funzione del bollo n. 5/12, e se omogeneo era il valore dei bolli della
serie “pubblica”, è plausibile che analoga sia stata la funzione dei bolli ove compare
l’indicazione del meddíss e che, di conseguenza, quest’ultima non servisse tanto a
datare l’anno di produzione della tegola ma, piuttosto, fosse in relazione con un
ufficio svolto dal magistrato. Tale ufficio potrebbe essere consistito tanto in una
forma di controllo esercitato sulla produzione laterizia quanto in un più ampio
intervento sull’edilizia pubblica. A questo riguardo si può osservare che per i bolli
rinvenuti nel santuario di Ercole a Campochiaro è stata sottolineata la quantità in
rapporto al periodo «relativamente non lungo» entro cui si andavano a porre e
come, ancora, fosse possibile osservare una distribuzione preferenziale di alcuni di
essi in rapporto alle parti che compongono il santuario, tale da rendere ipotizzabile
che i bolli maggiormente documentati in una determinata area fossero da riferire al
momento in cui si era proceduto alla copertura dell’edificio che vi sorgeva ed i bolli 69
presenti in numero inferiore fossero da riferire a restauri successivi . A Capo di
68 Viene da chiedersi se un possibile confronto per l’azione svolta da n(iumsis) pap(iís) non possa essere offerto dall’iscrizione pavimentale del tempio minore di Schiavi d’Abruzzo (La Regina 2006; Crawford 2011, pp. 1208-1209, Terventum 36) ove un personaggio legú tanginúd, ovvero per decisione dei legútús, appalta e collauda un intervento edilizio realizzato da un g. paapii(s) g. f. Nei legútús (= lat. lecti) è stato proposto di vedere un’assemblea locale richiamando la pressoché coeva iscrizione ILLRP 305 dal non lontano territorio di Atri ove due magistri operano de a(d)lec[torum sententia] e, ancora, l’iscrizione ILLRP 620 da Larino ove un mag(ister) p(agi) opera de del(ectorum) s(ententia), La Regina 2006, pp. 49-51. Tuttavia, mentre nelle iscrizioni di Atri e Larino i personaggi che agiscono de a(d)lectorum/delectorum sententia operano in qualità di magistri / magistri pagi, nel caso di Schiavi d’Abruzzo, il personaggio che legú tanginúd appalta e poi collauda sembra essere privo di titoli magistratuali, almeno a giudicare dalla ricostruzione che di questo lacunoso segmento dell’iscrizione offrono Poccetti 1979, pp. 49-50, n. 34 e Crawford 2011, p. 1208 (diversamente La Regina 2006, p. 48 ritiene che la lacuna, di 10-12 caratteri, non sia ricostruibile).
69 Capini 1978, p. 435.
GIANLUCA SORICELLI238
Campo la ridotta superficie scavata, il sistematico reimpiego di tegole e coppi nelle
strutture posteriori ed il numero ancora ridotto di esemplari bollati (se confrontato
con quello di Campochiaro) non permettono ancora lo sviluppo di analoghe
osservazioni. Tuttavia, tenuto conto che al momento non si osserva una presenza
maggioritaria di questo o quel bollo, se ciò non dovesse dipendere dalla messa in
opera già al momento della prima copertura di tegole e coppi con marchi differenti,
i bolli attestati potrebbero testimoniare anche sul sito matesino una attenta
manutenzione delle coperture, con la regolare sostituzione delle tegole e dei coppi
danneggiati o caduti. Tuttavia, tanto la messa in opera di tegole e coppi prodotte in
tempi diversi quanto la periodica sostituzione dei soli elementi danneggiati implica
che le misure degli elementi fittili si siano mantenute costanti nel lungo periodo,
con minimi scarti nelle dimensioni tali da potere essere assorbiti in fase di
montaggio e, di conseguenza, non sarebbe da escludere la possibilità che il meddíss
abbia esercitato, nell’ambito dei suoi compiti istituzionali, un controllo di qualità
sulla produzione laterizia vigilando, in particolare, sul rispetto dei parametri 70
metrologici e che di tale ufficio i bolli della serie “pubblica” siano il riflesso. L’incarico affidato a n(iumsis) pap(iís) sembra però andare al di là di questo mero
controllo di qualità ed investire una sfera d’azione più ampia che potrebbe
individuarsi, considerata la presenza dei suoi bolli a Capo di Campo, Campochiaro
e Colle d’Anchise, nella manutenzione edilizia dei rispettivi complessi. Ma se tale è
il senso dei suoi bolli, è possibile che analogo valore abbiano anche i bolli ove
compare il nome del m(eddíss) t(úvtiks). La presenza dei medesimi bolli in
differenti complessi edilizi del territorio di Bojano potrebbe dunque riflettere una
regolare attività di manutenzione delle aree pubbliche (religiose o civili che
fossero), curata centralmente, in genere affidata alla cura del meddíss ma talora a
privati che agivano per conto della comunità; in entrambi i casi i bolli
evidenzierebbero il ruolo di costoro come responsabili e/o esecutori dell’opera
nelle sue diverse fasi (compresa la produzione del materiale fittile necessario). Se
così, il m(eddíss) t(úvtiks) sarebbe intervenuto nell’ambito dell’edilizia pubblica
non soltanto curando direttamente la realizzazione o l’appalto ed il collaudo di
70 L’importanza dell’aspetto metrologico è stata richiamata da Manacorda 1993, p. 39. Sul
controllo delle dimensioni insiste anche Finkielsztejn 2012, pp. 82-83. L’impiego della tegola come unità di misura - e dunque la necessità che queste avessero dimensioni standard quanto meno a livello locale - è ben documentato nella legislazione romana di età tardo-repubblicana (Lex Tarentina, I.28, Crawford 1996, pp. 302-312, in part. p. 310; Lex coloniae Genetivae, cap. LXXVI, Crawford 1996, pp. 393-454. in part. p. 439; cfr. anche Cass. Dio, XLVI, 31, 3 e Cic., ad Caes. iun. I, in Non. Marc., p. 411 Lindsay). Sia pure riferito ad altro ambito geografico e cronologico (la provincia di Britannia in età imperiale) la contrazione che subisce la tegola in fase di essiccatura è stata giudicata responsabile in misura limitata delle variazioni dimensionali che si osservano nei prodotti finiti e valutata, partendo dalle dimensioni dei bolli presenti su di esse ed impressi con il medesimo stampo, in circa ±3% rispetto alla media dei valori dimensionali degli stessi, vd. Warry 2006, p. 247.
NUOVI BOLLI OSCHI SU TEGOLA DALL’AEREA DEL LAGO DEL MATESE 239
opere ma anche occupandosi della manutenzione - ordinaria e straordinaria - del
patrimonio edilizio pubblico esistente.
È peraltro possibile che la sostituzione periodica delle sole tegole e coppi
danneggiati abbia reso la produzione di questo materiale laterizio non continua ma
strettamente legata agli interventi da eseguire e che, di conseguenza, essa non si sia
svolta necessariamente all’interno di un’officina “pubblica” bensì possa essere
stata anche appaltata, se e quando necessario, ad officine private. Di ciò potrebbero
essere indizio i bolli ove il nome del meddíss è preceduto dal nome di un altro
personaggio nel quale potrebbe riconoscersi colui che aveva avuto in appalto la
produzione di una determinata partita di materiale laterizio. Se il l(úvkis) sta(íís)
m(a)r(aheís) del bollo n. 15 potesse essere identificato con il l(úvkis) sta(íís)
m(a)r(aheís) che compare, da solo, su alcuni esemplari di Campochiaro e se questi 71
due differenti bolli fossero anche contemporanei , potremmo avere un esempio di
produzione del materiale laterizio da porre in opera compiuta in parte direttamente
dal meddíss, in parte affidata ad un privato. Una possibilità alternativa, che meglio
forse potrebbe spiegare la eventuale contemporaneità di questi bolli, è che il
personaggio citato per primo non fosse il produttore quanto, piuttosto, colui che
offriva tutto il (o una parte del) materiale laterizio che il meddíss responsabile
dell’intervento edilizio avrebbe poi messo in opera. In questi casi il privato avrebbe
partecipato all’opera edilizia donando parte del materiale necessario e lasciando
l’onere dell’intervento al meddíss ed in questo senso i bolli nn. 5/12 e 11, 3/13 e 15
documenterebbero le due forme che poteva assumere l’intervento privato, ovvero
assunzione in prima persona - come responsabile e/o esecutore - dell’intervento
edilizio il primo, oppure parziale partecipazione ad esso i secondi.
71 Capini 1985, pp. 248-249, n. 24, tav. XLVII, 24; Crawford 2011, p. 1016, Bovianum 23. L’identità dei due personaggi sembra certa per La Regina 1989, pp. 328, 335-336, secondo cui i bolli si riferirebbero a due distinti mandati di l(úvkis) sta(íís) m(a)r(aheís), in uno dei quali era subentrato a g(aavis) kam( ), e Marchese 2002, p. 254.
GIANLUCA SORICELLI240
ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE
Antonini 1981 R. Antonini, ‘Italico’, SE XLIX, 1981, pp. 299-357.
Antonini 2004R. Antonini, ‘Eituns a Pompei. Un frammento di DNA italico’, in F. Senatore (ed.), Pompei, Capri e Penisola Sorrentina, Capri 2004, pp. 273-322.
Broughton 1951T. R. Broughton, The Magistrates of the Roman Republic, New York 1951.
Callebat - Gros 2003L. Callebat, P. Gros, Vitruve. De l’architecture, Livre II, Paris, 2003.
Capini 1978S. Capini, ‘Campochiaro (Cb)’, SE XLVI, 1978, pp. 420-443.
Capini 1981S. Capini, ‘Campochiaro’, SE XLIX, 1981, pp. 295-297.
Capini 1985S. Capini, ‘Campochiaro (CB): santuario italico. Venafro (IS). Pozzilli (IS): necropoli preromana’, SE LIII, 1985, pp. 245-255.
Capini 1986S. Capini, ‘Campochiaro, loc. Civitella. Scavo del santuario italico, SE LIV, 1986, pp. 248-250.
Crawford 1974M.H. Crawford, Roman Republican Coinage, Cambridge 1974.
Crawford 1996M.H. Crawford (ed.), Roman Statutes, London 1996.
Crawford 2011M.H. Crawford (ed.), Imagines Italicae. A Corpus of Italic Inscriptions, London 2011.
De Benedittis 1978G. De Benedittis, ‘Sannio (CB): Piana di Boiano’, SE XLVI, 1978, pp. 409-420.
De Benedittis 1979G. De Benedittis, ‘Sannio: Monte Vairano’, SE XLVII, 1979, pp. 353-367.
De Benedittis 1980G. De Benedittis, ‘Sannio (CB): Monte Vairano. Saepinum. Spinete’, SE XLVIII, 1980, pp. 419-424.
De Benedittis 1981G. De Benedittis, ‘Monte Vairano’, SE XLIX, 1981, pp. 291-292.
De Benedittis 1983G. De Benedittis, ‘Osco. Appunti sulla sezione BA dell’articolo di R. Antonini (REI IX, pp. 316-322)’, SE LI, 1983, pp. 310-314.
De Benedittis 2005G. De Benedittis, Prima dei Sanniti? La Piana di Bojano dall’Età del Ferro alle Guerre Sannitiche attraverso i materiali archeologici, Campobasso 2005.
Di Niro 1978A. Di Niro, ‘S. Giovanni in Galdo (Cb)’, SE XLVI, 1978, pp. 444-455.
Finkielsztejn 2012G. Finkielsztejn, ‘Réflexions additionnelles sur le marquage des instruments et récipients à l’époque hellénistique’, in K. Konuk (ed.), Stephanèphoros. De l’économie antique à l’Asie Mineure. Hommages à Raymond Descat, Bordeaux 2012, pp. 77-84.
NUOVI BOLLI OSCHI SU TEGOLA DALL’AEREA DEL LAGO DEL MATESE 241
Franchi de Bellis 1981A. Franchi de Bellis, Le iovile capuane, Firenze 1981.
Gabba 1976E. Gabba (a cura di), Appiani Bellorum Civilium Liber Primus, Firenze 1976.
La Regina 1989A. La Regina, ‘I Sanniti’, in AA.VV., Italia omnium terrarum parens, Milano 1989, pp. 300-432.
La Regina 2006A. La Regina, ‘Il santuario di una comunità del Sannio dopo Annibale e prima di Silla’, in S. Lapenna (a cura di), Schiavi d’Abruzzo. Le aree sacre, Sulmona 2006, pp. 47-53.
Maiuri 1913A. Maiuri, ‘Boiano - Tegoloni con bolli oschi’, NSA 1913, pp. 480-484.
Manacorda 1993D. Manacorda, ‘Appunti sulla bollatura in età romana’, in V.W. Harris (ed.), The Inscribed Economy, JRA Supplementary Series 6, Ann Arbor 1993, pp. 37-54.
Marchese 2002M.P. Marchese, ‘Contatti greco-sannitici: i bolli oschi con indicazione eponima’, SE LV-LVIII, 2002, pp. 251-260.
Marchese - Poli 2006M.P. Marchese, F. Poli, ‘Molise (CB). Iscrizione osca dalla chiesa di Santa Maria del Piano’, SE LXII, pp. 298-301.
Mommsen 1850Th. Mommsen, Die unteritalischen Dialekte, Leipzig 1850.
Oakley 1995S.P. Oakley, The Hill-forts of the Samnites, London 1995.
Poccetti 1979P. Poccetti, Nuovi documenti italici, Pisa 1979.
Prosdocimi 1980A.L. Prosdocimi, ‘Studi sull’italico’, SE XLVIII, 1980, pp. 187-249.
Rix 2000H. Rix, ‘‘Tribù’, ‘stato’, ‘città’ e ‘insediamento’ nelle lingue italiche’, Archivio Glottologico Italiano LXXXV, 2000, pp. 196-231.
Rix 2002H. Rix, Sabellische Texte, Heidelberg 2002.
Salomies 2008O. Salomies, ‘Les prénoms italiques: un bilan de presque vingt ans après la publication de Vornamen’, in P. Poccetti (ed.), Les prénoms de l’Italie antique. Journées d’études Lyon, 26 janvier 2004, Firenze 2008, pp. 15-38.
Soricelli 2011G. Soricelli, ‘Bolli oschi su tegola dall’area del lago del Matese’, Oebalus 6, 2011, pp. 51-67.
Soricelli 2013G. Soricelli, ‘Il sito sannitico-romano di Capo di Campo sul Lago del Matese (Castello del Matese, CE)’, Atlante Tematico di Topografia Antica 23, 2013, pp. 85-97.
Sutherland 1984C.H.V. Sutherland, The Roman Imperial Coinage, I, London 1984.
GIANLUCA SORICELLI242
Untermann 2000J. Untermann, Worterbuch des Oskisch-Umbrischen, Heidelberg 2000.
Vetter 1953E. Vetter, Handbuch der italischen Dialekte I, Heidelberg 1953.
Warry 2006P. Warry, ‘A dated typology of roof-tiles (tegulae)’, Journal of Roman Archaeology 19, 2006, pp. 247-265.
NUOVI BOLLI OSCHI SU TEGOLA DALL’AEREA DEL LAGO DEL MATESE 243