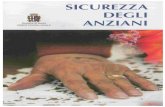L'Ospedale degli Innocenti dalle origini al Granducato mediceo: la fabbrica, la committenza...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of L'Ospedale degli Innocenti dalle origini al Granducato mediceo: la fabbrica, la committenza...
INDICE
PrE*senut;lrlom*
ATESSANDRA MAGGI
$-'(.)*6reuflair deg{i $mna*aenti r.*a{iw rurig;fmi a] ffirafldruratry
LUCIA SANDRI
lntroduzione
Corporazioni e cantieri cittadini. fArte della Seta
e la fondazione dell'Ospedale degli lnnocenti
La fabbrica dell'Ospedale. Priori d'eccezione e committenza
artistica nella prima metà del Quattrocento
Lapiazza dell'Ospedale. Una scenografia per la corte medicea
(secc. XV-XVIl)
Pila, buca ferrata, presepio e ruota. Un luogo
per gli abbandonati
Documenti
Bibliografia
{-+ opere
Restauri per un nuovo percorso museale
BRUNELLA IEODORI
Simone Talenti, ian Giovanni Evangelista
ALESSANDRA GRIFFO
Giovanni di Francesco del Cervelliera, Eterno, Angeli
e I Santi lnnocenti con stemma dell'Arte della Seta
e Pila dei fanciulli
BRUNELTA TEODORI
t3
t7
r8
23
Bernardo Barbatelli detto Bernardino poccetti, Allegoriacelebrativa di Francesco / . Giovan Battista Sermei,Francesco / . Pittore fiorentino sec. XVll, Due putti
, , :,lt "'::::: no un cartistio con iscrizione e data
Simone Talenti, ian Giovanni Evangelista ztI iL,':ì I il irl
Giovanni di Francesco del Cervelliera, Eterno, Angelie i Santl lnnocenti con stemma dell,Arte deila Setae Pila dei fanciulli
31
Bernardo Barbatelli detto Bernardino poccetti, Allegoriacelebrativa di Francesco / . Giovan Battista Sermei,Francesco / . Pittore fiorentino sec. XVll, Due puttiche sorreggono un cartiglio con iscrizione e data j3
Pittore fiorentino sec. XVll, Stemma di Ferdinando te Cristina di Lorena e tondi con putti 38
' ,1r0 // Rlnasclmento dei Bambini del 2007, que-
, volume segna la seconda tappa nel cammino
realizzazione del MUDI, il Nuovo Museo degli
riocenti. ll progetto del MUDI nasce per valo-,are l'insieme di opere d'arte, documenti,
; rrtture architettoniche che costituiscono il
. r I rimonio culturale dell'lstituto degli lnnocenti.
rr patrimonio unico al mondo fortemente lega-
, ;rll'opera sociale dell'istituzione, fin dalla fon-
i"rzlone della fabbrica brunelleschiana.
ti llinascimento dei Bambini raccontava la storia,'ll'infanzia abbandonata e dell'0spedale, prima
,lituzione laica dedicata all'accoglienza dei fan-
rulli. Un luogo fortemente voluto dalla Firenze
,lol tempo, impegnata ad attuare gli ideali uma-
,i',tici dell'uomo e di tutti i suoi figli, anche i
reno fortunati.
rli lnnocenti e /a Città rappresenta un passo
,rlteriore e approfondisce la storia dell'anticoI )spedale fra Quattrocento e Cinquecento allalirce delle profonde relazioni tra l'lstituzione e la
, lritas fiorentina. Firenze nei secoli ha sempre
r ondiviso e sostenuto la nuova concezione di
,rccoglienza e crescita deì bambini proposta
rlagli lnnocenti, ponendo la città all'avanguardia
nella cultura dell'infanzia.
Ljna storia di eccellenza quindi, culturale e socia-
le, sostenuta dalle forze economiche e politiche
rlel territorio ma anche partecipata dai cittadini.
Una storia che prosegue, e che il MUDI si propo-
ne di raccontare e rinnovare.
t.e attività educative ed espositive del MUDI
nel suo complesso sono state finora sostenute
dall'Assessorato alla Cultura della Regione
Toscana, dall'Assessorato alla Pubblica
lstruzione del Comune di Firenze e dal
Quartiere 1. I restauri connessi al nuovo museo
sono stati realizzati dall'Opificio delle Pietre
Dure e dalla Soprintendenza per il Patrimonio
Storico, Artistico ed Etnoantropologico per leprovince di Firenze, Pistoia e Prato.
La stessa logica di "rete" sta guidando anche
la definizione dei contenuti culturali del pro-
getto, a cui hanno collaborato le
Soprintendenze e le Università di Firenze,
Siena, Verona.
Le ricerche contenute in questo volume sono
state realizzate da un gruppo di lavoro che ha
coinvolto l'opificio delle Pietre Dure e laSoprintendenza per il Patrimonio Storico,
Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo
Museale di Firenze.
Uno degli obiettivi principali del MUDI è ren-
dere il nuovo Museo degli lnnocenti un luogo
accogliente per tutti, con particolare attenzio-ne per l'infanzia e le famiglie, in linea con latradizione secolare degli lnnocenti.
È perciò naturale che dalle ricerche sia nato un
percorso didattico che permette di conoscere
meglio la storia di questo straordinario "luogo
dei fanciulli", anche per promuovere quella
"cultura dell'infanzia" che l'lstituto continua
ancora oggi a sviluppare e diffondere.
LA PRESIDENTE
Y
DALLEAL
t_A
DECTI
:LA
La riorganizzazione degli ospedali destinati alsolliovo dei poveri e degli ammalati ebbe parteirrtcqrrnlt', tra XVI e XVll secolo, nella formazio_rrc rirr;li st,rti reqionali della nostra penisola.
(,i.r rrt'll,r prirrr,r rnetà del XV secolo le autoritàrrrrlrrr ip,rli t, i rr.rsccnti governi signorili diedero ilvi,r,rrrn,r rr,rir rli iniziative per il controllo e il mi_r;lror,trrrcrrlo rkli servizi di assistenza. Quest,epocaIrr r urrlr,rsst'r1r.rta da importanti interventi, comel,r .,oplrrt,ssiorre di enti ormai decaduti e la con_r crrtnrzinrro tii fiorenti patrimoni in grandi organi-rrrri ,rssistenziali. Le città furono caratterizzatecosì da un nuovo modello di struttura pubblicapreposta ai bisogni della collettività: l,OspedaleMagno" Questo nuovo tipo di struttura ospedalie_ra, laica e munita di nuovi regolamenti, si orientòverso programmi innovativi, che inclusero unanuova categoria di utenti: i bambini abbandonati.
lntorno alla metà del XV secolo, dunque, i
governi cittadini avevano già realizzato una radi_cale trasformazione in senso moderno dell,asset_to dei servizi sanitari e assistenziali, che eranodivenuti laici, centralizzati e largamente munici_palizzati: un cambiamento che si materializzò
S*Mi, {
anche nella maggiore attenzione attribuita allefabbriche ospedalierg individuate come edifici diimportanza civica da abbellire con una commit_tenza architettonica e artistica di prim,ordine.
Le pagine che seguono trattano, in sintesi,delle vicende che videro la promozione politica eistituzionale dell'0spedale degli lnnocenti diFirenze dalla fondazione ai primi decenni delXVll secolo, attraverso le testimonianze di accre_scimento e di abbellimento della sua fabbrica.Nel primo paragrafo verrà analizzato il ruolosvolto dall'Arte della Seta nella fondazione di unluogo esclusivamente destinato ai bambini. Nelsecondo si parlerà degli spedalinghi, chiamatialla direzione dell'Ospedale nel Quattrocento, edell'opera da loro profusa nel perfezionamentodella fabbrica. Nel terzo verrà considerata lapiazza e la scenografia architettonica sviluppata_si a seguito di un progetto globale, che si deter_minò già alla fondazione dell'0spedale.Nell'ultimo paragrafo si affronterà, con unanuova chiave di lettura, il tema del luogo del_l'abbandono dei bambini, sotto il loggiàtodell'0spedale.
I \ /\ r ANco: Francesco Rosselli (attribuito),, r «rlelLa Catena», particotare con I'Ospedale
l, rrrocenti (t4lo ca.), Firenze, Museo Storico
tr,rlico «Firenze com'era»
A Firenze, dal Xlll secolo, il Comune aveva
,llidato la realizzazione di grandi opere pub-
I rlir he di notevole valore architettonico e arti-',1rco alle Arti Maggiori. ll Battistero era stato,rttribuito ai Mercanti di Calimala, che seguiva-rro anche i lavori della basilica di San Miniato;l,r Cattedrale a quelli dell'Arte della Lana.
I .r direzione della fabbrica di Orsanmichelelra stata data nel 1333 all'Arte della Seta,
rna la cura delle nicchie e delle sculture spetla-
va alle singole corporazioni. Alle Arti di Cali-
mala, del Cambio, della Seta e dei Giudicir: Notai, infine, erano stati assegnati tra XIV
e XV secolo i maggiori ospedali della città:di Bonifazio, di San Matteo, di San Paolo e di
Santa Maria della Scala.
Tra XIV e XV secolo, Firenze aveva raggiunto
dunque la centralizzazione dei servizi assisten-
ziali, tramite le corporazioni di mestiere, organiz-
zando un complesso apparato, che durerà sino
alla piena attuazione, nel XVlll secolo, dello
Masaccio, San Pietro in Cottedra, particolarecon ritratto del Brunelleschi, Firenze, Santa Maria
del Carmine, Cappella Brancacci
stato regionale sotto il Granducato lorrttt'st'.
La fondazione dell'Ospedale degli lrrnocertli,
notevolmente innovativa anche dal punto di
vista urbanistico, coinvolse l'Arte della Seta,
detta di Por Santa Maria. [Arte aveva già otte-nuto in quest'ambito, tra Xlll e XIV secolo, il
patronato di alcuni ospedali della città e del
contado, tra cui San Gallo e Santa Maria della
Scala, già impegnati nell'assistenza ai bambini
abbandonati. ldonea dunque a gestire il cospi-
cuo lascito del mercante pratese Francesco
Datini, per la fondazione di un ospedale che
ricevesse i trovatelli, l'Arte lo integrò e comprò,
nel 141 9, da Rinaldo di Maso degli Albizzi, un
terreno sulla piazza «dei Servi di Maria».
Successivamente chiamò Filippo di ser
Brunellesco, iscritto all'Arte medesima, a farne
il progetto. Nel 142'1, quando esistevano già lefondamenta del nuovo Ospedale, il Comune
approvo l'operato dell'Arte della Seta, che ne
divenne patrona e istituì entrate costanti (mar-
chiatura e pesatura delle sete, matricole ecc.)
per sostenere sia i lavori della «muraglia» (la
costruzione), sia l'attività dell'ente. ll Comune,
i" d,
:l;
Sorro: Veduta deI porticato dett'OspedaleÙrsrnn: Giovanni di Francesco del Cervelliera,Eterno, Angeli e i Sonti lnnocenti con stemmadell'Arte della Seta e Pila dei fanciul1i, particolarecon la pila dei fanciulli dopo il restauro, Firenze,lstituto degti lnnocenti, Loggiato
da parte sua, contribuì concedendo numerosiprivileqi e la cessione perenne dell'entrata di;rlcune tasse.
Alla corporazione spettava l'elezione delloSpedalingo e di tre 0perai, che gestivano ilcantiere e partecipavano alla conduzionerlell'Ospedale, mentre ai Consoli dell'Arte era,,ìtlribuita la supervisione del loro operato.
La costruzione procedette sotto la direzionedel Brunelleschi sino al 1427, anno in cui è testi-rnoniata già la presenza del Loggiato. Dopo unrallentamento durato circa nove anni, il lavoroalla «muraglia» riprese nel 1436 sotto FrancescoDella Luna, presente tuttavia da un decennio tragli Operai responsabili della fornitura dei mate-riali e della condotta delle maestranze.
ll 24 gennaio del 1445, al tempo del prioratodi messer Marco da Borgo San Lorenzo, si cele-brò con una solenne cerimonia l'apertura ufficia-le dell'Ospedale.
Tra XV e XVI secolo, al vertice degli ospedalifiorentini si avvicendarono personaggi di note-vole cultura, con competenze artistiche, tecni-che e scientifiche. La presenza degli spedalin-ghi nell'Ospedale degli lnnocenti è datata dal1420, anno d'inizio dei lavori della fabbrica.Dal 1454, per volontà di papa Niccolò V essivennero estratti dall'Arte patrona tra i soliecclesiastici.
Nel 1436, quando ripresero i lavoridell'Ospedale, rallentati dall'assenza delBrunelleschi, che dal 1427 era impegnato inquelli della Cupola di Santa Maria del Fiore,venne nominato priore messer Tommaso daPerugia. ll neoeletto aveva già dato prova dicompetenze specifiche in materia di cantieriedilizi sia per la nuova chiesa di San Niccolò inOltrarno di cui era priore, sia per l'ospedale deiBuondelmonti, quando era pievano di SantaMaria a lmpruneta. La scelta di Tommaso daPerugia pare collegata alla designazione di
I rancesco Della Luna a successore del Bru-
nelleschi nella direzione dei lavori del nuovo
lspedale: il Della Luna era infatti consuocero
riei Quaratesi, benefattori della chiesa di San
N iccolò.
Una decina d'anni dopo, tra il 1456 e il
1457, quando maestro Bernardo detto il Ros-
,,ellino dette inizio alla costruzione della scali-
rrata di accesso al Portico, l'Ospedale vantava
run altro spedalingo d'eccezione: messer Loren-
zo di Frosino.
Lorenzo era membro della nota famiglia dei
Della Volpaia, celebri costruttori di orologi
meccanici tra cui il futuro e geniale realizzato-
re dell'orologio planetario per Lorenzo il Ma-
gnifico nella sala dei Gigli in Palazzo Vecchiol.
Lo si era forse voluto onorare assegnandogli la
dlrezione dell'Ospedale, istituzione di pubblica
utilità e di grande prestigio in città.
Messer Pace di Sandro da Empoli, succeduto
come priore al Della Volpaia e rimasto in carica
sino al 1460, fu nel 1458 l'estensore dell'inca-
rlco a Giovanni di Francesco, detto il Cervellie-
ra, per affrescare l'arco sopra la porta della
Srnrsrnn: Andrea detla Robbia, putto in terracotta
invetriata, Firenze, lstituto degli lnnocenti, faccìata
Sorro: Domenico di Tommaso Bagordi detto
il Ghirtandaio, ldorazione dei Magi, particolare
col ritratto di Francesco Tesori, Firenze, lstitulodegli lnnocenti, Museo
chiesa. Durante il suo priorato iu portala a ter-
mine anche l'ammattonatura, l'intonacatura e
la rifinitura del Porticato. Nel 1487, al tempo
dell'elezione di messer Francesco Tesori, la
Loggia venne ulteriormenle abbellita dai putti
in terracotta invetriata di Andrea della Robbia.
ll Tesori dimostrò, inoltre, tutta la sua abilità
nel concludere il contratto con Domenico
Ghirlandaio, artista emergente dell'epoca, per
l'esecuzione dell'Adorazione dei Magi, da utiliz-
zarsi come pala per l'altare maggiore della
chiesa dell'0spedale.
r Archivio Ospedale lnnocenti Firenze (A0lF), Entrata e
uscita E (1 456-l 459'), n.4189, Ìncipit, dove si nomina
appunto il priorato di ser Lorenzo di Frosino Della Volpaia
dall'anno 1456 al 1457.
Sara Taglialagamba (Unìversità di 5iena), che ringra
ziq mi ha conlermato l'appartenenza di Lorenzo di
Frosino alla genealogia dei celebri orologiai.
, iiì,
' ,ir,ii,i;l:.ri
itqi1,,:,.fìid!,ifir,:,t!, ri
.irr::* r,r, rrt3l
r,§..1&.
j
.!. 'r.,. s irl:l.i*t, r$i"
Lostensione o il disegno del fronterlell'Ospedale, caratterizzato dalla Loggia sullapi,rzza, era l'elemento innovativo più appariscenlt rlella nuova fabbrica, insieme alla muratura airrlonaco, abbinata, con nuovo impatto cromati-r,r, all'uso della pietra di macigno.
Iingresso all'0spedale era assicurato da dueporte, una a destra e l'altra a sinistra del Loggiato;quest'ultima chiudeva via del Rosaio (oggi viadella Colonna), e già dal 1496 la magistratura deiCapitani di Parte ne aveva ordinato l'apertura.
Dal 1478, Lorenzo il Magnifico aveva intantoacquistato un lotto di terreno, confinante conl'Ospedale di San Matteo, dove nel 1516 si aprì,con Giuliano da Sangallo, il cantiere per lacostruzione della Loggia dei Servi, che si volle«fussi come quella de 'Nocienti al dirimpetto».
Tra il 1515 e il 1516, divenuto papa Leone X,figlio di Lorenzo, vennero edificate per lui, accan-to al convento dei Servi di Maria, le «stalle delPapa». Nel 1597 la compagnia di laici devoti fon-
data nel Xlll secolo da s. Filippo Benizzi, cheaveva avuto in concessione dall'0spedale un ora-torio con ingresso da via della Colonna, interessa-ta ad avere uno sbocco sulla piazza, si offrì disostenere la spesa di 2000 scudi per costruire unarco sopra la porta di accesso alla via, uguale aglialtri del Loggiato brunelleschianor. Nel I 598, lacompagnia si rivolse ancora al Granduca per otte-nere di continuare i lavori costruendo sopra l'arco«fino al piano della Loggia predetta», per orna-mento ma anche per far guadagnare all'Ospedaleuno spazio utile per i telai della seta delle giovaninocentiner. Nel 1 599, finalmente, il priore RobertoAntinori concesse alla compagnia di portare a ter-mine i suddetti lavori.
Nel 1601 venne modificata e completataanche la terza Loggia, quella antistante la chiesadell'Annunziata.
2 A0lF, Filza d'Archivio 21 11473-1614), n.6217,anno 1 597, c. 41 .
r lvi, c. 3, anno I 598.
i.:r . i. .,
!&rrìlI§§
',1,rNA A FTANCO: Fra' Bartotomeo, Veduta dellat rzza della Sontissima Annunziota $495-t5t6),
,nze, Gabinetto Disegni e Stampe degti Uffizi
, ro: Disegno del progetto per I'aperturaìla via della Colonna e la costruzione dell'Arcoprastante, A.O.l.F., Filza d'Archivio n' zl,l:-t6t4), n.6zt7, c. 42v, anno 1597
',rnn: Putto in pietra, di autore anonimo, secc.i XVl, Firenze, lstituto degli lnnocenti, Archivio
rI ,,.
'I id
#
4
;trim
La replica delle Logge nella piazza pare fosse,,tata predefinita dal Brunelleschi stesso a circo-
',crivere un luogo pubblico con finalità esclusiva-
rnente sociali: un teatro o un foro.
[ulteriore arricchimento del 1608, con la statua
r,questre di Ferdinando I de' Medici, opera di
l'ietro Tacca, sotto la direzione del Giambologna,
ronfermò la valenza urbanistica "spettacolare" e
rrello stesso tempo unitaria di questa parte della
( ittà. Tutto era in funzione del potere mediceo,
rlalla piazza dei Servi, all'area del convento di San
Marco (già sede della biblioteca di Cosimo il
Vecchio), al Palazzo Medici di via Larga (oggi via
Cavour). ll porticato stesso dell'Ospedale reca
tracce di questa volontà di celebrazione: a sinistra
sopra la "ruota" compare il busto di Francesco l,
sormontato dall'affresco allegorico del Poccetti;
quello di Cosimo I è sopra la porta d'ingresso e in
fondo al portico a destra, è posizionato quello di
Ferdinando l, tutti opera di Giovanni Battista
Sermei, anch'egli discepolo del Giambologna. Al
centro del Loggiato all'esterno verso la piazza,
appare infine il busto di Cosimo ll, opera secente-
sca attribuita a Giovanni Gargiolli.
L'Ospedale degli lnnocenti utilizzò all'origine
come emblema quello dell'antico Ospedale di San
Gallo, rappresentato da un neonato fasciato e
messo all'interno di un calice/pila (rappresentato
anche nell'affresco di Giovanni di Francesco del
Cervelliera), in seguito fece proprio il putto ritto in
fasce scolpito in pietra, che compare ancora su
molte case un tempo di proprietà dell'Ospedale.
Quest'ultimo emblema fu utilizzato anche in altre
città toscane (Prato, Pisa, Arezzo), per istituzioni
dedicate all'accoglienza dei bambini. ll putto rob-
biano in terracotta smaltata a braccia aperte,
della fine del XV secolo, sarà invece introdotto
molto piir tardi a rappresentare l'Ospedale e la
sua attività rivolta all'infanzia.
La «pila» (una pietra a forma di conca o di
acquasantiera) era lo strumento usato in Toscana
per accogliere i bambini. Agli lnnocenti, tra XV e
XVI secolo, consolidatasi la volontà di accettare i
soli neonati, la pila si trasformò in una finestra
con una doppia grata, una esterna e una interna,
delimitanti uno spazio dove venivano adagiati i
Srwtsrnn: Marco della Robbia detto frate Mattia,M.odonno e Son Ciuseppe 115r,5),Frrenze, Istilulo degli lnnocenti, Museo
l:,,0, pitu dei fanr iulti (r45r).
orsegno sulla sratola delle reliquie rilrovatasotto l'altare maggiore nella chiesadi Santa Maria degli Innocenti,Firenze, Istituto degli lnnocenti, Sacrestia
bambini, ma solo quelli che riuscivano a passareattraverso le maglie della prima. Dal 1525, incorrispondenza dell,affermarsi dappertutto àellasua devozione, venne allestito ai iaìi aelfa _ierrt.r», u1 xplot"Oio»; 6911 questo termine le fonti,oa quesl.r epor,r, rndirheranno il luogo dell,ab_ba.ndono dei barnbini nell,Ospedale. i. ,*rt*,raffiquranti la Maclonna e s Giuseppe, sonoriplr,r rli M,rrr l rloJl,r Robbia, eseguitesott; ill)tior,rto rli rnosser Francesco Cesari; il Gesù bam_Irrrrrr si irrc,rm.rv;r invece nel trovateilà ;*;r*;rrr,ll, r «rnanqi.rloi;r»_
. Nol l(160, al ternpo del rettorato di paolo\r1u,rrr i,rlupi, si cliede inizio ai lavori sopra l,arcopcr costruire uno spazio destinato alle baligsrìpèrate dalle fanciulle fin dal 1622a. ln questaoJ ys19ne il «presepio» venne spostato in fondo,tt porhco, dov'e attualmente la grata, sormonta_to dall'affresco coevo, che sappiamo ora essere
r A0lE processo n. 23, n.1121, inserto n. g, doc.n.2.
stato commissionato al pitlore Agnolo Gori\.
. il tuogo dell'abbandono a FireÀze fu dunquela pila, poi il presepio: tuttavia, n.f fingrrgg;comune, esso viene ancora oggi aesigÀato"lome«ruota», termine con il quale si indicàva un cilin.oro tn legno ruotante su se stesso, in uso pressoi conventi e utilizzato anche in alcuni brefotrofl-moderni, ma mai in Toscana nel tardo wedioevo.
Nel 1 875, con l,entrata in vigore d.llu l;gl;;:'.z1o1e
che mise termine all,abbandono O.i Èurlbini nell'anonimato, anche lsidoro del ir.qo,scrittore, poeta e storico, nella lapide.rp."r;;sotto la «finestra ferrata» per celebrare ialencorrenza, indicò impropriamente come «ruota»l-tuogo dell'antico «presepio» fiorentino, predi_sposto ad accogliere i piccoli innocenti.
_ 'n"o]!^OriScterlo di Cassa X (t 653-t 664), n. s364,anno 1660, djcembre 30. c. 'I67, clovu .ompar" il paga_men,to.di 42. Iire d uAgnolo Gorl, pittorc per sue latiche
l-(:lofl per ld piflurd a lresco sopra il prerepio p ootc
tn cntesd)., nolizia inedita che hd consenlilo cli aflribuirel'affresco sinora anonimo.
;l,iirr{j-$til},ffi
A seguire un elenco redatto nel XVlll secolo e
' opia dell'originale del XV secolo, relativo agli
rntroiti dell'Arte dovuti all'0spedale ogni quattrornesi, iniziando dal primo quadrimestre:
Nota, che si ha avere dall'Arte della Seta
'trln'anno, et mese per mese, cioè:
Gennaia, Febbraio, Marzo, AprileLa terza parte di tutto quello si risquotono
t,(er) le Marchiature
La metà delle Pesature de//e sete mese p(er)ine5e
Lire due p(er) ciascuno che si matricolal"ire sei p(er) ciascuno Consolo non più seduto
Soldi due p(er) lira delle CondennagioniLire 500 da 20 sensali una volta l'anno in questi
4 mesi
ll secondo quadrimestre differisce in parte dalprimo:
Maggio, Giugno, Luglio, AgostoLa terza parte delle Marchiature
La metà delle Pesature del/e sete
Lire due p(ef ciascuno, che si matricolaLire sei p(er) ciascuno Consolo non piit seduto
ll terzo quadrimestre è invece in tutto ugualeal primo:
Sette m b re, Ottobre, Nove m bre, Di ce mb reLa terza parte delle MarchiatureLa metà delle Pesature de//e sete
Lire due p(er) ciascuno che si matricolaLire sei p(e) ciascuno Consolo non più sedutoSoldi due p(er) lira di tutte le Condennagioni
Sotto il priorato di messer pace da Empoli siconcluse la trattativa per l,affresco sopra lach iesa.
ln un primo momento venne stipulato un con-tratto con Alessio Baldovinetti il 2g febbraio1458 (stile moderno), per l,esecuzione diun'Annunciazione. Baldovinetti non eseguì mail'opera g dal 3l dicembre 145g al 22 iarzo1459, troviamo una serie di pagamenti aGiovanni di Francesco (il Cervelliera), alcuni deiquali (calcina, rena e specialmente i denari spesiper il colore azzuno) fanno intendere come iipittore lavorasse a un affresco, identificato conqu-ello della lunetta sopra l,ingresso della chiesa,raffigurante il Padre Eterno e Angeli.
Giovanni di Francesco dipintore de,dare a di31 di dicembre l" paio di colombelle s(oldil a
e de' dare uno mezzo baritte di vino di quellodi chasa doldi) Z
e a dì 5 di gennaio t45B (1459) per lui aVentura ortolano che glieli aveva prestati a suaistanza doldi) 8
. e de' dare per l " paio di chalze gli facemmodare a Marcho di piero Rossellì a di 20 di gennaiolire 4 soldi B, posto Marcho avere in quesio a c.146
E de' dare a dì 2Z di gennaio soldi undici disseper comp(ra)re lac(c)ha di gom(m)a a uscita c.76,s(oldil 8
E de' dare a dì l4sotdi dieci per staia 3 dicha(l)cina e rena, dotdi) 10
E de'dare a di 2t di febbraio 1458 (1459) I(ire)cinque e s(oldi) l0 per una fodera di chastrone
'
nera ebe per noi da Nicholò di Lorenzo vaiaio,portò monna Mea sua madre, debbi avere a Librorosso B, c. 121, l(ire) cinque, s(otdi) l0
. E a di 2 di marzo l(ire) una s(otdi) portò e,detto a uscita a c.78, l(ire) 1
E a di 13 di marzo s(oldi) 52 per una mezzaoncia d'azzurro agli lngesuati, a uscita lire 2doldi) 12
E a di 22 di marzo soldi venticinque contanti,l(ire) 1 s(oldi) 5
Questa è la prima richiesta inoltrata il 4 luglio
rlel 1597 al Granduca Ferdinando ldai membri
rlella congregazione di San Filippo Benizzi, per
ottenere l'apertura dello sbocco di via della
Colonna sulla piazza della SS. Annunziata, col
sostituire alla porta un arco e rendere questo
spazio più decoroso e consono al luogo.
Se r (e n i ssi) m o Granduc)
ll Priore, et li operai dell'lnnocenti humilisdmi)
derv)i di V(ostra) A(ltezza) S(erenissima) espongo-
no a quella come circa tre anni fa per un refugio
il Priore, accomodò alli huomini della compagnia
di ian Filippo Benizi uno oratorio di essi lnnocenti
nella via della Colonna, et hora detti huomini
desidererebbero accrescerlo, far ivi un'altra porta
verso la Nuntiata et fare uno arco scambio della
porta della via della Colonna conforme all'incluso
disegno a loro spese. Et se bene si verrebbe a
abbellire la città, fare utile allo spedale, et levare
l'occasione del fare l'immonditie si fanno nella
strada, con tutto ciò li esponenti non lo consenti-
rebbero senza il placet di quella. Et però la suppli-
cano a restare s(er)vita di comandar la sua volun-
tà et Dlo felicissima la cons(e)vi.
Nello stesso documento compare la risposta
di assenso data dal Granduca:
Faccisi
sotto la firma del cancelliere della Segreteria
granducale e la data:
Giovanni Battista can(celliere) 4 luglio (15)97
tll r,,,,,ri
rlri{&
I
{-l;x1,,,I. l
il'Ìr..1,;,ir+n
,{flir$,,Utuii.1tl,li
,, ll pagamento che segue ha reso possibile
r rdentttrcazione dell,autore, Agnolo Gori,dell'affresco posizionato sopra il pràsepio (latinestra ferrata) detto comunemente «ruota»,corne si evince anche dalla lapide appostavi nellB/5, all'epoca della legge che vietava inTosrana l'abbandono dei bambini nell,anoni_mato.
1660 dicembre 30
E.a d!.3.0 dicembre scudi quarantadue portocontanti Agnolo Gori pittore per sue fatijche ecolori per la pittura a fresco sopra il presepio eCroce in chiesa.
... Qui di seguito viene riportata Ia memoria del
XVlll secolo dell'acquisto del terreno su cui - -
venne costruito il nuovo ospedale.
. Sunto di scritture, et lnstrumenti del padronatodello Spedale delli tnnocenti che ha l,Arte dellaSeta, dalla medesima fondato, edificato, finito, edotato, quali scritture si conservano in detto offi_zio Originali.
ll detto Spedate delli tnnocenti di Firenze, epadronato dell,Arte di por Santa Maria detiade/ia Seta la quale l,anno l419 ro*pro u, ò,rb, ,Giardino posto vicino alla piazza de,frati de,Servip(er) edificarvi detto Spedale, si come l,edificol'anno 1421 con un oratorio, o cappella, e fudetto lo Speda/e de, Gettatelli, e'ù compuò dalnobile, et egregio cavaliere Rinaldo del'nobiti, etegregio cavaliere m(esser) Maso di Lucadegl'Albizzi per prezzo di fiorini lt00 d,oro, egabella, alla quale vendita acconsenti m(onn)aSandra noglie del sop(ra) scritto Rinaldo, ettgltuola di Ugucciozzo di Ardingo de, Ricci.
I
flilll,' '*;,lllll )
1
".ìgt-,=--
i";]1,
: xffi-'rl r
herici, U., L'assistenza all'infanzia ed i/ R. Speda/e
ili lnnocenti di Firenze, Stabìlimenti Grafici Vallecchi,
'nze 1932t',lorozzi, G., Ricerche sull'aspetto originale dello
',11ale degl'lnnocenti di Firenze, «Commentari», XV
't{14), pp.'186-201
Mendes Atanasio, M.L. - Dallai, Gf ., Nuove indaginiti o Speda/e deql'lnnocenti a Firenze, «Commentari»,
,i ll (1966), pp.83-106
lìellosi, L. (a cura di), ll museo dello Speda/e deg/i
tiocenti a Firenze, Electa, Milano 1 977
Davidsohn, R., Stoda di Firenze, vol. Vl, Sansoni,
ttnze 1977
Morozzi, G. - Piccini, A., ll restauro dello Spedale ditnta Maria degli lnnocenti 1966-1970, Becocci, Firenze
984
Andreatta, E. - Quinterio, F., La loggia dei Servi in
piazza SS. Annunziata a Firenze, «Rivista d'Arte», Studi
rlocumentari per la storia delle Arti in Toscana, anno
XL, serie quarta, vol. lV 0lschki, Firenze 1 988
Sandri, 1., [a gestione dell'assistenza a Firenze nel
XV secolo, in la Ioscana al tempo dÌ Lorenzo ilt\4agnifiro. Politica, Economia, Cultura, Arte, Convegno
di Studi promosso dalle Università di Firenze, Pisa e
Siena, 5-8 novembre 1992, vol. lll, Pacini, Pisa'1996,
pp.1363-l380
Romby, G.C., Le vircnde architettonidle ner ,sero/t, tn
L. Sandri (a cura di), G/i /nnocenti e Firenze nei seco//.
Un Ospedale, un arthivio, una città,Spes, Firenze 'l 996,
ristampa 2005, pp.21 32
Dini, 8", La ricchezza documentaria per l'arte della
seta e l'economia fiorentina ne/ Quattrocento, in L.
Sandri (a cura di), G/i /nnocenti e Firenze nei secoli. Un
1spedale, un archivio, una città, Spes, Firenze 1 996,
ristampa 2005, pp. 1 53-1 78
Takahashi, T., ll Rinascimento dei trovatelli. ll brefo-
trofio, la città e le campagne nella Toscana del XV seco-
/0, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2003
Sandri, 1., Ospedaii e assistenza, in M. Ciliberto (a
cura di), Storla della civiltà toscana. ll Rinascimento,
Firenze 2003, vol. ll, pp. 597-614
Sandri, 1., Ia gestione dell'Ospedale. Regolamenti e
cariche istituzionali a Firenze tra XV e XVI secolo, in E.
Diana - E. Ghidetti (a cura di), la bellezza come tera-
pia. Arte e assistenza nell'Ospedale di Santa Maria
Nuova a Firenze, Biblioteca di Medicina & Storia 6,
Polistampa, Firenze 2005, pp. 1 27 -157
Badino, G,, San Niccolò )ltrarno 1420 circa: note
sulla chiesa del Quaratesi e di Gentile, in M. Ciatti - C.
Frosinini (a cura di), // Gentile risorto. ll Polittico
dell'lntercessione di Gentile da Fabriano. Studi e restau-
ro, Edifir, Firenze 2006, pp. 45-54