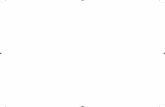Una questione di “habito”e di “Ordine”: l’iconografia di Verdiana da Castelfiorentino
Transcript of Una questione di “habito”e di “Ordine”: l’iconografia di Verdiana da Castelfiorentino
Raffaele Argenziano
UnA qUestione di «hAbito» e di «oRdine»: l’iconogRAfiA di VeRdiAnA dA cAstelfioRentino
«l’immagine è una similitudine un’effigie e un ritratto di quella cosa
ad imitazione della quale fu fatta»1
lo studio dell’iconografia di santa Verdiana da castelfiorentino2 prende le mosse dall’analisi della tavola realizzata da Ugolino di nerio (fig. 1) entro il secondo decennio del trecento per l’altare della santa, nella cappella a lei dedicata nella chiesa di s. Antonio a castelfiorentino3. il dipinto, stando alle testimonianze documentarie, doveva anche essere ab immemorabili la sua più antica immagine. esso fu probabilmente commissionato per non perdere la memoria dell’aspetto di Verdiana e anche perché la sua effigie riprodotta su tavola ne garantisse la sua presenza tangibile. sappiamo infatti, fin dall’epoca paleocristiana, che il ritratto funerario riprodotto sulla tomba forniva tutte le informazioni necessarie sul defunto, sia di carattere fisionomico, sia relative ai dati personali: una sorta di carta di identità4. d’altra parte, già negli scritti di giovanni damasceno, teodoro studita e niceforo di costantinopoli si sosteneva che l’icona di cristo rappresentava cristo nella sua natura umana e divina, così come l’effigie di un santo raffigurava il santo stesso, proprio come l’immagine dell’imperatore era l’imperatore stesso e dunque una estensione della presenza imperiale. questo era un modo di assicurarsi la vicinanza del santo, così che ci si potesse rivolgere a lui in maniera più diretta per l’adempimento delle richieste e per i propri bisogni. Ancora più evidente è questo aspetto quando, in mancanza dell’esistenza delle spoglie mortali, o perché disperse, o perché non esistenti, o perché occultate in un luogo diverso da quello dove si trovava l’immagine – come nel caso di Verdiana – l’oggetto diveniva una sorta di sostituto dei mancanti patrocinia, acquistando
1. ioannis damasceni, Sermo de imaginibus. cfr. pure ghini, Dell’imagini sacre, p. 20.2. Per una approfondita e accurata indagine agiografica su Verdiana da castelfiorentino cfr.: benvenuti, Storia di un culto in questo
stesso volume e «In castro poenitentiae», pp. 264-303; eadem, Verdiana da Castelfiorentino, con bibliografia; ead., Capi d’aglio. sulla data di morte di Verdiana Anna benvenuti propende per il 1242, cfr. benvenuti, «In castro poenitentiae», pp. 263, 267. Più recentemente cfr. pure gianni, Iconografia delle sante cellane.
3. Il Museo di Santa Verdiana (1999), p. 31; Museo di Santa Verdiana (2006), pp. 35-37.4. Ahlqvist, Maria, Madre di Cristo, p. 22.
62 RAffAele ARgenziAno
sul finire del Medioevo un «autonomo potere taumaturgico»5. A partire dal duecento in italia e appena poco più tardi anche in francia e in inghilterra, si assistette alla proliferazione di pratiche religiose che assomigliavano a quelle magiche. i devoti arrivavano addirittura a grattare via dai muri l’intonaco dipinto sul quale erano state realizzate le immagini dei santi, e soprattutto della Madonna, per sciogliere la polvere così ottenuta nell’acqua e bere la “pozione”, nell’intento di una pronta guarigione dal male che li affliggeva. oppure mettevano la tavola con l’immagine del santo al quale si erano votati sulle parti del corpo malate o ferite con la speranza di essere guariti6.
Al ritratto del defunto, quasi sempre a figura intera, erano spessissimo connesse delle scene, alcune delle quali confermavano l’arrivo del defunto in Paradiso e quindi il raggiungimento del suo status ultraterreno, mentre altre potevano mostrare episodi della sua vita mortale, o anche miracoli post mortem7. questo aspetto è ancora molto evidente nelle raffigurazioni sulle tombe di santi e beati in ambito toscano e, come vedremo, è attestato pure per il sepolcro di Verdiana8.
dunque se il ritratto è importante, lo sono allo stesso modo anche la fisionomia e l’abito con il quale furono riprodotte quelle sante immagini. Per Verdiana possiamo avere conoscenza di questi due aspetti attraverso la lettura delle fonti agiografiche, le quali a partire da quella più antica trecentesca, testimoniano caratteri che resteranno costanti attraverso il tempo9. sappiamo così che la giovane reclusa fin da adolescente era schiva dal fare sfoggio di abiti realizzati con stoffe preziose. infatti, non aveva ancora compiuto dodici anni che già vestiva di umili e rozzi panni: «habitu abiecta, pauperitatis avida parvis minimisque contenta»10; e anche per infliggersi con ‘discrezione’ punizioni corporali «cominciò a portare alle carne uno cerchio di ferro (...) et per camicia ella portava uno aspro cilitio alle sue carne strettamente»11. e quella ‘divisa’ è conveniente, anche quando all’età di dodici anni, si reca a fare da domestica presso la famiglia di un «huomo (...) pertinente a parentado»12. durante i suoi viaggi a compostella – da dove portò come ricordo una crocetta di zolfo che ancora oggi si può vedere nel Museo della santa a castelfiorentino13 – e a Roma, dove soggiornò secondo il brocchi fino all’anno 1188, non sappiamo quali abiti indossasse la vergine castellana, ma trattandosi di un pellegrinaggio, possiamo pensare che portasse le vesti tipiche dei pellegrini14.
sappiamo invece con certezza quali abiti aveva Verdiana il giorno in cui lasciò il mondo per farsi ‘murare’. infatti, al ritorno da Roma, essendo stata ultimata la cella, una domenica presso la pieve di s. ippolito, dopo essersi confessata e comunicata «statuta siquidem die, astante populo in plebe castri, Viridiana obedientiam domino plebano promictit, qui, habitum et velum benedicens, ipsam
5. Vauchez, La sainteté en Occident, p. 529; strezova, Relation of Image; bacci, L’invenzione della memoria.6. Vauchez, La sainteté en Occident, p. 529; Rigaux, Usage apotropaïques de la fresque; sansterre, Vénération et utilisation; Rigaux,
Réflexions sur les usages; più recentemente cfr. c. calciolari, scheda n. 34, in Affreschi novaresi, p. 258; trivellone, Tête, lions et attributs sexuels.
7. brown, The Cult of the Saints; Ahlqvist, Maria, Madre di Cristo.8. Argenziano, La prima iconografia; id. Corpi santi e immagini a Siena nel medioevo: i santi patroni; id. Corpi santi e immagini nella Siena
medievale: l’iconografia; id. L’iconografia del beato Atto.9. elenco di seguito le testimonianze agiografiche non comprese nel presente volume: gonnelli, Vita di Santa Verdiana; brocchi,
Ristretto della Vita; felice da Porretta, Vita di s. Verdiana.10. Vita di biagio, v. infra, p. 89.11. Vita ii di giacomini, cf. infra, p. 119; «Vestita di vili e rozzi panni [cingendosi] strettamente il suo tenero corpo con un grosso
cerchio di ferro il quale tenne poi continuamente sopra la carne fino alla morte usando sempre un ruvido cilizio», brocchi, Ristretto della Vita della Gloriosa, p. 9.
12. Vita ii di giacomini, cf. infra, p. 119; brocchi, Ristretto della Vita della Gloriosa, pp. 5, 9. Proprio in casa di quest’uomo compie il miracolo della moltiplicazione delle fave, cfr. infra Vita di biagio, p. 89, Vita i e Vita ii, cap. ii.
13. così il brocchi, Ristretto della Vita della Gloriosa, p. 11: «risolvette di partirsi dalla patria, come fece, con gran disgusto de’ paesani, andando in compagnia di alcune divote donne alla visita del corpo di s. iacopo nella galizia; di dove poi ritornando a castel fiorentino, prese seco una crocetta di zolfo portandola sempre addosso con divozione».
14. cfr. infra, le Vite di biagio, pp. 89-90 e giacomini, cap. iii.
UnA qUestione di «hAbito» e di «oRdine»: l’iconogRAfiA di VeRdiAnA dA cAstelfioRentino 63
induit et velavit suoque canonico ut eam intromictat imponit»15. in questa prima testimonianza agiografica l’indicazione circa l’abito indossato è generica. l’attestazione è più puntuale nella Vita del giacomini, dove si legge che:
promisse nelle mani del piovano (...) di vivere religiosamente per infino alla morte et benedixe l’habito, conforme alla sua vita, cioè tunica e mantello, le puose in capo il velo benedecto et, facto questo,commisse a uno suo canonico procuratore ordinato a questo la dovesse menare al Romitorio et quivi la serrasse, secondo l’ordine dato16.
il padre lorenzo giacomini, a proposito dell’abito, ribadisce in maniera perentoria che: «del vestimento non dico alcuna cosa, però che quello solo ebbe, col quale entrò et, se altro fu di bisogno, quanto più vile et meno fu quanto si poteva»17. la testimonianza del giacomini è ribadita pure nel Ristretto della Vita di Verdiana redatto da giuseppe Maria brocchi nel quale leggiamo che:
trovando già terminata la cella, si portò subito in un giorno di domenica alla pieve di s. ippolito ove, assistito ch’ell’ebbe al santo sacrifizio della Messa e ricevuti con somma divozione i santissimi sacramenti della Penitenza e dell’eucaristia, rinunziò a se stessa (conforme l’uso di quei tempi) nelle mani del Piovano e si vestì di voto, al riferire del giacomini, con tonaca e mantello ed avendo poscia ricevuta la benedizione dal medesimo Piovano (il quale in quell’atto la consegnò ad un canonico della sua Pieve, acciò ne prendesse la cura)18.
Una volta indossato l’abito che avrebbe portato fino alla morte, Verdiana con tutto il consesso del popolo e del clero di castelfiorentino si avviò, portando una croce a imitazione di cristo, verso la sua ‘tomba’ e verso il suo ‘martirio’19. Allorché ebbe preso il congedo dai suoi concittadini e dopo aver fatto benedire la sua cella, vi entrò e si fece murare. dentro la sua «cella-tomba» Verdiana si ispirò allo stile di vita dei Padri del deserto e in special modo a quello di Antonio abate: «et come ebbe speciale divotione a sancto Antonio, come grande maestro in quella beata arte heremitaria, volse seguitare lui»20, del quale imitò pedissequamente tutto quanto aveva riferito Atanasio nella sua biografia antoniana21. il regime alimentare della futura santa castellana fu rigidissimo: non bevve mai più vino dissetandosi solo con l’acqua pura e
radissime volte mangiò di cocto et spetialmente con condimento carne, o cacio o uova, non che mangiasse, ma non le volse né vedere né toccare né udire. e se alcuna volta, quando dalle buone persone l’era portato o presentato alcuna cosa per sua vita o sostentatione di quello che non mangiava, non volse mai pigliare né ricevere22.
Anche per dormire si imponeva uno stile severo: «asside nuda cum cippo sub capite semper dormivit et circulo, ut diximus, ferreo et cilitio asperrimo super nudo corpore assidue vestita fuit»23.
15. V. infra, p. 90.16. cfr. Vita ii di giacomini infra, pp. 123-24.17. Ibidem, p. 125.18. brocchi, Ristretto della Vita della Gloriosa, pp. 12-13.19. felice da Porretta, Vita di s. Verdiana, pp. 12, 21.20. cfr. infra, Vita ii di giacomini, p. 124. 21 Atanasio, Vita Antonii, pp. 4-179.22. cfr. infra, Vita ii, p. 124. Anche Antonio abate aveva un regime alimentare molto severo: «Manducabat enim semel in die,
post occasum solis, aliquando post biduum et aliquoties quadriduum gustabat. erat enim illi esca pani set sale ut potus sola aqua», Atanasio, Vita Antonii, p. 22.
23. cfr. infra, Vita di biagio, p. 90. Anche nella biografia antoniana è narrato che: «Ad dormire autem [si contentava di una stuoia, ma per lo più] et in terra dormiebat», Atanasio, Vita Antonii, pp. 22-23.
64 RAffAele ARgenziAno
questo fu l’inizio del suo volontario isolamento che durò, stando a quanto ci narrano le fonti, ben trentaquattro anni: «completis in cellula XXXiiii annis»24. durante questo periodo di abbandono del mondo per dedicarsi a quella ‘mitica’ vita da eremita, come aveva sentito dalla lettura di brani tratti dalle Vite dei Padri del deserto, Verdiana non ebbe, o meglio non avrebbe avuto l’opportunità di incontrare «uomo alcuno in viso»25. bisogna però segnalare che almeno un uomo Verdiana lo ha incontrato e anche più di una volta: questi fu il vescovo di firenze monsignor Ardingo: «Ad noti-tiam sancte memorie domini Ardinghi, doctoris in sacra pagina, episcopi florentini, hoc devenit. Ad eam ut pater pius perrexit, sub multa coactione obedientie sibi sub confessione retulit»26.
la condizione di volontario isolamento non fu per Verdiana uno stato ideale, così per perfezionare la sua scelta di vita chiese a cristo di concederle «qualche sollazzo, o piacere di compagnia, che a˙llei fusse con fructo della anima a exercitio di pena et di fatica et a merito di martirio»27. come abbiamo già visto, il racconto della vita di Verdiana, in molte parti, sembra esemplato su quello dell’eroe atanasiano. Una conferma ulteriore ci viene dall’incontro, riedizione in chiave moderna dell’episodio occorso ad Antonio abate, che la reclusa castellana ebbe nel suo sepolcro con i due serpenti, i quali diventeranno nella tradizione iconografica i suoi ‘attributi caratteristici’. si legge infatti nella Vita Antonii:
deductus itaque ad monumentum ab ipso viro secundum consuetudinem clausit ostium et remansit solus intus. et stare quidem non poterat propter plagas daemonum, iacens orabat et post orazione dicebat: «hic sum ego Antonius. non effugio plagas vestras. etenim si plura horum feceritis non separabo a caritate christi» (...) inimicus autem, qui bona odio habere solitus est et miratus quia et post plagas ausus est venire deinde convocavit canes suo et increpans dicebat ad illos: «Videtis quia nec spiritu fornicationis neque plagis potuimus compescere, sed magis audaciam sumit adversum nos. Accedamus usque ad eum aliter». facile est autem diabolo transfigurari in malo (...) et continuo repletus est locus ille phantasias leonum, et ursorum, leopardorum, colubrorum, tauro-rum, aspidum, scorpionum et luporum. leo rugiebat, volens insilire in eum, taurus volebat ventilare cornibus, coluber repens non adtingebat et lupus de impeto suo retinebatur. et in totum omnium. Repens torquebatur se et sibiliabat super eum. et simul omnes terribiles erant ira et sono suo. et Antonius vero suscipiebat flagella illorum et sustinebat punctus illorum et sentiebat quidem asperiorem dolorem corporis, lente vero vigilans magis animo iacebat, gemens quidem propter dolorem corporis, sobrius autem mentem28.
l’episodio dell’incontro di Verdiana con i due serpenti, che la assisteranno torturandola e infliggendole i peggiori supplizi per tutti i trentaquattro anni del suo isolamento, è testimoniato fin dalla prima Vita latina. questa esigenza, come ci narrano le fonti agiografiche, nasce dopo che la giovane reclusa ebbe ascoltato il 17 di gennaio, nel giorno della festa di sant’Antonio abate, la predica in cui si narrava proprio quell’episodio, tratto dalla Vita Antonii. così, nelle successive edizioni della Vita di Verdiana, questo avvenimento è arricchito di maggiori particolari29.
24. cfr. infra, Vita di biagio, p. 91.25. «con questo tenore di vita perseverò ella XXXiV anni continovi, aliena totalmente da i pensieri e da i discorsi del secolo e
senza mai vedere se non per qualche gravissima necessità uomo alcuno in viso», brocchi, Ristretto della Vita della Gloriosa, p.14.26. cfr. infra, Vita di biagio, p. 90.27. cfr. infra, Vita ii, pp. 126.28. Atanasio, Vita Antonii, pp. 26-28. e ancora nella Vita di Antonio si legge che: «Rafforzando sempre di più la sua maniera di
vivere si diresse impetuosamente verso il monte, e al di là del fiume trovò una fortificazione deserta da tanto tempo e piena di serpenti. si trasferì in essa e vi rimase», ibidem, pp. 32-33.
29. cfr. infra, Vita ii, cap. Vii. «occorse che in questo tempo predicando un sacerdote nella suddetta chiesa di s. Antonio e narrando egli come fosse in varie guise questo santo straziato da i demoni che sotto diversi aspetti di feroci animali lo flagellavano s’accese talmente di desiderio d’essere anch’essa tormentata in simil guisa per amor del signore che non cessava continuamente di pregarlo a volerle concedere un tal favore. stando ella pertanto un giorno in orazione, volle il signore esaudirla: onde si vide improv-visamente entrare dalla finestra due serpi di spaventosa figura e di egual grandezza e benché sul principio si spaventasse, nondimeno
UnA qUestione di «hAbito» e di «oRdine»: l’iconogRAfiA di VeRdiAnA dA cAstelfioRentino 65
dunque, i nuovi compagni di Verdiana la sottoposero a feroci tormenti fino alla sua morte, senza mai lasciarla sola per lungo tempo. i due animali mangiavano con Verdiana dallo stesso recipiente e quando il cibo era scarso, la battevano così forte con le loro code da lasciarla, a volte, tramortita per un lungo tempo:
hii hora refectionis, dum manducaret, ad mensulam accedebant, ex parasside secum cibum sumebant et siquid eis deficiebat, versus irati se vertebant et eam sic caudis acriter verberabant, quod per plures dies surgere non valebat30.
i due animali:
a quell’ora che la serva di dio Verdiana voleva mangiare, eglino erono presenti et quello che mangiava lei man-giavano loro et, che più è, in quel medesimo vaso che lei. Alcuna volta pane bagnato in acqua, o legumi molli, o agrumi, o cocto senza condimento, o di sale o di olio, et quando veniva caso che allora mancasse il cibo, irati contro a ˙llei si levavono et con le code loro gravemente la battevono et alcuna volta sì crudelmente la batterono, che più dì ne stava a diacere et poco si poteva levare31.
i serpenti, metafora animale del maligno, saranno gli instancabili aguzzini di Verdiana la quale, ben contenta di averli come perenni ospiti nella sua cella, mai oppose alcuna resistenza alle loro sevizie. e, anche quando questi rischiarono di essere uccisi dalle ruote del carro che trasportava la famiglia di un legato apostolico che passava dalle parti del romitorio di Verdiana, «caude cuilibet ad medium brachium acceperunt»32, i due infernali animali, rifugiatisi nella cella della santa reclusa e da questa risanati, come ricompensa le offrirono maggiori e più terribili molestie. Verdiana nella dipartita di questi animali ‘infernali’ vide il segno premonitore della sua morte, la liberazione dai suoi due ‘carnefici’ prefigurò cioè la liberazione dalle pene terrene, in attesa che le si spalancassero le porte del Paradiso33.
dunque, le questioni da affrontare per chiarire quanto la produzione iconografica ci ha tramandato, riguardano due aspetti: uno, come abbiamo appena visto, è relativo alla presenza dei serpenti, spiegata dall’emulazione dell’episodio di sant’Antonio abate, mentre l’aspetto ancora irrisolto, concerne le raffigurazioni di Verdiana con gli abiti di diversi ordini religiosi. concordando con quanto ribadiscono i padri bollandisti, i quali giustamente sostengono che: «neque tamen certum non usos consuetam licentiam pictores»34, cercheremo di chiarire sia le ragioni che hanno prodotto l’iconografia che ci mostra Verdiana abbigliata con le vesti di una terziaria domenicana, come nella tavola per l’altare della santa nella sua chiesa di castelfiorentino, attribuita a Ugolino di nerio, sia i motivi che hanno visto proliferare altre sue immagini con indosso l’abito di altri ordini religiosi35.
nella tradizione biografica della santa castellana non si fa mai menzione alla sua appartenenza ad alcun ordine religioso, fino dalla più antica Vita trecentesca. sappiamo, come abbiamo visto,
fattasi prima il segno della croce e poi di nuovo postasi in orazione conobbe esserle inviati quegli animali dal signore per esercitarsi nella sofferenza siccome aveva chiesto», giuseppe Maria brocchi, Ristretto della Vita della Gloriosa, pp. 14-15.
30. cfr. infra, Vita di biagio, p. 90.31. cfr. infra, Vita ii di giacomini, pp. 126-27. «onde accoltigli con giubbilo grande ne rese grazie a dio e continuamente gli
tenne in sua compagnia cibandoli alla sua parca mensa. questi però in vece d’usarle gratitudine alcuna benespesso colle loro code la percotevano e talora sì aspramente che per otto giorni non si poteva alzare da terra, siccome confessò poi al Vescovo fiorentino gio-vanni da Velletri (e non ad Ardingo come asseriscono quelli che assegnano la sua morte nel MccXlii)», brocchi, Ristretto della Vita della Gloriosa, p. 25.
32.cfr. infra, Vita di biagio, p. 90.33. brocchi, Ristretto della Vita della Gloriosa, p. 17.34. Acta Sanctorum, februarii vol. i, p. 256, par. 3.35. Museo di S. Verdiana, pp. 35-37.
66 RAffAele ARgenziAno
che la santa entrò nella sua cella solo con l’habitum et velum. nell’edizione della Vita pubblicata dal gonnelli nel 1644, si legge:
essendosi confessata e comunicata devotissimamente con molta copia di lacrime renuntiò se stessa, conforme all’uso di quei tempi [1208] nelle mani del piovano facendo il solito voto con promettere povertà, castità e obbe-dienza [fu condotta] al luogo dove si dovevano insepolcrire li spassi mondani e il corpo caduco36.
così, pure giuseppe Maria brocchi, uno dei biografi di Verdiana, affidandosi alla tradizione prosopografica precedente, cercò di dare una spiegazione ai dubbi che affioravano a proposito dell’appartenenza della santa a un ordine religioso:
Alcuni affermano, che ella fosse terziaria francescana, altri domenicana ed altri Agostiniana: molti poi stima-no, che ella professasse l’istituto Vallombrosano, come si legge nelle lezioni dell’Ufizio di lei approvato dalla sacra congregazione de’ Riti e nel Martirologio Romano sotto il dì primo di febbraio, in cui cade la sua festa (...). circa l’istituto che ella professasse io non voglio decidere la controversia che sopra di ciò verte tra le Religioni camal-dolense, Vallombrosana, domenicana, Agostiniana e francescana: dico bene che non trovandosi nella Vita di lei scritta anticamente cosa veruna che possa fondatamente indicarci esser ella stata Religiosa di alcuno istituto (come saviamente avverte l’eruditissimo bollando della compagnia di gesù) ne segue che ella fosse veramente una ver-gine secolare la quale al riferire di tutti gli scrittori [biografi], volendosi rinchiudere per meglio servire al signore, non è improbabile che per mezzo del Piovano di castel fiorentino (dalle cui mani secondo il parere di tutti, prese ella l’Abito di cappa, Mantello e Velo) prendesse ancora qualche sorta di regola37.
Una conferma a queste considerazioni ci viene dalla stampa che accompagna l’edizione livornese della Vita scritta dal gonnelli nel 1644, nella quale Verdiana è mostrata abbigliata con «l’Abito di cappa, Mantello e Velo», in ginocchio dinanzi all’altare della sua cella con alle spalle un angelo che le indica il crocifisso e, in basso a sinistra, un cestinetto di vimini nel quale sono raffigurati i due serpenti38. lo stesso gonnelli però nel testo che segue a quella stampa, sostiene che Verdiana sareb-be una agostiniana perché ebbe a professare vita eremitica per ben 34 anni «imitando san guglielmo d’Aquitania rinnovatore degli eremitani»39.
il brocchi poi segnala una serie di raffigurazioni in diversi luoghi di castelfiorentino nelle quali si vede:
dipinta l’immagine di lei con varie sorte d’abiti (...). Una antichissima ve n’ha in sagrestia dipinta sull’asse circa al Mccc in abito di terziaria domenicana, [questo conferma che già nel 1735 la tavola di Ugolino mostrava Verdia-na con gli abiti da terziaria domenicana e che se ci sono state delle ridipinture queste dovevano essere precedenti a quella data] un’altra ivi parimente sul cuoio dorato dipinta verso il Mccccl in Abito di secolare, una nella tavola di mezzo dell’altare maggiore in Abito di francescana, siccome in altri luoghi in Abito d’Agostiniana. oltre a queste nella Potesteria ve n’è una dipinta nel McccciX in Abito scuro e finalmente ve n’è un’altra fuori della sua chiesa di pittura antichissima sul muro a fresco in Abito di Monaca Vallombrosana40.
il biografo poi per dare una spiegazione e dunque giustificare il suo convincimento che Verdiana non ebbe a indossare abiti di alcun ordine, prosegue sostenendo che:
36. gonnelli, Vita di Santa Verdiana, pp. 23-24.37. brocchi, Ristretto della Vita della Gloriosa, pp. 2, 6-7. questo non è l’unico punto poco chiaro nella vicenda di Verdiana, così
che pure sulla data della morte gli agiografi si sono confrontati fin dal secolo XiV. Per una esaustiva esposizione sulla questione della datazione confronta qui, la bibliografia nella nota 2. cfr. anche giovanni boccaccio, Il Decamerone, gior. V, nov. X.
38. Ibidem.39. gonnelli, Vita di Santa Verdiana, p. 92.40. brocchi, Ristretto della Vita della Gloriosa, pp. 7-8.
UnA qUestione di «hAbito» e di «oRdine»: l’iconogRAfiA di VeRdiAnA dA cAstelfioRentino 67
tutte queste cose però poco giovano a provare con fondamento, sotto qual istituto ella vivesse, essendo lecito a i Pittori rappresentare le cose, qualmente più loro aggrada, come in fatti si vede nel caso nostro41.
così la causa di quella produzione figurativa che mostra Verdiana abbigliata con abiti di diversi ordini religiosi, sarebbe dovuta all’estro dei pittori. siccome questa affermazione, come sappiamo, non ha alcun fondamento scientifico, i motivi vanno cercati altrove.
tutte le testimonianze biografiche superstiti non fanno alcun cenno ad un abito religioso particolare o alla professione di fede pronunciata per alcun ordine. dunque, la rassegna degli abiti
che la santa castellana ha indossato dal 1320 ai nostri giorni deve avere i suoi fondamenti in altre istanze cultuali.
la genesi dei suoi «panni» è già nella prima biografia del secolo XiV, dove si legge che:
habitu abiecta, paupertatis avida, parvis minimisque contenta, circulo ferreo asperoque cilicio corpore super nudo precinta et induta42.
questo era il ‘guardaroba’ di Verdiana e a questi capi di abbigliamento furono aggiunti, prima che la reclusa fosse murata e come ci segnala la tradizione prosopografica successiva, soltanto il mantello e il velo. il brocchi, nel sottolineare lo stile di vita severo e il rigoroso abbigliamento di Verdiana, ci informa che:
di dodici anni, era nell’aspetto suo assai speciosa et bella di corpo, ma molto più dell’anima et in abito suo disprez-zata, fuggendo nel vestire suo ogni appetito, e ogni vana gloria più attendeva alla strema et ultima necessità di coprire il corpo che a superfluità di panni, o lini, o lani et come persona confermata a cristo era vaga et desiderosa della povertà (...) et oltre allo spregio di coprire il corpo dalla parte di fuori aveva già tanta perfectione in se che cominciò a domare la carne del corpo proprio, acciò che non pigliasse vezzo e costume di ribellare allo spirito. cominciò a portare alla carne uno cerchio di ferro il quale per infino al tempo presente si dimostra nella sua chiesa et è al populo in grande reverentia et per camicia ella portava uno aspro cilitio alla sue carne strettamente 43.
A conferma dell’abbigliamento austero di Verdiana, sappiamo che, quando fu ordinato di ricomporre il cadavere per la cerimonia funebre, le matrone alle quali era stato conferito quel compito:
et spogliando il corpo della sancta trovarono intorno al corpo suo il cerchio di ferro sopradecto, et per camicia uno aspro cilicio et, di sopra, il vestimento suo assai vile, et umile et disprezzato, et non più che uno, cioè tonacha et mantello et il capo involto di vili e pochi pannilini44.
Una eccezionale testimonianza figurativa, nella quale è mostrato l’abbigliamento di Verdiana al momento della sua morte, ci è data dalla scena ricamata verso il 1440 da un artista fiorentino ed oggi conservata al Victoria and Albert Museum di londra, nella quale si vede il Ritrovamento del cadavere di Verdiana alla presenza di rappresentanti del popolo e del clero di Castelfiorentino (fig. 8). la santa è raffigurata con indosso un mantello rosso sopra una tunica di colore verde e con il velo bianco sul capo, sta in ginocchio davanti all’altare con le mani giunte in preghiera, con i serpenti ai suoi piedi, il popolo e il clero di castelfiorentino alle sue spalle e in alto è illustrata l’elevatio animae.
41. Ibidem. 42. cfr. infra, Vita di biagio, p. 89.43. brocchi, Ristretto della Vita della Gloriosa, pp. 30-31. sempre il brocchi ci informa che Verdiana non ancora dodicenne già
indossava un «grosso cerchio di ferro il quale tenne poi continuamente sopra la carne fino alla morte» e vestiva di «vili e rozzi panni (...) usando sempre un ruvido cilizio», giuseppe Maria brocchi, Ristretto della Vita della Gloriosa, p. 9.
44. cfr. infra, Vita ii di giacomini, p. 134.
68 RAffAele ARgenziAno
il brocchi, in riferimento a quell’evento, aggiunge che, oltre agli indumenti sopra descritti, furono ritrovati pure (fig. 62):
la croce di zolfo (portata da s. giacomo di galizia) (...) il capo della serpe col panierino di giunchi, con entrovi un gomitolo di refe scuro, un immagine di basso rilievo dell’Apostolo s. iacopo fatta di osso nero, alcuni lavori, che soleva ella fare di sua mano per non istare oziosa, ed un capo d’aglio, il quale dopo tanti secoli ancora di presente incorrotto e fresco45 .
Una volta preparato il corpo per la cerimonia funebre, questo fu portato nella chiesa di s. Antonio e fu esposto al pubblico per ben 17 giorni46. Passato questo tempo fu realizzata, all’interno di quella che era stata la cella di Verdiana, una cappella annessa poi alla chiesa di s. Antonio47. questa ope-razione assimila la reclusa castellana ai martiri di epoca paleocristiana. infatti, fin dal iV secolo, nei luoghi dove furono trovate le spoglie mortali dei primi testimoni della fede cristiana furono edificate le prime grandi basiliche, alcune delle quali divennero in seguito luoghi di pellegrinaggio.
in quella cappella della chiesa di s. Antonio fu costruito un altare «sotto del quale fu poi collocato il suo santo corpo»48. la cappella poi fu ingrandita e trasformata in chiesa, ma trovandosi questa fuori le mura di castelfiorentino, col passare del tempo si rivelò un luogo poco sicuro a custodire quelle sante reliquie, le quali furono traslate nel 1376 nella «sagrestia della Pieve nuova che già era fondata fino dall’anno McXcV»49. da qui poi il corpo fu traslato sotto l’altare maggiore della collegiata di s. lorenzo, per essere poi posto definitivamente sopra l’altare maggiore della stessa collegiata «in una bellissima cassa di legno intagliata e messa a oro co’ suoi cristalli davanti la quale sta presentemente serrata [1735] con quattro chiavi»50.
dalla biografia settecentesca del brocchi apprendiamo che alcune reliquie della santa cellana era-no conservate a firenze. infatti «due nodi delle vertebre delle reni e cinque stinchetti o internodi delle dita delle mani» furono richiesti dalla corte granducale nel 1612 per inviarle in «germania e in lorena in alcuni Monasteri ne’ quali avevano le loro sorelle Monache» 51.
sappiamo pure che il potere intercessorio della santa castellana, ben documentato nelle fonti agiografiche, si realizzò attraverso il compimento di miracoli, la maggior parte dei quali furono esemplati sul modello evangelico di cristo52.
così Verdiana, come gesù a cana, compì il miracolo di tramutare l’acqua in vino53; guarì una donna cieca da molto tempo54; risanò il figlioletto di un contadino che si era rotto una gamba e il miracolo avvenne appena che il bimbo ebbe appoggiato l’arto sulla soglia della finestra della cella di Verdiana55. nelle testimonianze documentarie vengono poi elencati una serie di miracoli compiuti per intercessione della santa e per i quali i devoti fecero realizzare degli ex voto. così dopo aver gua-rito nel 1409 dal «male d’invecchiata allentatura» iacopo Antonio Peri potestà di castelfiorentino, questi fece dipingere «nella sala della Potesteria quell’immagine della santa che ancora vi si vede»
45. brocchi, Ristretto della Vita della Gloriosa, p. 19. sappiamo anche che il brocchi, recandosi a vistare nel 1721 il sepolcro di Verdiana, le portò un ex voto nella forma di un cuore d’argento. Ibidem, p. 20.
46. cfr. infra, Vita ii di giacomini, p. 134; brocchi, Ristretto della Vita della Gloriosa, p. 20.47. benvenuti, Capi d’aglio e serpenti, p. 314.48. brocchi, Ristretto della Vita della Gloriosa, p. 21.49. Ibid., p. 22.50. Ibid., p. 23. Per le vicende della chiesa di s. Verdiana confronta il più recente improta, La chiesa di Santa Verdiana.51. brocchi, Ristretto della Vita della Gloriosa, pp. 24-27. 52. si vedano le Vite pubblicate in questo volume.53. cfr. infra, Vita i e ii di giacomini, cap. X; brocchi, Ristretto della Vita della Gloriosa, pp. 27-28.54. cfr. infra, Vita i e ii di giacomini, cap. Xii; brocchi, Ristretto della Vita della Gloriosa, p. 28.55. cfr. infra, Vita i e ii di giacomini, cap. Xi.
UnA qUestione di «hAbito» e di «oRdine»: l’iconogRAfiA di VeRdiAnA dA cAstelfioRentino 69
(fig. 12)56. e anche, dopo aver salvato dalla morte, nel 1407, una donna di fano di nome Piera di simone becci gravemente malata, questa per ringraziare la santa castellana «fece dipingere la sua immagine nella chiesa di s. domenico» a fano57. dopo aver aiutato un uomo a liberarsi da un usu-raio, il graziato fece dipingere nel 1337 su un pilastro della chiesa di orsanmichele in firenze l’im-magine di santa Verdiana58. quella che si vede oggi (fig. 6) è databile verso la fine del XiV secolo. nella facciata della casa degli Attavanti a castelfiorentino, è murata una immagine di Verdiana in bassorilievo ancora visibile (fig. 17), realizzata nel primo quarto del XiV secolo da un artista vicino a giovanni di balduccio, sotto la quale si poteva leggere la scritta: hoc opus fecit fieri nicholaus et vante andree stefani nicholai vantis iacobi de attavanti59. Un tale guiduccio di zano-bi, fabbro dopo essere stato calunniato ingiustamente si «raccomandò addio et a sancta Verdiana» e come voto per essere stato liberato dalle ingiuste calunnie, fece fare «una imagine di cera della statura sua» cioè di dimensioni reali. quell’ex-voto «fu per lungo tempo intorno allo altare di sancta Verdiana, et ora et fu, per suo scampo et liberatione»60.
Un uomo di nome Alberto franzesi da staggia, vicino siena, ingiustamente incarcerato e con-dannato a morte, invocando la santa castellana affinché lo aiutasse a non essere sottoposto a quelle ingiuste e orribili pene, ebbe in sogno la visione di Verdiana, la quale vestita «in abito assai onesto et divoto secondo era consueto di vederla nelle dipincture», lo rassicurò di avere «confidentia nella misericordia di dio» così che sarebbe stato liberato da quella ingiusta condanna61. quest’ultima in-dicazione proverebbe che la numerosa produzione figurativa di Verdiana la ritraeva non con indosso abiti di un particolare ordine religioso, ma piuttosto un generico abito da beghina62. Poi lo stesso Alberto franzesi da staggia dopo essere stato liberato per intercessione di Verdiana le fece «fare un’imagine con la mannaia et ogni cosa, come richiede la forma di quello caso et per lungo tempo fu apresso allo altare della gloriosissima sancta Verdiana»63.
sono testimoniati anche altri miracoli compiuti dalla santa castellana, come quello che ci narra della liberazione del figliolo di una donna «dalle forze del demonio» e che si poteva vedere:
in firenze rappresentato in una tavola da altare fatta di terra cotta della maniera di luca della Robbia; il quale alta-re è quello di padronato della famiglia dei signori Attavanti posto nella chiesa di s. Pancrazio allato alla bellissima cappella dei signori Marchesi Riccardi64.
sappiamo però che il corpo della santa, entro il secondo decennio del trecento fu forse tolto dal suo altare e fu seppellito sotto terra nella sagrestia. stette lì fino alla fine degli anni settanta dello stesso secolo, allorché fu disseppellito e traslato di nuovo nel suo originario altare. si legge infatti che:
È da sapere ancora che il decto corpo di sancta Verdiana per spatio di tempo fu cavato dallo altare et fu posto in sacrestia della decta chiesa, sotto terra in due casse, l’una nell’altra conficte et serrate et ferrate, sotterra tre o quattro braccia, credo per sospecto di guerre o altra buona cagione. erono morti quegli i quali sapevono dove era questo corpo, rimase pure in notitia di uno et può essere circa di anni cinquanta cinque o cinquanta sei, cioè circa gli anni mille trecento settanta sei, poco più o meno, el decto corpo sancto fu translatato et cavato, et tucto
56. brocchi, Ristretto della Vita della Gloriosa, p. 31.57. cfr. infra, Vita i e ii di giacomini, cap. XXXVi; brocchi, Ristretto della Vita della Gloriosa, p. 34.58. brocchi, Ristretto della Vita della Gloriosa, p. 35.59. brocchi, Ristretto della Vita della Gloriosa, p. 39.60. cfr. infra, Vita ii di giacomini, p. 140.61. cfr. infra, Vita ii di giacomini, pp. 141-42.62. benvenuti, Capi d’aglio e serpenti.63. cfr. infra, Vita ii di giacomini, p. 142.64. brocchi, Ristretto della Vita della Gloriosa, p. 30.
70 RAffAele ARgenziAno
il populo mi ricorda entrare nella decta fossa, dove era stato, et pigliare della terra, ch’era stata presso alla cassa del corpo di sancta Verdiana et serbarla, perché giettava grande odore et io ne pigliai con mia madre et per lungo tempo si riservò, et d’allora innanzi il decto corpo fu posto, et è al presente, nella sacrestia della sopra decta pieve di castel fiorentino 65.
le notizie degli spostamenti del corpo di Verdiana sono importanti, perché ci permettono di fare alcune considerazioni circa la tavola di Ugolino di nerio, la quale era creduta nel 1690 dal «più che celebre ed erudito Accademico cruscante e scrittore particolarmente delle materie di Pitture» filip-po baldinucci come databile «della maniera più antica sicchè potrebbe dirsi di poco dopo il 1300» e come realizzata «se non da cimabue almen da un di quei maestri allievi di giotto che fiorirono poco dopo il 1300»66.
Apprendiamo dalle testimonianze biografiche che la committenza di questo imponente possibile ex voto dipinto deriva probabilmente da una guarigione che la santa eseguì in favore di un «certo cava-liere Romano», sanandolo dalla ferita di una freccia di ferro conficcataglisi nell’osso di una gamba67.
così il badii ci dice che ha:
udito spesse volte essendo cosa comune in quella patria che fu quello per opera del quale fu fatta la tavola ov’è l’imagine ed il conio di s. Verdiana e quelli che per vista la conobbero dissono essegli molto somigliante, il che si ha per tradizione negli antichi passata ne’ posteri loro.
la narrazione prosegue informandoci che come ringraziamento il devoto, non solo fece molti doni alla cappella della santa, ma dispose pure che fosse dipinta a sue spese
la tavola di s. Verdiana che è oggidì in sullo Altare e quegli che la poterono considerare e viva e morta il Maestro la dipinse assai simile alla faccia sua propria quanto era possibile al dire di quegli che la viddono allora cioè in quello tempo68.
dunque, se nella tavola di Ugolino di nerio Verdiana è mostrata con indosso l’abito delle terzia-rie domenicane, possiamo porci la seguente domanda: da dove deriva questa iconografia che non è documentata nella tradizione prosopografica e che i biografi ben pongono in evidenza ribadendo che «alcuna scrittura ne faccia menzione»?
nella scheda di restauro della tavola di castelfiorentino non sono evidenziati interventi di tagli nelle parti laterali, né è possibile stabilire una approssimativa datazione degli interventi di restauro precedenti a quello ultimo ottocentesco.
la parte più antica del dipinto risulta essere quella del volto e delle mani, come è ben evidenziato nella scheda di restauro dove si legge che: «stratigrafie di frammenti di colore sul bordo di cadu-ta di colore intorno al viso hanno permesso di verificare che questa parte è pittura antica anche se molto consumata»69. il fatto che il volto della santa abbia conservato la mestica originaria conferma la volontà dei devoti di preservare una memoria tangibile e il più possibile vicina al ritratto della loro protettrice. dagli interventi di pulitura risulta anche un’altra interessante indicazione: pare che
65. cfr. infra, Vita ii di giacomini, p. 135.66. badii-Poltri, Vita della gloriosa, pp. 320-21.67. Victor schmidt afferma che «sembrerebbe logico immaginare una connessione originaria del dipinto con la tomba della
santa, invece fu commissionato come ex voto da un cavaliere romano» e come tale, secondo lo studioso, e stando alle indicazioni che ci fornisce il gonnelli, uno dei biografi della santa castellana, assolveva la funzione di dipinto «portatile», cfr. schmidt, Tipologie e funzioni, p. 543.
68. badii-Poltri, Vita della gloriosa, p. 186. brocchi, Ristretto della Vita della Gloriosa, p. 29.69. soprintendenza ai beni Artistici e storici delle province di firenze e Pistoia, Ufficio Restauro, Scheda di restauro n. 5252.
UnA qUestione di «hAbito» e di «oRdine»: l’iconogRAfiA di VeRdiAnA dA cAstelfioRentino 71
sull’aureola che circonda il capo di Verdiana, ci siano tre strati di dorature, che evidenzierebbero così tre tipi di interventi conservativi avvenuti in epoche differenti70.
È possibile invece che la realizzazione della tavola di Ugolino di nerio si possa legare al momento in cui il corpo di Verdiana venne sepolto sotto terra. questo fatto indusse probabilmente i devoti castellani a richiedere una immagine della santa che sostituisse le occultate spoglie mortali. così da poter avere, in luogo dei tangibili patrocinia, un ritratto il più possibile somigliante alle reali sem-bianze di Verdiana. e, come abbiamo sottolineato all’inizio di questo lavoro, la presenza tangibile della santa si realizzava pienamente nella sua riproduzione su tavola, assicurandone la vicinanza materiale ai suoi devoti. la data alla quale si fa risalire lo spostamento cioè al secondo decennio del trecento, andrebbe anche in accordo con l’attribuzione a Ugolino, il quale in quegli anni, se pure tardi per la sua attività, avrebbe potuto realizzarla. il fatto che Verdiana abbia indosso gli abiti di una terziaria domenicana è più difficile da spiegare, almeno stando alle fonti documentarie.
A tale proposito il badii nel 1692 si chiedeva se fosse:
credibile che quegli Antichi che avevono delle fattezze del Volto di s. Verdiana non l’avessero molto più anche della qualità dell’Abito di essa, che forse allora conservavasi come Reliquia, non averebbero permesso certo che fusse dipinta coll’Abito domenicano se ricevuto non l’avesse dal P. s. domenico e che posta fusse l’immagine di più in pubblico sul proprio altare [?]71.
e aggiungeva pure un’ulteriore considerazione in virtù del fatto che, a quella data, nessun frate di nessun ordine avrebbe chiesto che quell’immagine fosse soppressa o nascosta da quel luogo, limi-tandosi soltanto a farla riprodurre nelle loro chiese e in altri luoghi legati alla propaganda delle loro «religioni»con l’abito proprio dei loro istituti. Poiché, non bastava che Verdiana fosse dipinta da «terziaria domenicana per asserirla tale», il badii chiosava le sue considerazioni in tale proposito, col ribadire che Verdiana era «stata sempre per il tempo della sua mirabile solitudine vestita con abito di divota e modesta penitente nel modo che si racchiuse»72.
dobbiamo dunque credere che la prova di appartenenza di Verdiana a un ordine religioso derivi dall’iconografia della tavola di Ugolino di nerio, così che quell’immagine in mancanza di fonti scritte, è diventata la sola fonte superstite? quale fosse l’abbigliamento di Verdiana nella raffigura-zione di quella tavola non possiamo saperlo per certo visto che, quasi la totalità di essa è stata ridi-pinta con le vesti da terziaria domenicana. Possiamo però supporre, stando alle poche ma consistenti testimonianze agiografiche e ad un’unica testimonianza iconografica, che la primitiva iconografia di Verdiana sia stata realizzata secondo quanto era indicato nelle fonti scritte, cioè senza che indossas-se alcun abito di ordine religioso. A sostegno di questa affermazione abbiamo una raffigurazione nella chiesa di sant’Agostino a san gimignano sulla parete della navata destra tra una serie di santi dipinti in affresco. si può vedere in uno stato frammentario «liberato dallo scialbo e restaurato nel 1995» un frammento, attribuito da Alessandro bagnoli a bartolo di fredi e eseguito tra il 1365 e il 1367, che mostra un’immagine di santa Verdiana con gli abiti di una bizzocca (fig. 2), cioè di una laica con veste tonacale annodata in vita da una cintura di corda, con sul capo il velo e con ai lati i due serpenti ritti che la guardano, proprio come è nella tavola di Ugolino73.
70. «Un altro frammento preso fra il velo e il fondo dorato ha dimostrato che in tutto vi erano state tre dorature la prima originale sopra la quale è stato trovato uno strato di gesso e una nuova doratura e per ultimo una nuova ammannitura prima dell’ultimo restauro visibile», soprintendenza ai beni Artistici e storici delle province di firenze e Pistoia, Ufficio Restauro, Scheda di restauro n. 5252.
71. badii-Poltri, Vita della gloriosa, pp. 186-87. 72. Ibidem, pp. 187, 189, 195.73. bagnoli, La Maestà, pp. 107, 150 e nota 148.
72 RAffAele ARgenziAno
Alla fine degli anni sessanta del trecento deve essere stata probabilmente modificata quella an-tica iconografia adeguandola alle nuove esigenze cultuali e religiose legate soprattutto agli ordini mendicanti. si è provveduto così a cambiare l’abito che mostrava Verdiana sul più antico documento iconografico che ci sia stato tramandato e che probabilmente era posto sull’altare della santa fin dal secondo decennio del trecento.
che il modello al quale tutti i committenti e i pittori si ispireranno per la produzione figurativa successiva a partire dalla metà del XiV secolo sarà proprio la tavola di Ugolino, ci è confermato ancora alla fine del XVii secolo, poiché di quel modello iconografico ne sono testimoniate delle co-pie «nel modo e forma che sta quella», una delle quali fu realizzata nel 1690 dal pittore fiorentino Andrea di domenico cianchi74.
questi il 18 dicembre del 1690, all’età di sessantotto anni, in presenza del notaio Agostino ciuri-ni di castelnuovo di Valdelsa, del settantaseienne cancelliere giovan giacomo neri di castelfioren-tino e del trentaduenne dottore giovan Michele di ser giannozzo del Pela dichiarò di aver:
copiato la presente figurina di s. Verdiana e come sta in una tavola posta nella chiesa di detta santa in castelfio-rentino e secondo il mio parere giudico essere maniera di cimabue o altro suo allievo. l’altezza originale è braccia tre, e di lunghezza braccia uno e un sesto [le attuali misure di centimetri 172 × 68,5, corrispondono quasi preci-samente a queste] in campo dorato detto originale è presentemente collocato sotto l’organo di detta chiesa sopra la finestra. inoltre attesto essere realmente detto originale dipinto con abito domenicano e che le scrostature che in detto quadro si vedono con altra osservazione della mia professione sono indizi della predetta antichità75.
e sulla antichità della tavola trecentesca, come sulla copia seicentesca dell’icona di Verdiana, si era già pronunciato, come abbiamo segnalato in precedenza, il baldinucci, il quale il 20 febbraio del 1690 dichiarò che:
con avermi esso molto Reverendo Padre [il domenicano Raffaello badii] mostrata a tale effetto una copia che dicesi pure esser stata ricavata a tutta imitazione della Pittura stessa come anche ad imitazione di parte dell’ornamento d’essa tavola, avendo ben considerato detta copia, dico essere il mio parere, che per quanto apparisse dall’antichità che mostra la tavola, l’ornato e la pittura il tutto fu fatto ne’ più vicini tempi alla morte della santa che altre mai si sia fino ad oggi veduta nelle parti di toscana. dico che il detto ornato della tavola è nella forma che facevansi simili ornamenti dal 1260, fino a tutt’il secolo del 1300, cioè fino al 1400, o poco più, benché dal 1350 in poi essendo alquanto migliorato il gusto se ne vedessero alcuni di miglior maniera, quello però di cui ora si tratta dico essere della maniera più antica sicché potrebbe dirsi di poco dopo il 1300. Al che se aggiungerò l’osservazione fattasi dal Pittore [cioè dal cianchi] sopra l’antichità della medesima pittura non mi pare di poter dubitare, che ella non fosse fatta, se non da cimabue, almeno da un di quei Maestri Allievi di giotto che fiorirono poco dopo al 1300 e per esser tale il mio parere soscriverò di mia propria mano. io filippo baldinucci sono del soprannotato parere e di mia propria mano ho sottoscritto questo dì ed anno suddetto in firenze76.
dunque queste testimonianze starebbero a certificare non solo l’antichità della pittura ma pure la vetustà del contenuto iconografico, cioè il fatto che Verdiana in quella tavola fosse dipinta fin dal 1320-29 con l’abito da terziaria domenicana.
Ma come abbiamo già detto, gli ordini mendicanti rivendicheranno ciascuno l’appartenenza di Verdiana tra le proprie ‘glorie’. i francescani sosterranno, come ci informa padre benedetto Mazzara, che il ‘leggendario soldato Romano’ possibile committente della tavola trecentesca, «tra gli altri doni che alla santa offerì per ringraziamento dell’impetrata salvezza la fe’ dipingere in quella forma,
74. badii-Poltri, Vita della gloriosa, pp. 318-19.75. Ibidem.76. Ibid., pp. 320-21.
UnA qUestione di «hAbito» e di «oRdine»: l’iconogRAfiA di VeRdiAnA dA cAstelfioRentino 73
che ora si vede nella chiesa coll’abito del terz’ordine francescano cinta di corda»77. ed anche se il badii sottolinea che «niuno [dipinto] si vede in castelfiorentino in quelle chiese, oratori, e compa-gnie che rappresenti s. Verdiana coll’Abito descritto dalli scrittori prenominati», noi vedremo che Verdiana fu ritratta in abito da francescana in diverse pitture.
cercheremo qui di ricostruire, per quanto è possibile, la questione circa l’appartenenza di Ver-diana a un particolare ordine religioso, attraverso le notizie che ci vengono dalle fonti agiografiche, senza dimenticare che molta della produzione figurativa della santa castellana è andata irrimedia-bilmente perduta.
Una di queste immagini di Verdiana che è andata distrutta, ma della quale abbiamo una testi-monianza fotografica, si trovava nella chiesa dei santi Michele e giacomo a certaldo (fig. 3) 78. in uno degli antichi altari trecenteschi di questa chiesa, si può vedere ancora oggi un affresco realizzato da Memmo di filippuccio79, che mostra una Madonna in trono con il Bambino tra i santi, Giacomo maggiore a destra e a sinistra Pietro. Ai piedi di san giacomo è raffigurata in ginocchio una donatrice con le mani giunte in preghiera. Un documento fotografico precedente al restauro mostra (fig. 3) la donatrice trasformata, o meglio travestita, da santa Verdiana sul finire del quattrocento da un artista vicino al botticini. questo pittore dietro indicazione di una ‘motivata’ committenza, dipinse, sten-dendo un nuovo strato di intonaco, Verdiana con il suo attributo caratteristico, cioè il cestino con le due serpi, mantenendo per la santa, inaspettatamente, l’acconciatura dei capelli della donatrice80. la distruzione di questa testimonianza iconografica, avvenuta probabilmente nel corso degli ultimi restauri della chiesa compiuti negli anni sessanta del novecento, conferma la forte devozione per la santa castellana pure nel territorio di certaldo, comune peraltro ‘antagonista’ di castelfiorentino anche sul piano cultuale.
il locatelli, afferma che Verdiana prese dalle mani del pievano l’abito composto da tunica, man-tello e velo, e che quegli indumenti facevano parte:
dell’abito monastico dell’ordine di Vallombrosa il quale da questa s. Verdiana fu dimandato avendo in esso già molto tempo innanzi gran divozione siccome a tutto l’ordine di Vallombrosa ancora che era famoso molto per la toscana mediante i religiosi santi e buoni che in esso ogni dì andavano fiorendo81.
Ma lo stesso badii qualche pagina più avanti precisa che:
nella vita latina scritta dal Vescovo Acaiense (...) a proposito dell’abito suddetto (...) sarà necessario replicare che prima per qualche anno era stata s. Verdiana per qualche anno del terz’ordine di s. domenico cioè fino all’anno 1221 [anno di morte di domenico] e poi fino alla sua felice morte terziaria di s. francesco o pure per non tacciar così saggia Verginella (ne meno per ombra) d’incostanza sarà d’uopo affermarla colli signori Rappresentanti suoi compatriotti professa dell’uno e dell’altro istituto, per avere da due santi Patriarchi ricevuto in diversi tempi l’abito per la divozione che ugualmente ad ambidue meritamente ella aveva ad esempio forse del P. s. domenico che come riferiscono li stessi PP. francescani nella Vita del loro ss. Padre col P. Arturo nel loro Martirologio volle dal suo diletto amico s. francesco il suo cordiglio che per divozione ed attestato della stretta amicizia, sopra del proprio Abito domenicano palesemente portava; ma ciò ammesso per vero non per questo si poteva dire s. domenico esser Professo di s. francesco ma amico divoto solamente di lui e così ancora di s. Verdiana dirassi lo stesso82.
77. Ibid., p. 323.78. Empoli, il Valdarno inferiore, pp. 153–55.79. bagnoli, La Maestà.80. Ringrazio l’amico Alessandro bagnoli per i preziosi suggerimenti in tale proposito.81. badii-Poltri, Vita della gloriosa, pp. 117-18. locatelli, Vita del glorioso, lib. ii, cap. 42.82. Ibidem, p. 184.
74 RAffAele ARgenziAno
bisogna però tenere conto che lo stesso autore aveva poco prima precisato che gli indumenti che componevano l’abito delle terziarie domenicane erano «tonaca bianca colla cintola di quoio, man-tello nero e bende o velo bianco di lino o di canapa come si ha dalle loro costituzioni al cap. 9»83.
dunque per il badii Verdiana avrebbe indossato l’abito delle terziarie domenicane con il «cor-diglio» delle francescane: questo contribuisce a confondere maggiormente la questione della veste portata dalla santa castellana. eppure sappiamo che apparve in una visione a un tale che testimoniò di averla veduta «assai venerabile d’aspetto, vestita di panni bigi e il capo velato di panni bianchissimi e col mantello di sopra la tonaca di quel medesimo colore bigio»84. insomma in abito da penitente, come si vede «a volte dipinta» per esempio, sostiene sempre l’autore, in «orsanmichele in firenze»85. il gonnelli, però, ci narra che l’abito che le fu trovato indosso dopo la sua morte era di «lana ben grossa ed ordinario senza’altra tintura di quella che gli aveva dato la natura né altri vestimenti si trovarono come contentissima di un abito solo»86. Ma il badii ribadisce che questo non impedisce di credere che quell’abito di colore naturale non tinto, possa essere la tonaca delle terziarie domenicane87.
il frate nicola Magri dell’ordine Agostiniano, ci dice che essendo da «più fiate» chiamata romita, ella potesse considerarsi una agostiniana. e questo si poteva arguire non tanto dal fatto che a Verdia-na fosse assegnata la qualifica di romita, per la quale «convien sapere che ogni volta si dice Romito s’intende della Religione Agostiniana», quanto per l’esistenza all’epoca, cioè sul finire del duecento, di un’unica vera religio eremitana: quella degli eremitani di sant’Agostino. questi furono istituiti un primo gruppo nel marzo del 1244, attraverso la riunione di un cospicuo numero di eremiti dell’antica tuscia e nel 1256 con la cosiddetta Magna unio, quando a loro furono aggregati pure gli eremiti di san guglielmo, quelli di san giovanni bono, quelli di Montefavale e quelli di brettino88.
Per la questione delle immagini che mostrano Verdiana con l’abito delle terziarie francescane, il badii ci dice che prima del 1221 furono i francescani, nella persona di francesco stesso, a dare l’ uniforme alla reclusa e che questa era fatta di un «abito bigio e col cordiglio francescano»89.
dunque, sulla questione dell’abito, e cioè sul fatto se Verdiana sia stata terziaria domenicana, Vallombrosana, francescana o Agostiniana, il badii ci dice che:
ella avesse da s. domenico l’abito sebbene non abbiamo alcuna scrittura che ne faccia menzione, tuttavia l’anti-chissima pittura della sua immagine effigiata nella vecchia tavola dell’altar maggiore della sua chiesa sebbene ora da quello rimossa e posta sopra l’altare a canto la porta a mano sinistra ce ne fa assai certo testimonio veggen-dosi coll’abito bianco sotto e sopra la cappa nera, abito proprio di quell’illustrissima Religione e tale immagine si tien per fermo esser quella che fece dipingere quel soldato Romano (...) e quanto all’Abito si può creder fosse il medesimo sendo stata da dotta e maestrevol mano di quei tempi poco dopo la morte sua dipinta90.
Ancora in riferimento alla tavola di Ugolino di nerio il badii, a conferma del fatto che la cellana di castelfiorentino abbia indossato fin dall’inizio della sua vita di reclusa l’abito dei frati Predicatori, ci segnala che nell’edizione della Vita del gonnelli, al capitolo 19 si legge:
83. Ibid., p. 182.84. Ibid., p. 204.85. Ibid., p. 205.86. Ibid.87. Ibid., pp. 205-6.88. Per la questione dell’ordine di sant’Agostino cfr., Rano, Agostinianim pp. 278-381. badii-Poltri, Vita della gloriosa, p. 118.89. badii-Poltri, Vita della gloriosa, pp. 196, 202-3.90. Ibidem, pp. 184-85.
UnA qUestione di «hAbito» e di «oRdine»: l’iconogRAfiA di VeRdiAnA dA cAstelfioRentino 75
come apparisce in una pittura antichissima che si trova in castrelfiorentino nella chiesa di s. Verdiana in un qua-dro portatile, il quale è stato portato secondo l’occasione in diversi luoghi della detta chiesa ed ora si trova sotto l’organo sopra la porta principale dove si vede coll’Abito bianco di sotto e di sopra la cappa nera abito proprio di quell’illustrissima Religione91.
Molto interessante in questa citazione è il fatto che la tavola di castelfiorentino sia definita un «quadro portatile», cioè un oggetto che poteva con facilità essere trasportato da un luogo ad un altro per la promozione del culto di Verdiana o per questioni di carattere devozionale92. Ma il biografo, cioè il badii, si contraddice subito dopo affermando che:
nel breve di clemente Vii sotto 21 settembre 1533 e in quello de’ signori cardinali emanati a tempo di giulio ii del 1504 non ci è espresso che ella fosse Religiosa come a chi legge apparisce reflettendo alle parole dell’uno e dell’altro93.
egli arriva addirittura a sostenere che la tavola di Ugolino possa essere stata realizzata perché «fresca era la memoria della santa in castelfiorentino» e il pittore avrebbe potuto trarre dalle testimonianze dell’epoca quanto stava per raffigurare, come se all’artista fosse lasciata la libertà di decidere su quello che doveva raffigurare94. infine il badii conclude affermando, in modo rocambolesco, che Verdiana
ricevette da s. domenico e prese l’abito suo come attesta l’antico quadro e da s. francesco fu ricevuta nel suo terz’ordine come il padre frate Mariano riferisce95.
Una soluzione questa che non dà alcun chiarimento sul fatto che la santa sia rappresentata abbi-gliata con le vesti di ordini religiosi differenti.
nella testimonianza biografica del badii è descritta anche la chiesa di s. Verdiana a castelfiorenti-no. l’autore si dilunga sia sulla descrizione della parte architettonica, sia su quella più propriamente decorativa. così tra le pitture presenti in quella chiesa sul finire del seicento, sono ricordate nel coro dietro l’altare maggiore:
tre gran tavole con cornici graziosamente intagliate e dorate ciascuna delle quali tavole ricopre il muro delle tre facciate che fa il detto coro. in quella che è dalla parte del Vangelio [alla destra dell’altare maggiore] rappresentasi con figure maggiori del naturale quando la gloriosa nostra santa prese la benedizione dal Pievano di quel tempo, s’inviò col clero della terra e rappresentanti il di lei pubblico e popolo della medesima a racchiudersi nel romitorio già a sua richiesta fabbricato a timignano. questa è opera di gio. batista detto titta di galeazzo gidoni pittor fio-rentino fatto nel 1637. l’altra che gli è di rincontro più dell’altre stimata da’ Professori ed intendenti, rappresenta l’essequie che fatte furono alla santa ed attorno al catafalco oltre al clero e detti Rappresentanti e Popolo, si vedono effigiati alcuni indemoniati, ciechi, storpiati ed altri infermi. e questa è di mano di filippo tarchiati, discepolo già di santi di tito dipinta nel 1633 col costo di sc. 130. quella di poi che è in faccia rappresenta la santa dopo essere spirata e vedesi l’immagine di quella gloriosa anima presentarsi alla santissima trinità che a cielo aperto stanno ad aspettarla le tre santissime Persone96.
Poi è descritta una Crocifissione con la Madonna, Giovanni Evangelista e ai piedi della croce la Mad-dalena sotto la quale era raffigurata l’immagine di Verdiana. questa, secondo il badii, era opera di
91. Ibid., p. 185.92. schmidt, Painted Piety.93. badii-Poltri, Vita della gloriosa, p. 206.94. sulla questione dell’istituto al quale apparteneva o sarebbe appartenuta Verdiana cfr. Ibid., pp. 177-208, in particolare p. 200. 95. Ibid., p. 207.96. Ibid., p. 249.
76 RAffAele ARgenziAno
bartolomeo salvestrini e fu realizzata nel 169297. Poi sono descritte le pitture affrescate nella volta del coro e in quella della chiesa, le quali vengono assegnate correttamente a francesco salvestrini e giovan battista di Vincenzo Rosati. in esse sono rappresentate scene che mostrano la santa in gloria e «azioni più singolari della stessa descritte nella vita». i pennacchi della volta sono ornati con le raffigurazioni delle tre Virtù teologali. e gli spazi che ci sono tra queste figure sono «vagamente arricchiti con bizzarri arabeschi d’oro, festoni, fogliami e simili artifizi, per finimento leggiadro dell’opera». queste pitture furono realizzate entro il 1626 e furono pagate 106 scudi98.
Poi la narrazione prosegue con la descrizione della decorazione che orna le pareti della sagrestia situata sul lato sinistro del coro e che «fu principiata» nel 1599 . di seguito è ricordata l’antica ubicazione della tavola di Ugolino di nerio, come collocata in uno degli altari «a man sinistra della chiesa». la tavola nel 1607 era sistemata sull’altare maggiore, mentre al tempo del redattore di queste note biografiche, cioè nel 1692, la stessa si trovava sotto l’organo, il quale era collocato sopra la porta principale della chiesa99.
È segnalata pure una tavola che raffigurava La Vergine Assunta con a destra santa Verdiana e a sinistra sant’Antonio abate (fig. 24), eseguita nel 1601 dal pittore iacopo da empoli, su commissione di una «divota donna detta mona Mea di Marco Mosti serva già del signor pievano Antonio berrettani»100.
Pure nella chiesa del Monastero di s. Verdiana a firenze sono segnalate testimonianze figurative della romita castellana. Una di queste era all’altare maggiore in una tavola realizzata dal pittore fio-rentino Pier dandini (fig. 33), nella quale erano raffigurati «a figure intere» tra i vari santi e sante anche Verdiana, la quale era posta accanto al vallombrosano san giovanni gualberto. Mentre nelle lunette del coro, della stessa chiesa «vi si scorgono dipinte a fresco» alcune storie tra quelle più im-portanti (fig. 49) tratte dalla Vita di Verdiana101.
Anche la produzione delle Vite di Verdiana fu sostenuta per conservare la memoria della santa e per promuovere il suo culto, come ci informa Alessandro di francesco di grazino quaglini in una lettera inviata da siena il 29 novembre del 1575. egli ci fa sapere che filippo, bernardo e Ruperto degli Attavanti, ordinarono «cinquanta istorie o leggende le quali hanno fatto tradurre di latino in volgare e stampare nelle quali si contiene la Vita e i miracoli di essa s. Verdiana». Ma lo stesso badii riferisce che non se ne è trovato uno di quei cinquanta esemplari della Vita di Verdiana in castelfiorentino102.
Alla tomba di Verdiana furono fatti molti doni e tra questi è ricordata «una corona d’argento tocca d’oro tutta ornata di gioie per porre sulla testa di legno dorato ove già stava racchiuso il santo teschio della stessa santa», questo dono fu offerto a Verdiana il 28 maggio del 1599 da giovanni fedeli, medico fisico di castelfiorentino»103.
furono rimesse insieme dal fiorentino giovanni bernini e per volere della signora camilla di Vincenzo strozzi fiorentino, tutte le ossa di Verdiana che erano rinchiuse alla rinfusa in una cassetta di legno, in modo da formare uno scheletro. i resti mortali così riuniti furono vestiti di
tabì pavonazzo puro alla foggia delle monache Vallombrosane con calcetti di velluto rosso, fu posato sopra a un ricco strapunto e guanciali simili e racchiuso in una cassa molto artifiziosamente intagliata e riccamente dorata,
97. Ibid., p. 250.98. Ibid.99. Ibid., p. 252.100. Ibid., p. 253.101. Ibid., p. 262.102. Ibid., pp. 264-65.103. donazioni alla santa e alla sua chiesa provennero non solo dal territorio toscano ma pure da altre regioni. Ibid., p. 267.
UnA qUestione di «hAbito» e di «oRdine»: l’iconogRAfiA di VeRdiAnA dA cAstelfioRentino 77
sopra di cui è parimente con gentilezza grande intagliata e d’oro ricoperta una corona di fiori alla quale s’avvolgono due serpi fatte di carta pesta e sopra maestosamente si solleva un bello e vago giglio di foglia d’argento104.
il badii narra anche del furto di un dente di Verdiana ad opera del reverendo padre giacinto chel-lini sacerdote di origine castellana. questi quando ebbe sotto mano la testa della santa mostratagli dal pievano dionigi Attavanti «destramente cavò dalla s. testa un dente» che portò con se a Roma dove stava talvolta presso i suoi nipoti. Purtroppo si ammalò gravemente e dando la cagione di que-sta malattia allo ‘scellerato’ gesto commesso, per rimediare a ciò decise di restituire quella reliquia irrispettosamente sottratta, per riporla nel luogo di dove era stata estratta105.
il cardinale francesco de’ nerli di firenze donò alla chiesa di s. Verdiana, in segno di «singola-rissima divozione ed ossequio» un busto d’argento rappresentante la figura della santa «sottilmente e ingegnosamente lavorato di peso di libbre 12»106.
le immagini di Verdiana dovevano essere sicuramente molto più numerose rispetto a quelle che ci sono state tramandate. infatti, nelle fonti agiografiche sono ricordate molte raffigurazioni della santa castellana. sappiamo così che su commissione di Pandolfo Attavanti fu fatto eseguire dal pit-tore iacopo coppi nel 1571, per l’altare di loro patronato dedicato a san Vincenzo ferrer nella chiesa di s. Maria novella a firenze, un dipinto, dove sono raffigurati San Vincenzo Ferrer che predica alla presenza di Tobia, Raffaele Arcangelo e Verdiana (fig. 23) 107.
Ma la conferma che il culto di Verdiana, a castelfiorentino e a firenze, fosse molto diffuso e con-solidato ci è data dalla lettura del supplemento del 1692, alla Vita di lorenzo giacomini, per opera del frate domenicano Raffaello badii. in questo documento al capitolo Xiii si legge:
d’alcuni ritratti antichi, e diverse immagini, che in più luoghi si vedono di s. Verdiana in attestato della sin-golar divozione de’ fedeli verso di essa, con alcune tradizioni della stessa s. appartenenti108.
in questa parte della Vita si sottolinea l’importanza dell’iconografia rispetto a quanto è narrato nei testi scritti, affinché:
a tutti apparisca chiara la verità, che dalla diversità delle penne, e della negrezza degl’inchiostri, è talvolta alterata, o nascosta, il che è peggio, colla menzogna, o altra artifiziosa finezza dagli appassionati109.
così apprendiamo, come abbiamo già detto, che nel 1690 il pittore domenico cianchi eseguì una copia della antica tavola di santa Verdiana «nella forma espressa da terziaria domenicana»110. e che all’altare di:
s. giovanbatista padronato de’ sig. Attavanti è una tavola che si crede di mano del grillandaio, nella quale è in mezzo l’effigie della Verg. Maria col bambino in collo, s. gio. batista alla mano destra ed alla sinistra di s. Verdiana con abito per di sotto tanè Vallombrosano e manto più scuro con cintola, testa velata con velo bianco e nero e colle due serpi allato ed il panierino in mano111.
104. Ibid., pp. 268-69. Ai pievani di castelfiorentino che custodivano le reliquie di Verdiana furono fatte da diverse parti nume-rose richieste per ottenere qualche resto mortale della santa castellana. Ibid., pp. 287-89.
105. Ibid., p. 290.106. Ibid., p. 271.107. Ibid., p. 199.108. Ibid., p. 317.109. Ibid., pp. 317-18.110. Ibid., p. 321.111. Ibid., p. 322.
78 RAffAele ARgenziAno
Un’altra immagine di Verdiana si poteva vedere (fig. 12):
nella sala del palazzo del sig. Potestà di castelfiorentino nella facciata di mezzo (...) sopra l’arme del sig. iacopo Antonio Peri, stato Potestà l’anno millequattrocentonove [si deve leggere 1490 poiché il Potestà ricopre quella carica in questi anni], la quale effigie di s. Verdiana è coll’abito tanè Vallombrosano oscuro ed il manto più oscuro dell’abito colla cintola ed il velo bianco e di sopra il nero e due serpi a canto ed il panierino in mano112.
il badii prosegue informandoci che:
nella compagnia di s. soffia, che è contigua al convento de’ RR. PP. s. francesco di castelfiorentino nel primo ingresso di detta confraternita vi sono due altari con tavole molto antiche uno de’ quali è a man dritta ove vi sono cinque tavole di legno unite assieme, come s’usava in que tempi, in quella di mezzo vi è il Ritratto di Maria Vergine col bambino giesù in collo, a mano dritta vi è il ritratto di s. francesco colle stimate e a mano sinistra vi è il ritratto di s. gio. evangelista ed a man destra in quarto luogo vi è il ritratto di s. Verdiana coll’abito tanè oscuro Vallombrosano, velata col velo bianco e di sopra il velo nero, tiene nella mano sinistra un panierino e colla destra da mangiare due gran serpe, ed a sinistra in quinto luogo vi è il ritratto di s. soffia; ed in piedi di dette cinque figure vi è notato giovanni biondi fiorentino dipinse l’anno MccclX ed il nome de’ predetti santi colla santissima Vergine Maria113.
Ma nel 1692 il cancelliere giovan giacomo neri testimoniò che oltre ai su citati ritratti di Ver-diana in castelfiorentino si trovavano anche altre immagini della reclusa castellana e cioè, quella
nella sagrestia della Venerabile compagnia di s. bastiano vi si trova un quadro o tavola di legno ove è dipinto il martirio di detto santo titolare nel di cui adornamento di larghezza d’un quarto di braccio vi si scorge tra l’altre figure che vi sono pennelleggiate quella di s. Verdiana posta alla sinistra in alto colle due solite serpi e panierino in mano con abito Vallombrosano chiaro, con cintola e con il velo bianco orlato con fregi o pure frange nere [come le clarisse nel breviario francescano miniato da sano di Pietro e conservato oggi presso la biblioteca comunale degli intronati di siena 114], siccome nella cappellina della stessa compagnia, ove si celebra in una delle cinque tavolette dorate, che vi si trovano al presente pure si vede la s. vestita di nero chiariccio ben ombreggiato, col velo bianco e nero, e cintola senza manto o cappa, qual ritratto apparisce ancora antico assai ed è effigiata la s. con viso lungo e in piedi nella stessa positura e maniera dell’antichissima figura che sta nella di lei chiesa rappresentata da terziaria domenicana115.
e poi, per confermare l’appartenenza di Verdiana all’ordine Vallombrosano, in una lettera del 21 marzo 1690, si segnala che il cancelliere neri così dichiarava:
ho dopo molto avuto campo di poter vedere da vicino il Ritratto di s. Verdiana, che è nella chiesa de’ frati di s. francesco all’Altare oggi dell’Angelo custode, che anticamente era di s. girolamo con s. francesco sulla destra e s. Verdiana sulla sinistra la qual tavola è stata messa sopra l’adornamento di legno sono salito su alto, e visto più da vicino e trovato che è in tutto e per tutto vestita da Vallombrosana, se non erro: il manto benché sia più oscuro dell’abito di sotto, si vede che pende in rossiccio e l’Abito è più chiaro, ma ancor esso scopre il rosso più del Manto ed ha la cintola di quoio infilata nella fibbia116.
con la descrizione di queste tavole, che il badii segnala come gli unici «ritratti antichi» di Ver-diana nel territorio di castelfiorentino, si passa poi all’elenco delle testimonianze figurative «mo-
112. Ibid., p. 323. Per la datazione e l’attribuzione a benozzo gozzoli e bottega, crf. bernacchioni, Benozzo Gozzoli, pp. 113-15.113. badii-Poltri, Vita della gloriosa, p. 323. 114. Argenziano L’iconografia del «Breviarium Fratrum Minorum».115. badii-Poltri, Vita della gloriosa, pp. 324-25.116. Ibid., p. 325.
UnA qUestione di «hAbito» e di «oRdine»: l’iconogRAfiA di VeRdiAnA dA cAstelfioRentino 79
derne», cioè «quei ritratti ed immagini che si vedono nelle chiese e luoghi non molto lontani da castelfiorentino per scrivere poi finalmente degli altri che altrove sono stati dipinti per attestato di singolarissimo ossequio verso la medesima» 117.
comincia così l’elenco dei dipinti che raffigurano Verdiana al di fuori del territorio di castelfio-rentino. il primo che ci segnala è:
nella chiesa dell’antichissima Pieve detta celi aula e corrottamente ciricciavoli, vicina a Monte spertoli diocesi fiorentina, vedesi pure nell’antichissima tavola dell’altare maggiore il ritratto di s. Verdiana allato a quello della Vergine Maria, quale sta nel mezzo e porge a s. tommaso Apostolo genuflesso a’ suoi piedi la sua cintola ed esta s. è collocata alla destra dalla parte del Vangelo, con velo, e soggolo bianco, con tonaca nera da monaco col suo manto parimente nero, colli piedi, per quello apparisce, scalzi, e sopra la testa vedesi la diadema senza raggi, colla destra mano tiene un libro aperto e colla sinistra sostiene il suo manto o coppa, che dir debbasi, allato a questa così effigiata sta s. iacopo Apostolo, e dall’altra parte di questa tavola a mano sinistra s. gio. battista, e s. Antonio Abate118.
questa informazione resa dal pievano della chiesa di «ciricciavoli» cesare Monaldi il 23 dicem-bre del 1690, è confermata da un «sacerdote regolare con una relazione scritta di mano propria» il 28 marzo del 1691119.
Un altro dipinto si trovava nella chiesa di s. bartolomeo a Vignale, nella diocesi di Volterra, dove si poteva vedere un’immagine di santa Verdiana dipinta in affresco:
presso all’altar maggiore, d’ altezza di braccia due, e larghezza d’uno, effigiata con manto sopra alle spalle di colore scuro, cinta con cordone distintissimo, che perciò è stimato essere vestita da francescana, siccome in un’altro ri-tratto, dicono, posto nella chiesa di s. Miniato a fonte Rutoli già nella diocesi di fiesole ed ora di quella di colle, nel chianti120.
il badii ci segnala pure la scultura in terracotta, visibile ancora oggi, che mostra Verdiana in abito da francescana (fig. 16), realizzata verso gli inizi del cinquecento, da un anonimo scultore, per la chiesa del convento francescano di s. Vivaldo:
nella chiesa del convento di s. Vivaldo de’ Padri Minori osservanti, e altrimenti di s. Maria e s. francesco del boscotondo della diocesi di Volterra del vicariato di s. Miniato presso Montaione (...) vedesi la statua della gloriosa s. Verdiana effigiata nella forma e nel modo che dei detti padri pretendono, oltre all’essere dipinta nel chiostro interiore di questo luogo121.
stando alla testimonianza del badii quella scultura fu realizzata insieme ad altre due, che avrebbero dovuto raffigurare rispettivamente san leonardo e san lorenzo, gli altri due santi protettori di castel-fiorentino, per obbligo contratto da «essi religiosi colla comunità di castelfiorentino, che concedette a’ medesimi quel terreno d’antichissimo padronato di quella» 122. Ma pare che delle tre sculture furono realizzate solo quelle di san lorenzo e di santa Verdiana, le quali nel 1692 si potevano vedere «nella facciata dell’altar maggiore in due nicchie, quello a man destra e quest’a man sinistra»123. di questa scultura ci viene fornita, se pure indirettamente, la datazione, poiché è detto che quella:
117. Ibid., p. 326.118. Ibid. 119. Ibid.120. Ibid., p. 328.121. Ibid., p. 329.122. Ibid.123. Ibid., pp. 330-31.
80 RAffAele ARgenziAno
effigie da 190 anni circa s’onora ed ossequia nella chiesa di s. Vivaldo da quei religiosi e dagli altri divoti fedeli del-la stessa santa che in gran quantità frequentano questo pio e celebre luogo, come la esperienza stessa manifesta124.
dunque se sottraiamo alla data di edizione del testo del badii, che è 1692 i 190 anni circa, indi-cati nel testo, otteniamo proprio la datazione 1502, che si può assegnare a quella scultura e che si lega bene ai suoi tratti stilistici.
tra le immagini di Verdiana viene ricordato pure:
un Ritrattino di due palmi in circa [che] ne tengono in casa come cosa molto pregiata e cara li signor Vincenzio Viviani, e fratelli nella città di s. Miniato al todesco, dipinta in figura intera, con abito lionato monastico antico Vallombrosano, e velo simile, posta in mezzo alle due serpi, col panierino ripieno di frutte nella destra e colla si-nistra tiene il cibo, che ad una di esse porge125.
questo ritratto di Verdiana era tenuto in casa dei Viviani in segno di devozione per la santa, eletta «antica protettrice della lor famiglia»126.
l’elenco delle effigi di Verdiana prosegue con la segnalazione dell’affresco, che era visibile ancora alla fine del seicento, su uno dei pilastri di destra dell’altare maggiore di orsanmichele a firenze. questa immagine fu fatta dipingere, come abbiamo già detto, da «quel di lei divoto, per gratitu-dine d’esser stato liberato per il di lei mezzo dalla pressazione di quel suo importuno creditore che l’angustiava»127. l’affresco doveva essere accanto ad un altro che raffigurava l’immagine di santa lucia. il badii ci informa che Verdiana era:
rappresentata con volto giovanile ed abiti modesti di secolare in figura intera dal pittore, che fu iacopo landini da Prato Vecchio detto il casentino, quale al riferire del Vasari nella prima parte delle Vite de’ Pittori a 210, dipinse dopo il 1337128.
sotto questa immagine di Verdiana era dipinta una scenetta nella quale si vedeva la santa in ginoc-chio con nelle mani un cestellino e accanto «aggruppate le due serpi, ed in uno scorcio dall’altra parte rappresentato vedesi castelfiorentino patria della santa», la presenza della raffigurazione della città natale di Verdiana fuga ogni dubbio sulla sua identificazione129. Purtroppo, quello che si vede oggi in orsanmichele (fig. 6), nel luogo indicato dal badii, ci mostra un affresco male identificabile per il cattivo stato di conservazione e che mostra una figura femminile con indosso delle vesti di colore ver-de, e che non può essere datato per motivi stilistici al 1337, bensì agli anni tra il 1390 e il 1396130.
Pure nella chiesa di:
s. Piero scheraggi già collegiata, consacrata dal Vescovo di todi Ridolfo fiorentino, Amministratore della sede Vescovile di firenze (...) vedesi nel coro a mano sinistra dalla parte del Vangelo una pittura con ornato di pietra, che tondeggia, creduta della prima maniera di Alessandro filippei fiorentino, detto sandro botticello, discepolo di frate filippo lippi del carmine (...) nella quale nel mezzo è la santissima Vergine in trono col bambino giesù, alla di cui destra è l’Arcangiol Raffaello in piedi e tobbiolo in ginocchioni, o pure l’Angiol custode, e dalla sinistra
124. Ibid., p. 331.125 Ibid.126. Ibid., p. 335.127. Ibid., p. 337. 128. Ibid.129. Ibid.130. Per la datazione di questo affresco ringrazio l’amico Roberto bartalini.
accanto al bambino due angeli, dopo a quali è il ritratto di santa Verdiana vestita coll’abito Vallombrosano antico in mezzo a due gran serpi, a una delle quali porge il cibo, e colla mano manca regge il solito panierino131.
Pure nella «chiesa abbaziale di s. Pancrazio de’ Padri Vallombrosani» presso l’altare della cappella Attavanti si poteva vedere, accanto a un affresco «che è opera di Piero cavallini», un gruppo sculto-reo realizzato in «terra cotta poco meno del naturale» da «Andrea del Verrocchio, pittore, scultore ed architetto famoso fiorentino», che rappresentava una Pietà con san Giovanni Evangelista, le Marie e i santi Giovanni Gualberto e Verdiana, quest’ultima raffigurata con l’abito dei vallombrosani132.
il badii ci segnala pure altri tre ritratti di Verdiana dislocati fuori della toscana «che vedonsi in Roma di due dei quali fa menzione particolare il Padre Magri nella sua Apologia come favorevoli al suo istituto ed opinione»133.
il primo di questi si trovava nella chiesa di s. Agostino ed era probabilmente una tavola che mostrava l’immagine di Verdiana, realizzata «infino dalla fondazione di detta chiesa [da un] pittore famosissimo» sul finire degli anni ottanta del duecento, addirittura tre decenni prima di quella che aveva realizzato Ugolino di nerio134. Purtroppo di questa testimonianza iconografica non se ne sono trovate tracce per ora. Possiamo però qui rimarcare, che l’esistenza di una immagine di Verdiana così vicina agli anni della sua morte, testimonia senza alcun dubbio la presenza di un culto tributato alla santa cellana, già nell’ultimo quarto del Xiii secolo.
la seconda raffigurazione romana, si trovava nello «spedale della Vergine Maria della conso-lazione in campo Vaccino»135. qui insieme alla «santissima effigie della gran Madre di dio» che, stando a questa testimonianza documentaria, era nella cella di Verdiana quando ella era ancora viva, si sarebbe potuto vedere una immagine su tavola della santa, posta tra le due serpi e abbigliata con l’abi-to agostiniano136. sotto questa raffigurazione vi era un «epitaffio» o «compendio della Vita della beata Verdiana» tratto dalla prima edizione, quella del 1593, del Leggendario dell’abate silvano Razzi137.
la terza immagine di Verdiana che si poteva vedere a Roma, era quella collocata nella cappella degli Attavanti nella chiesa di «san bernardino da siena in Monte bagnanapoli» tenuta da terziarie francescane138. in questo ritratto (fig. 29) Verdiana era raffigurata con indosso l’abito nero, cioè sen-za particolare riferimento a nessun ordine religioso. il cavaliere sigismondo Attavanti aveva fatto erigere la cappella in onore della santa e l’aveva dotata con l’obbligo di due messe alla settimana. sotto l’immagine di Verdiana si poteva leggere la seguente scritta: «s. Verdiana Attavanti Virgo de castro florentino insignis Religione et Miraculis illustris. Anno M (...) c»139.
Un’altra immagine di Verdiana era nella chiesa di santa caterina d’Alessandria di Pisa «nel prin-cipio di novembre del 1650 abbruciata», nella quale la santa castellana era raffigurata insieme a
131. badii-Poltri, Vita della gloriosa, p. 338.132. Ibid., p. 339.133. Ibid. 134. Ibid.135. Ibid., p. 340. 136. da approfondire, mi sembra la questione circa la tavola con l’immagine della Madonna, che secondo quanto narra il badii,
doveva essere nella cella di Verdiana. questa immagine miracolosa pare fosse una delle cosiddette ‘Madonne di san luca’, cioè una achiropiita. Ma di essa ancora oggi non si hanno testimonianze, se non nella tradizione documentaria tardo seicentesca, dopo la qua-le questa icona sembra far perdere le sue tracce, cfr. badii-Poltri, Vita della gloriosa, pp. 340-43. Per le immagini achiropiite della Madonna e in particolare per quella della Madonna dello spedale di santa Maria della consolazione a Roma cfr., bacci, Il pennello dell’Evangelista, pp. 354, 356-57, 360-61, 363, 376.
137. il badii sottolinea che nella seconda edizione della Vite del Razzi, quella del 1627, è stato aggiunto che Verdiana prese l’abito delle Agostiniane, dopo il soggiorno romano, badii-Poltri, Vita della gloriosa, pp. 340-41.
138. Ibid., p. 343.139. Ibid. l’anno non era leggibile molto bene nell’iscrizione e come tale lo dà il badii.
UnA qUestione di «hAbito» e di «oRdine»: l'iconogRAfiA di VeRdiAnA dA cAstelfioRentino 81
caterina da siena, ma con indosso un «abito solo di voto» che il badii precisa essere «differente da quello della stessa santa caterina sanese ma però conforme a quello che usano le monache di santa Marta di Milano e gli Agostiniani calabresi detti li colorati»140. la tavola era presso l’altare della famiglia guerrazzi di Pisa.
l’ultima immagine di Verdiana ricordata dal badii si trovava in fiandra e la mostrava raffigurata con l’abito di una cappuccina141.
Abbiamo visto dunque, dopo questo non piccolo catalogo delle immagini di Verdiana, che quelle che hanno avuto culto attraverso i secoli non si sono esaurite in quelle che il culto lo hanno ancora oggi. con il volgere del tempo alcune di queste immagini hanno perso la loro funzione perché o sono state trasferite in luoghi diversi da quelli per i quali erano state realizzate o sono state addirit-tura distrutte. noi sappiamo che in toscana un deciso discrimine fra culto e abbandono dello stesso sono state le disposizioni sulle immagini sacre emanate nella seconda metà del settecento dai lorena e dall’imperatore d’Austria per i territori sottoposti. Un colpo decisivo al culto di numerosissime immagini fu poi dato dalle soppressioni napoleoniche.
lo stato della situazione per Verdiana ne è un esempio, poiché proprio quegli ordini religiosi, riferiti in precedenza, si appropriarono del culto e dell’iconografia di questa santa uniformandosi a un costume, che a partire dalla fine del Xiii secolo, vide affermarsi quel fenomeno che mostrava santi appartenenti a epoche diverse o che non facevano parte di alcuna regola religiosa, entrare nelle schiere dei diversi ordini e prenderne l’abito. Un esempio tra i più noti è quello di sant’Ago-stino, il quale a partire dagli inizi del XiV secolo nell’iconografia viene mostrato con l’abito degli agostiniani sotto i paramenti vescovili. questo fenomeno però non ha permesso lo sviluppo uni-forme, almeno nell’abbigliamento, dell’iconografia della santa castellana. iconografia che doveva essere, come è stato mostrato in questo studio, quella che presentava Verdiana con abiti da laica tra i due serpenti ritti ai suoi lati, proprio come in quel frammento di affresco (fig. 2) che è nella chiesa di s. Agostino di san gimignano, databile alla metà degli anni sessanta del trecento, il quale traeva origine dalla sua primitiva iconografia. questo modello figurativo, che fu il prototi-po delle successive immagini di Verdiana e che risulta contaminato dalle ridipinture nella tavola di Ugolino di nerio, dove la santa cellana indossa l’abito delle terziarie domenicane, subì con il passare del tempo una variante. in esso Verdiana con indosso i differenti abiti religiosi di agosti-niani, francescani, vallombrosani e domenicani, era mostrata con un piccolo cestino in mano dal quale prendeva il cibo per i due striscianti aguzzini affamati, i quali, come abbiamo visto, non la abbandonarono mai.
queste varianti iconografiche non hanno favorito lo sviluppo del culto di Verdiana, il quale sareb-be stato molto più facile propagandare se a questo fosse stato associato un unico modello iconografi-co della santa. esso avrebbe permesso ai devoti, come era già accaduto per molti altri santi, di poterla immediatamente identificare in quelle immagini ‘icona’, veicolo intercessorio al quale rivolgere la memoria nella speranza di ottenere un efficace beneficio.
dunque, questa varietà di abiti nell’iconografia ha, se pure in minima parte, contribuito a che il culto per Verdiana restasse circoscritto all’ambito locale avvicinandola più a un ‘santo di paese’ che a una ‘patrona di qualche grande città’.
140. Ibid., p. 344.141. Ibid.
RAffAele ARgenziAno82