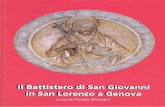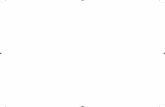Una questione tardo-antica: l'altare della Vittoria, «Esiti», 5, 1995, pp. 17-30
Transcript of Una questione tardo-antica: l'altare della Vittoria, «Esiti», 5, 1995, pp. 17-30
Francesco P. Di Teodoro
UNA QUESTIONE TARDO-ANTICA: L'ALTARE DELLA VITTORIA
L'indagine che segue muove dalla nota questione dell'altare della Vittoria perindirizzarsi, poi, verso le lettere di Sant'Ambrogio e gli scritti di Prudenzioed approdare, infine, ai testi sacri veterotestamentari non ancorasufficientemente indagati, mi sembra, sotto il profilo del «restauro» e della«tutela» o «non tutela» del costruito.43In appendice sono riportati passi significativi per la comprensione del testo.
Introduzione
Nato in ambiente giudaico e inizialmente confuso dai romani con la religioneebraica, il cristianesimo se ne era poi distaccato e distinto con sforzodottrinario e organizzativo, ponendosi di fronte all'impero romano come unnuovo problema politico-religioso. Difficile dire quali furono i gruppi socialipiù sensibili a questa nuova religione. All'inizio certamemnte i ceti più umilidi ambiente cittadino (gli abitanti delle campagne sono sempre stati i piùrestii ad ogni mutamento anche in ambito religioso) 44; poi anche esponenti
3 Si veda, tuttavia, il bel saggio: X. Leon-Dufour, La presenza nel mondo della cittàideale secondo la Bibbia, in Atti del convegno nazionale di studi su La Città Idealenella tradizione classica e biblico-cristiana, Torino 2-3-4 Maggio 1985, a cura di R.Uglione, Torino 1987, pp. 157-172.
E1 noto che il termine pagano deriva da pag«.j=villaggio i cui abitanti, i contadini,sempre stati restii ad ogni mutamento, lo furono anche nell'ambito della religionetradizionale e dei suoi riti.Per i rapporti giudaismo-cristianesimo si veda M. Simon - A. Benoit, Giudaismo ecristianesimo, Bari 1978 (1A ed. Paris 1968). Per i problemi relativi ai rapportipaganesimo-cristianesimo nonché alle più generali questioni storiche tardoantiche cfr.A.H.M. Jones, Lo sfondo sociale della lotta fra paganesimo e cristianesimo, in //
17
di ceti elevati. Certamente dovevano già essere individuati come cristianiquando furono accusati da Nerone, nel 64 d.C., dell'incendio di Roma.4-'Nerone però non attuò una persecuzione sistematica né emanò contro icristiani una legge apposita; i cristiani non erano perseguiti in quanto seguacidi una religione condannata dallo stato, ma perché considerati responsabili divari crimini.4^ Fu questa la caratteristica dei rapporti tra autorità ecristianesimo fino alla svolta rappresentata dall'editto di Decio (250 d.C.). Icristiani, per tutto il corso dei primi due secoli, furono per l'autorità unproblema di ordine pubblico, e dunque politico, prima che religioso (bisognaricordare che Roma era sempre stata tollerante verso le religioni).Illuminante a tal riguardo è la famosa lettera scritta dal governatore dellaBitinia, Plinio il Giovane, all'imperatore Traiano (110 d.C.) in cui sichiedono istruzioni su come comportarsi nei confronti dei cristiani, semprepiù causa di scompiglio dell'ordine pubblico. Traiano risponde e stabiliscecome norma che i cristiani non dovessero essere perseguiti in quanto tali, o inbase a denunce anonime, ma solo se i delitti specifici dei quali erano accusatifossero stati provati; soprattutto non dovevano essere inquisiti a priori. 'Tale norma divenne una prassi presso i successori e isolate furono lemanifestazioni di violenza. Con Decio (249-251) la politica religiosa verso laChiesa ebbe una svolta: per la prima volta si stabilì inequivocabilmente laperseguibilità dei cristiani. Con un editto egli impose a tutti i sudditidell'impero di sacrificare nei modi dovuti all'imperatore e di farsi in tal modorilasciare dalle autorità un certificato (libellum) attestante l'atto formalecompiuto. Sotto questo profilo, l'azione di Decio rappresenta un momentoessenziale dei rapporti tra impero e cristianesimo. L'editto riguardava tutte lefedi religiose, ma è evidente che colpiva i cristiani in modo particolare e li
conflitto tra paganesimo e cristianesimo nel secolo IV, a cura di A. Momigliano,Torino 1968 (1A ed. London 1963), pp. 21-44; P. Brown, // mondo tardo antico. DaMarco Aurelio a Maometto, Torino 1974 (1A ed. London 1971); G. Clemente, Guidaalla storia romana, Milano 1977; P. Siniscalco, // cammino di Cristo nell'imperoromano, Bari 1983; M. Sordi, // cristianesimo e Roma, Bologna 1965; Id., I cristiani el'impero romano, Milano 1983.45 Come noto l'incendio di Roma dette luogo ad una nuova organizzazione deglispazi urbani. Per l'urbanistica in età neroniana cfr. Svetonio, De vita Caesarum, LibroVI.46 Marta Sordi (// cristianesimo..., cit, pp. 81-82) ritiene, invece, che, nonostantel'eterogeneità delle accuse, i cristiani venissero condannati per l'adesione ad unareligione che lo Stato non aveva riconosciuto, ad una superstitio illicita. Exitiabilissuperstitio l'aveva detta Tacito; superstitio nova et malefica la chiamò Svetonio esuperstitio prava, immodica la disse Plinio.
Cfr. C. Plini Caccili Secundi, Epistularum libri decem, Recognovit breviqueadnotatione critica instruxit R.A.B. Mynors, Oxonii 1985 (1A ed. 1963), X.xcvi;X.xcvii.
18
coinvolgeva per la prima volta collettivamente.Il periodo successivo, e fino ai primi anni del IV secolo, fu segnato da ungrave momento di persecuzione sotto il regno di Valeriano (253-260). Questivolle colpire la gerarchia ecclesiastica con l'ordine di partecipare ai riti delculto ufficiale, mirò alla disgregazione delle comunità cristiane proibendo ditenere assemblee e addirittura di entrare nei cimiteri, luoghi in cui spesso ifedeli si riunivano. Per la prima volta furono presi di mira anche i cristianiappartenenti ai ceti dirigenti e facoltosi della società (si parla di senatori, diegregii viri, di cavalieri).Con il successore di Valeriano, Gallieno, inizia un periodo di pace tra imperoe comunità cristiane destinato a durare per oltre quarantanni, fino all'ultimagrande persecuzione dioclezianea.Diocleziano (284-305) attuò una persecuzione sistematica contro i cristianiemanando ben quattro editti dal 303 al 304. Egli, legato ad una visionerestauratrice dello stato, con lo sguardo volto al passato intendeva eliminaredel tutto il fenomeno cristiano in una visione ormai astorica del problema.Con tali editti Diocleziano proibiva il culto cristiano, ordinava il sequestrodei libri e degli oggetti sacri, imponeva la distruzione degli edifici destinati alservizio divino48, impediva ai cristiani di intentare azioni giudiziarie,ingiungeva che tutti i responsabili della chiesa fossero imprigionati e costrettia sacrificare con ogni mezzo. Nel quarto editto arrivava a colpire l'interaplebs Dei prescrivendo a tutti di offrire sacrifici agli dei sotto pena di morte.Queste disposizioni rimasero in vigore fino al 311, ma la persecuzione siattuò solo in Oriente; in Occidente si estinse dopo pochi anni. Fu appuntocon l'imperatore Galerio nel 311 che venne redatto l'editto che pose fine auna lunga fase repressiva e costituì l'inizio di una svolta che porterà ilcristianesimo ad essere riconosciuto come religione ufficiale dell'impero. Siconcesse ai cristiani di potere di nuovo esistere e di ritrovarsi4^ nei loro
48Relativamente alla nascita degli schemi strutturali dedicati al culto cristiano si
veda S. Bellini, Lo spazio architettonico da Roma a Bisanzio, Bari 1978 (inparticolare il cap. VI: Spazio bizantino e tradizione basilicale); per le questioni menospecifiche cfr. invece: J.B. Ward-Perkins, Architettura romana, Milano 1974; R.Kraulheimer, Early Christian and Byzantine Architecture, Harmondsworlh 1965 (ed.it. Torino 1986); A. Choisy, L'Art de batir chez les romains, Paris 1873; J.P. Adam,La construction romaine. Materiaux et techniques, Paris 1984 (ed. it., Milano 1988).4" II testo dell'editto riportato in Latlanzio, De mortibus persecutorum, così recila alai proposilo: «[...] ut denuo sint christiani et conventicula sua componant», laddovecon conventicula si intendono comunità cristiane minori e ciò spiega l'uso del verbocomponere nel senso di riunire. Eusebio, altra fonte dell'editto, nella sua Historiaecclesiastica, traduce in greco: hai tus òikus en ois synègonto synthòsin dove tus òikussignifica edifici e synthòsin è inteso come ricostruire. Per le due interpretazioni sivedano: P. Siniscalco, op.cit,, p. 161; J. Moreau, Lactance, Paris 1941, in Sourceschrétiennes, 39 (vengono forniti il testo latino e la traduzione francese del De
19
luoghi di riunione a patto che nulla compissero contro l'ordine pubblico epregassero il loro Dio per la salute degli imperatori, della res publica e loropropria, per poter vivere senza timore presso i loro focolari. Tale edittocontiene elementi di notevole interesse non solo perché abroga ledisposizioni dioclezianee, ma anche perché richiama quelli che erano stati itermini di base dello scontro originario tra res publica e chiesa.Nel 313 Costantino e Licinio promulgarono il famoso editto di Milano colquale si concesse ai cristiani piena libertà di seguire la propria religione(importante, ai nostri fini, è che si stabilì che tornassero di proprietà deicristiani quegli edifici dove in precedenza eran soliti riunirsi, sia che fosserostati incamerati dal fisco imperiale o acquistati da privati).Infine il cristianesimo verrà riconosciuto come unica religione dell'impero daTeodosio il Grande nel 391 proibendo ogni forma di culto esteriore pagano eordinando la chiusura dei templi.^0
Gli antefatti
Prima, però, di poter scendere nei particolari dell'indagine è necessarioancora dire degli antefatti.^'Subito dopo la battaglia di Azio — 31 a.C., data che, in campo storico-
mortibus...,cil.). La questione è dibattuta in M. Sordi, // cristianesimo...cit., p. 367. Iltesto di Eusebio, curato da Bardy, è pubblicato nella stessa collezione di Sourcesprecedentemente citata (31, 41, 55, 73); una traduzione italiana è stata condotta daDel Ton (Firenze 1943).^" In realtà il paganesimo ebbe ancora lunga vita. Lo dimostra, ad esempio, anchel'art. CVIII dell'Edictum Theodorici Regis che così recita: «Si quis pagano rifusacrificare fuerit deprehensus, arioli etiam atque umbrarii, si reperti fuerint, subiusta aestimatione convicti, capite puniantur; malarum artium consci!, id est malefìci,nudati rebus omnibus, quas habere possunt, honesti perpetuo damnantur exilio,humiliores capite puniendi sunt». Cfr.: Fontes luris Romani Antejustiniani, Parsaltera, Auctores edidit notisque illustravi! J. Baviera, Libri Syro-Romaniinterpretationem a C. Ferrini confectam, castigavit iterum edidit novis adnotationibusinstruxit J. Furlani, Florentiae 1968, pp. 683-710:703.
Traggo le notizie che seguono dalla classica edizione de «Les Belles Lettres»:Prudence, Psychomachie. Cantre Symmaque, Texte établi et traduit par M.Lavarenne, Paris 1963 (1A ed. 1948). In seguito si farà sempre riferimento a questotesto, oltre che per la Cantra Symmachum, anche per la Symmachi relatio e leAmbrosii Epistolare. Ma si veda anche (con bibliografia precedente) la recentissimaSimmaco-Ambrogio, L'altare della Vittoria, a cura di F. Canfora, con una nota di L.Canfora, Palermo 1991 («La città antica», 6). La relatio di Simmaco è alle pp. 140-159, le due epistolae di Ambrogio alle pp. 166-183, 192-227.
20
artistico, per consuetudine si pone come fine dell'ellenismo — Augustoaveva fatto collocare nella Curia la statua della Vittoria già presa aiTarantini.^^ Ai piedi della statua venne eretto un altare. Ogni senatore,entrando, vi faceva bruciare dei grani di incenso. La dea presiedeva alledeliberazioni del Senato. Verso di lei si tendevano le mani, giurando fedeltàad ogni nuovo imperatore e ogni 3 gennaio quando si facevano voti solenniper la salus dell'imperatore e la prosperità dell'impero.Nel 357 Costanze fece rimuovere l'altare dalla Curia, ma quasiimmediatamente vi fu ricollocato, non appena l'imperatore ebbe lasciatoRoma per Costantinopoli, per cura della maggioranza pagana del Senato e,successivamente, per ordine di Giuliano l'Apostata.Nel 382 Graziano, energico oppositore di ogni tendenza pagana, disposenuovamente la rimozione dell'altare decretando, allo stesso tempo, lasoppressione dei privilegi dei sacerdoti pagani e delle vestali, la confiscadelle terre possedute dai templi e dai collegi sacerdotali, la ripartizione tratesoro pubblico e cassa del prefetto del pretorio del denaro una voltadestinato alla celebrazione delle feste religiose pagane, la perditadell'esenzione dalle imposte da parte dei sacerdoti pagani.A seguito di ciò i senatori pagani inviarono a Milano una deputazionepresieduta da Simmaco, perché perorasse presso l'imperatore affinchè l'altarevenisse ricollocato al proprio luogo. Il vescovo Ambrogio, però, fece intempo a mostrare all'imperatore una dichiarazione (fattagli pervenire da papaDamaso) di senatori cristiani che si dissociavano dai colleghi pagani di modoche Graziano rifiutò di ricevere Simmaco.Nel 382 Graziano fu assassinato a Lione ed in suo luogo fu nominato ilfratellino dodicenne, Valentiniano IL Teodosio, che Graziano si eraassociato all'impero attribuendogli l'Oriente, si riservò, però, in pratica, ognifunzione tutoria.Simmaco, nel frattempo divenuto prefetto di Roma, credette di dover tornarealla carica pensando di potere cavalcare la tigre della giovane età del nuovoregnante e della violenta carestia che, nel frattempo, aveva colpito l'Italia, laSpagna e la Gallia.Questa volta il vecchio senatore, ottimo retore, ottene di poter leggere unarelatio davanti all'imperatore ed ai suoi consiglieri. Ambrogio, però, inviòuna energica prima lettera al giovane imperatore minacciandolo, nel caso incui avesse accolto le istanze dei pagani, di non più accoglierlo in chiesa. Unaseconda lettera inviò il vescovo di Milano nella quale, dettagliatamente,criticava i contenuti della relatio.Alle tre affermazioni fondamentali del rapporto di Simmaco — 1) Romareclama i suoi antichi dei perché le hanno donato l'impero del mondo; 2)bisogna rendere ai sacerdoti ed alle vestali il loro trattamento e le loro
52Cfr. Dione Cassio, Romaikè historìa, LI, 22, 1-2.
21
immunità fiscali; 3) la carestia è segno dell'irritazione degli dei — Ambrogiocontrappose, con perentorietà che: a) Roma doveva la sua grandezza alvalore dei suoi soldati; b) le vergini ed i sacerdoti cristiani non godevano ditrattamenti di favore; e) la carestia era un fenomeno naturale e frequente.Inoltre, faceva osservare che soltanto una persecuzione avrebbe potutoobbligare i senatori cristiani ad assistere ai sacrifici che i colleghi paganiavrebbero offerto alla Vittoria. L'ovvia conseguenza fu che i pagani nonottennero alcuna concessione.
Tutela ?
La scelta del soggetto è quanto mai significativa perché gli avvenimenti sicollocano in anni particolarmente cruciali: a poco meno di dieci anni didistanza Teodosio avrebbe proclamato il cristianesimo unica religione distato ed avrebbe decretato la chiusura dei templi pagani. Inoltre, la posizioneassunta dagli esponenti più influenti della comunità cristiana d'allora (partedel Senato, il papa Damaso, il vescovo Ambrogio), colpendo un simbolo,l'altare posto nel luogo più sacro alla storia civile romana, si configura comeprimo atto ufficiale nei riguardi del patrimonio artistico individuabile come«pagano». Posizione, peraltro, intransigente, mai aperta a soluzioni dicompromesso, ma decisamente orientata verso un exitus di non tutela. Lamotivazione di tale atteggiamento verrà precisata nell'indagine che segue.Nonostante la commossa partecipazione nel leggere l'accorata, appassionatae malinconica preghiera costituente l'ultima difesa del paganesimo recitata daSimmaco in nome della tradizionale tolleranza romana («Ergo diis patriis,diis indigetibus pacem rogamus. Aequum est, quidquid omnes colunt, unumputari. Eadem spectamus astra, commune caelum est, idem nos mundusinvolvit: quid interest, quia quisque prudentia veruni requirat? Uno itinerenon potest pervenir! ad tam grande secretum.»), è opportuno rivolgerel'attenzione al pesante intervento di Sani'Ambrogio nella questione. Le sueaffermazioni e, successivamente, quelle di Prudenzio, che riprenderàl'argomento circa l'anno 402 o 403 (forse a seguito di un'ulteriorericollocazione dell'altare della Vittoria nella Curia nel 400), mi sembra chepossano dar ragione degli avvenimenti e di quegli anni e di quelli successivi.Mi riferisco all'iconoclastia feroce attuata dai cristiani alla fine del IV secolo,alla distruzione dei templi ed alla dispersione di arredi, statue e suppellettilitemplari nei secoli che immediatamente seguirono.Ambrogio inizia con un'affermazione che non ammette repliche: quello deicristiani è il solo vero Dio, sono demoni le divinità pagane:
«ipse enim solus verus est Deus, qui intima mente
22
veneretur: 'Dii enim gentium daemonia', sicutScriptura dicit.(Psal.XCV, 5)» (Amb., XVII, 1)
Mentre i pagani adorano oggetti creati da artefici, il Dio cristiano non vuoleessere adorato nella pietra:
«Vos manum vestrarum adoratis opera, nos iniuriamducimus omne quod fieri potest Deum putari. Nonvult se Deus in lapidibus coli.» (Amb., XVIII, 8)
«vestrum enim Deum lignum putatis» (Amb., XVIII, 9)
Un antico rancore, forse, fa dire ancora ad Ambrogio: «Et de dispendisqueruntur, qui numquam nostro sanguini pepercerunt, qui ipsa Ecclesiarumaedificia subruerunt», con probabile riferimento alle distruzioni perpetratenegli anni degli editti di Diocleziano a danno dei luoghi di culto cristiani.Prudenzio, che conclude il ciclo relativo all'altare della Vittoria, forte dellaposizione definitivamente di potere assunta dai cristiani dopo il 391,abbandonando ogni pudore consiglia a Simmaco ed ai senatori suoi alleati,ormai minoranza, di farsi da parte («infirma minoris / Vox cedat numeri,parvaque in parte silescat.»)-^, mentre riconosce come negativa la tradizioneletteraria e figurativa pagana:
«Sic unum sectantur iter, sic inania rerumSomnia concipiunt et Homerus et acer ApellesEt Numa, cognatumque volunt pigmenta, camenae,Idola: convaluit fallendi trina potestas.»(II, 45-48)
«Desine, si pudor est, gentilis ineptia, tandemRes incorporeas simulatis fingere membris»(II, 57-58 )
Solamente un uso corretto delle immagini, private cioè del valore sacrale chele distingueva, avrebbe potuto salvarle dalla distruzione. Ai tempi diPrudenzio lo zelo distruttivo era così cieco da obbligare (già nel 399)l'imperatore Onorio a pubblicare un editto che prescriveva di rispettare gliornamenti degli edifici pubblici.^
53Cfr. Prudence, Psychomachie...c\t., I, 606-607.Cfr. Cod. Theod., XVI, 10, 15. Per le questioni attinenti ai rapporti tra edifici e
legislazione in età tardo-antica si veda D. De Bernardi Ferrerò, Edilizia e legislazione:edifìci pagani, edifici cristiani, in Esperienze di storia dell'architettura e di restauro,I, Roma 1987, pp. 31-39.L'atteggiamento di Prudenzio nei riguardi delle opere d'arte è, tuttavia, degno di nota.
23
Prudenzio scriveva, difatti:
«Deponas iam festa velini puerilia, ritusRidiculos, tantoque indigna sacraria regno.Marmerà tabenti respergine tincta lavate,O proceres! Liceat statuas consistere puras,Artificum magnorum opera; haec pulcherrima nostraeOrnamenta fiant patriae, nec decolor ususIn vitium versae monumenta coinquinet artis.»(I, 499-505 )
Ma, nonostante che:
«[...] Caementa remino,Et quae saxa Paros secat, et quae Punica rupis,Quae viridis Lacedaemon habet maculosaque Synna.Nativum nemo scopuli mihi dedicet ostrum,Templum mentis amo, non marmoris; aurea in ilioFundamenta manent fidei, structura nivaliConsurgit pietate nitens, tegit ardua culmenlustitia, interius spargit sola pietà rubentiFlore pudicitiae pudor almus et atria servat.Haec domus apta mihi est, haec me pulcherrima sedesAccipit, aeterno caelestique hospite digna.»(II, 245-255)
la questione si poneva, ormai, anche come problema attinente allacostruzione di veri e propri edifici.55
II cristiano si era sostituito al vero civis romanus attribuendosi persine lasalvaguardia della tradizione. Mi riferisco anche a quel particolareatteggiamento, caratteristico del romano soprattutto del periodorepubblicano, di «cattiva coscienza»56 nei riguardi dell'arte e dellediscussioni artistiche. L'affermazione di Prudenzio (II, 45-48) o il nescioquis proferito da Sant'Agostino nei confronti di Virgilio57 si pongono nella
Egli, difatti riconosce loro un valore intrinseco che nulla ha a che vedere con lesovrastrutture metafisiche di cui molte erano cariche. E' un fatto, però, che spesso èproprio l'oggetto di venerazione ad essere maggiormente tutelato; non per nulla solol'aver dedicato il Pantheon alla Vergine nel 609 ne ha impedito la distruzione.55 Edifici erano stati costruiti, proprio per l'uso cristiano, anche nei secoli precedenti,come appare chiaro anche dall'affermazione di Ambrogio (XVII, 4) e dagli editti diDiocleziano del 303 e 304.56 E' la definizione data in R. Bianchi Bandinelli, Roma. L'arte romana nel centro delpotere, Milano 1969 (ed. 1978, p.43).57 Cfr. S. Agostino, La città di Dio, Traduzione di C. Borgogno, Introduzione e
24
stessa direttrice di giudizio che condusse Cicerone ad impiegare taluneespressioni durante l'arringa contro Verre.L'oratore romano, difatti, ricorrendo ad un espediente da leguleio, si fecesuggerire dall'assistente il nome del grande Policleto, autore di alcune operetrafugate da Verre in Sicilia: «ecco, giustamente mi vien suggerito: dicevanoche fosse Policleto».58
Non appena il potere è sicuro, la posizione del cristiano migra dallasituazione di perseguitato a quella di persecutore, volgendosi ad unatteggiamento di intolleranza tipico delle religioni monoteiste.E' a questo punto che, al di là di ogni legge promulgata dagli imperatori,diviene più forte il richiamo della Legge. Mi sembra, infatti, (e questogiustificherebbe il comportamento dei cristiani dalla fine del IV secolo in poinei riguardi anche degli edifici sacri pagani), che la situazione venutasi acreare, dopo il 391, all'interno di quello che era stato il grande impero diRoma, fosse sostanzialmente la stessa che si era presentata al popolod'Israele durante la conquista della Terra Promessa.Leggiamo, difatti, nel Deuteronomio:
«Abolirete completamente tutti i luoghi nei quali quelle nazioni a cui voitoglierete il possesso, hanno adorato i loro dei, sopra i monti, sopra i colli, osotto ogni albero frondoso. Abbattete i loro altari, spezzate i loro cippi,incendiate i loro pali sacri, fate a pezzi i simulacri dei loro dei, cancellate illoro nome da quel luogo» ( 12,2).
Ed anche:
«Se tu sentirai dire che in una delle tue città, che il Signore, Iddio tuo, ti dain possesso per abitarvi, degli uomini perversi sono usciti di mezzo a te ehanno sedotto gli abitanti della loro città, dicendo: 'Andiamo, serviamo altridei', che voi non avete mai conosciuti, prima informati, investiga e interrogacon cura, poi se trovi che la cosa è vera, il fatto è certo e tale abominazione èstata realmente commessa in mezzo a te, metti senz'altro a fil di spada gliabitanti di quella città, vota la città stessa alla distruzione, con tutto quelloche contiene, compreso il bestiame. Fatto questo, raduna tutte le spoglie inmezzo alla pubblica piazza, poi appicca il fuoco alla città con tutte le suespoglie, sì che bruci completamente per il Signore Iddio tuo, e diventi uncumulo di rovine in perpetuo, né venga più riedificata.» (13, 13-17).
revisione di A. Landi, Roma 1973. Virgilio è più volte citato; cfr. ad vocem.co
Cicerone, Contro Verrem.
25
Le ultime parole del testo sacro suggeriscono una indagine ricca di promessee suggestioni nella direzione della tutela/non tutela secondo la tradizionebiblica. Per intanto offro in nota un primo elenco, per necessità sommario edincompleto, di passi pertinenti delle Sacre Scritture.59
Concludo, però, con un primo significativo passo, riguardante la non tutela,tratto dal libro di Giosuè e relativo alla distruzione delle mura di Gerico:
«Fu allora che Giosuè pronunciò quest'imprecazione: 'Sia maledetto dalSignore colui che si metterà a riedificare questa città di Gerico: sul suoprimogenito ne getti le fondamenta, e sul suo ultimogenito ne innalzi leporte'» (Giosuè, 6, 26).
Appendice
Prima lettera di Sant'Ambrogio(Ambrosii Epistola XVII)
1 - «[...] nessuno può assicurare la propria salvezza se non adorandosinceramente il vero Dio, cioè il Dio dei cristiani che governa tutte le cose. Èlui, infatti, che è l'unico, vero Dio, degno di essere venerato dal profondo delcuore. Giacché 'gli dei delle nazioni non sono che demoni' come dice laScrittura (Salmo 95,5)» (XVII, 1).
2 - «D'altronde, vengono loro a lamentarsi delle loro perdite, loro che nonhanno mai risparmiato il nostro sangue ed hanno abbattuto le nostre chiese?»(XVII, 4).
3 - «Se oggi un imperatore pagano — Dio non voglia! — innalzasse unaltare agli idoli e obbligasse i cristiani a recarvisi per assistere ai sacrifici, pervedere e respirare la cenere dell'altare, la brace del sacrilegio, il fumo delrogo; se questi formulasse il proprio parere in questa curia dove i cristiani
59 Deuteronomio: 12,2-7; 13,13-17; 27,15; Giosuè: 6,26; / Re: 16,34; II Re: 12,5 16'22,3-7; 23,5-20; 25,8-9; 25,13-17; // Cronache: 24,4-14; 20,9; 32,5; 32,13-15; 34,8-11; 36,19; Esdra: 1,9; 3,6-13; 4,11-16; 5; 6 (in part.6,12); Neemia: 1,3; 2,5; 7,8; 2,13-16; 2,17; 2,19-20; 3,1-32; 3,37; 4,4; 6,15; 12,27; Tobia: 14,4-5; Giuditta: 1,13-15; 3,8;4,1-3; 4,12; 5,18; I Maccabei: 1,31-33; 2,45; 3,35; 3,58-59; 4,36-61; 5,1; 5,4-5; 5,28-36; 5,44; 5,51; 5,65-68; 6,7; 6,12; 6,62; 8,10; 9,50-52; 9,54; 10,10-11; 10,44-45'10,84; 11,4; 11,48; 12,35-38; 13,10; 13,33; 13,43-52; 14,7; 14,15; 14,33-34; 14,37;16,23; II Maccabei: 1,8; 1,33-34; 6,1-5; 8,3; 8,33; 9,16; 10,1-8; 14,33-36; 15, 17-18-Salmi: 9-10(9), 6-7; 48(47), 1-15.
26
sarebbero costretti a prestar giuramento all'altare dell'idolo prima diesprimere il loro parere (l'altare — si spiega infatti — è stato allestito perporre ogni seduta in cui si delibera sull'interesse generale sotto la garanzia —secondo quel che affermano — del giuramento prestato su di esso; giacchéormai la curia si riempie di un numero ben più grande di cristiani), ilcristiano la considererebbe una persecuzione. Ora, tale costrizione èfrequente; talvolta è anche molestandoli che si obbligano i Senatori a venirealle sedute. Sotto il vostro regno i cristiani saranno dunque costretti a prestargiuramento su un altare pagano? Che cos'è prestar giuramento se nonriconoscere la potenza divina di colui che si prende a testimone della propriabuona fede? È sotto il vostro regno che si chiedono, che si reclamano talimisure: far innalzare un altare, sovvenzionare sacrifici profani!» (XVII, 9).
4 - «Cosa risponderete al sacerdote che vi dirà: 'la chiesa non cerca i vostridoni, poiché voi avete ornato di doni i templi dei pagani'. L'altare del Cristorifiuta i vostri doni, poiché avete innalzato un altare agli idoli; giacché lavostra voce, la vostra mano, la vostra firma sono opera vostra. Il SignoreGesù rifiuta e respinge la vostra obbedienza, poiché voi avete obbedito agliidoli. Infatti egli vi ha detto: 'Non potete servire due padroni allo stessotempo' (Matteo, 6, 24). [...]» (XVII, 14).
Seconda lettera di Sant'Ambrogio(Ambrosii Epistola XVIII)
5 - «Voi chiedete agli imperatori la pace per i vostri dei, noi chiediamo alCristo la pace per gli imperatori stessi. Voi adorate l'opera delle vostre mani,noi riteniamo illecito considerare come dio tutto ciò che si può fabbricare.Dio non vuole essere adorato nelle pietre.» (XVIII, 8).
6 - «voi considerate un oggetto di legno come il vostro Dio» (XVIII, 9).
7 - «Ma bisogna — dice Simmaco — rendere gli altari agli idoli, gliornamenti ai templi. [...] Un imperatore pagano ha mai innalzato un altare alCristo?» (XVIII, 10).
PRUDENZIO, Contra Symmachum.
1 - «Una volta che la vana superstizione ebbe invaso i cuori pagani dei nostripadri, si propagò senza interruzione attraverso la successione degli anni. Ilgiovane erede adorò tremante tutto ciò che i suoi avi dai capelli canuti gliavevano insegnato a venerare; il bambino bevve l'errore col primo latte; egli
27
aveva gustato, quando ancora vagiva, la farina dei sacrifici, aveva visto lestatue spalmate di cera, ed i Lari tutti neri, umidi d'olio profumato; quand'erapiccino, aveva visto vicino a lui una pietra sacra che rappresentava la Fortunacol suo corno dell'abbondanza e sua madre che pregava davanti, pallida. Benpresto, nelle braccia della nutrice, sfiorò la statua coi baci, le confidò le suepuerili preghiere, sollecitò favori dalla pietra cieca ed ebbe la convinzioneche era a lei che bisognasse chiedere ciò che si desiderava. Mai egli levò gliocchi o l'anima verso la sede celeste della Ragione; nella sua credulitàconservò pratiche insipide, offrendo ai suoi dei familiari, per onorarli, ilsangue degli agnelli. Poi, uscendo di casa, ammirò i giorni delle festepubbliche ed i giochi, vide l'alto Campidoglio, i sacerdoti, la fronte cintad'alloro, eretti nei templi degli dei e la Via Sacra ripiena di muggiti davantial santuario di Roma: perché Roma stessa ricevette un culto sanguinoso, allamaniera di una dea; il nome di un luogo è trattato come un dio, i templi dellaCittà e di Venere si innalzano coi fastigi ad uguale altezza, l'incenso bruciaallo stesso tempo per queste due dee. Allora, credendo vero tutto ciò che si facon l'autorità del Senato, dette la sua fede agli idoli e considerò padroni delciclo questa razza di ritratti dai visi orribili. Qui Alcide, ospite dell'Arcadiadopo aver depredato Gades, si erge rigido nel bronzo fulvo; poi i duegemelli, bastardi d'una madre impura, figli di Leda, cavalieri notturni, deidella grande Roma, stanno appesi, sostenuti dalle loro lance, e fissano nelpiombo fuso sotto di loro quei passi che annunciarono un grande trionfo.Ecco ancora le statue degli antichi re: Tros, Italo, Giano bifronte, il padreSabino, il vecchio Saturno e Fico dal corpo maculato, nelle membra del quales'è sparso il veleno che la sua sposa gli ha somministrato. Davanti ai piedi diognuno è posto un piccolo antico altare. Ancora si offrono a Giano, quandoarriva un mese famoso, festini sacri osservando i presagi: ciò si affannano afare con inveterato omaggio (ah! miseri!) e lo si festeggia gioiosamente ogniprimo del mese. È così che è divenuta grande una religione disgraziatamenteun giorno introdotta dagli antenati, poi trasmessa alle età successive esviluppata dai tardi nipoti; i cuori stolti trascinarono una lunga catena ed uncostume tenebroso si è sparso nei secoli perversi» (I, 197-244).
2 - «Non conviene, o regina, che tu contempli ad occhi bassi la terra caduca,che tu cerchi la divinità nelle regioni infime delle cose alle quali tu stessa seisuperiore. Non sopporterò che tu conservi sotto il mio regno vecchiesciocchezze, che tu adori mostri di dei tarlati. Se sono pietre la vetustà ledissolve, oppure una debole scossa le fa spaccare; se una sottile foglia d'ororiveste il gesso, essa si scolla a poco a poco e si sfalda; se è a delle placche dimetallo che lo sfregamento della lima ha confidato la forma della statua, o lecave membra s'incurvano da un lato sotto il loro peso, oppure la morsuradella ruggine attacca, rode la statua e la fora di numerosi buchi.» (I, 430-441).
28
3 - «Vorrei che tu abbandonassi ormai le feste puerili, i riti ridicoli, i sacrificiindegni d'un sì grande impero. Lavate, signori, questi marmi tinti di schizziinfetti. Permettiamo alle statue, opere di grandi artisti, di innalzarsi pure; cheesse diventino bellissimi ornamenti della nostra patria; ma che un malvagiouso non contamini più, non asservisca al male i monumenti d'arte.» (I, 499-505)
4 - «Perché ricordare nei miei versi che i Gracchi, amici del popolo, chedetenevano il potere, che avevano un posto eminente in Senato, ordinaronodi svellere le immagini degli dei, e si posero umilmente coi loro littori sottol'autorità di Cristo onnipotente?» (I, 561-565).
5 - «Se tutto ciò manca a quelli che combattono, una Vittoria d'oro potràpure, in un tempio di marmo, dispiegare le sue ali risplendenti e drizzare ilsuo corpo fatto di materia preziosa, ma ella non verrà , si mostrerà ostile, saràla disfatta. Perché, soldato, diffidi delle tue forze e t'aspetti il vano soccorsodi una figura di donna? Mai una legione bardata di ferro vide una fanciullaalata che indirizzasse il dardo degli uomini ansimanti. Tu cerchi la signoradelle vittorie? E' per ciascuno la propria mano e Dio onnipotente. Non è unafemmina dai capelli ben pettinati, che si tiene in equilibrio sul piede nudo, ilpetto sostenuto da un corsetto, la veste fluttuante sui seni turgidi. O la manodei pittori, rappresentando esseri fantastici come ne scrivono i poeti, vi hainsegnato ad inventare le divinità; oppure è al vostro culto che l'amabiledipinto ha improntato i concetti ai quali ha dato forma, che ha reso con lineevariate rivestite di cera liquida, e che alla maniera di sua sorella, la poesia, haosato, facendosene burla, ornare di colori sfumati. E così che seguono lostesso cammino, è così che immaginano vane chimere Omero, l'ardenteApelle e Numa, e vogliono parentela i pennelli, le Muse e gli idoli: si èrinforzata una triplice potenza di menzogna. Se non è così, ditemi: perché lefavole poetiche vi propongono riti che provengono dai quadri o dagli scritti?Perché il sacerdote del Berecinto perde la sua virilità mutilata, quando lapoesia ha castrato il bell'Attis? Perché dunque i cavalli dagli zoccoli di cornosono scartati dal tempio di Trivia e dai suoi boschi sacri, quando la Musa hacantato il casto fanciullo trascinato sulla riva dal suo carro veloce, e che unaffresco dai molti colori vi rappresenta la stessa scena? Si cessi, dunque, sec'è pudore, di rappresentare sciocchezze da pagani, con corpi raffiguranticose immateriali; [...]» (II, 27-58).
6 - «Credimi, ciò che ho creato dal nulla, non è una parte di me. Così forza,mortale, non innalzare templi che a me solo e non adorare come dio che mesolo. Ti dispenso dal cemento e dalle pietre che si tagliano a Paro, o nellarocca punica, dalle pietre verdi di Sparta, o dalle pietre chiazzate di Sinnade.Nessuno mi consacri la porpora naturale della pietra. È un tempio dello
29
spirito ch'io amo, e non di marmo. Questo poggia sulle fondamenta d'orodella fede, la bianchezza della neve della pietà ne costituisce la muraturasplendente, la giustizia sublime ne copre il fastigio, nell'interno il suolo ècosparso di dipinti che vi forma, coi fiori rosseggiami della castità, il dolcepudore, guardiano vigile dell'ingresso. Ecco la dimora che mi conviene, eccola sede magnifica, degna d'un ospite eterno e celeste, che mi accoglie.» (II,243-255).
7 - «[...] non vede, Augusto, che siamo, tu ed io, consacrati a Dio, in onoredel quale abbiamo chiuso i templi sordidi ed abbiamo distrutto gli altariumidi di sangue corrotto. Che il Cristo solo governi e preservi il nostropalazzo; che nessun demone conosca più la cittadella di Romolo; che la miacorte non serva che il solo Signore della Pace.» (II, 763-768)
30
Carlo Tosco
LA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI ANTICHIE LA CRISI DELL'IMPERO
I. Premessa storica: romani e germani al tramonto dell'impero
E' difficile ricostruire oggi le conseguenze che la crisi dell'Impero Romano ele invasioni germaniche ebbero sui monumenti antichi. Risulta comunquechiara la necessità di superare una visione storiografica ereditata dal secoloscorso, secondo la quale le distruzioni provocate dai barbari furonoincalcolabili, dovute all'ignoranza e alla ferocia dei conquistatori. In realtà laricerca più moderna ha tentato di riconoscere la continuità delle istituzioniromane all'interno del dominio dei popoli germanici, identificando i restiancora attivi ed efficaci dell'apparato amministrativo imperiale per tutto il Ve il VI secolo, almeno in Italia.^ Le fonti antiche non sono particolarmenteesplicative in proposito, e l'analisi del fenomeno del progressivo degrado delpatrimonio architettonico antico non risulta agevole per lo storico. E'rmrjortante pero' stabilire fin dall'inizio la distinzione tra un degradoordinario, dovuto alla mancanza di manutenzione progressiva delle strutture,e un degrado traumatico, riferibile alla_distruzipne violenta^degli edifici, perazioni militari o vandaliche da~parte dei nuovi conquistatori. Soltanto
60Sulla posizione della storiografia contemporanea riguardo a questi problemi
rimandiamo ai lavori generali di G. Romano, A. Solmi, Le dominazioni barbariche inItalia (395-880), Milano 1940; S. Mazzarino, Aspetti sociali del IV secolo, Roma1951, pp. 271-344; M. Rostovzev, Storia economica e sociale dell'Impero Romano,Firenze 1953, pp. 151-228; E. Stein, Histoire du Bas-Empire, Bruges 1959, voi. I; G.Pepe, // Medio Evo barbarico d'Italia, Torino 1959; A. H. M. Jones, The LaterRoman Empire, Oxford 1964; R. S. Lopez, La nascita dell'Europa, Torino 1966, pp.9-68; G. Falco, La Santa Romana Repubblica, Milano 1954, pp. 17-77; il volume diautori vari I goti in Occidente (III Settimana di studio del Centro Italiano di Studisull'Alto Medioevo), Spoleto 1956; G. Tabacco, Egemonie sociali e strutture dipotere nel medievo italiano, Torino 1974, pp. 49-92.
31