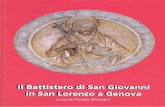Adolf Wilhelm, Louis Robert e una presunta eco cretese della polemica sull'altare della Vittoria
Transcript of Adolf Wilhelm, Louis Robert e una presunta eco cretese della polemica sull'altare della Vittoria
Rend. Mor. Acc. Linceis. 9, v. 24: 237-256 (2013)
ADOLF WILHELM, LOUIS ROBERT E UNA PRESUNTA ECO CRETESE DELLA POLEMICA SULL’ALTARE DELLA VITTORIA(*)
Nota di Ignazio Tantillopresentata(**) dal Socio Corrispondente A. Giardina
Abstract. – A statue base found in Olus (Crete) at the end of the XIXth century bears two texts engraved on opposite sides, one in verses and the other in prose. Since the first editor, the two inscriptions are commonly believed to form a single dedication, honouring a late Roman provincial governor, Asclepiodotus (already known and in char-ge in 382-3 ca.), in connection with the ‘Victory of the Romans’. In his Hellenica IV (1948) Louis Robert proposed to connect this double text to a supposed reaction of the Cretan pagan elites to the removal of the altar of Victory in Rome. In the same period (1950) Adolf Wilhelm, without knowing Robert, suggested that the two texts were in fact separated and offered a new reading of the one in verses. Robert finally accepted, at least to some extent, the interpretation of Wilhelm, nonetheless more recent scholars still refer to Robert's first interpretation (no doubt because of the extraordinary influence of his Hellenica IV). In year 2012, the author was able to inspect the stone, which had not been re-examined since its discovery. Such an examination has definitively confirmed that the two texts belong to different inscriptions and that Wilhelm was right. The small base was firstly used (may be in the third century) for carrying a statue of Victory, and was eventually re-used as pedestal for a bust or portrait of the governor Asclepiodotus. Various problems concerning both formal and textual aspects of the two inscriptions are therefore discussed.
I. Una curiosa epigrafe fu rinvenuta nel 1898 tra le rovine dell’antica Olus ( jOlou'"), sul golfo di Mirabello nella Creta orientale, durante i lavori com-piuti per la costruzione di un canale attraverso l’Istmo di Poros. Trasportata nel vicino isolotto di Spinalonga, lì fu vista da Joseph Demargne e da questi
(*) Questo lavoro si inserisce nel quadro delle ricerche sulle iscrizioni tarde del Pretorio di Gortina, condotte da chi scrive grazie al permesso dell’Eforia di Heraklion e al sostegno della Scuola Italiana di Atene.
(**) Nell’adunanza dell’11 gennaio 2013.
COPIA P
ER CONSULT
AZIONE
238 IGNAZIO TANTILLO
pubblicata nel 1900(1). Non ebbero modo di vederla invece né Doro Levi, che la ridiscusse nel 1922(2), né Margherita Guarducci che ne fece menzione nel 1929(3). Anche per l’edizione nel primo volume delle Inscriptiones Creticae, del 1935, la Guarducci si fondò su una conoscenza indiretta del testo: «reco-gnovit Halbherr ectypum chartaceum a [G.] Gerola missum», un calco che era stato effettuato poco dopo la scoperta tra il 1900 e il 1902(4). D’altronde, la sua collocazione sull’isolotto di Spinalonga – trasformato in lazzaretto nel 1903 e tale rimasto fino al 1957 – doveva rendere un’autopsia del documento alquanto inagevole.
La pietra è descritta come una base in marmo bianco di modeste dimen-sioni (l. cm 42 e h. cm 38(5)) ricomposta da due frammenti perfettamente combacianti e iscritta su due lati opposti. Demargne aveva notato che la pa-leografia dei due lati era diversa; nondimeno egli aveva reputato tale discre-panza insufficiente a separare i due testi, che sono stati da allora considerati come parte di un’unica dedica(6). Trascrivo secondo le IC (I, XXII, 13; in ap-parato le varianti di Demargne), e allego l’immagine del calco, verosimilmen-te quello di Gerola, ivi riprodotto (calco incompleto: manca circa un terzo del testo su entrambi i lati) (Fig. 1):
A
Oijkoumevnion DwsivqeonjAsklhpiovdotoªn to;ºnlam(provtaton) uJpatiko;nhJ jOlountivwn boulh;to;n eujrgevthn.
(1) Demargne 1900, pp. 237-238, nr. 6 (per le circostanze del ritrovamento p. 223). (2) Levi 1922, pp. 378-380, nr. 24 si limita di fatto a parafrasare Demargne e ciò con-
ferma che questa iscrizione non fu tra quelle che egli vide di persona (vd. quanto affermato nell’introduzione al suo contributo: 1922, p. 321).
(3) Guarducci 1929, pp. 169-170. (4) Fu questo in effetti il periodo in cui Giuseppe Gerola, su incarico dell’Istituto Vene-
to di Scienze Lettere e Arti, svolse a Creta la sua campagna di studi sulle testimonianze del-la dominazione veneziana (vd. G.M. Varanini, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma 1999, pp. 460-463).
(5) Solo larghezza e altezza sono fornite da Demargne. (6) Demargne 1900, pp. 237-238, nr. 6; cf. Levi 1922, pp. 378-379: «la differenza
non è tale che non si possa attribuire alla maggior cura adoperata nell’incisione del distico, piuttosto che a diversità di tempo».
COPIA P
ER CONSULT
AZIONE
ADOLF WILHELM, LOUIS ROBERT E UNA PRESUNTA ECO CRETESE ... 239
BNivkh/ JRwmaivwn pavtrh/ de;ajneqhkev min Ou\rso"nhovn te Eujdikivh" hJge-movnwn te ªgºevno". folium
r. 3-4: hJªgeº/movnwn Demargne.r. 4: ªgºevn ªoº" Demargne.
Da un lato (A) avremmo dunque una dedica a un governatore (consularis) da parte del consiglio della città di Olus; l’onorato, Asclepiodotus, è un per-sonaggio ben conosciuto che intorno al 383 restaurò il pretorio di Gortina e
Fig. 1 – Calco parziale delle due facce iscritte della base (da IC I).
COPIA P
ER CONSULT
AZIONE
240 IGNAZIO TANTILLO
pose una serie di statue in onore di illustri senatori romani(7). Sul lato B, in-vece, colui che si era occupato dell’erezione della statua, Ursus, avrebbe inteso omaggiare in versi (nello stile, quindi, più alla moda in questa età) Asclepio-dotus, consacrando la statua di quello alla ‘Vittoria dei Romani’ nonché alla propria patria: «Alla Vittoria dei Romani e alla patria, pose Urso [la statua di] costui, tempio di giustizia e stirpe di governatori». Questa l’interpretazione di Demargne, seguita anche da Levi e dalla Guarducci(8).
La valorizzazione storica di tale testimonianza e del rapporto tra i due testi A e B si deve però a Louis Robert, che proprio nelle pagini finali del IV volume dei suoi Hellenica (pp. 103-106) ne proponeva un inquadramento alquanto suggestivo. Robert accettava la lettura del primo editore e di Mar-gherita Guarducci, salvo ad apportare, sulla base dell’esame dell’ectypum for-nito, una piccola correzione all’ultimo rigo di B: non te gevno", bensì te mevno", ‘forza di governatori’(9). Il formulario di B apparterrebbe a un tipo comune, quello delle dediche alla città, alla patria (spesso associate a qualche divinità). Nondimeno – ammetteva Robert – la prima parte dell’epigramma «n’est pas sans surprendre». Perché dedicare a un governatore, sprovvisto di poteri militari, una statua alla Vittoria? E se anche vi fosse qui un riferimento indiretto all’imperatore, perché allora non Nike dell’Augusto, Victoria Augu-sta o Augusti? La soluzione era suggerita a Robert proprio dal collegamento con il lato A e il governatore Asclepiodotus – autore appunto di una decina di dediche a importanti senatori romani nel pretorio di Gortina(10) – e con
(7) La datazione precisa del mandato di Asclepiodotus si ricava dai riferimenti alle fun-zioni ricoperte dai personaggi da lui onorati nel pretorio: PLRE I, p. 115, s.v. Asclepiodotus 2; De Tommaso 2000; da ultimo Bigi, Tantillo 2012. Per la lista dei personaggi, infra, nt. 10.
(8) Demargne traduce «à la victoire des Romains et à sa patrie Ursus a consacré la sta-tue d’Asclépiodotos, temple de la Justice et race de gouverneurs»; similmente Levi 1922, p. 379: «alla vittoria dei Romani e alla sua patria, Ursus ha dedicato la statua di Asclepiodoto, tempio di giustizia e razza di governanti»; Guarducci 1929, p. 169 parafrasa il contenuto del distico come segue: «col quale un certo Ursus dedica la base, e quindi anche la statua che la sormontava, alla Vittoria dei Romani e alla sua patria». La stessa Guarducci, tuttavia, nel commento per le IC preferisce intendere: «Victoriae, id est Romanorum patriae, consularis effigiem (min) dedicari, ipsumque Iustitiae templum stirpemque imperatorum esse, sermone, ut aetatis mos fuit, satis inflato, Ursus dicit», il che equivale a distinguere il verso come segue: Nivkh/, JRwmaivwn pavtrh'/ de ktl. Ma non si vede in che modo Nike possa essere definita ‘patria dei Romani’; anche la resa di hJgemovne" con ‘imperatori’ è inaccettabile.
(9) Robert 1948, p. 104, nt. 5: «A la verité, la photographie publiée par M. Guarducci (I. Cret.) ne s’accorde guère avec cette lecture – Il y a la place et les restes d’une lettre large, dont il semble qu’on reconnaisse deux hastes verticales paralléles». Per i confronti invocati da Robert, vd. infra, nt. 19.
(10) I personaggi onorati sono: Valerius Severus (IC IV, 315), Anicius (Auchenius) Bas-sus (IC IV, 314), (Vettius) Agorius Praetextatus (IC IV, 316), Anicius Paulinus (IC IV, 320), [- - -] Probianus (Gabinius Vettius Probianus?: IC IV, 319), Anicius Claudius (IC IV, 322), (Sextus Claudius) Petronius Probus (IC IV, 318), Fl. Hypatius (IC IV, 317).
COPIA P
ER CONSULT
AZIONE
ADOLF WILHELM, LOUIS ROBERT E UNA PRESUNTA ECO CRETESE ... 241
la cronologia del suo mandato, 382 e 383, gli anni in cui tra Roma e Mi-lano si dibatté la questione dell’altare della curia(11). Di qui la conclusione: «L’epigramme d’Olonte est un écho de la réaction païenne à la suppression de l’autel. Ursus, avec son entourage, tient à affirmer son attachement au culte menacé. Dès lors, on comprend le Nivkh/ JRwmaivwn; il s’agit bien de la Victoire des Romains… Peut-être alors le mot pavtrh/ ne designe-t-il pas la patrie d’Ursus, Olonte, mais la patrie romaine, dont parle Symmaque dans son plaidoyer; la patrie est liée à ce culte de la Victoire: Cui enim magis com-modat quod instituta maiorum, quod patriae iura et fata defendimus quam tem-porum gloriae? [rel. III 2] Ursus savait, en donnant cette forme à l’inscription de la statue de Asklépiodotos, qu’il était en communauté de sentiments avec lui. Les inscriptions du prétoire de Gortyne, gravées sur les bases des statues élevées par Asklépiodotos lui-même, nous introduisent dans la haute aristo-cratie du Sénat, dans le milieu romain où se sont recrutés les défenseurs de l’autel de la Victoire». Al proposito Robert non mancava di ricordare che tra essi figurava il grande Pretestato, noto e irriducibile pagano. Insomma «Ursus et Asklépiodotos faisaient partie du milieu où la Victoire Romaine était un signe de ralliement»(12).
Per quanto seducente, tale ricostruzione suscita alcune perplessità. A parte la stranezza di una dedica posta su due facce opposte(13), sussiste il proble-ma di associare questa dedica a quelle del tipo “alla tale divinità e alla pa-tria”: simili dediche hanno come oggetto statue di divinità, personificazioni – proprio Nike, per esempio – o altri oggetti o strutture(14); non però statue onorarie, come è quella di Asclepiodoto secondo il testo A. Infine nemmeno il collegamento proposto da Robert con le statue del pretorio convince pie-namente: dei grandi senatori celebrati a Gortina c’è un solo pagano sicuro contro un gran numero di cristiani certi(15).
(11) Superfluo fornire qui i riferimenti alle fonti e alla bibliografia per questo episodio troppo celebre: si rimanda al recente Cameron 2010, pp. 31-51.
(12) Robert 1948, p. 104 con nt. 6 riteneva di poter riconoscere un altro indice di paganesimo nell’impiego del verbo ajnativqhmi, volutamente arcaizzante; in realtà il verbo continua a esser usato in età tarda sia in ambito pagano sia in quello cristiano, come precisato da Roueché 2002, p. 545 e nt. 51.
(13) Al limite il testo sulla faccia principale di una base può essere corredato, su una o su entrambe le facce laterali, da altri testi collegati (una semplice datazione, ovvero una copia del decreto…).
(14) Tipico il caso delle dediche delle statue di Nike da Efeso ora riesaminate da Roue-ché 2002.
(15) Di questi (elenco supra, nt. 10), solo Pretestato è certamente pagano. Una comples-siva revisione di questo gruppo di dediche, della loro cronologia, del loro contesto monumen-tale è in corso di preparazione ad opera di chi scrive, di F. Bigi e di P. Porena.
COPIA P
ER CONSULT
AZIONE
242 IGNAZIO TANTILLO
Tornando all’esegesi di Robert, bisogna da subito dire che essa si è impo-sta – come si vedrà – lasciando nell’ombra un’altra soluzione avanzata più o meno negli stessi anni da un altro insigne studioso, Adolf Wilhelm. Senza co-noscere quanto scritto da Robert, Wilhelm dedicava alla base di Olus alcune pagine di uno dei suoi ultimi contributi, quello sugli epigrammi cretesi, ap-parso postumo (1950, pp. 67-72). Come Robert, Wilhelm preferiva ricono-scere nella lettera evenascente del quarto rigo di B un my, salvo a considerarla parte della parola tevmeno". Ma, soprattutto, egli pensava a un reimpiego, proprio in base alla posizione dei due testi sulla base e alla differenze grafiche: «ferner wird jeder Unbefangene beide Inschriften wegen ihrer Anbringung auf entgegengesetzten Seiten der Basis, der Vorder- und der Rückseite, und wegen der von M. Guarducci allerdings nicht beachteten Verschiedenheit der Schrift trennen». In B, che costituirebbe l’iscrizione originale, la più antica, bisognerebbe distinguere le prime due parole dal resto: Nivkh JRwmaivwn, al nominativo quindi, indicherebbe l’oggetto posto sopra la base. È la Nivkh, insomma, a esser dedicata alla patria. Wilhelm apportava una lunga serie di confronti epigrafici per questo tipo di formula iniziale(16) e, a ulteriore confer-ma del fatto che questa fosse la lettura esatta, segnalava anche la presenza dei segni di interpunzione, effettivamente visibili sul calco riprodotto nelle IC, che distinguono varie sezioni del testo come segue:
Nivkh JRwmaivwn • pavtrh/ de;ajneqhkev min • Ou\rso"•nhovn te • eujdikivh" • hJge-movnwn tevmeno".
Oltre alla statua di Vittoria Ursus avrebbe ‘consacrato’ un «tempio, recin-to sacro della giustizia (eujdikivh con l’iniziale minuscola(17)) dei governatori», ove appunto tevmeno" è apposizione di nhovn. Tale tempio è da intendersi in senso metaforico, come un luogo deputato all’esercizio della giustizia dei go-vernatori romani («eine Stätte der Betätigung und der Verehrung ihrer Recht-lichkeit»).
(16) Ai casi citati si dovrebbe aggiungere anche quello di un’iscrizione di Aphrodisias, relativa proprio a una statua di Nike: Reynolds 1982, pp. 155-156, nr. 32 (al cui commento rimando): Nivkh pavreimªiº qeogevneªiº / Kaivsari ajei;. L’iscrizione era stata discussa da Robert 1965, pp. 128-130.
(17) Per eujdikivh ci sono vari confronti: nell’epigramma per Marcellinus prefetto del 340 ca. da Gortina (IC IV, 323; Tantillo 2012); nelle iscrizioni per i proconsoli di Achaia Theo-dorus, da Atene (IG II, 2, 4223); Phosphorius da Megara (IG VII, 96) e Pretestato da The-spiae (AE 1928, 48; ora IThesp. 418 [http://hisoma.mom.fr/Thespies/ITVII(2009).pdf ]); cf. anche IK Eph. 1311.
COPIA P
ER CONSULT
AZIONE
ADOLF WILHELM, LOUIS ROBERT E UNA PRESUNTA ECO CRETESE ... 243
Nella sua elegante semplicità, la soluzione di Wilhelm appare senza dubbio vantaggiosa(18): il dev del primo verso acquisterebbe maggior senso e il min non si troverebbe ad esser giustificato dal testo inciso sull’altra faccia della base; soprat-tutto non avremmo una statua di un governatore consacrata ‘alla vittoria e alla patria’. Infine non avremmo una dedica sui due lati opposti di uno stesso sup-porto. Si aggiunga che la restituzione di tevmeno" è spontanea e in sé preferibile a quel mevno" di Robert che evoca un’immagine senza paralleli stringenti(19) e tanto più curiosa se la si immaginasse riferita a un governatore di una provincia che fu di norma amministrata da funzionari puramente civili; all’inverso, l’uso metaforico di tevmeno" in composizioni tarde di questo genere è ben testimo-niato, come lo stesso Robert aveva altrove avuto modo di illustrare(20).
L’accoglienza da parte di Louis Robert nei confronti di questa diversa esegesi non è stata immediatamente positiva. Nel «Bulletin Épigraphique» dell’anno successivo all’apparizione del volume di Wilhelm – lo stesso «Bul-letin» in cui ne annunciava con commozione la scomparsa – Robert, senza abbracciare l’ipotesi del grande maestro austriaco, non la respingeva del tutto, preoccupandosi però di sottolineare che essa non modificava l’interpretazione storica da lui offerta di questa doppia epigrafe: «Il [sc. A. Wilhelm] n’a pas connu, lors de sa rédaction, l’étude Hellenica, IV, 103-106 (Bull. 1949, 143). Il nous semble qu’il n’a pas mis les inscriptions dans leur cadre chronologique et historique. Que Nivkh JRwmaivwn soit un nominatif détaché en tête de l’inscription ou un datif, l’interpretation historique n’a pas à être modifiée. Au vers 4 de B W. lit hJgemovnwn tevmeno"»(21). In realtà, v’è appena bisogno
(18) E fu accolta da Vollgraff 1952, pp. 254-255; vd. anche Eitrem 1950, p. 115, nr. 112, citato infra. Senza conoscere Wilhelm, anche U. Gehn in LSA-1161 pensa a un reimpiego.
(19) Nei confronti prodotti da Robert il termine non si trova mai in associazione con governatori o funzionari: Anth. Pal. VIII 134 (rJhtorikh'" mevno" di un defunto retore); IG V, 1, 455 ( iJ[ero;n] mevno" ajrht[h'ro"]?); IGLCM 30.
(20) Robert 1948, pp. 35-37 discute l’epigramma di Sardi per il vicario Acholius (IGR IV, 1510), ove l’enumerazione dei meriti dell’onorando si chiude con il ricordo della costru-zione di un tevmeno" ejleuqerivh", da intendersi in senso metaforico come cinta muraria; cf., sempre in Robert 1948 (pp. 94-95), l’analisi dell’epigrafe di Megara commemorante l’erezione della statua ajmfi; Divkh" temevnei (IG VII, 95 = Kaibel 909). Wilhelm invocava invece come paralleli IGUR IV, 1528 (su un’erma di Milziade: Pevrsai kai; Marathwvn, sh'" ajreth'" tevmeno"), Imerio (or. LXIV, 3, ll. 27-28 Colonna, ove il teatro è detto Mousw`n kai; JErmou' tevmeno") e Cassio Dione (LII, 35, 5). Forse di tevmeno" delle Ninfe si parla anche nell’epi-gramma di Hierapolis pubblicato da Ritti 1986, pp. 700-701 con nt. 24. Giovanni Lido (Mag. III 27,5; 65,5) chiama il secretum del tribunale prefettizio tevmeno" th`" Divkh".
(21) «BE» (1951), p. 185, nr. 183, che continua così: «W. eût certainement introduit des modifications ou des additions sur épreuves (cf. p. 83) à sa rédaction un peu ancienne, puis que, dans Anz. Wien 1950, 373 et 375, il renvoyait à des passages du tome IV des Hellenica et voulait bien approuver la restitution de l’épigramme de Nicopolis de l’Istros sur le gouver-neur Basilianos, etudiée là, pp. 141 sqq.».
COPIA P
ER CONSULT
AZIONE
244 IGNAZIO TANTILLO
di dirlo, la diversa interpretazione di B (statua di Vittoria, non di Asclepiodo-tus) e l’idea di un reimpiego modificano radicalmente le cose(22).
Nel «Bulletin Épigraphique» di due anni dopo (1953, pp. 164-165, nr. 170), stimolato dall’apparizione di una nota di Samson Eitrem all’epigrafe(23), Robert riprendeva l’esame del problema in modo ampio, giungendo ad accettare la sostanziale bontà della ricostruzione di Wilhelm. Robert ammetteva che l’ipotesi di un reimpiego fosse ‘più naturale’; Ursus avrebbe dedicato una statua della Vittoria e un pretorio, una basilica, un tribunale, dove appunto sarebbe stato posto il monumento: «il nous parait en définitive que W. a vu juste, une fois de plus, pour la reconstruction et la restitution de cette épigramme. Son interprétation… nous paraît au-jourd’hui préférable à celles de J. Demargne et M. Guarducci… et à celle de L. Robert, qu’il n’avait pas connue». Si direbbe tuttavia che Robert non avesse del tutto rinunciato alla sua ipotesi di un qualche rapporto tra la ‘Nike dei Romani’ evocata su quest’epigrafe e la polemica sull’altare della Vittoria; in effetti, poco oltre egli affermava: «ce remploi de la base pour la statue d’Asklépiodotos – qui était en fonctions, comme l’a relevé L.R. [1948, pp. 104-5] à l’époque de l’affaire de l’autel de la Victoire à Rome – n’est d’ailleurs guère postérieur, d’après les écritures, à l’épigramme d’Ur-sus» e poi che «elle [la statua di Nike] fut remplacée, sans doute peu après, par la statue du gouverneur Asklépiodotos». Ancora molti anni dopo («BE» (1971), p. 481, nr. 527), recensendo un nuovo tentativo di interpretazione dell’epigramma da parte di Reinhold Merkelbach (che fondeva l’interpre-tazione storica di Robert e una lettura simile a quella di Wilhelm, senza conoscerlo)(24), Robert osservava: «M. accepte un rapport avec l’autel de la Victoire au Sénat (Hellenica, IV, 103-106), mais il coupe les mots et pon-ctue différemment», senza specificare però che l’idea di un tale rapporto era difficilmente compatibile con la lettura di Wilhelm, e quindi avrebbe dovuto essere abbandonata o comunque rivista.
Forse Robert aveva conservato un qualche dubbio sulla proposta di Wilhelm, o non aveva del tutto abbandonato l’idea che la Vittoria dei Ro-mani invocata nel quasi contemporaneo testo B (una contemporaneità per
(22) Si noterà che nel passo sopracitato Robert non menziona esplicitamente il fatto che Wilhelm reputasse distinte le due iscrizioni e pensasse a un reimpiego.
(23) Eitrem 1950, p. 115, nr. 112, nota in sé poco significativa: l’autore interpretava male hJgemovne" e introduceva, si direbbe per una banale svista, un errore nella lettura del pentametro.
(24) Merkelbach 1970 leggeva tevmeno" e intendeva che Ursus, oltre alla statua di Asclepiodotus (cui si riferirebbe il min), avesse dedicato un tribunale; quanto alla Nike dei romani egli era indeciso tra due soluzioni: vedervi un nominativo separato dal resto come una sorta di acclamazione, ovvero supporre un errore del lapicida e correggere pavtrh/ in patrivh/; in Merkelbach 1971 l’autore precisava che tevmeno" era già stato proposto da Wilhelm.
COPIA P
ER CONSULT
AZIONE
ADOLF WILHELM, LOUIS ROBERT E UNA PRESUNTA ECO CRETESE ... 245
lui comprovata dalla paleografia) potesse avere a che fare con l’altare della Vittoria nella curia. In ogni caso la retractatio di Robert nel «Bulletin» non ha avuto la stessa risonanza della sua prima, avvincente interpretazione. È infatti quest’ultima, ancor oggi, a essere presa come riferimento(25).
II. Nell’aprile 2012 mi è stato possibile, grazie alla cortesia delle autori-tà greche, accedere al magazzino del Museo di Aghios Nikolaos(26) dove, tra
(25) Peek 1954/55, p. 220 [non vidi]; Merkelbach 1970; più di recente Roueché 1989, pp. 51-52; Smith 2002, p. 149; Roueché 2002, pp. 544-545 (che riesamina il testo dell’epigrafe nel quadro di una complessiva revisione del significato delle statue di Nike in età tarda); Baldini 2010, p. 227 con nt. 53.
(26) Tengo a esprimere la mia riconoscenza all’Eforia di Aghios Nikolaos e in particolare alla Direttrice Dott.ssa Krissa Sophianou, per la sua amabile disponibilità; ringrazio anche la Dott.ssa Klio Zervaki. Durante il sopralluogo ho potuto avvalermi del prezioso aiuto di Lucio
Fig. 2 – Foto dei due lati opposti della base (foto autore).
COPIA P
ER CONSULT
AZIONE
246 IGNAZIO TANTILLO
il 2001 e il 2003, la nostra base è stata trasportata insieme agli altri reperti dell’Isola di Spinalonga. Qui ho potuto rinvenirne uno dei due frammenti (il secondo risulta ad oggi irreperibile). Nondimeno, quanto rimane è sufficiente a chiarire vari aspetti della questione. Ecco le foto (Fig. 2) e una trascrizione dell’epigrafe, con le interpunzioni:
AOIKOUMEN[- - -]ASKLHP[- - -]LAM vac. UP[- - -]HOLOUN[- - -]TONEU[- - -]
B[- - -]•PATRHDE[- - -]•OURSOS•[- - -]KIHS•HGE[- - -]EMENO[.]
Dall’esame autoptico è emerso, senza ombra di dubbio, che si tratta di due iscrizione distinte, incise da due mani diverse. Le differenze paleografiche sono molto più evidenti di quanto non si potesse discernere dalla riprodu-zione del calco fornita nelle IC. Il testo B è inciso con cura e presenta tratti fini, netti e di profondità regolare, spesso ingentiliti da piccole apicature; A è intagliato più profondamente, con uno scalpello più largo di quello usato per B, da un lapicida senz’altro meno esperto: questi non ha rifinito il tracciato delle lettere lasciando visibili i segni dei singoli colpi dati di punta(27); B è im-paginato in modo regolare, mentre i righi di A sono tracciati a mano libera e presentano un andamento oscillante. Ma, molto più importante, B è iscritto su una superficie polita, mentre A su una superficie lavorata a gradina. Ciò indica che è proprio B il testo originale. Come ulteriore conferma ci sono le tracce di incasso del plinto sovrastante: esso presenta una forma approssimati-vamente quadrangolare, ricurva in corrispondenza del lato con l’iscrizione B, che perciò costituiva la fronte originale del monumento (Fig. 3); l’incasso e le dimensioni si adattano a una piccola statua, un busto o un’erma.
Un reimpiego, quindi. Su questo punto, come sulla cronologia relativa dei due testi (B più antico di A) aveva ragione Wilhelm. L’autopsia ha per-messo inoltre di confermare – come ipotizzato sia da Robert che da Wilhelm
Del Corso, al quale sono grato anche per i numerosi suggerimenti. Ringrazio inoltre France-sca Bigi, autrice del disegno.
(27) Si noterà anche che in A, diversamente che in B, si hanno sigma ed epsilon lunate (a parte un caso in cui my e epsilon formano un nesso); in B le lettere sono su modulo tenden-zialmente quadrato in A sono piuttosto allungate; in B la traversa orizzontale di pi fuoriesce ampiamente rispetto ai tratti verticali, e la barra di eta è staccata dai tratti verticali, etc. Solo un pregiudizio estetico nei confronti della scrittura tarda (il cui unico tratto distintivo è il fatto di essere sciatta) può giustificare l’affermazione di Demargne quanto alla sostanziale uni-formità dello stile scrittorio dei due testi.
COPIA P
ER CONSULT
AZIONE
ADOLF WILHELM, LOUIS ROBERT E UNA PRESUNTA ECO CRETESE ... 247
– che alla fine del quarto rigo di B non bisogna leggere g, bensì m, di cui si lasciano facilmente individuare entrambi i tratti verticali(28). Nel disegno se ne offre una ricostruzione (Fig. 4).
Non possiamo a questo punto che riproporre l’epigramma secondo la ri-costruzione di Wilhelm:
Nivkh JRwmaivwn. Pavtrh/ de;ajneqhkev min Ou\rso"nhovn te, eujdikivh" hJge-movnwn tevmeno".
‘Vittoria dei Romani. Alla patria la dedicò Urso, insieme a un tempio, sacro recinto della giustizia dei governatori’.
(28) D'altronde visti anche da Federico Halbherr, come testimonia la sua trascrizione – evidentemente basata sull’esame del calco – di questo rigo in un quaderno autografo dal tito-lo Iscrizioni cretesi 59, conservato presso lo studio di Epigrafia greca, Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Università di Roma Sapienza. Si ringrazia la Prof.ssa Gabriella Bevilacqua che ne ha permesso la consultazione.
Fig. 3 – Foto del ripiano superiore della base (foto autore).
COPIA P
ER CONSULT
AZIONE
248 IGNAZIO TANTILLO
Se il testo A va collocato intorno al 383, quello sul lato opposto non è databile. Si tratta di una dedica di età imperiale, che la forma delle lettere suggerisce di porre in epoca piuttosto avanzata. Come si è detto, infatti, le
Fig. 4 – Disegno ricostruttivo (F. Bigi).
COPIA P
ER CONSULT
AZIONE
ADOLF WILHELM, LOUIS ROBERT E UNA PRESUNTA ECO CRETESE ... 249
differenze paleografiche tra i due testi sono forti, e nessun elemento permette di sposare l’affermazione del primo editore, fatta propria da Robert, per cui essi sarebbero all’incirca coevi. Prudentemente, indicheremo un arco cronolo-gico ampio, 200-350 ca., fermandoci cioè a una generazione prima del 383, data del reimpiego(29).
Ursus potrebbe essere un governatore, o piuttosto, vista la dedica alla pa-tria Olus, un membro dell’élite locale che agisce a titolo evergetico, o en-trambe le cose insieme: conosciamo almeno altri tre casi di governatori di IV secolo che appartengono all’aristocrazia dell’isola(30). Il nome (originalmente diffuso soprattutto nella regione dalmatica(31)) è decisamente raro in area el-lenofona e non testimoniato a Creta, se non indirettamente (conosciamo un Fl. Ursus proprietario a Creta in età flavia)(32).
Dobbiamo figurarci che sulla base si ergesse una statuetta raffigurante la Vittoria(33) e che tale monumento fosse collocato entro una struttura desti-nata all’esercizio dell’attività degli hJgemovne". Non è inverosimile la presenza a Olus di un edificio destinato a ospitare il governatore in viaggio per l’iso-la, una basilica o un tribunal(34): è noto come il governatore potesse disporre
(29) La paleografia costituisce sempre un elemento molto incerto di datazione, ma una collocazione di questo testo in età precedente al III secolo appare molto difficile: se alcune ca-ratteristiche, come il sigma “quadrato”, diffuso in genere dal III secolo d.C., non sono incom-patibili con una datazione più alta (cf. p.es. IC I, XXII, 12, dedica a Tiberio), la resa comples-siva è innegabilmente “tarda”. Sui ritmi di reimpiego delle basi – eccettuando i monumenti in onore di personaggi colpiti da damnatio memoriae che potevano naturalmente esser riusati subito – vd. Horster 1998, p. 43, nt. 29 e Bigi, Tantillo 2010, p. 294, nt. 181. Un ele-mento che potrebbe suggerire una datazione più alta è proprio la menzione del tevmeno" dei governatori: sembra che i governatori delle più piccole province tardoantiche tendessero a spostarsi di meno (Lavan 2001, p. 46: «provincial government had become largely sedentary from the time of Diocletian and Constantine… the old conventus, the formal circuit of de-signated assize centres, probably did not survive in most provinces»), un tribunale a Olus si spiegherebbe quindi meglio prima della creazione della provincia di Creta in età tetrarchica.
(30) Questo tipo di strutture o edifici sono in genere costruiti dai governatori, trattando-si di edifici pubblici: Lavan 2001, pp. 43-44. Per i governatori cretesi di origine locale: PLRE I, p. 105, s.v. Aristides; p. 756, s.v. Pyrrhus 2 e 3; Tantillo 2012, pp. 412-413. Sulla nor-mativa che impediva, salvo dispensa imperiale, di ricoprire cariche di governo nella propria provincia, e sulle trasgressioni a tale regola, da ultimo Slootjes 2006, pp. 25-26.
(31) Kajanto 1965, p. 18. (32) Su Flavius Ursus, cui Stazio dedicò una consolatio, PIR III 2, F 404; Hatzfeld
1919, p. 158; Bowsky 2004, p. 43; Cassia 2012, p. 126. La possibilità di trovare degli indi-vidui di (più o meno lontana) origine occidentale tra i notabili di Creta (e anche di Olus) è tutt’altro che remota: cf. ora Bowsky 1999, spec. p. 315, nt. 25 e pp. 333 sgg.
(33) Per una statuetta di Vittoria con dimensioni compatibili a quelle della nostra, si confronti l’esemplare di Pompei, alto circa cm 50, in Pohlsander 1969, p. 591 con fig. 1.
(34) A meno di non immaginare che la pietra si trovasse originariamente (cioè al mo-mento della dedica posta da Ursus) altrove, magari a Gortina, e che fosse stata trasportata
COPIA P
ER CONSULT
AZIONE
250 IGNAZIO TANTILLO
di varie residenze o servirsi di strutture riservate alla sua attività in località minori(35). E immaginare un simulacro della Vittoria in simile contesto non ha in sé alcunché di strano(36). Inoltre, un’iscrizione del 364-367 da Cuicul in Numidia, dalla sintassi un po’ faticosa, ricorda l’intervento di un governatore sulla Basilica Tisediacor(um) che sembra aver riguardato il tribunal e una statua della Vittoria(37). Una connessione tra un simulacrum della Vittoria e un tribu-nal sembra testimoniata anche da un’epigrafe di Minturnae del II secolo(38).
Il simulacro della Vittoria dei Romani fu poi, intorno al 383, eliminato o rimosso e la base impiegata per sorreggere un busto(39) o una piccola statua ri-volta verso il lato opposto, che rappresentava il consularis benefattore di Olus, tanto attivo nella metropoli della provincia(40).
Fin qui per la ricostruzione del monumento e della sua vicenda. Che fare della Vittoria dei Romani? Purtroppo c’è poco da aggiungere. Come accen-nato, lo stesso Robert sottolineva che non è qui evocata la Victoria Augu-sta, come ci si aspetterebbe in età imperiale (a dire il vero, le dediche alla Nike degli imperatori sono visibilmente meno diffuse in Oriente che in Occidente(41)). Della ‘Vittoria dei Romani’ le tracce sono scarsissime: l’esi-
a Olus in occasione del reimpiego come base per Asclepiodotus: ma non ci sono ragioni o indizi per presupporre un tale trasferimento.
(35) Egger 1966; Martin 1988, pp. 230-231; Alessio 2006, pp. 680-682; una lista delle iscrizioni relative ai pretori in Zucca 1992, pp. 627-635.
(36) Sulla diffusione del tema soprattutto a partire dal III secolo, cf. McCormick 1986; ora Lavan 2011, pp. 445-450. Smith 2002, p. 149 con nt. 70 (cf. p. 136) nota che tra le pitture dell’edificio forse interpretabile come la sede del governatore di Aphrodisias (dubbi su questa identificazione in Lavan 1999, p. 150) compariva anche un’immagine di Vittoria.
(37) ILAlg II, 3, 7914 (rinvenuta nell’abside della basilica costruita poco tempo prima dal proconsole Publius Caeionius Albinus): Ulpius Egna/tius Faventi/nus v(ir) c(larissimus) cons(ularis) / p(rovinciae) N(umidiae) quod vel / amplitudi/ni vel orna/tui basilicae / Tisediacor(um) / tribunalium / defuerat Vic/toriae simula/crum consti/tuendum con/locandumque / curavi(t). Lepelley (già in 1981, p. 406, nt. 21) metteva in relazione questo monumento al paganesimo del dedicante e alla volontà di richiamarsi alla statua della Vittoria della curia romana.
(38) AE 1982, 157: [- - -]ae et Proculae Burb[ulei - - -] / [- - - t]rib(unal?) et simulacr(um) Victor(iae) A[ug(ustae) - - -] / [- - - op]eris dedicat(ione) decurionibus et fili(i)s e[orum - - -] / [- - - d]ec(urionum) uxor(ibus) HS XII n(ummum), Aug(ustalibus) HS VIII n(ummum), cet(eris) [- - - - - -].
(39) Un piccolo busto da Olus è pubblicato da Kostis Davaras in «Archailogikon Del-tion» 28 (1973), p. 593 con tav. 560.
(40) Sul ripiano superiore si riconosce solo l’originale incasso descritto sopra. Ciò lascia pensare che il nuovo busto-ritratto fosse semplicemente appoggiato sulla basetta o al limite ancorato con grappe laterali, di cui non rimane però traccia sul frammento superstite.
(41) Una discussione sulle differenze tra i culti di Victoria e Nike, con insistenza sulle sfumature, in Hölscher 1967, pp. 177-179; Fears 1981, pp. 753-773; vd. ora Frija 2010, pp. 56-57.
COPIA P
ER CONSULT
AZIONE
ADOLF WILHELM, LOUIS ROBERT E UNA PRESUNTA ECO CRETESE ... 251
stenza a Efeso di un culto apposito è stata ipotizzata sulla base di una le-genda monetaria RWMAIWN NEIKH EFESIWN QEA dell’età di Marco Aurelio(42). Nella monetazione greca l’evocazione della “Nike dei Romani” è praticamente assente(43), mentre in quella romana VICTORIA ROMA-NORVM è uno slogan diffuso a partire dalla metà del IV secolo(44). Super-fluo aggiungere che nell’epigrafia occidentale mancano riferimenti a statue dedicate specificatamente alla Vittoria dei Romani(45). Troppo poco per for-mulare ipotesi circostanziate. Potrebbe trattarsi di un’evocazione vaga, di una statua posta in un momento qualsiasi, ovvero di un riferimento a un episodio specifico, un’importante vittoria(46), che magari aveva riguardato l’isola, o ad-dirittura dalla quale era dipesa la salvezza dei suoi abitanti. Riesce sponta-neo pensare all’incursione gotica del 269, ma non si escluderanno neanche le guerre civili, per esempio quella di Costantino contro Licinio a Crisopoli, ove Crispo aveva condotto una flotta rinforzata di navi dall’Egeo (che anzi ai successi nelle guerre civili si addice la definizione di “vittoria romana” forse ancor meglio che alle guerre esterne, poiché in esse bisognava sottolineare che a vincere erano stati i buoni, i veri Romani(47)). Ribadisco che si tratta di pure congetture, che si presentano a titolo esemplificativo. La cosa più ragionevole è in questo caso limitarsi a ammettere l’impossibilità di una soluzione.
Sfortunatamente, non si potrà usare più l’iscrizione di Olus come chiave per dare un significato al singolare ciclo di statue del pretorio di Gortina, o per illustrare la polemica religiosa innescata dalla rimozione dell’altare della
(42) Nollé 2003; Frija 2010, p. 57, nt. 59 esprime qualche riserva al riguardo. (43) Cf. le due monete di Nicea per Valeriano con legenda RWMAIWN NIKH: SNG
von Aulock 714 e 7077. (44) Slogan naturalmente collegato ad altri simili, p.es. al più antico e diffuso GLO-
RIA ROMANORVM, a ROMA VICTRIX ecc. Oltre ai riferimenti forniti da Nollé 2003, p. 463, vd. gli indici di RIC VIII e X. Molte emissioni VICTORIA ROMANORVM si datano sotto Giuliano Augusto, ma compaiono già sotto Costanzo II (RIC VIII, p. 294 del 352-353). Sulla rappresentazione di Vittoria nella monetazione, cf. più in generale Bellin-ger, Berlincourt 1962.
(45) In genere le dediche sono fatte alla Victoria Augusta, o semplicemente a Victoria; tra le pochissime eccezioni, CIL VIII, 1823 = ILS 495 da Althiburos in Proconsolare che sostene-va una Victoria sen(atus) Rom(ani), e fu eretta insieme a una dedica alla Victoria Augusta. Già Gustav Wilmanns (ad CIL) metteva in relazione questa coppia di documenti alle vicende del 238, cf. anche Lepelley 1981, p. 64.
(46) Così come ipotizzato da Reynolds 1982, p. 156 per la già menzionata iscrizione di Aphrodisias (supra, nt. 16), da riferirsi forse a una vittoria di Cesare durante le guerre civili.
(47) Il tema della romanità e della difesa della libertà romana era particolarmente sfrutta-to in occasione dei conflitti civili, molto sotto Costantino e sotto Teodosio: i nemici del vero principe non sono romani, è questo un tema che ricorre in molte opere panegiristiche del IV secolo. Cf. PanLat XII, 5, 3; II, 24-30; Zos., II, 46, 3; cf. anche il formulario di una dedica di Aeclanum a Costanzo orbem terrae Romano nomini subiugans: CIL IX, 1117 = ILS 734; in generale p.es. Tantillo 1997, pp. 330-332.
COPIA P
ER CONSULT
AZIONE
252 IGNAZIO TANTILLO
Vittoria da parte di Graziano, vagheggiando una solidarietà degli ambienti della periferia ellenofona alla difesa della tradizione intrapresa nell’Urbe dai senatori pagani.
La vicenda dell’interpretazione di questa piccola pietra, a lungo rimasta isolata nell’ultimo lazzaretto d’Europa, è comunque istruttiva. Con essa si sono misurati probabilmente i due più grandi epigrafisti del mondo greco (ed altri studiosi di eccezionale valore), dando prova della loro prodigiosa eru-dizione e sensibilità storica. Dai loro ragionamenti e argomentazioni, come dai loro errori, si ha ancora molto da imparare(48). Il riesame dell’iscrizione di Olus che si è qui condotto ha confermato la validità della soluzione di Adolf Wilhelm contribuendo – ci si augura – a farla uscire dall’ombra; e ha per-messo di scartare gli eventuali, rimanenti dubbi di Louis Robert, il cui stra-ordinario Hellenica IV continua a guidare i passi dello storico che si accosti al mondo tardoantico.
Abbreviazioni bibliografiche
Alessio 2006 = S. Alessio, Praetorium e palatium come residenze di imperatori e governatori, «Latomus» 65 (2006), pp. 679-689.
Baldini 2010 = I. Baldini, La virtù dei governatori: monumen-ti onorari tardoantichi a Gortina e Afrodisia, in S. De Maria, V. Fortunati (a cura di), Monumento e memoria dall’antichità al contemporaneo, Atti del convegno (Bologna, 11-13 ottobre 2006), Bologna 2010, pp. 219-232.
«BE» = «Bulletin épigraphique», «REG» 1888 sgg.Bellinger, Berlincourt 1962 = A.R. Bellinger, M.A. Berlincourt, Victory as
a coin type, New York 1962.
(48) Non è certo questa la sede per discutere del debito intellettuale di Robert verso Wilhelm, debito che lo studioso francese ha ampiamente riconosciuto, sia nel particolare – in tante singole pagine dei suoi lavori –, sia di maniera più generale. Si cf. specialmente il di-scorso di commemorazione pronunciato da Robert all’apertura del II Congresso di Epigrafia (Robert 2007 [1953], pp. 74-78; ma vd. anche Robert 1989 [1980], pp. 659 e 663) che contiene uno straordinario ritratto dello studioso austriaco, dotato – vi si legge – di eccezio-nale Sprachgefühl («il avait des antennes…») e di una mirabile finezza, uno studioso che «a eu le privilège de se tromper très rarement, et ses fautes ont témoigné elles aussi de sa pénétra-tion…» (Robert aveva usato un’espressione simile nella sua lezione inaugurale al Collège de France nel 1939 a proposito di Jean-Antoine Letronne; 1969 [1939], p. 1673). Una defini-zione, quest’ultima, applicabile a Louis Robert stesso.
COPIA P
ER CONSULT
AZIONE
ADOLF WILHELM, LOUIS ROBERT E UNA PRESUNTA ECO CRETESE ... 253
Bigi, Tantillo 2010 = F. Bigi, I. Tantillo, Il reimpiego: le molte vite delle pietre di Leptis, in I. Tantillo, F. Bigi (a cura di), Leptis Magna. Una città e le sue iscrizioni in epoca tardoromana, Cassino 2010, pp. 253-302.
Bigi, Tantillo 2012 = F. Bigi, I. Tantillo, Gortyna, in R.R.R. Smith, B. Ward-Perkins (eds), Last Statues of Antiquity, Oxford c.d.s.
Bowsky 1999 = M.W. Baldwin Bowsky, The Business of Being Roman: The Prosopographical Evidence, in A. Chaniotis (ed.), From Minoan Farmers to Roman Traders. Sidelights on the Economy of Ancient Crete, Stuttgart 1999, pp. 305-347.
Bowsky 2004 = M.W. Baldwin Bowsky, From Traders to Lan-downers: Acculturation in Roman Gortyn, in Creta romana e protobizantina, Atti del Congresso Inter-nazionale (Iraklion, 23-30 settembre 2000), I, Pa-dova 2004, pp. 33-47.
Cameron 2010 = A. Cameron, The Last Pagans of Rome, New York 2010.
Cassia 2012 = M. Cassia, Andromaco di Creta. Medicina e pote-re nella Roma neroniana, Acireale-Roma 2012.
Demargne 1900 = J. Demargne, Monuments figurés et inscriptions de Crète, «BCH» 24 (1900), pp. 221-246.
De Tommaso 2000 = G. De Tommaso, Nota su alcune iscrizioni del Pretorio di Dositeo, in A. Di Vita (a cura di), Gor-tina V.1. Lo scavo del Pretorio (1989-1995), Padova 2000, pp. 384-388.
Egger 1966 = R. Egger, Das praetorium als Amtssitz und Quar-tier römischer Spitzenfunktionäre, Wien 1966.
Eitrem 1950 = S. Eitrem, Varia, «SO» 28 (1950), pp. 113-115.Fears 1981 = J.R. Fears, The Theology of Victory at Rome, in
Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, II, 17, 2, Berlin-New York 1981, pp. 736-826.
Fittschen, Zanker, Cain 2010 = K. Fittschen, P. Zanker, P. Cain, Katalog der römischen Porträts in den Capitolinischen Muse-en und den anderen kommunalen Sammlungen der Stadt Rom, Band II, Die männlichen Privatporträts, Berlin-New York 2010.
Frija 2010 = G. Frija, Nommer les empereurs divinisés. Epi-clèses et assimilation dans le culte impérial des cités grecques d’Asie à l’époque julio-claudienne, «ARG» 12 (2010), pp. 41-64.
Guarducci 1929 = M. Guarducci, Le iscrizioni del Pretorio di Gor-tina, «RIA» 1 (1929), pp. 143-184.
COPIA P
ER CONSULT
AZIONE
254 IGNAZIO TANTILLO
Hatzfeld 1919 = J. Hatzfeld, Les trafiquants Italiens dans l’Orient Hellénique, Paris 1919.
Hölscher 1967 = T. Hölscher, Victoria Romana. Archäologische Untersuchungen zur Geschichte und Wesenart der rö-mischen Siegesgöttin von den Anfängen bis zum Ende des 3. Jhs. n.Chr., Mainz 1967.
Horster 1998 = M. Horster, Ehrungen spätantiker Statthalter, «AntTard» 6 (1998), pp. 37-59.
IC = M. Guarducci, F. Halbherr, Inscriptiones Cre-ticae, opera et consilio Friderici Halbherr collectae, Roma 1935-1950.
IGLCM = A. Bernand, E. Bernand, Les inscriptions grecques et latines du Colosse de Memnon, Paris 1960.
Kaibel = G. Kaibel, Epigrammata graeca ex lapidibus conlecta, Berlin 1878.
Kajanto 1965 = I. Kajanto, The Latin Cognomina, Helsinki 1965.Lavan 1999 = L. Lavan, The Residences of Late Antique Gover-
nors: A Gazetteer, «AntTard» 7 (1999), pp. 135-164.Lavan 2001 = L. Lavan, The praetoria of civil governors in Late
Antiquity, in L. Lavan (ed.), Recent Research in Late Antique Urbanism, Portsmouth 2001, pp. 39-56.
Lavan 2011 = L. Lavan, Political Talismans? Residual ‘Pagan’ Statues in Late Antique Public Space, in L. Lavan, M. Mulryan (eds), The Archaeology of Late Antique ‘Paganism’, Leiden 2011, pp. 439-477.
Lepelley 1981 = C. Lepelley, Les cités de l’Afrique Romaine au Bas-Empire, II, Paris 1981.
Levi 1922 = D. Levi, Silloge in corsivo delle iscrizioni metriche cretesi, «SIFC», n.s., 2 (1922), pp. 321-400.
LSA = R.R.R. Smith, B. Ward-Perkins (dir.), Last Stat-ues of Antiquity Database, http://laststatues.classics.ox.ac.uk.
Martin 1988 = A. Martin, Praetoria as Provincial Governor’s Pa-laces, in Historia testis. Mélanges d’épigraphie, d’his-toire ancienne et de philologie offerts a T. Zawadzki, Freiburg 1988, pp. 229-240.
McCormick 1986 = M. McCormick, Eternal Victory. Triumphal Rulership in Late Antiquity, Byzantium and the Ear-ly Medieval West, Cambridge-Paris 1986.
Merkelbach 1970 = R. Merkelbach, Epigramm auf einem consularis Cretae, «ZPE» 6 (1970), pp. 243-244.
Merkelbach 1971 = R. Merkelbach, Nachträge zu Epigrammen, «ZPE» 7 (1971), p. 52.
Nollé 2003 = J. Nollé, Ein ephesischer Kult der «Victoria Ro-manorum» und das sogenante Parthermonument, «Chiron» 33 (2003), pp. 459-484.
COPIA P
ER CONSULT
AZIONE
ADOLF WILHELM, LOUIS ROBERT E UNA PRESUNTA ECO CRETESE ... 255
Peek 1954/55 = W. Peek, PEIRATA TECNHS, «Wissenschaft-liche Zeitschrift der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Gesellschafts- und Sprachwis-senschaftliche Reihe» 4 (1954-1955), pp. 215-236.
PLRE = A.H.M. Jones, J.R. Martindale, J. Morris, Prosopography of the Later Roman Empire, Cam-bridge 1971-1992.
Pohlsander 1969 = H.A. Pohlsander, Victory: The story of a statue, «Historia» 18 (1969), pp. 588-597.
Reynolds 1982 = J. Reynolds, Aphrodisias and Rome, London 1982.
Ritti 1986 = T. Ritti, Un epigramma del tardo impero da Hie-rapolis, «ASNP» ser. III, 16 (1986), pp. 691-716.
Robert 1948 = L. Robert, Hellenica: recueil d’épigraphie, de nu-mismatique et d’antiquités grecques, IV, Epigrammes du Bas-Empire, Paris 1948.
Robert 1965 = L. Robert, Hellenica: recueil d’épigraphie, de numismatique et d’antiquités grecques, XIII, Compte rendu du volume VIII des Monumenta Asiae Minoris Antiqua, Paris 1965.
Robert 1969 [1939] = L. Robert, L’Epigraphie grecque au Collège de France, Leçon d’ouverture donnée le 25 avril 1939. Appendice: Bibliographie de Paul Foucart, in Opera Minora Selecta, III, Amsterdam 1969, pp. 1670-1704.
Robert 1989 [1980] = L. Robert, Recensione alla riedizione di A. Wil-helm, Akademieschriften zur griechischen Inschrif-tenkunde, «Gnomon» 52 (1980), pp. 1-5 [poi in Opera Minora Selecta, VI, Amsterdam 1989, pp. 659-663].
Robert 2007 [1953] = L. Robert, L’œuvre d’Ad. Wilhelm. L’épigraphie et ses méthodes, in Actes IIe Congrès Intern. Epigraphie, (Paris, 1952), Paris 1953, pp. 1-20 [poi in Choix d’écrits, Paris 2007, pp. 73-86].
Roueché 1989 = Ch. Roueché (with contributions by J. Reyn-olds), Aphrodisias in Late Antiquity, London 1989.
Roueché 2002 = Ch. Roueché, The image of Victory: New evi-dence from Ephesus, «T&MByz» 14 (2002), pp. 527-546.
Slootjes 2006 = D. Slootjes, The Governor and His Subjects in the Later Roman Empire, Leiden-Boston 2006.
Smith 2002 = R.R.R. Smith, The statue monument of Oecume-nius: A new portrait of a late antique governor from Aphrodisias, «JRS» 92 (2002), pp. 134-156.
Tantillo 1997 = I. Tantillo, La prima orazione di Giuliano a Co-stanzo, Roma 1997.
COPIA P
ER CONSULT
AZIONE
256 IGNAZIO TANTILLO
Tantillo 2012 = I. Tantillo, «Dispensatore di governatori». A propo-sito di una dedica a un prefetto al pretorio da Gortina (IC IV 323), «RFIC» 140 (2012), pp. 407-424.
Vollgraff 1952 = W. Vollgraff, Recensione a Wilhelm 1950, «Mnemosyne» 5 (1952), pp. 253-255.
Wilhelm 1950 = A. Wilhelm, Griechische Epigramme aus Kreta, Oslo 1950 (Symbolae Osloenses Suppl. 13).
Zucca 1992 = R. Zucca, Un’iscrizione monumentale dall’Oristane-se, in L’Africa Romana, Atti del IX Convegno di stu-dio (Nuoro, 13-15 dicembre 1991), Sassari 1992, pp. 595-636.
COPIA P
ER CONSULT
AZIONE