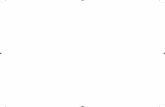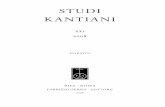La questione dell’emancipazione ebraica nel biennio 1847-1848: note sul caso livornese
Teleologia e questione degli inizi in Husserl
Transcript of Teleologia e questione degli inizi in Husserl
1. Necessità, metodo e finalità della considerazione storica
1.1. La necessità della ricerca
Husserl avvia un’analisi fenomenologica della storia a partire dalla cre-scente consapevolezza della radicalità della crisi della civiltà europea, dicui quella delle scienze costituisce il sintomo paradigmatico, per sorpren-dere “l’origine più profonda del pericoloso naturalismo, oppure, che è lostesso, del dualismo moderno dell’interpretazione del mondo”1, che pre-senta, come implicazione ontologica e al contempo come riflesso “esisten-
INDAGINI SUL PENSIERO CONTEMPORANEO
ROCCO SACCONAGHI
TELEOLOGIA E QUESTIONE DEGLI INIZI IN HUSSERL
1 E. HUSSERL, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die traszendentalePhänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie, Husserliana,vol. VI, a cura di W. Biemel, Nijhoff, Den Haag 1954 (trad. it. di E. Filippini, La crisidelle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Il Saggiatore, Milano 1961, p.332). Husserl si concentra sul problema del senso della storia in risposta alla crisi euro-pea (e sulla scorta del continuo approfondimento dell’intersoggettività come dimensionetrascendentale originaria fondamentale e della temporalità della coscienza), ma il proble-ma della storicità incomincia a imporsi nel suo percorso filosofico nel contesto del dibat-tito tra “neokantismo” e “filosofia della vita” sul problema della fondazione delle scienzedello spirito e del loro statuto rispetto alle scienze naturali, i cui principali protagonistisono stati Rickert e Windelband sul primo versante, Dilthey sul secondo. A partire da que-sto dibattito Husserl comincia a porre il problema dello statuto trascendentale della stori-cità. Per un confronto tra la fenomenologia di Husserl e la filosofia di Dilthey rimandia-mo a R. CRISTIN, Fenomeno storia. Fenomenologia e storicità in Husserl e Dilthey, Guida,Napoli 1999.
Rivista di Filosofia Neo-Scolastica, 4 (2008), pp. 537-560
© 2
008
Vita
e P
ensi
ero
/ Pub
blic
azio
ni d
ell’
Uni
vers
ità C
atto
lica
del S
acro
Cuo
re
03_Sacconaghi:01_Vimercati_04_08 5-06-2009 11:02 Pagina 537
538 ROCCO SACCONAGHI
2 HUSSERL, La crisi delle scienze europee, p. 35.3 ID., Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die traszendentale
Phänomenologie. Ergänzungsband: Texte aus dem Nachlass, 1934-1937, Husserliana, vol.XXIX, a cura di R.N. Smid, Kluwer, Dordrecht 1993, p. 228.
4 ID., Erste Philosophie (1923-1924), I: Kritische Ideengeschichte, Husserliana, vol.VII, pp. 3-199, a cura di R. Boehm, Nijhoff, Den Haag 1956 (trad. it. di G. Piana, Storiacritica delle idee, Guerini, Milano 1989, p. 28).
5 ID., La crisi delle scienze europee, p. 537.6 Ibi, p. 410.7 Ibi, p. 537.8 Ibi, p. 86.9 Ibi, p. 41.
ziale”, la reificazione del soggetto: “Le mere scienze di fatto creano meriuomini di fatto”2.
Egli parla di una “segreta convinzione” che lo muove a interrogare ladimensione storica: “Poterci comprendere meglio a partire dalla storia, noiche certamente in questa storia siamo divenuti”3. La crisi, infatti, non puòessere ricondotta semplicemente alla concezione riduttiva della ragionemessa in campo dall’ultima generazione di filosofi e nemmeno alla solaingenuità dell’atteggiamento naturale; allo stesso modo, la nascente feno-menologia non può essere ascritta all’ispirata e geniale intuizione di un filo-sofo isolato. Entrambe si presentano cariche di un’eredità secolare, svelan-do delle possibilità che appartengono alla struttura della soggettività, ma chenon avrebbero potuto manifestarsi in un momento qualsiasi della storia.
La percezione della crisi, che si esplicita nella “profonda insoddisfa-zione” di Husserl per la “situazione generale spirituale”4, “attribuisce unsenso ben distinto al problema del compito attuale della filosofia, in quan-to problema che si pone in questo tempo”5: “Quest’insoddisfazione contie-ne alcuni motivi che ci possono indurre ad avviare una considerazione sto-rica, a considerare il nostro presente filosofico come un presente nella sto-ria della filosofia e a ridestare il ‘ricordo storico’ dei nostri progenitori filo-sofici”6; si rende perciò necessario “approfondire le nostre considerazionistoriche se dobbiamo poter capire noi stessi in quanto filosofi e ciò cheattraverso di noi cerca di diventare una filosofia”7.
In particolare, occorre attuare riflessioni storiche che giungano a “unagrande chiarezza attorno all’origine dello spirito moderno e perciò – datal’importanza, che non sarà mai sottolineata abbastanza, della matematica edelle scienze naturali matematiche – attorno all’origine di queste scienze”8.All’inizio della modernità si è infatti espressa con una forza inaudita laspinta alla piena autocomprensione del soggetto, tramite la costruzione diuna filosofia intesa come compimento della ragione universale; tuttavia, nelsuo sviluppo, questo ideale ha subito una “intima dissoluzione”9, derivante
03_Sacconaghi:01_Vimercati_04_08 5-06-2009 11:02 Pagina 538
TELEOLOGIA E QUESTIONE DEGLI INIZI IN HUSSERL 539
dal venir meno del radicalismo teoretico. L’esito è stato il progressivoimporsi del “concetto residuo”10 di ragione proprio del positivismo, che ha,come inevitabile correlato, una concezione della storia come continuo einsensato avvicendarsi di forme in cui le differenze si rivelano illusorie einconsistenti:
Il mondo e l’esistenza umana possono avere un senso se le scienze ammettonocome valido e come vero soltanto ciò che è obiettivamente constatabile, se la sto-ria non ha altro da insegnare se non che tutte le forme del mondo spirituale, tutti ilegami di vita, gli ideali, le norme che volta per volta hanno fornito una direzioneagli uomini, si formano e poi si dissolvono come onde fuggenti, che così è semprestato e sempre sarà, che la ragione è destinata a trasformarsi sempre di nuovo innon-senso, gli atti provvidi in flagelli? Possiamo accontentarci di ciò, possiamovivere in questo mondo in cui il divenire storico non è altro che una catena inces-sante di slanci illusori e di amare delusioni?11.
1.2. Il metodo
La “considerazione storica” di Husserl non consiste in una mera analisi sto-riografica dello sviluppo della filosofia. Innanzitutto egli riconosce comeirrealizzabile l’ideale che sottende la scienza storiografica comunementeintesa: “Una storia che potesse osservare in maniera sovratemporale e defi-nitiva ‘come sono andate veramente le cose’ è, per ragioni di principio,impossibile”12. Egli vuole attuare una “profondissima auto-considerazioneche tende a una comprensione di ciò che si è in quanto esseri storici”13: essaè storica in “un senso inconsueto”, poiché si svolge seguendo “una dire-zione tematica che dischiude problemi profondi completamente estraneialla comune storiografia (Historie)”, affrontando problemi che, “a modoloro, sono pure indubbiamente di ordine storico”14.
Si tratta di un’indagine volta a cogliere il senso della storia penetran-do “attraverso la crosta storica dei ‘fatti storici’ esteriori”15, al fine di chia-rire il presente. Perché la ricerca storica non si limiti ad essere un’analisiche concepisce il “divenire temporale” come “una successione causalemeramente esterna”, essa deve attuarsi “dall’interno”16, ovvero a partire
10 Ibi, p. 38.11 Ibi, p. 36.12 HUSSERL, Die Krisis. Ergänzungsband, p. 233.13 ID., La crisi delle scienze europee, p. 99.14 Ibi, p. 380.15 Ibi, p. 47.16 Ibi, p. 99. Landgrebe osserva che “in Husserl la storicità si rende tematica come storicità
della coscienza intenzionale fluente”: è sempre nell’ambito della coscienza trascendentale che
03_Sacconaghi:01_Vimercati_04_08 5-06-2009 11:02 Pagina 539
dalla coscienza del proprio presente17: solo così la storia passata si svelanel suo senso e, a sua volta, “spiega” il presente mostrandone la prove-nienza. Nel cercare di liberarsi dal “groviglio che ci offrono la scienza ela filosofia del presente”, Husserl vuole “ritornare ai tempi dei primiinizi”18, cioè al luogo “sorgivo” di quello sviluppo che ha portato al nostropresente: ad essere tematiche sono quelle “origini quasi-storiche [...] chenon cadono sotto il concetto di una ‘storia della filosofia’ scientifica”19.Egli intende cioè interrogare la storia secondo una prospettiva trascen-dentale, chiedendo conto dell’insorgenza del senso: “Quali avvenimentistorici hanno inaugurato il nostro attuale orizzonte di senso?”. Gli avveni-menti che Husserl decide di interrogare sono “trascendentali”: egli non sirivolgerà ai fatti della storia empirica, ma alla storia della filosofia20, e inparticolare ai “punti di rottura nella storia”, quelli in cui “diventa eviden-te una motivazione ad una presa di coscienza nuova e del tutto radicale, ipunti, cioè, dove sono in questione la possibilità e l’autentica struttura disenso di una filosofia”21.
540 ROCCO SACCONAGHI
ci si muove per un’indagine fenomenologica della storia. In questo senso, la storia non è tema-tizzata “nel senso di un divenire obiettivo, eventualmente di storia universale”, giacché “è giàpreventivamente individuata la soggettività come base della questione stessa” (L. LANDGREBE,Phänomenologie und Geschichte, Gütersloher Verlaghaus Gerd Mohn, Gütersloh 1968 [trad. it.di M. von Stein, Fenomenologia e storia, Il Mulino, Bologna 1972, p. 13]). Analogamente, aproposito del metodo della ricerca husserliana, Derrida osserva che “si tratta [...], ancora unavolta, di una ricerca del senso originario mediante il metodo della riduzione trascendentale;riduzione che non ha più un senso semplicemente egologico, ma si pratica a partire da unacomunità trascendentale” (J. DERRIDA, Le problème de la genèse dans la philosophie deHusserl, P.U.F., Paris 1990 [trad. it. di V. Costa, Il problema della genesi nella filosofia diHusserl, Jaca Book, Milano 1992, p. 267]).
17 “Considerazioni come queste ottengono piena luce soltanto dalla storia che, inter-pretata a partire dal presente, illumina a sua volta comprensivamente il presente stesso”(HUSSERL, Storia critica delle idee, pp. 28-29).
18 Ibi, p. 29.19 HUSSERL, Die Krisis. Ergänzungsband, pp. 48-49.20 In modo analogo a quanto afferma al proposito Derrida nella sua opera giovanile sul
problema della genesi in Husserl (cfr. DERRIDA, Il problema della genesi nella filosofia diHusserl, pp. 274-275), Vincenzo Costa osserva: “La filosofia della storia di Husserl tendea identificarsi, a volte fino a confondersi, con la storia della filosofia”; per Husserl, infatti,“la storia delle idee è qualcosa di più della storia degli eventi intellettuali: essa segnala lostato profondo del rapporto dell’uomo con la verità. Sarà di conseguenza in una discussio-ne della storia delle idee che si giocherà l’interpretazione di ciò che ci accade oggi, dellacrisi della civiltà” (in V. COSTA - E. FRANZINI - P. SPINICCI, La fenomenologia, Einaudi,Torino 2002, p. 231).
21 HUSSERL, Die Krisis. Ergänzungsband, pp. 417-418 (trad. it. parziale di N. Ghigi, Lastoria della filosofia e la sua finalità, Città Nuova, Roma 2004, p. 128).
03_Sacconaghi:01_Vimercati_04_08 5-06-2009 11:02 Pagina 540
1.3. La finalità
Questa “auto-considerazione storica” è animata dalla tensione alla completachiarificazione del “compito storico”22, essendoci ancora oscurità al riguardo:“Io so naturalmente ciò che perseguo sotto il titolo di filosofia, so qual è loscopo e il campo del mio lavoro. E tuttavia, insieme, non lo so. A quale auto-nomo pensatore è mai bastato questo ‘sapere’, per quale pensatore, nella suavita filosofica, la ‘filosofia’ ha mai cessato di essere un enigma?”23. Perciò, tra-mite la realizzazione del compito specifico e particolare della filosofia delnostro tempo, la riconsiderazione storica, si ottiene chiarezza a proposito delmetodo del compito storico in senso vero e proprio, quello definitivo. Lariconsiderazione storica è propedeutica all’attuazione del compito finale: essaè necessaria “per orientarsi”24 in un momento di confusione, in cui l’obliodella soggettività è causa e conseguenza della dimenticanza delle proprie ori-gini storiche. Solo con una comprensione critica “della nostra storia”25 (e nondi “un qualunque sistema attuale o tradizionale”), si ottiene una piena coscien-za del compito: la nostra storia, infatti, “ha un’unità spirituale fondata sull’u-nità e sulla forza di propulsione emanante da quei compiti che nel divenire sto-rico [...] vogliono giungere, attraverso fasi di oscurità, a una chiarezza soddi-sfacente, e infine a un’intelligibilità perfetta ed evidente”26.
Quando questa tensione allo svelamento dei compiti universali infinitiche muovono la storia viene resa oggetto della coscienza, essa non può chediventare anche fine esplicito della volontà personale; per questo Husserldice che l’autoconsiderazione “serve alle decisioni”27: “Occorrono esau-rienti considerazioni storiche e critiche per giungere, prima di qualsiasidecisione, a un’auto-comprensione radicale”28.
2. La storia come progressivo oblio dell’evidenza originaria
2.1. La geometria come tradizione
La necessità di questa indagine sottende una particolare concezione dellastoricità del senso, contraria alla “convinzione dominante di coloro che
TELEOLOGIA E QUESTIONE DEGLI INIZI IN HUSSERL 541
22 ID., La crisi delle scienze europee, p. 99.23 Ibi, p. 540 (corsivi nostri).24 Ibi, p. 538.25 Ibi, p. 99.26 Ibidem.27 Ibi, p. 100.28 Ibi, p. 47.
03_Sacconaghi:01_Vimercati_04_08 5-06-2009 11:02 Pagina 541
indagano nell’ambito delle scienze rigorose”29, i quali non percepiscono lanecessità della continua tematizzazione della dimensione storica, giacché il“controllo logico” del sistema delle scienze si svolge “nel presente, senzache la storia della scienza debba rivivere e senza che essa, le opere e i pianidel passato debbano essere sottoposti alla critica”30.
È al pensiero logico, la cui unica dimensione temporale è il presente(inteso come “luogo” astratto dalla storia), essendo la sua validità sovra-temporale per essenza, che si fa appello quando, nell’attuazione dellascienza, si incontrano problemi, anche nel caso in cui questi coinvolgano ifondamenti della scienza in questione. Nonostante “si imbattano continua-mente in queste difficoltà”, gli scienziati affrontano il problema “senzarisalire alla dimensione storica”31. Ma questa concezione, dice Husserl,“finisce per celare i problemi più profondi e più specifici della storia”32. Inuno scritto del 193633, il frammento chiamato L’origine della geometria,Husserl offre un esempio di “critica storica” della scienza. Egli compieun’analisi storico-intenzionale della geometria, raccogliendo “sotto il tito-lo di geometria [...] tutte quelle discipline che si occupano delle forme esi-stenti matematicamente nella spazio-temporalità”34, ma i problemi trattati“assumeranno un significato esemplare”35, giungendo a porre la questionedella “storia universale in generale”36.
Lo sviluppo della geometria è una tradizione, e per questo possiamointerrogarne l’origine: pur non sapendo nulla delle sue origini fattuali, noisappiamo che essa è “una tradizione che si è costituita nel nostro spazioumano e in base all’attività umana, sappiamo che è spiritualmente divenu-ta”37, che è il “risultato complessivo di una serie di operazioni spirituali”38.
542 ROCCO SACCONAGHI
29 Ibi, p. 521.30 Ibidem.31 Ibidem.32 Ibi, p. 397.33 Si tratta di un testo pubblicato nel 1939 da E. Fink col titolo Vom Ursprung der
Geometrie (Sull’origine della geometria) nella «Revue Internationale de philosophie»,Bruxelles, A.I.N. 2; l’edizione italiana è pubblicata come terza appendice ne La crisi dellescienze europee. In questo testo, Husserl giungerà ad attribuire al linguaggio e alla scritturail carattere di elementi trascendentali, vale a dire originariamente costitutivi dell’idealità geo-metrica, in quanto le conferiscono la necessaria autonomia dalla singola psiche di un sogget-to individuale e quella “tradizionalizzazione assoluta” da cui sorge la sua oggettività ideale.
34 HUSSERL, La crisi delle scienze europee, p. 381.35 Ibi, p. 380.36 Ibidem.37 Ibi, p. 381.38 Ibi, p. 382. “Ogni vissuto, ogni atto, anche ogni atto di conoscenza [...] è motivato,
ha dunque la sua tradizione. Tutta la vita sta nell’unità di una storicità” (HUSSERL, DieKrisis. Ergänzungsband, p. 343).
03_Sacconaghi:01_Vimercati_04_08 5-06-2009 11:02 Pagina 542
In quanto tale custodisce in se stessa un senso implicito che, come puòessere dimenticato, può essere riattivato: “Questo non sapere include sem-pre, per essenza e implicitamente, un sapere che può essere esplicitato, unsapere di una evidenza incontestabile”39. Poiché “il nostro sapere, la formaculturale della geometria attualmente vivente, è una tradizione che insiemeproduce una tradizione”40, esso “‘implica’ l’intero passato culturale”41: a pre-scindere dalla nostra eventuale ignoranza a proposito della storia empiricache ci precede, noi “sappiamo a priori che ogni presente culturale – quindiogni presente scientifico – implica nella sua totalità la totalità del passato”42.Per questo, “rendere evidente la geometria significa [...] esplicitare la sua tra-dizione storica”43. Partendo dall’ultimo strato dello sviluppo storico possia-mo perciò “risalire agli inizi originari e ormai sommersi della geometria, aquegli inizi ‘originariamente fondanti’ così come devono necessariamenteessersi prodotti”44. Ma, proprio in quanto tradizione, la geometria è anchedestinata a “estrinsecarsi tecnicizzandosi”45, perdendo perciò l’originaria evi-denza del senso delle proprie operazioni: in quanto costituisce “una forma-zione di senso vivente e produttivamente progressiva”46, può procedere inpiena apoditticità solamente nel momento in cui “i fondamenti della costru-zione deduttiva siano stati realmente prodotti in un’evidenza originaria”47 equindi “obiettivati” in modo tale da essere “diventati un prodotto accessibilea tutti”48: solo rendendo possibile una “continuità da persona a persona” del-l’evidenza delle operazioni originarie una scienza come la geometria può cre-scere come tradizione aderente al proprio senso iniziale.
Questa condizione, però, non è stata rispettata: si è perciò privi dellafacoltà del “riattivamento delle attività originarie rinchiuse nei concetti fonda-mentali, e quindi anche del cosa e del come dei loro materiali pre-scientifici”49.La geometria si trova ad essere una tradizione “svuotata del suo senso”50.Poiché hanno spazio d’azione solamente i “modi di pensiero” necessari a quel-
TELEOLOGIA E QUESTIONE DEGLI INIZI IN HUSSERL 543
39 HUSSERL, La crisi delle scienze europee, p. 382.40 Ibi, p. 397.41 Ibidem.42 J. DERRIDA, Introduction à l’Origine de la Géométrie de Husserl, P.U.F., Paris 1962
(trad. it. di C. Di Martino, Introduzione a Husserl ‘L’origine della geometria’, Jaca Book,Milano 1987, p. 165).
43 HUSSERL, La crisi delle scienze europee, p. 398.44 Ibi, p. 381.45 Ibi, p. 77.46 Ibi, p. 392.47 Ibidem.48 Ibidem.49 Ibi, p. 393.50 Ibidem.
03_Sacconaghi:01_Vimercati_04_08 5-06-2009 11:02 Pagina 543
la che ormai è divenuta una “tecnica”, ciò che rimane escluso è “il pensierooriginario, che conferisce propriamente un senso a questo procedimento tec-nico e una verità ai risultati ottenuti conformemente alla regola”51: viene amancare il necessario “ritorno al senso propriamente scientifico”52, cioè alleevidenze in base a cui si definiscono il senso e il metodo di una scienza.
2.2. L’oblio dell’evidenza originaria
L’origine perciò si svela come il luogo dell’evidenza perduta, quell’evi-denza di un “essente nella sua presenza-in-persona originale”53 vissuta, adesempio, dal proto-geometra, grazie alla quale solamente è potuta sorgerela scienza. Essa è stata sommersa dagli sviluppi successivi della scienzastessa: il progresso ha portato a un “insabbiamento” di “quegli ‘inizi origi-nariamente fondanti’”54. Il mondo-della-vita, il “regno delle evidenze ori-ginarie”55, è ormai coperto da uno strato di categorie idealizzanti: “Ilmondo in cui viviamo e compiamo giudizi di conoscenza, a partire dalquale ci affetta ciò che diverrà sostrato di possibili giudizi, ci è sempre datoin anticipo come permeato dai sedimenti delle operazioni logiche”56.
Noi, in quanto moderni, abbiamo ereditato l’immagine del mondo che diesso ha plasmato la scienza, eppure “questo senso è divenuto per noi tantoovvio, che ci costa fatica persino renderci conto che esso è il prodotto di unosviluppo e che occorre indagarne i motivi originari e l’evidenza originaria”57.Il mondo ci si offre come determinabile scientificamente di principio, tantoche “per questo mondo che ci è già dato è per noi ovvia, sul fondamento dellatradizione dell’età moderna, l’idea così esprimibile: ‘l’infinita totalità dell’e-sistente in generale è in sé una totalità razionale che deve essere correlativa-mente dominata mediante una scienza universale e senza residui’”58. Noi nonabbiamo mai esperienza degli “oggetti della scienza”: lo spazio esatto dellageometria nasce sulla base di questa nostra esperienza, “proviene dallo spa-zio dell’intuizione con la sua tipica vaga e variabile”59.
544 ROCCO SACCONAGHI
51 Ibi, p. 75.52 Ibidem.53 Ibi, p. 383.54 Ibi, p. 381.55 Ibi, p. 156.56 E. HUSSERL, Erfahrung und Urteil. Untersuchungen zur Genealogie der Logik, a cura di
L. Landgrebe, Klaassen Verlag, Hamburg 1948 (trad. it. di F. Costa e L. Samonà, Esperienzae giudizio. Ricerche sulla genealogia della logica, Bompiani, Milano 1995, p. 38).
57 ID., La crisi delle scienze europee, p. 373.58 ID., Esperienza e giudizio, pp. 38-39.59 Ibi, p. 40. Come afferma Patocka, “la verità del mondo della vita è pratica, imprecisa,
relativa in rapporto alla situazione, ma non fantastica né ‘relativa’ nel senso dell’arbitrio
03_Sacconaghi:01_Vimercati_04_08 5-06-2009 11:02 Pagina 544
Perciò, l’esperienza che facciamo dell’universo, come qualcosa chesembra offrirci naturalmente delle “determinatezze in sé”, è in realtà fruttodi un vero e proprio “rivestimento di idee” gettato “sopra il mondo dell’in-tuizione e dell’esperienza immediate, sopra il mondo-della-vita”60. Comenota Derrida, “benché l’idealità geometrica sia prodotta a partire dall’idea-lità morfologico-sensibile, questo punto di partenza facto-storico è sop-presso come fondamento all’interno della geometria costituita”61. Le con-quiste scientifiche “allontanano sempre di più dalle origini e rendono insen-sibili appunto al problema dell’origine e quindi al senso proprio di essere edi verità delle scienze nel loro complesso”62; in questo senso, Galileo è “ungenio che scopre e insieme occulta”63. La storia, letta a partire dalla traiet-toria dello sviluppo scientifico, appare quindi come un progressivo obliodelle evidenze originarie.
3. La storia come progressivo superamento dell’ingenuità iniziale
3.1. Il filosofo e la tradizione
L’incidenza della dimensione storica sulla ricerca filosofica assume uncarattere particolare e paradigmatico: essa rappresenta la ricerca che piùesplicitamente richiede una continua “rivisitazione” della propria storia. Ilfilosofo è chiamato a rifarsi al suo presente e a non far valer nulla che nonsia verificabile in piena evidenza (“il filosofo, che vive nel mondo presen-te degli uomini, nel presente della sua nazione [...] ha in questo presente lasua attualità dell’agire – dell’agire immediatamente dentro di esso e su di
TELEOLOGIA E QUESTIONE DEGLI INIZI IN HUSSERL 545
individuale” (in J. PATOCKA, Il mondo naturale e la fenomenologia, a cura di A. Pantano,Mimesis, Milano 2003, p. 132). Per la determinazione della categoria husserliana di mondo-della-vita è essenziale risalire al concetto naturale di mondo, che Husserl riprende da RichardAvenarius. Per una rigorosa trattazione di queste tematiche rimandiamo al saggio introdutti-vo di V. COSTA, Il concetto naturale di mondo e la fenomenologia, contenuto in Problemi fon-damentali della fenomenologia. Lezioni sul concetto naturale di mondo, Quodlibet, Macerata2008 (trad. it. a cura di V. Costa).
60 HUSSERL, Esperienza e giudizio, p. 41.61 DERRIDA, Introduzione a Husserl, p. 183.62 HUSSERL, La crisi delle scienze europee, p. 393. In particolare, è stato Galileo a radi-
calizzare e richiedere come metodologicamente necessario questo oblio. Con Galileo si ècompiuta la piena matematizzazione della natura: l’universo viene idealizzato mediante lamatematica, in modo tale da poter “leggere” in esso un sistema unitario di causalità per-fettamente determinabili in quanto matematicamente determinate, “una causalità naturalein sé conclusa entro cui qualsiasi accadimento è preliminarmente ed univocamente deter-minato” (ibi, p. 89).
63 Ibi, p. 81.
03_Sacconaghi:01_Vimercati_04_08 5-06-2009 11:02 Pagina 545
esso”64); ma il presente svela come proprio “contenuto” una sorprendentecontinuità con tutta la storia passata: “In quanto filosofo [...], il presentefilosofico è per lui l’essenza stessa totale della coesistenza filosofica, l’in-tera storia della filosofia”65. Infatti, “il passato filosofico è attualmentemotivante per il filosofo del presente”66 e per questo “noi, in quanto filoso-fi, per quanto riguarda quei fini che sono indicati dal termine ‘filosofia’, perquanto riguarda i concetti, i problemi, i metodi, siamo eredi del passato”67:si tratta della peculiare “generatività filosofica”68.
Per questa natura del “presente filosofico”, il filosofo non può che muo-versi sottoponendo a critica la storia da cui proviene e di cui eredita leintenzioni. Il nostro “essere storico”, afferma Husserl, “risale sì a unanostra attività spirituale”, e “tuttavia proviene da un’eredità”69. La “consi-derazione storica” a cui è chiamato ogni filosofo è necessaria poiché nonsolo si è inevitabilmente eredi del passato, ma occorre esserlo in modo cri-tico, cioè pienamente razionale: “In quanto eredi, raccogliamo la nostraeredità, e, in quanto scolari, la interpretiamo e la sviluppiamo”70.
3.2. Il progressivo superamento dell’ingenuità originaria
Nella prima parte del corso del semestre invernale 1923-1924 (intitolatoErste Philosophie), dedicata alla Storia critica delle idee, Husserl svolgeun’interpretazione fenomenologica della storia del pensiero dai sofisti finoa Kant, e compie un’operazione analoga, partendo da Descartes, nella Crisidelle scienze europee, privilegiando i “momenti di capovolgimento dellastoria”71. Si tratta di una genealogia del motivo trascendentale, tesa a sor-
546 ROCCO SACCONAGHI
64 HUSSERL, La crisi delle scienze europee, p. 514.65 Ibidem.66 Ibi, p. 513.67 Ibi, p. 46.68 Ibi, p. 411.69 Ibidem.70 Ibidem.71 HUSSERL, La storia della filosofia e la sua finalità, p. 131. Come osserva Angela Ales
Bello, “Husserl ricerca il significato delle varie soluzioni filosofiche, tenendo conto inprimo luogo del loro valore teoretico; non si tratta quindi di un accurato elenco di tutti ipensatori, ma solo di quelli che Husserl ritiene fondamentali, in quanto hanno dato unacerta impronta allo sviluppo filosofico dell’umanità” (A. ALES BELLO, Edmund Husserl ela storia, Nuovi Quaderni, Parma 1972, p. 117). Nel corso sulla storia critica delle ideeHusserl concede molto spazio ai greci (sofisti, Socrate, Platone, Aristotele, logica stoica) ead alcuni autori moderni (Descartes, Locke, Berkeley, Hume e Kant, con un breve ma deci-sivo riferimento alla monadologia di Leibniz). Egli non prende in considerazione la filoso-fia medievale e non opera un’analisi della filosofia degli idealisti tedeschi, con cui intrat-tiene un rapporto molto particolare, criticandoli per l’assenza di rigore metodologico e al
03_Sacconaghi:01_Vimercati_04_08 5-06-2009 11:02 Pagina 546
prendere il presentarsi e l’oscurarsi di quella che poi sarà la grande intui-zione della fenomenologia, vale a dire l’intenzionalità come strutturaessenziale della soggettività trascendentale, sede della costituzione delsenso dell’esperienza.
Nell’interpretazione husserliana, la storia della filosofia si presentacome un avvicendarsi “dialettico” di tentativi animati da due diverse istan-ze, le quali si combatteranno fino a quando troveranno nella fenomenolo-gia una scienza rigorosa che le comprenda entrambe: da una parte, l’istan-za dell’indagine “positiva”, che come proprio tema ha il mondo nella suatotalità; dall’altra parte, l’istanza della critica, che affiora dai sofisti sino aHume e propone la soggettività come tema d’indagine. Mentre l’interroga-zione del mondo assunto ingenuamente come già-dato degenererà inevita-bilmente in dogmatismo, l’istanza critica, insistendo sul ruolo costitutivodel soggetto nella conoscenza senza riconoscerne lo statuto trascendentale,si “consumerà” sempre nello scetticismo.
Ma progressivamente, nel succedersi di questi tentativi parziali, viene inluce lo statuto trascendentale della soggettività (con Kant) e la necessità delmetodo descrittivo (con Hume). In questo percorso, sono due i momenti cru-ciali individuati da Husserl: Platone, per la “creazione dell’idea della scienzavera e autentica o – cosa che per molto tempo ebbe esattamente lo stesso senso– dell’idea della filosofia”72, e Descartes, che con le sue Meditationes rappre-senta un “inizio completamente nuovo”, poiché tenta, “con un radicalismosinora sconosciuto, di scoprire l’inizio assolutamente necessario della filoso-fia, attingendolo alla autoconoscenza assoluta e completamente pura”73. MaDescartes incorre in un “autofraintendimento”74: egli, avendo raggiunto l’egocome terreno della ricerca, non ne riconosce la natura trascendentale e lo ridu-ce a mero punto di partenza di una costruzione metafisico-dogmatica. La
TELEOLOGIA E QUESTIONE DEGLI INIZI IN HUSSERL 547
contempo indicando nella sua filosofia il compimento del vero idealismo. Per un confron-to tra Husserl e Fichte, il filosofo idealista con cui egli si confronta maggiormente, e a cuidedica un importante ciclo di tre lezioni (E. HUSSERL, Fichtes Menschheitsideal, inAufsätze und Vorträge 1911-21, Husserliana, vol. XXV, a cura di T. Nenon e H.R. Sepp,Kluwer, Dordrecht 1987, pp. 267-293 [trad. it. parziale di F. Rocci, Fichte e l’ideale diumanità. Tre lezioni, ETS, Pisa 2006]), rimandiamo ad A. STAITI, Fenomenologia dell’i-deale. Husserl lettore di Fichte nelle lezioni del 1917, «Annuario Filosofico», XXII (2006),pp. 401-421, in cui vengono tematizzate le questioni della storicità e della teleologia. Siveda anche in I.A. BIANCHI, Etica husserliana. Studio sui manoscritti inediti degli anni1920-1934, Franco Angeli, Milano 1999, il capitolo 7, nel quale è prestata particolareattenzione alla tematica dell’etica come dimensione essenziale del soggetto pensato nellaprospettiva di un idealismo teleologico.
72 HUSSERL, Storia critica delle idee, p. 29.73 Ibidem.74 HUSSERL, La crisi delle scienze europee, p. 106.
03_Sacconaghi:01_Vimercati_04_08 5-06-2009 11:02 Pagina 547
causa di questo equivoco è riconducibile, secondo Husserl, all’assunzione delparadigma ontologico dualista codificato da Galileo, che Descartes eredita eripresenta nella distinzione tra res cogitans e res extensa.
La fenomenologia husserliana si concepisce come conclusione di que-sto percorso e come cominciamento assoluto di una nuova scienza. Essainfatti ha la pretesa di compiere l’istanza originaria della filosofia, al culmi-ne di due percorsi profondamente intrecciati: l’uno che porta a un soggetti-vismo scettico, alla resa rassegnata della ragione di fronte all’apparenteirrealizzabilità dei propri compiti infiniti; l’altro che, sempre a partire da unaposizione soggettivista, riabilita la ragione, affermando l’“impossibilitàetica”75 della sua resa e riconsegnandola all’incessante ricerca del senso.Husserl parla della fenomenologia nei termini di una “rivoluzione” che “puòessere designata come una trasformazione dell’obiettivismo scientifico, diquello moderno ma anche di quello di tutte le filosofie precedenti, [...], in unsoggettivismo trascendentale”76. Infatti, nel momento in cui più grave si fala minaccia scettica, come esito di un secolare irrigidimento nell’obiettivi-smo, la fenomenologia husserliana ne accetta in pieno la sfida e porta a com-pimento le spinte del soggettivismo, emerse nella storia del pensiero comeun filo continuo, conferendogli una “direzione trascendentale”.
L’unità rintracciabile nel divenire della filosofia, riconoscibile a partiredal suo compimento nella fenomenologia, è la tensione a un telos che infor-ma l’intera storia: si tratta di una “teleologia insita nel divenire storico dellafilosofia”77, che consiste perciò nell’“idea unitaria di un compito, il quale sitramanda intersoggettivamente nel corso della storia e che ha fatto irruzio-ne nella storia europea, mediante una ‘fondazione originaria’ di quei filo-sofi, che per primi hanno concepito l’intento completamente nuovo della‘filosofia’ e della cui realizzazione hanno fatto la propria missione”78. Ciòche riconosciamo nella storia come permanente, quella “determinazione disenso sempre uguale, deve per forza provenire dalla ‘fondazione origina-ria’”79: è il “senso finale” della filosofia, che attraversa (costituendola) tuttala sua storia, “‘ereditandosi’ da generazione a generazione”80.
548 ROCCO SACCONAGHI
75 Sul tema dell’etica del continuo rinnovamento e della responsabilità come cifraprofonda dell’umanità pienamente razionale si vedano i cinque saggi che Husserl scrive perla rivista giapponese «Kaizo» tra il 1922 e il 1923, pubblicati in E. HUSSERL, Aufsätze undvorträge (1922-1937), Husserliana, vol. XXVII, a cura di T. Nenon e H.R. Sepp, Nijhoff,Den Haag 1989, pp. 3-94 (trad. it. parziale di C. Sinigaglia, L’idea di Europa, Cortina,Milano 1999).
76 HUSSERL, La crisi delle scienze europee, p. 97.77 Ibi, p. 99.78 HUSSERL, La storia della filosofia e la sua finalità, p. 96.79 Ibi, p. 81.80 Ibidem.
03_Sacconaghi:01_Vimercati_04_08 5-06-2009 11:02 Pagina 548
Se dunque la storia delle scienze si è sviluppata come un progressivooblio delle evidenze originarie, la storia della filosofia è, al contrario, ilcontinuo superamento dell’ingenuità originaria: “È [...] implicita nella sto-ria della filosofia una motivazione manifesta, anche se incompleta, diretta aportare l’ingenuità, come tale, a consapevolezza, a costruire in massimogrado criticamente i presupposti fondamentali delle filosofie e da ultimo diogni filosofia e, infine, a porre tutto ciò in questione”81; questa motivazio-ne “esercita una causalità che determina, definendolo, lo sviluppo di tuttala storia e conferisce forza e, dunque, compiutezza alle sue moltepliciforme di unità e di totalità”82.
In che cosa consiste questa ingenuità originaria che la filosofia è chia-mata a superare? Si tratta di una necessaria implicitezza iniziale del telos.Inizialmente, il telos ha solo una “necessità di fatto”83, ovvero muove lastoria verso l’autocoscienza filosofica prima ancora che se ne prendacoscienza; ma solo in questa presa di coscienza il telos si realizza nella suanatura, vale a dire quella di compito personale del filosofo: “Allora questocompito non ha più soltanto una necessità di fatto ma diventa un compitoche ci è veramente assegnato in quanto siamo filosofi”84. Il senso origina-rio della fondazione della filosofia è “vago”85 per principio, e a propositodel suo senso finale è finora mancata chiarezza “non per motivi casuali,bensì necessari”86: “La fondazione originaria del compito filosofico è unaprima prensione intuitiva, una ‘intuizione’ che inizialmente ha afferratoquesto compito nel primo modo della vaga oscurità e della più ambiguaindeterminatezza”87.
L’ingenuità “all’inizio è inevitabile”88, e il cammino della filosofia è pro-prio quello che “porta al di là dell’ingenuità”89, riattraversando l’atteggiamen-to ingenuo a partire dal livello di coscienza a cui si è giunti. Quest’ingenuitàiniziale comporta una unilateralità necessaria nel modo in cui la filosofia sorgee si sviluppa: “la prima filosofia dei greci” era “ingenuamente orientata versoil mondo esterno”, e questo è il motivo per cui “subì nel suo sviluppo una rot-tura attraverso la scepsi sofistica”90, che a sua volta provocò la reazione di
TELEOLOGIA E QUESTIONE DEGLI INIZI IN HUSSERL 549
81 Ibi, p. 128 (corsivi nostri).82 Ibi, p. 129.83 HUSSERL, La crisi delle scienze europee, p. 99.84 Ibidem.85 Ibi, p. 515.86 HUSSERL, La storia della filosofia e la sua finalità, p. 109.87 Ibi, p. 117.88 HUSSERL, La crisi delle scienze europee, p. 350.89 Ibidem.90 HUSSERL, Storia critica delle idee, p. 29.
03_Sacconaghi:01_Vimercati_04_08 5-06-2009 11:02 Pagina 549
Socrate, che ad essa si oppose come “riformatore pratico”91. Il cammino èstato finora caratterizzato da continue “sedimentazioni”92 del telos, il qualetuttavia può sempre essere ridestato, attraverso un’operazione tesa a “rivivifi-care la concettualità sedimentata, la quale, diventata ovvietà, costituisce il ter-reno del suo lavoro privato e non-storico”, per sorprenderne “il nascosto sensostorico”93. Solamente attraverso una “reiterata considerazione, una riprodu-zione, un rinnovamento dell’originarietà, dell’evidenza del suo senso pro-prio”94 la filosofia può realizzarsi come “conoscenza universale”95. La filoso-fia, come attuazione definitiva della ragione umana nella sua integralità, èancora alla ricerca del proprio inizio, ovvero della propria “fondazione fina-le”96, che rinnova in sé la fondazione della modernità, la quale è a sua volta“una rifondazione e una trasformazione dell’originaria fondazione greca”97: lafenomenologia rappresenta l’iniziale realizzazione di questa “fondazione fina-le che il processo storico non può eludere”98, e che si realizza nel momento incui “giunge a una perfetta chiarezza il compito corrispondente”99.
La piena chiarezza del compito, finalità dell’autoconsiderazione stori-ca husserliana, coincide con il delinearsi della fisionomia del metodo dellaricerca filosofica: la filosofia giunge così “al suo inizio, al suo orizzonte direalizzazione apodittica”100. Perciò, più che la “conclusione dello svilup-po”, la fenomenologia rappresenta “un inizio in cui sarebbe superata lavaghezza relativa all’idea e al metodo e quell’opera infinita diverrebbe ope-rativa nell’iniziare e nel continuare a costruire di fatto, ovvero nel conti-nuare a costruire sempre già un compito infinito di quell’infinitezza sempreirrisolta, per le future generazioni di ricercatori”101.
4. L’“inizio teleologico”
L’origine si è quindi dimostrata come ciò a cui occorre tornare in quantoluogo dell’evidenza perduta e, al contempo, ha rivelato come suo caratte-
550 ROCCO SACCONAGHI
91 Ibi, p. 30.92 Per un’indagine rigorosa sul significato dei concetti husserliani Stiftung e
Sedimentierung (“fondazione” e “sedimentazione”), rimandiamo a J. DODD, Crisis and reflec-tion, Kluwer, Dordrecht 2004, in particolare il capitolo 2, The manifold sense of foundation.
93 HUSSERL, La crisi delle scienze europee, p. 100.94 Ibi, p. 350.95 Ibidem.96 Ibi, p. 100.97 Ibi, p. 99.98 Ibi, p. 100.99 Ibi, p. 101.100 Ibidem.101 HUSSERL, La storia della filosofia e la sua finalità, p. 117.
03_Sacconaghi:01_Vimercati_04_08 5-06-2009 11:02 Pagina 550
re essenziale una sorta di oscurità, un’inevitabile ingenuità che caratteriz-za gli “inizi” in quanto tali. Si tratta dunque di un complesso intersecarsidi linee, che hanno come propria comune conclusione una situazione sto-rica che vede al contempo la negazione più radicale della soggettività,nella forma dell’obiettivismo positivista, e la sua massima affermazione,tramite la tematizzazione di essa resa possibile dalla riduzione fenomeno-logica. Il doppio carattere dell’inizio dello sviluppo filosofico-scientifico,inteso come luogo dell’evidenza a cui tornare e luogo dell’ingenuità dasuperare e “illuminare”, dipende dalla sua particolare natura di “inizioteleologico”102.
Questo inizio teleologico rappresenta la nascita di quella particolare pras-si, la “prassi teoretica”103, che rende possibile il cammino verso la piena presadi coscienza del soggetto, nella forma della fenomenologia. È un inizio sto-rico che rappresenta la possibilità di un superamento della fattualità storicastessa e dei suoi limiti: in questo senso è un “fatto” sui generis e costituiscel’unico vero inizio, perché inaugura un irreversibile “movimento di progres-siva trasformazione”104 dell’umanità. Se, da una parte, “la Ragione teleologi-ca abitava già l’umanità nei suoi tipi empirici prima della presa di coscienzafilosofica che l’ha fatta nascere a se stessa, annunciando alla storia il sensopuro della storicità, vale a dire il suo senso stesso”105, dall’altra “la presa dicoscienza di ciò che vi era segna già una rottura e, di conseguenza, un’origi-ne radicale e creatrice”106. La nascita della filosofia presenta una natura par-ticolare: con essa si inaugura, nella storia, una nuova storicità.
4.1. La coscienza pre-filosofica: l’origine mitica
Husserl individua tre gradi della storicità. In un primo senso, la storicitàè una dimensione propria della vita in quanto tale: “La vita umana ènecessariamente storica”107; l’esistenza umana è sempre “un che di stori-co, in questo senso lato, un che di inferiore, di primitivo, o di superiore,con una forma spirituale misera o ricchissima”108. In questo senso, la sto-ricità “è già da sempre in atto”, essendo “un che di generale che inerisceall’esistenza umana”109: essa si configura come “un divenire unitario delle
TELEOLOGIA E QUESTIONE DEGLI INIZI IN HUSSERL 551
102 ID., La crisi delle scienze europee, p. 99.103 Ibi, p. 140.104 Ibi, p. 335.105 DERRIDA, Introduzione a Husserl, p. 206.106 Ibidem.107 HUSSERL, La crisi delle scienze europee, p. 529.108 Ibidem.109 Ibidem.
03_Sacconaghi:01_Vimercati_04_08 5-06-2009 11:02 Pagina 551
persone, nelle persone, e in quanto mondo circostante, nella molteplicitàdelle figure del mondo circostante”110. L’evoluzione umana in quanto tale“si distingue nettamente dal tipo di uno sviluppo organico e anche daquello di uno meramente animale”111: a differenza dell’animale, infatti,che in “una condizione di regolare soddisfazione dei suoi istinti e deivalori con ciò definiti vive in un mondo ambiente finito in una tempora-lità ristretta”, l’uomo, anche se a questo grado della storicità non ne haancora piena coscienza, “vive nell’‘infinito’, che è il suo costante oriz-zonte di vita, [...] eccede gli istinti, crea valori di grado superiore ed ecce-de questi valori”112.
A questo grado di storicità si impongono già “questioni relative almondo e legate ad una curiosità universale”113, ma si tratta di un livelloancora pre-scientifico: si rimane sempre all’interno del contesto della tra-dizione nazionale particolare. Nel “mondo delle tradizioni nazionali”, “ilmitico è uno strato comune profondamente penetrato nella più ordinariaquotidianità”114: il mondo si offre in una pre-comprensione mitologica, èimpregnato di interpretazioni tradizionali che chiudono in un’inesorabilefinitezza l’orizzonte delle questioni relative al senso.
La storicità delle culture non ancora investite dalla “rivoluzione” filo-sofica, definite dall’esercizio di un sapere mitico al servizio della prassireligiosa, è una storicità essenzialmente finita, chiusa all’interno dell’o-rizzonte della propria tradizione: “La cultura extra-scientifica, la culturanon ancora sfiorata dalla scienza, è un compito e un’operazione dell’uo-mo nella finitezza”115, poiché “l’orizzonte infinitamente aperto in cui eglivive non si è ancora dischiuso; i suoi fini, le sue azioni, la sua attività ele sue evoluzioni, la sua motivazione personale, di gruppo, nazionale,mitica, tutto si muove nella dimensione del mondo circostante finito econtrollabile”116. In essa, cioè, non si dà alcuna prospettiva di sviluppoteleologico: il legame alla tradizione come cifra fondamentale dell’eser-cizio del sapere implica una concezione dell’origine come qualcosa checi precede, da cui si proviene e a cui si è “soggetti”. Lo sviluppo del sape-re, in queste civiltà, si definisce perciò come continua reiterazione dellatradizione.
552 ROCCO SACCONAGHI
110 Ibidem.111 HUSSERL, L’idea di Europa, p. 42.112 ID., Zur Phänomenologie der Intersubjektivität, Dritter Teil (1929-1935),
Husserliana, vol. XV, a cura di Iso Kern, Nijhoff, Den Haag 1973, p. 405.113 ID., La storia della filosofia e la sua finalità, p. 93.114 Ibidem.115 Ibidem.116 HUSSERL, La crisi delle scienze europee, p. 337.
03_Sacconaghi:01_Vimercati_04_08 5-06-2009 11:02 Pagina 552
4.2. La coscienza filosofica: il sorgere delle idee e il tradimento del telos
“La vita scientifica, la vita degli scienziati nell’orizzonte degli altri scienziati,comporta una nuova storicità”117: si tratta della soglia della filosofia al suoprimo grado, che rappresenta “il secondo grado dell’umanità”118. L’insorgenzadell’atteggiamento teoretico ha come frutto le idee che, rispetto alle altre ogget-tualità, presentano un “genere d’essere completamente diverso, una diversatemporalità”119: “Implicitamente [...] con l’‘essente’ in senso filosofico, [...] èentrata in scena l’infinità”120. A partire dallo svelarsi dell’orizzonte dell’infinità,prima impensabile, “si diffonde una nuova umanità [...] che, pur vivendo nellafinitezza, vive protesa verso i poli dell’infinità”121. Emerge l’idea del compitoinfinito, inteso come incessante tensione alla verità come telos.
Nella cultura filosofica si forma una “nuova comunità interiore [...] fon-data su interessi puramente ideali”122; questa comunità di nuovo tipo, in cuigli uomini sono “congiunti nella dedizione alle idee”123, ha un caratterenecessariamente universale, poiché le idee “nella loro identità sono propriedi tutti”124, e perciò si presenta come trans-nazionale. Questo “affrancamen-to dalla relatività delle verità situazionali”125 determina un’“autentica rivolu-zione nella costituzione del senso del mondo”126, che finora “era comprensi-bile per ognuno a partire dalla tradizione nazionale”127, mentre adesso “è l’u-niverso di tutte le cose identiche, dell’‘essente’ nel nuovo senso filosofico, ilcui essere proprio è ritenuto diverso da tutte le apprensioni tradizionali”128.
Ma i primi filosofi “ereditano” l’ingenuità dell’esperienza naturale pre-scientifica, ipostatizzando le nuove formazioni ideali129 e dimenticandocompletamente la loro radice nell’esperienza soggettiva del mondo-della-
TELEOLOGIA E QUESTIONE DEGLI INIZI IN HUSSERL 553
117 Ibi, p. 535.118 Ibi, p. 530.119 Ibi, p. 336.120 HUSSERL, La storia della filosofia e la sua finalità, p. 95.121 ID., La crisi delle scienze europee, p. 335.122 Ibi, p. 346.123 Ibidem.124 Ibidem.125 HUSSERL, La storia della filosofia e la sua finalità, p. 90.126 Ibi, p. 93.127 Ibidem.128 Ibidem.129 Cfr. ibi, p. 96. Come spiega Nicoletta Ghigi nel suo saggio introduttivo a La storia
della filosofia e la sua finalità, “questo rifiuto della possibilità gnoseologica della doxa,ossia della verità di quel senso comune tradizionalmente tramandatosi, di contro all’asso-luta unicità di valore dell’episteme, ossia della verità obiettiva, si rivela già dal principioimproduttiva per diverse ragioni. Una di queste, a suo avviso, è l’assumere quelle validitàingenue, ancora proprie dell’atteggiamento naturale che le assumeva come valide
03_Sacconaghi:01_Vimercati_04_08 5-06-2009 11:02 Pagina 553
vita, vale a dire la “tanto disprezzata doxa”130, l’unico ambito dell’espe-rienza in cui “ha senso il discernimento di vero e falso, in riferimento allaeffettiva validità di esistenza o meno”131. In questo modo, “tutti i concettignoseologici si trasformano, per così dire, dall’interno e, come se nonbastasse questo disprezzo della validità della doxa, vengono tolti ad essa iconcetti di essere, di verità, di fondazione e di ragione e, d’ora in avanti,solamente l’episteme concernente la vera ragione e i suoi concetti partico-lari correlati sono proclamati come autentici”132.
Husserl vede in questa iniziale distinzione perentoria tra doxa ed epi-steme, che dimentica il radicarsi di questa su quella, e nella conseguenteattribuzione alla sola episteme di una validità conoscitiva, l’inizio dell’o-biettivismo innaturale che si mostrerà in tutta la sua gravità secoli dopo,conducendo alla separazione tra razionalità ed esistenza133. La situazioneattuale deriva perciò da quell’inavvertita dimenticanza del terreno fondan-te di ogni conoscenza: “Ormai [...] le singole scienze prosperano nel loroisolamento; la filosofia, che era chiamata a dar loro unità, è disprezzata. Lescienze, che si rendono autonome, credono di non averne bisogno; e l’uo-mo pratico, che vive alla giornata, utilizza le scienze là dove lo aiutanotecnicamente e gli offrono mezzi per la realizzazione di scopi pratici acci-dentali”134.
Paradossalmente, l’oblio dell’origine naturale in nome dell’abbandonodel legame con ogni tradizione religiosamente o miticamente intesa e conil mondo della doxa, considerato altrettanto arbitrario, porta a un’altraforma di concezione “mitologica” dell’origine: quella del naturalismoscientista che, nella forma dello psicologismo, pretende di far risalire leoperazioni costitutive del senso dell’esperienza a dinamiche meramentepsicologiche. Tanto la spiegazione kantiana, quella del vuoto formalismo,quanto quella del naturalismo in ogni sua versione, compresa quella stori-
554 ROCCO SACCONAGHI
in maniera a-problematica (come la ‘possibilità indubitabile di dimostrare ogni intenzio-ne’), e che, per l’appunto nell’atteggiamento teoretico, vengono ri-assunte senza essererivalutate nei relativi fondamenti” (pp. 41-42).
130 HUSSERL, La crisi delle scienze europee, p. 148.131 N. GHIGI, Introduzione a HUSSERL, La storia della filosofia e la sua finalità, p. 42.132 Ibi, p. 96.133 Questa separazione di principio tra la scienza come sapere rigoroso e le problema-
tiche ineludibili legate al senso dell’esistenza è uno dei temi fondamentali della Conferenzadi Praga del 1935: di fronte a una scienza che “esclude di principio proprio quei problemiche sono i più scottanti per l’uomo” (HUSSERL, La crisi delle scienze europee, p. 35), lafenomenologia si costituisce come una scienza “aperta a queste questioni di senso cosìcome ai problemi che riguardano l’esistenza” (N. GHIGI, La metafisica in Husserl, FrancoAngeli, Milano 2007, p. 208).
134 HUSSERL, L’idea di Europa, p. 135.
03_Sacconaghi:01_Vimercati_04_08 5-06-2009 11:02 Pagina 554
cistica, sono “mitiche”135, nel senso che non possono esibire la loro legitti-mità, non essendo state attinte all’esperienza mediante intuizione imme-diata. La coscienza filosofica “spezza” il legame mitico con l’origine apren-do l’orizzonte dell’infinità, ma, negando il legame con l’origine tout-court,non si avvede dell’origine trascendentale e così ripete il mito, producendol’assurdità dell’origine “naturale”.
4.3. La coscienza fenomenologica: l’inizio come telos
Il terzo grado della storicità si raggiunge con la “trasformazione della filo-sofia in fenomenologia”136: non si tratta dell’esito conclusivo di una storiadi cui si può scorgere l’inizio passato, bensì di un inizio consapevole dellapropria natura in quanto aperto a ciò che “deve essere”. Questa nuova sto-ricità, infatti, non si definisce in altro modo se non come il fondarsi su ciòa cui si tende: in questo senso, l’inizio è il telos.
L’inizio del tragitto della filosofia è possibile solamente nella presa dicoscienza che ne attua il filosofo: “Il telos esiste a partire dal filosofo ori-ginariamente fondante in poi (esiste in quanto ricompreso e apodittica-mente assunto dagli uni e poi dagli altri) ed esso esplicita la più profondae particolare unità della comunità di tutti i filosofi, nell’unità della sto-ria”137. Vale a dire, la fondazione della filosofia non avviene come applica-zione di un progetto concepito in precedenza, ma come lo svelarsi del pro-blema della verità e, con esso, dell’orizzonte dell’infinità. Il telos porta anuovi gradi di autocoscienza e, al contempo, le progressive prese dicoscienza costituiscono la condizione per cui il telos si realizzi pienamen-te. Noi infatti, in particolare noi moderni, siamo i “portatori” di questateleologia, in quanto “contribuiamo ad attuarla”138 attraverso la nostravolontà personale.
La natura dell’inizio teleologico si definisce dunque in relazione a ciòdi cui è l’inizio e non “deriva” da ciò da cui pur proviene: esso non si fondain ciò che lo precede, ma in ciò che inaugura. In questo senso è compren-sibile il doppio carattere dell’origine e la necessità della considerazionestorica che si è imposta a Husserl: essendo un inizio che assume il propriosenso a partire dallo sviluppo di ciò di cui è l’inizio, esso vive immerso in
TELEOLOGIA E QUESTIONE DEGLI INIZI IN HUSSERL 555
135 A proposito delle “operazioni strutturanti della soggettività pura” che Kant intra-vede, Husserl dice che sembrano rimanere sospese “in un’atmosfera enigmatica, comel’operare di facoltà trascendentali che restano mitiche” (HUSSERL, Storia critica delle idee,p. 211).
136 ID., La crisi delle scienze europee, p. 530.137 ID., La storia della filosofia e la sua finalità, p. 121.138 ID., La crisi delle scienze europee, p. 99.
03_Sacconaghi:01_Vimercati_04_08 5-06-2009 11:02 Pagina 555
un’oscurità essenziale che attende di venir rischiarata, e solo a partire daquesto sviluppo può essere ricompreso.
Si tratta di un cammino dalla coscienza ingenua sino alla compiutaautocoscienza, che si attua come “un giusto ritorno all’ingenuità della vita,ma attraverso una riflessione che s’innalzi al di sopra di essa”139. Gli inizioscuri sono aperti allo sviluppo successivo e da esso rischiarati: essi sonoteleologicamente disposti in un’apertura alla comprensione di sé.
4.3.1. La “nascita spirituale”
“Naturalmente – dice Husserl – la nascita dell’atteggiamento teoretico,come tutto ciò che diviene storicamente, ha una sua motivazione di fatto nelcontesto concreto degli accadimenti storici”140, rappresentata dall’incontrodei greci con altre comunità nazionali: “Nell’intimità dell’interazione tra idiversi popoli presto sollecitata ed in continuo accrescimento attraverso legenerazioni”141, accadde ai greci di prendere coscienza di uno strato comu-ne dell’esperienza, un livello “oggettivo” irriducibile alle molteplici rap-presentazioni mitologiche nazionali. “In tutte le diversità dei mitologhemipropri e stranieri (di quelli egizi, persiani e simili)”142 era infatti riconosci-bile “anche un nucleo extra-mitologico”143, uno strato invariante dell’espe-rienza: “Si tratta certamente dello stesso sole, della stessa luna, della stes-sa terra, dello stesso mare, ecc., che diviene oggetto del mito così in manie-ra diversa nei diversi popoli, a seconda certamente della loro tradizione”144.
Sorge così la coscienza della differenza tra “la rappresentazione delmondo e il mondo reale” e si pone il nuovo problema della verità, intesacome verità in sé, “identica e valida, non più accecata dalla tradizione”145:in altri termini, si tratta del “divenire-tangibile di una certa relatività”146.
556 ROCCO SACCONAGHI
139 Ibi, p. 88.140 Ibi, p. 343 (corsivo nostro).141 HUSSERL, La storia della filosofia e la sua finalità, p. 91.142 Ibidem.143 Ibidem.144 Ibidem.145 HUSSERL, La crisi delle scienze europee, p. 344.146 ID., La storia della filosofia e la sua finalità, p. 91. Ne Il cerchio e l’ellisse, Vincenzo
Costa attua una dettagliata analisi delle fasi di questa trasformazione dell’atteggiamentonaturale verso l’insorgenza dello stupore per il mondo come tonalità emotiva essenzialedell’atteggiamento teoretico. Cfr. in particolare il capitolo 8, La manifestatività: verità estoria, in cui si insiste sulla distinzione tra l’affermazione della storicità come dimensionetrascendentale dell’esistenza e lo storicismo, inteso come prospettiva che assorbe la veritàcome punto di vista temporaneo e relativo alla particolare “apertura di mondo” in cui ci sitrova: “L’idea di verità non si dissolve nella varietà dei mondi storici. Tutti i mondi storici
03_Sacconaghi:01_Vimercati_04_08 5-06-2009 11:02 Pagina 556
Ma la novità epocale della filosofia non può sorgere da questa “moti-vazione di fatto”, la sua natura di inizio teleologico non può essere ricon-dotta a cause meramente empiriche: si tratta di un fatto “che deve avere tut-tavia la sua essenza”147. Non si può perciò concepire questa origine come“storica” nel senso di meramente fattuale, cioè empirica, destinata adaggiungersi alle altre confondendosi con esse: in questo modo, infatti, sinegherebbe il carattere peculiare di ogni effettiva origine, ovvero il suocostituire un inizio nuovo, l’insorgenza di una reale differenza.
Per cogliere la natura profonda di questa nascita, che si configuracome una rottura radicale e definitiva, Husserl ne descrive gli effetti: l’at-teggiamento teoretico ha come frutto le idee, le quali generano un uomonuovo, definito dall’orizzonte dell’infinità del compito etico-conoscitivo.Se fosse riducibile a un’origine empiricamente intesa, la filosofia costi-tuirebbe solamente una figura temporanea della continua metamorfosi delmondo, il quale, continuando il suo corso, la condannerebbe a mutareforma negandone l’identità. La sua insorgenza è da considerarsi storicanel senso della peculiare storicità da essa stessa inaugurata, vale a direl’instaurazione della storia come storia del senso: la storia è tale, e non siriduce a una mera successione temporale di fatti slegati tra loro, in quan-to assume un senso costituendosi come infinita tensione a un telos.Questa origine storica, verificatasi nello spazio e nel tempo, non è da essicompletamente definita, nel senso di delimitata: una volta accaduta, infat-ti, li “trasfigura”, istituendo una nuova storicità: si tratta di una “nascitaspirituale”148.
Solo così è comprensibile l’insorgenza della geometria, inspiegabile apartire dalla sua “base”, costituita dall’idealità morfologica: “Le fondazio-ni – osserva Derrida – non sono qui dei fondamenti, benché questi non deb-bano far dimenticare quelle”; è infatti sempre “un ‘pensare puro’ che èresponsabile dello slancio idealizzatore e della verità geometrica cometale”149. Sempre Derrida nota come l’idealizzazione che permette il pas-saggio dalle forme vaghe dell’empiria descrittiva a quelle della geometriasi presenti come un “atto inaugurale assoluto”, in forza di una “libertà radi-cale e irrompente che in esso si manifesta”150. Anche qui siamo di fronte aun’insorgenza storica non spiegabile a partire da ciò che l’ha preceduta,
TELEOLOGIA E QUESTIONE DEGLI INIZI IN HUSSERL 557
sono riferiti, intenzionalmente, all’idea di verità, cioè all’unico mondo, poiché tutti deter-minano, con significati diversi, gli stessi oggetti percettivi” (V. COSTA, Il cerchio e l’ellis-se. Husserl e il darsi delle cose, Rubbettino, Soveria Mannelli 2007, p. 172).
147 HUSSERL, La crisi delle scienze europee, p. 344.148 Ibi, p. 334.149 DERRIDA, Introduzione a Husserl, p. 193.150 Ibidem.
03_Sacconaghi:01_Vimercati_04_08 5-06-2009 11:02 Pagina 557
bensì “a partire da una struttura anticipativa dell’intenzionalità [...], versoil polo ideale e invariante di una approssimazione infinita”151.
4.3.2. La possibilità della crisi iscritta nell’origine
Oltre alla natura particolare della nascita, “storica” in un senso inaudito, ciòche viene reso comprensibile dall’idea dell’inizio come telos è il fenome-no della crisi, altrimenti inspiegabile nella prospettiva di una teleologia chefosse pensata nei termini di un inesorabile dispiegarsi di un senso già con-tenuto nell’inizio. Come può essere “negato” dal processo storico ciò chepermette lo svolgimento del processo stesso?
È per la peculiare natura dell’inizio teleologico (che si riflette nelduplice carattere dello sviluppo storico) che può verificarsi la crisi.Innanzitutto è il carattere essenzialmente oscuro degli inizi che rende pos-sibile lo smarrirsi del senso proprio del momento attuale: “L’inizio di ognievoluzione è imperfezione”152. Ma perché vi sia imperfezione, deve giàessersi inaugurata un’evoluzione. Vale a dire, perché qualcosa possa pre-sentarsi come “imperfetto”, occorre che si sia già presa coscienza dellaperfezione come “idea teleologica”153, la quale “guida coerentementenello sviluppo”154. Il cammino innescato dall’inizio teleologico implicaoriginariamente in sé il raggiungimento della piena autocoscienza, il cuicompimento, in questa prospettiva, ha ancora da venire; coerentemente, ipassi compiuti con una coscienza ancora parziale conserveranno un carat-tere di unilateralità, pur realizzando, nel corso dello sviluppo, un relativosuperamento dell’ingenuità.
Ma l’oblio della crisi non è quello dell’atteggiamento naturale, è moltopiù radicale. Mentre quello naturale, che ha come radice profonda la natu-ra “anonima” dell’intenzionalità fungente, è aperto al proprio superamentoessendo in esso innata la disposizione al telos, l’alienazione dell’obiettivi-smo, essendo nata a partire dalla spinta della filosofia, ne ha in un certosenso neutralizzato la spinta trascendentale, assorbendone solamente lapotenza idealizzatrice, la capacità d’astrazione. L’obiettivismo del positivi-smo, culmine dell’alienazione dell’umanità europea, è infatti possibile lad-dove è sorto il secondo grado della storicità; solo laddove l’umanità sia “giàdivenuta consapevole di questo telos (avendo mangiato dell’albero dellaconoscenza)”155, avendo rinunciato a portarlo “alla più piena coscienza”, è
558 ROCCO SACCONAGHI
151 Ibidem.152 HUSSERL, L’idea di Europa, p. 45.153 Ibidem.154 Ibidem.155 Ibi, p. 136.
03_Sacconaghi:01_Vimercati_04_08 5-06-2009 11:02 Pagina 558
possibile giungere all’assurdità dell’affermazione di una “verità in sé”, diun senso estraneo alla correlazione intenzionale. Si tratta propriamente diuna “interpretazione assurda”156, la quale infatti deriva da
un’assolutizzazione filosofica del mondo, che è del tutto estranea alla considera-zione naturale del mondo stesso. Quest’ultima è appunto naturale, essa vive inge-nuamente nel compimento della tesi generale da noi descritta, per cui non può maidiventare assurda. L’assurdità nasce quando si filosofa e, volendo comprendere ilsenso ultimo del mondo, ci si lascia sfuggire che il mondo stesso possiede il suoessere complessivo come un certo “senso” che presuppone la coscienza assolutaquale campo del conferimento di senso157.
La filosofia “esaspera” e radicalizza le due possibilità della coscienza trascen-dentale: obliarsi nell’oggetto nell’atto stesso del costituirlo158 o cogliersi come“fonte trascendentale del senso” in forza della spinta etica all’autocompren-sione. L’esasperazione dell’oblio soggettivo accade quando il pensiero si ridu-ce a tecnica. Il “perdersi temporaneo in un pensiero meramente tecnico”159
rappresenta “qualcosa di completamente legittimo, anzi di necessario”160 alcostituirsi e al crescere delle scienze, ma lo scienziato è chiamato a prenderconsapevolezza della relatività delle proprie operazioni: “Tutto ciò può e devecostituire un metodo inteso e praticato coscientemente”161.
Quando la filosofia viene meno al suo compito di guida delle scienze,queste perdono il loro riferimento al problema della verità e i ruoli inevita-bilmente si invertono: la filosofia assume il paradigma codificato in ambi-to scientifico, come è avvenuto quando Descartes assunse il dualismo gali-leiano come “modello ontologico” della sua filosofia. La capacità astratti-va della scienza, resa a sua volta possibile dallo svelarsi della dimensioneideale che coincide con il sorgere della filosofia, viene potenziata ed “este-sa” all’intera esistenza: non si astrae solo il singolo tema dalla totalità deinessi dell’esperienza, ma si astrae dall’esistenza il soggetto stesso.
TELEOLOGIA E QUESTIONE DEGLI INIZI IN HUSSERL 559
156 E. HUSSERL, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischenPhilosophie. Erstes Buch: Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie,Husserliana, vol. III/1, a cura di K. Schuhmann, Nijhoff, Den Haag 1976 (trad. it. di V.Costa, Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica. Libro primo:Introduzione generale alla fenomenologia pura, Einaudi, Torino 2002, p. 140).
157 Ibidem.158 Così si esprime Merleau-Ponty, parlando della “costituzione della cosa”: “Noi ci
ignoriamo in essa, ed è appunto ciò a farne una cosa” (M. MERLEAU-PONTY,Phénoménologie de la perception, Librairie Gallimard, Paris 1945 [trad. it. di A. Bonomi,Fenomenologia della percezione, Bompiani, Milano 2003, p. 442]).
159 HUSSERL, La crisi delle scienze europee, p. 76.160 Ibidem.161 Ibidem.
03_Sacconaghi:01_Vimercati_04_08 5-06-2009 11:02 Pagina 559
La nascita della filosofia è perciò l’inizio di quel telos che, se tradito,ingenera una crisi altrimenti impossibile. Ma, se la nascita della nuova sto-ricità porta con sé la possibilità della crisi, essa esalta anche la possibilitàdi percepire questa crisi come tale, e solo in risposta alla “sfida” di questacrisi è potuta sgorgare la fenomenologia, come fondazione finale e terzogrado della storicità. Il compimento della filosofia, che si ha al livello dellastoricità cui si giunge con la fenomenologia, è quello definito dall’inces-sante tensione al telos: “Una volta che, lungo lo sviluppo, il telos si rivelacome tale alla coscienza, esso diventa necessariamente anche un fine prati-co della volontà; si delinea così un grado nuovo e più alto dello sviluppo,una fase retta da norme, da idee normative”162.
Quel che si è rivelato tramite la considerazione trascendentale dellapropria storia è un’“aderenza ultima e autentica alla propria origine”163:l’inizio continua a valere come tale, non è mai superato, perché non è cro-nologico-fattuale, bensì trascendentale. Si supera in questo modo la con-cezione pre-filosofica dell’origine mitica e quella pre-fenomenologica del-l’origine empirica, e si apre l’orizzonte del cammino infinito alla veritàcome telos.
560 ROCCO SACCONAGHI
162 Ibi, p. 334.163 Ibi, p. 47.
03_Sacconaghi:01_Vimercati_04_08 5-06-2009 11:02 Pagina 560