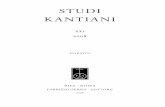ASSET PROTECTION TRUST E DIRITTO PUBBLICO STRANIERO: UNA QUESTIONE DI PRINCIPIA
L’Eni e la questione petrolifera in Iraq negli anni Sessanta
Transcript of L’Eni e la questione petrolifera in Iraq negli anni Sessanta
Aldo Moro, l’Italia repubblicana e i popoli del
Mediterraneoa cura di
Italo Garzia, Luciano Monzali, Federico Imperato
Impaginazione Paola PerrucciProgetto grafico originale Loredana My
© Salento BooksVia Duca degli Abruzzi, 15
73048 Nardò (LE)Tel. +39 0833 871608Fax +39 178 277 6708
Opera realizzata con i Fondi PRIN 2008, con il contributo della Regione Puglia – Assessorato al Mediterraneo, Cultura, Turismo e con il patrocinio della Fondazione Gramsci di Puglia, del Centro di Studi e Formazione nelle Relazioni Interadriatiche-Cesforia di Bari e di Europe Direct Puglia.
9
11
15
56
68
125
163
199
215
233
275
302
341
376
400
Indice
Prefazione di Luigi Masella
Introduzione di Luciano Monzali, Federico Imperato, Italo Garzia Aldo Moro, la Csce e il Mediterraneo di Luciano Tosi Il Mediterraneo nel pensiero politico di Aldo Moro di Italo Garzia Aldo Moro e la politica estera dell’Italia repubblicana nel Mediterraneo (1969-1978). Momenti e problemi di Luciano Monzali Aldo Moro e i rapporti italo-turchi (1963-1972) di Federico Imperato L’Italia e la crisi cipriota di Paolo Soave Aldo Moro e le relazioni italo-iraniane di Soroor Coliaei Tempi nuovi. Moro, Israele e la svolta filo-araba della diplomazia italiana (1967-1976) di Daniele Caviglia Aldo Moro, l’Italia e la questione palestinese di Miriam Rossi L’Italia e Moro tra Nasser e Sadat di Massimiliano Cricco Moro, l’Italia repubblicana e la Libia. Momenti e problemi delle relazioni bilaterali di Lorenzo Medici Il Pci e il Mediterraneo negli anni Settanta: il Medio Oriente di Luca Riccardi La questione arabo-israeliana nelle posizioni di politica estera del Movimento Sociale Italiano tra la guerra dei Sei Giorni e quella dello Yom Kippur di Thomas TonucciL’Eni e la politica estera italiana in Siria e in Libano (1962-1973) di Silvio Labbate
441
498
534
576
578
L’Eni e la questione petrolifera in Iraq negli anni Sessanta di Massimo Bucarelli L’Eni e l’Algeria (1963-1973) di Rosario Milano Moro, Berlinguer e le antinomie dell’eurocomunismo di Giuseppe Vacca Note biografiche degli autori
Indice dei nomi
7
Elenco dei fondi archivistici, delle raccolte documentarie, delle sigle e delle abbreviazioni
A/PV – United Nations General Assembly/Verbatim RecordAAPBD – Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland, München, 1993 sg.ABC – Archivio Storico Fondazione Bettino Craxi, RomaACS – Archivio Centrale dello Stato, RomaAFT – Archivio Storico della Fondazione di Studi Storici Filippo Tu-rati, FirenzeAL – Afrique et LevantALUCE – Archivio Storico LuceAMAE – Archives du Ministère des Affaires Etrangères, ParisAMEI – Archivio del Ministero degli Affari Esteri Iraniano, Tehran/TeheranAP – Atti ParlamentariAPCI – Archivio Storico del Partito Comunista ItalianoASDMAE – Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, RomaASE – Archivio Storico dell’Eni, Pomezia (Roma)ASPR – Archivio Storico della Presidenza della Repubblica, RomaASSR – Archivio Storico del Senato della RepubblicaBAC – BAC Fonds-EEC and ECSC CommissionsBPA – British Petroleum Archive, University of Warwick, Coventry (United Kingdom)CC – Co-ordinating Committee / Comitato CentraleCF – Country FilesCFPF – Central Foreign Policy FilesCSCE – Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione EuropeaDBPO – Documents on British Policy Overseas, London, DDF – Documents Diplomatiques Français, Parigi-Berna, 1987 sg.DGAP – Direzione Generale Affari PoliticiFAF – Fondo Amintore FanfaniFAM- Fondo Aldo MoroFBC – Fondo Bettino CraxiFCO – Foreign and Commonwealth Office
8
FENI – Fondo EniFGG – Fondo Giovanni GronchiFIG – Fondazione Istituto Gramsci, RomaFO – Foreign OfficeFPCM – Fondo Presidenza del Consiglio dei MinistriFRL – Fondo Riccardo LombardiFRUS – Papers on Foreign Relations of the United States (dal 1932 Foreign Relations of the United States), Washington DC, 1861 sg.HAEU – Historical Archives of European Union, FirenzeIAI – Istituto Affari InternazionaliILS – Istituto Luigi SturzoMAE – Ministero degli Affari EsteriNA – National Archives, Kew, LondraNARA – National Archives and Record Administration, College park, MDNPMS – Nixon Presidential Material Staff FilesNSC – National Security CouncilPA – Politisches Archiv, BerlinRG 59 – General Records of Department of StateRPI ONU – Rappresentanza Permanente Italiana all’OnuSE – Sérié Europe 1956-60. GénéralitésSSI – Sous Sérié Italie (1961-1970)b. busta, boxd. documento / dd. documentif. fascicolon. numero / nn. numeriRis. Risoluzione / Riss. Risoluzionis. series.a. senza autores.d. senza datasez. sezionesg. seguentiss. sottoserievol. volume / voll. volumi
441
Massimo BucarelliL’Eni e la questione petrolifera in Iraq negli anni
Sessanta
Il 1° giugno del 1972, il presidente della Repubblica irachena, il generale Ahmed Hasan al-Bakr, annunciò la decisione del governo di Baghdad di nazionalizzare le attività petrolifere della Iraq Petroleum Company (Ipc),1 società partecipata da alcune delle maggiori compa-gnie internazionali (British Petroleum, Royal Dutch Shell, Compagnie Française des Pétroles, Standard Oil of New Jersey/Esso e Standard Oil of New York/Mobil) e detentrice, fino ad allora, della concessione per lo sfruttamento di uno dei giacimenti più ricchi dell’intero Medio Oriente, nella zona di Kirkuk, nel nord del paese.2 La nazionalizzazio-ne dell’Ipc poneva fine a un lungo contenzioso tra le multinazionali e i vari governi iracheni, che si erano succeduti al potere dopo la fine della monarchia hashemita nel 1958. Motivo del confronto era stato il tentativo da parte delle autorità irachene di riequilibrare il rapporto con le compagnie petrolifere nella gestione delle immense ricchezze presenti nel sottosuolo del paese, affinché, contrariamente a quanto accaduto per decenni, la maggior parte dei notevoli profitti derivanti dallo sfruttamento delle riserve di greggio non finisse più nelle casse delle major, bensì in quelle dello Stato iracheno.3
In quello stesso periodo, tra il marzo 1972 e il febbraio 1973, men-
1 Nota dell’Ambasciata della Repubblica dell’Iraq a Roma, Roma, 5 giugno 1972, in ASE, FENI, Presidenza Raffaele Girotti, b. 94, f. 3521.2 Per un quadro complessivo delle vicende storiche dell’Ipc e dello sfruttamento del petrolio iracheno: D. Yergin, The Prize. The Epic Quest for Oil, Money and Power, Simon & Schuster, New York 1991; J. Bamberg, The History of The Brit-ish Petroleum: Vol. 2, The Anglo-Iranian Years, 1928-1954, Cambridge University Press, Cambridge 1994; Id., British Petroleum and Global Oil. The Challenge of Nationalism, Cambridge University Press, Cambridge 2000; E. T. Penrose, E. F. Penrose, Iraq: International Relations and National Development, Ernest Benn, London 1978.3 S. Saul, Masterly Inactivity as Brinkmanship: The Iraq Petroleum Company’s Route to Nationalization, 1958-1972, “The International History Review”, vol. 29, 2007, n. 4, pp. 746 sg.
442
tre maturava la decisione del governo iracheno di nazionalizzare l’Ipc, la compagnia petrolifera di Stato (Iraq National Oil Company – Inoc) firmava un accordo quadro, un memorandum d’intesa e un protocollo aggiuntivo con l’Ente Nazionale Idrocarburi (Eni), holding pubblica italiana attiva nel settore dell’energia, per la vendita di 20 milioni di tonnellate di greggio nell’arco di 10 anni, in cambio della fornitura di beni e servizi da parte delle società del gruppo Eni e di altre imprese coordinate dall’ente italiano.4 L’intesa tra l’Inoc e l’Eni concludeva un processo negoziale lungo e complicato, durante il quale le due parti avevano più volte cambiato strategie e obiettivi, subendo le pressioni delle major europee e nordamericane, che per decenni avevano domi-nato il settore petrolifero iracheno. L’accordo, oltre ad avere rilevan-za economica, sembrava essere perfettamente in linea con la politica mediorientale seguita dai governi italiani dopo la guerra arabo-isra-eliana del giugno 1967, caratterizzata dalla ricerca dell’equidistanza tra i belligeranti, da una parte, e dalla volontà di essere presenti in un quadrante importante per gli interessi nazionali, dall’altra.5 Tuttavia, l’intesa petrolifera italo-irachena sottoscritta nel 1972 si rivelò non del tutto corrispondente né alle iniziali aspettative della dirigenza dell’Eni, dimostratasi talvolta incerta nel corso dei negoziati, né alle aspirazioni della politica italiana, la quale, a dire il vero, nell’azione di sostegno collaterale alle iniziative della compagnia di Stato, non agì sempre con linearità e determinazione. Incertezze e incoerenze, che in realtà non erano motivate da una mancanza di attenzione verso la po-litica e il settore petrolifero iracheni, ma dalla debolezza complessiva
4 Copie dell’accordo Eni-Inoc, firmato a Roma il 10 marzo 1972, del memorandum d’intesa e del protocollo aggiuntivo, sottoscritti a Baghdad rispettivamente il 20 di-cembre 1972 e il 4 febbraio 1973, si trovano in ASE, FENI, Estero – Coordinamento regioni estere, b. 114, f. 5.5 Sulla politica italiana verso il Medio Oriente negli anni Sessanta e Settanta: L. Riccardi, Il «problema Israele». Diplomazia italiana e PCI di fronte allo Stato ebraico (1948-1973), Guerini e Associati, Milano 2006; Id., Aldo Moro e il Medio Oriente (1963-1978), in F. Perfetti, A. Ungari, D. Caviglia, D. De Luca (a cura di), Aldo Moro nell’Italia contemporanea, Le Lettere, Firenze 2011, pp. 551-583; D. Caviglia e M. Cricco, La diplomazia italiana e gli equilibri mediterra-nei. La politica mediterranea dell’Italia dalla guerra dei Sei giorni al conflitto dello Yom Kippur (1967-1973), Rubbettino, Soveria Mannelli 2006.
443
del sistema paese, che, proprio tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta, entrò in una profonda crisi politica, economica e sociale, destinata a durare per tutto il decennio successivo.
La lunga strada verso l’indipendenza del settore petrolifero iracheno
La presenza delle multinazionali petrolifere sul suolo iracheno ri-saliva agli inizi del Novecento, all’epoca delle concessioni assegnate dall’Impero ottomano, alla vigilia della prima guerra mondiale, alla Turkish Petroleum Company (Tpc) per l’esplorazione e lo sfruttamen-to delle zone di Mosul e Baghdad. La Tpc era una società creata nel 1911 e detenuta al 50% dalla Anglo-Persian Oil Company (compa-gnia controllata dal governo britannico, denominata poi, nel 1935, Anglo-Iranian Oil Company e, nel 1954, British Petroleum), dalla Royal Dutch Shell (società a capitale misto anglo-olandese, nata dal-la fusione tra la Royal Dutch e la Shell) e dalla Deutsche Bank, ognu-na con una quota del 25%. Alla fine della prima guerra mondiale, la Deutsche Bank venne estromessa dal pacchetto azionario e al suo posto subentrò la Compagnie Française des Pétroles (creata nel 1924 con una partecipazione di capitale pubblico pari al 40%). L’ingresso della compagnia francese si inseriva nell’ambito di un’ampia intesa franco-britannica per la nuova sistemazione degli assetti politici, ter-ritoriali ed economici dei territori mediorientali appartenenti all’Im-pero ottomano, uscito sconfitto dal conflitto insieme alla Germania. I governi di Londra e Parigi, oltre ad accordarsi – come è noto – per la divisione dei mandati sui paesi arabi in Medio Oriente, con l’asse-gnazione dell’amministrazione della Siria e del Libano alla Francia e di quella dell’Iraq e della Palestina alla Gran Bretagna, raggiunsero un’intesa anche sulle questioni petrolifere: la Francia, in cambio della partecipazione al futuro sfruttamento del petrolio iracheno, attraver-so l’acquisizione delle quote tedesche della Tpc, rinunciò alla regione di Mosul a beneficio dell’Iraq e si impegnò a consentire la costruzione di due oleodotti in territorio siriano e libanese, attraverso cui sarebbe dovuta passare la produzione irachena.6
6 Promemoria, s.d. e s.a., in ASE, FENI, Direzione Estera, b. 173, f. 1598. Anche:
444
Crollato l’Impero ottomano e creato il nuovo Stato iracheno, retto dalla dinastia hashemita e sottoposto a mandato britannico, la Tpc rinegoziò le concessioni petrolifere con il governo di Baghdad. Con una serie di accordi sottoscritti tra il 1925 e il 1938, la Turkish Petroleum Company riuscì a ottenere il controllo dell’intero settore petrolifero iracheno, assicurandosi la possibilità di operare in condi-zioni di monopolio su quasi tutto il territorio nazionale.7 Oltre alla concessione assegnata alla Tpc nella zona di Kirkuk, dove nel 1927 furono scoperti alcuni dei giacimenti petroliferi più ricchi e redditi-zi del Medio Oriente, le compagnie straniere azioniste della società riuscirono a estendere le proprie attività sul resto del suolo iracheno, beneficiando di due altre concessioni: a Mosul, nella parte occidenta-le del paese, e a Bassora, nel sud dell’Iraq. A tale scopo furono create due società affiliate alla Tpc, la Mosul Petroleum Company (Mpc)8 e la Basra Petroleum Company (Bpc); le tre compagnie, controllate dagli
Yergin, The Prize, cit., pp. 184 sg.; C. Tripp, Storia dell’Iraq, Bompiani, Milano 2003, pp. 94-95; D. Styan, France and Iraq: Oil, Arms and French Policy Making in the Middle East, I.B. Tauris, Londra 2006, pp. 12 sg.7 Unica zona a non essere sottoposta al monopolio della Tpc fu un’area di 1800 km2 al confine con l’Iran, nel distretto di Khanaqin, dove era attiva la Khanaqin Oil Company, società comunque controllata dalla Anglo-Persian: Bamberg, British Petroleum, cit., p. 532, nota 4.8 In realtà, inizialmente, la concessione nella zona di Mosul, particolarmente ricca di greggio, era stata assegnata alla Mosul Oil Fields, società creata all’inizio degli anni Trenta da una compagnia britannica indipendente, la British Oil Development, in partnership con altre società franco-svizzere e tedesche, e con l’italiana Agip (Azien-da Generale Italiana Petroli, società pubblica fondata negli anni Venti e destinata - come è noto - a diventare, nel secondo dopoguerra, parte integrante dell’Eni – Ente Nazionale Idrocarburi), che per la prima volta interveniva nella politica petrolifera internazionale. Nonostante la scoperta di importanti giacimenti petroliferi, la com-pagnia italiana, che con il tempo era arrivata a controllare la quota di maggioranza della società, fu costretta ad abbandonare l’impresa, a causa della crisi finanziaria e delle difficoltà economiche seguite alla guerra italo-etiopica del 1935-1936, e a vendere le proprie quote alla Ipc, che successivamente trasformò la Mosul Oil Fields in Mosul Petroleum Company. Si veda: Promemoria, cit., in ASE, FENI, Direzione Estera, b. 173, f. 1598. Anche: D. Pozzi, Dai gatti selvaggi al cane a sei zampe. Tec-nologia, conoscenza e organizzazione nell’Agip e nell’Eni di Enrico Mattei, Marsilio, Venezia 2009, pp. 71-76, e pp. 107-109.
44
stessi azionisti e amministrate dallo stesso management, gestivano in regime di esclusiva l’intero processo produttivo del greggio iracheno, dalla ricerca ed estrazione, alla raffinazione e commercializzazione.9
Successivamente, le major petrolifere europee furono affiancate anche da quelle statunitensi, contrarie all’oligopolio economico an-glo-francese nei territori sottoposti a mandato della Società delle Na-zioni. Nel corso degli anni Venti, le grandi compagnie nordamericane fecero pressioni, affinché nel mercato petrolifero del Medio Oriente si applicasse la politica della “porta aperta”, nel tentativo di inserirsi nello sfruttamento delle riserve di greggio locali. Fu così che nel lu-glio del 1928, dopo un periodo di frizioni, le multinazionali europee e americane raggiunsero un’intesa che prevedeva l’ingresso nella Tpc della Standard Oil of New Jersey e dalla Standard Oil of New York at-traverso una nuova società compartecipata dalle due major americane, la Near East Development Corporation (di cui inizialmente facevano parte anche altre compagnie statunitensi, uscite di scena però nel cor-so degli anni Trenta). Il nuovo assetto azionario della Tpc, che nel 1929 prese il nome definitivo di Iraq Petroleum Company, vedeva la partecipazione con quote del 23,75% ciascuna della Anglo-Persian, della Royal Ducth Shell, della Compagnie Française des Pétroles e della Near East Development Corporation, mentre il rimanente 5% andava a Calouste Gubelnkian, uomo d’affari armeno, promotore e artefice della creazione della Tpc all’epoca dell’Impero ottomano.10
Anche il governo di Baghdad, nel corso dei negoziati condotti con
9 Promemoria, cit., in ASE, FENI, Direzione Estera, b. 173, f. 1598; L’IPC e il gover-no iracheno, appunto del 4 agosto 1967, ivi, Relazione Esterne, b. 133. Anche Saul, Masterly Inactivity as Brinkmanship, cit., pp. 746-748.10 L’intesa tra le grandi compagnie petrolifere europee e statunitensi, nota come Red Line Agreement, prevedeva anche una sorta di desistenza nella corsa al petrolio mediorientale, dato che le società firmatarie si impegnavano a cooperare in una vasta area corrispondente ai territori mediorientali dell’ex Impero ottomano, delimita-ta da una linea rossa disegnata su una mappa allegata all’accordo. Si veda: Studio dell’addetto commerciale dell’Ambasciata d’Italia a Baghdad, Ariosto Bernardini, sull’industria petrolifera, allegato al telespresso n. 2302 del 3 dicembre 1969 (co-pia), in ASE, FENI, Direzione Estera, b. 168, f. 15A9; Promemoria, cit., ivi, b. 173, f. 1598. Yergin, The Prize, cit., pp. 203-205; Saul, Masterly Inactivity as Brinkman-ship, cit., pp. 747-748.
44
la Tpc per l’assegnazione delle concessioni petrolifere, chiese di poter partecipare con una quota del 20% alla gestione della società e di avere un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione. Tuttavia, contrariamente a quanto accaduto nel caso delle imprese statunitensi, le richieste irachene non furono accolte dai vertici della Tpc, dispo-sti soltanto ad andare incontro alle esigenze finanziarie delle autorità di Baghdad, senza concedere alcuno spazio nel controllo del settore petrolifero locale. Le intese tra la compagnia e la dirigenza irachena del marzo 1925 prevedevano, quindi, che, in cambio delle concessioni assegnate alla Tpc, lo Stato iracheno ricevesse una somma forfettaria di 400 mila sterline all’anno, senza alcun ruolo nella conduzione della società. Nel marzo del 1931, l’aspetto finanziario delle concessioni fu rinegoziato e un nuovo accordo stabilì il pagamento di royalties pari a 4 scellini oro per ogni tonnellata di petrolio prodotta.11
Lo sfruttamento commerciale delle risorse di greggio irachene ini-ziò a dare risultati apprezzabili a metà degli anni Trenta, dopo l’entra-ta in funzione dei due primi oleodotti da Kirkuk ad Haifa e da Kirkuk a Tripoli. Pur essendo evidente, dalle ricerche e dalle prospezioni ef-fettuate, che la ricchezza dei giacimenti fosse tale da collocare l’Iraq tra i primi paesi al mondo per la quantità delle riserve accertate, fino all’inizio degli anni Cinquanta i proventi derivanti dal settore petro-lifero non costituirono certo la principale fonte di reddito dell’econo-mia nazionale, rappresentando non più del 16% delle entrate del go-verno iracheno. Vari furono i motivi del limitato apporto delle rendite petrolifere, alcuni di natura tecnica, altri, invece, conseguenza diretta delle scelte effettuate dalle multinazionali attraverso l’Ipc e le sue affi-liate. Indubbiamente, la mancanza di infrastrutture costituì per mol-to tempo uno dei principali ostacoli all’aumento della produzione petrolifera: solo tra la fine degli anni Quaranta e l’inizio degli anni Cinquanta, con la costruzione di nuovi oleodotti e l’ampliamento di quelli esistenti, venne raggiunta la capacità tecnica e logistica neces-saria ad aumentare in maniera significativa le esportazioni di greggio.
11 Promemoria, cit., in ASE, FENI, Direzione Estera, b. 173, f. 1598; L’IPC e il go-verno iracheno, cit., ivi, Relazione Esterne, b. 133; Tripp, Storia dell’Iraq, cit., p. 95 e pp. 108-109.
447
Tuttavia, a determinare i bassi livelli di produzione e a impedire la crescita degli introiti nelle casse irachene, fu soprattutto la scelta del-le major petrolifere azioniste della Ipc di limitarsi allo sfruttamento dello 0,5% del territorio dato loro in concessione. Le multinazionali erano attive anche in altri paesi del Medio Oriente (come l’Iran e l’A-rabia Saudita) e non erano disposte ad aumentare la produzione ira-chena, per non alterare gli equilibri (e i prezzi) del mercato petrolifero mondiale, caratterizzato all’epoca da una bassa domanda di greggio. Le compagnie ritenevano che i quantitativi di petrolio estratti dal ric-co sottosuolo di Kirkuk, Mosul e Bassora, fossero più che sufficienti all’attuazione delle proprie strategie industriali, non curandosi degli interessi e delle esigenze dei governi di Baghdad, i cui introiti erano legati al numero di tonnellate di greggio prodotte.12
Fu solo nel secondo dopoguerra che si verificò un’inversione di tendenza, sia nelle strategie delle major petrolifere in Iraq, che nei rapporti tra queste e il governo di Baghdad, in seguito a una trasfor-mazione complessiva del mercato petrolifero internazionale. È noto, infatti, che le conseguenze politiche ed economiche della seconda guerra mondiale cambiarono radicalmente il quadro di riferimento nella gestione delle risorse petrolifere mediorientali. Da un lato, si ebbe una crescita esponenziale del fabbisogno di greggio, dovuta alla vasta opera di ricostruzione dei paesi coinvolti nelle vicende belliche e alla notevole crescita economica e industriale delle società occidenta-li. Dall’altro lato, la guerra fredda e la divisione del mondo in blocchi contrapposti fecero assumere al petrolio prodotto dalle multinaziona-li un’importanza strategica fondamentale, in quanto elemento essen-ziale per lo sviluppo e il rafforzamento del mondo occidentale, impe-gnato in una difficile e lunga competizione politica ed economica con il campo sovietico.13 La crescente importanza del petrolio come fonte
12 Studio dell’addetto commerciale dell’Ambasciata d’Italia a Baghdad, Ariosto Ber-nardini, sull’industria petrolifera, cit., in ASE, FENI, Direzione Estera, b. 168, f. 15A9. Anche Saul, Masterly Inactivity as Brinkmanship, cit., pp. 747-749; C. Whittleton, Oil and the Iraqi Economy, in AA.VV., Saddam’s Iraq. Revolution or Reaction?, Zed Books, London 1990, 2a edizione, pp. 54-55.13 Yergin, The Prize, cit., pp. 409 sg.; L. Maugeri, L’arma del petrolio, Loggia de’ Lanzi, Firenze 1994, pp. 20 sg.
448
energetica primaria e le implicazioni della guerra fredda posero inevi-tabilmente il Medio Oriente, con le sue ricche riserve di greggio, al cen-tro delle strategie internazionali. Le major europee e nordamericane, spinte dalle crescenti necessità economiche del sistema capitalistico e dalle pressioni politiche dei propri governi nazionali, furono costrette a rivedere le politiche industriali e a incrementare la produzione del greggio mediorientale. Nel giro di poco più di un decennio, l’attività di estrazione nei campi petroliferi del Medio Oriente conobbe una crescita impressionante: alla vigilia della seconda guerra mondiale, il greggio estratto nelle regioni mediorientali costituiva soltanto il 5% della produzione petrolifera mondiale, con una estrazione annua di 16 milioni di tonnellate; mentre a metà degli anni Cinquanta, a dieci anni dalla fine del conflitto, il greggio proveniente dal Medio Oriente rappresentava il 25% della produzione petrolifera a disposizione delle economie occidentali, grazie agli oltre 150 milioni di tonnellate di greggio estratti ogni anno (che, costituendo il 90% delle importazioni petrolifere dell’Europa occidentale, determinavano l’assoluta dipen-denza dell’economia europea dal greggio mediorientale).14
Altro fattore cruciale nella trasformazione degli assetti petroliferi
14 Relazione sulla situazione petrolifera in Iraq, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, la Costa dei Pirati e l’Oman, senza data (ma almeno 1956), “Riservato”, in ASE, FENI, Relazioni Esterne, b. 132, f. 2F53. Secondo uno studio realizzato dagli esperti dell’Eni all’inizio del 1957, le riserve di petrolio accertate erano valutabili in 34 miliardi di tonnellate, di cui circa 4 miliardi si trovavano all’interno del territorio dell’Unione Sovietica e dei suoi satelliti, e circa 30 nel resto del mondo. I 30 miliar-di presenti nel sottosuolo del “mondo libero” erano suddivisi nel seguente modo: gli Stati americani produttori di greggio (Canada, Stati Uniti, Messico, Venezuela) detenevano complessivamente 7,8 miliardi di riserve; i paesi europei e africani 0,2 miliardi; l’Australia e i paesi asiatici (esclusi quelli mediorientali) 0,9 miliardi; i re-stanti 21 miliardi (i 2/3 della produzione mondiale) si trovavano in Medio Oriente. Il rapporto tra le riserve presenti nel resto del mondo e quelle delle regioni medio-rientali veniva definito “già di per sé sconcertante” dagli esperti dell’Eni, ma appa-riva ancora più significativo se si teneva conto anche di un altro fattore: la sempre più evidente mancanza di nuove fonti facilmente accessibili e sfruttabili in territorio americano, e la parallela presenza in Medio Oriente di vasti giacimenti ancora ine-splorati o non pienamente utilizzati. Si veda: Illustrazione geologico-mineraria sulle possibilità petrolifere dell’Iran, senza data (ma 1957), in ASE, FENI, Presidenza / Enrico Mattei, b. 102, f. 67b.
449
mediorientali e nella revisione delle strategie industriali delle grandi compagnie furono i radicali cambiamenti politici verificatisi a livello locale nel secondo dopoguerra, con la fine del sistema dei mandati e del controllo esercitato dai governi di Londra e Parigi su gran parte dei territori della regione. Il raggiungimento dell’indipendenza po-litica e l’ascesa al potere, in quasi tutta l’area, di classi dirigenti desi-derose di liberarsi da qualsiasi forma di tutela straniera crearono non poche difficoltà al sistema produttivo controllato dalle multinaziona-li. I problemi sollevati dalle élite locali non avevano solo motivazioni d’ordine economico, derivanti dalla volontà dei paesi produttori di rivedere gli accordi con le società petrolifere per aumentare gli introiti dei governi locali; ma anche implicazioni di carattere politico, perché gli immensi profitti delle major erano considerati dalle popolazioni mediorientali come una forma di sfruttamento imperialista e neoco-lonialista su paesi poveri e arretrati, ma ricchi di materie prime. La prima questione affrontata dalle classi dirigenti mediorientali fu quel-la del prezzo del petrolio, la cui struttura era estremamente favorevole alle compagnie e molto poco vantaggiosa per i paesi produttori, dato il valore piuttosto basso delle royalties riscosse dai governi locali. L’A-rabia Saudita fu il primo paese produttore a chiedere di rinegoziare i termini delle intese petrolifere e ad aprire una vertenza, che portò alla firma, nel dicembre del 1950, di un nuovo accordo per la divisione paritaria degli utili tra il governo saudita e le compagnie petrolifere. L’esempio saudita fu immediatamente seguito dagli altri Stati medio-rientali produttori di petrolio e, nel giro di pochi anni, il cosiddetto accordo “fifty-fifty” fu esteso a tutta la regione.15
Anche l’Iraq, alla luce della maggiore importanza delle riserve di greggio mediorientale per i paesi occidentali e dei nuovi termini con-trattuali ottenuti dal governo saudita, chiese e ottenne di rinegoziare gli accordi con l’Ipc e le sue affiliate. Il governo guidato da Nuri al Said, il principale protagonista della vita politica irachena negli anni della monarchia hashemita, convinto sostenitore dell’allineamento al blocco occidentale e garante del legame speciale con la Gran Breta-gna, riuscì a migliorare notevolmente le condizioni contrattuali con
15 Yergin, The Prize, cit., pp. 431 sg.; Maugeri, L’arma del petrolio, cit., pp. 22 sg.
40
le multinazionali. In base al nuovo accordo, firmato nel 1952, l’Ipc e lo Stato iracheno si impegnavano a dividere i profitti derivanti dalla produzione di greggio su base paritaria, applicando quindi la clausola del 50/50; la compagnia petrolifera garantiva al governo di Baghdad un introito minimo, consentiva al governo iracheno di acquistare fino al 12,5% della produzione come parte della quota di sua spettanza (da vendere, poi, liberamente sul mercato mondiale) e ammetteva, per la prima volta, la nomina di direttori iracheni nel consiglio di ammini-strazione per partecipare alle discussioni sui prezzi del petrolio. L’ac-cordo del 1952 rappresentò il presupposto per la straordinaria crescita del settore petrolifero iracheno negli anni successivi e per il notevole aumento degli introiti nelle casse dello Stato iracheno. La produzione di greggio passò dagli 8,4 milioni di tonnellate del 1951 ai 29,5 milio-ni del 1954, con un incremento superiore al 350%; nello stesso perio-do, la quota irachena dei profitti petroliferi crebbe da 13,7 milioni di dinari iracheni a 68,4 milioni (in dollari statunitensi, da 38,36 milioni a 191,52 milioni, circa).16
Tuttavia, contrariamente alle aspettative e alle aspirazioni genera-li, il nuovo accordo non segnò quella svolta decisiva per lo sviluppo dell’Iraq, auspicata e attesa dalla popolazione locale. L’enorme cresci-ta della produzione di greggio e il parallelo incremento delle royalties destinate all’erario nazionale non migliorarono la situazione econo-mica e sociale del paese, né contribuirono al superamento delle pro-fonde divisioni etniche e religiose (tra curdi e arabi, e tra musulmani
16 Il dato è ancora più evidente e significativo se considerato nel lungo periodo: nei primi 18 anni di vita dell’industria petrolifera irachena, dal 1934 (anno in cui lo sfruttamento commerciale del greggio iracheno iniziò a produrre profitti) al 1951, il reddito derivato allo Stato iracheno sulla base di una produzione complessiva di cir-ca 60 milioni di tonnellate fu di appena 45 milioni di dinari/ 126 milioni di dollari (di gran lunga inferiore all’apporto in valuta estera delle esportazioni di prodotti agricoli); enorme il contrasto con i successivi 18 anni, durante i quali la produzione aumentò del 1380% (per un ammontare complessivo di 828 milioni di tonnellate) e il contributo in valuta all’economia del paese si incrementò del 4004% (per un totale di 1802 milioni di dinari, equivalenti a 5945,6 milioni di dollari). Si veda: Studio dell’addetto commerciale dell’Ambasciata d’Italia a Baghdad, Ariosto Bernar-dini, sull’industria petrolifera, cit., in ASE, FENI, Direzione Estera, b. 168, f. 15A9. Anche Tripp, Storia dell’Iraq, cit., pp. 178-179.
41
sunniti e sciiti), che avevano minato la stabilità politica del paese fin dalla sua formazione. I governi dell’epoca decisero di destinare il 70% dei proventi derivanti dal settore petrolifero a un vasto piano per la re-alizzazione di infrastrutture (impianti di irrigazione, canali e dighe), di cui si avvantaggiarono soprattutto i grandi proprietari terrieri per le loro attività agricole; una decisione che, però, limitò fortemente gli investimenti in altri settori, come la produzione e l’importazione di beni di consumo, l’edilizia, la costruzione di reti idriche per uso civile, l’assistenza sanitaria e l’istruzione, in grado di determinare benefici immediati per strati più ampi della popolazione, in piena espansio-ne demografica e sempre più attratta dai centri urbani.17 Il drenaggio delle risorse verso programmi di investimenti favorevoli ai grandi lati-fondisti era la conseguenza dell’assetto sociale esistente in Iraq, carat-terizzato dalla presenza di gruppi privilegiati (apparati politici e isti-tuzionali legati alla monarchia hashemita, sceicchi proprietari terrieri e grandi commercianti, appartenenti in gran parte alla minoranza sunnita), detentori del potere politico ed economico e interessati più ad investire in speculazioni immobiliari e nel terziario, che a finanzia-re lo sviluppo industriale del paese. Secondo l’addetto commerciale dell’ambasciata italiana a Baghdad, Ariosto Bernardini, l’Iraq negli anni Cinquanta si trovava in “una situazione tipica ai Paesi del Terzo mondo”: forte espansione demografica; capacità di produzione insuf-ficiente per soddisfare i bisogni dei nuovi strati urbanizzati della po-polazione; vertici politici ed economici del paese beneficiari di “una parte eccessiva” del reddito nazionale; importazione massiccia di beni non essenziali, ad esclusivo uso delle classi più abbienti; allarmante esportazione di capitali; amministrazione corrotta e dedita a spese di natura “personale”, non coincidenti con gli interessi della popolazio-ne irachena. Nel complesso, una situazione di miseria generalizzata, a fronte di una gestione fraudolenta delle ricchezze del paese, che favorì
17 Relazione sulla situazione petrolifera in Iraq, cit., in ASE, FENI, Relazioni Ester-ne, b. 132, f. 2F53. Anche: Telegram From the Embassy in Iraq to the Department of State, Baghdad, 12 marzo 1958; Staff Notes Prepared for President Eisenhower, Washington, 16 aprile 1958, in FRUS, 1958-1960, vol. XII, dd. 101 e 102. Tripp, Storia dell’Iraq, cit., pp. 182-190; Whittleton, Oil and the Iraqi Economy, cit., pp. 56-57.
42
il colpo di Stato militare del luglio 1958, con cui si pose brutalmente fine alla monarchia irachena.18
Il re Faisal II e altri membri della famiglia reale, insieme ai maggio-ri leader politici legati alla dinastia hashemita, tra cui lo stesso Nuri al-Said, furono fisicamente eliminati, per far posto a un regime repubbli-cano guidato dal generale Abdul Karim Qassim. Obiettivi primari dei nuovi dirigenti iracheni, accolti con favore dalle masse popolari per aver soppresso i personaggi più rappresentativi dell’esperienza monar-chica, considerati strumento e simbolo della presenza britannica nel paese, dello sfruttamento straniero delle risorse nazionali e dell’op-pressione sociale di gran parte della popolazione, erano il raggiungi-mento dell’indipendenza economica e la costruzione di un sistema sociale più equo. Le principali aree d’intervento individuate per l’at-tuazione di un vasto programma di riforme, in grado di garantire una più ampia redistribuzione della ricchezza e assicurare la pacificazione nazionale tra i vari gruppi etnici e religiosi, erano sostanzialmente tre: la realizzazione di un complesso di infrastrutture, per rilanciare lo svi-luppo industriale; il ridimensionamento del ruolo politico ed econo-mico dei grandi latifondisti, con il conseguente miglioramento della qualità della vita della popolazione rurale; la rinegoziazione degli ac-cordi con le multinazionali, per dare allo Stato iracheno la possibilità di intervenire nella gestione del settore petrolifero e di ricevere una quota maggiore degli utili derivanti dalla produzione di greggio.19
Era evidente, però, che il fattore determinante, da cui sarebbe di-pesa la riuscita dell’intera azione riformatrice di Qassim e della diri-genza repubblicana, era rappresentato dai cambiamenti nel rapporto con le compagnie petrolifere e dalla partecipazione delle autorità di
18 Studio dell’addetto commerciale dell’Ambasciata d’Italia a Baghdad, Ariosto Ber-nardini, sull’industria petrolifera, cit., in ASE, FENI, Direzione Estera, b. 168, f. 15A9. Anche: Memorandum from the Deputy Director for Plans of the Central In-telligence Agency (Wisner) to the Director of Intelligence and Research (Cumming), Washington, 3 luglio 1958; Briefing Notes by Director of Central Intelligence Dulles, Washington, 14 luglio 1958, in FRUS, 1958-1960, vol. XII, dd. 108 e 110; Whit-tleton, Oil and the Iraqi Economy, cit., pp. 56-57.19 M Farouk-Sluglett, P. Sluglett, Iraq since 1958. From Revolution to Dicta-torship, I.B. Tauris, London-New York 2001, pp. 47 sg.
43
Baghdad nella direzione delle attività produttive della Ipc e delle so-cietà affiliate. Il petrolio era la principale risorsa dell’economia nazio-nale (se non l’unica): alla fine degli anni Cinquanta, era dalle royal-ties petrolifere che derivavano il 60% delle entrate pubbliche, il 40% del prodotto interno lordo, il 45% del bilancio ordinario dello Stato, il 95% del budget destinato ai piani di sviluppo, l’80% della valuta straniera, necessaria per l’importazione di materie prime, macchinari industriali, beni di consumo e prodotti alimentari.20 In buona sostan-za, la vita dell’Iraq e il suo sviluppo dipendevano ormai in maniera quasi esclusiva dall’estrazione del greggio. Al di là dei proclami ad uso propagandistico interno, diretti contro il predominio straniero in un settore strategico quale quello petrolifero, il governo di Baghdad era consapevole che il ricorso a decisioni e atti unilaterali nei confronti delle compagnie sarebbe stato esiziale per l’economia nazionale e per la sopravvivenza del regime stesso. A Baghdad, si aveva ben presente quanto era accaduto all’inizio degli anni Cinquanta nel vicino Iran, in occasione della nazionalizzazione dell’industria petrolifera, con-tro cui le multinazionali avevano reagito, attuando un vero e proprio embargo sulle esportazioni di greggio iraniano e portando di fatto al collasso l’economia del paese. Conseguentemente, il regime repubbli-cano riprese i negoziati avviati dai precedenti governi con la dirigenza della Ipc, per migliorare i termini contrattuali in vigore, impegnando-si a rispettare gli accordi del 1952 e senza minacciare nazionalizzazio-ni ed espropriazioni.21
Nei colloqui svoltisi all’inizio degli anni Sessanta, le autorità ira-chene, oltre a chiedere la revisione del prezzo del petrolio e la rine-goziazione della divisione degli utili, posero nuovamente il problema della partecipazione nella gestione della compagnia, con una quota pari ad almeno il 20% del pacchetto azionario, reclamando anche il rilascio delle aree date in concessione alla Ipc e alle sue affiliate, ma
20 K. E. Hassib, Vers une politique petroliere nationale en Iraq, “Arab Studies”, mag-gio 1968, pp. 3-4, copia in ASE, FENI, Direzione Estera, b. 168, f. 1517, pp. 3-4; Saul, Masterly Inactivity as Brinkmanship, cit., p. 749.21 Farouk-Sluglett, Sluglett, Iraq since 1958, cit., pp. 78 sg.; Bamberg, Brit-ish Petroleum, cit., p. 164; Telegram From the Embassy in Iraq to the Department of State, Baghdad, 19 luglio 1958, in FRUS, 1958-1960, vol. XII, dd. 124 e 129.
44
ancora non sfruttate dalle major petrolifere.22 Le richieste irachene ri-spondevano, in primo luogo, a motivazioni di ordine politico ed era-no dettate dalla necessità di consolidare il regime guidato da Qassim; le condizioni negoziali poste dalle autorità irachene rappresentavano, di fatto, un primo passo verso il graduale recupero del patrimonio nazionale e verso il ridimensionamento del ruolo dominante delle multinazionali nella vita del paese, senza però rischiare la contrappo-sizione frontale e la chiusura totale.23 Il riequilibrio dei rapporti con le major rientrava in una strategia più ampia, volta a rendere l’Iraq maggiormente indipendente sia sotto il profilo economico, che po-litico; il rilancio dei negoziati con l’Ipc, infatti, fu accompagnato dal riposizionamento del paese in ambito internazionale, segnato dall’u-scita dal Patto di Baghdad, alleanza regionale saldamente allineata al blocco occidentale, e dalla normalizzazione dei rapporti diplomatici con l’Unione Sovietica, cui seguì la firma di una serie di accordi per la cooperazione economica, gli scambi commerciali e l’assistenza finan-ziaria e militare.24
Naturalmente, le proposte di revisione delle intese petrolifere avanzate dal governo di Baghdad erano motivate anche da esigenze di carattere economico e finanziario. Tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta, la produzione di greggio iracheno crebbe quasi del 60%, senza che però le entrate nelle casse dello Stato derivan-ti dalle royalties aumentassero in proporzione. In quegli anni, infatti, i ricavi del settore petrolifero passarono da 242 milioni di dollari nel 1959 a 353 milioni nel 1963, con un incremento del 45%.25 L’eviden-te sproporzione fu determinata dalla decisione delle multinazionali di
22 Saul, Masterly Inactivity as Brinkmanship, cit., pp. 750 sg.23 L’IPC e il governo iracheno, cit., in ASE, FENI, Relazione Esterne, b. 133; Fa-rouk-Sluglett, Sluglett, Iraq since 1958, cit., pp. 78 sg.; Bamberg, British Petroleum, cit., p. 164. Sulla eccessiva influenza delle major nella vita politica ed economica dei paesi produttori di petrolio del Medio Oriente: Summary Minutes of Meeting of the Interdepartmental Committee of Under Secretaries on Foreign Econo-mic Policy, Washington, 13 Dicembre 1961, in FRUS, 1961-1963, vol. IX, d. 345.24 O. Smolanski, B. M. Smolanski, The USSR and Iraq. The Soviet Quest for Influence, Duke University Press, Durham-London 1991, pp. 13-16.25 National Intelligence Estimate, Washington, 1° Novembre 1960, in FRUS, 1958-1960, vol. XII, d. 222; Farouk-Sluglett, Sluglett, Iraq since 1958, cit., pp. 78 sg.
4
ridurre il posted price (il valore del greggio all’esportazione, stabilito dalle compagnie stesse e indicato come prezzo di riferimento per il calcolo dei profitti netti da dividere con i paesi produttori). Se era vero che il consumo mondiale di petrolio era quasi raddoppiato nel corso degli anni Cinquanta, era altrettanto vero che il greggio era ancora una materia prima relativamente poco costosa e abbondante, per cui la produzione superava di molto la richiesta, determinando la saturazione del mercato. Ne conseguì la necessità per le compagnie internazionali, al fine di preservare gli equilibri del mercato petroli-fero, di tagliare il posted price in maniera significativa, a tal punto che, fatto 100 il valore del prezzo del greggio nel 1954, esso scese a 98,6 nel 1959, a 92,5 nel 1960 e a 89,2 nel 1961, seguendo un trend negativo destinato a fermarsi solo nel 1967, in conseguenza della guerra arabo-israeliana dei “sei giorni”.26
La reazione del governo di Baghdad alla riduzione del posted price fu duplice: da un lato, l’Iraq si schierò con altri paesi produttori di petrolio (Arabia Saudita, Iran, Kuwait e Venezuela) per dare vita nel 1960 all’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (Opec), nel tentativo di creare un fronte negoziale comune in grado di contrap-porsi alla gestione unilaterale del mercato petrolifero da parte delle multinazionali;27 dall’altro lato, le autorità irachene provarono a in-crementare il volume delle rendite derivanti dal settore petrolifero, chiedendo all’Ipc di rivedere la ripartizione degli utili e, soprattutto, di rilasciare le aree non utilizzate dalle major, per poterle poi dare in concessione ad altre compagnie interessate al greggio iracheno. Sen-za un sensibile aumento delle entrate nelle casse dello Stato, l’azione riformatrice del regime di Qassim, già di per sé non propriamente ef-ficace ed efficiente, rischiava la paralisi e il fallimento: la metà degli introiti derivanti dal petrolio servivano a finanziare la spesa pubblica, composta essenzialmente dal mantenimento delle forze armate, dal pagamento degli impiegati statali e dagli acquisti di beni alimentari
26 Memorandum of Conversation, Washington, 29 gennaio 1964, in FRUS, 1964-1965, vol. XXXIV, d. 175; Bamberg, British Petroleum, cit., pp. 143 sg.; Farouk-Sluglett, Sluglett, Iraq since 1958, cit., pp. 78 sg.; Whittleton, Oil and the Iraqi Economy, cit., p. 62.27 Yergin, The Prize, cit., pp. 519 sg.; Bamberg, British Petroleum, cit., pp. 143 sg.
4
all’estero (necessari a compensare gli squilibri della produzione lo-cale); l’altra metà non era sufficiente ad attuare un grande piano di riforme, ma solo interventi di minore portata e rilevanza. In assenza di progetti di sviluppo industriale di ampio respiro, la disoccupazio-ne avrebbe continuato a crescere, determinando una sempre minore capacità di acquisto da parte della popolazione irachena, ormai quasi del tutto urbanizzata; la permanente stagnazione economica avreb-be costretto il governo a impegnare una quota maggiore delle rendite petrolifere in capitoli di spesa di natura assistenziale non direttamen-te collegati ai piani di sviluppo economico: un circolo vizioso, a cui Qassim sperava di porre rimedio rinegoziando gli accordi con l’Ipc.28
Le multinazionali, sempre attente a non alterare gli equilibri del mercato petrolifero e a non innescare pericolosi effetti domino in Medio Oriente, respinsero la maggior parte delle richieste irachene, limitandosi ad una trattativa sull’eventuale riconsegna delle aree non sfruttate. Contraria a rivedere la divisione degli utili e soprattutto ad ammettere la partecipazione dello Stato iracheno alla gestione della compagnia, la dirigenza dell’Ipc arrivò ad offrire il rilascio immediato del 75% delle aree non sfruttate e di un altro 15% nei successivi 7 anni. Per Qassim e il suo governo, si trattava di una proposta inac-cettabile, dato che le richieste irachene erano state presentate come un pacchetto complessivo, i cui punti principali (revisione del prezzo e della divisione degli utili, partecipazione alle quote azionarie della Ipc e rilascio delle concessioni) non potevano essere disgiunti e nego-ziati separatamente; un’intesa limitata solo al rilascio di alcune aree avrebbe rappresentato una sorta di “suicidio politico” per i governanti iracheni, sempre più pressati dal malcontento popolare e incalzati da numerose proteste, spesso degenerate in scontri armati tra manife-stanti e forze di sicurezza.29
La rigidità delle posizioni assunte dalle multinazionali causò, quin-di, il fallimento e l’interruzione dei negoziati. Qassim, nel timore di perdere il controllo della situazione e di essere allontanato dal potere
28 National Intelligence Estimate, cit., in FRUS, 1958-1960, vol. XII, d. 222.29 L’IPC e il governo iracheno, cit., in ASE, FENI, Relazioni Esterne, b. 133; Bam-berg, British Petroleum, cit., p. 165; Hassib, Vers une politique petroliere nationale, cit., p. 5.
47
per aver fallito l’obiettivo di ridimensionare il ruolo delle major, si vide costretto ad abbandonare l’atteggiamento conciliante e disponi-bile tenuto fino ad allora, passando ad azioni unilaterali in grado di mettere sotto pressione la dirigenza dell’Ipc e di recuperare consenso all’interno del paese. Nel settembre 1960, il premier iracheno rese di pubblico dominio i resoconti dei colloqui in corso con i rappresen-tanti della società petrolifera, con il chiaro intento di rafforzare la pro-pria posizione davanti all’opinione pubblica nazionale e di screditare ulteriormente la dirigenza della compagnia; nell’aprile 1961, intimò all’Ipc di sospendere ogni attività di esplorazione condotta sul suolo iracheno e nel dicembre del 1961 fece promulgare le legge 80, che an-nullava la maggior parte delle concessioni assegnate alla compagnia, senza alcun indennizzo. In base alla nuova legge, considerata una delle misure più radicali contro l’oligopolio delle multinazionali in Medio Oriente dopo la nazionalizzazione del settore petrolifero iraniano del 1951, lo Stato iracheno rientrava in possesso del 99,5% dell’area data in concessione all’Ipc e alle sue affiliate, ad eccezione di tre zone a Mosul, Kirkuk e Bassora (per complessivi 1900 Km2), dove le attività estrattive delle multinazionali erano operative ormai da anni. Non si trattava, quindi, di una vera e propria nazionalizzazione del settore pe-trolifero, la cui gestione rimaneva ancora nelle mani delle compagnie straniere, ma del recupero di territori lasciati improduttivi per scelta delle major stesse, come i ricchi giacimenti della zona di Rumayla, nel sud del paese, con l’obiettivo di coinvolgere altre società interessate al greggio iracheno, aumentare la produzione e incrementare i ricavi destinati alle casse statali.30
D’altronde, lo Stato iracheno nel 1961 non aveva ancora le capa-cità imprenditoriali, manageriali e tecniche, necessarie ad avviare au-tonomamente l’estrazione e la commercializzazione del greggio; non era ancora stato istituito un ente nazionale per la gestione in proprio dell’industria petrolifera, né erano state poste le condizioni per crea-re un mercato alternativo a quello controllato dalle multinazionali, a
30 Farouk-Sluglett, Sluglett, Iraq since 1958, cit., pp. 76 sg.; Bamberg, Brit-ish Petroleum, cit., pp. 165-166; Saul, Masterly Inactivity as Brinkmanship, cit., pp. 759-761.
48
cui vendere i circa 70 milioni di tonnellate di greggio iracheno pro-dotti annualmente dall’Ipc e dalle sue affiliate. La nazionalizzazione, quindi, non era ancora una strada percorribile, a meno di non voler portare al collasso l’economia nazionale e far precipitare il paese nel caos politico e sociale. Nell’immediato, per porre fine al monopolio delle major e rendere centrale il ruolo dello Stato iracheno nella dire-zione dell’industria petrolifera nazionale, Qassim sembrava non ave-re altra soluzione che mettere sotto pressione la dirigenza della Ipc e, allo stesso tempo, tentare di aprire il settore petrolifero nazionale agli investimenti di nuovi partner stranieri, senza però ricorrere alla nazionalizzazione delle attività estrattive gestite dalle multinazionali. Tuttavia, Qassim non ebbe modo di migliorare le relazione con la Ipc, né di allacciare rapporti con altre compagnie straniere, a causa di un nuovo colpo di Stato militare, organizzato tra l’8 e il 9 febbraio del 1963, che pose fine, ancora una volta brutalmente, alla sua esperienza di governo.31
Mentre Qassim e altri membri del suo esecutivo venivano processa-ti sommariamente e fucilati, alcuni ufficiali dell’esercito, sensibili alla causa del nazionalismo arabo di matrice nasseriana, guidati dal colon-nello Abdul Salam Arif, conquistavano il potere, insieme ad esponenti, sia militari, che civili, del partito Baath, il cui ruolo nella vita politica irachena, fino ad allora, era stato marginale. Nato in Siria, nella prima metà degli anni Quaranta, come movimento di liberazione nazionale contro l’amministrazione francese e, allo stesso tempo, come movi-mento di rinnovamento della politica araba, il partito Baath (“partito della Rinascita”) con il tempo aveva definito più chiaramente i propri obiettivi e il proprio programma, diventando una forza politica na-zionalista e panaraba, favorevole all’attuazione di riforme sociali ed economiche di ispirazione socialista (ma non marxista), in grado di risolvere le profonde disuguaglianze presenti nelle società arabe. Le idee baathiste arrivarono in Iraq alla fine degli anni Quaranta, senza riuscire a fare molta presa sull’opinione pubblica e sulla società civile; privo di una struttura e di un’organizzazione forte e capillare come
31 Sul colpo di Stato del 1963: Farouk-Sluglett, Sluglett, Iraq since 1958, cit., pp. 82 sg.; Tripp, Storia dell’Iraq, cit., pp. 224 sg.
49
quella siriana, il ramo iracheno del partito Baath non era omogeneo e coeso al suo interno, essendo composto da individui e gruppi il cui principale fattore di affiliazione era rappresentato dai contatti di na-tura personale, familiare e regionale.32 Inizialmente favorevoli alla ri-voluzione del 1958 e al nuovo regime repubblicano, i baathisti furono presto costretti alla clandestinità, in seguito al fallimento di un atten-tato contro il generale Qassim, organizzato da un gruppo di aderenti al partito (tra cui anche un ventiduenne Saddam Hussein). Il colpo di Stato del 1963, attuato insieme agli ufficiali nazionalisti panarabi, rappresentò, quindi, la grande occasione per conquistare il potere e recitare un ruolo di primo piano nella politica irachena. Filonasseria-ni e baathisti trovarono un terreno d’intesa nella comune avversione alla politica di Qassim, accusato di aver contrastato il panarabismo con il sostegno attivo del partito comunista e di aver isolato il pae-se dal resto del mondo arabo, essendosi opposto ai disegni del leader egiziano Nasser. Tuttavia, le due forze politiche si divisero ben presto nella conduzione dello Stato, a causa della radicalità delle posizioni del Baath e dell’estremismo dei suoi rappresentanti, resisi subito re-sponsabili, con le proprie milizie, di vendette cruente e regolamenti di conti brutali contro i sostenitori del precedente regime e del partito comunista. Fu così che, nel novembre del 1963, Salam Arif e i filo-nasseriani, preoccupati per l’eccessiva libertà d’azione della Guardia nazionale baathista e forti anche della solidarietà e dell’appoggio della componente militare del Baath, interessata a contenere gli ambienti civili del partito, estromisero i membri baathisti dal governo, assu-mendo il controllo assoluto dello Stato.33
32 Sulle origini e lo sviluppo del partito Baath in Iraq: Farouk-Sluglett, Slu-glett, Iraq since 1958, cit., pp. 87 sg.; Id., Iraqi Ba’thism: Nationalism, Socialism and National Socialism, in AA.VV., Saddam’s Iraq, cit., pp. 89 sg.33 Memorandum From the Department of State Executive Secretary (Brubeck) to the President’s Special Assistant for National Security Affairs (Bundy), Washington, 13 febbraio 1963; Memorandum From Robert W. Komer of the National Security Coun-cil Staff to President Kennedy, Washington, 20 febbraio 1963; Memorandum From the Deputy Director of the Defense Intelligence Agency (Quinn) to Secretary of Defense McNamara, Washington, 18 Novembre 1963, in FRUS, 1961-1963, vol. XVIII, dd. 157, 158 e 363.
40
Anche per il regime nazionalista e panarabo, guidato da Salam Arif, proclamato presidente della Repubblica, l’attuazione di un vasto piano di riforme economiche e sociali, in grado di promuovere final-mente lo sviluppo del paese, rappresentava una priorità assoluta, da cui dipendevano non solo il rafforzamento dell’unità nazionale, ma anche le chance di sopravvivenza della nuova dirigenza irachena.34 La politica economica dei governi militari succedutisi durante la presi-denza di Salam Arif e di suo fratello, Abdul Rahman Arif (che ne pre-se il posto dopo la scomparsa per un incidente in elicottero nel 1966), si ispirò al modello del “socialismo arabo” teorizzato e attuato da Nas-ser in Egitto; si trattava – come è noto – di un modello che vedeva nello Stato il principale promotore e artefice dello sviluppo nazionale, chiamato a pianificare e favorire la crescita del paese garantendone il quadro istituzionale e politico, senza controllare, però, tutti i settori della vita economica e produttiva. L’applicazione irachena delle te-orie nasseriane portò il regime di Arif ad annunciare, nel luglio del 1964, in occasione del sesto anniversario della rivoluzione repubbli-cana del 1958, la nazionalizzazione del settore bancario e assicurativo e delle principali attività industriali e commerciali; una misura che, nell’immediato, ebbe l’unico risultato di deprimere ulteriormente l’e-conomia nazionale (per la fuga di capitali, lo scarso interesse a investi-re in attività esposte al rischio di essere espropriate e l’aumento della disoccupazione), senza affrontare il vero problema dell’economia ira-chena rappresentato dal monopolio straniero del settore petrolifero.35
Era evidente che, indipendentemente dai governi al potere e dai loro programmi, il fattore cruciale nella vita del paese era il controllo dell’industria petrolifera nazionale, da cui dipendeva larga parte del prodotto interno lordo e del bilancio statale. Anche il regime dei fra-telli Arif, dunque, fu chiamato ad affrontare la questione petrolifera e a confrontarsi con la dirigenza dell’Ipc, nel tentativo di ridimensiona-re lo strapotere delle compagnie straniere e di incrementare le risorse a disposizione dello Stato. La direzione della politica petrolifera e la
34 Circular Airgram From the Department of State to Certain Posts, Washington, 2 marzo 1963, in FRUS, 1961-1963, vol. XVIII, d. 174.35 Farouk-Sluglett, Sluglett, Iraq since 1958, cit., pp. 93-100;
41
gestione dei rapporti con l’Ipc vennero affidate ad Abd al-Aziz al-Wattari, un ingegnere formatosi negli Stati Uniti, presso l’Università del Texas, ritenuto un tecnico di tendenze moderate, perché consape-vole della necessità di ridefinire di comune accordo con le compagnie straniere l’assetto del settore petrolifero. Tuttavia, il nuovo ministro delle attività petrolifere, pur disposto a rilanciare i negoziati con l’Ipc, chiarì immediatamente che il percorso intrapreso dall’Iraq con l’ap-provazione della legge 80 del 1961 non poteva essere abbandonato, perché il recupero dei distretti petroliferi non sfruttati dalle società straniere era considerato dall’opinione pubblica una tappa fondamen-tale nella conquista della piena indipendenza nazionale. Al-Wattari, in pratica, non si discostò dall’impostazione data alla politica petro-lifera da Qassim: alla luce del precedente iraniano, sempre ben pre-sente nelle menti delle classi dirigenti mediorientali, l’idea di fondo era di dialogare senz’altro con le multinazionali, evitando di arrivare alla contrapposizione frontale, ma restringendone progressivamente il perimetro d’azione, a vantaggio del ruolo dello Stato.36
Ne derivò la doppia decisione di istituire un ente pubblico, per la creazione di un settore petrolifero nazionale indipendente dalle com-pagnie straniere, e di rilanciare i negoziati con la dirigenza dell’Ipc. L’8 febbraio del 1964, il ministro del Petrolio annunciò la promulgazio-ne da parte del governo di Baghdad della legge 11, istitutiva dell’Iraq National Oil Company, compagnia petrolifera nazionale incaricata di promuovere e gestire direttamente le attività esplorative ed estrattive nelle zone recuperate dallo Stato iracheno in applicazione delle legge 80 del 1961;37 un passo resosi necessario, secondo le autorità irachene, anche per l’impossibilità di trovare partner internazionali disposti a collaborare con il governo di Baghdad, a causa del veto posto dalle multinazionali detentrici dell’Ipc, contrarie al riconoscimento della legge 80 e delle sue implicazioni, come la revoca delle concessioni non sfruttate, e pronte a esercitare la massima pressione possibile per im-pedire l’ingresso di altre società nel settore petrolifero iracheno. Allo
36 Saul, Masterly Inactivity as Brinkmanship, cit., p. 764.37 Una copia in inglese del testo della legge 11 dell’8 febbraio 1964 si trova in ASE, FENI, Direzione Estera, b. 168, f. 15AB.
42
stesso tempo, al-Wattari riprese le trattative con i responsabili dell’Ipc, giungendo ad un accordo preliminare da sottoporre alla definitiva approvazione del governo iracheno. Secondo l’intesa, raggiunta nel giugno del 1965, l’Ipc riconosceva finalmente la legge 80 con la con-seguente rinuncia alle concessioni ritirate dal governo di Baghdad; in cambio, però, la compagnia recuperava parte di quelle concessioni, in particolare i distretti considerati più ricchi e promettenti, come quello della zona nord di Rumayla, già oggetto di esplorazioni e pro-spezioni da parte dei tecnici dell’Ipc, per un totale di quasi 4 mila km2; inoltre, per lo sfruttamento di un’altra parte delle concessioni revocate nel 1961, era prevista la costituzione di una società mista Ipc-Inoc (la Baghdad Oil Company, detenuta per 1/3 dalla Inoc e per 2/3 dalle multinazionali), incaricata di condurre attività esplorative su un territorio di circa 32 mila km2; l’Inoc, poi, sarebbe stata libera di collaborare con altri partner internazionali nelle rimanenti zone, non incluse nei precedenti punti dell’accordo, purché il governo iracheno non avesse concesso ad altre compagnie condizioni migliori di quelle accordate all’Ipc e alla società mista; infine, l’Ipc si impegnava a ver-sare una somma forfettaria di 20 milioni di sterline e ad aumentare la produzione di greggio. In buona sostanza, in cambio del riconosci-mento della legge 80, del coinvolgimento parziale dell’ente di Stato nelle attività petrolifere e dell’incremento delle entrate destinate all’e-rario, al-Wattari aveva permesso alle multinazionali di recuperare il controllo di tutti i distretti petroliferi più importanti e di conservare il controllo della vita economica del paese.38
L’accordo venne accolto negativamente dal resto del governo ira-cheno, a tal punto da provocare le dimissioni di sei ministri filonas-seriani, fermamente contrari a sottoscrivere un’intesa così favorevole agli interessi delle compagnie straniere. Secondo la componente della dirigenza irachena più sensibile ai richiami panarabisti del leader egi-ziano, l’intesa negoziata da al-Wattari lasciava inalterato il predomi-nio delle major nel settore petrolifero nazionale, non condizionan-
38 Farouk-Sluglett, Sluglett, Iraq since 1958, cit., pp. 96-97; Bamberg, British Petroleum, cit., pp. 166-167; Saul, Masterly Inactivity as Brinkmanship, cit., pp. 766-772.
43
done in alcun modo l’assoluta discrezionalità nel determinare i livelli di produzione e il volume dei ricavi percepiti dallo Stato iracheno. L’accordo del giugno 1965 non venne approvato dall’esecutivo ira-cheno, rimanendo sostanzialmente lettera morta; l’insuccesso della mediazione tentata da al-Wattari, oltre a determinarne l’uscita di sce-na politica, pose fine a ogni possibilità di future intese tra i governi di Baghdad e l’Ipc. Negli anni successivi, il dialogo e i negoziati vennero rilanciati più volte, senza giungere mai a un accordo. Anzi i punti di discussione e di confronto aumentarono, perché – contrariamente a quanto accaduto nel 1965 – da parte irachena si tornò a chiedere la partecipazione alla gestione della Ipc e la revisione del valore del-le royalties; condizioni che i responsabili delle compagnie straniere si rifiutarono costantemente di accettare, facendo precipitare i rapporti con le autorità irachene alla logica del “muro contro muro”.39
Il contenzioso con l’Ipc venne aggravato anche dalla disputa in corso tra la compagnia e il governo siriano per l’oleodotto che, par-tendo dai ricchi campi petroliferi del nord dell’Iraq, attraversava il territorio siriano, portando l’intera produzione di quei giacimenti verso il Mediterraneo; le autorità di Damasco chiesero con insistenza un aggiornamento nel calcolo delle tariffe di transito che l’Ipc pagava per il tratto siriano dell’oleodotto, arrivando, nel dicembre del 1966, a interrompere il flusso di greggio. Le conseguenze della decisione si-riana furono gravissime per l’economia irachena, dato che i due terzi della produzione nazionale di petrolio (pari a poco meno di 70 mi-lioni di tonnellate all’anno – t/a) provenivano dai distretti del nord del paese; la chiusura dell’oleodotto siriano impose una drastica ridu-zione delle esportazioni di petrolio, ridotte al solo greggio prodotto nel sud dell’Iraq (pari a circa 22 milioni t/a) e convogliato verso il Golfo Persico. Inevitabilmente anche le entrate nelle casse dello Stato, derivanti dalle royalties e dalle imposte petrolifere, furono fortemente ridimensionate, passando da circa 350 milioni di dollari all’anno, a circa 118 milioni di dollari; perdite e danni che, per gli ambienti po-litici e l’opinione pubblica del paese, erano direttamente imputabili alla rigidità della dirigenza dell’Ipc, andandosi così ad aggiungere agli
39 Bamberg, British Petroleum, cit., pp. 167-169.
44
altri motivi di recriminazione da parte irachena.40
La posizione irachena nei confronti dell’Ipc e, in particolare, nei confronti delle major angloamericane si radicalizzò ulteriormente, in conseguenza della guerra arabo-israeliana del giugno 1967, che causò la rottura delle relazioni del regime di Baghdad con i governi di Lon-dra e Washington, colpevoli di sostenere lo Stato d’Israele.41 All’in-terno della società irachena e della classe dirigente si rafforzò enorme-mente la convinzione che fosse giunto il momento di porre del tutto fine alla dipendenza del paese dalle compagnie straniere e di compiere i passi necessari per interrompere ogni legame con le multinazionali, il cui “imperialismo” – così sostenevano alcuni ambienti politici – non sarebbe mai cambiato.42 Fu, quindi, in un contesto di forte contrap-posizione con l’Ipc, che maturò la decisione del regime del presidente Abdul Rahman Arif di approvare due nuove leggi per rendere l’Inoc finalmente operativa, escludere definitivamente l’Ipc dai distretti più ricchi, ma non ancora produttivi, e coinvolgere altre società petrolife-re, chiamate a collaborare con gli iracheni nell’estrazione del greggio e non più a sfruttare le riserve nazionali in regime di monopolio.
In base alla prima delle due nuove leggi approvate dal governo di Baghdad, la numero 97 dell’agosto 1967, la titolarità dei diritti per lo sfruttamento di tutti i territori recuperati dallo Stato iracheno e sottratti alle concessioni assegnate all’Ipc veniva attribuita all’Inoc; inoltre, si stabiliva che, nell’attività di ricerca, estrazione e commer-cializzazione del greggio, l’ente petrolifero nazionale avrebbe potuto avvalersi della cooperazione di altri partner, anche stranieri, senza ri-
40 Telegram from the Embassy in Iraq to the Department of State, Baghdad, 17 dicem-bre 1966; Information Memorandum from the Deputy Assistant Secretary of State for Near Eastern and South Asian Affairs (Handley) to Secretary of State Rusk, Wash-ington, 1° febbraio 1967, in FRUS, 1964-1968, vol. XXXIV, dd. 197 e 202. Anche: Bamberg, British Petroleum, cit., pp. 168-169; Saul, Masterly Inactivity as Brink-manship, cit., pp. 773-774.41 Tripp, Storia dell’Iraq, cit., pp. 248-249.42 Nota di Humbaraci, al ritorno da Beirut, per Cefis, 22 agosto 1967, in ASE, FENI, Relazioni Esterne, b. 133. Arslan Humbaraci, giornalista di origine turca, era un consulente dell’Eni, incaricato di raccogliere informazioni sulla situazione politica in Africa del Nord e in Medio Oriente; si veda: M. Pirani, Poteva andare peggio. Mezzo secolo di ragionevoli illusioni, Mondadori, Milano 2010, pp. 298 sg.
4
correre, però, all’assegnazione di concessioni in esclusiva, bensì a con-tratti di servizio.43 Pochi mesi dopo, nel settembre del 1967, venne approvata la legge 123, che ridefiniva i poteri e la struttura dell’Inoc, al fine di renderla concretamente operativa nella costruzione di un’in-dustria petrolifera nazionale, ponendone l’operato sotto il diretto controllo politico.44 La nuova normativa adottata dal regime iracheno rappresentò una “seconda rivoluzione” degli assetti petroliferi locali, dopo quella determinata dalla legge 80 del 1961, dal momento che stabiliva l’esclusione definitiva dell’Ipc (e delle multinazionali che ne detenevano il pacchetto azionario) dallo sfruttamento dei ricchi gia-cimenti della zona nord di Rumayla e, allo stesso tempo, attribuiva all’ente di Stato la possibilità di coinvolgere altre compagnie, concor-renti di quelle consorziate nell’Ipc, nella coltivazione dei nuovi campi petroliferi. Il combinato disposto delle due leggi indebolì notevol-mente le posizioni di quelle major, che, attraverso l’Ipc, avevano mo-nopolizzato il settore petrolifero iracheno fino ad allora; la sorte delle multinazionali anglo-americane sembrò seguire di pari passo quella dei governi di Londra e Washington, le cui posizioni in Iraq venne-ro messe fortemente in crisi dalla guerra arabo-israeliana del giugno 1967 e dalla conseguente rottura dei rapporti bilaterali.45 Era evidente che, in Iraq, erano ormai maturate le condizioni favorevoli all’ingres-so di nuovi partner economici e politici.
Il primo a trarne vantaggio fu l’ente di Stato francese Erap (Enter-prise de Recherches et d’Activités Pétrolières), creato dal governo di Parigi nel 1965 per entrare in competizione con le compagnie private e dimi-nuire la dipendenza energetica del paese dalle multinazionali straniere. In Francia, gli ambienti economici e i circoli dirigenti erano diventati
43 Una copia in inglese del testo della legge 97 del 6 agosto 1967 si trova in ASE, FENI, b. 133. Alcune considerazioni in: Memorandum from George R. Jacobs of the Office of International Resources and Food Policy to the Assistant Secretary of State for Economic Affairs (Solomon), Washington, 11 agosto 1967, in FRUS, 1964-1968, vol. XXXIV, d. 207.44 Una copia in italiano del testo della legge 123 del 21 settembre 1967 si trova in ASE, FENI, b. 168, f. 15AB.45 Telegram From the Embassy in Iraq to the Department of State, Baghdad, 6 giugno 1967, in FRUS, 1964-1968, vol. XXI, d. 194.
4
particolarmente critici non solo della politica seguita dall’Ipc in Iraq, ma anche dell’incapacità della compagnia francese Cfp (partecipata da una quota di capitale pubblico, ma gestita privatisticamente) di tutelare gli interessi nazionali e di differenziare la propria posizione rispetto a quella dei partner anglo-americani.46 La Francia era maggiormente di-pendente dal petrolio mediorientale rispetto alla Gran Bretagna e agli Stati Uniti; e la stessa Cfp non aveva certo dimensioni, potenzialità e sbocchi di mercato, comparabili a quelle delle major anglo-americane; un terzo del petrolio prodotto dalla Cfp proveniva dall’Iraq e il prin-cipale mercato della compagnia era quello francese, al cui interno il greggio iracheno occupava una quota pari al 20%. La debolezza del si-stema francese emerse con chiarezza in occasione della guerra del giu-gno 1967, quando, a causa dell’embargo petrolifero attuato per alcune settimane dal governo iracheno contro i paesi occidentali, il governo di Parigi si rese perfettamente conto della propria vulnerabilità in campo energetico. In Francia, la rigidità assunta dalla dirigenza dell’Ipc nei rap-porti con il governo di Baghdad non poteva essere certo apprezzata; era chiaro, quindi, che si rendevano necessarie iniziative autonome rispetto a quelle attuate dagli anglo-americani anche in campo economico, così come era accaduto in campo politico, allorché il presidente De Gaul-le aveva preso le distanze dai governi di Londra e Washington, con-dannando l’iniziativa militare israeliana e interrompendo la fornitura di armi allo Stato d’Israele.47 Nel novembre del 1967, l’Inoc e l’Erap raggiunsero un’intesa di massima, perfezionata e ratificata nel febbraio successivo, per la sottoscrizione, da parte della società pubblica france-se, di un contratto di servizio finalizzato alla ricerca, alla produzione e allo sfruttamento commerciale del petrolio estratto in un’area di circa 11 mila km2 ,nel sud dell’Iraq (con l’esclusione dei campi petroliferi di Rumayla). Oltre ad assumersi i costi e i rischi dell’operazione, l’Erap
46 Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale Affari Economici, all’ENI, fono-gramma “riservato” n. 8461 del 13 Novembre 1967, in ASE, FENI, b. 133. Anche: Styan, France and Iraq, cit. pp. 50-52. 47 Roux a Couve de Murville, Il Cairo, 6 giugno 1967; Appunto della Direzione per il Levante sul conflitto arabo-israeliano, Parigi, 27 giugno 1967, in DDF, 1967, vol. I, dd. 259 e 337; Appunto sulle armi destinate al Medio Oriente, Parigi, 1° agosto 1967, ivi, 1967, vol. II, d. 65.
47
si impegnava a pagare 15 milioni di dollari all’Inoc, in caso di ritrova-mento di giacimenti petroliferi sfruttabili commercialmente; in cam-bio, l’ente di Stato francese otteneva la possibilità di acquistare il 30% del greggio prodotto a un prezzo inferiore a quello di mercato e di agire come intermediario per conto dell’Inoc nella vendita della quota ira-chena del greggio estratto.48 L’accordo introduceva un nuovo modello di relazioni tra paesi produttori e compagnie petrolifere: l’ente naziona-le iracheno era l’unico proprietario del greggio in tutte le fasi della pro-duzione, mentre la società francese si limitava a prestare la propria opera di contrattista, lavorando per conto dell’Inoc.49 Il presidente Rahman Arif definì l’accordo “un passo fondamentale per porre fine al controllo oligopolistico delle risorse nazionali esercitato dalle multinazionali” e per la costruzione di un’industria petrolifera nazionale indipendente.50
L’intesa Erap-Inoc fu seguita un mese dopo, nel dicembre del 1967, da un “accordo quadro” tra l’Iraq e l’Unione Sovietica, ben contenta, per motivi politici, più che economici, di inserirsi in qual-che modo nelle vicende petrolifere mediorientali e di approfittare dei problematici rapporti tra le classi dirigenti locali e le potenze anglo-americane.51 In virtù della “lettera d’intenti” scambiata tra i due go-verni, l’Urss avrebbe assicurato all’Inoc i capitali, le attrezzature e gli aiuti tecnici necessari allo sfruttamento di nuovi campi petroliferi, in cambio di forniture di greggio.52 L’intesa, tuttavia, non poté diventa-
48 Gorce a Couve de Murville, Baghdad, 29 novembre 1967, in DDF, 1967, vol. II, d. 261. Saul, Masterly Inactivity as Brinkmanship, cit., pp. 772-778.49 Appunto della Direzione Affari Economici e Finanziari sui negoziati petroliferi fran-co-iracheni, Parigi, 31 gennaio 1968, in DDF, 1968, vol. I, d. 78.50 Smolanski, Smolanski, The USSR e and Iraq, cit., p. 38. Alcune considerazio-ni anche in: Appunto della Direzione Africa – Levante sulle relazioni franco-irachene, Parigi, 31 gennaio 1968, in DDF, 1968, vol. I., d. 77.51 Appunto del MAE all’ENI, riassuntivo di un colloquio tra l’ambasciatore italiano a Baghdad e il suo omologo sovietico, 12 marzo 1968, preso in visione da Ratti e Gandolfi e indirizzato a Girotti, in ASE, FENI, Presidenza Raffaele Girotti, b. 94, f. 3521; Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale Affari Economici, all’ENI, te-lespresso n. 077/8357, del 10 aprile 1972, a firma Ricciulli, “d’ordine del ministro”, ivi, b. 168, f. 15A8.52 Studio dell’addetto commerciale dell’Ambasciata d’Italia a Baghdad, Ariosto Bernar-dini, sull’industria petrolifera, cit., in ASE, FENI, Direzione Estera, b. 168, f. 15A9.
48
re operativa a causa di due nuovi colpi di stato militari, che, tra il 17 e il 30 luglio, posero fine al regime di Rahman Arif, permettendo al partito Baath di conquistare definitivamente il potere.53 Nonostante le valutazioni inizialmente positive dei diplomatici statunitensi sugli orientamenti del regime baathista avessero indotto i circoli politici di Washington a sperare in una soluzione amichevole della controver-sia con l’Ipc, la nuova dirigenza irachena chiarì immediatamente che le intese petrolifere sottoscritte dal precedente regime sarebbero sta-te rispettate.54 Era l’ennesima riprova che, indipendentemente dagli uomini e dai gruppi al potere di volta in volta a Baghdad, la politica petrolifera rimaneva immutata, essendo costantemente diretta al pro-gressivo ridimensionamento del ruolo delle multinazionali, con il fine ultimo di portare il settore petrolifero, di gran lunga la principale fon-te di reddito nazionale, sotto il pieno controllo dello Stato.
Il regime baathista (guidato dal generale Ahmed Hasan al-Bakr, nominato presidente della Repubblica dal Consiglio del Comando Rivoluzionario, l’organo supremo detentore del potere esecutivo, le-gislativo e giudiziario) non solo confermò il contratto di servizio fir-mato con la compagnia nazionale francese Erap, ma diede attuazione anche alla “lettera d’intenti” sottoscritta con l’Unione Sovietica, no-nostante il feroce anticomunismo dimostrato dal movimento baathi-sta negli anni precedenti. Fu così che, nel giugno del 1969, l’Inoc e la sovietica Machinoexport conclusero due contratti, per la fornitura di assistenza tecnica e di materiali per cicli completi di operazioni petro-lifere, destinati allo sfruttamento della zona di Al Halfayah (a 120 km da Bassora). Poche settimane dopo, nel luglio dello stesso anno, i go-verni di Mosca e Baghdad raggiunsero un accordo per la cooperazione tecnica ed economica, grazie al quale l’Iraq avrebbe ricevuto un cre-dito di 70 milioni di dollari per rendere finalmente operativi i ricchi
53 Osservazioni sull’attuale situazione politica in Iraq, appunto senza data (ma secon-da metà 1968), in ASE, FENI, Presidenza Girotti, b. 94, f. 3521.54 Memorandum From John W. Foster of the National Security Council Staff to the President’s Special Assistant (Rostow), Washington, 22 luglio 1968, in FRUS, 1964-1968, vol. XXI, d. 200; Research Memorandum From the Acting Director of the Bu-reau of Intelligence and Research (Denney) to the Acting Secretary of State (Johnson), 27 febbraio 1969, in FRUS, 1969-1976, Vol. E-4, d. 252.
49
giacimenti della zona nord di Rumayla a partire dal 1972 con una pro-duzione iniziale di 5 milioni di tonnellate all’anno, e per la costruzio-ne di un oleodotto di 130 km fino al porto di Fao, nel Golfo Persico; sia i contratti, del valore di 72 milioni di dollari, che i finanziamenti, sarebbero stati onorati con forniture di petrolio prodotto dall’Inoc.55 Deciso a conquistare quanto prima la piena indipendenza economica e a tagliare ogni legame con le compagnie consorziate nell’Ipc, il re-gime baathista estese considerevolmente la propria rete di partnership petrolifere, concludendo una serie di contratti di servizio e di accordi di cooperazione anche con alcuni satelliti dell’Unione Sovietica, sulla base dello stesso modello di relazioni economiche e commerciali uti-lizzato nelle intese con Mosca. A partire dal novembre 1969, l’Iraq sottoscrisse una serie di accordi barter e varie intese finanziarie con Cecoslovacchia, Ungheria, Polonia, Bulgaria e Repubblica Demo-cratica Tedesca, per la fornitura di impianti, attrezzature e assistenza tecnica, e per la concessione di crediti, in cambio di greggio; fornitu-re e crediti finalizzati all’attuazione di progetti industriali e agricoli, alla costruzione di raffinerie, stabilimenti petrolchimici e oleodotti, e alla realizzazione di infrastrutture.56 Non era più lo Stato iracheno a farsi direttamente carico della progettazione e del completamento delle opere necessarie allo sviluppo e alla modernizzazione del paese, impiegando le royalties petrolifere pagate dalle multinazionali, la cui entità e il cui valore, però, fluttuavano in funzione delle esigenze del-le compagnie; ma erano le società pubbliche, controllate dai governi esteri, a sottoscrivere contratti d’appalto, in cambio di forniture di greggio, da utilizzare, poi, per l’approvvigionamento energetico dei
55 Studio dell’addetto commerciale dell’Ambasciata d’Italia a Baghdad, Ariosto Ber-nardini, sull’industria petrolifera, cit., in ASE, FENI, Direzione Estera, b. 168, f. 15A9; Bernardini al Ministero degli Affari Esteri, Baghdad, 18 giugno 1971, tele-spresso “riservato” n. 917 (copia girata per conoscenza all’Eni in data 2 luglio con telespresso “riservato n. 077/14016, a firma Ricciulli, “d’ordine del ministro”), ivi, f. 15A4. Anche: Smolanski, Smolanski, The USSR and Iraq, cit., pp. 38-45.56 Studio dell’addetto commerciale dell’Ambasciata d’Italia a Baghdad, Ariosto Ber-nardini, sull’industria petrolifera, cit., in ASE, FENI, Direzione Estera, b. 168, f. 15A9; Bernardini al Ministero degli Affari Esteri, Baghdad, 18 giugno 1971, cit., ivi, f. 15A4. Anche: Smolanski, Smolanski, The USSR e and Iraq, cit., pp. 48-50.
470
rispettivi paesi o da vendere liberamente sul mercato petrolifero mon-diale. In questo modo, lo Stato iracheno acquisiva un ruolo centrale nel controllo e nella gestione del settore petrolifero nazionale, non dipendendo più dalle strategie industriali e dai livelli di produzione decisi dalle multinazionali.
L’Eni e il petrolio iracheno: alla ricerca di una terza via
Gli accordi conclusi con l’Unione Sovietica e con alcune democra-zie popolari non implicavano, però, una netta scelta di campo ideolo-gico, né tantomeno uno scivolamento verso l’integrazione nel blocco sovietico. La strategia attuata dai regimi iracheni degli anni Sessanta rispondeva alla necessità di diversificare le partnership petrolifere e le fonti di reddito, al fine di ottimizzare i profitti economici e i benefici in termini di sviluppo industriale e infrastrutturale, mettendo in con-correnza le società straniere interessate al greggio iracheno e rompen-do il controllo monopolistico dell’Ipc e delle sue affiliate.57 I governi di Baghdad e l’Inoc, infatti, non si rivolsero solo ai paesi del campo co-munista, ma anche a governi e compagnie del blocco occidentale, con la sola eccezione delle società anglo-americane. Tuttavia, all’infuori del caso della francese Erap, i tentativi furono per lo più fallimentari, a causa del veto posto dalle multinazionali consorziate nell’Ipc nei con-fronti delle altre compagnie occidentali. Era evidente che solo gli enti di Stato e le aziende pubbliche dei paesi del blocco sovietico potevano agire senza alcun timore di subire le conseguenze delle ritorsioni legali ed economiche, minacciate dalle major anglo-americane dell’Ipc con il sostegno, in alcuni casi, anche dei rispettivi governi.58
57 Studio dell’addetto commerciale dell’Ambasciata d’Italia a Baghdad, Ariosto Ber-nardini, sull’industria petrolifera, cit., in ASE, FENI, Direzione Estera, b. 168, f. 15A9; Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale Affari Economici, all’ENI, telespresso n. 077/3501 del 16 febbraio 1972, a firma Ricciulli, “d’ordine del mini-stro”, ivi, f. 15A8; 58 Studio dell’addetto commerciale dell’Ambasciata d’Italia a Baghdad, Ariosto Ber-nardini, sull’industria petrolifera, cit., in ASE, FENI, Direzione Estera, b. 168, f. 15A9; Massa Bernucci al MAE, Baghdad, 24 aprile 1972, telespresso n. 613 (copia),
471
Tra le compagnie occidentali invitate a collaborare nella produ-zione del greggio iracheno, vi fu anche l’Ente Nazionale Idrocarburi (Eni), l’ente di Stato italiano creato nel 1953 da Enrico Mattei e im-pegnato nel difficile compito di dare all’Italia una politica energetica in linea con le necessità e le aspirazioni del paese, avviato a diventare una delle maggiori potenze industriali del mondo. Già all’inizio degli anni Sessanta, durante il regime dal generale Qassim, le autorità ira-chene avevano tentato di entrare in contatto con la compagnia italia-na. L’Eni era una realtà emergente nell’industria petrolifera mondia-le e sembrava in grado di reggere il confronto e la competizione con operatori presenti in Medio Oriente da decenni. All’epoca, però, non fu possibile dar vita ad alcun negoziato concreto per la collaborazione nel campo della ricerca e dello sfruttamento di greggio a causa della ferma opposizione dell’Ipc, contraria a qualsiasi interferenza esterna nel settore petrolifero iracheno.59
Le conversazioni esplorative tra l’Eni e le autorità irachene furo-no rilanciate a metà degli anni Sessanta, attraverso un lungo scambio epistolare tra i vertici dell’ente di Stato italiano e i responsabili dell’I-noc e del ministero degli Affari Petroliferi iracheno. Nel novembre del 1965, fu Raffaele Girotti, direttore generale dell’Eni e ammini-stratore delegato dell’Agip, a rinnovare alla dirigenza dell’Inoc “la volontà e l’intenzione” da parte italiana di dar vita a un negoziato per un’eventuale collaborazione petrolifera in territorio iracheno.60 A tale scopo, tra il marzo e il luglio del 1966, i vertici dell’Eni inviaro-no due volte a Baghdad un proprio rappresentante, Enrico Gandolfi, responsabile della Direzione Esteri, per approfondire lo scambio di vedute e presentare una proposta di accordo per lo sfruttamento dei giacimenti della zona Nord di Rumayla.61 La strategia dell’ente di Sta-
ivi, f. 15A8; FRUS, 1969-1976, Vol. E-4, d. 252.59 Su tutto questo, si veda: A. Tonini, Il sogno proibito. Mattei, il petrolio arabo e le ‘sette sorelle’, Polistampa, Firenze 2003, pp. 106-124.60 Notizie della lettera di Girotti del 6 novembre 1965 si ricavano dalla risposta inviatagli dall’amministratore delegato dell’Inoc: Alukaili a Girotti, Baghdad, 23 novembre 1965, lettera (copia), in ASE, FENI, Presidenza Raffaele Girotti, b. 94, f. 3521.61 Notizie delle missioni di Gandolfi a Baghdad e degli obiettivi dell’Eni in Iraq
472
to italiano era chiara: i nuovi contatti facevano seguito al fallimento dei negoziati del 1965 tra il governo iracheno e l’Ipc, ed erano diretti all’ottenimento di una concessione per la ricerca e l’estrazione degli idrocarburi nel distretto petrolifero più promettente tra quelli espro-priati dal governo di Baghdad nel 1961. Facendo leva sui contrasti sempre più insanabili tra le autorità irachene e la dirigenza dell’Ipc, l’Eni sperava di inserirsi nel settore petrolifero iracheno in una po-sizione di assoluto privilegio, offrendo al governo di Baghdad quella sponda alternativa necessaria per rompere il pluridecennale oligopo-lio delle compagnie angloamericane. Nel far ciò, il gruppo energetico italiano avrebbe cointeressato l’ente nazionale iracheno nella gestione del processo produttivo, così come era accaduto precedentemente in Iran, in Egitto e in Marocco, grazie all’applicazione della cosiddetta “formula Mattei”, che prevedeva, tra le altre cose, una ripartizione de-gli utili non paritaria, bensì favorevole ai governi locali.62
Tuttavia, pur ricevendo attenzione e interesse da parte della di-rigenza dell’Inoc e del ministero degli Affari Petroliferi, le proposte dell’Eni non si tradussero in accordi e i negoziati non segnarono signi-ficativi passi in avanti per molto tempo. Secondo un appunto interno dell’Eni, i motivi della mancata concretizzazione dei contatti italo-iracheni furono fondamentalmente due: 1) la perdurante situazione di tensione tra il governo di Baghdad e l’Ipc, i cui vertici continuava-no a dichiarare illegittima la legge 80 del 1961 e la conseguente revoca
sono in: Abdullah Ismail (Direttore generale del Ministero de Petrolio) a Gandolfi, Baghdad, 6 marzo 1966, lettera (copia); Shukri Saleh Zaki (Ministro del Petrolio) a Girotti, Baghdad, 20 luglio 1966, lettera (copia); Talib a Girotti, Baghdad, 27 novembre 1966, lettera “confidenziale” (copia), in ASE, FENI, Presidenza Raffaele Girotti, b. 94, f. 3521.62 È noto che la cosiddetta “formula Mattei” rappresentava un superamento del principio paritario (50/50) di divisione degli utili, applicato nel secondo dopo-guerra dalle multinazionali petrolifere in Medio Oriente, perché attribuiva ai go-verni locali il 75% dei profitti, lasciando alle compagnie straniere il restante 25%. Sull’origine di tale formula e sulla sua applicazione da parte dell’Eni negli anni della presidenza Mattei: Tonini, Il sogno proibito, cit., passim; B. Bagnato, Petrolio e politica: Mattei in Marocco, Polistampa, Firenze 2004; M. Bucarelli, All’origine della politica energetica dell’ENI in Iran: Enrico Mattei e i negoziati per gli accordi petroliferi del 1957, “Nuova Rivista Storica”, 2010, n. 2.
473
del 99,5% delle concessioni (tra cui i ricchi giacimenti di Rumayla, sulla cui titolarità sembrava esserci molta incertezza); 2) la “perma-nente situazione di instabilità politica e di lotta politica e militare” esistente in Iraq, che rendeva difficile avere rapporti con uomini di governo e dirigenti politici, in grado di prendere decisioni stringenti e vincolanti.63 In realtà, l’azione dell’Eni venne rallentata anche dal ri-tardo con cui i responsabili del gruppo italiano sembrarono cogliere il cambiamento in atto nella politica petrolifera irachena. Il rilancio del-le conversazioni con l’Eni, infatti, fu di poco antecedente alle conver-sazioni delle autorità di Baghdad con la compagnia francese Erap e si andò a inserire nella nuova strategia irachena di sottoscrivere contratti di servizio e accordi barter con varie realtà imprenditoriali straniere, senza concedere diritti esclusivi di sfruttamento e senza rinunciare al pieno controllo delle risorse nazionali. L’iniziale proposta della socie-tà italiana, quindi, non era del tutto in sintonia con i mutati indirizzi della politica irachena, interessata a coinvolgere l’Eni nell’industria petrolifera nazionale non come concessionario, ma come appaltatore.
Le trattative entrarono nel vivo e sembrarono avviarsi alla conclu-sione di un’intesa solo dopo che il governo di Baghdad fece chiarezza sul modello di relazioni che intendeva applicare alla collaborazione con l’ente di Stato italiano. Nel gennaio del 1967, il generale Naji Ta-lib, primo ministro e ministro degli Affari Petroliferi ad interim du-rante la presidenza di Rahman Arif, presentò ai vertici dell’Eni un dettagliato pacchetto di proposte finalizzate alla sottoscrizione di un contratto di lavoro tra il governo di Baghdad e la compagnia italiana. Secondo il testo preparato dal premier, lo Stato iracheno avrebbe man-tenuto la proprietà esclusiva dei campi petroliferi, delle attrezzature e della produzione, mentre l’Eni avrebbe prestato la propria opera e i propri servizi nelle varie attività di ricerca, esplorazione ed estrazione del greggio; due sarebbero state le aree nel Sud del paese destinate ad essere messe in coltivazione: la zona Nord di Rumayla, già oggetto di prospezioni da parte dell’Ipc e pronta a produrre grossi quantitativi di petrolio, e una seconda zona a scelta dell’Eni, in base alle valutazioni
63 Appunto: l’ENI e l’Iraq, Roma. 6 febbraio 1967, ASE, FENI, Presidenza Raffaele Girotti, b. 94, f. 3521.
474
geologiche dei suoi tecnici; gli investimenti necessari e i costi opera-tivi, sostenuti per intero dalla compagnia italiana, sarebbero stati ri-pagati con forniture di greggio a prezzi inferiori rispetto a quelli del mercato internazionale; l’Eni avrebbe dovuto garantire allo Stato ira-cheno il ritiro di almeno 20 milioni di tonnellate di petrolio all’anno, allo stesso prezzo praticato per il greggio importato a compensazione degli investimenti; l’ente italiano, inoltre, avrebbe acquistato ulteriori quantitativi di petrolio, a un prezzo da fissare in successivi negoziati e a fronte della vendita di beni e servizi occorrenti all’Iraq, nel quadro della realizzazione di programmi di sviluppo economico e industriale; l’accordo avrebbe avuto una durata venticinquennale a partire dalla reale disponibilità di greggio.64
Nonostante il progetto iracheno si discostasse dall’iniziale richie-sta dell’Eni di ottenere una concessione petrolifera, configurando, in-vece, una prestazione di opere e servizi, la compagnia italiana decise di aderire all’invito del premier Talib di approfondire lo studio delle sue proposte.65 Pur avendo ben presenti le difficoltà esistenti sia a livel-lo locale, che internazionale, la dirigenza dell’Eni ritenne opportuno provare a inserirsi nel settore petrolifero iracheno, anticipando tutte le altre compagnie nello sfruttamento di uno dei giacimenti conside-rati più promettenti e importanti del Medio Oriente. In una lettera del 17 marzo 1967, Girotti, annunciando a Talib l’invio in Iraq di Gandolfi munito di pieni poteri per condurre le trattative, anticipò i punti centrali della controproposta italiana. Nonostante la disputa in atto da anni tra il governo di Baghdad e l’Ipc per la titolarità dei diritti di sfruttamento della zona, l’Eni sostanzialmente accettava l’offerta irachena per la messa in produzione del campi del Nord Ru-mayla; anzi, per l’ente di Stato italiano – puntualizzava il direttore generale del gruppo, facendo cadere una delle obiezioni che in pre-cedenza sembravano aver frenato i colloqui tra le due parti – la legge 80 del 1961 aveva attribuito allo Stato iracheno la proprietà e la piena disponibilità dell’area, per cui non sembravano esserci impedimenti
64 Ibidem.65 Girotti a Talib, Roma, 23 febbraio 1967, lettera (copia), in ASE, FENI, Presiden-za Raffaele Girotti, b. 94, f. 3521.
47
di sorta nella conclusione di un accordo relativo al distretto in que-stione. L’Eni – scriveva Girotti – era disposta ad assumersi l’impegno di acquistare almeno 20 milioni t/a, al prezzo di un dollaro e 14 cen-tesimi al barile (contro un dollaro e 80 al barile praticato sul mercato mondiale all’epoca); gli investimenti e i costi sostenuti sarebbero stati dedotti dall’importo dovuto dal gruppo italiano per l’acquisto dei 20 milioni t/a; l’Eni, inoltre, avrebbe offerto i propri servizi, in qualità di broker, anche per la vendita della produzione di greggio in eccesso rispetto alla quota minima di 20 milioni t/a garantita dall’accordo; la compagnia italiana, infine, avrebbe assicurato l’apertura di una linea di credito di 25 milioni di dollari per l’acquisto di beni e servizi presso le società del gruppo, il cui importo, con i relativi interessi, sarebbe sta-to anch’esso dedotto dai pagamenti dovuti dall’ente di Stato italiano per l’acquisto del greggio. Girotti concludeva la lettera sollecitando una pronta risposta da parte delle autorità irachene, in considerazione della complessa programmazione, che un’impresa del genere avrebbe reso necessaria, e della portata degli sforzi finanziari e tecnici, che un accordo così impegnativo avrebbe implicato.66
La replica irachena fu sì rapida, ma non del tutto in linea con le aspettative dei vertici dell’Eni. I punti di disaccordo, precisati in due lettere del premier iracheno a Girotti del 22 marzo e del 4 aprile 1967, erano essenzialmente tre: 1) il prezzo di un dollaro e 14 centesimi al barile proposto dalla compagnia italiana era ritenuto “non accettabi-le” da Talib, che suggeriva, invece, di non fare riferimento a un prez-zo fisso, ma di individuare piuttosto una formula o un prezzo base, a cui aggiungere percentuali variabili da concordare; 2) la somma di 50 milioni di dollari, che l’Eni avrebbe dovuto versare come pagamento anticipato per le quote annuali di petrolio da acquistare era ritenuta insufficiente; 3) il governo iracheno avrebbe mantenuto la più ampia libertà di decidere se commercializzare la proprio quota di greggio di-rettamente o avvalendosi della mediazione del gruppo italiano a una tariffa da stabilire di comune accordo.67
66 Girotti a Talib, Roma, 17 marzo 1967, lettera (copia), in ASE, FENI, Presidenza Raffaele Girotti, b. 94, f. 3521.67 Nei documenti conservati presso l’archivio dell’Eni è stata ritrovata solo la lettera del 4 aprile, in cui si fa riferimento ad una precedente missiva del 22 marzo 1967;
47
Le controproposte irachene non furono accolte favorevolmente dalla dirigenza dell’Eni, a tal punto da spingere Girotti a rivolgersi al governo italiano, affinché un eventuale intervento politico potesse fa-cilitare il raggiungimento di un’intesa positiva per entrambe le parti. Il 24 marzo del 1967, il direttore generale scrisse ad Amintore Fanfa-ni, ministro degli Esteri del terzo governo guidato da Aldo Moro, per richiamarne l’attenzione sulla vicenda. Il responsabile della Farnesina, che era stato già messo a conoscenza dallo stesso Girotti dei negoziati in corso, in quei giorni era in partenza per un giro di visite ufficiali in Libano, Giordania e Iraq, nel tentativo di dare un contributo alla soluzione della difficile situazione mediorientale determinata dal con-flitto arabo-israeliano per la Palestina. Nella lettera, il direttore ge-nerale informava Fanfani che le controproposte comunicate da Talib si discostavano “fortemente” da quelle avanzate dal gruppo italiano; motivo per cui si rendeva necessario un interessamento anche da parte del governo. A tale scopo, in vista degli incontri che Fanfani avrebbe avuto con le autorità irachene e dei vari temi che presumibilmente sarebbero stati affrontati nei colloqui, a margine della crisi palestine-se, Girotti aveva ritenuto “doveroso” inviare nuovamente Gandolfi a Baghdad, in concomitanza con l’arrivo del ministro degli Esteri, per aggiornarlo sull’andamento delle trattative.68
Con ogni probabilità, l’intervento di Fanfani fornì un utile con-tributo al superamento delle difficoltà negoziali, dato che, poche set-timane dopo, il vicepresidente dell’Eni, Eugenio Cefis, il vero artefice delle strategie dell’ente nel dopo Mattei,69 scrisse al ministro per le Partecipazioni Statali, Giorgio Bo, per chiedere l’autorizzazione a
si veda: Talib a Girotti, Baghdad, 9 aprile 1967, lettera, in ASE, FENI, Presidenza Raffaele Girotti, b. 94, f. 3521.68 Girotti a Fanfani, Roma, 24 marzo 1967, lettera (copia), in ASE, FENI, Presiden-za Raffaele Girotti, b. 94, f. 3521.69 Sulla riorganizzazione e sui nuovi equilibri all’interno dell’Eni, e sulle nuove stra-tegie dell’ente, nel dopo Mattei: Pozzi, Dai gatti selvaggi al cane a sei zampe, cit., pp. 459 sg.; R. Milano, Una difficile transizione. Momenti e problemi dell’azione internazionale dell’ENI dopo la scomparsa di Enrico Mattei (1962-1965), “Clio”, 2011, n. 2, pp. 285 sg.; S. Labbate, Il governo dell’energia. L’Italia dal petrolio al nucleare (1945-1975), Le Monnier, Firenze 2010, pp. 103 sg.
477
continuare le trattative con il governo iracheno. Nella lettera, Cefis ricapitolò i punti salienti dell’operazione: al fine di giungere “ad una forma di collaborazione” per lo sfruttamento dei campi petroliferi si-tuati nel Sud del paese, denominati “Nord Rumayla”, l’Eni, attraverso l’Agip, avrebbe dovuto accettare il principio di operare sulla base di un contratto di lavoro, mentre la proprietà del campo, delle attrez-zature e del greggio prodotto sarebbe rimasta in mano irachena; gli investimenti necessari e i costi operativi, anticipati dalla compagnia italiana, sarebbero stati ripagati con il petrolio estratto a un prezzo più favorevole di quello praticato sul mercato internazionale; l’Eni si sa-rebbe impegnata a garantire un ritiro annuale di 20 milioni di tonnel-late per 25 anni; il gruppo italiano, infine, avrebbe dovuto anticipare al governo iracheno, alla data della firma dell’eventuale accordo, una somma a titolo di prestito, rimborsabile attraverso il ritiro del greggio prodotto.70
I vertici dell’Eni, chiesta l’autorizzazione per la prosecuzione dei negoziati, inviarono ancora una volta Gandolfi a Baghdad, con l’in-carico di consegnare al primo ministro Talib una bozza di accordo redatta sulla base dei vari punti emersi nei precedenti contatti. Secon-do Girotti, estensore della lettera di accompagnamento alla proposta dell’Eni, il testo posto all’attenzione del governo iracheno rappresen-tava un “serio contributo” alla conclusione dell’accordo di cooperazio-ne per la messa in produzione dei campi petroliferi del distretto Nord di Rumayla; una puntualizzazione che lasciava intendere il raggiungi-mento del limite massimo di concessioni, che la compagnia italiana era ormai disposta a fare.71 La risposta del premier iracheno, però, fu interlocutoria: Talib scrisse a Girotti che il governo di Baghdad aveva bisogno di ulteriore tempo per “analizzare e studiare” il documento presentato dall’Eni, prima di entrare in conversazioni più dettagliate sui vari aspetti dell’accordo, indicando una serie di punti specifici su cui riteneva ancora necessario riflettere e discutere: 1) il ruolo dell’A-gip di General Contractor al servizio dell’Inoc (apparentemente in
70 Cefis a Bo, Roma, 17 aprile 1967, lettera (copia), in ASE, FENI, Presidenza Raf-faele Girotti, b. 94, f. 3521.71 Girotti a Talib, Roma, 18 aprile 1967, lettera (copia), in ASE, FENI, Presidenza Raffaele Girotti, b. 94, f. 3521.
478
contraddizione con i contenuti del testo proposto, che sembrava con-figurare piuttosto un rapporto di partnership); 2) la determinazione del prezzo del petrolio di riferimento; 3) la durata venticinquennale dell’accordo; 4) l’impegno a commercializzare almeno 20 milioni di tonnellate di greggio all’anno; tutti punti su cui il primo ministro ira-cheno si dichiarava d’accordo in linea di principio, ma che avevano bisogno di nuove e più approfondite valutazioni.72
In realtà, la richiesta di analisi e verifiche supplementari era un modo per evitare la conclusione dell’accordo, rinviandola a data da destinare. I motivi alla base della decisione di Talib di non procedere ulteriormente nella definizione della collaborazione con l’Eni erano dovuti sia a questioni di politica interna, che a pressioni internazio-nali. La posizione del primo ministro iracheno si era notevolmente indebolita negli ultimi tempi: Talib, infatti, si era dimostrato incapace di superare le divisioni interne al corpo ufficiali, i veri detentori del potere politico in Iraq, e di ampliare la propria base politica di rife-rimento, composta essenzialmente dalla fazione filonasseriana dell’e-sercito. Nella prima settimana di maggio del 1967, pochi giorni dopo la richiesta di una pausa di riflessione ai dirigenti dell’Eni, il premier iracheno diede le dimissioni e il presidente Rahman Aref si assunse in prima persona la responsabilità di formare un nuovo governo, met-tendosi egli stesso a capo di un esecutivo di unità nazionale, con la partecipazione delle componenti più moderate del partito Baath e de-gli ufficiali nazionalisti, e il netto ridimensionamento della corrente nasseriana.73
Tuttavia, non furono solo le perduranti divisioni interne alle forze armate a mettere in difficoltà l’esecutivo guidato da Talib. La crisi del
72 Talib a Girotti, Baghdad, 24 aprile 1967, lettera “confidenziale”, in ASE, FENI, Presidenza Raffaele Girotti, b. 94, f. 3521.73 Briatico (Servizio relazioni pubbliche ENI) a Girotti, Roma, 9 maggio 1967, lettera “urgente” con allegate due relazioni sulla situazione irachena provenienti da Beirut e da Londra; Briatico a Girotti, Roma, 11 maggio 1967, appunto; Briatico a Girotti, Roma, 12 maggio 1967, telex, con cui trasmetteva le notizie dall’Iraq ricevute per telefono da Humbaraci (Beirut) in ASE, FENI, Presidenza Raffaele Girotti, b. 94, f. 3521. Una copia del telex di Briatico anche in: ASE, FENI, Relazioni Esterne, b. 133.
479
maggio 1967 fu anche il risultato delle pressioni esercitate dalla diri-genza dell’Ipc sul governo di Baghdad, colto in un momento di estre-ma debolezza a causa della chiusura dell’oleodotto siriano e dell’in-gente danno economico che ne stava derivando per le finanze pub-bliche. Proprio in concomitanza con lo scoppio della crisi di governo, l’Ipc raggiunse un’intesa con le autorità irachene per la concessione di un finanziamento di 14 milioni di sterline, da intendersi come an-ticipo delle royalties da versare una volta risolto il contenzioso con la Siria e ripristinati i normali livelli di produzione ed esportazione di greggio.74 Con ogni probabilità, quindi, esisteva una correlazione tra l’intervento della Ipc, la caduta di Talib e la formazione di un governo di concentrazione nazionale, con la presenza di personalità ritenute maggiormente disponibili nei confronti della compagnia controllata dalle major, come il generale Taher Yahia, numero due del nuovo ga-binetto (già primo ministro nel 1965 all’epoca dell’accordo con l’Ipc negoziato dall’allora ministro del Petrolio al-Wattari), nominato, poi, capo dell’esecutivo nel luglio del 1967.75 Ancora più probabile la cor-relazione tra la crisi di governo e le pressioni esercitate dall’Ipc per far fallire i negoziati tra le autorità irachene e l’Eni. Prova ne furono le difficoltà immediatamente riscontrate da Gandolfi nel riprendere i negoziati con i rappresentanti del nuovo governo iracheno formatosi sotto la guida del presidente Arif. Malgrado ogni sforzo da parte sua e le assicurazioni ufficiali da parte delle autorità locali, l’inviato dell’Eni a Baghdad, il 20 maggio del 1967, scriveva di non potere “sfortunata-mente garantire” di rientrare a Roma con un nuovo testo, a causa delle pressioni dell’Ipc sul ministro per gli Affari Petroliferi, Al Hussein. Come constatò lo stesso Gandolfi, era evidente che la sua azione or-mai era diventata “molto difficile”.76
74 Memorandum from George R. Jacobs of the Office of International Resources and Food Policy to the Assistant Secretary of State for Economic Affairs (Solomon), Wash-ington, 11 agosto 1967, cit. Anche: Bamberg, British Petroleum, cit., pp. 168-169.75 Briatico a Girotti, Roma, 12 maggio 1967, cit., in ASE, FENI, Presidenza Raffaele Girotti, b. 94, f. 3521.76 Promemoria per Girotti, contenente la trascrizione di un telegramma inviato da Gandolfi, Roma, 22 maggio 1967, in ASE, FENI, Presidenza Raffaele Girotti, b.
480
L’Ipc non si limitò a interferire nella vita politica irachena, facen-do leva sulla propria importanza per gli assetti economici e sociali del paese, ma intervenne direttamente e con forza anche nei confronti dell’Eni. Il 26 aprile del 1967, l’amministratore delegato della Ipc e delle società affiliate (Mpc e Bpc), Christopher M. Dalley, scrisse ai vertici del gruppo italiano per protestare ufficialmente contro le noti-zie di negoziati in corso tra l’Eni e le autorità irachene, finalizzati allo sfruttamento di aree petrolifere su cui le tre società vantavano dei di-ritti. Nella lettera, il massimo dirigente dell’Ipc ricordava che, in base agli accordi stipulati tra lo Stato iracheno e le tre compagnie, e consi-derati da quese ultime ancora in vigore, le concessioni assegnate copri-vano tutto il territorio iracheno, ad eccezione di due zone di modesta estensione (i giacimenti di Khanaqin al confine con l’Iran). Nono-stante l’approvazione della legge 80 del 1961 e la creazione dell’Inoc, a cui il governo di Baghdad aveva affidato lo sfruttamento delle aree espropriate, l’Ipc e le sue affiliate continuavano a considerarsi le uni-che società titolari dei diritti di sfruttamento del suolo iracheno, così come previsto dagli accordi esistenti, la cui validità era salvaguardata dalle norme di diritto internazionale. Le tre compagnie, quindi, non solo affermavano di non riconoscere la legge del 1961 e i suoi effetti, ma avvisavano l’Eni che avrebbero intrapreso ogni azione ritenuta ne-cessaria per la tutela dei propri diritti, considerando responsabile per la violazione di tali diritti chiunque interferisse o tentasse di interfe-rire nella loro applicazione. La lettera dell’amministratore delegato si chiudeva con una vera e propria diffida nei confronti dell’ente di Stato a non proseguire oltre nei negoziati in corso: l’Eni – scriveva Dalley – era ormai consapevole dei diritti dell’Ipc e delle obiezioni mosse dalla sua dirigenza; pertanto, se le trattative si fossero chiuse con un accordo, il gruppo italiano se ne sarebbe assunto tutti i rischi.77 Due giorni dopo, fu la volta del vicepresidente esecutivo della Standard Oil of New Jersey (Esso), William R. Scott, a scrivere alla dirigenza della compagnia italiana per esprimere la propria preoccupazione di fronte
94, f. 3521.77 Dalley a Boldrini, Londra, 26 aprile 1967, lettera, in ASE, FENI, Presidenza Raf-faele Girotti, b. 94, f. 3521.
481
al tentativo dell’Eni di ottenere la disponibilità di zone ancora legal-mente detenute dall’Ipc e dalle sue affiliate. La Esso, la multinazionale più vicina all’Eni e fautrice del riavvicinamento tra il gruppo italiano e le major dopo le frizioni dei primi anni della presidenza Mattei,78 non poteva far altro che ribadire “il suo completo appoggio alla posi-zione giuridica” assunta dalla Ipc e dal suo management.79
Le pressioni per impedire l’apertura del settore petrolifero iracheno alle iniziative dell’Eni non si fermarono alle intimazioni nei confronti dell’ente di Stato, ma coinvolsero anche il governo italiano, presso cui furono compiuti alcuni passi ufficiali da parte dei rappresentanti dei paesi di residenza delle major azioniste della Ipc. Il 3 maggio del 1967, fu l’ambasciatore britannico a Roma, Sir Evelyn Shuckburg, a chiedere direttamente a Fanfani assicurazioni in merito ai contatti in corso tra l’Eni e le autorità irachene.80 Non avendo ricevuto alcuna risposta in tal senso dal governo italiano, il segretario di Stato per gli Affari Esteri, il laburista George Brown, diede istruzioni all’ambasciatore di conse-gnare un memorandum per ribadire che l’eventuale accordo tra l’ente di Stato italiano e il governo iracheno avrebbe gravemente pregiudica-to non solo la posizione dell’Ipc nel paese, ma anche gli interessi dei governi francese, statunitense, inglese e olandese, collegati alle attività dell’Ipc, ripercuotendosi, poi, sulle altre intese petrolifere nel Medio Oriente. La positiva conclusione del negoziato in corso avrebbe signi-ficato – proseguiva il promemoria – che l’Eni, una società petrolifera pubblica italiana, era pronta a favorire, se non addirittura a istigare, la rottura unilaterale delle convenzioni petrolifere esistenti. Da parte britannica, quindi, si rinnovavano al governo di Roma le richieste di assicurazioni contro tale eventualità e di intervento immediato sulla
78 Su questo Pirani, Poteva andare peggio, cit., pp. 334-335.79 Scott a Gandolfi, New York, 28 aprile 1967, telegramma (copia sia in inglese, che tradotta in italiano), in ASE, FENI, Presidenza Raffaele Girotti, b. 94, f. 3521. Altre notizie sulle manovre condotte dall’Ipc per impedire la prosecuzione dei contatti italo-iracheni relativi allo sfruttamento dei campi del Nord Rumayla in: Briatico a Girotti, 26 maggio 1967, telegramma (copia) in ASE, FENI, Presidenza Raffaele Girotti, b. 94, f. 3521. 80 E. Ortona, Gli anni della Farnesina. Pagine del diario (1961-1967), SPAI, Mi-lano 1998, p. 169.
482
dirigenza dell’Eni, affinché non fosse rilasciata alcuna dichiarazio-ne o compiuto alcuno atto pregiudizievole dei diritti e degli interessi dell’Ipc.81 Il memorandum fu consegnato l’11 maggio del 1967 da Sir Evelyn Shuckburg a Egidio Ortona, segretario generale del ministero degli Affari Esteri, in presenza anche di Cesidio Guazzaroni, vicedi-rettore generale degli Affari Economici. Nel corso del colloquio, l’am-basciatore britannico affermò di avere ricevuto istruzioni di “tenore ancora più serio” rispetto a quanto apparisse nel documento, poiché a Londra si faceva esplicito riferimento a un “possibile riflesso” dell’inte-ra vicenda sugli amichevoli rapporti tra i due paesi.82
Il giorno successivo, Ortona fu il destinatario di un nuovo passo compiuto collettivamente da Sir Evelyn Shuckburg e dai suoi colleghi olandese, francese e statunitense, resisi a loro volta protagonisti nei giorni precedenti di démarches presso il ministero degli Affari Esteri.83 Fu l’ambasciatore britannico a prendere la parola e a parlare a nome degli altri rappresentanti, per ribadire, ancora una volta, critiche e proteste formali per l’operato dell’Eni:
L’Iraq è riserva della compagnie dell’IPC – affermò Sir Evelyn Shuckburg – in base alla legge del 1925. L’ENI sta compiendo un atto preoccupante per la politica dell’Europa alla vigilia di una de-cisione storica per l’economia europea quale l’ingresso della Gran Bretagna nel MEC. Si comincia con un atto politico sbagliato e giu-ridicamente (o eticamente) obbrobrioso proprio nei confronti della Gran Bretagna che prende tale decisione.
81 Il memorandum dell’ambasciatore britannico, Sir Evelyn Shuckburg, datato 11 maggio 1967, è allegato a: Ortona a Fanfani, Roma, 11 maggio 1967, “Appunto per l’On. Ministro”, in ACS, FAM, b. 65, f. 148.82 Ortona a Fanfani, cit., in ACS, FAM, b. 65, f. 148. Anche: Ortona, Gli anni della Farnesina, cit., pp. 173-174.83 Le notizie dei vari passi compiuti dagli ambasciatori francese, statunitense e olan-dese, si ricavano dalla minuta di un telegramma “segreto” indirizzato alle ambasciate italiane a Baghdad, Londra, Parigi, Washington e L’Aja da parte della Direzione Ge-nerale Affari Economici presso la Farnesina (e, quindi, con ogni probabilità redatta da Guazzaroni): Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale Affari Economici, Uff. III, alle ambasciate a Baghdad, Londra, Parigi, Washington e L’Aja, tel. “segreto” (minuta), senza data, in ACS, FAM, b. 65, f. 148; accenni anche in: Ortona, Gli anni della Farnesina, cit., pp. 169-174
483
Dati i rapporti amichevoli tra l’Italia e i paesi rappresentati dai quattro ambasciatori a colloquio con Ortona, e considerato il carat-tere di ente di Stato dell’Eni, Sir Evelyn Shuckburg e i suoi colleghi dichiararono senza esitazioni di attendersi un intervento del governo italiano per la sospensione dei negoziati, chiedendo di poterne parlare direttamente con Fanfani o, in sua assenza, con il presidente del Con-siglio, Moro.84
Questa sorta di offensiva diplomatica nei confronti dell’Eni e del governo italiano85 venne accompagnata da una campagna mediatica, cui prese parte anche l’autorevole Financial Times, il principale quoti-diano economico e finanziario del Regno Unito. Alla vicenda furono dedicati alcuni articoli pubblicati nella prima metà di maggio, con ogni probabilità ispirati da ambienti vicini sia al governo britannico, che alla British Petroleum, azionista della Ipc. I titoli degli articoli, dai toni particolarmente allarmistici, riferivano di uno “scontro” anglo-italiano per lo sfruttamento del greggio iracheno e di una “bufera politica” ab-battutasi sull’Italia per il negoziato tra l’Eni e il governo di Baghdad; all’interno degli articoli, poi, non solo veniva descritto con molta pre-cisione il confronto in atto tra l’Ipc e il gruppo energetico italiano per il petrolio iracheno, ma veniva anche data notizia, con abbondanza di particolari, dei passi compiuti dai quattro ambasciatori presso il gover-no di Roma per ostacolare le iniziative messe in campo dall’Eni.86
84 Briatico a Girotti, Roma 12 maggio 1967, appunto (copia), in ASE, FENI, Presi-denza Raffaele Girotti, b. 94, f. 3521 (una copia identica venne data in visione a Ma-rio Pirani ed è conservata in ASE, FENI, Relazioni Esterne, b. 133). Notizie anche in: Ortona, Gli anni della Farnesina, cit., pp. 173-174. Si noti che, nel diario di Ortona, le date e alcuni dettagli non coincidono perfettamente con quelli indicati nei documenti conservati presso l’Archivio dell’Eni: nella versione diaristica di Or-tona, i colloqui con gli ambasciatori sembrerebbero aver avuto luogo separatamente con ciascuno di essi tra l’11 e il 12 maggio (e non in un incontro unico e collettivo il 12 maggio). Inoltre, nel diario, il segretario generale degli Affari Esteri afferma di aver parlato della vicenda con Girotti, mentre dai documenti l’interlocutore dell’Eni risulterebbe Gandolfi.85 Notizie delle reazioni internazionali ai contatti tra l’Eni e il governo iracheno anche in: Nota di Humbaraci, al ritorno da Beirut, per Cefis, 22 agosto 1967, in ASE, FENI, Relazioni Esterne, b. 133.86 Si vedano, ad esempio: Anglo-Italian Clash Over Iraqi Oil Reserve Rights, “The
484
Il governo italiano e la dirigenza dell’Eni tentarono di coordina-re le proprie azioni in risposta ai passi compiuti dagli ambasciatori stranieri e dai vertici dell’Ipc, tenendo naturalmente conto dei diversi ambiti di competenza e delle diverse sfere di intervento. Fin dal pri-mo incontro tra Ortona e l’ambasciatore britannico, i responsabili dell’ente di Stato furono sollecitati dalla Farnesina a chiarire il quadro e i contenuti dei contatti in corso con le autorità irachene. Da parte dell’Eni, si precisò che il gruppo italiano non aveva alcuna intenzione di attuare iniziative pregiudizievoli dei “diritti validi” dell’Ipc; lo Sta-to iracheno, dopo aver riacquistato, in forza della legge 80 del 1961, la piena titolarità e la disponibilità delle aree precedentemente date in concessione all’Ipc, aveva deciso di procedere allo sfruttamento di al-cune di esse, particolarmente ricche di greggio; nell’ambito di tale po-litica, le autorità irachene intendevano affidare a una compagnia stra-niera l’incarico di effettuare, per conto del governo di Baghdad, tutti i lavori necessari alla messa in produzione dei nuovi campi petroliferi, con un meccanismo di rimborso che prevedeva la vendita del greggio estratto; l’Eni, dunque, era stata invitata ad esaminare la possibilità di prestare la propria opera e i propri servizi, come General Contractor; le conversazioni in corso, quindi, non erano finalizzate all’ottenimen-to di concessioni petrolifere, bensì alla sottoscrizione di un contratto di lavoro; un vero e proprio appalto che, in caso di mancata stipula con il gruppo italiano, sarebbe stato affidato alle compagnie sovieti-che o giapponesi, parimenti interessate e in grado di rispondere alle esigenze irachene.87 Questa fu, del resto, la posizione assunta anche pubblicamente dalla società petrolifera italiana, i cui vertici decisero
Financial Times”, 13 maggio 1967; Political Storm Over Italian Deal On Iraqi Oil, “The Financial Times”, 15 maggio 1967.87 Si confronti l’appunto conservato nell’archivio dell’Eni e datato 5 maggio 1967, con i documenti presenti tra le carte di Aldo Moro presso l’ACS: Appunto: Iraq, 5 maggio 1967, in ASE, FENI, Presidenza Raffaele Girotti, b. 94, f. 3521; Ortona a Fanfani, Roma, 11 maggio 1967, cit.; Ministero degli Affari Esteri, Direzione Gene-rale Affari Economici, Uff. III, alle ambasciate a Baghdad, Londra, Parigi, Washing-ton e L’Aja, cit.; Marchiori a Ortona, 11 maggio 1967, lettera con allegata la minuta della risposta alla nota britannica, dettata da Fanfani, in ACS, FAM, b. 65, f. 148. Anche: Ortona, Gli anni della Farnesina, cit., p. 170.
48
di non commentare in alcun modo le proteste diplomatiche, essendo ovviamente competenza del governo di Roma, limitandosi a replicare alle campagne mediatiche e alle richieste di chiarimenti da parte della stampa internazionale.88
Le versione dell’Eni fu fatta propria dal governo italiano. Le va-rie risposte date da Ortona agli ambasciatori britannico, francese, olandese e statunitense, tra l’11 e il 12 maggio del 1967, ricalcarono i chiarimenti forniti dai vertici dell’ente di Stato. Il segretario generale della Farnesina, infatti, fece presente che la compagnia italiana aveva accettato di impegnarsi nei negoziati in corso, accogliendo un invito rivoltole dalle autorità irachene, non per l’ottenimento di concessioni in esclusiva, ma solo per la stipula di un contratto di lavoro, che altri-menti sarebbe stato sottoscritto con altre società e compagnie, prime fra tutte quelle sovietiche; l’Eni – precisò Ortona – aveva valutato tutte le implicazioni legali della vicenda e agiva nella premessa che il diritto dello Stato iracheno desse titoli e disponibilità al governo di Baghdad; per i vertici del gruppo italiano, quindi, i rapporti tra le autorità irachene e l’Ipc, e le relative contestazioni, erano res in-ter alios acta. Il diplomatico italiano – su indicazione di Fanfani, che aveva usato gli stessi argomenti nel colloquio con l’ambasciatore bri-tannico del 3 maggio – ricordò che l’Eni, pur essendo una società a partecipazione statale, non agiva per conto e in nome del governo di Roma, bensì come una privata compagnia petrolifera; ne derivava che il tentativo della società italiana di “procurarsi lavoro e rifornimenti secondo le proprie norme istitutrici” non poteva essere considerato contrario all’amicizia del governo italiano con quelli di Londra e degli altri paesi interessati.89 Lo stesso Fanfani intervenne pubblicamente
88 Viscusi a Briatico e Pirani, New York, 16 maggio 1967, telex n. 2761/5; Pirani a Viscusi, Roma, 17 maggio 1967, telex s. n. (minuta); Viscusi a Briatico e Pirani, New York, 17 maggio 1967, telex. N. 2788; Pirani a Viscusi, Roma, 19 maggio 1967, telex s. n. (minuta), in ASE, FENI, Relazioni Esterne, b. 133.89 Ortona a Fanfani, Roma, 11 maggio 1967, cit.; Ministero degli Affari Esteri, Dire-zione Generale Affari Economici, Uff. III, alle ambasciate a Baghdad, Londra, Parigi, Washington e L’Aja, cit.; Marchiori a Ortona, 11 maggio 1967, lettera con allegata la minuta della risposta alla nota britannica, dettata da Fanfani, in ACS, FAM, b. 65, f. 148. Anche: Ortona, Gli anni della Farnesina, cit., p. 170.
48
per chiarire ulteriormente la posizione italiana, rilasciando alcune dichiarazioni al termine di un seminario organizzato dall’Istituto di Diritto Pubblico della Facoltà di Economia dell’Università di Roma, sul tema dell’organizzazione di una politica comune dell’energia nell’ambito della Comunità Economica Europea. Il responsabile del-la Farnesina sottolineò che, all’interno della Cee, vi erano alcuni paesi detentori di grandi riserve di gas naturale, che non intendevano con-dividere con altri partner europei, tanto che l’Italia era costretta ad approvvigionarsi altrove. L’Italia, quindi, secondo Fanfani, non pote-va essere certo rimproverata per l’eventuale acquisto di greggio in Iraq o in altre aree, perché non aveva la possibilità di far fronte al proprio fabbisogno energetico, se non ricorrendo a produttori disposti a pra-ticare condizioni migliori. Quanto alle obiezioni circa la proprietà del petrolio iracheno, il ministro degli Esteri ribadì che erano state date assicurazioni sulla titolarità dei giacimenti da parte delle autorità di Baghdad, pronte ad affrontare anche in tribunale questo aspetto del problema.90
Tuttavia, al di là della sostanziale concordanza tra le varie risposte fornite dai rappresentanti del governo di Roma e dai dirigenti dell’E-ni, all’interno della posizione italiana non vi era completa unanimità di vedute, né negli ambienti della Farnesina, né tra i vertici della diplo-mazia italiana e quelli dell’ente di Stato. Ortona sembrò non condi-videre del tutto la linea seguita da Fanfani, né tantomeno le iniziative del gruppo energetico italiano. Il segretario generale, sulle pagine del proprio diario, commentò con scetticismo il tentativo del ministro degli Esteri di “giocare sull’equivoco” derivante dall’autonomia deci-sionale e operativa dell’Eni; equivoco sfruttato da Fanfani nel collo-quio con l’ambasciatore britannico, a cui confessò di non sapere “in dettaglio” cosa stesse combinando l’Eni in Iraq, né di poter “molto influenzare” le attività della compagnia petrolifera italiana.91 In realtà – come riportato in precedenza92 – il responsabile della Farnesina era
90 Dichiarazioni dell’on. Fanfani sulla politica energetica, 19 maggio 1967, in ASE, FENI, Relazioni Esterne, b. 133.91 Ortona, Gli anni della Farnesina, cit., p. 169.92 Girotti a Fanfani, Roma, 24 marzo 1967, cit., in ASE, FENI, Presidenza Raffaele Girotti, b. 94, f. 3521.
487
perfettamente al corrente delle iniziative dell’ente di Stato, essendo stato aggiornato da Girotti e da Gandolfi in occasione della visita a Baghdad di fine marzo 1967; Fanfani, quindi, lungi dall’accogliere le richieste britanniche e degli altri paesi coinvolti nella vicenda, non solo non aveva alcuna intenzione di frenare le trattative in corso, ma al contrario, essendo più che mai favorevole alla collaborazione tra l’Eni e il governo iracheno, premeva affinché l’accordo si concludesse il prima possibile.93 Ortona, invece, – come confidò a Gandolfi il 12 maggio, informandolo dei passi ufficiali compiuti dagli ambasciatori britannico, olandese, francese e statunitense – era “veramente” preoc-cupato per le ripercussioni che l’intera vicenda avrebbe potuto avere in ambito europeo, proprio alla vigilia del vertice comunitario di Roma di fine maggio 1967, nel decennale della firma dei trattati istitutivi del Mercato Comune Europeo e dell’Euratom.94 Il processo d’inte-grazione europea attraversava da tempo una delle fasi maggiormente critiche, a causa del fallimento dei “piani Fouchet”, dei disaccordi re-lativi all’adesione della Gran Bretagna e della crisi della “sedia vuota”, che vide la Francia astenersi dal partecipare ai lavori comunitari; le difficoltà nel percorso di costruzione e rafforzamento delle istituzioni comunitarie erano tali e tante che i leader dei paesi membri della Cee non si riunivano dal vertice di Bonn del luglio 1961; data la delicatez-za del momento, era evidente che i lavori e i risultati della conferenza di Roma non potevano essere messi a repentaglio dalle polemiche e dai contrasti causati dalle questioni petrolifere irachene.
Il segretario generale – sempre nell’incontro con Gandolfi – am-mise di non vedere con favore una nuova missione dell’Eni a Bagh-dad per riprendere le trattative interrotte dalla crisi del governo Ta-lib d’inizio maggio; pur non essendo contrario in linea di principio alla partnership petrolifera con l’Iraq, Ortona non poteva esimersi dall’esporre le proprie preoccupazioni e i propri timori, che reputò opportuno comunicare anche all’ambasciatore italiano a Baghdad, in modo che si regolasse di conseguenza nella sua azione presso il nuovo
93 Ortona, Gli anni della Farnesina, cit., pp. 170 e 174.94 Briatico a Girotti, Roma 12 maggio 1967, cit., in ASE, FENI, Presidenza Raffaele Girotti, b. 94, f. 3521. Ortona, Gli anni della Farnesina, cit., p. 170.
488
governo iracheno.95 I vertici della diplomazia italiana, mossi dal timo-re di andare incontro a conseguenze sgradite in ambito comunitario e atlantico, tentarono fino all’ultimo di trovare un punto d’incontro tra la volontà dell’Eni di proseguire il negoziato in corso e le richieste di chiarimenti e assicurazioni dei governi di Londra, Parigi, L’Aja e Washington. Fu il vicedirettore degli Affari Economici alla Farnesina, Guazzaroni, a proporre di replicare ai vari passi diplomatici con un dichiarazione, in cui si garantisse che l’Eni era pronta a concludere un accordo con l’Iraq “a condizione che i diritti degli altri [fossero] tutelati”. Tuttavia, la dirigenza dell’ente di Stato, che nel corso dell’in-tera vicenda non si mostrò mai “eccessivamente” preoccupata per le proteste dell’Ipc, non accolse positivamente la soluzione di compro-messo proposta dalla Farnesina, dal momento che l’Eni si era limitata ad aderire all’invito delle autorità di Baghdad “di effettuare un lavo-ro per conto” dello Stato iracheno, senza essersi mai fatta parte attiva nel tentativo di ottenere concessioni o diritti esclusivi a danno di altri operatori.96
Nonostante le esitazioni degli ambienti diplomatici italiani, è noto che Gandolfi partì ugualmente alla volta di Baghdad nella seconda metà di maggio, per riannodare i fili della trattativa con il nuovo go-verno iracheno. È altrettanto noto che la crisi politica irachena, ali-mentata in parte anche dalle pressioni dell’Ipc sulle autorità di Bagh-dad, fece rallentare i negoziati, impedendo di fatto la conclusione dell’accordo.97 Il responsabile della Direzione Esteri dell’Eni si recò in Iraq almeno altre due volte nei mesi successivi, in giugno e settem-bre, senza riuscire a far compiere ai colloqui dei sostanziali passi in avanti, a causa di una situazione diventata sempre più complicata per la compagnia italiana, le cui proposte vennero sottoposte a numerose
95 Briatico a Girotti, Roma 12 maggio 1967, cit., in ASE, FENI, Presidenza Raffaele Girotti, b. 94, f. 3521; Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale Affari Econo-mici, Uff. III, alle ambasciate a Baghdad, Londra, Parigi, Washington e L’Aja, cit., in ACS, FAM, b. 65, f. 148. Anche: Ortona, Gli anni della Farnesina, cit., p. 174.96 Briatico a Girotti, Roma, 12 maggio 1967, cit., in ASE, FENI, Presidenza Raffaele Girotti, b. 94, f. 3521.97 Promemoria per Girotti, cit., in ASE, FENI, Presidenza Raffaele Girotti, b. 94, f. 3521.
489
critiche, tanto da imporre ai responsabili dell’Eni un ripensamento sull’intera operazione.98 È noto anche, infine, che, tra il novembre e il dicembre del 1967, l’ente di Stato italiano fu sopravanzato dalla fran-cese Erap nella sottoscrizione di un contratto di servizio per la produ-zione del petrolio iracheno e dal governo sovietico nella firma di un “accordo quadro”, per la fornitura di capitali, attrezzature e aiuti tecni-ci necessari allo sfruttamento di nuovi giacimenti, in cambio di forni-ture di greggio; intese che, però, escludevano la messa in produzione della zona di Rumayla, motivo di perdurante tensione internazionale.
In buona sostanza, quindi, fu l’Eni a fare le spese della crisi politica irachena del 1967. La compagnia italiana, infatti, rimase esclusa dalle intese raggiunte dal nuovo governo di Baghdad, stretto tra la neces-sità di evitare pericolose ritorsioni da parte dell’Ipc e la volontà di procedere lungo la via di una maggiore diversificazione delle società petrolifere operanti nel paese.99 Con ogni probabilità, nella secon-da metà del 1967, le autorità irachene ritennero opportuno operare una sorta di marcia indietro nei negoziati condotti fino ad allora con il gruppo italiano, con l’intento o di tenere fuori la questione dello sfruttamento dei distretti di Rumayla dall’eventuale accordo o di alza-re notevolmente le richieste economiche.100 Pur continuando a consi-derare l’ingresso dell’Eni nella realtà petrolifera nazionale un fattore importante, la dirigenza irachena non poteva certo accettare di pagare costi economici e politici tali da minacciare la propria permanenza al potere; in particolare, le reazioni internazionali ai contatti con il gruppo energetico italiano fecero comprendere alle autorità di Bagh-dad l’estrema gravità della crisi che ne sarebbe derivata. Gli strumenti
98 Viscusi a Girotti, New York, s.d. (ma 25 giugno 1967), telex (copia); Gandolfi a Pasetti, Baghdad, 30 settembre 1967, telex (copia), “letto al dr. Cefis, il 2/X/67”; Telegramma da Baghdad, 26 marzo 1968 (copia), in ASE, FENI, Presidenza Raffa-ele Girotti, b. 94, f. 3521; anche: Nota di Humbaraci, cit., in ASE, FENI, Relazioni Esterne, b. 133.99 Sulla cautela e sulla prudenza del nuovo governo iracheno, formatosi dopo la ca-duta di Talib e il ridimensionamento degli ufficiali filonasseriani, e guidato, prima, dal presidente Aref e, poi, dal generale Yahya, si veda: Tripp, Storia dell’Iraq, cit., pp. 248-249.100 Gandolfi a Girotti, 4 aprile 1968, appunto, in ASE, FENI, Presidenza Raffaele Girotti, b. 94, f. 3521.
490
di pressione nelle mani dell’Ipc erano di notevole portata, dato che la società controllata dalle multinazionali avrebbe potuto portare la pro-duzione alla soglia minima prevista dagli accordi in vigore o, nella mi-gliore delle ipotesi, rifiutarsi di aumentarla, con grave danno in ogni caso per l’erario statale; di fronte alle eventuali rappresaglie dell’Ipc per la messa in produzione dei giacimenti di Rumayla, l’Eni avreb-be dovuto farsi carico delle ingenti perdite economiche irachene e, conseguentemente, della sopravvivenza del regime iracheno: un com-pito evidentemente troppo oneroso, in termini finanziari e politici, per la compagnia italiana.101 Oltre alla battuta d’arresto dei negoziati in corso, ne derivò, probabilmente, un ripensamento complessivo da entrambe le parti: da una parte, le autorità di Baghdad si resero per-fettamente conto dell’impossibilità per l’Eni, così come per qualun-que altra società occidentale singolarmente presa, di poter reggere il confronto con le major azioniste dell’Ipc per quanto concerneva la questione dello sfruttamento dei campi di Rumayla; dall’altra parte, preso atto dell’accantonamento, i vertici del gruppo italiano ritennero che l’operazione non fosse più interessante e tanto meno conveniente, in relazione all’impegno richiesto.
Nei mesi e negli anni successivi, anche dopo i colpi di Stato del lu-glio 1968 che decretarono la fine del regime di Aref e la definitiva asce-sa al potere del partito Baath, i contatti tra l’Eni e le autorità irachene proseguirono, assumendo però contenuti e finalità differenti. Tra la fine del 1968 e i primi mesi del 1969, la compagnia italiana e l’Inoc la-vorarono a un nuovo contratto di servizio, per la ricerca e l’estrazione di idrocarburi, senza più far menzione dei giacimenti di Rumayla.102 Il documento, che ricalcava il testo dell’accordo sottoscritto dagli ira-
101 Si vedano alcune considerazioni in proposito in Colloquio con il Sig. Itaya, re-dattore del Middle East Economic Survey, 18 agosto 1967, appunto, in ASE, FENI, Presidenza Raffaele Girotti, b. 94, f. 3521.102 Egidi a Ratti, San Donato Milanese, 19 novembre 1968, lettera con allegata la relazione della missione presso l’Inoc di Sergio Cambi, inviato dell’Agip; Girotti a Sa’dun Hammadi, Presidente dell’Inoc, Roma, 11 dicembre 1968, lettera (co-pia); Hammadi a Girotti, Baghdad, 19 dicembre 1968, lettera; Girotti a Hammadi, Roma, 13 gennaio 1969, lettera (copia); in ASE, FENI, Presidenza Raffaele Girotti, b. 94, f. 3521.
491
cheni con l’Erap, prevedeva la firma di un’intesa per l’esplorazione e l’eventuale sfruttamento di alcune aree nel Sud del paese; la titolarità dei permessi di ricerca e la proprietà “a bocca di pozzo” del greggio rinvenuto sarebbero rimaste nelle mani dell’Inoc, che avrebbe affidato all’Agip la conduzione di tutte le operazioni petrolifere; la compagnia italiana, quindi, avrebbe assunto la veste di contrattista, anziché quel-la tradizionale del concessionario, nonché la veste di finanziatore e di acquirente di parte del greggio prodotto. In caso di rinvenimento di petrolio, il 50% delle riserve sarebbe stato accantonato come “riserva nazionale” ed escluso, quindi, dallo sfruttamento industriale; il rima-nente 50% sarebbe stato, invece, messo in produzione dall’Agip, che ne avrebbe acquistato una quota pari al 30% a un prezzo predetermi-nato in accordo con l’Inoc e non di mercato, e avrebbe assistito l’ente di Stato iracheno a vendere il restante 70%. La compagnia italiana, in caso di ritrovamento di un giacimento sfruttabile economicamente, avrebbe corrisposto all’Inoc dei bonus per un importo complessivo va-riabile, in funzione dei livelli di produzione, fino a un massimo di 20 milioni di dollari Usa. I vertici dell’Eni avevano previsto un volume di investimenti da effettuare nell’arco di quattro anni pari a 18 milioni di dollari, circa, a cui aggiungere un’ulteriore spesa di 5 milioni di dol-lari per le consulenze locali e l’acquisizione di dati e rapporti tecnici relativi a pozzi e rilievi geologici e geofisici.103
Tuttavia, anche in tale occasione, la compagnia italiana e le autori-tà irachene non riuscirono a concludere l’accordo e rendere operativa la collaborazione, che da anni – almeno a parole – entrambe le parti cercavano di avviare. L’intesa tra l’Eni e l’Inoc non venne raggiunta per il rifiuto iracheno di inserire nelle aree destinate ad essere esplorate dalla società italiana alcune zone ritenute particolarmente interessanti e promettenti per la produzione di greggio. Il presidente dell’Inoc, Hammadi, nei colloqui con i rappresentanti dell’Agip, Luigi Scarpa e Sergio Cambi, in missione a Baghdad nel febbraio e nel marzo del 1969, precisò che in Iraq i distretti nel Sud del paese scelti dai tecni-
103 Egidi a Grandi, San Donato Milanese, 7 gennaio 1969, promemoria; Cefis al Mi-nistero delle Partecipazioni Statali, Roma, 19 gennaio 1969, lettera n. 15/69 (copia); Nota tecnica: nuova iniziativa in Iraq, Roma 26 febbraio 1969, prot. n. 27/69, in ASE, FENI, Direzione Programmazione, b. 12.
492
ci italiani erano considerati alla stessa stregua della zona di Rumayla, con ricchezze di riserve e potenzialità di sfruttamento simili: un patri-monio nazionale importante la cui gestione non poteva essere affidata a società straniere; motivi politici, quindi, impedivano alla dirigenza dell’Inoc di accettare la richiesta dell’Agip, che però avrebbe potu-to optare per qualunque altra parte del territorio iracheno.104 Vista la mancanza di elementi tecnici tali da poter formulare proposte al-trettanto convenienti per altre aree e vista, quindi, la sostanziale man-canza di alternative parimenti interessanti per le strategie produttive dell’Eni, i vertici del gruppo italiano decisero di prendersi una nuova pausa di riflessione e di cloroformizzare per l’ennesima volta i contatti con la dirigenza irachena.105
La situazione di sostanziale stallo raggiunta nei rapporti tra l’Eni e l’Inoc spinse il presidente dell’ente nazionale iracheno a rivolgersi direttamente al governo italiano, offrendo un nuovo tipo di accordo: non più la sottoscrizione di un contratto di servizio, ma la stipula di un accordo barter per la vendita all’Italia di greggio prodotto dall’I-noc con contratti di lungo periodo, in cambio di beni e servizi italiani forniti dalle varie società del gruppo Eni e da altri gruppi industriali nazionali in grado di operare in territorio iracheno.106 In particolare, in caso di accordo, l’Iraq avrebbe affidato alla Snam (società controlla-ta dall’Eni) la costruzione di una raffineria a Bassora e di un oleodotto da Bassora ai terminali del Mediterraneo.107 La mossa di Hammadi, perfettamente in linea con le nuove strategie petrolifere e industriali del regime baathista, che avrebbero portato di lì a breve alla sottoscri-zione di numerosi accordi barter con i paesi del blocco sovietico, die-
104 Missione a Baghdad del 15/2/1969 e del 13/3/ 1969, Roma, 17 marzo 1969, re-lazione a firma Luigi Scarpa; Missione a Baghdad dal 13 al 16/3/1969, relazione a firma Luigi Scarpa, in ASE, FENI, Presidenza Raffaele Girotti, b. 94, f. 3521.105 Grandi a Bartolotta, Roma, 19 maggio 1969, lettera n. 1133, in ASE, FENI, Direzione Programmazione, b. 12.106 Hammadi a Massa Bernucci, Baghdad, 2 giugno 1969; lettera (copia), in ASE, FENI, Direzione Estera, b. 170, f. 15A6.107 Appunto: proposta irakena di accordo “barter” con l’Italia, a cura della Direzione Generale Affari Economici (Uff. III), del Ministero degli Affari Esteri, Roma, 17 giugno 1969, in ASE, FENI, Direzione Estera, b. 170, f. 15A6.
493
de origine a nuova fase di contatti tra l’Eni e l’ente di Stato iracheno. Su sollecitazione del presidente dell’Inoc, che nel novembre del 1969 inviò a Girotti una bozza di accordo su cui poter lavorare per giungere a un’intesa,108 i rappresentanti dei due enti nazionali si incontrarono nuovamente tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio del 1970 a Roma. In tale occasione, la distanza tra le due posizioni risultò an-cora incolmabile. La proposta irachena di fornire greggio in cambio di beni, servizi e assistenza tecnica, in realtà, non apparve particolar-mente conveniente agli occhi della dirigenza dell’Eni; la compagnia italiana – precisarono i rappresentanti del gruppo – aveva sviluppato proprie fonti di approvvigionamento, raggiungendo l’autosufficienza, e pertanto non aveva interesse ad accettare contropartite in greggio. L’Eni, invece, era ancora molto interessata a operare nel campo della ricerca e della produzione di idrocarburi, e a sviluppare una qualche forma di partecipazione allo sviluppo delle risorse petrolifere irache-ne, essendo in grado di assicurare sbocchi non solo sul mercato italia-no, ma anche su molti mercati stranieri.109
Gli incontri dei mesi successivi servirono a chiarire definitivamente l’impossibilità di una collaborazione mineraria tra i due enti, a causa soprattutto del sostanziale veto posto dagli iracheni sulle zone scelte dai tecnici italiani e delle differenze di valutazione sulle aree alterna-tive a quelle indicate dall’Eni; venuto meno il progetto di partnership per l’esplorazione e lo sfruttamento in comune di nuovi giacimenti di greggio iracheni, rimase in piedi solo l’idea dell’assistenza tecnica per la realizzazione di impianti e infrastrutture in cambio di fornitu-re petrolifere.110 La compagnia italiana, alla fine del 1970, ritornò sui
108 Hammadi a Girotti, Baghdad, 11 novembre 1969, lettera (copia), con allegata bozza di accordo per la cooperazione tra l’Inoc e l’Eni, in ASE, FENI, Presidenza Raffaele Girotti, b. 94, f. 3521.109 Resoconti dei colloqui del 29 gennaio e del 3 febbraio 1970 tra i rappresentanti dell’INOC e quelli dell’ENI, Roma, 30 gennaio e 9 febbraio 1970 in ASE, FENI, Direzione Estera, b. 170, f. 15A6.110 Dall’Aglio all’ENI (Servizio Sviluppo Industriale e Commerciale all’Estero), Beirut, 28 aprile 1970, lettera “riservata” n. 1272, in ASE, FENI, Direzione Estera, b. 172, f. 15EA; Missione in Iraq, appunto di Antonio M. Selem, Roma 10 settem-bre 1970; Hammadi a Ratti, Baghdad, 10 novembre 1970, lettera (copia); Prome-moria di Dall’Aglio, Roma 20 novembre 1970, in ASE, FENI, Direzione Estera, b.
494
propri passi e accettò di avviare dei negoziati per la conclusione di ac-cordi barter, nonostante il netto rifiuto posto fino ad allora alle richie-ste irachene in tal senso; la decisione dell’Eni fu la conseguenza della flessione della produzione petrolifera nel Mediterraneo, determinata dalle tensioni italo-libiche per la decisione del regime di Gheddafi di espellere gli italiani residenti in Libia e di confiscarne le proprietà; av-venimenti che fecero aumentare l’interesse dell’Eni nell’acquisto del greggio iracheno disponibile nei porti del Mediterraneo.111 Tuttavia, anche in questo caso, le trattative si protrassero per molto tempo, con-cludendosi solo all’inizio del 1972. L’ultimo ostacolo da superare nel-la collaborazione italo-irachena riguardava l’origine del petrolio che l’Inoc avrebbe fornito all’Eni: l’ente di Stato iracheno, infatti, offriva greggio proveniente non dai quantitativi messi a disposizione dall’Ipc come pagamento delle royalties dovute per le concessioni, ma dalla riserva nazionale, compresi i giacimenti di Rumayla, la cui produzio-ne – grazie alla cooperazione tecnica e finanziaria sovietica – sarebbe andata a regime a partire dal 1972; il nodo centrale dell’intera que-stione, dunque, rimaneva ancora la contestazione sollevata dall’Ipc sulla titolarità dei pozzi di Rumayla, con il corollario di pressioni e fri-zioni che sarebbero derivate dall’acquisto di greggio estratto da quei giacimenti tanto contesi. Pur risultando del tutto evidente l’interesse dell’Eni e dell’Italia in generale ad acquistare greggio direttamente da un paese produttore senza più l’intermediazione delle multinazionali, la linea seguita dalla compagnia italiana, anche su suggerimento degli ambienti di governo, fu quella di proseguire con cautela e prudenza nei negoziati con la controparte irachena, in attesa che il quadro poli-tico e giuridico relativo al petrolio estratto a Rumayla fosse chiarito.112
170, f. 15A6.111 Iraq: relazioni con la INOC, 23 novembre 1970, appunto; Ratti a Hammadi, 30 novembre 1970, lettera (copia); Relazione sulla missione a Baghdad del 3-7 dicembre 1970, a cura di Dall’Aglio, Roma 9 dicembre 1970, in ASE, FENI, Direzione Estera, b. 170, f. 15A6.112 Guazzaroni all’ENI, Roma, 14 marzo 1971, fonogramma n. 073/140 (copia); Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale Affari Economici (Uff. III) all’ENI, Roma, 29 aprile 1971, telespresso n. 073/8641 “urgentissimo per motocliclista” (copia), con allegato: Resoconto di riunione interministeriale sugli scambi commer-
49
Il chiarimento atteso dall’Eni e dal governo italiano arrivò nel corso del 1972, con la commercializzazione dei primi quantitativi di greggio prodotto a Rumayla e venduto a numerosi paesi, non solo dell’Est europeo, ma anche non allineati come India e Sri Lanka;113 l’esportazione di tale petrolio rese evidenti l’inconsistenza e l’inef-ficacia del veto posto dall’Ipc, data l’impossibilità di intercettare le petroliere sovietiche impiegate nel trasporto o di distinguere l’origine del greggio dopo la raffinazione.114 Ancora più importante fu il chia-rimento determinato dalla nazionalizzazione delle attività petrolifere dell’Ipc: la decisione del governo di Baghdad, preceduta dalla costru-zione di una rete di relazioni e collaborazioni, strette soprattutto con i paesi del blocco sovietico, rimosse ogni possibile ostacolo alla gestio-ne in totale autonomia del settore petrolifero, depotenziando i possi-bili strumenti di ritorsione nelle mani delle multinazionali consociate nella Ipc.115 Parallelamente a tali avvenimenti, giunse quindi a positiva conclusione anche l’ultimo round negoziale tra l’Eni e l’Inoc:116 fu così che il 10 marzo 1972 venne firmato a Roma un accordo quadro, seguito poi da un memorandum d’intesa e da un protocollo aggiun-tivo, sottoscritti a Baghdad rispettivamente il 20 dicembre 1972 e il 4 febbraio 1973. L’accordo generale prevedeva che, a fronte dell’ac-quisto a un prezzo competitivo sul piano internazionale di 20 milioni di tonnellate di greggio iracheno in un periodo di 10 anni, venissero forniti all’Iraq, in contropartita, beni e servizi da parte delle società
ciali italo-iracheni, in ASE, FENI, Direzione Estera, b. 170, f. 15A6; 113 Massa Bernucci al Ministero degli Affari Esteri, Baghdad, 8 febbraio 1972, tele-spresso n. 196 (copia); Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale Affari Eco-nomici (Uff. III) all’ENI, Roma, 10 aprile 1972, telespresso n. 77 in ASE, FENI, Direzione Estera, b. 168, f. 15A8.114 Massa Bernucci al Ministero degli Affari Esteri, Baghdad, 24 aprile 1972, tele-spresso n. 613 (copia), in ASE, FENI, Direzione Estera, b. 168, f. 15A8115 Massa Bernucci al Ministero degli Affari Esteri, Baghdad, 13 dicembre 1971, te-lespresso n. 1817 (copia), in ASE, FENI, Direzione Estera, b. 168, f. 15A4. Anche: Saul, Masterly Inactivity as Brinkmanship, cit., pp. 791-792.116 Riunione a Baghdad dal 10 al 12 gennaio 1972 per la discussione di un accordo quadro, appunto a cura di Ugo Barbera, Roma 19 gennaio 1972; Riunione con l’am-basciatore dell’Iraq a Roma, 18 febbraio 1972, appunto s.a. del 21 febbraio 1972, in ASE, FENI, Direzione Estera, b. 172, f. 15EA.
49
del gruppo Eni e di altre società coordinate dalla compagnia italia-na. Il memorandum d’intesa e il protocollo aggiuntivo definirono il prezzo di cessione del petrolio iracheno e le modalità di pagamento della prima fornitura di 2 milioni di tonnellate prevista per il 1973: veniva stabilito che il 30% del valore del greggio sarebbe stato pagato cash dall’Agip all’Inoc, mentre il restante 70% sarebbe stato versato su un conto speciale aperto presso la Banca Centrale dell’Iraq, per es-sere destinato al pagamento delle forniture italiane all’Iraq previste dall’accordo.117
L’interesse iracheno alla conclusione dell’accordo con l’Eni, cer-cato a lungo nel corso degli anni Sessanta, era evidente: l’obiettivo dei vari regimi succedutisi al potere a Baghdad in quegli anni era co-stantemente diretto al raggiungimento dell’indipendenza economica e politica, attraverso la diversificazione più ampia possibile degli ope-ratori internazionali attivi nel principale settore produttivo del paese, quello petrolifero: conseguentemente, le autorità irachene avevano stretto accordi e intese di vario tipo (contratti di servizio e barter) con l’Unione Sovietica e le democrazie popolari, per poter controbilan-ciare e ridimensionare la pluridecennale presenza delle multinaziona-li occidentali consociate nell’Ipc; sempre in quest’ottica, per evitare un’eccessiva dipendenza dalla partnership sovietica ed est-europea e non passare semplicemente dal controllo economico anglo-america-no a quello russo, i dirigenti iracheni erano più che mai interessati ad ampliare il numero delle collaborazioni internazionali, coinvolgendo anche altre società indipendenti ed enti di Stato, come la francese Erap prima e l’Eni poi, la cui importanza, soprattutto in ottica euro-pea e mediterranea, non sfuggiva certo ai responsabili della politica petrolifera irachena.
Altrettanto evidente era l’interesse dell’Eni e dell’Italia in genera-le, come paese consumatore di petrolio, nel sottoscrivere un accordo che avrebbe dato la possibilità alla compagnia italiana di acquistare
117 I testi degli accordi, del memorandum d’intesa e del protocollo aggiuntivo, con-clusi tra l’Eni e l’Inoc, si trovano in ASE, FENI, Estero – Coordinamento regioni estere, b. 114, f. 5. Per un’analisi del loro contenuto all’interno dell’Eni, si veda Iraq. Accordo con l’ENI per la fornitura di greggio, appunto del 7 maggio 1973, in ASE, FENI, Direzione Estera, b. 170, f. 15A6.
497
greggio direttamente dal paese produttore a un prezzo più vantaggio-so di quello praticato fino ad allora dalle major straniere, detentrici dell’oligopolio nel settore petrolifero iracheno; evidente era anche l’interesse a riequilibrare la bilancia dei pagamenti tra i due paesi, so-stituendo i flussi finanziari in uscita verso l’Iraq con forniture di beni e servizi, funzionali anche a un’eventuale penetrazione economica nel paese mediorientale. Tuttavia, è bene ricordare che nel corso del tempo, a partire dai primi contatti degli anni Sessanta, gli obiettivi e la portata della strategia dell’Eni in Iraq si erano andati progressiva-mente ridimensionando e limitando: dal tentativo di accaparrarsi lo sfruttamento in esclusiva di alcuni dei giacimenti ritenuti più ricchi e importanti dell’intero Medio Oriente, come quelli della zona di Ru-mayla, il gruppo energetico fu costretto dalle pressioni internaziona-li, dagli inviti alla cautela degli ambienti di governo italiano e anche dalle crescenti difficoltà economiche del paese, ad accontentarsi di sottoscrivere, non senza difficoltà, uno dei tanti accordi barter con-clusi dall’Iraq in quegli anni, dopo che intese simili erano già state firmate non solo dai paesi del blocco sovietico, ma anche dall’India, dallo Sri Lanka e dalla Spagna. Era chiaro che l’Eni di fine anni Ses-santa e inizio anni Settanta, guidata da Cefis e Girotti, non era più la compagnia nazionale emergente di un paese in piena e rapida crescita economica; ma un gruppo industriale impegnato soprattutto a con-solidare la propria presenza nel settore energetico mondiale, costretto a confrontarsi con criticità sempre maggiori di vario tipo e su diversi fronti, all’interno del paese, così come in ambito internazionale (na-zionalizzazioni delle produzioni di greggio e gas in Medio Oriente e Nord Africa, radicalizzazione del conflitto arabo-israeliano, rialzo progressivo e costante del prezzo del petrolio, tensioni italo-libiche); un gruppo intento a riconsiderare e rivedere le strategie espansive, non sempre proficue e vantaggiose, attuate negli anni di Mattei, non essendo più intenzionato a esporsi oltre il necessario, politicamente e finanziariamente, nella ricerca di nuove opportunità; un gruppo, infine, che rispecchiava il difficile momento del paese, minato al suo interno da una crisi economica e sociale così profonda, da indebolirne gravemente l’azione politica.