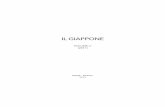Cantare la santità negli anni di Sisto V (1585-1590)
Transcript of Cantare la santità negli anni di Sisto V (1585-1590)
sanctorum, 6, 2009
Stefano Patuzzi
Cantare la santità negli anni di Sisto V (1585-1590)*
Un’ulteriore conferma dell’importanza cruciale del pontificato di Felice Peretti per le dinamiche di canonizzazione e venerazione dei santi andò per me delineandosi nel corso delle fasi preparatorie del mio studio sulle Sacre lodi a diversi santi, un libro di madrigali spirituali di Giovanni Giacomo Gastoldi edito a Venezia da Ricciardo Amadino nel 1587.1 Lungi dal voler proporre una panoramica della produzione madrigalistica spirituale durante il pontificato di Sisto V – che oltretutto si legge nella seconda appendice all’importante lavoro di Katherine Powers2 – intendo invece ribadire alcuni aspetti legati all’idea stessa di venerazione dei santi che ebbi modo di trattare in quella monografia e avan-zare qualche ulteriore considerazione circa le strategie “controriformistiche” attuate nel periodo specificato: tutto ciò attraverso la straordinaria lente delle Sacre lodi, appunto, che per la loro singolarità e il loro ventaglio di significati,
* Questo saggio attinge a materiale originariamente esposto nell’intervento dal titolo Santi e musici: il papato di Sisto V (1585-1590) da me presentato al Convegno Internazionale di Studi «Pietosi affetti: il madrigale spirituale nell’Italia del Cinquecento», organizzato dall’As-sociazione “Il Saggiatore musicale” e svoltosi a Venezia presso la Fondazione Cini nei giorni 30-31 ottobre 2000, i cui atti sono in preparazione per i tipi di Olschki a cura di Paolo Cecchi. Ringrazio Simon Ditchfield per i numerosi consigli.
1. Cfr. S. Patuzzi, Madrigali in basilica. Le Sacre lodi a diversi santi (1587) di G.G. Ga-stoldi: un emblema controriformistico, Firenze 1999. Al medesimo lavoro gastoldiano – già trattato in specie nel principale studio “mantovano” di Iain Fenlon (Music and patronage in sixteenth-century Mantua, II, Cambridge, London, New York 1982), il quale propose anche la trascrizione del madrigale A Santa Barbara – Isabella Grisanti dedicò un intervento in occasio-ne del Terzo Convegno Annuale della Società Italiana di Musicologia (20-22 settembre 1996), apparso poi a stampa successivamente alla pubblicazione del mio volume ora citato (I. Grisanti, Musica, poesia e pittura nella basilica di Santa Barbara in Mantova: le “Sacre lodi a diversi santi” di G. G. Gastoldi. Primi risultati di una ricerca, in «Rivista Internazionale di Musica Sacra», 20/2 [1999], pp. 243-253).
2. Si veda K.S. Powers, The Spiritual Madrigal in Counter-Reformation Italy: Definition, Use, and Style, PhD dissertation, University of California – Santa Barbara 1997, pp. 520-558.
Il tema: Plasmare il suono48
i quali rimandano a vari aspetti della sfera religiosa dell’epoca, si impongono come un manifesto difficilmente eguagliabile per esemplarità e ampiezza.3
Balza immediatamente all’occhio che il breve papato di Peretti coincise, cronologicamente, con la seconda metà del decennio più prolifico delle storie parallele del genere madrigalistico tout court e del sottogenere spirituale. Fu-rono gli anni, per non citare che gli esempi più notevoli, in cui videro la luce i Madrigali spirituali a tre voci di Lelio Bertani e Costanzo Antegnati, i tre libri di madrigali spirituali di Felice Anerio (il Secondo e il Terzo sono perduti),4 Le lagrime del peccatore di Ludovico Agostini – dedicate al duca di Mantova Guglielmo Gonzaga –, la riedizione delle fortunatissime Vergini a tre voci di Matteo Asola, il Secondo e il Terzo libro de madrigali spirituali a sei voci di Philippe de Monte. Fra i libri collettivi spicca la Musica spirituale composta da diversi eccellentissimi musici a cinque voci, edita nel 1586, e riecheggiante nel titolo quella pietra angolare del genere che fu la Musica spirituale appron-tata per le stampe da Giovanni del Bene e pubblicata nel 1563.
Si tratta di un dato di certo non casuale e stimolante, se non altro per le potenzialità intrinsecamente propagandistiche che il madrigale spirituale cer-tamente possedeva. Infatti, se con “disciplinamento” si è definito «lo sforzo e la capacità di ottenere comportamenti programmati e uniformi, anche a livello di antropologia dei comportamenti quotidiani, mediante l’uso della religione istituzionale»5 il madrigale spirituale, perdipiù così declinato, va allora letto an-che come un efficace mezzo di disciplinamento. Un disciplinamento che, se interpretato come diffusione delle posizioni di Sisto V, ebbe a che fare sia con la volontà di azzerare, per quanto possibile, le spinte centrifughe rispetto a Roma, sia con l’antiprotestantesimo sistematico che caratterizzarono tutta l’attività pubblica del francescano Peretti, tanto prima della sua ascesa al soglio nei ran-ghi dell’Inquisizione, quanto – dopo il 1585 – nel suo ruolo di pontefice.
Le relazioni di varia natura con Sisto V andavano inoltre indagate proprio alla luce del legame diretto che univa l’intera struttura della basilica di Santa Barbara (per cui le Sacre lodi, lo vedremo, furono concepite) alla figura del Sommo Pontefice: costituita come abbazia, e culmine di una secolare proget-
3. “Controriforma” è termine avversato da certa storiografia, e talora non senza ragione. Il suo uso, qui, insieme a quello dei suoi derivati, intende solamente circoscrivere la sfera di influenza papale e sottolineare un carattere oppositivo – o anche emulativo, ma e contrario – che il corso degli eventi di quel tempo lascia scorgere di quando in quando. Per la questione terminologica rimando a J. O’Malley, Trent and all that. Renaming Catholicism in the Early Modern Era, Cambridge (Mass.), London 2000.
4. Cfr. Powers, The Spiritual Madrigal, p. 78.5. O. Niccoli, La vita religiosa nell’Italia moderna, Roma 1998, p. 136.
Patuzzi, Cantare la santità negli anni di Sisto V 49
sanctorum, 6, 2009
tualità gonzaghesca intesa a plasmare il tessuto urbano e la geografia del sa-cro di Mantova,6 la basilica palatina godeva di particolari privilegi: Breviario, Messale, repertorio di canto piano propri.7 Da ultimo, le Sacre lodi illustrano, forse meglio di ogni altro lavoro commissionato, i decenni di intensa politica culturale del periodo di regno di Guglielmo Gonzaga, duca di Mantova dal 1550 al 1587 e attentissimo ai molteplici aspetti della sfera religiosa.
Queste le ragioni che spiegano la precedenza che viene accordata qui ai testi poetici e ai loro contenuti. Se altre rilevanti informazioni possono di cer-to provenire dall’osservazione analitica delle musiche, per indagare l’azione riassunta nel titolo è necessario accostarsi al contesto articolato a cui Gastoldi intendeva riferirsi attraverso i testi cantati: testi che rimandano a ben precise coordinate culturali che costituivano una griglia di precondizioni interpreta-tive per l’ascoltatore – cólto, vista la tendenziale esclusività della cappella ducale di Santa Barbara – cui le Sacre lodi erano principalmente rivolte. I loro tratti peculiari consentono da un lato di affermare il legame saldissimo che unisce i testi poetici dei madrigali, i luoghi precisi in cui essi dovevano essere eseguiti (perlomeno idealmente) e alcune linee conciliari promosse da Sisto V; dall’altro di considerare le Sacre lodi forse l’emblema più rappresentativo nella sfera del madrigale spirituale di alcune tendenze proprie della Controri-forma durante il papato di Sisto V.
Già il titolo, Sacre lodi a diversi santi, fornisce qualche indicazione dire-zionale. Sia che la scelta vada attribuita al duca, sia che vada ascritta a Gastoldi (o ad altri), il fatto di aver voluto, come talvolta usava, un titolo che non con-tenesse la dicitura “madrigali spirituali” (una dicitura che come è stato notato assolveva all’altezza degli anni Ottanta anche a precise funzioni di marketing,
6. Mi sia consentito rinviare al saggio di Danilo Zardin e Stefano Patuzzi, in preparazione, che apparirà nel volume secondo della Storia della cultura mantovana promossa dalla Fonda-zione Banca Agricola Mantovana, Tre Lune Edizioni.
7. Cfr. I. Fenlon, Music and Patronage in Sixteenth-Century Mantua, Cambridge 1980 e 1982, passim, e Id., Patronage, Music, and Liturgy in Renaissance Mantua, in Plainsong in the age of polyphony, a cura di Th. Kelly, Cambridge-New York 1992, pp. 209-235; P. Besutti, Un tardivo repertorio di canto piano, in Tradizione manoscritta e pratica musicale. I codici di Puglia, Atti del Convegno di studi (Bari, 30-31 ottobre 1986), a cura di D. Fabris, A. Susca, Firenze 1990, pp. 87-97; Ead., Testi e melodie per la liturgia della Cappella di Santa Barbara in Mantova, in Trasmissione e recezione delle forme di cultura musicale, Atti del XIV congresso della Società Internazionale di Musicologia (Bologna, 27 agosto-1° settembre, Ferrara-Parma, 30 agosto 1987), II (Study Sessions), a cura di A. Pompilio, D. Restani, L. Bianconi, F. Alberto Gallo, Torino 1990, pp. 68-77; Ead., Catalogo tematico delle monodie liturgiche della Basilica Palatina di S. Barbara in Mantova. I canti dell’Ordinario, in «Le Fonti musicali in Italia», 2 (1988), pp. 53-66.
Il tema: Plasmare il suono50
e che del resto compare in calce ad alcune pagine dei libri-parte delle Sacre lodi) esprime l’intento di sottolineare fin da principio l’aspetto celebrativo nei confronti della santità.
La successione dei madrigali all’interno del libro conferma poi l’esisten-za di un progetto articolato: si leggono, nell’ordine, i brani A DIO, Alla Croce, Alla Beata Vergine, A Santa Barbara, A S. Gio. Battista, A S. Pietro, A Santo Silvestro, A Santo Adriano, A Santa Maria Maddalena, A Santa Margherita, A tutti i Santi – cioè Anime sante e belle, un componimento di Torquato Tas-so8 – e infine la Canzone a S. Francesco, posta in musica nei nove madrigali conclusivi.
Trattando prima il secondo blocco di madrigali, si evince come i brani sulle stanze e sul congedo della Canzone a S. Francesco costituiscano un pri-mo, chiaro segnale di omaggio ossequioso nei confronti del pontefice regnan-te. Non solo è il caso di rammentare che Peretti proveniva dall’ordine dei frati minori conventuali, ma anche di notare che oltre a promuovere alacremente la diffusione della figura e delle gesta di Francesco d’Assisi – in specie attra-verso le incisioni e i dipinti – egli nutriva a quanto è dato a sapere anche una speciale devozione privata, personale nei confronti del santo; una devozione testimoniata ad esempio dagli Avvisi di Roma del fondo Urbinate Latino 1053, nei quali si rammenta come il pontefice, per coincidenza proprio all’altezza dell’agosto 1587, fosse solito «da un pezzo in qua farsi leggere ogni Venerdì le regole et ordini et vita di san Francesco».9 D’altro canto la devozione al Poverello costituisce una cifra essenziale della Controriforma, seppur con toni e sfumature assai differenti rispetto alla tradizionale venerazione tributata al santo nel corso dei secoli precedenti.10 Difficilmente sopravvalutabile, poi, è il ruolo centrale che l’ordine francescano svolse nella predicazione delle indul-genze, una sorta di filo rosso che conferisce ulteriore compattezza alle Sacre lodi, come vedremo, e invita a considerare sotto questa ottica i brani collocati nella sezione iniziale.11
8. Cfr. T. Tasso, Opere, a cura di B. Maier, II, Milano 1964, p. 380 e A. Vassalli, Il Tasso in musica e la trasmissione dei testi: alcuni esempi, in Tasso, la musica, i musicisti, a cura di M.A. Balsano, T. Walker, Firenze 1988, pp. 45-90: 83, 85.
9. J.A.F. Orbaan, La Roma di Sisto V negli “Avvisi”, in «Archivio della R. Società romana di storia patria», XXXIII (1910), pp. 277-312: 300.
10. Cfr. P. Askew, The Angelic Consolation of St. Francis of Assisi in Post-Tridentine Italian Painting, in «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», XXXII (1969), pp. 280-306: 280-282.
11. Rinvio alla voce «Osservanza, congregazioni di Osservanza», in Dizionario degli Isti-tuti di Perfezione, vol. VI, coll. 1048-1054.
Patuzzi, Cantare la santità negli anni di Sisto V 51
sanctorum, 6, 2009
Questi, lo si legge nella lettera dedicatoria rivolta al duca Guglielmo, fu-rono «composti in loda, & honore di quelle sante reliquie, le quali con tanta singolar riverenza, con tanto nobil culto, & pretiosi ornamenti ella fa custo-dire nella sua Chiesa di Santa Barbara». Tanto dal committente quanto dal presbitero Gastoldi l’accento è risolutamente posto sulle reliquie, uno degli argomenti che dal 1517 in avanti contribuirono a dividere la Cristianità, e a cui Calvino, per non citare che l’esempio forse più significativo fra i molti possibili, dedicò negli anni Quaranta il suo pungente Petit traité sur la recher-che des reliques qu’on croit partout fort utile à la Chrétienté.12 Nonostante i grandi sforzi prodotti dalla Chiesa di Roma lungo tutto il Cinquecento per incanalare nell’alveo dell’ortodossia una devozione sbilanciata – in quanto rivolta più agli oggetti che alla memoria dei santi di cui avrebbero dovuto essere testimonianza tangibile – la propensione per questa particolare forma di idolatria continuò a configurarsi come una costante di quella cultura e di quell’epoca. Affermativa e provocatoria appare quindi la decisione di rimar-care, sia nella dedicatoria sia nella struttura del libro, orientamenti così mani-festamente antiprotestanti. Si considerino allora l’ordine dei brani da quello rivolto a s. Barbara in avanti (A Santa Barbara, A S. Gio. Battista, A S. Pietro, A Santo Silvestro, A Santo Adriano, A Santa Maria Maddalena, A Santa Mar-gherita) e la disposizione degli altari (ognuno dei quali ospitava, in posizione ben visibile, alcune reliquie del santo dedicatario) all’interno della basilica, come nello schema sotto riportato.
12. Cfr. J. Calvin, Traité des reliques, a cura di I. Backus, Ginevra 2000.
S. BARBARAiiiiiii
S. Maddalena S. Margheritaii
S. Adriano S. Silvestroii
S. Giovanni Battista S. Pietroii
Il tema: Plasmare il suono52
È evidente come la successione dei madrigali scandisca un netto tracciato processionale interno che, muovendo dall’altar “maggiore” dedicato alla santa eponima, conduce attraverso un percorso a forma di ampia “S” dall’altare del Battista fino a quello di S. Margherita.
Corona il percorso argomentativo che ho brevemente riassunto un interes-sante documento finora solo parzialmente valorizzato.13 Si tratta del SOMMA-RIO DELL’INDULGENZE / concesse da diversi Sommi Pontefici alla Chiesa di San. / ta BArBArA di MAntovA, attualmente conservato presso l’Archivio di Stato di Mantova.14 Il foglio a stampa, nella cui parte superiore campeggia l’immagine solita di s. Barbara che impugna con la mano destra la palma del martirio e con la sinistra regge la torre raffigurante il luogo di prigionia, ri-porta dettagliatamente le indulgenze concesse da Pio IV (1559-1565), Pio V (1566-1572), Gregorio XIII (1572-1585) e Clemente VIII (1592-1605); spic-ca l’assenza di Sisto V. Questa la trascrizione integrale.15
PAPA Pio quarto concede a quelli, che saranno presenti alle solenni benedittioni delle dignità veramente pentiti, & confessi, o che haveranno fermo proposito di confessarsi a’ tempi ordinati cent’anni d’indulgenza.A quelli, che visitaranno l’Altare di Santa Croce ogni Mercordì cent’anni, & cento qua-rantene.A quelli, che visitaranno li sette Altari in ciascheduna delle quattro Domeniche dell’Ad-vento l’istesse indulgenze, come se visitassero in tal giorno le sette Chiese di Roma.A chi contrito, & confesso sarà presente al Matutino le feste di Santa Barbara, della Nativi-tà, & Resurrettione di Nostro Signore, o celebrarà in dette tre feste plenaria indulgenza.Gregorio XIII. confermando una bolla di Pio V. & ampliandola, concede all’Abbate d’es-sa Chiesa, & in sua assenza alle dignità successivamente di poter assolvere con indulgen-za plenissima in articolo di morte tutti quelli, che sono sottoposti alla sua giuriditione, & hanno recitato le preci con l’orationi la feria 2. 4. e 6. a S. A. & quelli che servono S. A. S. anco laici, che recitano l’offitio di S. Barbara, & possano l’Abbate, & in sua assenza le dignità successivamente dar auttorità a gli inferiori d’assolverli.La santità di Clemente ottavo concede indulgenza plenaria tutte le feste della Madonna, & degli Apostoli a’ confessi, & contriti, che recitaranno una Corona avanti la Croce donata da S. Santità all’A. S. che si pone su l’Altar maggiore in dette feste, & cominciarà la vigi-lia d’esse Feste, & durarà per tutto il giorno seguente.
Oltre al resto si legge che un’indulgenza concessa da Pio IV consentiva di lucrare cent’anni e cento quarantene a chi avesse visitato «li sette Altari
13. Ne ho dato notizia in Madrigali in basilica, p. 21.14. Mantova, Archivio di Stato (sigla RISM), Archivio Gonzaga, busta 3300 bis.15. Sono stati conservati i segni di interpunzione, le maiuscole, le singole grafie così come
appaiono nell’originale; si sono invece adeguati all’uso moderno gli accenti, si è distinta u da v, si è esplicitata la grafia talora sottintesa dalla presenza del titulus sopra alcune vocali.
Patuzzi, Cantare la santità negli anni di Sisto V 53
sanctorum, 6, 2009
[verosimilmente S. Giovanni Battista, S. Pietro, S. Silvestro, S. Adriano, S. Maria Maddalena, S. Margherita e S. Barbara] in ciascheduna delle quattro Domeniche dell’Advento […], come se visitassero in tal giorno le sette Chiese di Roma», cioè San Pietro, San Giovanni, San Paolo, Santa Maria Maggiore, San Lorenzo, San Sebastiano, Santa Croce in Gerusalemme. Una devozione fra l’altro, quella tributata alle sette chiese, espressamente riaffermata da papa Sisto V con la bolla Egregia populi Romani pietas del 13 febbraio 1586.16 Questo documento riporta alla memoria la cruciale predicazione dell’indul-genza per la Fabbrica di San Pietro del 1516 affidata al domenicano Johann Tetzel, la quale prevedeva la remissione completa dei peccati qualora si fosse versato un obolo e, appunto, si fossero visitate almeno sette chiese. Riconsi-derando l’indulgenza barbarina viene pertanto da chiedersi quale sia il grado di relazione esistente fra l’indulgenza concessa da Pio IV – sul cui sfondo torreggia il quantomai evocativo “7” – la processione interna abitualmente effettuata in Santa Barbara nelle domeniche d’Avvento e i madrigali spirituali pertinenti presenti nella raccolta gastoldiana.17
Non abbiamo la certezza, allo stato attuale delle ricerche, di una o più esecuzioni della prima parte delle Sacre lodi all’interno dello spazio basilicale: quello che importa, a ogni modo, è che questi brani furono ideati e composti precisamente per una simile esecuzione, e precisamente davanti ai singoli altari. Ciò risulta lampante anche solamente dalla lettura di alcuni dei testi musicati. Si scorra ad esempio il madrigale A S. Gio. Battista, il cui testo esprime senza ambiguità la vicinanza dei cantori all’altare e alla reliquia esposta, un braccio, la cui presenza è attestata d’altro canto da tutti gli inventari di resti sacri con-servati nella basilica palatina: «Ecco per gratia intatto a noi serbato / Quel Braccio, più d’ogni thesor pregiato […]». Oppure la descrizione del capo di
16. «Il pellegrino cristiano a Roma in epoca moderna privilegiava le 7 chiese tra gli obiet-tivi della visita, per motivi storici e per motivi culturali. A queste chiese e basiliche principali […] erano collegate le specifiche indulgenze che i pellegrini potevano guadagnare visitandole. In esse erano custoditi i più ricchi tesori di reliquie e corpi santi dei martiri cristiani che attira-vano monaci e pellegrini provenienti da tutto il mondo. Presso di loro, avevano luogo alcune tra le più importanti stazioni liturgiche che scandivano topograficamente i periodi religiosamente salienti della Quaresima e dell’Avvento»; A. Di Nola, Percorsi reali e percorsi simbolici nelle guide di Roma tra XVI e XIX secolo, in Luoghi sacri e spazi della santità, a cura di S. Boesch Gajano.e L. Scaraffia, Torino 1990, p. 484. Rinvio poi a G. Severano, Memorie sacre delle sette chiese di Roma, Roma 1630 e S. de Blaauw, Immagini di liturgia: Sisto V, la tradizione liturgica dei papi e le antiche basiliche di Roma, in «Römisches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana», 33 (1999/2000), pp. 259-302.
17. Rammentata fra l’altro anche in Powers, The Spiritual Madrigal, p. 190.
Il tema: Plasmare il suono54
s. Adriano: «Di gemme e d’oro d’Adriano adorno / Il sacro capo in ricco altar risplende»; o ancora il braccio di santa Maria Maddalena: «De la già peccatrice Maddalena / […] In aureo avolto, in ricco adorno velo, / È questo, è ’l braccio sì possente e forte / Che ’l serpe antico ha vinto, ha vinta morte […]».
Aggiungo poi che oltre alla venerazione delle reliquie conservate presso i sette altari maggiori – e gli assai probabili legami con la citata processione interna alla basilica connessa a una speciale indulgenza – affiora dai testi po-etici musicati anche la volontà di sottolineare sia l’esemplarità delle vicende ritratte nelle tele sovrastanti gli altari, sia l’opportunità di tributare a queste e ai soggetti dipinti l’opportuna venerazione. La ballata piccola su cui è ordito il brano a s. Barbara, ad esempio, costituisce una rifinita ekphrasis della maesto-sa ancona sovrastante il coro absidale – opera del pittore veronese Domenico Riccio, detto il Brusasorci – nella quale è ritratto l’istante precedente il mar-tirio della santa. Rilevo oltre al resto anche un possibile riferimento testuale («nel sommo choro»)18 alla pregevole “Gloria d’angeli” originaria, ora conser-vata presso il Museo Diocesano “Francesco Gonzaga” di Mantova; sostituita nel corso del XVIII secolo con un lunettone di Pietro Fabbri «dall’Oboè»,19 essa raffigura schiere angeliche, e mostra alcuni angeli musicanti. Non meno esplicito è del resto, nel madrigale A Santo Silvestro, il riferimento iniziale alla pala, opera di Lorenzo Costa il Giovane, relativa al battesimo di Costantino: «A Te, Silvestro Santo, / Mentre nel fonte sacro / Porgi salubre a Constantin lavacro, / Volgo le rime, e ’l canto».
Argomenti – la venerazione di reliquie e immagini – d’attualità e dibat-tuti, come si rammenta; basti citare, fra gli atti estremi del Concilio tridenti-no, il decreto De invocatione, veneratione et reliquiis sanctorum, et de sacris imaginibus, con cui si ribadì appunto la liceità della venerazione dei sacri resti e delle immagini, sia pur specificando che quest’ultima andava indirizzata esclusivamente ad prototypa, dunque ai modelli cristiani che in esse erano effigiati:
[...] ita ut affirmantes, sanctorum reliquiis venerationem atque honorem non deberi, vel eas aliaque sacra monumenta a fidelibus inutiliter honorari, atque eorum opis impetrandae
18. «[…] ond’hor nel sommo choro / Sei di gioia perpetua coronata / Sovra le stelle, e sei nostra avvocata» (A Santa Barbara, vv. 9-11).
19. Cfr. M.G. Grassi, Pietro Fabbri, detto «dall’Oboe», pittore «foresto»: la prima fase documentata della sua attività mantovana (1716-1730), in «Atti e Memorie dell’Accademia Nazionale Virgiliana», n.s., LXIV (1996), pp. 223-267; Ead., Pietro Fabbri, detto «dall’Oboe», pittore «foresto»: la seconda fase della sua attività mantovana (1730-1746), in «Atti e Memo-rie dell’Accademia Nazionale Virgiliana», n.s., LXVI (1998), pp. 109-172.
Patuzzi, Cantare la santità negli anni di Sisto V 55
sanctorum, 6, 2009
causa sanctorum memorias frustra frequentari: omnino damnandos esse, prout iampridem eos damnavit et nunc etiam damnat ecclesia. Omnis porro superstitio in sanctorum invo-catione, reliquiarum veneratione et imaginum sacro usu tollatur, omnis turpis quaestus eliminetur, omnis denique lascivia vitetur […].20
Si affollano alla memoria, a questo riguardo, i numerosi casi di indulgen-ze legate alla recita di specificate preghiere (cito a campione Ave sanctissima Maria, Salve santa facies, O Domine Jesu Christe) di fronte a immagini preci-sate, frequenti nei libri d’ore e altrove, e l’evidente parallelismo – se non altro devozionale e, per così dire, tecnico – con l’atto dato dalla pronuncia cantata delle Sacre lodi al cospetto di appropriate immagini sacre.21 Un processo che, oltre a coinvolgere il senso dell’udito, mirava a stimolare in modo assai diretto anche quello visivo; e ciò contribuiva ad accrescere il grado di comparteci-pazione alla vicenda storicamente remota del santo, ingenerando una pietas ancor più tangibile e religiosamente edificante.
Le Sacre lodi – un’apologia madrigalistica della santità – costituiscono pertanto un’esplicita dichiarazione di ortodossia e di allineamento ai dettami correnti della Chiesa di Roma. Aggiungo en passant che, considerati i non sempre distesi rapporti occorsi durante il principato di Guglielmo fra lo Stato gonzaghesco da un lato, l’Inquisizione e la Sede pontificia dall’altro, esse ri-velano possibilmente anche la manifestazione di una volontà di adeguamento e testimoniano di una sottomissione figurale del ducato mantovano alla Santa Sede, pur mediante riferimenti continui a molteplici aspetti della singolarità difficilmente emulabile propria della basilica di Santa Barbara.22
Per rievocare in modo ancor più rifinito il più generale contesto religioso entro cui le Sacre lodi furono concepite e date ai torchi mette conto ricordare che dal 1523 al 1587 non si ebbe una sola canonizzazione. Anche per sotto-lineare la liceità e l’autorevolezza dell’esistenza di una schiera selezionata di
20. Lo si legge in Conciliorum Oecumenicorum Decreta, a cura di G. Alberigo et al., Bologna 19912, pp. 774-776. E si vedano anche C. Borromeo, Instructionum fabricae, et supel-lectilis ecclesiasticae, Milano 1577 e R.V. Schofield, “Tu es diaboli ianua”. Carlo Borromeo, misoginia e architettura, in Lo spazio e il culto. Relazioni tra edificio ecclesiale e uso liturgico dal XV al XVI secolo, a cura di J. Stabenow, Venezia 2006, pp. 281-351.
21. Rinvio a B. Blackburn, For whom do the singers sing?, in «Early Music», XXV/4 (November 1997), pp. 593-609.
22. Caso simile è dato dalla basilica di San Lorenzo a El Escorial: cfr. I. Fenlon, Giaches de Wert and the Palatine Basilica of Santa Barbara: Music, Liturgy, and Design, in Music and Culture in Late Renaissance Italy, Oxford 2002, pp. 180-204. Per una breve guida all’Inqui-sizione cfr. G. Romeo, L’Inquisizione nell’Italia moderna, Roma-Bari 2002 e ora A. Del Col, L’Inquisizione in Italia dal XIV al XX secolo, Milano 2006, pp. 221-506.
Il tema: Plasmare il suono56
modelli cristiani esemplari da venerare, la Chiesa romana attuò una strategia di somma cautela e di attesa, astenendosi dall’intraprendere qualsiasi processo di canonizzazione per un lasso di tempo di sessantacinque anni. Le Sacre lodi videro la luce sul limitare estremo (seppure probabilmente inconsapevole) di tale lungo periodo di stasi, e appaiono dunque da questo punto di vista la ra-tifica di un imponente status quo. La situazione sarebbe stata sbloccata solo nel luglio dell’anno successivo, il 1588, quando Sisto V diede inizio a una nuova stagione di santi con la canonizzazione, insistentemente sollecitata dal re cattolico Filippo II23 e debitamente evidenziata nelle fonti d’epoca, del mis-sionario francescano spagnolo Diego di Alcalá.24
23. Cfr. G. Sabatelli, Diego di Alcalá, in Bibliotheca sanctorum, IV, col. 607.24. Cfr. M. Gotor, Chiesa e santità nell’Italia moderna, Roma-Bari 2004, pp. 30-78 e A.
Benvenuti et al., Storia della santità nel cristianesimo occidentale, Roma 2005, pp. 285-297. Cfr. S. Ditchfield, Tridentine Worship and the Cult of Saints, in Cambridge History of Christi-anity, VI, a cura di R. Po-Chia Hsia, Cambridge 2007, pp. 201-224, 640-643.
Patuzzi, Cantare la santità negli anni di Sisto V 57
sanctorum, 6, 2009
Descrizione della fonte e dedica
SACRE LODI / A DIVERSI SANTI / CON UNA CANZONE / Al Glorioso Se-rafico S. Francesco. / DI GIO: GIACOMO GASTOLDI DA / Caravaggio, Novamente poste in luce. / [fregio] / A CINQUE VOCI. / [marca tipografica di Amadino] / IN VENETIA, MDLXXXVII. / Appresso Ricciardo Amadino.
L’unico esemplare superstite, completo dei cinque fascicoli in ottavo di Canto, Quinto, Alto, Tenore, Basso, è conservato a Danzica presso la Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk (PL-GD).
Sul verso del frontespizio si legge:
AL SERENISSIMO SIGNORE / MIO SIGNORE E PADRONE COLENDISSI-MO, / IL SIGNOR DUCA DI MANTOA / E di Monferrato.
La natura Serenissimo Signore, ha inestato in tutte le cose quasi un certo de-siderio di riunirsi al lor principio: onde e ’l fiume doppo l’essersi per molto spacio serpeggiando aggirato per valli, e per campagne; alla fine si riposa nel mare, dal quale esso trahe l’origine: e i rami de gli alberi vediamo, che ripiegandosi in sé medesimi, continuamente van rimirando la radice, la quale porge loro & l’essere, & la vita. Qual maraviglia poi, se uscendo questi miei Madrigali alla luce, non sanno inviarsi altro-ve, che alla Serenissima A. V. come a quella dalla quale riconoscono l’origine loro? Sì perché quanto io ho giamai apparato di Musica, tutto l’ho apparato sotto l’ombra sua felicissima: sì ancora, perché quando impiegai la penna al comporre la presente armonia, lo fei bramoso di far cosa, ch’a lei tornasse in grado, la quale si compiacque di accennarmi (ma i suoi cenni mi furono come saran sempre, strettissimi comanda-menti) ch’io dovessi attendere a spirituali componimenti, Per non dire che essendo questi Madrigali composti in loda, & honore di quelle sante reliquie, le quali con tanta singolar riverenza, con tanto nobil culto, & pretiosi ornamenti ella fa custodire nella sua Chiesa di Santa Barbara; io non doveva, io non poteva consacrarli ad altro nome, che a quello di V. A. Serenissima. Et che poi; s’io volessi soggiungere, che & a cacciatori i cani, & a soldati le spade si donano convenevolmente? onde io non ope-rava conforme alla ragione, se havessi procacciato appoggio a questa mia Musica di Prencipe immusico. e tra Prencipi Musici. qual si ritrova miglior intenditore dell’arte di lei? Ma questo mare lascerò solcar ad altri: & io raccogliendo la vela supplicherò V.
Appendice documentaria
Il tema: Plasmare il suono58
A. Serenissima ad aggradire se non il dono come di poco momento, almen la volontà del donatore: & a lasciarmi entrare con la mia debil barchetta nell’ampio porto della sua bona gratia. Baciandole fra tanto humilissimamente la mano, & pregandole da Dio la presente, & futura salute.
Di V. A. SerenissimaHumilissimo servitore,
Gio. Giacomo Gastoldi.
Conclude ciascun fascicolo una
TAVOLA DELLI MADRIGALI
Sommo SignorSalve de’ peccatoriVergine bellaPalme corone, e fregi (sic)Ecco che qual AuroraHor che risuonaA te Silvestro SantoDi gemme e d’oroDe la già peccatrice MadalenaRicco del ciel thesoroAnime sante e belle
Canzone a S. FrancescoSacrati horroriFaticosi sentieri (sic)Prendi le piaghe sueO tu prode AnnibalPorti ben tuVive vinseDi te rimbomba il gridoMa tu ch’a gran ragionMente che mai non posa
Criteri editoriali
- Si è distinta u da v;- le diverse forme della lettera s presenti negli originali sono state ridotte all’unica
oggidì utilizzata;- si è conservata la congiunzione arcaizzante et. Il lettore avvertito sa che all’epoca
essa veniva pronunziata e, o, se seguìta da vocale (eventualmente preceduta da h) e in assenza di sinalefe, ed; la nota tironiana & è stata coerentemente sciolta in e o ed. Le abbreviazioni sono state sistematicamente sciolte, senza ulteriore segna-lazione. Si è conservata la -t- in posizione intermedia anche qualora il suono cor-rispondente sia l’affricata dentale sorda. Si è mantenuta l’h, anche qualora figuri nelle voci del verbo avere. Tutto ciò al fine di preservare quanto più possibile il significativo insieme di valori grafici presente nella veste originaria;
- apici e accenti sono stati trattati in conformità agli usi ortografici attuali;
Patuzzi, Cantare la santità negli anni di Sisto V 59
sanctorum, 6, 2009
- le vocali non presenti nelle stampe originali a causa di elisioni sono state ripristi-nate, ove ritenuto opportuno, in carattere corsivo.
- si sono conservate sia le maiuscole presenti a inizio verso, sia quelle con funzio-ne “segnaletica” che figurano all’interno dei versi, come suggerisce certa prassi ecdotica corrente relativa ai testi del periodo che qui importa.
- la punteggiatura è negli originali inesistente, eccezion fatta per il punto fermo conclusivo. Essa è stata apposta tenendo in debito conto sia le consuetudini in-terpuntive del tardo Cinquecento, sia opportune esigenze di chiarezza. Altri segni che qui compaiono – parentesi, trattini, e quant’altro – sono da attribuire all’in-tervento dell’editore.
- per esplicitare l’architettura metrica di alcuni versi si è apposta la dieresi sopra determinate vocali che in essi appaiono, qualora l’assetto del verso lo richieda.
Testi poetici
A DIOSommo Signor, Tu che de l’universoIl giusto impero tieni, e reggi il cielo,Ben veggio che d’amor ardente zeloIn questa mortal spoglia
5 T’avolse per alzar l’humana voglia,Che languida giacea preda a l’errore,Per sottrarne di morte al cieco horrore.
Alla CroceSalve, de’ peccatori unica speme,Sacrato legno, Croce trïonfale:Ben sovr’i cieli ’l preggio tuo ne sale. I’ t’inchino, t’adoro, e sacro ’l core,
5 E qui mirand’affisso il mio SignorePiango ’l mio fallo, e mercé spero, e grido: – Miserere di me, ch’in te confido! –.
Alla Beata VergineVergine bella, d’humiltà soggiorno,Al Re del cielo Madre, e figlia, e sposa,Per te sia la mia vita ogn’hor gioiosa;Prega il tuo caro figlio
5 Che ver’ me volga di pietade il ciglio,In quest’ondoso Mar fida mia stella, Porto tranquillo in horrida procella.
Il tema: Plasmare il suono60
A Santa BarbaraPalme, Corone, e freggiNon di perle contesti, gemme, et oro,
T’ornaro già la fronte,Barbara santa, all’hor che sovr’il monte
5 Combatendo per ChristoPorgesti il collo ignudo Al crudo ferro, al padre assai più crudo;Ma ben co ’l sangue il glorïoso acquistoDel ciel facesti: ond’hor nel sommo choro
10 Sei di gioia perpetua coronataSovra le stelle, e sei nostra avvocata.
A S. Gio. BattistaEcco che qual Aurora il Sol precedeGiovanni il precursore,Di cui non fu, né nacque unqua il maggiore;Ecco per gratia intatto a noi serbato
5 Quel Braccio, più d’ogni thesor pregiato:Questi sostegno sia del viver frale,Ch’al tempo, a morte, a Pluto ei pur prevale.
A S. PietroHor che risuona a l’harmonia del canto,Ad honor suo fumand’incensi e fuochi,Di Pietro il nome santo,Di Pietro che del ciel n’apre, ne serra
5 Le porte, e i Mostri dell’inferno afferra,Benché indegni preghiam ne scorga al cielo, Sciolti dal mortal velo.
A Santo SilvestroA Te, Silvestro Santo,Mentre nel fonte sacroPorgi salubre a Constantin lavacro, Volgo le rime, e ’l canto.
5 Quel che del mio Signor opra contempio
Patuzzi, Cantare la santità negli anni di Sisto V 61
sanctorum, 6, 2009
Serbarsi intatta in sacro santo tempioPregoti che dal ciel gratia m’impetri,Che da l’error m’aretri;E mentre il cor del suo fallir si pente
10 Sian di lagrime gl’occhi ampio torrente.
A Santo AdrianoDi gemme e d’oro d’Adriano adornoIl sacro capo in ricco altar risplende,E l’alma in vago, in bel desir s’accende.Noi dunque a tutte l’hore
5 Rendiam al Santo riverente honore,Mentre egli assunto a la superna sedePer noi prega, per noi sempre intercede.
A Santa Maria MaddalenaDe la già peccatrice Maddalena,Hor glorïosa collocata in cielo,In aureo avolto, in ricco adorno velo,È questo, è ’l braccio sì possente e forte
5 Che ’l serpe antico ha vinto, ha vinta morte;E noi speramo ogn’hor vita e salute,Virtù di quel che diede a te virtute.
A Santa MargheritaRicco del ciel thesoro,Unica pretïosa Margherita:S’il tuo bel nome honoro,S’il merto amiro, e tua virtù infinita
5 Di giustitia e clemenza, al Real ThronoDeh piacciati impetrar per me perdono.
A tutti i SantiAnime sante e belle, Che da gli affan<n>i humani e da’ martiriVolaste a più sublimi ed alti giri,Gradite i nostri preghi;
5 Su l’ali de la fede e de la speme,E pur co’ vostri insieme,
Il tema: Plasmare il suono62
La giustitia supernaHormai fuor di suo corso a noi si pieghi,Peccatori, e no ’l celo.
10 Voi colonne del cielo,Anzi i Cieli voi sète,Alme felici e liete, Che narrate di Dio la Gloria eterna.
Canzone a S. Francesco Sacrati horrori, ove la folta chiomaDe l’aspro monte antico verno imbianca,Che da la parte mancaL’Arno rimira, e dopo sé nasconde
5 L’altero fiume ch’apre il seno a Roma,Irrigator de le latine sponde:Qui valli ime e profonde,Qui vedi impenetrabili caverne,Rotte pietre e sospese
10 Produr gelide e nude arbori eccelse.L’inospito paese,Per habitar con Dio, Sant’huomo scelse:O pie memorie eterneChe gli cederon poi le pietre stesse,
15 E ’l suo Signore in lui se stesso impresse!
Faticosi sentier, spelunche oscure(Ché Dio si scopre ove si cela il sole),Erta e sassosa mole,Rupi e rüine, ahi! che stupori havete:
20 Ecco, in mezzo le nevi, alme sicureArder, e benedir zelanti e liete.Qui strade erme e secretePremon quei Sacri piè poveri e scalzi;Scalzi, e tanto pregiati
25 Ché in essi si degnâr l’eterne piante Stampar segni beati De le lor piaghe redentrici e sante.Così, fedel, t’inalziChe ti trasformi al fin col proprio oggetto:
30 Man con man, piè con piè, petto con petto.
Prendi le piaghe sue, felici doglieChé pietà le bramò, pietà le diede;
Patuzzi, Cantare la santità negli anni di Sisto V 63
sanctorum, 6, 2009
Sanguinosa mercedeChiedesti orando a feritor clemente,
35 Et egli per temprar l’accese voglieT’aperse il petto, e ti beò la mente,Alma che duol non sente,Se non quel duol che ’l suo dolor sia pocoA l’infinito merto
40 Ch’acquistò in terra il creator del Cielo.Ma del costato apertoRicevé più mercé, scoprì più zelo:Ahi zelo, ahi vivo focoSpirto di ferma fede hor godi, ed hora
45 L’amor che ti ferì mira ed adora.
O tu, prode Annibal, che qui d’intornoSol col tuo nome impalidir facesti:Superbo, hor che direstiCh’un huom cinto di fune, inerme, imbelle,
50 Di te resti più chiaro, e più del giorno, E co ’l lacero piè calchi le stelle?Veder voti e facelleA’ suoi vil panni, e di color di terra;I dator di corone
55 In humil maestà chinarsi a’ piedi;Torrenti di personeTal’hor vedresti qui; ma nulla vedi, Fabro e foco di guerra: Reggono gli altri i tuoi rapiti imperi.
60 Ma tu dove hora sei, che puoi, che speri?
Porti ben tu fatal forza di Marte,Ma il santo cor viva virtù d’amore:Ei pace, e tu rigore, Ardir, odii, e rapine al mondo insegni,
65 O d’inquetar altrui mirabil arte.Feroce vincitor d’honor indegni,Hor va, pigliati i regniChe ’l tuo fero valor vinse e travolse,Ché quei ch’andò mendico
70 D’un ampio Regno è possessor felice.E tu di te nemicoPoco dal tuo furor sperar ti lice:Morte il tuo ben ti tolse,
Il tema: Plasmare il suono64
Et ei, che non curò cosa mortale,75 Hebbe vita al morir, morte al natale.
Vive, vinse, ed amò gl’emuli e i vinti,Mansüeto guerrier d’arme di luce;E tu, campion e duce, Ben festi un tempo inenarrabil prove:
80 Ma son gli ardori de’ tuoi sdegni estinti,Tronchi l’opere tue stupende e nove.Questi, che non si move,Fisso pensier d’un’incavata pietra,Di là da i Monti e ’l Mare
85 Vince genti straniere, anime ignote,Prede dilette e care,In servitù beate, in Dio divote;Et hor prega ed impetraE vede il Mondo, e ’l ciel c’hora l’inchina,
90 Povero habitator di grotta alpina.
Di te rimbomba il grido, e tu no ’l senti,Morto al piacer dell’immortal tuo nome,Honor rapido, o comeLa credula speranza alletti e chiame;
95 E di quanto desii tanto ti penti,Ché ’l cibo d’una voglia a l’altra è fame.Ché tante avide brame,Ché tanto affaticar speme traditaSe di nostra natura
100 Velocissimo è ’l corso, incerto il campoChe ci lusinga e fura?Un abisso è il voler, la vita un lampo:E se manca la vita Che ti giova la fama, e che i conforti?
105 La gloria è viva a i vivi, e morta a i morti.
Ma tu, ch’a gran ragion fuggisti il mondo,Vedi che di là su si scerne a pena.O di patria serenaHumil di Dio dispregiator d’honori,
110 Ch’uscendo di camin cieco e profondoIl ciel t’aperse in fronte almi splendori:Tu pungi i nostri coriCon gli amati tuoi guai stanco e ferito,
Patuzzi, Cantare la santità negli anni di Sisto V 65
sanctorum, 6, 2009
Plachi l’onde al desio115 De l’altrui vita a la tua vita acerba;
Ferma ed affina in DioLa speme fuor di Dio vile e superba,Et a me, forsi ardito,Perdona, e sien queste palpebre intanto
120 Labra de gli occhi, e le parole il pianto.
Mente, che mai non posa,Come ne i suoi desir cresce, e sormonta;E che farà, dogliosa,S’ogni contento human cade e tramonta?
125 Stolta, peni e vacilli.Del bramar, de l’haver t’angi e contristi:Poco vuoi, molto perdi, e nulla acquisti.