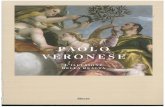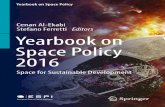Dall’esempio alla santità. Stefano di Thiers e Stefano di Obazine: modelli di vita o fondatori di...
Transcript of Dall’esempio alla santità. Stefano di Thiers e Stefano di Obazine: modelli di vita o fondatori di...
Gert Melville, Markus Schürer (Hg.)
Das Eigene und das Ganze Zum Individuellen
im mittelalterlichen Religiosenturn
LIT
Der vorliegende Band wurde mit Mitteln des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft gedruckt.
Gedruckt auf alterungsbeständigem Werkdruckpapier entsprechend
ANSI Z3948 DIN ISO 9706
Die Deutsche Bibliothek- CIP-Einheitsaufnahme
Das Eigene und das Ganze : Zum Individuellen im mittelalterlichen Religiosenturn I Gert Melville, Markus Schürer (Hg.).- Münster : LIT, 2002
(Vita regularis ; 16) ISBN 3-8258-6163-5
© LIT VERLAG Münster- Harnburg- London
GrevenerStr.179 48159Münster Tei.0251-235091 Fax0251-231972 e-Mail: lit@ lit-verlag.de http://www.lit-verlag.de
INHALT
Vorwort
GERTMELVILLE
Einleitende Aspekte zur Aporie von Eigenem und Ganzem im mittelalterlichen Religiosenturn
GRUNDLAGENREFLEXIONEN
ALOIS HAHN I CORNELIA BOHN
Partizipative Identität, Selbstexklusion und Mönchtum
ANNETIE KEHNEL
Gnadenlehre oder Reproduktionserfolg. Alte und neue, historische und biowissenschaftliche Geschichten zum Thema Individualität
SUSAN R. KRAMER I CAROLINE W. BYNUM
Revisiting the Twelfth-Century Individual. The Inner Self and the Christian Community
DER EINZELNE UND GOTT
FRANZ NEISKE
"Bei deinem Namen habe ich dich gerufen". Individuum und Seelenheil in der frühmittelalterlichen Klostergemeinschaft
PIROSI<I\ NAGY
lndividualite et !armes monastiques. Une experience de soi ou de Dieu?
J ENN IFER A. l-L\RRIS
Peter Damian and the Architecture of the Self
IX
XI
3
27
57
89
107
131
VI Inhalt
•, ' ~ .. "l•:
'.r
STEPHAN MüLLER
Der tufel sach sin jamer an. Die schmerzliche Selbsterkenntnis eines Teufels in der Episode 'Aurons Pfennig' im mittelhochdeutschen 'Wartburgkrieg'
PERSÖNLICHKEIT, MODELL, TYP
CRISTINA ANDENNA
Dall'esempio alla santita. Stefano di Thiers e Stefano di Obazine: modelli di vita o fondatori di ordini?
ACJ--IIM WESJOHANN
Individualitätsbewußtsein in frühen franziskanischen Quellen? Eine Suche nach Indizien
MARlA PlA ALBERZONI
Unus novellus pazzus in mundo. Individualita e affermazione del carisma
RAMONA SICKERT
Difficile tamen est iudicare alieni cordis occu/ta ... Persönlichkeit oder Typus?- Elias von Cortona im Urteil seiner Zeitgenossen
NL\RKUS SCHÜRER
Die Findung des Heiligen. Dominikus von Guzman und Petrus Martyr als Figuren zwischen Topik und Singularität
SELBST, IDENTITÄT, GEMEINSCHAFT
JEr\N-PIEIU\.E MAI-JE
Monachisme et personnalite dans l'Armenie medievale (Vc-XJIIc siecles)
GUIDO CARIBONI
Lber discede. La liberta di lasciare il noviziato: un aspetto della fortuna della Regula Benedil'li
BRUCE BR,\SINGTON
Avoiding the 'Tyranny of a Construct'. Structural Considerations Concerning Twelfth Century Canon Law
159
177
225
269
303
339
381
393
419
Inhalt
BRIAN PA TRICK MCGUIRE
Aelred's Attachments. Individual Growth in Community Life
ANNE MÜLLER
Singuläre Rollenspiele am Rande der Welt. Anmerkungen zur Mission des Franziskaners Johannes von Montecorvino in China
JöRG OBERSTE
Gesellschaft und Individuum in der Seelsorge der Mendikanten. Die Predigten Humberts de Romanis (t 1277) an städtische Oberschichten
DAS INDIVIDUELLE UND DAS INSTITUTIONELLE
SEBASTIEN BARRET
L'individu en action. Quelques reflexions autour des coutumes et statuts clunisiens (Xlc-XJIIc siecles)
P ETER VON MOOS
Abaelard, Heloise und ihr Paraklet: ein Kloster nach Maß. Zugleich eine Streitschrift gegen die ewige Wiederkehr hermeneutischer Naivität
H ELMUTFELD
Mittelalterliche Klosterfrauen im Spannungsfeld von Kommunität und religiöser Individualität
REINHARDT BUTZ
Gemeinschaftliche Individualität versus institutionelle Einbindung. Die Auseinandersetzungen der Nonnen im Heilig-Kreuz-Kloster bei Meißen mit dem zuständigen Diözesan, dem Papsttum und dem Zisterzienserkloster Altzelle bei Nossen
Personenregister
VII
439
467
497
531
563
621
651
669
-
DALL'ESEMPIO ALLA SANTITA
Stefano di Thiers e Stefano di Obazine: modelli di vita o fondatori di ordini?
CRISTINA ANDENNA
Nel 1190 Gerardo Ithier, compilando una raccolta di miracoli compiuci da Stefano di Thiers, il De reve/atione beati Stephani, scriveva: Inte/legan/ igitur e/ percipiant increduli et embescant infideles, quia Deus beatum Stephanum mirificavit e/ minficando laudabile reddidit nec voluit occultare diutius sanctitatem ipsius qui velut gemma laiebat in s/erquilinio oblivionis1• Piu altre il setcimo priore di Grandmont narrava ehe il pontefice "aveva inviato il vescovo di Preneste, il cardinale Giovanni di San Marco, legato della sede apostolica, consegnandogli il privilegio con l'ordine di recarsi velocemente a Grandmont e di canonizzare il santo di Dia in modo onorevole, come si conveniva, e di inserirlo nel catalogo dei sanci"2.
La disposizione papale era stata preceduta da una lettera solenne datata 21 marzo 1189, nella qualeil pontefice Clemente III aveva deciso di dichiarare la sancita di Stefano di Thiers, defmito nel testo papale Grandimon/ensü ordinü institutor, dopo essere stato pienamente informato de vita, meritis et conversatione del santo3. L'esecutore dell'intera operazione sarebbe stato il cardinale Giovanni di
Gerardus Iterius, Vita Stephani Muretensis ampliata, in: Scriptores ordinis grandimontensis, ed. J. BECQUE'l' (Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis 8), Turnhout 1968, pp. 138-160, in particolare Prologo, pp. 273 s. (sie!), p. 273: Omnia polest, quaemmque vu/1 opera/ur. Intelleganl igilur el percipianl inmduli el embescanl injideles, quia Deus bealum Stephanum mirijicavil e/ mirijicando laudabile reddidil nec voluil orcullare diulius sanclilalem ipsius qui velul gemma Iaiebai in s/erquilinio oblivionis. Con le stesse parole Clemente III nella lettera di canonizzazione esprimeva lo stesso concetto a proposito della santita di Stefano: e/ jidelimfl commodis el ipsius sancli viri honori, qui baclmus velul in slerquilinio gemma lalueral, congme viderelm; Gerardus Iterius, De revelatione beati Stephani, in: Scriptores ordinis grandimontensis (come sopra), pp. 275-311, in particolare III, p. 282.
Ibid., III, p. 281: deslinavil domi1111111 Praeneslinmfl episcopum, Iohannem Sancli Marci cardinalem e/ aposlolicae sedis legalui!J, dans ei privilegium alqm manda/JIIfl, quale//1/S velori cursu ad Grandimonlem accederel, el sanclum Dei honotijice, ul decebal, canonizarel, el sanclomi!J calalogo conitmgerel.
3 Ibid., Ia lettera di Clemente III si trova al capitolo III , pp. 282 s.: plmius inslmcli de vila, merilis el conversalione qua saepedirlus vir sanclus asserilur ßomisse, e/ quod eum mullimodis miramlomf!J indiciis divina voluil pielas i/his/rare [. . .] ipsum inter sanclos, auclotilale qua flmgimur, nos dmunliel adscripsisse; deinceps in
178 Cristina t\ndenna
'\ .... ~:<· Anagni, legato papale inviato in missionein quelle terre e~li il preeiso intento di raggiungere un aeeordo di paee fra il re di Franeia eil sovrano inglese4• La sosta a Grandmont potrebbe essere interpretata eome una sorta di eanonizzazione, in jom1a commissoria5, nella quale il eardinale aveva svolto una funzione essenziale. Egli, infatti, dotato di ampi poteri deeisionali, veloci curso, dopo la morte di Enrieo II, si era fermato a Grandmont, ove aveva deeiso l'elevazione del eorpo del santo e la sua traslazione nella ehiesa abbaziale, nella quale, alla presenza dei veseovi delle dioeesi limitrofe, di altri importanti uomini religiosi e di un folto popolo, era stata poi eelebrata la messa solenne per iserivere Stefano nel eatalogo dei santi.
Defmire ehi fosse il nuovo santo, ehe nel 1189 velut gemma latebat, ma ehe sino ad allora era rimas to in sterqui/inium oblivionis, non e sempliee, poiehe il suo pereorso verso la santita non appare del tutto lineare nelle fonti.
Il cammino verso la santita
Il rieonoseimento uffieiale della santita di Stefano di Thiers, con il conseguente inserimento del suo nome nel eatalogo dei santi, era uno degli atti eonclusivi di un proeesso di riforma perseguito sia per volonta dei responsabili dell'ordine, sia per intervento della euria romana e delle maggiori autorita eeclesiastiehe, al fine di risolvere il grave dissensium ehe durante gli anni Ottanta del XII seeolo
sanc/omm colalogo 111111/enmdum, e/ per ipsius metila Redemptotis mffragia decrevisse C/1111 reliquomm sanclomm interoentionib11s postulanda.
W. MALECZEK, Papst und Kardinalskolleg von 1191 bis 1216. Die Kardinäle unter Codestin 111. und Innocenz 111. (Publikationen des Historischen Instituts beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom 6), Vienna 1984, pp. 70-73 . Si tratta di Giovanni di r\nagni, o Anagnino, cardinale diacono di Santa Maria in Portico prima del 1159, dal 1167 cardinale prete di San Marco e dal 1190 al 1196 cardinale vescovo di Preneste. Fu inviato in Francia da Clemente lii ncl 1189 come mediatore per raggiungere Ia pace nella controversia ehe opponeva Enrico II e Luigi VII. La legazione si concluse con un completo insuccesso. Dopo Ia morte di Enrico II, sulla strada verso I'Inghi.lterra, mentre intendeva raggiungere Riccardo Cuor di Leone, figlio del sovrano inglese, egli si fermo a Grandmont il 28 agosto del 1189. Sulla legazione in terra di Francia si veda W. JANSSEN, Die päpstlichen Legaten in Frankreich vom Schisma r\naklets I!. bis zum Tode Codestins 111. (1130-1198), Köln/Graz 1961, pp. 134 ss.
J. PETERSOHN, Die päpstliche Kanonisationsdelegation des 11. und 12. Jahrhunderts und die Heiligsprechung Karls d. Ge., in: S. KL:ITNER (a cura di), Proceedings of the Fourth International Congress of Medieval Canon Law (Toronto, 21-25 August 1972) (Monumenta iuris Canonici. Series C: Subsidia 5), Citta del Vaticano 1976, pp. 164-206, in particolare sul caso della canonizzazione di Stefano di Thiers, pp. 182 s.
---Dall'escmpio alla santita 179
aveva travagliato Ia religio Grandimontensis, diffusasi in partieolar modo nelle regioni del Limousin e dell'Aquitania6.
I dissidi interni all'ordine, oltre ehe dalla peeuliaridt della straordinaria forma di religio, nella quale ehieriei e laiei eollaboravano parallelamente e eon pari dignita, naseevano al tempo stesso anehe da una piu eomplessa situazione politiea ed eeonomiea, oltre ehe eeclesiastiea, ehe aveva earatterizzato in Franeia !'ultimo trentennio del XII seeolo7. La religio di Grandmont durante Ia seeonda meta del seeolo XII godette, nonostante i prineipi ehe l'avevano ispirata, di un notevole favore da parte delle maggiori autorita politiehe ed eeclesiastiehe del regno di Franeia. Luigi VII aveva fondato e dotato alcune cellulae o loca Iegate a Grandmont nel territorio dell'Aquitania8, ma quella del sovrano non era stata
Sulla crisi si vedano le ampie e ben documentate osservazioni di J. BECQUET, La regle de Grandmont, in: Bulletin de Ia Societe archeologique et historique du Limousin 86 (1958), pp. 9-36 e ID., La premiere crise de !'Ordre de Grandmont, in: Bulletin de Ia Societe archeologique et historique du Limousin 86 (1958), pp. 283-324, ora entrambe i contributi ripubblicati in: J. BECQUET, Etudes grandmontaines (Memoires et documents sur Je Bas-Limousin 22), Paris 1998, pp. 91-118 e 119-160. Un dettagliato studio delle relazioni con Ia curia romana si trova in V. PFAFF, 'Grave scandalum'. Die Eremiten von Grandmont und das Papsttum am Ende des 12. Jahrhunderts, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung 75 (1989), pp. 133-154. Ne! Prologodel De revelatione beati Stephani (come nota 1), p. 277 Gerardo affermava ehe: C11111 ordo Gnmdimonlensi11111 di11 pos//ransi/11111 beali S tepbani confessotis Cbtisli, divina largimle gralia, rdigione, smtclilale ac bonilale, pop11lis /l/llltiplicai11S in magna pace, catilale, bonore e/ prospetilate non modica perstitisset, 11ltimo anno papatt/S utcii III, Pbilippo rege Franeorum et Hemico t~ge
Anglomm regnantib11s, oborta es/ gravis dissmsio, peccalis noslris exigentib11s, Deo pet7!1illenle el inimico b11mani genetis insliganle, in ipso ordine nos/ro. Unde necessilas coegi/11/ jralres invicem alterean/es ad cmiam accelerarenl. [. . .] Flebanl, l11gebanl, lamen/aban/11r, ang11stiabanl11r pene Oll/I/es amiri ordinis, eo q11od viderenl el a11direnl falsidicos e/ inimicos verilalis impia verba profem, garrire, strepere conlra religionis observanliam advers11s rarilalem jralemam. Timebanl a11/e111 de ordine tre mbverteret11r, 1111/lare/11r, deslil11ere/11r, mm aspiceturl, cemerenl per/11rbari 1111diq11e s/aflllll ordinis, disc11mre fralres ac vagari per saeclllllm, alios invitos, alios sponlaneos. Inviti defendebanl ordinem, sponlanei conlra ordinetl!. EI q11id pl11ra? 'Dispersi SIII/I Iapides sancl11arii in capile 011111i11m plaleamm. Q11i soliti eranl vesci in C7Vceis, amplexali smrl slercora'. Caritas jralema verlil11r in odi11111, vetilas in mendaritii!J, bonilas in /aedillm, sanclilas in opprobri11m, sobrielas in derisum, b11militas in conlemp1111lf, t~ligio in deltimml11m, oboedienliam in nibil11m fere otmris virt11s in viti11m.
In particolarc si veda R. FOREVILLE, L'Eglisc ct Ia royaute en Angleterre sous Henri II. Plantagenet (1154-1189), Parigi 1943; ma per il Limousin cfr. anche B. BARRIERE, L'abbaye cistcrcienne d'Obazine en Bas Limousin. Les origines - le patrimoine, Tulle 1977, pp. 17-40.
Al sovrano francese e legato l'insediamento dei grandmontani nella cella di Viccnnes. I bonibomines provenienti da Grandmont vivevano a Vicennes gia a partire dal 1158, ma solo nel 1164 Luigi VII poteva concedere loro un diploma nel quale donava il bosco e una rendita di frumento. II documento di fondazione di Vicennes e solo uno degli atti ehe, a partire da quella data, i1 sovrano francese rivolse a Grandmont; cfr. A. LUCHAIRE, Etudes sur !es actes de Louis VII, Parigi 1885, doc. 417,441,475,508. Importante personaggio legato alla corte di Luigi VII e suo valido, anche se discreto, consigliere fu il chierico Bernardo de Ia Coudre, ehe sino al 1200 fu superiore della cella di Vicennes. Sulla fondazione di Vicennes, Ia sua importanza e i1 ruolo di Bernardo de Ia Coudre si veda il contributo di J. BECQUET, Les grandmontains de Vicenncs: signification
180 Cristina r\ndenna
l, ... .r< un'iniziativa isolata. La domus e i bonihomines, cosi erano clllamati da alcune fonti contemporanee i grandmontani, avevano ottenuto il sostegno, anche economico, di Enrico II Plantageneto, ehe nel 1170 aveva espresso di fronte ai suoi piu stretti collaboratori il desiderio di essere sepolto a Grandmont, ai piedi della tomba di Stefano di Thiers, inumato presso Ia domus principale9.
Lo stile eremitico penitenziale scelto da Stefano di Thiers nella solitudine di Muret e condiviso da un piccolo gruppo di discepoli, raccoltisi intorno a lui, diede origine agli inizi del secolo XII ad una esperienza religiosa, Ia cui peculia-
d'une fondation, in: Vicehnes aux origines de )'Etat moderne. Actes du Colloque sur Les Capetiens et Vicennes au Moyen Age, Parigi 1996, pp. 137-144, ora in: ID., Etudes grandmontaines (come nota 6), pp. 197-201. Fu alla presenza del sovrano francese Luigi VII ehe chicrici e laici nel dicembrc dcl 1187, al termine della prima crisi ehe aveva travagliato l'ordine, cercarono di raggiungere un accordo, superando Ia contraddizione, su quegli aspetti ehe avevano causato Ia discordia. II risultato fu Ia redazione di un documento ehe avrebbe dovuto essere trasmesso alla curia pontificia pcr l'approvazione; cfr. anche J. BECQUET, La premiere crise (come nota 6), pp. 305-307.
Benedictus abbas, Gesta Regis Henrici secundi, in: The Chronicle of the reigns of Henry II . and Richard I. a. D. 1169-1192, known commonly under the name of Benedict of Peterbourgh, ed. \V STUBBS, 2 voll ., Londra 1867, vol. 1, p. 7. r\ partire dal 1160 il sovrano inglese destino ampi finanziamenti alla costruzione della chiesa di Grandmont, per Ia quale fece pervenirc materiali da costruzione, fra i quali anche una certa quantita di piombo, e manodopera di provenienza inglcse. Gli interventi di costruzione erano forsc stati incoraggiati dalla decisione del sovrano nell'agosto dcl 1170 di eleggere quel luogo a sua sepoltura. Dopo il tragico evento dell'assassinio di Thomas Bccket, il priorc Gugliclmo di Treignac ed i grandmontani rifiutarono di collaborare con il rc e rinviarono gli operai inglesi al sovrano. Tuttavia a partire dal 1174, dopo Ia pubblica dichiarazione del re a Cantcrbury, i grandmontani ebbero nuovamente un atteggiamento conciliantc con il sovrano, ehe ncl suo testamento stabili di donare a Grandmont una somma di denaro, stimata in 3000 marchi, di gran lunga superiorc rispetto alla cifra di 2000 marchi destinata a Fontevraud. La somma di dcnaro, con altri oggetti sacri, era stata poi sottratta dal figlio Enrico il Giovanc. r\lla scomparsa di Enrico il Giovane il padrc si era procurato di restituire alla domus di Grandmont il maltolto e di destinare in quel luogo Ia sepoltura del figlio. Grandmont, posta al confme occidcntale del Lirnousino, era sicuramente un luogo di grande interesse politico per le mire espansionistiche di Enrico II verso Bourges e Toulouse. Nel dicembre del 1177 inoltre a Grandmont il conte r\udeberto aveva venduto al re Ia contea della Marca; cfr. Benedictus abbas, GestaRegis Henrici secundi (come sopra), vol. 1, pp. 196 s. Piu ampie e dettagliate informazioni si trovano in R. GRAHAM, The order of Grandmont and its Hauses in England (English Ecclesiastical Studies), Londra 1929, pp. 216-218. r\ltri piu recenti contributi E . M. 1-IALLAM, Henry II , Richard I and the order of Grandmont, in: Journal of Mcdieval History 1 (1975), pp. 165-186; J. MARTIN / E. M. LORNA WALKER, r\t the feet of St. Stephen Muret. Henry II and the order of Grandmont redivivus, in: Journal of Medieval History 16 (1990), pp. 1-12 e infine C. T. Wooo, La mort et les funerailles d'Hcnri II, in: Henry II Plantagenet et son temps. r\ctes du Colloque de Fontevraud (29 septembre - 1 octobre 1990), Poitiers 1994, (= Cahiers de civilisation medievale 37 [1994) ), pp. 119-1 23 e L. GRANT, Le patronage architectural d'Henri II ct son entourage, in: ibid., pp. 73-84, in particolare pp. 75 s.
Dall'esempio alla santita 181
rita avrebbe generato es1t1 molto differenti rispetto alle iniziali intenzioni dell'eremita limousinoto.
Fra il 1185 e il 1188 un gruppo di chierici, guidati dal dimissionario priore Guglielmo di Treignac (1170-1189), era stato spinto ad abbandonare la domus di Grandmont e a cercare rifugio altrove. Lo scisma scoppiato all'interno dell'ordine nasceva da un lungo e grave dissidio sul ruolo dei laici e dei chierici, la cui convivenza e cooperazione alla realizzazione di una perfetta comunita sull'esempio degli apostoli e del primo cristianesimo rappresentava il vero elemento originale e caratterizzante di questa straordinaria religio11 •
10 Per cio ehe riguarda gli inizi dell'esperienza eremitico-penitenziale di Stcfano di Thiers e Ia successiva evoluzione in una religio si vedano i contributi di Jean BECQUET, ehe a questi studi, insieme all'analisi sulle forme della vita religiosa in Francia nei secoli XI e XII ha dedicato Ia sua esistenza di studioso. Come sintesi significativa delle sue ricerche, all'interno delle quali e possibile reperirc tutti i riferimenti relativi alla sua produzione scientifica, rirnando al volume miscellaneo J. BECQUET, Etudes grandmontaines (come nota 6). lmportante c anchc Ia pubblicazione dei regesti e talvolta dei documenti papali diretti a Grandmont: 10., Le Bullaire de !'Ordre de Grandmoor, in: Revue Mabillon 46 (1956), pp. 82-93, 156-168, 189-201; 47 (1957), pp. 34-43, 245-257; 48 (1958), pp. 40-58, 176-196, 258-268; 49 (1959), pp. 77-92, 152-171; 50 (1960), 21-29, 84-97, 145-154; 53 (1963), pp. 111-133, 137-160. Una recente storia dell'ordine si trova in C. A. HUTCHINSON, The Heremit Monks of Grandmont (Cistercian Studies Series 118), Kalamazoo 1989; infine i risultati del convegno G. DURAND I J. NOUGARET (a cura di), L'Ordre de Grandmont. Art et histoire. Actes des Journees d'etudes de Montpellier, 7 et 8 Octobre 1989, Carcassonne 1992 e G. MELVILLE, Von der 'Regula regularum' zur Stephansregel. Der normative Sonderweg der Grandmontcnser bei der Auffacherung der 'vita rcligiosa' im 12. Jahrhundert, in: H. KELLER I F. NEISKE (a cura di), Vom Kloster zum Klosterverband. Das Werkzeug der Schriftlichkeit, München 1997, pp. 342-363. Ioteressanti spunti per una rivisitazione della storia dcll'ordine si trovano nci contributi di M. M. WILKINSON, The 'Vita Stephani Muretensis' and the Papal Re-constitution of the Order the Grandmontin 1186 and thereafter, in: J. LOADES (a cura di), Monastic Studies, 2 voll., Bangor 1991, vol. 2, pp. 133-155; M. M. WILKINSON, Lai'cs et convcrs de !'Ordre de Grandmontau XII< siecles: Ia creation et Ia destruction d'une fraternite , in: Les mouvances laiques des ordres religieux. Atti del III Colloquio internazianale dcl C.E.R.C.O.R (Tournus, 17-20 giugno 1992), Saint-Etienne 1996, pp. 34-50; EAD., La vie dans Je monde d'Etiennc de Muret et Ia 'Vita Stephani Muretensis', in: G. D URAND I J. NOUGARET (come sopra), pp. 23-41. Infine il recentissirno G. MELVILLE, 'In solitudine ac paupertate'. Stephans von Muret Evangelium vor Franz von Assisi, in: G . MELVILLE I A. KEHNEL (a cura di), 'In proposito paupertatis'. Studien zum Armutsverständnis bei den mittelalterlichen Bettelorden (Vita regularis 13), MünsteriHamburgiLondon 2001, pp. 7-30. Su Stefano di Thiers (di Muret) cfr. J. BECQUET, "Etienne de Muret, saint, fondateur de !'Ordre de Grandmont", in: Dictionnaire de Spiritualite, vol. 412, Parigi 1961 , coll. 1504-1514, ora in 10., Etudes grandmontaines (come nota 6), pp. 3-20 e 10., "Etienne de Muret", in: Dictionnaire d'histoire et de geographie ecclesiastique, vol. 5, Paris 1963, coll. 1252 s. e 10., Saint Etienne de Muret parmi !es saints limousins, in: Cahiers grandmontains 6 (1992), pp. 51-56, ora in 10., Etudcs grandmontaines (comc nota 6), pp. 29-36 ed infine H. PLATELLE, "Stefano di Muret", in: Bibliotheca Sanctorum, vol. 11, Roma 1968, coll. 1046-1048.
II J. BECQUET, La premicre crise (come nota 6), pp. 289-313.
182 Cristina Andenna
'I • .. _t.: .,.
Il racconto delle fasi risolutive dello scisma e narrato con dovizia di dettagli nel De reve/atione beati Stephani, un testo agiografico con la raccolta dei miracoli di Stefano, scritto intorno al 1190 da Gerardo Ithier, il priore eletto dal capitolo generale al termine della grave crisi, dopo il raggiungimento della pacetz. Lo scisma era in corso da circa tre anni, quando, dopo numerosi e vani viaggi a Roma, una legazione di Jratres recatasi presso la curia ottenne un diretto e risolutivo intervento del pontefice Clemente III. La risposta del papa fu decisiva, poiche Clemente III confermo le institutiones e la regula, rinnovo molti altri privilegia, fra i quali la concessione dell'esenzione dall'ordinario diocesano e il permesso di trattenere le decime, e dispose ehe i priori, eletti dai due partiti in contrasto, fossero deposti e ehe si procedesse, ex more de eligmdo priore, alla rielezione di un nuovo pastore, ehe avrebbe dovuto in tal modo garantire la pace e la durata della raggiunta concordia13. Ma se il De revelatione indicava ehe la regula approvata da Clemente III era gia stata precedentemente confermata da altri pontefici, quali Adriano IV, Alessandro III e Lucio III, tuttavia il testo di quella lettera, datata 25 giugno 1188, norninava solamente delle institutiones, ehe, corrette da una comrnissione, avevano ricevuto l'approvazione del suo predecessore Urbano III. Nella successiva bolla del 27 giugno dello stesso anno il papa apponeva invece la conferma al testo della regula, anch'essa corretta dal predecessore Urbano III su consiglio e approvazione di molti cardinali e vescovi italiani, ehe sarebbe stata offerta tam c/ericis quam conversis ad eius firmitatem et pepetuam pacemt4.
12 J. BECQUET, Les premiers ecrivains de ('ordre de Grandmont, in: Revue Mabillon 43 (1953), pp. 121-137, ora in: ID., Etudcs grandmontaines (comc nota 6), pp. 249-266, in particolare p. 130 e ID., Bibliotheque des ecrivains de l'Ordre de Grandmont, in: Revue Mabillon 53 (1963), pp. 59-79, ora in: ID., Etudes grandmontaincs (come nota 6), pp. 267-287, in particolare pp. 66 s.
13 Gerardus Iterius, De revelatione beati Stephani (come nota 1), l'intero racconto si trova al capitolo III, pp. 280-282, qui in particolare III, p. 280: Cumque, 111 praelibavinms, isla dismuio fere per lrietwium graviler perdurassel, ibanl ad Cllriam jralres saepissime, el revertebanlur pamm aul nihi/ proficienles, usque ad lempus C/emenlis pape Ill, qui itemm post conjif7!1alionem Adriani, A lexandri, Ltcii praedecmomm S/10171111, regulam insililulionesque conjif711avil, privilegia imrovavil, duosq11e priores qui tune lemporis invicem eranl conlrarii desliluil, el licenliam eligendi priorem indulsit. Accepta igit11r licenlia jralm ab eo, complelisque negoliis in pace el gaudio revertunlur, adtmaloque 1111iversa/i capitlllo in Grandimonle ex praecepto domit1i papae in jeslo Sancli Michaelis, lraclalur ex more de eligmdo priore; allamett 11011 difllemnl, qui hoc 111 11011 fieret perlurbare nitebanlur. Alii dicebanl sie, alii vero sic;fere 11111/Jquisque S/111111 quaerebat priorem. S ed 110n es/ sapimlia, no11 es/ pmdenlia, 11011 es/ consilium co11lra Detltn. Le lettere di Clementc III si trovano in J. BECQUET, Le Bullaire de l'Ordre de Grandmont 46 (1956) (come nota 1 0), pp. 92 s., docc. 18-21 e pp. 157-159, docc. 22-28. 1 ~ J. BECQUET, Le Bullaire de l'Ordre de Grandmont 46 (1956) (come nota 10), doc. 22, p. 156: 25 giugno 1188; doc. 24, pp. 157 s.: 27 giugno 1188. Sulla eccezionalita della regola di Grandmont si veda G. MELVILLE, Von der 'Regula Regularum' (come nota 10), pp. 342-363.
Dall'esempio alla santita 183
Nel suo privilegio Urbano III cliehiarava inveee cli accogliere e approvare Ia regula, siCIIt in vestro ordine15, eome avevano fatto i predeeessori Alessandro IIJ1 6 e Lueio 11117, anehe se il papa affermava cli aver aggiunto aleuni capitoli a eorrezione della stessa, soprattutto quelli ehe imponevano il lavoro sostitutivo della penitenza e funzionale alla remissione dei peeeati. Era inoltre speeifieato ehe le institutiones- e qui si ha Ia eonferma del fatto ehe si trattava cli un testo preeedente e separato rispetto alla regula- erano state approvate da Adriano IV, ma ehe in seguito erano state ampliate dai Jratres ad castigationemtB.
15 J. BECQUET, Le BuUaire de !'Ordre de Grandmont 46 (1956) (come nota 10), doc. 13, p. 91; i1 testo e pubblicato in Thesaurus Novus Anecdotorum, ed. E . MARTENE I u. D URAN D, vol. I, Parigi 1717, coU. 627-629 e Patrologia Latina 202, coU. 1416 s.: ad i!ISfar praedecessomm nosfromm felicis 1~cordationis Alexandri ef Ludi romanom!ll pontijicum, onmibus regulam vesfram servantibus, simf in vesfro ordine, ef suprapositis nosfrae comctionis capitulis salubriter contimtur, Iabore/II loco poenilmfiae, ef in peccafomm momm mnissionem iniugimus, quem in ipsa observantia patiunfur. Insfitutione!tl quoque quam ad castigationem vesfram post confinnafiomm felicis recordationis Adriani papae praedecessoris nostri salubriter addidistis, auctoritafe apostolica confinnamus, ef perpetuis decemifiiiiS temporibus valituram, sfafllellfes 111 /ibemm vobis sit, smmdutn regulam vestratn, atque institufa ordinis, absqm aliquomm gravaminibus vel mo/estiis, Domitto famlllori, sa/va in omnib11s aposto/icae sedis auctorifafe. 16 J. BECQUET, Le BuUaire de !'Ordre de Grandmont 46 (1956) (come nota 10), pp. 87 s., doc. 6; il testo datato Tuscolo 8 marzo 1171/1172 e stato pubblicato in: De Antiquis Ecclesiae Ritibus, ed. E. MARTENE, vol. 4, Anversa 1738, col. 923. II testo e citato anche nel privilegio di Clemente III e di Innocenzo III; J. BECQUET, Lc BuUaire de !'Ordre de Grandmont, 46 (1956) ( come nota 1 0), pp. 15 7 s., doc. 24 e p. 166, doc. 44. 17 Ibid., pp. 88-90, doc. 8; 27 agosto 1187: Stotuimus preterea 111 libemm vobis sif semndum institufa vestri ordinis sine aliq11omm mo/estiis Domino jam11fari. Ne! privilegio non si fa alcuna menzione tuttavia al fatto ehe gli insfitu/a fossero stati precedentemente approvati dai predecessori.
18 Ibid., p. 87, doc. 4-5; il testo e indicato da Jean BECQUET come datato 25 marzo 1156: Insfifutiottef/1 quoqm quam ad castigotionem veslran1 post co!ifinnatiotte/11 felicis recordotionis Adriani papae praedecessoris nostri sa/11briter addidistis. Secondo quanto affermato da L. DELISLE, Examen de treize chartes de l'Ordre dc Grandmont, in: Memoires de Ia Societe des Antiquaires de Normandie 20 (1854), pp. 171 ss. II documento papale sarebbe stato interpolato e notevolmente alterato. M. M. WtLKINSON, suUa base deUe osservazioni di J. lV\MACKERS Q. lV\MACKERS, Papsturkunden in l'rankreich, N . F., vol. 5: Touraine, Anjou, Maine und Bretagne [Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingcn. Philosophisch-historische Klasse, 3. F., 35], Göttingen 1956, p . 25, doc. 3) suggerisce invece di circoscrivere Ia datazione deUa lettcra di Adriano IV al 1159. Qucsta datazione e anche confermata da M. M. WILKINSON, The 'Vita Stephani Muretensis' and the Papal Re-constitution (come nota 10), pp. 142 s., in particolare alla nota 56. La studiosa trascrive una notizia presente in un manoscritto del secolo XII-XIII proveniente dalla biblioteca di Grandmont (Ms. Paris Bibliotheque National10.891 , fol. 77r) neUa quale si ha Ia conferma ehe il pontefice Adriano IV aveva approvato vifafll ef instituciones frotmm de Grandimonfe e ehe questa beneplacito deUa sede apostolica era giunto tramite l'intercessione di due vescovi, Gerardo di Lirnoges e di suo nipote Gerardo, secondo Ia notizia anch'egli vescovo di Canterbury, presenti in quei giorni a Roma in occasione deUa loro visita ad /imina. Series episcoporum ecclesiae catholicae quotquot innotuerunt a beato Petro apostolo, a multis adjutus ed. P. P. GAMS, Leipzig 1931, p. 565: Gerardo di Cher, vescovo di Lirnoges, clctto prima del 1142 e deceduto il 7 ottobre del 1177; cfr. anche nota 135. Gerardo di Canterbury, invece non compare neU'elenco dei vescovi
:~/ ... .,.
184 Cristina Andcnna
'':."'/>,
I documenti pontifici pertanto testimoniano ehe, a partlre dalla meta del secolo XII, Ia curia romana aveva mostrato una certa attenzione per Ia re/igio di Grandmont. Dal 1159 infatti i fratres de Grandimonte avevano ricevuto l'approvazione della loro vita e delle loro institutiones da parte della curia romana. Negli anni successivi i contatti con i1 papato si erano intensificati, anche se secondo gli studi di Volkert PFAFF, si dubita ora della autenticidt dei testi di aleuni privilegi19. Nonostante Je osservazioni critiche circa i testi papali e Ia loro complessa tradizione, non e possibile ignorare i1 fatto ehe Clemente 111 non fosse stato i1 solo ad essersi occupato della straordinaria re/igio, anche i1 suo predecessore Urbano 111, direttamente interpellato dalle parti in lite, aveva sollecitato con molteplici interventi Ia risoluzione delgrave scanda/unf2°.
Fra Je misure di intervento previste da Clemente 111 era sottolineata anche Ia precisa indicazione di deporre i due priori scismatici. A queste prescrizioni faceva seguito nel racconto del De reve/atione l'invito a convocare un capitolo generale in occasione della festa di San Michele, durante i1 quale si sarebbe dovuto
indieato da GAMS, fra il 1139 c il 1161 era veseovo a Canterbury Teobaldo; Serics episcoporum eeclesiae eatholieae, p. 183.
19 V. PFAFF (eome nota 6), pp. 133-154. 20 II 15 luglio del 1186 il pontefiee Urbano Ill era intervenuto csortando alla paee e alla ripresa della normalita: ne inimims h11mani generis, q11i semper rirmil q11aerens quem devorel, piis invidet st11diis peifectomm, per Sllae calliditalis asl11liam adverms vos, Domino resislmle, praevaleal, el proposilllm religionis e/ ordinis s11b q11o lauriobilifer mililalis, vimlenla s11ggesliom imm11/e/ aliq11alen11s, vel per111rbe/, in vobis fralemae pacis gralia!IJ violanrlo. Inde siq11idem es/, q11od c11m inter vos, pemJitlenle ipso q11i fideles mos lenlari non patiltlr, s11pra id q11od portare possinl, seminariutn scanrloli mbort11m ji1eril, quod so/lirilllrlitle pl11rimomm adhibila, hacle/11/S sedari nequiveril; ad noslram praesenliam q11idam ex 11/raq11e parte fratmm litiganlium accessenml coram nobis e/ jrallib11s noslris, plmima de inslil11tione veslri ordinis, e/ illalis hinc inde iniuriis, preponmles. Nos vero, a11dilis onmibus diligmler q11ae in noslro d11xenml a11ditorio proponenda, 111 de celero inimico vir111111m omni11m nocenrli aditus clalldere/ur, el in ordine ves/ro maleriam i11rg,iomm, man11m correclionis aposlolicae de fralmm nosfromm consilio dllxillms apponendam. Aeeanto ad aleune sottolineature sulle eondizioni di ingresso dei religiosi il papa stabiliva ehe priori a11/em lam in spiril11alib11s, q11am in lemporalibus, plmam COJ/cerlim11s al/clorilale aposlolica poteslalem: ila 111 uni conversomm, q11i magis idom11s j11eri/ in ce/lis veslris lemporalia disponmda commillal, q11i de ipsi11s prioris mandalo, elemosynas deposilaqm reripial, el eas in pios IIS/IS ac mcessilaletn do11ms provida consideralione converlal. C11ra vero spiril11alit11n libere de manrlolo prioris circa clericos ipsos residea/: ila q11od n11!111s laicomm fralmm in conjessionibus, poenilenliis, divinis o.f!iciis celebrandis, el corrigendis excessibus clericomnJ, 111/am sibi al/clorila/em 1/SI/rpet: sed haec omnia per priorem iam rlicl11m, vel de mandalo ipsi11s, per clericos expleanlllr. Si trattava delle eorrezioni ehe Urbano li! aveva apportato alla regola, ehe egli confermava insieme con Je imlilliliones, di cui si e gia detto; J. BECQUET, Le Bullaire de !'Ordre de Grandmont 46 (1956) (come nota 10), p. 91, doc. 13; il testo e pubblicato in: Thesaurus Novus Anccdotorum (come nota 15), coll. 627-629 e Patrologia Latina 202, coll. 1416-1418.
Dall'escmpio alla santita 185
eleggere il nuovo priore21. Il racconto della fonte del De revelatione offre, al di la del carattere volutamente agiografico del testo, una interessante e dettagliata descrizione delle procedure di elezione di un nuovo priore, in cui si nota una perfetta rispondenza con quanto indicato nel testo normativo della Regtt!a al capitolo LX, De electione prioris 22. Fra coloro ehe si erano radunati nel capitolo generale, circa 220 chierici e 260 conversi, regnava un grande scetticismo sulla possibilita di raggiungere un accordo unanime fra le due fazioni ehe si contendevano l'elezione di un nuovo priore (Aiii dicebant sie, alii vero sic;fere unusquisque suum quaerebat priorem), ehe avrebbe dovuto garantire il completo superamento delle discordie. Un evento miracoloso, il cui ricordo evoca direttamente il racconto della Pentecoste, era intervenuto a pacificare gli animi: lo Spirito Santo, infatti era disceso a infiammare i cuori dei presenti, e Jacta in capitulo tranqui/litas magna et exultatio, il convmtus dei Jratres raggiunse un accordo per una unanirne modalita di elezione23. Furono scelti sei chierici e sei conversi, i quali, Deo volente,
21 La lettera di Clemente III ehe dispose Ia deposizione c datata 23 giugno 1188: J. BECQUET, Le Bullaire de I'Ordre de Grandmont 46 (1956) (come nota 10), p. 93, doc. 21, il tcsto e traseritto in Patrologia Latina 204, eol. 1375. 22 Regula venerabilis viri Stephani Muretcnsis, in: Scriptores ordinis grandirnontensis (come nota 1), pp. 63-99, in particolare LX, pp. 96 s.: De eleclione p1ioris- Cmn prior digmdum esl,jmlres ex singulis cellis bini convmian/ in Gmllflimon/em, quemadmodum ad coJwm/um bini vmiJ? consuevenm/. In eisdem vero Ioris J?tnanm/es, lolius eleclioni conven/us se pro cer/o concedere, celeris abmnlibus, promil/anl. Aduna/o ilaque convm/11, pos/ invocalionem nominis Domini, d11odecim fideles el religionis amalores, sex videlicel cle1iri el sex conversi, ad eligmd11111 prioml1 designe11111r, q11i postq11am a11dierinl ab omnib11s eleclionem mam a 11111fo Jim ronlmdicendam, seors111JJ in/er se de ea perlraclen/. Talis ilaque paslor eligalur, qui an/ea fidelis huius J?ligionis disripulus exslileril, 111 alios ex seipso considerans, prou/ opus fimil, srial 1111iCI/ique utilia providere. Si vero in/er ipsos duoderi111 aliqui in eleclione dessenserinl, maiori parti concedmdum es/ quae scilicel fidelior saniorque inlellegilur, 11ihil ibi nisi commumm ulilila/em collsideralls, i//is disselllielllibiiS a co11silio e/ eliam extra COI/Ve/1111111, 11/ lo/um sine eis jial, eieclis. Ex ipso lamm conven/11 /olidem concilio adicianlur quo/ eiecli fiminl, e/ de eisdem sitJe clericis, sive conversis, 11/ in duodecim senper eleclio consisla/. Il nome dell'autorc della Regola, ehe J ean BECQUET indiea in Stefano di Liciae, o in un eontemporaneo, non e ecrto: infatti dalle rcecnti osscrvazioni di M. M. WILKINSON (eome nota 10) emergc ehe Ia Vita sarebbc stata redatta eon il solo seopo di illustrarc e dare fondamento ad una regola pcrfczionata attorno agli anni Ottanta del secolo XII; J. BECQUET, L'ordre de Grandmontau XIII• siede, in 10., Etudes grandmontaincs (eome nota 6), pp. 217-246, in particolare pp. 217-220 e alcune riflessioni eritiehe dal tono di reeensione 10., Le premicr siede de Grandmont d'apres un travail en cours, in: Les Cahiers grandmontains 4 (1981), pp. 2-4. 23 Gerardus lterius, Dc revelatione beati Stephani (eome nota 1), li! , p. 280: Cumque vidisse/ divina bonilas eomm corda vehementer ab invicel!t esse divisa, ex improviso adfuil in eomm convenlo S ancli Spirillls praesmlialiler consolalrix gralia, q11ae corda eom111 vehementer accendit e/ itiflammavil e/ in 111111111 converlil. Facta esl igilur in capitulo lranquillilas magna e/ exul/alio, ila 11bi vidm/ur quod Dws omnipolms in medio eomm descendissel. Flebanl igilur jraiJ?S je!? omnes, e/ comolabanlllr invicem e/ laetabanlur, Dmm bmedimtles C/1111 gaudio, centmies Dei praesmliam ar!fuisse. Cfr. anche Regula venerabilis viri Stcphani Muretensis (come nota 22), LX, pp. 96 s.
186 Cristina Andenna
'\.-'" ~r<
reeitata prima una preghiera, elessero il nuovo priore: Ge~~rdo Ithier24. Egli era il settimo dopo Stefano di Thiers, la eui elezione fu eonfermata dalla solenne promessa di obbedienza ehe il neoeletto rieevette dall'intero conventus dei Jratres eonvoeati in eapitolo25.
La risoluzione della discordia tuttavia e direttamente eollegata nel De revelatione ad un evento di altrettanto signifieativa importanza per la religio: appena dopo l'elezione fu affrontato il problema della Revelatio beati Stephani. Ottenuto il eonsenso del eapitolo generale e dell'areiveseovo Elia di Bordeaux26, del veseovo Saibrando di Limoges27 e di Bertrando di Agenzs, ehe in quei giorni erano eonvenuti a Grandmont, furono redatti, eon la eollaborazione anehe di altri presuli, areiveseovi, prineipi ed abati, una serie di doeumenti e di lettere indirizzate al pontefiee e alla euria. Le missive furono portate a Roma da due Jratres: il saeerdote Roberto e il frate eonverso Guglielmo29. Confrontando il raeeonto della fonte e quanto inveee e eontenuto nella lettera di eanonizzazione, e possibile avanzare l'ipotesi ehe la presenza dei tre veseovi al eapitolo di Grandmont non fasse easuale, in quanto nelle loro lettere vi erano probabilmente i risultati delle inehieste de vita, meritis et mnversatione di Stefano e, non da ultimo, anehe delle indagini intomo ai suoi miraeoli per la defmitiva attestazione della sua santita30.
2~ J. BECQUET, "Gerard Ithicr", in: Dictionnaire de Spiritualite, vol. 6, Parigi 1967, pp. 275 s., ma anche il rimando bibliografico in ID., "Gerard Ithier", in: Dictionnaire d'histoire et de geographie ecclesiastique, vol. 20, Parigi 1984, col. 774. 2' Gerardus Iterius, D e revelationc beati Stephani (comc nota 1) , III, 34-44, p. 281: C11!11que sie visilali j11issenl a Domino el consolali per dimidiam fere boram 11nanimiler concordan/es dixemnl: 'E/iganl11r jralres d11odecim ex 110bis, sex cle1iri el sex conversi, q11i, Deo volenle, el Jac/a p1imil11s oralione, sibi nobis ac loli11s ordinis Hlifilali p1vvideanl, e/ eligan/ pas/orem'. Q11od ila Jac/11111 es/, e/ Deo vo/enle, alque 11niversa/i rapi111fo consenlienle, Gerald11s eligil11r a b. S lepbano plior VII. Ga11denl fideles e/ exH!tanl, /ae/an/Hrq11e in la11diblls divinis. PromilliiHr ei oboedienlia ab omnib11s. Eran/ ibi Jralres congregali fere n11111ero q11ingenli, min11s tliginli, d11cenli clelici el ampli11s viginli e/ d11cenli conversi e/ sexaginla. 26 Series episcoporum ecclesiac catholicae (come nota 18), p. 520: Elias de Malemort, arcivescovo di Bordeaux da! 1188 al 19 marzo 1207. 27 Ibid., p. 565: Saibrando (o Sebrando) Chabot, vescovo di Limoges da! 1179 e deceduto nel marzo fra il 1197 e il 1198. 28
2?
Ibid., p. 479: Bertrando I di Bcceiras (Veceras), vcscovo di r\gen dal1183 al1208.
Gerardus Itcrius, De rcvelatione beati Stephani (come nota 1), 111 , p. 281. 30 E necessario sottolineare ehe Ia presenza di miracoli, oltre ehe l'esemplarita di vita , e ancora durante il secolo XII uno dei criteri costitutivi del riconoscimento della santita; A. V AUCHEZ, La saintete en Occident aux dernicrs siedes du Moyen Age, Roma 1981, ora trad. it.: La santita nel Medioevo, Bologna 1989, pp. 25-40.
-Dall'csempio aUa santitit 187
11 testo della lettera di eanonizzazione si rileva inoltre ehe le pratiehe per il rieonoseimento della santita dell'institutor Grandimontensü ordinis erano gia state avviate durante il pontifieato di Urbano III. 11 papa audita fama religionis et vilae commendabilis puritate di Stefano di Thiers, e eonoseiuta Ia fama dei suoi miraeoli, volendo ehe essi fossero noti al mondo, aveva disposto l'istituzione di una inehiesta de vita, men'tis et conversatione'>1• I due eardinali preseelti furono eon buona probabilita Ottaviano32 e Bobone33, i quali, diretti nei domini dei Plantageneti, avevano sostato a Grandmont, dove insieme ad una eommissione eostituita da Enrieo II, dagli areiveseovi Guglielmo di Rheims, eardinale di Santa Sabina34, Bartalarneo di Tours3S ed Elia di Bordeaux, nonehe da! veseovo Saibrando di Limoges, si erano informati sulla vita di Stefano e, soprattutto sulla regola, ehe in quel preeiso momento rappresentava il vero pomo della diseordia ehe opponeva i ehieriei e i eanoniei.
La morte del pontefiee aveva rallentato le proeedure, ehe tuttavia sfoeiarono nella deeisione di avviare il proeesso di eanonizzazione solo dopo Ia eompleta risoluzione dello seisma e il ristabilimento della normalita, alla quale a partire da! 1188 anelava anehe Clemente III36. Abbiamo pertanto eon buona probabi-
3l Gcrardus Iterius, Oe revclatione bcati Stephani (come nota 1), 111, p. 282: Inde siq11idem j11il q11od bonae memoriae praedecessor nos/er Urban11s, a11dila ja!l/a religionis, e/ vilae CO!IIIIICIIdabilis p11rilale, q11a sanclae recordalionis Stephan11s Grandimonlensis ordinis insli/11/or emimil, q11anlis eliam mirac/1/omm leslimoniis om11ipolms Dms ip.ri11s voluil 1111111do declarare, legalis, q11os ad parles i/las dimdl pro q11ib11sdam mgoliis ecclesiae lrac/andis, plnwm circa haec invesligalionem commilere voluil, 111 el ipsomm celerommq11e viromm, q11ib11s sine d11bilalione Jides esse/ adhibmda, /eslimonio, ad id agmdum consullo procederenl, quod el .fidelill/1/ commodis e/ ipsi11s sancli viri honori, q11i hac/ei/IIS ve/111 in s/erq11ilinio gemma lalueral, congme viderelur.
32 W. MALECZEK (comc nota 4), pp. 80-83: Ottaviano fu elcvato aUa dignitit cardinalizia comc diacono dei Santissimi Scrgio e Bacco nel 1182. Compi a partirc dall'autunno dcl 1186 una scric di lcgazioni in Francia c Inghiltcrra, in particolarc pcr mediarc ncUa difficile situazionc politica fra Luigi VII c Enrico II. Dopo il 5 aprile 1187 e prima deU'agosto dcUo stesso anno cgli fu anchc a Grandmont dove opero per introdurre deUe riformc istituzionali c per risolvcrc lo scisma scoppiato all'interno deU'ordinc.
33 Ibid., pp. 68-70: Giacinto Bobone fu nominato cardinale diacono di Santa Maria in Cosmedin il 23 dicembre dcl 1144 da! pontefice Lucio II. Fra il 1162 e il 1165 ottennc il compito della legazione in Francia.
3-l Ibid., p. 68: Guglielmo di Champagne, arcivcscovo di Sens nel 1176 e succcssivamentc arcivcscovo di Reims da! 1176 al 1202. Fu norninato cardinalc prctc di Santa Sabina a partire dal 1179 alla morte il 7 o 9 dicembrc dcl 1202.
3S Serics episcoporu~ ecclesiae catholicac (come nota 18), p. 640: Bartolomeo de Vendomc, arcivescovo di Tours dal 1174 al 15 ottobre 1206.
36 J. BECQUET, Le Bullaire dc !'Ordre de Grandmont 46 (1956) (comc nota 10), p. 93 , doc. 21; il testo del 23 giugno 1188 e trascritto in: Patrologia Latina 204, coll. 1375 s. Il pontefice Clcmcnte 111 intimava Ia deposizione dei due priori ed esortava a proccdere alla clczione di un nuovo priorc: Volmles ergo lmnqllillilali e/ q11ieli ves/rae circumspeclione modemminis aposlolici providere, 11/ OI!JIIis in/er vos de cae/ero, auc/ore Deo, dissmsioii/1/!J e/ j11rgiomm maleria sopialur, de consilio e/ assmsu jralmm
188 Cristina r\ndenna
t,_ .. /'. '-·
lita ragione cli pensare, eome si e gia detto, ehe la deeisione cli avviare eon forza ed in modo risolutivo il 'proeesso' cli santita cli Stefano fosse maturata lo stesso giorno nel quale il eapitolo aveva proeeduto alla elezione del nuovo priore Gerardo Ithier.
Non solo le fonti interne all'orcline e le lettere papali testimoniano il grave scanda/um: La religio cli Grandmont fu oggetto cli riflessione infatti a partire dalla meta del secolo XIP7• Le fonti narrative e eronaehistiehe registrano e annotano una generale deeadenza rispetto alla purezza degli ideali delle origini. Il 'clisinteresse' per le eose mondane, earatteristiea, questa, ehe rappresentava uno degli elementi clistintivi della seelta religiosa dei grandmontani, aveva laseiato spazio all'avarizia, rendendo la vita a Grandmont assolutamente eontradclittoria rispetto alle aspirazioni e .alle intenzioni iniziali.
Una fonte eontemporanea offre un elemento cli ulteriore ehiarifieazione. Stefano, un ehierieo vittorino priore dal 1176 della eanoniea parigina cli SainteGenevieve e destinato alla sede veseovile cli Tournai, esprimeva fra il 1178 e il 1180 un giudizio molto severo su Grandmont e la sua religioJB. In una lettera indirizzata all'abate del monastero eistereense cli Pontigny, Roberto, il ehierieo regolare rifletteva sulla eomplessa questione relativa al transitus. Due professi cli Grandmont si erano rifugiati nel monastero eistereense cli Pontigny e vi erano stati aeeolti eome novizi. Il problema era eanonieamente molto eomplesso, poiehe eolui ehe aveva eompiuto la professione, dopo il periodo del noviziato,
noslrvmm, Iom GNilleiiiJIIIIJ q11i abmumriasse dignosril11r, q11am Stephan11m, pro bono pacis el concordiae inter vos rejinmandae, a priora/11 regimine d11xim11s amovwdos, eligwdi priorei/J facllllalem vobis liberam concedenles. A riguardo dcUa regola erano inoltre riconfcrmatc lc correzioni stabilite da Urbano JII : 111 Reg11/am ordinis veslri, sic11/ eam bonae memoriae Urbmms praedecessor nos/er, de consilio el assenm cardinali11m, mllllommqlle episcopomm llaliae, praesentib11s ex vobis Iom deriri q11a111 conversis, ad ei11s jir71Jilalem el perpe111am pacem invicem oscNIIIIIJ sibi pmesenlib11s, con~xisse dignosril11r, el lam in privilegio Silo, q11am noslro pleni11s repetilm; in poslem111 sine conlradiclione q11alibel observelis. Fra il 25 giugno c il 1 luglio del 1188 il pontefice invia altre lettere fra le quali Ia concessione deU'esenzione e Ia conferma deUa regola secondo le correzioni apportate da Urbano 111; J. BECQL'ET, Le BuUaire de !'Ordre de Grandmoor 46 (1956) (come nota 10), pp. 156-158, docc. 22-25.
37 V. PFAFI' (come nota 6), pp. 133-154. Walter Map, De Nugis curialium, ed. M. R. ]MIES /
C. N . BROOKE / R. r\ . MYNORS, Oxford 1983, pp. 52-54 e 112-114.
38 Stephanus Tornacensis cpiscopus, ep. 71, in: Patrologia Latina 211, coU. 361-370. r\ proposito di qucsta lettera cfr. anche le considerazioni di P. Li\NDAL', 'Officium' und 'libertas christiana' (Sitzungsberichte. Bayerische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse 1991 , 3), München 1991 , pp. 89-91 .
-Dall'esempio alla santita 189
deeidendo di destinare la sua anima eompletamente a Dio, non avrebbe potuto infatti reeedere dal suo voto39.
Affrontare la questione da un punto di vista canontstteo signifieava per il giurista Stefano ehiedersi come potesse eollocarsi dal punto di vista della legislazione eeclesiastiea la re/igio di Grandmont. Tale ordine si presentava eome una forma straordinaria di religio, bifronte come Giano e biforme eome il eentauro40, eomposta sia di ehieriei, ehe di laiei. I ehieriei non volevano, ma al tempo stesso non potevano neppure essere deftniti canoniei, poiche i eanoniei regolari vivevano ormai stabilmente seeondo la Regola di Agostino. I laiei non istruiti erano, inveee, ererniti. Insieme eon i ehieriei si faeevano ehiamare bonihomines e vivevano in eomune in luoghi isolati detti ce//ulae, oppure bonhominaf!l1•
Dal punto di vista normativo essi seguivano alcune constitutiones raeeolte in un Ube//us, ma aneora una volta il eanonieo vittorino coglieva l'oecasione per ribadire ehe non si trattava di una regola, ma di una vita, indieata loro dal maestro, un eerto bonus homo di nome Stefano de Mureto. Il nostro ehierieo, non maseherando nelle sue parole una eerta ironia, sosteneva ehe se essi attribuivano l'origine del proprio assetto normativo al magister Stefano. Eppure, a suo parere, tutto cio non era affatto certo42• Anehe amrnettendo ehe egli avesse redatto un testo normativo, questo tuttavia era rimasto sconoseiuto alla Chiesa Romana, la quale non aveva pertanto potuto emanare alcun privilegio di approvazione. Il papa, infatti - ribadiva il eanonieo vittorino - non era solito attribuire privilegi su eio ehe non esisteva, ne tanto meno su situazioni delle quali egli non aveva rieevuto notizia43.
39 Stephanus Tornaccnsis episcopus, Epistolarium (come nota 38), cp. 71, col. 365: Solo anima, si ea voveris, commllfafioml!lnOII recipit.
~o Ibirl., col. 368.
~ 1 Ibirl.: Sed ef canonicos reg11lares nostri femporis s11b Reg11la beati A11g11sfini Christo deseroire scii!IIIS, ef s11b ea in domo Domini 1111i11S moris babitare.
H Ibirl.: Ipsi Ollfe/li non Aug11sfinum, sed quemdam, 111 dicm1f, bo/111/ll bomimm Stepbam/1!1 de M11refo magisfmm SIIII/II projitmf11r. Ubell11s efiam q11i eomm constifllfiones continmf, non regula appellat11r ab eis, sed vita. Inde esf q11od sialf a reg11la q11am obseroenf canonici nostri, dic11nf11r reg11lares; sie etiam ipsi necesse esf a vifa q11am projitmfur, dica//fllr cleJici, smlaici vitales.
~3 Ibirf., col. 369: Crerlim11s q11ia necdm11 fradito eraf a domino Stepbano de lvf11reto regulam isfomm; Oll!, si fradito eraf, S ancfae Romm1ae Ecclesiae incognita eraf. Et qt~omodo polerat S/1/!lfli/IS pontifex privilegi11m dare bis q11i JJecd11m eranf, vel in notitia SIIO!ll nond11m vmerant?
190 Cristina r\ndenna
Desiste, mi domine, aut si non ftcen·s, certe non diligam 'fi?! signa et prodigia e il traclimento dell'ideale
I1 rieonoseimento della santita di Stefano appare allora aver avuto un pereorso lento, durato molti deeenni, e tutt'altro ehe lineare. Dal raeeonto del De revelatione provengono anehe aleuni dettagli preziosi per eomprendere le reazioni ehe la notizia della imminente eelebrazione della eanonizzazione provoeo a Grandmont. Il conventus dei fratres raeeolti in eapitolo aeeolse la novita eontenuta nella lettera di Clemente III e in quella sede l'autore del testo deeise di affrontare le diffieolta ehe il rieonoseimento della euria romana aveva generato nell'ordine.
Nel De revelatione affiora tuttavia un'ambiguita: il silenzio sui rniraeoli e sulla santita di Stefano degli anni preeedenti, almeno sino al 1160, trova una sua plausibile giustifieazione. Dal raeeonto della fonte si pereepisee ehe i grandmontani non avevano attribuito nel eorso del tempo alla santita di Stefano di Thiers lo stesso valore.
Aneora una volta nel De revelatione si seorge la testimonianza delle perplessita ehe la notizia della deeisione pontifieia di eanonizzare Stefano, elevandolo all'onore degli altari, aveva suseitato presso i fratres raeeolti in eapitolo. Una dupliee reazione, infatti, aveva pervaso gli anirni degli astanti: da un lato essi avevano espresso la loro gioia per il fatto ehe illoro maestro aveva ottenuto il supremo rieonoseimento della Chiesa; dall'altro, tuttavia, l'eeo del disagio provoeato dal rieordo di una duplieita di atteggiamento nei eonfronti della santita di Stefano permaneva ed offuseava la letizia del momento.
Immediatamente dopo la morte di Stefano, infatti, durante il periodo del priorato di Pietro di Limoges (1124-1137), il manifestarsi della santita del maestro attraverso signa et prodigia fu aeeolto dalla eomunita dei Jratres con una certa diffidenza, quasi una aperta ostilita. Il capitolo generale dei jralfu, come raceonta il De reve/atione, aveva chiesto a Gerardo Ithier, ehe appariva fra i maggiori interlocutori della decisione della curia romana, se egli conosceva la durezza con la quale il priore Pietro di Limoges aveva proibito al defunto Stefano di Thiers di manifestare prodigia ac signcfl4. Egli, infatti, preoceupato per la religio e per l' humilitas dei grandmontani, si era mostrato infastidito per il fatto ehe Stefano avesse iniziato a rivelare la sua santita con signa et miramla. I primi priori avevano eoncepito gli eventi prodigiosi eome un ostaeolo alla realizzazione
H Gerardus Iterius, De revelatione beati Stephani (come nota 1), 111, p. 283: Domit1e pater, veslra dism lio novil q11oll!odo el quemadmod11m paler spirilalis domn11s PelniS Lemovicanm prior smmd11s, domino ac vmerabili patri prima bealo Strphano, el q11asi incrrpando ac minando, ct/111 cernerel q11od Dms per merila ipsi11s prodigia ac signa facerel, et/111 m la/iler agerel prohib11il.
Dall'esempio alla santita 191
della via humilitatis et paupertatis, in quanto la curiosita avrebbe sicuramente attirato una moltitudine di uomini ehe avrebbe impedito agli eremiti di vivere la loro scelta religiosa in secreto solitudinis. Il tono del discorso e forterneute polemico. L'artificio retorico della domanda ripetuta Quid est hoc? Quid es! quod agis, pater amatissime? mostrava la preoccupazione di Pietro di Limoges, ehe ammoniva il maestro spiegandogli ehe non era necessario ehe egli si manifestasse in quel modo. Essi non avevano bisogno, infatti, di queste testimonianze per credere alla sua santita (Numquid non credimus sanctitati tuae? Certe credimus. Ut quid vexare nos cupis? Quid tibi et miraculis?): le azioni e le virt:U da lui compiute durante la sua esistenza testimoniavano in modo esaustivo la radicalita dell'esempio ehe la vita di Stefano proponeva, dimostrando al tempo stesso la validita e la ragionevolezza della scelta di porsi alla sua sequela. Quasi con una vena di rimprovero, il priore domandava al maestro di smettere di rivelarsi con signa, altrimenti egli avrebbe dovuto intervenire: i suoi discepoli sarebbero stati costretti a non amarlo e a dimenticarlo, spostando il suo corpo in un luogo umile e disonorevole45.
Il breve intervento raccontato dal De revelatione lascia trasparire tuttavia ehe la linea dura di Pietro di Limoges, non costituiva un episodio isolato, ma ehe si trattava di un atteggiamento ben radicato presso i gruppi dirigenti e presso gli intellettuali della comunita di Grandmont.
Come ha ben delineato Pierre-Andre SIGAL, almeno sino al priorato di Stefano di Liciac (1139-1163), sembrano convivere entro la comunita due atteggiamenti cantrastanti nei confronti della manifestazione di santita: da un lato la tendenza dei Jratres favorevoli allo sviluppo di un culto locale, supportati al tempo stesso anche dal desiderio della popolazione della regione di Limoges entro la quale la venerazione si era diffusa. Dall'altra parte invece i priori, soste
nuti dai gruppi intellettuali e piu colti della religio, si rendevano conto di quale fosse il pericolo dei miracoli e dei prodigi per la tranquillita della vita comunitaria. Gli eventi straordinari e la fama di santita del fondatore avrebbero provo-
ü lbid.: Quid es/ hoc? Quid es/ quod agis, pater amanlissime? Quare vis nos servos sanclilalis luae perpetrando miracu/a lua exc/uden ab hac pauperlalis humililalisque via? Nonm signa ac miracu/a lurbas congregalionesque hominum nquimnl? EI quomodo poterinms pennanen in secrelo so/itudinis, si undique lurbae adveniunl, auditis el visis luis signis elmiraculis luis? Numquid non credi!lJIIS sanclilali luae? Cerle credimus. Ut quid vexare nos cupis? Quid tibi elmiram/is? Desim, desine, cave dico ab eomm pompis, nihil tibi el illis. Desisle, mi domine, a111 si non feceris, cerle 110n diligam le, sed ab islo loco inhonesle omnino excludam le, el proiciam le in aliqum1 /oC/1!11 vilissillJIIIl1 el inhones/J//11.
192 Cristina r\ndenna
' \-'" ~r , .. ,
eato l'arrivo dei pellegrini. In questo senso essi operaron~f per ridurre i signa e per limitare la venerazione delle reliquie46.
La Vita, nella versione edita da Jean BECQUET, sarebbe stata eomposta durante la seeonda meta del seeolo XIIper dare fondamento al testo normativo47.
Essa tuttavia presenta talvolta una profonda rielaborazione delle informazioni, talaltra inveee una eomplessa ripresa e riproposizione di materiale piu antieo. Emergono infatti aneora, e a piu riprese, l'intenzione e la volonra da parte dei priori di eostringere al silenzio sui miraeoli: la santita doveva rimanere eireoseritta fra le mura della domus ed entro i eonfmi dell'eremo. I priori temevano ehe l'afflusso di pellegrini, eonnesso al verifiearsi di segni prodigiosi, avrebbe eomportato un tradimento rispetto agli insegnamenti del maestro, un abbandono della paupertatis via e della solitudine, distruggendo sia la poverta, a eausa dell'afflusso di elemosine, sia l'umilta predieata e mostrata eon l'esempio da Stefano di Thiers e posta a fondamento della sua seelta di vita e di quella della eomunita.
Per questo motivo in uno dei eapitoli eonclusivi della Vita, prima della sezione dei miraeoli, ehe sembra inveee essere un'aggiunta sueeess~va eome appare dall'E.xp/üit, emerge un raeeonto signifieativo: ad un paralitieo, ehe aveva rieevuto per intereessione di Stefano la eapaeita di eamminare, il priore aveva espressamente domandato il silenzio su eio ehe era avvenuto48• Nel eapitolo eonclusivo della Vita (E.xplici~, l'agiografo, diehiarando ehe la fede pura e la vera earita amano le apere piu ehe i segni, proponeva ai lettori di seguire 1' exemplum edifieante della vita di Stefano. 11 suo testo avrebbe taeiuto pertanto i molti miracula, di eui egli aveva avuto notizia49 . 11 motivo della seelta da parte
46 P. A SIGAL, Les miracles de saint E tienne de Muret (t 1124) au XII• siede, in: G. D URAND / J. NOUGARET (come nota 10), pp. 43-50, in particolare pp. 47 s.; inoltre lo stesso autore fornisce interessanti informazioni sull 'importanza presso i medievali di fondarsi sulla tradizionc orale cfr. ID., Le travail des hagiographes aux XI• et XII• siccles: sources d'information et methodes de redaction, in: Francia 15 (1987), pp. 142-182. 47 Vita venerabilis viri Stephani Muretensis auctore Stephano de Liciaco, seu alio coaevo redacta, in: Scriptores ordinis grandimontensis (come nota 1), pp. 101-137. Per Ia datazione M. M. WILKINSON, La vie dans le monde d'Etienne de Muret (come nota 10), pp. 23-42; cfr. anche nota 22. 48 Vita venerabilis viri Stephani Muretensis (come nota 47), XLII, pp. 129 s.: Inmpavil aule/11 prior el 111 nec ipse nec alii qui Cllfl/ eo eranl boc dicerenl, vebemenler probibuil. 49 Ibid., XLIII, p. 131: E'l,o quia purajides el cmilas vera IIIagis amanl opem quam signa, lacea/111/S 11111fla miracula quae, dum adbuc viverel, ab ipso audivimm el legimus Juisse facla, el colidie in promralione omni11111 noslromm sine possessionib11s, pec11dibus ac redrli1ib11s Deo cooperanle, jieri videmus. Seqlla/111/r aulem ipmm per oslens11m nobis sanctae conversalionis exemplum. Questa indicazione concorda anche con quanto affermato nel Prologus, p. 104: De bis lall/eil quae in miram/i el dignoscendis Jratribus cogitafioniblls per C/1111
Dall'esempio alla santita 193
dell'autore era spiegato eon il fatto ehe l'esclusione di una eireolazione di informazioni sui signa ac prodigia sembrava aver preservato Ia religio, almeno sino a quel momento, da ogni evoluzione, garantendole di eonservare !'ideale delle origini di una vita senza proprieta, senza redditi e senza animali. Per questo motivo il priore, eon tono duro, rivolgendosi a Stefano eome se egli fosse stato un uomo aneora vivo, gli ehiedeva di porre termine alle manifestazioni prodigiose; in easo eontrario, proprio sulla base dell'obbedienza ehe egli aveva personalmente promesso al suo maestro, avrebbe estratto le sue ossa da! sepolcro e le avrebbe gettate nel fiumeso.
Lo stesso atteggiamento sembrerebbe emergere aneora durante il priorato di Stefano di Lieiae, quando un mi/es, eolpito da una malattia ineurabile era giunto a Grandmont sperando di poter essere guarito51 . I! priore lo aveva aeeolto a male parole dieendo ehe in quel luogo non vi erano mediei e ehe presso quella eomunita egli non avrebbe trovato un rimedio alle pene eorporali52. Inoltre poiehe i resti mortali di Stefano di Thiers non potevano essere visti, lo aveva invitato a reearsi presso le reliquie di un altro santo, Ia eui fama di miraeoli e guarigioni fosse stata superiore. Rivolto al beato Stefano, quasi fosse vivo, il priore Stefano di Lieiae lo aveva inoltre minaeeiato e, seguendo quasi alla lettera le parole gia pronuneiate da un suo predeeessore, gli disse ehe, se avesse osato eontinuare a manifestare miracula, avrebbe estratto le sue ossa e le avrebbe gettate nel fiume. I! priore tuttavia aveva rassieurato e eonfortato il mi/es, garantendogli ehe i fratres avrebbero pregato per lui, perehe Dio gli eoneedesse eio ehe riteneva neeessario53. Ma l'insistenza del mi/es e dei Jratres, ehe sembravano es-
Dotni11us operari digna/us es/, pauco dicluri SIIIIIIIS, 11e forte incredulis verilas mwdacium esse videalm; e/ creduli ex paucis qm audierinf dimnf quia 011111ia possibilia SIII/I credwti.
so Ibid., XLIII, pp. 130 s.: Quae IIJiracula prior inluens, li!llltil sibi el a/iis quielei!JIIIillui el inlernae suavilalis dulcedimm lardius experiri si populomm lurbae miraculomm cousa lamm ad quem vemranl frequenlarenl. [ . . .] Cave igitur de celero ea miracula facias quae luam extollanl sanclilalem el noslmlll deslmanf lmmilitalem. [ . .] Quod si aliler jeceJis, dici11111S tibi el per oboedimtiam quam tibi promisimus conslanler asserimus quia ossa lua inde ex trahemus ef spargemus in ßumen. Le esortazioni a mantenere il silenzio sulla santita di Stefano sono espresse anche in altri miracoli e testimonianze, cfr. per questo i1 piu approfondito studio di P. A. SIGAL, Les miracles de saint Etienne de Muret (come nota 46), in particolare pp. 43-47. 51 La tcsi ehe durantC il periodo del priorato di Stefano di Liciac si sia mantenuto un rigido riserbo sui miracoli e Ia santita di Stefano di Thiers c pure sostenuta da P. r\. SIGAL, Les miracles de saint Etienne de tvluret (come nota 46), p. 47. 52 Vita venerabilis viri Stephani Muretensis (come nota 47), XLVI, p. 134: Frater, I/OS 11011 SIII!IIIS
medici, 11ec nobis nec aliis aliquid medicinae corpomlis ronsuevimus ex hibere remedium.
;J Ibid.: Prior milem limms sibi e/ aliis Jratribus quielml mi1111i el inlemae suavilalis du/cedinm1 lardius experiri, si populom111 lurbae miramlomm cousa lamm illum saepius frequent arm/, utpote qui saepius mm bealo viro quasi C/ltn vivo loquens homine, mper miraculis quae Jaciebal dmius increpaveraf, mini/ans ossa eius i11de
"· '>l .. ....
194 Cristina Andenna
'V"-'._:
sere eonsenzienti al rivelarsi della santita di Stefano, eonvin~~ inflne il priore ad aeeonsentire a ehe egli si prostrasse eon l'atteggiamento del penitente sulla tomba del santo per rieevere da lui l'attesa guarigione54.
Le fonti prodotte prima del rieonoseimento della santita di Stefano rivelano tutte una unanime intenzione di mantenere il silenzio sulla santita del maestro per non ineorrere in un tradimento nei eonfronti dei fondamenti della seelta religiosa di Grandmont, eoineidenti eon l'ideale proposto da Stefano di Thiers a Muret: la seelta dell'assoluta poverta e dell'umilra.
Religionis praeterea ornamentum, sicut a magistro suo et domino beato S tephano didicerat" et verbo et exemplo multum benigne gerebat. le parole,
l'esempio, l'insegnamento e la sequela
Almeno al momento delle origini, l'exemplum della rigida e austera seque/a Chnsti di Stefano appariva eome il fondamento della seelta religiosa della eomunira raeeoltasi attorno a lui a Muret. La sua santita non era posta in dubbio: i diseepoli ehe eon lui avevano vissuto sapevano ehe egli era santo, ma la venerazione si tradueeva in un eulto interno alla eomunita destinato solamente ai seguaei, ehe sul suo esempio eonformavano la loro vita. Nel periodo immediatamente sueeessivo alla sua morte, l'elemento di identita del gruppo era l'ideale apostolieo di una vita umile, eondotta in assoluta poverta e nel segreto della solitudine, di eui sieuramente la flgura e l'esempio di Stefano di Thiers rappresentavano un modello, ma non il solo. I diseepoli piu stretti, fra i quali Ugo di Laeerta, un anziano mi/es eonvertito, ehe dopo aver abbandonato il mondo lo aveva seguito55, e Pietro di Limoges, eolui ehe sarebbe stato seelto eome suo sueeessore, avevano imposto a Grandmontun simile paradigma56.
exlrabi e/ in ßumm proici, nisi cessarel a miraculis, dixil ad lnililelll: 'Frale1; beali vi1i S tepbani ossa vix auf nu111quam ab aliquo posmnl vidni; sed vade ad alios sanclos ad quomm memorias miracula crebemme jiunl, el nos/ibm/er orabimus pro le ul Dominus tribual quod tibi necessarium esse cognove1il~
5-l Ibid., XLVI, pp. 134 s. 55 Guillelmus de Dandina dicto de sancto Sabino, Vita beati 1-lugonis de Lacerta redacta temporc prioris Petri Bernardi a. 1163-1170, in: Scriptores ordinis grandimontensis (come nota 1), pp. 165-212, in particolare emblematico e guanto si dice a proposito della conversione di Ugo di Lacerta, XIV, p. 175: Pervmiens vero ad /oC/1111, l111111ilis docilisque ad palrem e/ magislmm conlinuo accessil discipulus, ul sancla religionis Jomta doclrinaque emdirelm;· el eius, ul voluil, desideriu111 complelus est, e ibid., XV, pp. 175 s.: Smceptus ilaque e/ fac/us discipulus, el religiosomm paupemm Christi nll!lltro socia/us intra congregaliomm, mox C/111/ Dei mvis conversmi elvivere coepil sectmdum pauper/alis volu111, ef modui!J regulam sub illo lanlo patre conslilulam. 56 Ibid., XXXI, pp. 186 s.
Dall'esempio alla santita 195
Ma quale era in pratica il modello cli comportamento? Seguiamo Je fonti interne all'ordine: il testo piu antico sembrerebbe essere, per Ia sua struttura narrativa, il Liber de doctrina, attribuito a Ugo cli Lacerta. In questo senso potrebbe essere collocabile entro il 1157, data della morte cli Ugo. Non siamo tuttavia in grado cli aggiungere particolari circa Ia datazione della fonte, per il fatto ehe Ia versione eclita da Jean BECQUET e tratta dallo Specu/um Grandimanfis 51 e da altri manoscritti contemporanei allo Specu/um5B. In origine Ia traclizione orale e il ricordo ancora vivo nella mente dei primi cliscepoli sembravano essere sufficiente garanzia per mantenere unita Ia vita della comunita raccolta a Muret e poi a Grandmont. Cio ehe emerge da! Liber de doctn'na e una climensione essenzialmente cristocentrica, alimentata pero anche da Jetture dell'Antico Testamente, dei Padri della Chiesa, cli Gregorio Magno e della traclizione orientale: nel testo Ia figura cli Stefano cli Thiers non e mai proposta come modello. II punto cli partenza per Ia scelta cli vita eremitica non era Ia sequela cli una regola o cli un modello, ma Ia risposta affermativa all'invito cristiano: Qui vu/t venire post me, to//at m1cem suam et sequatur me59.
Con Ia stessa raclicalita Stefano, eremita penitente6o, insecliatosi alle soglie del secolo XII presso un nemoromm montem nella regione dell'Aquitania fra Muret e
57 Lo Spec11111111 Grandi!ltofllis e un manoscritto in scrittura gotica del secolo XIII contcnente il co1p11s completo degli scritti relativi alla celebrazione della religio Grandimonlensis; J. BECQUET, Les premicrs ccrivains de !'ordre (comc nota 12), in particolare pp. 249-253. 58 Libcr de doctrina velliber sententiarum scu rationum beati viri Stephani primi patris religionis Grandimontis ab 1-lugone dc Laccrta et socü eius collectus antc annum 1157, in: Scriptores ordinis grandimontensis (come nota 1), pp. 1-62. Nel M.oniiii!H all'edizione (p. 2), Jean BECQUET avverte ehe il Prologo, Ia prima parte e Ia conclusione, hanno una tradizionc a sc rispetto al rcsto delle scntenzc. Esse potrebbero cssere state compostc da Gerardo I thier, poichc sono gli stessi brani ehe il settimo priore nelle due Explonolio aveva commentato. Sulla datazione delle opere rimando alla nota 47 e soprattutto a J. BECQUET, Les premicrs ccrivains de !'ordre (come nota 12), pp. 258-260.
59 Liber de doctrina vel libcr sententiarum (come nota 58), p. 6. Sulla radicalitit dclla scclta evangelica di Stefano cfr. G. MELVILLE, 'In solitudine ac paupertatc' (come nota 10), pp. 7-30. 60 Tra Ia fine dcl secolo XI e gli inizi del sccolo XII si diffonde in Francia un nuovo modello di cremitismo definito da Andre V AUCI-IEZ eremitismo penitenzialc; A Vi\I.CCI-IEZ, La spiritualite du Moycn Age occidental, Paris 1975, ora trad. it.: La spiritualira dcll'occidente mediocvale (Cultura e storia 1), Milano 1978, pp. 102 s.: "gli ercmiti nel secolo XII sono dei pcnitenti, illoro vestiario consunto, Ia loro apparenza trasandata e Ia loro spiritualita ne porta il segno. Gli eremiti in realta cercano luoghi sinistri, dormendo per terra nelle grotte o costrucndosi delle capanne di frasche . Si nutrono di lcgumi e di prodotti dcl raccolto, mai di carne e di vino. Vivono soli e non sono aiutati da nessuno, per questo motivo dcvono raddoppiare Ia vigilanza di fronte alle tentazioni del demonio. Cosi, nonostante l'ascetismo al quale si condannano, essi conducono una vita attiva, e non puramente contemplativa, come i reclusi e le recluse ehe vivono in celle adiacenti ai monasteri. Per necessita c per vocazione devono lavorare con le loro mani, portano Ia barba e si spostano a piedi e con un asino".
196 Cristina I\ndenna
1\~·:.•;
Limoges61, esortava eoloro ehe, seguito il suo esempio, avevano deeiso di eondividere Ia seelta di vita defmita eon il termine latino dücipliflc/'2 . La seelta della eroee, un motivo non seonoseiuto alla tradizione dei Padri, imponeva infatti seeondo l'eremita limusino una eonversione totale, poiehe, se si guarda Ia eroee e si segue il suo esempio, e molto diffieile perseverare nella strada intrapresa (Aspice cmcem, multum es! difficile ibi mamre). Aeeogliere una tale seelta di vita signifieava infatti perdere se stessi, il dominio sui propri oeehi, sulla propria boeea e sulle proprie membra, ma al tempo stesso abbandonare anehe il monda. Seegliere per Ia vita ch1istiana era per Stefano di Thiers abbraeeiare una eonversione radieale in ogni aspetto dell'esistenza, una rottura eon il mondo, eompresi i familiari, per garantire una dedizione integrale dell'animo a Dio63. Nelle parole del Liber de doctrifla la presentazione della vita eremitiea eondotta a Muret esprimeva una dura eritiea nei eonfronti delle altre espressioni di vita religiosa: il nuovo venuto doveva infatti sapere ehe avrebbe potuto ritomare nei monasteri ubi magt1a iflve!lietls aedificia, cibosque delicatos. Insomma in essi le rieehezze, eostituite da terre e bestiame, nell'eremo Ia poverta, eontrassegnata dalla seelta della eroee: Illic bestias n:pe1ies /errarumque /atitudimm, hic latltum cmcem et paupertatmf:A.
61 Vita venerabilis viri Stephani Muretensis (come nota 47), XI e XII, pp. 111 s.
62 Liber de doctrina velliber sententiarum (come nota 58), I, p. 6: Siml Iems Chtis/1/s ail in euangelio: 'Q11i v11ll uenire poslme, tollal cmcm1 s11am el seq11alllr me ', simili/er paslor nos/er eis dicebat q11os in disciplina ma rrcipiebat. 63 lbid.: Fralet; q11omodo poteris on11s mslinerr q11od tibi uis imponm? Aspice cmcem, 111111111!11 es/ dijficile ibi 1/Janet~. Si Iiiie aduenetis, in ea conjigetis, el amilies dominalionem q11ai!J habes in lemelipso, in omlis el in 01~ ac in celeris membtis. i\1andllcandi, ieimtandi, dormiendi ac uigilandi l11am relinq11es uolmtlalem, !1111llammq11e remm aliamm; el hoc q11od in saemlo diligis conlingettibi odio haben. Exinde non rruerleris ad dol!l//111 cognalomi/J l11omm, el si ipsi ad le ueneri111, neq11aq11am eis pa11pertalm1 II/am osle11des. Poletisne, fra/er, fossor esse, ligna el jilllll/11 portan, Cllnclisqm jratrib11s servit~? Hoc lori11m esse/ farile, sed cap111s tali carcerr manebis, 11bi 110n es/ Joramett, per q11od ad saeml11m rruerlaris, nisi 111 ipse feceris; el ego l11i mram 11011 agam, 11ec lemetipm111 agm sinam, a saec11lo q11ippe meos abscidi pedes; el si propter me non rrdeo, propter le non rrdibo. Adh11c ali11d S1rpetj11erit: forsilan millerem le in aliq11od nemomm el an notwill q11ai!J manib11s fll/11 ligneo ligone laborando acq11isieritis, ego accipenm, el eis q11i me hic mstodi11nl trib11erem. Ali11d uero restat honibili11s; cmllrpliciter tibi meli11s es/ damnari in saec11lo, q11a!11 hic; q11i mim ab altiori cadit, ampli11s laedit11r; el si hinc in itifen111111 caderes, 011111ib11J aliis perditis itiferior esses. T11 uetv peTJ,m potes ad q11odlibet monasleriomm, 11bi magna invenies aedijicia, cibosq11e delicalos mis temporib11s conslillllos. Illic bestias reperies le"ammq11e latil11dinem, hic lan/11!11 cmcem el pmrperlalem. Le stesse affermazioni, ma inserite nel contesto narrativo della conversione di Ugo di Lacerta e al suo dialogo con Stephano di Thiers, si trovano anche in Guillelmus de Dandina, Vita beati 1-Iugonis de Lacerta (come nota 55), pp. 165-212, XIII, pp. 172 s.
6-l Liber de doctrina velliber sententiamm (come nota 58), I , p. 6. I grandmontani, come anche il Liber dc doctrina (p. 61) ha modo di ribadire, dovevano essere in hemno lamq11am mort11i el abiecli a 1111111do. Sull'idea di povertit nel secolo XII cfr. 1-1. GRUNDMANN, Religiöse Bewegungen im Mittelalter. Untersuchungen über die geschichtlichen Z usammenhänge zwischen der Ketzerei, den Bettelorden und der religiösen Frauenbewegung im 12. und 13. Jahrhundert und über die
Dall'csempio alla santita 197
Si trattava dei contenuti fondamentali della scelta intrapresa da Stefano di Thiers: chiunque avesse voluto seguirlo avrebbe pertanto dovuto rinunciare a quanto un tradizionale ingresso in monastero avrebbe comportato, la comodita di vita, intesa come stabilita e dimora negli edifici, la sicurezza del cibo e un normale sostentamento garantito dal possesso delle terre e dalla loro messa a coltura, nonehe dall'allevamento del bestiame. Crux et paupertas erano invece i termini chiave della esperienza religiosa di Stefano di Thiers, ehe egli non mancava di ricordare a coloro ehe decidevano di condividere con lui un'esistenza lontano dal mondo.
La scelta religiosa era grazia, giustizia e custodia: per questo motivo parole e azioni dovevano necessariamente essere manifestazione della presenza divina65. Inoltre le indicazioni contenute nel Uber de doctrina sembrano essere nuclei di sentenze, pai:ole rivelate da Stefano di Thiers con il preciso intento di istruire (docere): si trattava di richiami morali, indicazioni di comportamento e piu in generale di spiegazioni e domande dei discepoli. L'obiettivo era dunque quello di preparare ad una vita religiosa piu perfetta. Il vir religiosus avrebbe dovuto circumspectus atque sollicitus, irnparare a parlare, in modo tale ehe tutto cio ehe avrebbe detto corrispondesse sempre al vero. Inoltre egli avrebbe dovuto camminare con un atteggiamento onesto e senza strepito, sedere in modo urnile e raccolto, lavarare senza lamentarsi. In caso di concupiscenza, lo sguardo
geschichtlichen Grundlagen der Deutschen Mystik, Berlin 1935, ora trad. it.: Movimenti religiosi nel Mediocvo. Ricerche sui nessi storici tra l'eresia, gli ordini mendicanti e il movimcnto religioso femminilc nel XII e XIII secolo e sulle origini storiche della mistica tcdesca, Bologna 197 4. Sul concetto di poverta presso gli eretici del secolo XII C. THOUZELLIER, Heresie et pauvrete a Ia fin du XII< et au debut du XIII< siede, in: M. MOLLAT (a cura di), Etudes sur l'Histoire de Ia pauvrete, 2 voll., Parigi 1974, vol. 1, pp. 347-387; K.-V. SELGE, Die Armut in den nichtrechtgläubigen religiösen Bewegungen des 12. Jahrhunderts, in: La poverta del secolo XII e Franccsco d'Assisi. Atti del li Convegno internazianale (Assisi, 17-19 ottobre 1974), Assisi 1975, pp. 179-216; C. VIOLANTE, La poverta neUe eresie del sccolo XI in Occidentc, in: 0. CAPITANI (a cura di), La concezione della povcrtil ncl Mcdiocvo, Bologna 51986, S. 193-255; E. WERNER, Povertil e richczza neUe concezioni degli eretici della chiesa orientale e occidcntale dei secoli X-XII, in: ibid., pp. 301-355; K. J. RIVINIUS, Zwischen Häresie und Orthodoxie. Die Armutsbewegungen des Mittelalters am Beispiel der Waldenser und der Franziskaner, Schwerte 1990; La conversione alla poverta nei secoli XII -XIV. Atti dcl XVII convegno storico internazionale. (Todi, 14-17 ottobre 1990), Spoleto 1991; M. P. ALBERZONI I A. AMBROSIONI I A LUC IONI (a cura di), Sulle tracce degli Umiliati, Milano 1997. Sul concetto radicale di poverta evangelica inteso da Stefano di Thiers cfr. L. GENICOT, Presentation de Saint-Etienne de Muret et de sa pauvrete, in: Revue Nouvelle 19 (1954), pp. 578-589; L. PALMA, La poverta neU'ordo di Grandmont, in: Aevum 48 (1974), pp. 279-287; C. PELLISTRANDI, La pauvrete dans Ia regle de Grandmont, in: M. MOLLAT (a cura di), Etudes sur l'Histoire de Ia pauvrete (come sopra), vol. 1, pp. 229-245; G. MELVILLE, 'In solitudine ac paupertate' (come nota 10), pp. 7-30. 65 Liber de doctrina velliber sentcntiarum (come nota 58), I, p. 7: Ideoq11e vir religioms in 0/111/C q11od loq11if11r ef operat11r, deberef Dei meditari praesmtiam qtti semper C/1111 infllefllr.
198 Cristina r\ndcnna
'\'"-'.:
avrebbe dovuto sempre essere clistolto, per non eader~ in tentazione66. Sarebbe inoltre stato neeessario ehe il cliseepolo si eomportasse in modo tale da non clivenire un eattivo esempio, tale per eui sarebbe stato cli seandalo per altri. La climensione religiosa imponeva inoltre neeessariamente un mutamento nei gesti del eorpo: l'aspetto esteriore era infatti il primo modo per mostrare una compositio inferiore. Colui ehe nei düta e nei Jacta era aneora legato alla climensione seeolare, eome avrebbe potuto essere religiosus nei pensieri? Sarebbe stato infatti piu sempliee eontrollare Ia propria espressione eorporea, piuttosto ehe i propri pensieri67. L'attenzione all'inclividuo e alla sua conversio, eome totale allontanamento dal mondo, si esprime nel Uber de doctrina attraverso la eonereta pratiea della vita eremitiea, in perfetta obbeclienza al magister. In essa appare eentrale Ia preoeeupazione cli realizzare una eomunidt ispirata all'ideale apostolieo nella quale tutti i membri avrebbero dovuto vivere cor unum et anima una68•
La sequela eostante cli un maestro, cli una guida spirituale, cliveniva allora il tramite e il fondamento basilare della seelta cli vita operata da eoloro ehe seeglievano cli operare in quella religio. Era neeessario tuttavia ehe eostoro sappessero eonformarsi perfettamente all'immagine del maestro e in questo, abbandonando se stessi (meipsum dedz~ meus 11011 sum. Si mecum vis dimicare, vade ad pastorem meum cuius sum et ipse tibi respo11debif)69, si eonformassero eompletamente ai suoi eonsigli.
Eppure, affmehe potessero imitare il maestro eon una disponibilita totale, era neeessario ehe essi rieonoseessero ehe la prima via attraverso Ia quale Dio si
66 Ibid.: EI qui lantopere speclalm; va/de sibi necessmium es/ 111 sil cirmmspeclus alque sollicitus, debetque discere loqui, ambulare, sedere, aspicere, operari, Deumqm deprecmi, alque omnia alia Jacere aliter qua/// in saemlo jaciebal. Loqui discal hoc modo, qualemts in sm11o11e mo Iaie relenlamlum jacialul semper quod dixeril, vemm esse possil; quodmmque eJiim verbll!ll aul SeJ/IeJIIiam vir religiosus dical, nisi sil Ji7tclus co1poris vel animae sibi alleri, seculanlas es/. Ire debel honesie ac sine slrepitu, sedere humiliter alque co/leclus, Iaborare sine mummre at' moderate. Gt!ll aliquid conmpiscibile aspexeril, oculos in carcere leneal, 11e eos ibi dljigal, sed vim111 avntal. Quando Dominus 1vgabit, 111111111111111 11011 facial, Deus enim vocm1 cordis exaudit; qui vero sie ora/11/ aliis noceal, ab oralione can'tale/11 excludil, quam ibi Dms amplius diligil.
67 Ibid.: In omnibus /;is alqm in celeris oporelel 111 Jratribus, mm quibus es/, caveal 111! pravmtm exemplum oslendal, unde in ipsll/11 scandalizmlur. Quisquis aulm1 JJOII mulal geslus co1poris, C/1111 ad religionem adveneril, 11011 es/ simile quod habi/11111 im111111el animae, sed semper eius ani11111m in saemli vanilale esse. Exterior mim composilio inlniorem oslendit aliquando, el qui saecularis es/ in diclis el actibus, quomodo religiosos eril in mis cogilalionisbus? FaciliiiS enim valel aliquis ad libilll/11 suum membra CO/poris relinere qua111 cogilalionem. 68 r\ct 4, 32-35, ma anche 2, 44-47: A1ulliludinis credentium eral cor unum el anima una; mc quisquam eomm, quae possidebal, aliquid S/111111 esse dicebal, sed eranl i/lis omnia cot111111111ia [. . .]. Neque enim q11isq11at11 egens eml inter i/los; q11olq11ol enim possessores agrvm111 aul domom111 eranl vendenles adferebanl pretia eomm quae vmdebanl el pombanl anle pedes apostolomm; dividebalur aulem singulis p1v111 cuique opus eral. 69 Liber dc doctrina velliber scntentiarum (come nota 58) , VI , p. 9.
Dall'escmpio alla santita 199
manifesta all'uomo era la coscienza del suo essere ignorante70, il riconoscimento dell'umilta e della insufficienza della condizione umana e dell'essere peccatore71.
Si trattava allora di un radicale capovolgimento non solo del normale modo di pensare, ma anche del tradizionale modo di concepire la dimensione religiosa e la conversio: chi voleva seguire Cristo, doveva disprezzare e abbandonare i sensi, ritrovando se stesso72. Inoltre coloro ehe sceglievano di vivere la dimensione religiosa dovevano spogliarsi del proprio essere corporeo e materiale. In cio avrebbero dovuto certamente essere aiutati dal costante insegnamento e dal continuo esempio del pastore e dei confratelli ehe gia da tempo vivevano nella comunita. In questo senso come il novizio era ancora pienamente intriso della dimensione di una vita secolare, allo stesso modo i jralf-es avrebbero dovuto difendere ratiocinando la loro scelta religiosa e questo anche attraverso le parole e l'esempio concreto delle apere (verbis et operibus docea~73 .
Dio avrebbe attribuito all'uomo religioso il necessario per poter sopravvivere74, sia attraverso il controllo delle proprie membra e del proprio corpo, come prima tramite per un dominio sull'anima e sui pensieri, sia attraverso il sostegno della comunita. L'uomo religioso avrebbe dovuto perseverare nella sua devozione a Dio e nella ricerca del raggiungimento della contemplazione75. Inoltre la correzione ex caritate sarebbe stata un utile strumento di richiamo e di crescita reciproca. Tuttavia se colui ehe era stato corretto avesse reagito con ira e non avesse saputo redimersi, colui ehe aveva tentato di condurlo al pentimento avrebbe dovuto accusare se stesso di non essere intervenuto nel giusto modo. La comunita avrebbe dovuto costituire un richiamo costante e continuo a mantenersi nella rettitudine non solo delle azioni, ma anche dei pensieri.
70 lbid., IX, pp. 12 s. 71 lbid., VIII , p. 11 : N11l!t1S mim sm 11o vel scrpt11ra sie hominem Deo facit proxi11111111, q11emadmod11m mom111 cognitio peccafomm, mide ipsi11s posf11fanfnr auxilit1111. Nihilq11e Deo acceptabilius esf in viro iusfo a quo valde diligitur, quam C/1111 iusfi/J nihi/ in se reperit quod Dms placeaf, nisi quod Deus in ipso opera/ur.
72
73
lbid., IX, p. 12.
lbid., IX, p. 13.
7~ lbid., X, p. 14: Qui magis Dmm diligit sapientior esf atqm religiosior, sed in nu/Ja re fanfa scimtia necessaria esf homini, quanfa ad serviendmn Deo mtionabiliter. Dominus aufem tradit jideli mo suppellectilia ef utmsilia OlllOri mo necessaria, sicufri dives aliquis mam 1111111if domu111 omamentis sibi convmimtibus. In nullo quoque fam delinquit vir religioms q11am in hoc, quia minime intellegit q11ae sint 11fmsilia a Deo sibi commissa ad su11m serviti11m peragendum; nam ideao quia no11 cognoscit ea incipit aliquando operari C/1111 snppellectili neq11aquam a Deo sibi tradita, jatigatusq11e continuo postmodum illam verecmrde demit, quando praemmif virtufem nondum sibi attributam , praefenlliffms a/iam in qua Dms vellet uf ipse exercmf11r.
75 lbid., X, pp. 14 s.
200 Cristina Andenna
I "f<·
La tradizionale dialettica esistente circa Ia superiorita''dei ruoli di Marta e Maria, fra Ia vita attiva e Ia vita contemplativa, trovava nella nuova dimensione religiosa una soluzione di compromesso76. Per timore della pena era infatti giusto occuparsi della buone opere, quali l'elemosina, secondo l'esempio di Marta. Tuttavia se si doveva considerare cosa fosse il meglio. Allorale sentenze rivelavano ehe Ia condizione piu opportuna non era il fare, ma il ricevere l'elemosina. Condizione, questa, ehe preparava al dono totale di se a Dio per potersi dedicare interamente alla contemplazione, come Maria, assisa ai piedi di Cristo77•
Dalla fonte emerge un interesse profondo al singolo soggetto: l'individuo ehe compie una scelta religiosa deve essere aiutato nella propria formazione interiore attraverso un percorso educazione. La vita religiosa infatti si pone come obiettivo ultimo il raggiungimento di una vita perfectionis, ehe coinvolge necessariamente il singolo e lo costringe, da solo, in quanto tale, con Ia sua anirna a Stare di fronte a Dio. Solo nel profondo dell'anirno l'uomo coglie se, ma nel cogliere se stesso individua cio di cui egli e fatto: Dio, del quale e creato ad immagine e somiglianza. La scoperta del se, allora, per l'uomo medievale e concepibile solo come percorso e strumento per conoscere Dio. La scoperta del seipsum procede per l'individuo come scoperta in se stesso della particolarita della natura umana, creata ad irnmagine di Dio. La scoperta del se procede pertanto attraverso Dio, ed ha come obiettivo ultimo Dio7B.
Tuttavia l'individuo necessita di una formazione interiore per campiere questo percorso. Si tratta allora di un passo ulteriore: dalla intuizione e necessario procedere alla strutturazione e alla legittimazione di cio al quale si tende. L'abitare entro le mura di chiostro, in una comunita, facilita questo percorso attraverso Ia sottomissione e lo sforzo di una graduale, ma volontaria, costri-
76 Sul ruolo di Marta e Maria, vita attiva e vita contemplativa, si veda G . CONSTABLE, Thc Interpretation of Mary and Martha, in: ID., Thrce Studies in Medieval Religious and Social Thought, Cambridge 1995, pp. 1-142. 77 Liber de doctrina velliber sententiarum (come nota 58), XXXV, p. 23: Prima q11oq11e via q11a ad Dmm perg,itllr es! poe11ae formido, c11m i11 lallfilm aliq11is Domi1111s pertimeseit q11od i1ljemi timore ma/11111 agere deseril; q11od bo!/11111 es/. Nemo vero debet i11 hoc desidia remamre. Me/i11s es/ mim Dm111 diligere ac bo11a opera facere amore i11slitiae, q11emadmod11111 lvfartha faciebat, q11ae lem Cbris/11111 hospitaballlr el promrabal propter amom11 q11e111 illi deferebat, ma anche XXXVI, p. 23 . 78 C. W. BYNUM, Did the Twelfth Century Discover the Individual?, in: Journal of Ecclesiastical History 31 (1980), pp. 1-17, ora ampliato e aggiornato in ID., Jcsus as Mother. Studies in the Spirituality of the High Middle Ages, Berkclcy/Los Angeles/London 1982, pp. 82-109, in particolare p. 87.
Dall'esempio alla santita 201
zione ad una vita rigidamente regolata in ogni aspetto dell'esistenza79. Adesione ed integrazione ad una comunita e alla sua disciplina, se da un lato sono lo strumento verso una progressiva istituzionalizzazione dell'individuo, dall'altro sono tuttavia una delle possibilita attraverso le quali il soggetto conosce il costitutivo del se, Ia propria anima, il seipsum 0 homo interiotll0 . La sfera dell'io, il campo del soggettivo, mantengono un proprio margine di autonomia, nonostante ehe ogni aspetto della vita del monaco sia regolato da rigide norme ehe ne scandiscono interamente l'esistenza quotidiana.
L'andamento narrativo con il quale furono redatte le sentenze raccolte nel uber de doctrina testimonia il chiaro intento di voler proporre delle linee direttrici sullo stile di vita e i principi ispiratori della comunira creatasi attorno all'esempio di Stefano di Thiers. In quale momento ebbe inizio il superamento
7? Sonderforschungsbereich 537 "Institutionalität und Geschichtlichkeit". Ein Informationsbroschüre, Dresden 1997, p. 65 (Programm des Teilprojektes C "Institutionelle Strukturen mittelalterlicher Orden"): "Keine andere Lebensform strebt so stringent eine 'totale lnstitutionalisierung' an wie die vita religiosa, und keine andere erreicht dieses Ziel auch in so hohem Maße. Es geht ihr immer um eine absolute Entsprechung zwischen spirituellen Leitideen und einem gemeinschaftlich geführten Leben, dessen Normen die freiwillige Einbringung des ganzes Menschen verlangen. Ein Religiose zu werden heißt, mit den Koordinaten der bisherigen weltlichen Existenz zu brechen und sich unter Vollzug einer couversio cordis in gänzlich neue Lebensmodelle einzuformen. Vita religiosa bedeutet, nicht mehr hinterfragbare Grundwerte radikal in lebenspraktisches Verhalten umzusetzen und sich einer Organisation vollständig unterwerfen, die das Leben in allen affektiven, emotiven, intellektuellen, körperlichen, wirtschaftlichen Bereichen, im Tagesablauf, in den Wohnverhältnissen, in der Nahrung und Kleidung etc. präzis, detailliert und vor allem unabdingbar regelt. Eine solche Lebensform muß - zumal dann, wenn sie in der Vielzahl von Einzelklöstern eines Ordens gemeinsam verwirklicht werden soll - sowohl eine unilas que iuterius seTJJauda es! iu cordibus wie auch eine unijotmitas exterius seTJJafa iu 11101ibus verwirklichen, muß die dauerhafte Sicherung einer einheitlichen Gesinnung wie eines uniformen Verhaltens zu erreichen suchen." 80 E necessario tuttavia tener presente ehe l'a ttenzione al singolo in eta medievale si esprime in modo completamente differente rispetto al mondo moderno. II termine Individuu111 non offrc alcun riferimento alla dimensione piu profonda del soggetto, concepita come individualitil originale e irripetibile. II concetto di lndividuu111 deriva semanticamente da! termine iudividualis, tipico del linguaggio della dialettica e della speculazione logica e ftlosofica. Si tratta pertanto di un concetto neppure lontanamente paragonabile a quello moderno di individualitil e di personalita, alla base del quale e implicita non solo Ia scoperta del se, ma un approfondimento continuo, progressivo e sopratnltto illimitato dell'io nella sua coscienza, come autocoscienza, ehe scopre se, come soggetto assolutamente unico, originale ed irripetibile. In proposito si veda 1-1. GRUND~Ii\NN, Religiöse Bewegungen im Mittelalter (come nota 64); M. D. CHENU, La Theologie au douzicme siede, Parigi 1957, ora trad. it.: La tcologia nel dodicesimo secolo, Milano 1986; M. 1-1. VICAIRE, L'imitation des apötres, Parigi 1963; M. D. CI-IENU, L'eveil de Ia conscience dans Ia civilisation medievale, Montreai/Parigi 1969; C. MORRIS, The Discovery of the Individual: 1050-1200, New York 1972; L. K. LITfLE, Religious Poverty and the Profit Economy in Medieval Europe, lthaca 1978.
202 Cristina Andenna
'\· .. .r<· del rieordo dell'insegnamento di Stefano entro Ia eomunita e Ia eostruzione di una memoria intesa eome riproposizione del suo modello di vita?
Gli anni eompresi fra il 1156 e il 1170 furono anni eentrali per il pereorso di maturazione istituzionale della religio. Pertanto sembrano essere i piu propizi per l'attuarsi anehe di questa trasformazione. La fonte ehe ei guida in questo pereorso di approfondimento e Ia Vita Hugonis Lacerta, nella quale e narrato il raeeonto della eonversione e della vita in religione dell'anziano mi/es Ugo, uno dei primi e prineipali diseepoli di Stefano di Thiers. I! testo fu eomposto sieuramente dopo il 1157, anno della morte di Ugo di Laeerta, e prima del 1170, durante gli anni di priorato di Pietro Bernardo, diretto sueeessore di Stefano di Lieiae (1139-1163). In essa brani tratti da! Uber de doätina e gli insegnamenti in esso esposti in forma di sentenze si tradueono in una dimensione di vita reale, quasi 'messi in seena' nel raeeonto animato dalla vivaeita dei personaggi, sullo sfondo della rappresentazione della vita della eomunita dei Jratres e delle sue diffieolta quotidiane81. L'agiografo Guglielmo di Dandina, ehe diehiara di non aver eonoseiuto i protagonisti e Je vieende narrate se non dalla lettura e da! raeeonto di eoloro ehe erano stati testimoni oeulari, aveva inoltre seelto di interrompere Ia sua narrazione della vita di Ugo per dedieare una parte dei eapitoli eentrali alla esposizione della Vita di Stefano di Thiers, eolui ehe era all'origine della eonversione del suo protagonistaB2. La seelta era funzionale all'obiettivo ehe l'autore intendeva perseguire: Ia trattazione su Stefano permette di rappresentare meglio Ia vita della eomunita e soprattutto di illuminare il rapporto esistente fra il maestro e il diseepolo Ugo.
I! rieordo delle origini e della figura di Stefano era presente e vivo nella memoria della prima eomunita dei diseepoli. Esso si fondava sulla eontinua reminiseenza di quella spontaneita di rapporti radieati nella solidita del eonfronto quotidiano ehe Ia eonvivenza dei Jratres eon il maestro aveva generato. Sequela, eondivisione, insegnamento, ammonimento, perdono ed esortazione eontinua erano gli elementi fondamentali attraverso i quali Stefano aveva istruito i suoi seguaei. Con il mutare delle generazioni, l'estinguersi della vivaeita e del nitido rieordo dell'immediatezza della vita eon Stefano imponeva ora di passare alla deserizione e alla eodifieazione preeisa, attraverso il rieorso alla serittura, degli ideali originari. Era inoltre neeessario giungere a mediate Ia memoria dell'ideale,
8 1 Cfr. nota 63, dove si puo osservarc ehe i1 discorso fra maestro e novizio sul problema della scelta per Ia vita crcmitica, viene qui messo in scena in una situazionc reale: l'incontro fra Stefano di Thicrs e ilmiles Ugo di Laccrta. 82 Guillelmus dc Dandina, Vita beati Hugonis Lacerta (come nota 55), X-XXX, pp. 172-186.
Dall'esempio alla santita 203
eon gli inevitabili eambiamenti ehe l'aumento numerieo degli insediamenti avevano imposto.
Ma quale migliore strategia poteva esservi per rendere aeeettabili gli inevitabili eambiamenti dovuti alla trasformazione istituzionale, se non eseogitando di proporre una interpretazione delle modifieazioni dei nodi organizzativi e normativi alla luee delle disposizioni stabilite e insegnate da Stefano di Thiers? Una narrazione vivaee, l'artifieio del dialogo e la messa in seena di episodi eonereti, tratti dalla vita quotidiana, spingevano le pulsioni dialettiehe fra Ia tradizione, rappresentata dall'ideale delle origini, e Ia novita verso Ia eonereta possibilita ehe l'immediatezza dell'esempio di Stefano di Thiers potesse perdurare nel tempo, ma attuando i dovuti e neeessari proeessi di adeguamento, ehe Ia religio avrebbe aeeettato per eonformarsi alle imposizioni della Chiesa.
La fonte si eolloea nella seeonda meta del seeolo XII, dopo Ia morte di Ugo di Laeerta, quando, seeondo le testimonianze a nostra disposizione, Ia religio, eome sembra, aveva appena rieevuto Ia eonferma della sede apostoliea e l'approvazione alla vita e alle institutiones da parte di Adriano IV. Dopo Ia eonferma inoltre i Jratres avevano aggiunto al testo normativo delle eorrezioni e delle modifiehe ehe erano state inserite ad castigationemB3.
Sin da! primo eapitolo della Vita Hugonis si pereepisee ehe Ia santita di Stefano eoineideva eon Ia sua seelta religiosa e eon Ia eoerenza eon Ia quale egli ogni giorno perseverava nel mantenerla insieme ai suoi diseepoli84: Ia sua vita diveniva in tal modo un esempio eonereto molto eloquente (Cuius etemm vita sermone es/ satis locu/ento), il eui valore era superiore a molti altri seritti eonservati in luoghi piu saeri (alias mipta in sacratioribus /ocis pro summo honore habetur et conseroatur). Fra questi seritti dobbiamo forse pensare ehe esistessero altri testi normativi provenienti dalla tradizione orientale, oppure dalle sentenze dei Padri della Chiesa85.
Egli era pertanto pater atque minister dei Jratres, ehe, habitantti1m in tmum, seeondo l'esempio della ecc/esia primitiva, desiderando servire Cristo, avevano abbando-
83 Cfr. nota 18 e G. MELVILLE, Von der 'Regula Regularum' (come nota 10), pp. 342-363.
8-1 Guillelmus de Dandina, Vita beati 1-Iugonis Lacerta (come nota 55), I, p. 167: Di.rponms igilur lege vilae dmi01is se slringere, inediae el vigiliamm /an/um patims coepit esse, 111 em11 sibimel fore cmdelem 11011 dubitares. 85 Ibirl.: La conferma della presenza di Jetture edificanti fondate sulla conosccnza dei Padri dclla Chiesa e delle passioni dei santi, insiemc ad altre Jetture formative da! punto di vista spirituale e testirnoniato da un passo della Vita venembili vi1i Stephani Murelemis. Al capitolo XXII, dedicato alla virtli della umilta, era ricordato infatti ehe in rejeclorio i fratres, non solo nutrivano il corpo, ma ricevcvano dalla lettura comunitaria il nccessario nutrimento dcll'animo; Vita venerabilis viri Stcphani Muretensis (comc nota 47), XXII, pp. 116 s.
204 Cristina r\ndenna
t ~. "/•.'
nato il mondo ed erano entrati nell'eremo, con Ia co~1sapevolezza ehe ess1 avrebbero ricevuto Ia loro ricompensa nei cieliB6.
Dai capitoli centrali della Vita Hugonis conosciamo come era avvenuta Ia conversione di Ugo: dopo aleuni decisivi incontri con Stefano di ThiersB7 egli aveva scelto di fuggire da! secolo, ma per far questo egli aveva dovuto, cosa tutt'altro ehe semplice, abbandonare Je terre di sua proprieta, i parenti, gli amici ed i congiunti e uscire dalla sua casa per raggiungere il luogo ove il maestro viveva con i suoi discepoli88. Giunto presso Ia comunita, egli aveva poi appreso, humi/is et doci/is, tramite il continuo rapporto con il maestro, sancta religionis forma et doctrina89 . Sembrerebbe quasi una forma di noviziato quella a cui Ugo e sottoposto all'inizio della sua permanenza presso Muret; dopo i colloqui, il confronto e l'imita~ione dell'esempio egli fu susceptus, factus discipulus et religiosomm paupemm Christi numero sociatttS intra congregationem. Da quel momento aveva iniziato a con gli altri confratelli a conversari et vivere [. .. ] secundum paupertatis votum e secondo modum et regulam da Stefano stabilita (sub il/o tanto patre constitutam)90.
Da allora in poi inoltre egli si era comportato in modo da apprendere il meglio possibile e da essere sempre piu perfetto nella sua imitazione della condotta del maestro, del quale aveva guadagnato Ia stima91, in modo tale da riconoscere l'utilita dei precetti e delle istituzioni di vita e da essere preparato a rispondere de statu religionis et regula92• D alla Vita Hugonis apprendiamo ehe Stefano era sempre
86 G uillelmus de Dandina, Vita beati Hugonis Lacerta (come nota 55), I, p. 167: Hic dmique ex quo beremum mida111 inlravil, Cb!islo seroire ex corde desideram ul de Sllis aliommque merilis mercedem in cae/is acciperel copiosam, Jratmm babilanlium in 111111111 exslilil pater alque minisln;· in qua cui eis babilans, cotidie in opere Dei S/lccrescebal, Jom1a111 lmms illim erclesiae pri111itivae de qua in Actibus apostolon1111 legilur: '111ulliludinis credwlium eral cor 111111111 e/ anima una; nec quisquam suu111 ibi esse aliquid dicebat; sed eranl i/lis omnia COIII/IIUnia'.
87
88
lbid. , XII -X IV, pp. 172-175.
lbiri. ,XIV, p.1 75. 89 lbid.: Perveniens vero ad lomm, lmmi/is docilisque ad patrem el magislmm conlinuo acemit discipulos u/ sanc/a religionis jom1a doclrinaque emdirelur; e/ eius, ul IJO/uil, desideriu111 complelum es/. 90 lbid. , XIV-XV, pp. 175 s.; in particolarc XV, p. 175: Susceptus ilaque elfac/us discipulus, e/ religiosomm paupemm CIHisli nu111ero socia/us intra congregaliomm, mox C/1111 Dei servis conversari e/ vivere coepit smmdum paupertalis volum, e/modum el regula111 sub i//o /anlo pair~ conslilu/am. 91 Ibid. , XIV, p. 175: piis moribus el exemplis ad plem1111 emditus, p1iusquam 01111/C religiosamm s/udiu!JJ inslilulionum adeplus es/, optimomm quoque jralnm1 babi/11111 el fac/umqm imila/us, eidem pal!i vemrabili prae ce/e1is cams acceplmque pos/modum faclus est, lbid., XV, pp. 175 s.: Pater vero magisler eius, u/ era/ vir pius, el Dominum limws, de profeclu p1vvecluque eius gaudebal, el Domino gralia agebal. 92 lbid., XV, pp. 175 s.: Maxime il/is qui Deo mviebanl ex corde, adbaerebal, ieirmiis e/ oralionibus e/ operib11s bonis, in lege Dei medilans die ac nocle. Cuique vero, 111 die/um es/, q11idq11id propri11m in il/a sanc/a socielale babere, vel ad dexleram vel ad sinislram declinare minime /icebal; ibique di11 piis moribm el exemplis ad plem1111 emdit11s, p1i11sqllalll 011111e religiosamm s111di11111 insli/11/iormm adep111s tsl, optimomm q11oque Jralmm
DaU'esempio aUa santita 205
stato attento alla formazione spirituale dei suoi discepoli, con i quali era solito communicare, quando essi interpellavano il suo parere in merito ad ogni necessita e difficolta quotidiana93, per questo motivo egli istruiva il suo discepolo a divenire simile a lui94.
Flagitante religiosa necessitate, sia Stefano di Thiers sia Ugo, erano statt mterpellati dai loro confratelli circa le necessita delle chiese, illoro ampliamento, la ricezione di nuovi insediamenti eil problema della ordinazione dei nuovifratres. I confratelli ritenevano infatti fasse opportuno inviare Ugo, sulla cui rettitudine di intenzioni e di proposito di vita essi non potevano in alcun modo dubitare, per istruire le nuove ce//ulae sul modo di vivere secondo la religio di Grandmont95. Ma Stefano di Thiers si era opposto volendo trattenere presso di se il discepolo, ehe egli tanto amava96.
Un altro evento e piuttosto fondamentale per dirnostrare la considerazione di cui Ugo aveva goduto entro la comunita, e piu ancora presso il maestro. Una volta avvenne ehe jlagitante ecc/esiastica necessitate due cardinali inviati in quelle terre dal pontefice, cioe Gregorio, il futuro Innocenzo II, e Pietro Pierleoni, colui ehe fra il 1130 e il 1138 sarebbe stato designato antipapa con il nome di Anacleto II97, erano giunti attratti dalle voci diffusesi su Stefano per conoscere
habitii!JI facllllnqlle imilallls, eidem patri vmerabili prae celeris cams accep111sqlle poslmodiii!J fac/1/s es/. [. . .} Atqm ita edoc/11s smsim atq11e pa11lalim proficimdi in religiom eidem amoris ardor im10111s es/, m qllisqllalll eam injir711are, vel q11idq11id dicere conlra ipsam, eo praesmle, praesl/merel, e/ gratia Dei sie in eo Sl/ccrescms cotidie proficiebal, 11/ m.fficimlissime poscentib11s reddere ratiomJ!I de s/alrt religionis e/ reg11la semper adessei para/1/s [. .. ]. ?3 Ibid., XX, p. 179.
?~ Ibid., XV, p. 176: praecip11e q11od divitw sibi misericordia discip11lis praes/are/1/r talis, q11i possei verbo el exemplo boni operis ce/eros consolari e/ aedificare s11isq11e necessitatib11s sat/1/!n consili11m providere.
9.> lbid., XVII, p. 176: que111 Ctlln de utilitale ecclesioe suae el o!nplificotione, de cellulis accipiendis el fratn"bus ordinanrlis satis diligen/er a//oqmren/11r el exhortarenlllr, iam seimies finmlltl saepedicti discip11li proposilllllJ, ad millmd11m tJ/1!1 omms pari/er laboravenml. 96 Ibid.: N11mq11id e/1/lJ lam vobisq11a!JI e/ mihi necessarillllJ videtis? M11lla vero beneficia De11s per mm opera-11/S eslnobis; propter q11od homm v11ltis rlimillere mm? 97 La visita dei due cardinali potrebbe essere datata al 1119, quando Callisto II si trovava in Francia, appena dopo Ia sua elezione avvcnuta a Cluny. I due inviati papali, a quel tempo uniti daUa legazione, sarebbero stati destinati a confrontarsi, come rivelano Je fonti, nello scisma degli anni 1130-1138 (q11i lamm postmod11m mram eiiiSdem divisi invicem mscepenmt, Ibid. , XVII, p. 176) e cfr. anche Vita venerabilis viri Stephani Muretensis (come nota 47), XXXII, p. 121: in/er q11os postmodllm de praelalione Romani papa111s, IIIIIOI/1/J/ es/, schisma j11il, CIII!J a Sf/1/lllJO pontifice in Galliam missi legatione s11a in partib11s Lemoviciniae fimgere/llr, ad h1111C Dei vilmm pari/er convmenml. A proposito dei duc cardinali si veda M. M. WILKINSON, La vie dans Je monde (come nota 10), pp. 36-38 e ID., Thc 'Vita Stephani Muretensis' and the papal Re-constitution (come nota 10), pp. 134 s.
206 Cristina Andenna
'v".r•,
ed approvare le sue norme di vita9B. I eolloqui ehe essi ebhero eon Stefano furono eondotti alla presenza, per esplieita riehiesta del maestro, di Ugo, ehe egli eonsiderava il diseepolo prediletto99. Lo stesso episodio, anehe se eon una tradizione differente e piu elaborata, e tradito pure dal raeeonto della Vita beati Stephani 100, e eon alcune vatianti e aggiunte nella versione della Vita ampliata1D1•
La narrazione dell'ineontro eon i eardinali dimostra l'estremo interesse ehe la religio aveva per dirnostrare il suo eollegamento eon la euria romana e il fatto ehe essa aveva dato una esplieita approvazione, quando Stefano di Thiers era aneora in vitai02.
98 Guillelmus de Dandina, Vita beati I-Iugonis Lacerta (come nota 55) , XVII, pp. 176 s. II ricordo deUa visita dei due cardinali, peraltro narrata anche daUa Vita beali Stepbani, testimonia ehe un primo contatto con Ia curia · romana per il riconoscimento deUa vila el conversalione deUa nuova religio doveva gia essere stato stabilito. Se Bernardo di Clairvaux aU'inizio degli anni Trenta, con maggior precisione fra il 1131 e il 1132, non menzionava ancora Ia religio di Grandmont neU'elenco deUe congregazioni religiose e monastiche fedeli al papa Innocenzo I! durante lo scisma di Anacleto I! (Opere di San Bernardo, a cura di F. GASTALDELLI, vol. 6/1: Lettere, Roma 1986, ep. 126, pp. 578-601). II suo biografo Ernaldo di BonnevaUe inveee, ehe eompone fra i1 1155 e il 1156, introduee neU'eleneo anehe Ia religio di Grandmont, segno questo, secondo WILKINSON, ehe a queUa data Ia eomunita raeeolta a Grandmont era eonsiderata eome una fra le forme di vita religiosa rieonoseiute ed approvate; M. M. WILKINSON , The 'Vita Stephani Muretensis' and the papal Re-eonstitution (come nota 10), p. 142. 99 Guillelmus de Dandina, Vita beati 1-Iugonis Laccrta (come nota 55), XVII, p. 177: Hmtc mim metl/11 discipulum bonumque filium ideo relimo mec11m, quoniam quidquid in secrelo dicelis mibi /olmn ipse poslmodum indicarem ei; /an/um aulem in eo consilii el bonilalis quanlum el in me procu/ dubio invmire poteslis; es/ mim in consilio va/de providus el in commisso fidelis. 100 Vita venerabilis viri Stephani Murctcnsis (eome nota 47), XXXII, pp. 121-124.
IOI Gerardus Iterius, Vita Stephani Muretensis ampliata (come nota 1), XXXII-XXXIV, pp. 140 s. 102 L'episodio narrato neUa Vita beali Stepbani (Vita venerabilis viri Stcphani Muretensis [eome nota 47], XXXII, pp. 121 s.) si presenta neUa forma molto piu elaborata e rieea di dettagli deltopos narrativo agiografico, utili a giustifieare le necessita ehe si erano presentate nella religio negli anni Ottanta dcl seeolo XII. Partiealarmente interessante si presenta il fatto ehe Stefano aveva maturato Ia sua seelta religiosa al tempo deUa sua permanenza in Italia presso l'areivescovo Milone di Benevento. Trovandosi presso Ia curia romana, in oeeasione del Iransitus deU'areiveseovo, egli aveva rieevuto dal pontefiee Gregorio VII il consenso al suo proposito di scguire Ia via pauperlalis el abiectionis, strada ehe egli aveva appreso dall'esempio di vita degli eremiti viventi in Calabria, i quali sim pecurlibm el possessionibus Deo seroiunl. Inoltre gia neUa prima versione deUa Vita, e poi aneora di piu nella sueeessiva Vita ampliala, egli affermava di non volersi attribuire in aleun modo ne l'appeUativo di monaeo, ne queUo di eanonico, dei quali non usava neppure le vesti. NeUa Vita ampliata inveec si insisteva suUa appartencnza aUo slalus di eremiti, poiehe questa dimensione era queUa maggiormente rispondente, in quanto essi evitavano il tumulto del secolo e permanevano neUe loro cellulae in silenzio ed orazione (Gerardus Iterius, Vita Stephani Muretensis ampliata [eome nota 1], XXXIV, p. 141). II riferire il riconoseimento al pontefiee Gregorio VII, e ai contatti frequenti eon Milone di Benevento, eonferiva alla religio di Grandmont una notevole autorita, anche supportata dal fatto ehe essa si basava su esperienze eremitiehe di vita antiehe e rieonosei-
Dall'esempia alla santita 207
Durante tutto il periodo in cui Ugo di Lacerta era rirnasto a Grandmont a fianco del suo maestro, egli lo aveva costantemente irnitato, si era istruito attraverso un continuo confronto per mezzo del dialogo. L'insistenza da parte dell'agiografo sulla capacita di Ugo di conformarsi perfettamente nella condotta di vita agli insegnamenti di Stefano di Thiers, sembrerebbe dirnostrare Ia volonta da parte dell'agiografo di sottolineare il fatto ehe egli era "il discepolo"I03, scelto quale depositario della fedelta all'ideale stile di vita intrapreso a Muretl04•
A conferma di questo Guglielmo di Dandina sottolineava piu altre nella Vita Hugonis ehe, se Stefano di Thiers lo aveva voluto al suo fianco a Muret, alla morte del maestro, durante il priorato di Pietro di Lirnoges, egli era stato chiamato a dirigere una cella dipendente, dove egli aveva insegnato Ia religio come egli l'aveva appresa da! suo maestro e dove aveva governato Ia dipendenza con parole ed esempi (verbo et exemplo multum benigne gerebaf) 105• I! testo agiografico presenta Ugo come un autentico successore di Stefano, capace di informare Ia nuova comunita sullo stile di vita appreso a Muret, ma al tempo stesso egli si presenta come perfettamente corrispondente al modello del santo erernita penitente descritto da Andre VAUCHEZ106• Similmente a Stefano, anche Ugo era, secondo il racconto della Vita Hugonis, repletus emditione, insigne nella pratica della religio, disprezzatore del mondo e amante di Dio e del prossirno. La sua
ute, quali quelle ealabresi. Ma queste fanti e Ia rielaboraziane da esse aperate di materiale antieo testimaniana da parte della religio Ia neeessita di rispondere ai nuavi problemi istituzianali ehe gli anni Ottanta con Ia seappio del graue scmtda/um avevana impasta. Cfr. J. BECQUET, Etienne de Muret et l'areheveque de Bencvent Milan, in: Bulletin de Ia Saeiete histarique et arehcalagique du Limausin 87 (1958), pp. 401-409, ara in: 10., Etudes grandmantaines (come nota 6), pp. 21-28. E tarnata sul signifieata ehe nclla Vita uemrabi/is uiri Stepbani assume questa 'mamenta italiana', M. M. WILKINSON, The 'Vita Stephani muretensis' and the papal Re-eanstitutian (eame nata 10), pp. 135-140. t\ proposito delle esperienze eremitiehe e il manaehesima di rita greco in Italia meridionale A. GU!LLOU, II monachesimo greco in Italia meridionaleein Sicilia nel medioevo, in: L'eremitisma in aeeidente nei secoli XI e XII. Atti della seeanda settimana internazianale di studio. (Mendala, 30 agasto- 6 settcmbre 1962), Milana 1965, pp. 355-381. 103 Guillelmus de Dandina, Vita beati Hugonis Lacerta (comc nata 55) , XVII, p. 176: Pater uero magisler eius, 111 era/ uir pius, el Domi1111111 limens, de projec/11 prouecluque eius gaudebal, e/ Domino gralia agebal; ob banc causam praeripue quod diuina sibi misericordia discipulis praeslare/ur ta/is, qui possei uerbo e/ exemplo boni operis celeros consolari e/ aedijicare suisqm mcessilatibus sam1m consilium prouidere. 10~ Ibid. , XX, p. 179: Cognouil au/em pas/or e/ credidit, quod mul/o melius praedixera/ so/us ille discipulus, quam ipse disposueral mm celeris omnibus, tmde e/ i//i proli!IIIS dixil: 'Sie wim,Jili mi, botms disripulus e/ Jidelis magislmm S/111111 ad Dmm /rabil alque reducit'; cfr. ibid., XXI, p. 179: Fuil wim cum Domino ac magislro tJos/ro S tepba!lo discipulus i/le usque ad obi/11111 eius,audiens mm Jide/iter el inletroga11s super senlenliis celerisque uilae noslrae ma11datis, /Je spiritalia semina quae procedebanl de ore eius absque multiplicalione, inso/enlia auditonlf/1 e/ 11egligettlia deperirenl; dei quoqm benignilas e/ec/11!11 bm1c de Iot mi/libus 111111111, qui el audita bumiliter srire suscipere eademque futuris saecu/i in suo /empore Jideliter reuelare.
to5 Ibid., XXX, pp. 185 s.
!06 Cfr. nata 60.
208 Cristina Andenna
condotta religiosa appariva esemplare, pregava assiduamente, digiunava di frequente e compiva buone opere107. Queste virtU sembrerebbero accordarsi perfettamente con !'ideale monastico, tuttavia egli era anche un eremita, o meglio un penitente volontario del secolo XII, ehe sul modello del suo maestro Stefano di Thiers, accoglieva e sostentava poveri, pellegrini, vedove e orfani. Juxta suam possibilitatem in necessitatibus subveniebat verecunde et abundanter. egli accoglieva chiunque incontrasse, fossero nobili o indigenti108. Si tratta allora di una forma di eremitismo del tutto nuova, caratterizzata dalla conciliazione dei due stati di vita, propri della scelta religiosa, la vita attiva e quella contemplativa. Nel nuovo eremita penitente infatti la fase individuale, destinata all'abbandono del mondo per adorare in solitudine Dio, aveva una durata limitata. L'apparenza trasandata, il vestiario consunto e la ricerca di luoghi isolati, sinistri ed abbandonati non impediva ai nuovi eremiti, come notava lo studioso francese, di condurre una vita attiva. La loro fuga dal mondo li riportava paradossalmente nel mondo: essi non erano indifferenti agli uomini e, proprio come la Vita Hugonis testimonia, sia nel caso di Stefano di Thiers, sia in quello di Ugo di Lacerta, essi si dimostravano pronti a prodigarsi in consigli utili a coloro ehe li interrogavano. La loro mobilita e la loro liberta permettevano di esercitare un apostolato assai vario e ehe va dalla assistenza ai viaggiatori, ai pellegrini, ai poveri, alle vedove e agli orfani. Per riprendere le parole dello studioso francese, "lo stesso Stefano di Thiers, il piu stabile degli eremiti, non esita a dichiarare ehe se e bene rinunciare al mondo e ancora meglio strappare le anime al diavolo"109. Sirnilmeute a Stefano di Thiers, le parole dell'agiografo lasciano trasparire in Ugo di Lacerta la stessa preoccupazione a svolgere anche un ruolo simile a quello dell'abate. Egli sapeva esercitare la discretio, tollerava le trasgressioni, anche se ad edificationem dei discepoli ricordava loro di perseverare nella virtU e li esortava ad abbandonare il peccato ed il vizioltO.
Un altro passo della Vita Hugonis rivela la preoccupazione circa il futuro della comunita. I fratres temevano il momento in cui illoro pastore Stefano li avrebbe abbandonati ed essi si sarebbero trovati soli e privi di una guida spirituale e materiale 11 1. La maggiore preoccupazione era rela tiva al modo in cui la
107 Guillelmus de Dandina, Vita beati Hugonis Lacerta (come nota 55), XXX, pp. 185 s.
10s Ibid.
109 r\. VAUCHEZ, La spiritualite (come nota 60) , pp. 102 s. 110 Guillelmus de Dandina, Vita beati Hugonis Lacerta (come nota 55), XXX, p. 186.
111 Ibid., XXVII, pp. 182 s.: Pater cmissime, pastorq11e bom, ecce I/OS reliq11im11s o!lmia et semti SI/11/IIS le; venimus ad te. Nm1c die ergo cui nos 111 relinq11is, qui mram habeat de nobis? Quid igitur nobis dabis consilii? Tu a11tem nos nullatemts habere permilfis bestias, tnramm possessiones, decimas, ecclesias el res ad eas perlimntes, redditus el q11aest11s sim q11omm mra vix auf flllmq11am lmporalis istapolest s11s!entmi vila.
Dall'csempio aUa santitil 209
comumta, dopo Ia morte di Stefano, avrebbe provveduto al sostentamento, messo seriamente in difficolta dalla proibizione loro imposta di accettare propriedt, bestie, terre, decime e chiese, con tutte Je cose ad esse pertinenti. Contrariamente al parere di quanti li esortavano a modificare sotto questo aspetto Ia loro scelta di vita, Stefano aveva loro ribadito ehe in nessun modo avrebbe permesso loro di accettare queste condizioni: Nolo ego ut habeatis bestias, nec terras, nec decimas, mc ecclesias, nec quaestus, nec redditus, ut Deus vobis sit magis necessarium112•
Essi infatti non dovevano temere, poiche Dio avrebbe concesso loro il necessario per sopravvivere, esattamente come era avvenuto a lui, ehe da circa cmquant'anni aveva abbandonato il mondo e mai aveva sofferto Ia fame 11 3.
A questo proposito inoltre ifratres avrebbero dovuto porre attenzione a non invidiare, ne desiderare Je proprieta dei loro vicini, altrimenti sarebbe stato alquanto impossibile riuscire a mantenere con essi una serena concordia 114. I! testo rivela lo specchio di una situazione successiva alla morte di Stefano: Ia lite con i monaci di Ambazac, a causa della quale Pietro di Limoges era stato costretto a trasferire Ia comunita dall'eremo di Muret, nella solitudine di Grandmont115. I due capitoli successivi della Vita Hugonis mostrano pertanto l'intenzione dei fratres di mantenere fede alle prescrizioni di Stefano di Thiers in materia di poverta. Guglielmo de Dandina aveva infatti ribadito ehe Je pressioni esterne avevano indotto i Jratres a riconsiderare il loro stile di vita in assoluta poverta. I! rifiuto di terre e animali li avrebbe infatti condotti, dopo Ia morte di Stefano, a non avere di ehe sostentarsi116. La risposta di Stefano di Thiers a questo proposito era stata chiara: "i confratelli e coloro ehe vi dicono queste cose errano". II perseverare in hac tam sancta vita, Ia poverta assoluta, avrebbe permesso loro di continuare ad avere di ehe vivere: se questo al momento pre-
11 2 lbid. , XXVII, p. 183. Cfr. G. MELVILLE, Von der 'Regula regularum' (come nota 10), pp. 349-351 e G. MELVILLE, 'In solitudinc ac paupertate' (come nota 10), pp. 7-30. Si veda anche Regula venerabilis viri Stephani Muretcnsis (come nota 22), IV-IX, pp. 73-76. 113 Guillelmus de Dandina, Vita beati Buganis Lacerta (come nota 55), XXVII, p. 183; lo stesso episodio lo si ritrova anche neUa Vita venerabili viri Stephani (come nota 47), XXXII, pp. 123 s.
114 Ibid. , XXVII, p. 183.
ll5 r\ proposito del trasferirnento a Grandmont cfr. J. BECQUET, La regle de Grandmont (come nota 6), pp. 91-97. 11 6 Guillelmus de Dandina, Vita beati Buganis Lacerta (come nota 55), XXVIII, p. 184: Fratres a11lem gavisi el sec11ri de patema consolatiom dixenml ei ilemm: 'Pater el domi11e, m11lli adh11c e/ ali11d 110bis dimnl: d11m mim vos vixerilis, nos mambii!IIIS insim11/,· poslqlla/JJ vos moriemi11i, neqHaqlla/JJ poterim11s mslm/ali, si beslias 11011 habNerim11s'.
·'· :,/,..'\I
210 Cristina r\ndenna
sente non appariva ehiaro, m un momento sueeessivo sarebbe divenuto piu evidente117.
Il raeeonto della Vita Hugonis laseia intuire ehe esistevano ormai, durante il priorato di Pietro Bernardo, sia una raeeolta di seritti eontenenti la Vita di Stefano di Thiers11 B, sia un testo normativo, indieato piu volte eon il termine di regula. Il pereorso di evoluzione istituzionale della religio era pertanto gia stato avviato e la vita testimoniava l'avvenuto mutamento e la neeessita di fondare la regola e i testi normativi eodifieati, applieando i prineipi nel eonereto delle situazioni vissute e dei dialoghi fra Jratres e diseepoli. Le due figure magister e discipulus emergono dal raeeonto eome autentiei eremiti, eonsiderati pertanto nella loro dimensione da un lato di abbandono del seeolo, dall'altro di ritorno in esso per dediearsi anehe alla vita attiva e alla eonsolazione degli uomini. Tuttavia il loro eomportamento si allontana dal distaeeato atteggiamento del magister del Uber de Doctrina, ehe esortava il diseepolo ehe lo aveva seguito in religione a stare attento, poiehe si propter me non redeo propter te 11011 redibo 11 9.
Nel Uber de doctn.na il nucleo fondamentale era assegnato al soggetto e all'approfondimento da parte del soggetto della sua seelta di eonversione personale, nel testo della Vita Hugonis, inveee, sia Stefano, ehe poi volutamente Ugo, rieordano eon illoro esempio di vita e eon le loro parole (verbo et exemplo) i grandi eremiti e i santi del seeolo XI e XII. Ma la loro eondotta esemplare di vita avrebbe dovuto tradursi inevitabilmente in una esemplarita, il eui modello avrebbe dovuto essere eapaee di durare nel tempo. Essi, da quanto emerge dal raeeonto della Vita Hugonis, si presentano eome figure earismatiehe ehe, eoseienti del ruolo ad essi affidato, sono protesi a eurare ehe la loro intuizione originaria potesse trasformarsi in un esempio eonereto di vita, un insieme di eompilazioni normative (institutio 11ostrae sanctae religionis et regulae) ehe rispettavano l'ecc/esiasticum morem120. Questi testi sarebbero stati validi indistintamente per
117 Ibid.
118 Secondo gli studi di WILKINSON Ia prima versione della V ita Stephani si fondercbbe su una tradizione solo orale, successivvamcnte essa si sarebbe stata trasformata in una versione scritta, Ia Vita Primitiva, cui avrebbe fatto seguito una versione letterariamentc piu claborata Vita Poste1ior, sulla base della quale sarebbe poi stata redatta Ia Vita Psmdo-normativa, edita da Jean BECQUET. La WILKINSON afferma inoltre di aver ritrovato una versione della Vita Postenor ncl testo del domenicano Vincenzo di Beauvais, ehe ncl suo SpeCII/111!1 Maius inseri anchc Ia vita di Stefano di Thiers, seppure in una versione molto abbreviata; M. M. WILKJNSON, La vie dans lc mond (come nota 1 0), pp. 24-27. 119 Liber de doctrina vel liber sentcntiarum (come nota 58), I, p. 6: et ego tui curam 11011 agam, nec temetipsum agere sillalll, a saeCIIIo quippe 1/Jeos absddi pedes; et si propter me 11011 redeo, propter te 11011 redibo. 120 Guillclmus de Dandina, Vita bcati Hugonis Lacerta (comc nota 55), LI II, p. 208.
Dall'csempio alla santita 211
tutti i diseepoli, in ogni luogo e in ogni eella. Il grande timore era infatti rappresentato dalle nova nemora, dai Jratres e dai novizi, segno questo ehe aneora al tempo della eompilazione della Vita Hugonis, fra il 1157 eil 1170, l'ampliamento eil sueeesso della religio continuavano a rimanere fonte di preoccupazione12 1.
Signa autem dantur infidelibus, non fidelibus: da exemplum per la comunita alla costruzione di un santo come modello di vita religiosa
Riprendiamo ora il raeconto del De revelatione interrotto nel momento in eui il eapitolo dei Jratres aveva mostrato un dupliee atteggiamento nei confronti della proclamazione della santita di Stefano di Thiers, posizione ehe peraltro abbiamo riscontrato anehe nelle fonti agiografiehe. La risposta di Gerardo Ithier alla obiezione del eapitolo si dimostrava eloquente, sintomo della volonta da parte del priore di sostenere entro la religio un atteggiamento nuovo nei confronti della santita di Stefano. A testimonianza di questa nuova eoseienza, ora a Grandmont si pregava perehe Stefano manifestasse i suoi signa122, i miraeoli ora erano un evento da annuneiare, non piu da taeere123: il nuovo priore aveva infatti ehiesto al conventus dei Jratres di pregare afftnehe Stefano si mostrasse in oeeasione della sua canonizzazione eon aleuni segni, poiche i fedeli, ottenebrati dal vinculum caecitatis atque infidelitatis, fossero favoriti nel eredere.
La manifestazione dei signa et prodigia era ora un elemento, non piu da naseondere, ma da proclamare uffieialmente, affinehe potesse divenire un esem-
121 Ibid., LI, p. 206. Su Grandmont come uno dei nuovi ordines del XII sccolo si veda anche J. BECQUET, L'eremitisme clerical et la!que dans l'ouest de Ia France, in: L'eremitismo in occidente (come nota 102), pp. 182-204 e P. ZERBI, 'Vecchio' e 'Nuovo' monachesimo alla meta del secolo XII, in: Istituzioni monastiche e istituzioni canonicali in occidcnte (1123-1215), Atti della settima settimana di studio (Mendola 28 agosto - 3 settembre 1977), Milano 1980, pp. 3-24, ora anche in ID., 'Ecclesia in hoc mundo posita'. Studi di storia e di storiografia medioevale (Bibliotheca crudita. Studie documenti di storia e ftlologia 6), Milano 1993, pp. 305-331. 122 Gcrardus lterius, De revclatione beati Stephani (comc nota 1), li!, p. 283: Vmite ergo ef congpgamini, ef ea/11/IS anfe sep11lchm111 beatissimi, ef invocem11s nomen Domini, 11/ q11i ett/11 mirijicare inripit, diversis dig~~et11r mm honorare miraCIIIis'.
123 P. r\. SIGAL, Les miracles (come nota 46), pp. 49 s.; Gcrardus Itcrius, De revelatione beati Stephani (come nota 1), XXVI, p. 302: Nos vetv, 111 de fanfo tamq11e pretioso mirac11lo mtiores redderem11r, ef hi/ariores efficeremllr, i11ssim11s e11111 add11ci ad IJOS, q11e111 vidiflii/S erecfllm ef amblllanfem, atq11e ex ei11s ore a11divim11s SilOI/I q11af!J primiiNS hab11it injirmitafem; deinde vero sanifafem, q11a111 per beafi Stephani metifa divinit11s reciperaf, veraciter pronmJfianfem. Haec vidi11111s, haec a11divifllfts, haec fesfamllr, haec caritati vestrae jideliter muumtiamm, 111 credatis signis ef prodigiis istis q11ae a11ditis, ef sie jideliter credmtes vitam aefema/11 habeatis.
212 Cristina Andenna
,,_ ... _,.,
pio mirabile da diffondere124. La eomunieazione de( prodigia provoeava l'affluenza di pellegrini ehe da luoghi sempre piu lontani, si reeavano alla tomba di Stefano sia per impetrare la grazia, sia in segno di devozione e di ringraziamento per i miraeoli rieevuti125. A Grandmont l'afflusso di pellegrini non era piu temuto e eonsiderato un elemento perieoloso alla realizzazione dei prineipi della religio; si trattava di un atteggiamento esattamente inverso rispetto a quanto avevano fatto i priori durante il seeolo XII. La solennita e l'offieialita della eerimonia eon la quale il eorpo era stato traslato ne e una testimonianza. Per ordine dellegato papale infatti il corpo era stato elevato dalluogo dove si trovava e eon una proeessione, ehe si era snodata lungo tutto il ehiostro e alla quale aveva parteeipato anehe il popolo, era stato deposto sopra l'altare della Vergine, fra eanti, luminarie e profurni di ineenso.
Un evento miraeoloso fu operato da Stefano e diede maggiore solennita alla eerimonia; il signum avvenne mentre i veseovi e gli areiveseovi si preparavano alla solenne eerimonia nella ehiesa alla presenza del popolo e mentre i fratres, ottenuto il permesso del eardinale stavano per eelebrare in una eappella separata la messa 126.
L'esemplarita di Stefano di Thiers, fondata sulle virtU e sulle sue azioni, era stata eonoseiuta solo all'interno della eomunita, ma ora la radiealita della sua seque/a Christi e soprattutto la grazia elargitagli dal Signore eon la manifestazione di signa e prodigia, divenivano un utile strumento e modello anehe al di fuori dei eonfmi dell'eremo. 11 rieordo dell'esperienza delle origini, vivo nella memoria dei prirni diseepoli, e la "eostruzione di un esempio valido per la eomunita" non erano piu suffieienti a reggere l'impatto di una diffusione e di un favore sempre ereseente, ehe la religio in quegli anni iniziava a riseontrare in Franeiat27 ed anehe
12~ Gcrardus Iterius, Dc revelatione bcati Stephani (come nota 1), III, p. 283: Nunc vero si placel, pater bone humiliter el piis precibus ßexisque genibus supplicare dignemini, qualetms lempore suae tfvelationis nos visilare ac consolari dignelur aliquibus signis. Vos cemilis q11ibus lmelllr Dei pop11!11s obliga1t1s vinm/is caecilalis atq11e infidelilalis, e/ nisi viderinl signa e/ prodigia, certe minime credenl. Signa a11/em dan/ur injide/ib11s, non jide/ibus. &quiral itaq11e veslra humililas ab eo 111 jian/ el appareanl aliqua miram/a eim merilis e/ precibus divino 1111111m in Dei populo. 125 Ibid., IX, p. 290: Divulgantibus fere omnibus signa e/ prodigia quae cotidie Dei bonila/e e/ beali viri merilis jiebanl in Granditnonle ac 11111llis in /ocis in quibus memoria nominis i//ius habebatur, coepemnl multi vmire COIIC/Irstl e/ occurs11 ex provinciis diversis, 11/ merili ipsius de mcessilatibus suis 1/ltrenlur a Domino Deo exaudiri; ibid., IX, p. 291: Haec C/1111 audivissem, admiralus S/1111 vehemmler, e/ glorijicare coepi IIOIIIC/1 Domini C/1111 celeris qui haec audiebanl, e/ repleli s11111 0/111/es stupore e/ admiraliom de eo quod contigerat i//is, e/ quia Dms lalis signis lamquam aperlis SIIIII/I sanc/11111 decorabat e/ honorabilem reddebal.
126 Ibid, IV, pp. 284 s.
127 J. BECQL!ET, "Grandmont", in: Dictionnaire d'histoire et de geographic ccclesiastique, vol. 21, Paris 1986, coll . 1129-1140, ora in: ID., Etudes grandmontaines (come nota 6), pp. 41-60.
Dall'escmpio alla santita 213
in Inghilterra128. L'evoluzione organizzativa dell'orcline e Ia sua maturazione istituzionale, per Ia quale si erano impegnati non solo i maggiori esponenti del gruppo, ma in primis anehe Ia euria romana, nonehe parte del clero franeese ed inglese e gli stessi sovrani Enrieo II cli Inghilterra e Luigi VII cli Franeia, avevano raggiunto illoro apiee eon Ia eanonizzazione.
La figura cli Stefano cli Thiers, in preeedenza quasi ignota alla euria romana, se si vuole tener fede a quanto seriveva il eanonieo vittorino Stefano fra Ia fme degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta, era stata offerta negli anni eentrali del seeolo XII alla eomunita eome esempio cli vita 'da imitare'. Cosi infatti Stefano cli Thiers figura ad esempio nella Vita Hugonis, ma al tempo stesso egli era anehe ripensato eome strumento per giustifieare preeise seelte normative e organizzative. Ora, dopo Ia eanonizzazione, eon Ia sua eeeezionalita cli vita fedelmente raclieata sul modello evangelieo e eon i numerosi miraeoli, Stefano si presentava eome un paradigma inimitabile e come un soggetto proposto alla generale ammirazione.
Questo pereorso evolutivo era stato lungo. Nella Vita ampliata- si intende eon essa le aggiunte apportate da Gerardo Ithier al testo della Vita vemrabili viri Stephani dopo Ia uffieiale proclamazione della santita - si riseontra una prima testimonianza cli un rinato interesse per il eulto delle reliquie cli Stefano cli Thiers. Al tempo del quarto priore Stefano cli Lieiae i resti mortali del maestro si trovavano deposti in un vaso cli legno e naseosti a tal punto ehe Ia maggior parte dei fratres ignorava Ia loro esistenza. Per ordine del priore, ehe era a quel tempo seriamente malato e febbrieitante, esse erano state spostate in un sareofago cli pietra e portate alla sua presenza; improvvisamente egli era stato liberato dalla malattia. L'evento miraeoloso tuttavia non fu subito ben aeeetto al priore: il santo, eoneedendogli quella guarigione e prolungandogli l'esistenza terrena, gli impecliva cli raggiungere eio ehe egli piu desiderava, presentarsi cli fronte a Cristo129. A giustifieazione del suo atteggiamento il priore ribacliva cli non essersi oeeupato dei miraeoli prodotti dalle reliquie, in quanto riteneva ehe le opere, e qui sono da intendere i jacta eompiuti da Stefano durante Ia sua vita, erano un segno ben piu importante per testimoniare Ia sua santita. Gli inereduli e gli stolti
lnoltrc alcune brevi schcde sui priorati francesi si possono reperire ncUa scconda sczionc "Art et Archeologic" in: G. DURAND / J. NOUGARET (come nota 10).
128 R. GRi\HMI (come nota 9). 129 Gerardus Iterius, Vita Stephani Muretensis ampliata (come nota 1) , LXII, p. 150: Quod des-idembam prolongasfi, quod nolebam dedisti.
214 Cristina Andenna
'\ .. :', neeessitavano inveee di signa et prodigia, mentre i fedeli, 1 giusti e 1 fermi nella fede non avevano bisogno di queste manifestazioni per erederel3°.
Il priorato di Stefano di Lieiae eorrisponde ad un momento di maturazione organizzativa e di trasformazione normativa entro Ia religio: dopo aver rieevuto l'approvazione della vita e delle institutiones da parte di Adriano IV, era stato neeessario passare alla eompilazione di una regula, eome rivela anehe !'Eiogia priorum131 , ehe stabilisse eon una preeisa determinazione i ruoli e le eompetenze affidate ai ehieriei e ai eonversi e ehe ehiarisse Ia diffieile questione del signifieato e del valore da attribuire alla poverta. Inoltre e proprio sotto il governo di Stefano di Lieiae ehe Ia figura di Stefano di Thiers torna ad avere un signifieato eentrale nella religio, a lui infatti si deve l'ordine di raeeogliere e serivere i Jacta et dicta del maestro, escludendo tuttavia i miracula132•
Fu solo durante il priorato di Pietro Bernardo (1163-1170) tuttavia ehe si ebbero le prime testimonianze di una ripresa del eulto, in forma piu uffieiale rispetto al periodo preeedente. Seeondo Ia notizia eontenuta negli Elogia priorum di Grandrnont, solo in questo periodo risale Ia traslazione del eorpo di Stefano di Thiers 133, notizia questa ehe eoneorda eon quanto narrato piu diffusamente dalla Vita ampliata134• Si narra infatti ehe questo priore il 26 dieembre, giorno di Santo Stefano, eonvoeato il eapitolo generale e alla presenza del veseovo di Limoges, Gerardo135, aveva disposto ehe il eorpo di Stefano fasse trasferito eon
I30 lbid.: N o11 mro de f11is mimmlis; sed pl11s ga11deo de operib11s /11ae sallcfilalis, i11cred111i el imbecilles, el i11jin11i sig11is e/ prodigiis i11digwt, jide/is el i11sti ac jim1i i11 fide his op11s 11011 habwt.
13 l Elogia priorum Grandimontis incerto auctoris, in: Scriptores ordinis grandimontensis (come nota 1), pp. 501-504, in particolare IV, p. 503.
l32 lbid., IV, p. 503. Sulla stesura della Vita cfr. J. BECQUET, La regle de Grandmont (come nota 6), pp. 91-97; M. M. Wll.KINSON , The 'Vita Stephani Muretensis' and the papal Reconstitution (come nota 10), pp. 133-155; ID., Lai'cs et convers de !'Ordre de Grandmontau XII• siedes (come nota 10), pp. 34-50; 10., La vie dans lc monde d'Etienne de Muret (come nota 1 0), pp. 23-41. 133 E logia priorum Grandimancis (come nota 131), V, pp. 503 s. Cfr. anchc J. BECQUET, La premiere crise de !'ordre (come nota 6), p. 286; m., Les premiers ccrivains de !'ordre de Grandmond (come nota 12), pp. 264 s.
l:l-1 Gerardus Itcrius, Vita Stephani Muretensis ampliata (come nota 1), LXVI, pp. 153 s. 135 C fr. nota 18. Gcrardo fu colui ehe si era recato insieme al nipote, vescovo di Canterbury, in visita ad limifla a Roma, dovc aveva ottenuto da Adriano IV l'approvazione della vila el illsfif11cioms Jmtres grat~dimofllis; cfr. nota 18. Egli consacro inoltre Stefano di Obazine abate e i suoi Jratres monaci nel 1142, quando l'eremita su consiglio di Aimerico vescovo di Clermont e, prima ancora di Guigo priore della Chartreuse, aveva scelto di aderire alla esperienza cistercense, offrendo in tal modo alla sua comunita e ai monasteri ad essa collegati, anche femminili, una piu stabile struttura normativa e istituzionale. Vie de Saint Etienne d'Obazine, texte etabli et trad. par M. AUBRUN (Faculte des Lettres et Seiences Humaines de l'Universite de Clermont-Ferrand. Publication de
DaU'csempio alla santita 215
una eerimonia dal claustro alla ehiesa e la Vita ei permette di eonoseerne meglio anehe la eolloeazione, eioe sotto il presbiterio, davanti all'altare136. A dare una maggiore solennita all'evento, l'agiografo raeeonta ehe un eerto frater Guglielmo per intereessione di Stefano aveva anehe riaequistato l'udito137.
La traslazione e sieuramente da eollocare dopo la eonsacrazione della ehiesa abbaziale di Grandmont, avvenuta nel 1166; la Chronica di Geoffroy de Vigeois, unico testo a riferire l'evento, non menziona infatti alcuno spostamento di reliquie di Stefano138• Un ulteriore limite cronologieo e offerto dalla indicazione eontenuta nella Chronica regis Hemici secundi. In essa si narra ehe fra l'agosto e il settembre del 1170 Enrieo II, gravemente amrnalato, aveva manifestato la sua intenzione di essere sepolto a Grandmont, in exitu capituli, ad pedes magistri eiusdem domus; segno questo ehe le reliquienon si trovavano aneora in ehiesa139. 11 passaggio delle reliquie dal claustro alla ehiesa ebbe luogo quasi sieuramente dopo il settembre del 1170140.
Nel modo di eoneepire la figura di Stefano di Thiers si nota un lento percorso: egli da testimonianza di vita nel ricordo dei primi diseepoli era divenuto modello esemplare per una comunita ehe neeessitava di giustifieare preeise scelte istituzionali. Infme era stato qualificato eome istitutore del nuovo ordine,
!'Institut d'Etudes du Massif Central 6) Clermont-Ferrand 1970, p. 96: Igitur OI/1/0 ab incamafione Domini MCXUI, dominica anfe Pascba qua111 Palmamm voca!IJIIS, presmfe Domno Geraldo Lemovicensi episcopo ef multisque religiosis vi1is, venerabilis pater S tepbanus a quondam abbate qui Cf/111 episcopo vmeraf, monacbus es/ effectus, statimque in abbatem promofus ef ab episcopo consecrafus, Oll/lies quos babebat clericos Jratres in monachos bmedixif, ceteros in p1istino babitu!IJOI/ere consfifuif.
136 Vita venerabilis viri Stephani Muretensis (come nota 47), XLI, p. 129. 137 Gerardus Iterius, Vita Stcphani Muretcnsis ampliata (come nota 1), LXVI, pp. 153 s.
l38 J. BECQUET, La premiere crise dc !'ordre (come nota 6), pp. 119-121 e 10., La regle dc Grandmoor (come nota 6), pp. 91-118. La notizia della consacrazione e notasolo dalla Cbronica rclativa agli eventi della regionc del Limousino, scritta prima del 1184 da un monaco di SaintMartial de Limoges, Geoffroy de Vigeois. La Cbronica e edita solo in un testo del secolo XVII: Gaudefredus cocnobita monasterü Sancti Martialis Lemovicensis ac prioris Vosciensis cenobü, Chronica, ed. P. LABBE (Nova Bibliotcca Manuscriptorum 2), Paris 1657. 139 Benedictus abbas, GestaRegis Henrici secundi (come nota 9), vol. 1, p. 7: Et posten praecepit episcopis ef comitibus ef baronibus, qui ei in illa injirmitafe assidebanf, quod si i/Iom no11 evasissef infir711ifafe assidebanf, corpus suum defemnf ad sepelimdum apud Grandem A1onfem, qui pamm distat a Sancto Leonardo. Et ipse ostmdit eis quandam carfam, quam Boni Homines de Grandi Monte ei fecenmf de corpore suo sepeliendo, in exifu capitulis domus Gramlimontis, ad pedes magistri eiusdm1 domus, qui ibide111 sepultus es/. Cum au/em baec audissml, vebemwfer mimli srml, e/ boc concedere nolmnml diemies boc esse co!rlra dignilale regni mi. Ipse vero magis instabat u/ boc fieret; sed paulo post, siml divinae placuit providwtiae, de illa convaluil infil711ifale; e/ quam ritius polerat sicu/ in illa injir711ifa/e voverat, inter anipuit C/1111 festinalione, rirca fest um S ancli Michaelis ad Smrclam Mariam de Rlifle Adamaloris. E t peracla i/la peregrinatione SI/tl rediit in Andegaviam.
140 Cfr. nota 135.
216 Cristina Andenna
1\ ~:-. . ,. il quale avendo rinunciato ai suoi propos1t1 ongmari, necessitava di un fonda-tore, nel quale incarnare, almeno in linea teorica, i principi fondanti della nuova identita e nel quale comparissero gli esempi di vita offerti come paradigmi inirnitabili per i novizi e per l'intera cristianita. Una testimonianza di questa evoluzione e visibile anche nel percorso ehe in anni differenti compirono le sue reliquie da Muret a Grandmont, e poi da! claustmm al presbiterio.
L'elaborazione della santita si affianca pertanto al percorso di maturazione istituzionale ehe Ia religio aveva affrontato per poter essere riconosciuta entro Ia struttura ecclesiastica, maturazione ehe aveva irnposto addirittura il sacrificio dell'ideale delle origini, Ia poveta assoluta, trasformando l'esperienza di Stefano di Thiers in solitudine ac paupertate in un'idea di modello nuovo di ordine religioso, capace di organizzare, anche se con un difficile sforzo di equilibrio, Je due dimensioni della vita religiosa: il compito di Marta e Ia predisposizione contemplativa di Maria. Sullo sfondo rimanevano le Iatte fra il sovrano di Francia Luigi VII e il re inglese Enrico II Plantageneta e i faticosi tentativi di conciliazione intrapresi da! papato.
Instututa magistn'pro lege habebant. vivere secondo una regola di vita quia vero brevesdies hominis sunt141
Simile, ma al tempo stesso molto diverso e l'esempio di Stefano di Obazine, un altro erernita ehe nei prirni anni del secolo XII aveva intrapreso, con lo stesso rigore, una rigida esperienza di vita penitente anch'egli nella regione di Lirnoges, al confme con l'Alvernia. Le notizie sulla sua vita e sul suo percorso di maturazione spirituale sono note dalla anonima Vita Stephani Obazjnensis, scritta a piu riprese fra il 1159 e il 1190, da un monaco ehe lo aveva personalmente conosciuto, vissuto nel cenobio di Obazine142. L'eccezionale testo agiografico segue
141 Vie de Saint Etienne d'Obazine (come nota 135), p. 96: Inlereafralm Obaifne millis adh11c scriplis legibiiS lemanl11r, sed inslil11la magislri pro lege habebanl, q11e Iom dislricla el ard11a eranl 111 ct!/llslibel reg11/e aspnilas eis in disciplim rigore addere nihil possel. 'Q11ia vero breves dies hominis SIII/I' el lamdi11 h11mana magisleria vigenl q11af!ldi11 preceplor vixeril a111 presens j11eril, plac11il aliCIIills ordinis eomm q11i in ecc/esia a11clorisali SIII/I professionem asmmerenl, 111 dejicienlib11s magislri, scriple legis allelorilas eis indejiciens permanerel. 142 B. BARRIERE, L'abbaye cistercienne d'Obazine (come nota 7), pp. 12-14. Si vcda inoltre Le cartulaire de l'abbaye cistercienne d'Obazine, ed. B. BARRIERE (XII<-XIII< siede) (Publications de !'Institut d'Etudes du Massif Central 33), Clermont-Ferrand 1989. Recentemente anche R. COMB1\, Cistercensi, certosini, eremiti: intrecci e istituzionalizzazioni di espcricnze monastiche nel XII sccolo, in: R. Co~mA / G . G . MERLO (a cura di), Certosini e cisterccnsi in Italia (secoli XII-XV). A tti del convegno Cu neo - Chiusa Pesio - Rocca de' Baldi (23-26 settembre 1999)
Dall'csempio alla santita 217
Ia storia personale di un giovane prete secolare, nato nella regione del basso Limousin, di media estrazione sociaJet43. Divenuto sacerdote egli aveva mutato completamente genere di vita ed aveva iniziato Ia sua attivita di predicazione, a fianco della quale egli si dedicava intensamente alla lettura e all'approfondimento delle Scritture, leggendo per se e pregando per gli altri. La meditazione approfondita dei testi sacri inoltre gli aveva indicato ehe era suo desiderio rinunciare al mondo, ogni giomo di piu, tralasciando Je eure temporali per "seguire con passo veloce e continuo, povero e nudo il Cristo povero"144. Risolutivo per Ia sua scelta di vita religiosa era stato il colloquio con Stefano di Mercceur, abate della Chaise-Dieu14S, dal quale era stato esortato a non perdere tempo, poiche abbandonare tutto, ponendosi sulle tracce della sequela di Cristo, avrebbe permesso ad altri, seguendo il suo esempio, di convertirsi146.
Con il discepolo Pietro, anch'egli sacerdote, a cui aveva rivelato i segreti del suo cuore, egli aveva inftne deciso di abbracciare Ia vita penitente e prendere l'abito religioso. Da quel momento essi si erano dedicati assiduamente in diversi religiosa /oca alla ricerca di una vita religiosa piu perfetta 147. Giunto nella solitudine di una foresta abbandonata e selvaggia egli aveva deciso, ottenuto il consenso del vescovo Eustorgio di Limoges148, di costruire in quelluogo delle dimore, sul modello di un monastero, costituite da una cappella, un dormitorio, una cucina e nel mezzo un chiostro149. La piccola comunita aveva scelto di regolarsi dal punto di vista liturgico secondo l'officio dei canonici, per il propositum di vita invece essi avevano mantenuto una forma eremitica, solidamente basata su una rigida disciplina, fondata sullavoro manuale, sulla lettura, Ia preghiera, i digiuni, Ia penitenza continua e il silenzio15°. Si trattava di una esperienza di eremitismo collettivo, in cui i momenti caratteristici della vita in comune convi-
(Societa per gli studi storici, archcologici ed artistici della provincia di Cuneo. Storia c storiografia 26), Cu neo 2000, pp. 9-32, in particolare pp. 17-19.
IH Vie de Saint Etienne d'Obazine (come nota 135), p. 43. 144 Ibid., p. 46: desideriis iliflammatm quotidie abremmriare semlo dispollebat 111 femmis cmis abiectis, pauperem Christum pauper ipse ac 1111dus, expedito gressu, collfi11110 sequerefur.
145 Stefano di Mercceur fu abate della Chaise-Dieu da! 1111 al 1146; P. R. GAL!SSIN, L'abbayc dc La Chaise-Dieu (1043-1518), Parigi 1962. 146 Vie de Saint Etienne d'Obazine (come nota 135), p. 48.
I H Ibid.: religiosa loca, sie ubi peifectioJi illsfituto, ta11fo peifectius, qua11fo ef Jortius pro Deo famulm~llflll: 148 Series episcoporum ecclesiae catholicae (come nota 18), p. 545: Eustorgio vcscovo di Limoges dal1106 al1137. 149 Vie de Saint Etienne d'Obazine (come nota 135), p. 54.
ISO Ibid.
218 Cristina ,\ndenna
vevano eon le forme della vita eremit:iea 151. 11 silenzio in partieolare era un aspetto sostanziale della loro seelta: non si pereepiva ne la loro parola, ne tanto meno il suono della loro voee. Ma se la boeea era ehiusa, le apere tuttavia parlavano eon ehiarezza: ispirati da Dio infatti essi rendevano testirnonianza evidente della loro spiritualita.
L'agiografo ribadiva inoltre ehe fra eostoro uno in partieolare si dirnostrava nettamente superiore agli altri, e tutti li dominava: eostui era Stefano di Obazine. 11 suo esempio di vita e i suoi insegnamenti erano istruttivi: l'autore della Vita infatti afferrnava ehe la eomunita si presentava in tal modo eome un esempio rnirabile agli oeehi altrui. Le sue parole erano come un fuoeo ardente, eapaee di illuminare le menti di eoloro ehe lo aseoltavano e inebriati da un tale amore divino, ess.i, pur eonservando la loro personalita, si aeeordavano all'unisono, in tal modo ne risultava mutata la qualita della loro vita e della loro eondotta. L'aspetto e il modo di eomportarsi di Stefano e tutto eio ehe egli eompiva, sostituivano completamente parole e diseorsi. Sull'esempio di un simile maestro, eapaee di istruire senza diseorsi e senza parole, non stupisee affatto allora ehe i diseepoli fossero tali e ehe la eomunita presentasse una tale rettitudine di vital52.
Dopo il trasferirnento della eomunita a Obazine era nata una eontroversia per deeidere ehi avrebbe dovuto dirigere il nuovo insediamento: ma la eontesa, notava l'agiografo, non presentava un aspetto tradizionale, sintomo della mentalita del mondo. Entrambe infatti sia Stefano, sia uno dei suoi piu antiehi diseepoli si rifiutavano di assumere la direzione della eomunira, non volendo rinuneiare al loro spirito di urnilta, preferendo entrambe sottomettersi alla volonra di un altro, piuttosto ehe irnporre la propria. Fu il veseovo di Chartres Geoffroy de Leves, legato a quel tempo per eonto del pontefiee Innoeenzo II, a risolvere la questione, irnponendo a Stefano di assumere la direzione della eomunita153, investendolo eome priore e affidandogli anehe la eura delle anime.
151 B. BARRI ERE, Les abbaycs issue de l'eremitisme, in : Les Cisterciens de Languedoc (XIIJc_ XJVc siecles) (Cahiers de Fanjeaux 21), Toulouse 1986, p . 77 eR. Cü~!ßi\ (come nota 142), p. 18.
152 Vic de Saint Etienne d'Obazine (comc nota 135), p. 58: Es! aulei!JIIJJIIS i11ler eos qui celnis preesl, afius magislerio edocti el iJJfor7!1ali exemplo ila refu/gwl. S ermo yus quasi ig11is ardws ila audiwtium 1/JCI/Ies acceJJdit el laJJio amore i11ebrial 111 maJJwle persoJJant/11 prvprielale, alii quodammodo ex aliis efficiaJJIIIr el vile eommmommque qualitas immulelur. S edel habitus yus el iJJcessuJ vel cmJcla que agil quaJi quidem JCT7/IO J/1111, 11ihilque aliml iJJcidanl quam vile ordimm mommque el acl/111111 disciplinam. Unde mimm non eJI lalu esse diicipuloJ qui Iainii haben/ magiJimm, qui eoJ e/ abJque verbo Sl!fJicienlerpotul docere.
153 Ibid., pp. 65 s.; per Ia lcgazione di Geoffroy dc Leves, cfr. W. JANSSEN (come nota 4) , pp. 18-30.
Dall'esempio alla santita 219
Divenuto priore egli continuo ad insegnare e ad adottare lui stesso il medesimo modo di vivere di prima, fondato sui principi di umilta, obbedienza, poverta e disciplina, e superiore a tutte le altre, sul principio della carita continua. Non avendo alcuna altra regola, gli instituta magisüi erano considerati una legge e divenivano il fondamento di una severa condotta, ehe Stefano imponeva in prima luogo a se stesso, intervenendo con afflizioni spirituali e dure punizioni corporee. In tal modo l'eremita si offriva come esempio per i discepoli ehe egli vigilava, correggendoli con amore e devozione, ma anche con severita154.
Come presso molti altri eremiti, attorno ai quali si era raccolta una piccola comunita, emerge dalla fonte narrativa il bisogno di una codificazione normativa stabile ehe regolasse la vita interna del gruppo, poiche se l'esempio di vita dell'iniziatore valeva come Iex, tuttavia esso avrebbe dovuto incarnarsi per poter durare nel tempo in un codex scritto. Per questo motivo il testo agiografico sottolinea sin dall'inizio l'abitudine e la preoccupazione di Stefano di Obazine di visitare altri monasten vicini per trarne un esempio di costumi e di disciplina da proporre ai suoi confratelli. E necessario tuttavia ribadire ehe la Vita fu scritta nella seconda meta del secolo XII, quando il monastero di Obazine era gia divenuto cistercense. L'agiografo pertanto, istruito e formato alla cultura e alla spiritualita cistercense, era proteso a dirnostrare come l'adesione a quel tipo di monachesimo, e pertanto ad una regola e a delle usanze codificate, fasse stata la scelta piu ragionevole, anzi l'unica possibile. La religio dei cistercensi infatti aveva introdotto nello spettro complessivo della organizzazione della vita religiosa delle significative varianti. Essa si fondava direttamente sulla regola benedettina, ma aggiungeva alla autorita della regola nuove e moderne strutture istituzionali, sostanziate su un piu solido e codificato concetto di diritto, ehe ben presto anche altre osservanze sarebbero state castrette ad adottare nel caso in cui esse avessero voluto trasformare l'azione dei loro fondatori in una realta duratura155.
Si trattava di campiere una sorta di riforma della vita religiosa, o meglio nel caso di Stefano di Obazine, di una evoluzione, sulla base di un fondamento organizzativo ehe, in modo piu chiaro rispetto ad altre espressioni di vita religiosa, potesse realizzare la vita monastica.
1"-' Vie de Saint Etienne d'Obazine (come nota 135), p. 70: C11mq11e 1111lla alic11j11s ordinis Iex posita baberet11r, instif11fa magistri pro lege eranf qm nibil ali11d q11a111 b11militatem, obedimtiam, pa11pntafm1 ac disciplinam ef mper bec, caritafem continlla/11 edocebanf.
!55 Cfr. G . M ELVILLE, Aleune osservazioni sui processi di istituzionalizzazione della 'vita religiosa' nei secoli XII e XIII, in: Benedictina 48 (2001 ), pp. 3 71-394. Sull'evoluzione istituzionale legata a Grandmont anche ID., Von der 'Regula Regularum' (come nota 10), pp. 342-363 .
... ,:;.;-,.-..1
220 Cristina r\ndenna
'\ ... _,.;
In una di queste peregrinazioni alla rieerea di una reg~fa, egli era giunto alla Chartreuse, durante Ia festa della dedieazione della Vergine, e aveva esposto al priore di quel luogo le proprie diffieoldt nel eondurre il suo proposittmJ di vita religiosa, domandando a suo parere quale via religionis fasse eonveniente seegliere. Lui e i suoi Jratres infatti avrebbero volontieri adottato gli instituta di un ordine, ed egli trovandosi in quelluogo avrebbe anehe seelto quelli della Chartreuse. I! priore eertosino, Guigo, aveva risposto in modo negativo alla proposta dell'erernita, indieando eome piu appropriato alla situazione di Stefano di Obazine e della sua eomunita un ordine religioso da poeo fondato, quello ·dei eistereensi. Costoro si mostravano infatti eome Ia via privilegiata ed i loro statuta si presentavano eome il pereorso rnigliore per raggiungere Ia perfezione. I! numero ristretto di religiosi aeeolti negli ererni legati alla Chartreuse era troppo lirnitato per Ia eomunita ehe si era raeeolta attorno a Stefano e ehe sarebbe stata destinata aneora a ereseere nel tempo. Guigo riteneva ehe sarebbe stato piu eonveniente per Stefano seegliere una professione monastiea, Ia quale rispondeva meglio sia alle neeessita di una moltitudine, sia a quelle di pieeoli gruppi. Le eomunita monastiehe infatti erano stimate indipendentemente da! numero dei loro membri, per lo spirito di religione e per le virtU, non per l'estensione dei dornini156.
I! ritorno ad Obazine aveva segnato un radieale mutamento: erano stati ampliati gli edifiei del monastero, le eui dimensioni non erano piu suffieienti a eontenere il numero ereseente dei religiosi, ed era iniziata anehe Ia eostruzione della ehiesa, ehe sirnilmente all'uso dei eertosini, sarebbe stata intitolata alla Beata Vergine. L'aumento numerieo anehe delle donne rieevute in religione impose a Stefano Ia eostruzione di un ehiostro femrninile, Coyroux, non Iontano da ObazineiS7.
I due monasteri, eolloeati a poea distanza l'uno dall'altro, furono eonsaerati nel 1142 da! veseovo Gerardo di Limogesl58. I religiosi divennero dopo Ia eonsaerazione monaei sottoposti al governo di Stefano ehe feee Ia professione
156 Vie dc Saint Etienne d'Obazinc (comc nota 135), p. 82: Vir itaq11e Dei C/1111 priore /ocifami/iariler co//om/11s eralwim discre/11S el religione fimdallls, ronsili11m q11ereba/ q11am sibi viam religionis decemerel eligwdam. Eralwim in hoc lam ipse, q11all/ fralres ei11s, 111 a/ic11i11s ordinis insli/11/a msciperwl, q11ia e/ hoc ibi COI/Ve-1/era/ illomm ordinem ad consili11m e/ vohmla/1!111 eomm mscipere deb11isse/. Ad q11od i//e respondms dixil Cislerciwses mtper exorlos 1~giam viam lemre, eomm s/a/11/a ad 0/111/e/1/ peifelionem posse /arge mfficere. 'Nobis mim, ail, el in personis es/ nllfllems el in possessionib11s /em1in11s es/ prejix11s. T11 vero, q11i pl11res ad Dei snvili11m congregasli el adlmnc a11tpliores mscipere decrevisli, cwobia/em magis expelere debes professionell/ q11e e/ 11111flis eque pale/ el paucis, quia non 1111/llero, sed religione, pwsa/11r el virlulibus non possessio11ibus eslimalur~ 157 lbid. , pp. 82-97. 158 Cfr. nota 135.
Dall'escmpio alla santita 221
monastiea nelle mani di un abate, mentre fu eonsaerato egli stesso abate dal presule. Lo stile di vita seeondo il modello eistereense fu introdotto da aleuni monaei provenienti dal monastero di Dalon, eolloeato al eonfme fra Limoges e Perigueux, eenobio in eui la diseiplina si ispirava agli usi eistereensi, anehe se il monastero non era aneora, a quella data, eompletamente affiliato all'ordine. In tal modo la eomunita di Stefano di Obazine, ehe sino ad allora non poossedeva testi normativi seritti, abbandonava gli instituta magistri, eonsiderati eome una Iex, la eui asprezza e durezza era tale ehe qualsiasi diseiplina fasse stata ad essi aggiunta, essa non avrebbe apportato alcuna signifieativa variante.
Ma poiehe vero brevesdies homini sunt e un insegnamento umano e valido solo sino al momento in eui vive l'ispiratore, o sino a quando egli e presente ed operante nella eomunita, i Jratres di Obazine si sottornisero alla diseiplina di un ordine rieonoseiuto nel sistema eeclesiastieo. In tal modo, alla morte del maestro, l'autorita di una regola sarebbe inveee rimasta eome elemento fondante attraverso un testo seritto ed approvatots9. Aderire ad un testo normativo rappresentava una sieurezza eompletamente differente rispetto al sempliee fondarsi su di un esempio di vita, per quanto perfetto esso si presentasse. Per parlare di una ineorporazione all'ordine tuttavia sarebbe stato neeessario attendere il 1147, quando il pontefiee Eugenio III, ehe un tempo era stato monaeo a Citeaux e poi abate del monastero eistereense di Sant'Anastasio alle Tre Fontane presso Roma, lo aveva presentato al eapitolo generale. In quella oeeasione il pontefiee aveva ehiesto agli abati di aseoltare l'esplieita domanda di Stefano ehe domandava ehe il monastero di Obazine, nonostante la presenza del eenobio femminile di Coyroux fasse ineorporato all'ordine eistereense16o. Fu per l'insistenza e
159 Vie de Saint Etienne d'Obazine (come nota 135), p. 96; cfr nota 141. 160 Vie de Saint Etienne d'Obazine (come nota 135), pp. 110-112. La presenza di una componente femminile rappresentava un motivo di ferma opposizione e di obiezione per i cistercensi. L'opposizione appare ancora maggiore se si pensa ehe Ia Vita fu scritta negli ultimi anni del secolo XII, quando il numero dei monasteri femminili ehe avevano chiesto di essere incorporati all'ordine era vistosamente aumentato e i monaci bianchi avevano bisogno di giustificare di fronte ai numerosi dinieghi, le motivazioni eccezionali ehe invece avevano caratterizzato il permesso accordato a quei cenobi femminili ehe invece erano parte dell'ordine. Sul problema delle incorporazioni dei cenobi femminili ai nuovi ordini religiosi cfr. K. ELM, Le donne negli Ordini religiosi dei secoli XII e XIII, in: G. ANDENNA I B. VETERE (a cura di) , Chiaraeil secondo Ordine. II fenomeno femminile nel Salento. Atti del Convegno di studi in occasione del'VIII centenario della nascita di Santa Chiara (Nardo, 12-13 novembre 1993) (Universita degli studi di Lecce. Dipartimento di studi storici da! Medioeva all'Eta contemporanea 36 I Saggi e ricerche 29), Galatina 1997, pp. 9-22; F. J. FELTEN, Verbandsbildung von F rauenklöstern. Le Paraclet, Premy, Fontevraud, mit einem Ausblick auf Cluny, Sempringham und Tart, in: H. KELLER I F. NEtSKE (come nota 10), pp. 279-345; M. P. ALBERZONI, Papato e nuovi Ordini religiosi femminili, in: II papato duecentesco c gli Ordini mendicanti. Atti del XXV Convegno internazianale di studi (Assisi, 13-14 febbraio 1998) Spoleto 1998, pp. 205-261 e le indicazioni bibliografiche in
.•, . / .. ·,,
222 Cristina r\ndenna
'v"/<
la santita di vita del richiedente, e per la volonta del p~htefice, ehe il capitolo generale cistercense decise di accogliere Stefano di Obazine in societatem ordinis, affiliando i suoi monasteri direttamente alla donms di Citeaux16I.
L'abate cistercense Rainardo, ehe conosceva Stefano e lo ammirava, assicuro presso gli abati cistercensi ehe tutto cio ehe nel cenobio dal punto di vista normativo e organizzativo era contrario alle istituzioni sarebbe stato poco a poco mutato. L'agiografo non mancava di introdurre una descrizione dei modi pacati, amorevoli e familiari con i quali la disciplina era stata introdotta dai monaci bianchi nel nuovo cenobio. La correzione mirava soprattutto a rivedere i testi ehe provenivano dal monastero di Dalon, dal quale Stefano aveva appreso i primi rudimenti della disciplina monastica di tradizione cistercense. Questi testi presentavano infatti le consuetudini e i riti cistercensi risalenti tuttavia ad un periodo precedente i cambiamenti introdotti dall'abbaziato di Bernardo di Clairvaux162•
La vita di Stefano di Obazine raccontata dall'agiografo dimostra una perfetta consonanza con la condotta di altri eremiti del secolo XII. Dalle sue parole e dal suo esempio traspariva la bellezza spirituale ehe lo caratterizzava. Interiormente era timoroso, ma all'esterno egli si mostrava amorevole in modo da poter attirare con la sua dolcezza coloro ehe desiderava correggere163. Egli infatti era attento e scrupoloso, seguiva passo a passo i propri discepoli nelle attivita quotidiane in modo tale ehe la loro pratica di vita corrispondesse in perfetta consonanza allo spirito della regola: mostrava a ciascuno il suo dovere, come un vero educatore, ma in questo senso istruiva piu con l'esempio personale ehe con la parola.
C. ANDENNA, Dalla 'Religio pauperum dominarum de V alle Spoliti' all' 'Ordo Sancti Damiani'. Prima evoluzione istituzionalc di un ordinc rcligioso femminile nel contesto delle esperienze monastiche del secolo XIII , in: G. MELVILLE / J. OBERSTE (a cura di), Die Bettelorden im Aufbau (Vita Regularis 11), Münster 1999, pp. 429-492, in particolare pp. 429-436. Sullo specifico problema delle incorporazioni dei monasteri cistercensi G. CARlßON I, Comunita religiose femminili Iegate ai cistercensi a Piacenza e in Lombardia tra i pontificati di lnnocenzo II e r\lessandro IV, Tesi di Dottorato- Universita Cattolica di Milano, aa. 1994-1997. 161 Vie de Saint Etienne d'Obazine (come nota 135), p. 112. 162 Ibid., pp. 113 s. L'importanza della adesione alla regola emerge da un passo della Vita, dove Stefano di Obazine ad esempio si costrinse ad adottare le usanze cistercensi sul problema della assunzione della carne, nonostante egli non fasse d'accordo con le prescrizioni previste. Ibid., p. 116: Cumque ei capitu/um regule pro ilifirmis oppomre11/111; ille /acebat, quia 11ec islud ei placm, mc regule auclorilals polerat displicere. 163 Ibid., p. 132.
Dall'csempio alla santita 223
L'intento dell'agiografo non era quello di lodare Stefano, quanto piuttosto di offrire un modello di edifieazione. I lettori avrebbero infatti appreso dall'esempio delle pieeole azioni raeeontate, l'attitudine ehe essi avrebbero dovuto adottare nelle azioni piu grandi. Nella mente dell'agiografo Stefano era pertanto proposto eome uno speeehio di virtU c di perfezione164.
La Vita e la eondotta dei due penitenti Stefano di Thiers e Stefano di Obazine testimonia una religiosita libera, orientata verso la eonquista di una dimensione personale, nella quale ogni uomo aveva la possibilita di ineontrare nel proprio intimo Cristo. Entrambi si presentano come individui, dotati di un earisma, il eui faseino e la eui forza attrattiva si sono inearnati progressivamente in un gruppo. Ma l'intuizione originaria di radiealita, nella seque/a Christi per durare nel tempo, ha dovuto neeessariamente trasformarsi in una istituzione. L'esperienza di Stefano di Thiers e quella di Stefano di Obazine, pur nella diversita degli esiti, testimoniano la rieerea eostante di una adesione sempre piu perfetta al Vangelo. Alle origini della loro esperienza religiosa essi, nella singolarita della loro esistenza, rieonoseevano eome uniea legge il Vangelo e, in eonsonanza eon lo spirito eristiano delle origini e la tradizione orientale, ritenevano ehe i Jratres raeeolti intorno a loro non neeessitassero di un legislatore, quanto piuttosto di un modello165. Ma la seelta religiosa si esprime eome un proeesso attraverso il quale l'individuo deeide di rompere eon il mondo dal quale esso proviene e nel quale esso ha vissuto sino al momento dell'ingresso in monastero. Abbandono del seeolo, disprezzo dei valori e dei beni del mondo e oblio delle esperienze mondane si esprimono attraverso una maturazione dell'individuo e una sua progressiva eonformazione ai prineipi spirituali ispiratori. Essi costituiseono il fondamento della seelta, ehe si esprime nel seeolo Xll nell'inserimento del singolo soggetto in un gruppo, la eui eonereta attuazione
trova il proprio eompleto eompimento in una vita eondotta in una eomunita religiosa166. Per ereare una istituzione e neeessario sostanziarla di una norma, sulla base della quale i singoli membri della eomunita orientino la loro persona-
IIH Ibid., p. 188.
11•; Poemen, in: J. C. Guv, Les apophtegmes des peres du dcscrt, Bcllefontainc 1966, ora in trad. it.: Vita c detti dei Padri della Chiesa, 2 voll., Roma 1975, vol. 2, n. 174: Un fratello ehiesc al padrc Poemen: 'Dei fratelli vivono eon me; vuoi ehe dia loro degli ordini?'. 'No gli diee l'anziano fa' il tuo lavoro tu, prima di tutto; e sc vogliono vivere, pcnscranno a se stessi'. II fratello gli diee: 'Ma sono proprio loro, padre, a volere ehe io dia loro ordini'. Diee a lui l'anziano: 'No! Diventa per loro un modello, non un legislatore'. 166 K. ELM, Cosa signifiea e a ehe scopo si studia Ia storia degli Ordini religiosi, in: Benedietina (in eorso di pubblieazione) . Cfr. anehe J. DALARUN, La mort des saints fondateurs: de Martin a Fram;ois, in: Les fonetions des saints dans le monde oeeidental (Ili<-XIII< siede) (Colleetion de l'Ecole frans;aise de Rome 149), Roma 1991, pp. 193-215.
224 Cristina Andenna
lita al serv121o e all'amore di Dio. Il passaggio dall'attrazione della forza earismatiea dell'esempio alla traduzione in una regola e un percorso molto lento e impliea al tempo stesso ehe il fondatore da modello imitabile divenga un modello inimitabile167. I singoli membri, senza perdere la peeuliarita della loro dimensione individuale, inveee, devono perpetuare nel tempo l'intuizione del earisma ehe essi hanno ineontrato e aderire eon obbedienza alla regola e alle preserizioni normative in essa eontenute.
167 Un simile percorso di promozione di una santita inimitabile avviene per Francesco d'Assisi al tempo del generalato di Bonaventura e della composizione della Legmda Maior, cfr. G. MICCOLI, Di aleuni passi di Bonaventura sullo sviluppo dell'ordine francescano, in: 10., Francesco d'Assisi. Realta e memoria di un'esperienza cristiana, Torino 1991, pp. 264-280; 10., Francesco e Bonaventura, in: ibid., pp. 281-302. Si veda anche J. DALARUN, La Malavventura di Francesco d' Assisi. Per un uso storico delle Ieggeode francescane (Fonti e ricerche 1 0), Milano 1996; cfr. anche G . MELVILLE, 'In solitudine ac paupertate' (comc nota 10), pp. 7-30. Sul concetto di carisma W. GEBHARDT, Charisma als Lebensform. Zur Soziologie des alternativen Lebens, Berlin 1994.























































![Stefano Medas, Due relitti con carichi lapidei rinvenuti al Bacàn (Bocca di porto di Lido, Laguna di Venezia) [Two shipwrecks with a stone slabs freight from Lido inlet, Venice lagoon]_2012](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/633282958d2c463a5800e861/stefano-medas-due-relitti-con-carichi-lapidei-rinvenuti-al-bacan-bocca-di-porto.jpg)